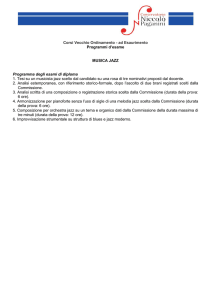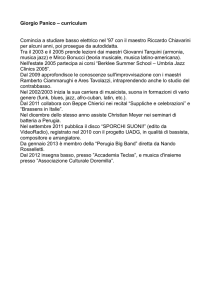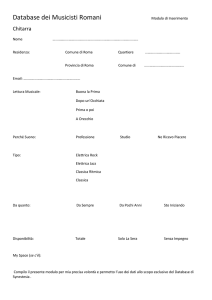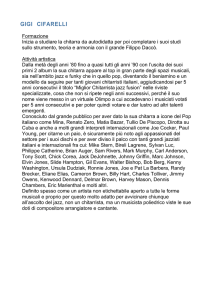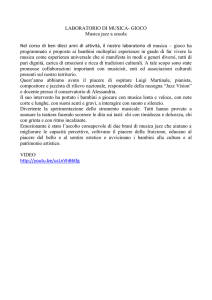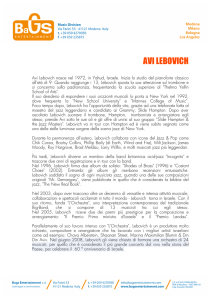PERIODICO DI INFORMAZIONE, ATTUALITÀ E CULTURA MUSICALE
IL ROBOT LITTLE DRUMMER BOY
CHE
VOLEVA
SUONARE
Periodico di informazione, attualità e cultura musicale a cura del Saint Louis College of Music
Novembre-Dicembre 2009
MANGIARE 68 FOGLIE
SPECIALE SESSANTOTTO
di Flavio Fabbri
P
on si può dire quale eredità sia stata
lasciata o cosa abbia significato il jazz
nel 1968 senza accennare alla «rivoluzione culturale» che invase il mondo a metà
degli anni Sessanta e che raggiunse la sua apoteosi nel 1968. In Occidente - Europa e Stati
Uniti - un numero imponente di studenti e operai prese posizione contro l’ideologia della
società dei consumi, che proponeva il valore del
denaro come punto centrale della vita sociale.
Nel blocco orientale le popolazioni si sollevarono per denunciare la mancanza di libertà e l’invadenza della burocrazia di partito, gravissimo
problema sia dell’Unione Sovietica che dei
Paesi legati ad essa. (...)
er l’Orchestra J
Futura la musica è prima di
tutto immaginazione:
una macchina non è
una macchina, un
robot non è un robot, un uomo non è un uomo.
Ma tutti suonano. In ogni sperimentazione è
presente la possibilità di assaporare a livello
multisensoriale una forma di inquietudine, di
fastidio, per ciò che non si comprende e non si
riesce a tradurre con i tradizionali strumenti
cognitivi. La sperimentazione vera, autentica,
significativa, deve rompere un equilibrio mentale, sociale, storico, percettivo e sensitivo, portare con sé una rara sapienza sovversiva e avere
l’ardire di mostrarsi spudoratamente coraggiosa, anzi arrogante nel suo essere ribelle. (...)
! CONTINUA NELLO SPECIALE SESSANTOTTO
! CONTINUA NELLA PAGINA CLASSICA-MENTE
di Adriano Mazzoletti
N
J AZZ
&blues
SONNY ROLLINS
di Nicola Cirillo
T
he little drummer boy («Il piccolo tamburino»), scritta nel 1941 da Katherine K.
Davis, suggerisce un tema natalizio, la storia di un ragazzino povero che propone in dono a
Gesù, poiché non ha nulla, di suonare per lui il
tamburo. Shall I play for you, pa rum pum pum
pum, On my drum? Oggi c’è un nuovo little
drummer boy: Gianluca Pellerito, 15 anni. Nato a
Palermo il 1° maggio del 1994 sotto il segno del
Toro, del Toro ha la determinazione. Conosce la
batteria dall’età di 4 anni - énfant prodige - e gioca
con amici tipo Peter Erskine, Alex Acuna, Gigi
Cifarelli, Davide Ghidoni e Michael Rosen. (...)
! CONTINUA NELLA PAGINA BEYOND
ALTNATIVE
ER
CHICKS ON SPEED
Direttore Responsabile
Salvatore MASTRUZZI
Direttore
ROMINA CIUFFA
Redazione
Romina CIUFFA [email protected]
Flavio FABBRI [email protected]
Rossella GAUDENZI [email protected]
Valentina GIOSA [email protected]
Roberta MASTRUZZI [email protected]
Contributi
Lorenzo Bertini, Rita Barbaresi, Luca Bussoletti
Nicola Cirillo, Stefano Cuzzocrea, Alessandra Fabbretti
Attilio Fontana, Gianluca Gentile, Adriano Mazzoletti
Corinna Nicolini, Livia Oreste, Paolo Romano
Sabrina Simonetti, Donato Zoppo
Music In Video
Videointerviste
Romina CIUFFA
Sabrina SIMONETTI
www.youtube.com/musicinchannel
Web > www.musicin.eu
www.myspace.com/musicinmagazine
Progetto grafico
Romina CIUFFA
Cristina MILITELLO
Redazione
Via del Boschetto, 106 - 00184 Roma
Tel. 06.4544.3086
Fax 06.4544.3184
Mail [email protected]
Marketing e Pubblicità
Mail [email protected]
Tipografia
Ferpenta Editore Srl
Via R. Gabrielli di Montevecchio, 17 Roma
Anno III n. 11
Novembre-Dicembre 2009
Registrazione presso il Tribunale di Roma
n. 349 del 20 luglio 2007
STEFANO
MASTRUZZI
EDITORE
MUSICALL
‘68 ITALIAN ROCK MUSICAL
TRAINING
LA «TAV» DEL JAZZ
«VUOI» SI DICE AGLI ARTISTI
Avviserei, prima che sia troppo tardi.
Oggi sono un Bianconiglio e, con un
orologio al collo, corro gridando:
«Presto, che è tardi!». Tra le pagine
della cronaca romana il Corriere
della
Sera
titola: «Troppo
Facebook? Si cura al Gemelli»,
e un occhiello: «Dipendenza
dal pc, apre un nuovo reparto». C’è un neonato ambulatorio psichiatrico sulle dipendenze patologiche ed è in
fibrillazione: chi dovrebbe
far musica trascorre il tempo
ad «addare». Non scherziamo. La vera musica si fa al
pianoforte, piegati sulla chitarra, sfiatati nel sax, alle
feste di paese e in locali sconosciuti la cui insegna domani
recherà: «Chiuso per fallimento». Odore di anice, sigari,
legno, odor di muffa e di periferia. Sta per: «Fatemi suonare, io
devo suonare, io adoro la muffa
mentre suono».
Chiediamo venia. Chiediamo agli stonati di
smettere di tormentarci dal web, di cercarsi un
lavoro, di iscriversi a un corso di canto ed armonia, se tenaci; perché crediamo che non esistano
stonati dove la voce e l’orecchio siano allenati
con tecnica accurata e sacrificio. Chiediamo
soprattutto ai loro amici di esser sinceri con loro,
come si deve a un amico. La tecnologia non può
significare questo, l’abbassamento se non l’azzeramento della qualità: è lo scotto da pagare?
Piuttosto ci pignorino il pianoforte. Parliamo, qui
nella rubrica ClassicaMente, di robots che suonano e congegni che consentono di eseguire concerti in streaming a distanza intercontinentale,
ma siamo privi di orecchio umano: giudichiamo
l’artista dalle visite che riceve in termini di click,
nemmeno si trovasse in una stanza di ospedale.
Si visita un malato, un artista lo si ascolta.
Mi rifiuto ancora di pensare che il parametro per
inserire una band nel palinsesto musicale sia
costituito dai downloads gratuiti: la musica non
consta del numero di amici contati nel network, la
musica è l’artista, è lui che ascolteremo cantare
stasera, non il click metallico e falso di un «add a
comment». Siamo tutti cantanti allora, tutti scrittori, tutti registi, perché ci sono i blog, Myspace e
Youtube; dimenticando che i networks sono solo
un biglietto da visita, al cui indirizzo deve corrispondere un citofono che non suoni una nota sola.
Continuiamo flebilmente a sostenere che il vero
artista debba saper non solo cantare e suonare
almeno due strumenti, ma anche solfeggiare; che
il vero scrittore non debba confondere «romanzo» con «alfabetizzazione»; e che il vero regista
debba saper sceneggiare. In poche parole, che in
ogni settore creativo siano richieste 3 condizioni,
necessarie ma non sufficienti: una profonda umiltà, studio incessante e fiere di paese.
Sì, proprio la porchetta o i funghi, il vino rosso, la
nocciola tonda gentile romana. Non è il web che
consacra il talento, ma il palchetto. L’evoluzione.
E gli artisti da web sono fermi, riversi sulle loro
pagine online a fare spamming, chiedere amicizie, creare gruppi, invitare ad ascoltare qualcosa
che dovrebbe esser convertito in manodopera o
volontariato. Ad appoggiare cause cantando testi
sulla guerra in congiuntivi sbagliati, senza muoversi dalla stanza. Forse, allora, una visita di cortesia gliela dovremmo fare davvero, e portar loro
le nocciole tonde di Ronciglione.
Romina Ciuffa
J AZZ
& blues
a cura di ROSSELLA GAUDENZI
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
SALVATORE RUSSO Esce JOE BONAMASSA Quando a 12 anni MILES DAVIS Ai tempi del bebop, tutti suonavano velo«La Touche Manouche» per la si partecipa a un tour di B.B. King è ine- cissimi. Sentivo gli altri musicisti suonare tutte quelle scale
label Saint Louis Jazz Collection vitabile cadere nella malia del blues.
e quelle note, e mai niente che valesse la pena di ricordare.
QUESTAGITANOMANIA
Occorre risalire all’anno 1000 d.C. circa e alla cacciata degli zingari dall’India e dal Pakistan da parte
del re afgano Mahmud di Ghazni per capire Salvatore Russo. E ascoltare «La Touche Manouche»
za di Michael Wegen, costruttore di plettri olandese e gran conoscitore dei chitarristi di jazz
manouche.
«Stiamo parlando del miglior costruttore di
plettri per chitarra gipsy: un vero artista, oltretutto profondo amante dell’Italia, dei nostri Da
Vinci e Michelangelo. Nel momento in cui decido di acquistare una seria chitarra gipsy mi
reco dal liutaio Leo Eimers ed è lì che nel 2007
mi imbatto in Stochelo Rosenberg, il più grande chitarrista di gipsy jazz vivente, indiscusso
a cura di Rossella Gaudenzi
talento internazionale e grande compositore».
Tra Salvatore Russo e Stochelo Rosenberg
è feeling immediato. Grande stima da parte
del musicista olandese, leader del Rosenberg
Trio, per il talento made in Italy: ascolta brani
composti da Salvatore e inizia a chiedergli di
incidere insieme un disco. «Mi prendo il pieno
merito di aver fatto conoscere Rosenberg nel
nostro Paese: ho organizzato due concerti in
Italia e quasi immediatamente è arrivata la
ntramontabile, il tempo dei gitani. È accaduto che per una richiesta del bis. L’idea di registrare un disco insieme a lui era
casualità Salvatore Russo, chitarrista di fama internaziona- talmente lusinghiera che, partiti dalla proposta di fargli regile, professionista da oltre 20 anni in contesti pop-rock ed strare solo due brani come special guest, il suo tocco ha invece
orchestrali e neo-direttore didattico del Saint Louis di impresso tutto il disco. Ci siamo incontrati a Lecce dov’è stato
Brindisi, ascoltasse Nuages di Django Reinhardt e ne rimanesse registrato metà del lavoro».
colpito al punto da voler conoscere a fondo questo jazz «poco
La storia è antica e affascinante: occorre risalire all’anno 1000
ortodosso». Siamo nel 2004 e stiamo mettendo piede nel mondo d.C. circa e alla cacciata degli zingari dall’India e dal Pakistan da
del gipsy jazz, o jazz manouche.
parte del re afgano Mahmud di Ghazni; le varie etnie sono approCiò che lo calamita è, ovviamente, la centralità della chitarra: date in Europa dopo una migrazione cinquecentenaria, stanziandobasti pensare che nel ‘35 il quintetto di Reinhardt - caposcuola si, se così si può dire per una popolazione nomadica, in Ungheria,
della chitarra gipsy - comprendeva una chitarra solista, due chitar- Francia, Spagna, Grecia, ed altri Stati europei. Musicalmente le
re di accompagnamento, contrabbasso e violino, quest’ultimo etnie risultanti dai vari ceppi, migrazioni e persecuzioni, si sono
nella persona di Grappelli.
fuse con le culture circostanti. Il musicista tzigano unisce il gusto
Nella sua ricerca e sete di conoscenza Salvatore procede dappri- musicale alla tecnica per colpire gli ascoltatori e stupirli con effetma a tentoni: innanzitutto su internet non trova una quantità di ti quasi circensi. Non conoscono la musica, non sono in grado di
informazioni paragonabile a quella oggi fruibile; inoltre come leggerla né di scriverla, occorre sempre ricordare che la loro tradimusicista rimane dapprima isolato in questa sua ricerca, non riesce zione musicale è legata all’oralità dalla notte dei tempi. Rosenberg
a trovare contatti con altri musicisti. La vera svolta è la conoscen- è di etnia sinti al 100 per 100: il nome però è stato scelto e stabili-
SALVATORERUSSO
I
to dal padre per sfuggire alle persecuzioni naziste. Egli suona
gipsy jazz dall’età di 10 anni seguendo le orme paterne ed ispirandosi al caposcuola della chitarra del genere, Django Reinhardt, e
forte di un trio che suona moltissimo a livello internazionale.
«Si percepisce la complessità di questo genere, ma arriva al
cuore, te ne arrivano le vibrazioni. In Italia siamo sommersi dalla
pop music, ma in fondo la chitarra elettrica è uno strumento sordo,
a differenza della chitarra gipsy; il gipsy jazz nasconde pochissime star e vi si riscontra un’umiltà non presente altrove: la tradizione musicale zingara, tzigana, fa sì che i musicisti abbiano bisogno gli uni degli altri, per suonare. Il jazz manouche è un genere
per addetti ai lavori, forse di nicchia, poiché percepito come antico. Il tramandarsi lo rende unico».
Oggi - per tramandare, appunto - esce La Touche Manouche
per l’etichetta Saint Louis Jazz Collection e contiene 13 brani,
di cui 4 composti da Salvatore Russo, 2 da Stochelo Rosenberg
(il suo inedito dà il titolo al disco) e i restanti pezzi di Django
Reinhardt e della tradizione gipsy rivisitati. Un intero anno di
lavoro. «Make the cd, Sal!, m’incitava Rosenberg fino a che non
ho deciso di mettermi al lavoro. È un musicista che incide raramente e sentirmi così sollecitato è stato estremamente gratificante. Si tratta del mio terzo lavoro discografico, successivo a dischi
rock e fusion (Salvatore Russo, 2000; Contact, 2004). I temi
gipsy mi hanno spinto a ricominciare. Ci sono temi riconoscibili, cantabili, comprensibili. Un anno di lavoro: buttavo giù le
parti, Rosenberg le demoliva e si ricominciava, più volte ci
siamo incontrati in Olanda. Difficile spiegare questo mio lavoro
ai produttori...».
«Da parte di Stefano Mastruzzi ho trovato il supporto necessario: ha avuto una visione chiara del progetto che era un pacchetto finito da stampare interamente ideato da me. Il riscontro
è stato molto buono, da subito: dovrò spedire una trentina di
copie in America perché in una settimana ne sono state vendute
venti. È un disco che ha le carte in regola per diventare un bestseller. Il 2010 sarà il centenario della nascita di Django
Reinhardt e spero che apra le porte alla conoscenza della musica manouche. Dovremmo prender parte al Fara Festival, in estate. E vogliamo diffondere un diverso modo di stare e comunicare con gli altri. Voglio portare Rosenberg in Italia».
di Rossella
Gaudenzi
comincia con il suonare la chitarra classica, ma quando a 12 anni si parteS icipa
a un tour di B.B. King è inevitabile cadere nella malia del blues. Ci si
fa conoscere nei primi anni del XXI secolo, ma dopo aver affiancato, a
Londra nel 2008, il mito Eric Clapton, oggi, all’età di 32, si è consacrati a pieno
diritto tra i migliori chitarristi blues contemporanei, a livello internazionale.
Sono linee guida della biografia di Joe Bonamassa, lo statunitense chitarrista
dalla voce suadente propria dei veri e buoni bluesman, a breve sui palchi italiani; nonché valido compositore, definito erede dallo stesso B.B. King in persona. Lui allieta il nostro dicembre 2010 - con qualche buona azione ce lo saremo meritato - imprimendo di sé con un tocco la rassegna La Chitarra, dopo il
WEWANTMILES
Vogliamo miglia e miglia da percorrere con Davis. Ne facciamo anche fino a Parigi
che fino al 17 gennaio 2010 ci fa viaggiare tra Saint Louis e l’odio di sé, l’uscita del
cool, la libertà controllata, la pulsazione del funk, la distorsione del rock, la solitudine.
arigi celebra ancora una volta Miles
Davis. La riuscita Cité de la Musique,
struttura risalente al ‘95 che ospita il
Conservatorio, il Museo della Musica ed
una vasta sala concerti, fino al 17 gennaio 2010
apre le porte ad un’esposizione, una serie di concerti di prestigio, film, workshops, conferenze e
molto altro. Il tutto incentrato sull’uomo, il musicista, l’artista Miles Davis qui racchiuso in un percorso suddiviso in otto stanze: Da Saint Louis alla
52ma Strada (1926-1948); L’uscita del Cool: l’invenzione e l’odio di sé (1949-1954); Miles Ahead:
in studio per la Columbia (1955-1962); Miles
Smiles: la libertà controllata (1963-1967); Miles
elettrico: la distorsione Rock (1968-1971);
All’angolo: la pulsazione del Funk (1972-1975);
Silenzio, solitudine e requiem (1976-1980); Star
People: l’icona interplanetaria (1980-1891).
Sono stanze che ripercorrono i periodi della sua
vita attraverso fotografie, estratti video dei concerti, strumenti, partiture, costumi di scena, manifesti, oltre a dipinti e sculture, in una mostra che ha
voluto focalizzarsi sulla musica, la prima a così
larga scala sul leggendario trombettista statunitense. Tra le formazioni musicali che lo rappresenteranno: Jimmy Cobb’s So What Band, Joe Lovano
Nonet, Paolo Fresu Quintet, Laurent Cugny
Enourmous Band. (Rossella Gaudenzi)
P
successo di quella dello scorso anno legata ai grandi nomi del basso elettrico in
circolazione. Nel 2009 è uscito l’album celebrativo di 20 anni di carriera, The
Ballad of John Henry, con brani originali e rivisitazioni di pezzi di Ailene
Bullock, Tom Waits e Tony Joe White. Ora l’Europa lo attende, attende il suo
show teatrale e il cambio delle sue trenta (o giù di lì) chitarre sulla scena da fissare entro il 13 dicembre sul palco dell’Auditorium Parco della Musica.
Da tenere a mente questa Chitarra, che durerà una lunga stagione invernale.
Sciorino in ordine sparso: non solo blues, ma ottimo jazz, musica folk, rock, pop
da Bill Frisell al leggendario Paco de Lucia, da Pat Metheny a Tuck & Patti, a
John Abercrombie; da Mark Knopfler a Mike Stern, alla nostra Carmen Consoli.
J AZZ
& blues
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
NUNZIO ROTONDO Nella notte fra il 14 e il 15 settembre è scomparso a Roma SONNY ROLLINS Per chiunque studi il linguaggio del jazz è un’estasi e un torNunzio Rotondo. Di lui parla, con un’anteprima del suo libro, Adriano Mazzoletti, mento. Per chiunque ami ed ascolti il jazz è un irraggiungibile, complesso labiringiornalista e scrittore, dirigente Rai e conduttore radio, che si occupa di jazz dal 1955 to di idee. Sonny Rollins vincerebbe una gara spirometrica con un quindicenne
JAZZROTONDO
di ADRIANO MAZZOLETTI
La personalità di Nunzio Rotondo è assai complessa. Dava voce jazzistica
al «fanciullino» pascoliano: pieno di speranza e insieme di timore del mondo,
incline a ripiegare in una malinconia senza altro sfogo che l’amarezza solitaria.
N
ella notte fra il 14 e il 15 settembre è scomparso a Roma Nunzio Rotondo. La sua
morte a 85 anni segue di poche settimane
quella di un altro nostro musicista di jazz, Gianni
Basso, di qualche anno più giovane. Nato a
Palestrina nel 1924, figlio di un clarinettista e di
una cantante, venne subito avviato allo studio
della tromba e nel 1944, quando Roma non era
stata ancora liberata, faceva già parte della sezione trombe di una orchestra dell’Eiar, quella diretta da Piero Rizza con Armando Trovajoli con il
quale Nunzio avrebbe avuto, negli anni successivi, occasione di esibirsi spesso.
La personalità di Rotondo è assai complessa.
Dava voce jazzistica al «fanciullino» pascoliano: pieno di speranza e insieme di timore del
mondo, incline a ripiegare in una malinconia
senza altro sfogo che l’amarezza solitaria. Di
sicuro c’è che Rotondo non ha mai voluto staccarsi da Roma, anche quando ebbe offerte allettanti da grandi musicisti, come Lionel Hampton,
Clark Terry, Sonny Rollins o Dizzy Gillespie
sempre alla ricerca di giovani talenti. Il suo
rifiuto di inserirsi nel mondo del jazz internazionale, che forse considerava difficile o insidioso,
che lo avrebbe allontanato dalla semplice e tranquilla vita romana, lo indusse a trovare rifugio
per lungo tempo negli studi della Radio e cambiare spesso partner, anche se per lui era difficile trovare musicisti alla sua altezza.
Il suo debutto discografico avvenne il 9
marzo 1950. Quella prima seduta ebbe grande
significato per il jazz italiano: un giro di boa di
notevole importanza. Dei tre brani incisi il
primo è il bel tema di Piero Piccioni Boppin’ for
Bop, in cui Rotondo si limita a suonare sedici
battute, incastonate fra uno splendido Marcello
Boschi e un modesto Bruno Campilli, pianista
che scomparve dal mondo del jazz così come
era apparso. Dove invece Rotondo è realmente
superbo è in The Man I Love. Un Rotondo davisiano non per scelta estetica ma per urgenza
interiore - lo sarebbe stato anche senza Miles
Davis - e il modello sono le ballad incise dal
quintetto di Charlie Parker, come ricorda anche
Marcello Piras.
Ma a parte che qui i ruoli sono invertiti-predominante la tromba, secondario il sax alto-,
Rotondo ha personalità tanto forte da ripensare
tutto a modo suo. Esordisce con un rubato per
tromba sola, come una invocazione tenera e
struggente; e si inoltra quindi nel giro armonico
gershwiniano, a tempo lentissimo, senza vincoli nel suo più libero canto. Del tema originario
egli espone poche note e subito se le scrolla di
dosso: è se stesso, lamentoso e commosso,
implorante e disperato. Sotto il volo della sua
tromba ha predisposto un fondale scritto per sax
alto e tenore, che evocano a note lunghe il familiare disegno del tema di Gershwin. Dopo il suo
assolo, Rotondo lascia spazio al sax alto di
Marcello Boschi, che vi colloca il più bell’assolo della sua vita, perfetto e quasi furioso nella
sua ansia scalpitante.
Non so se qualcuno nel lontano 1950 abbia
sottoposto qualche studioso americano o
anche europeo a un blindfold test. Con ogni
probabilità sarebbe rimasto assai sorpreso
nell’apprendere che quella tromba e quel sax
alto erano due ragazzi provenienti da quella
che all’epoca era considerata la più inaccessibile periferia del jazz.
Nel corso della sua continua evoluzione è
possibile individuare due momenti topici. Il
primo copre il periodo 1950-54, caratterizzato
da una produzione discografica con formazioni
di sei-sette elementi e da una notevole attività
concertistica. Il secondo periodo, 1958-1975,
segna invece gli anni più intensi del lavoro
negli studi radio con complessi di quattro-cinque musicisti.
Della sua lunga attività sono attualmente
reperibili solo quattro cd. Il primo è la riedizione del long playing Rca Romano Mussolini con
Nunzio Rotondo e Lilian Terry, con una splendida copertina in cui i tre protagonisti sono
fotografati, in una bella giornata di sole romano, sulla terrazza del Pincio che si affaccia su
piazza del Popolo. Il secondo una riedizione
delle sue prime incisioni, con The Man I Love,
in un cd della Riviera Jazz Record.
La cospicua produzione realizzata per la
radio e la tv giace ancora negli archivi del
nostro servizio pubblico. Solo di recente la giovane etichetta Via Asiago Dieci, che si prefigge
di rendere pubblico l’archivio radiofonico, ha
diffuso due cd con ventinove brani del periodo
1964-1980.
ADRIANO MAZZOLETTI, «IL JAZZ IN ITALIA DALL’ERA DELLO SWING AGLI ANNI 70»
ANTEPRIMA DAL VOLUME DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE EDITO DA EDT
Se il nostro Alessandro
Manzoni, tormentato
dai dubbi di lingua e di
stile, esponeva le bozze
dei suoi sposi promessi
in una casa aperta
al pubblico per poterle
liberamente correggere,
Sonny Rollins
di giorno studiava
il rapporto tra improvvisazione e struttura,
di sera lo sperimentava
sul Williamsburg
Bridge, nell’East Side
di NYC, per capire le
reazioni della gente
di Paolo Romano
Il Solo Album di Sonny
Rollins: 50 e passa
minuti di improvvisazione completamente
da solo. Un torrente
in piena di idee.
Sconvolgente. Non una
frase uguale all’altra,
ma un perfetto
marchingegno
di struttura e melodia.
E là, in quelle circostanze, presi definitivamente
atto del canyon che
separa un musicista,
pur talentuoso,
da un genio
SONNY, PLEASE
P
er chiunque studi il linguaggio
del jazz è un’estasi e un tormento. Per chiunque ami ed ascolti
il jazz è un irraggiungibile, complesso
labirinto di idee. Da 65 anni (sic!) è
nei più importanti santuari del mondo
di musica afroamericana e conta una
produzione in studio e live da doverla
almeno dividere in decadi per provare
a repertarla con dovizia. È Sonny, al
secolo Theodor Walter, Rollins, il
ragazzo ottantenne di Harlem che se
c’è un solo appassionato che, non
avendolo ancora fatto, si perde la
chance di ascoltarlo l’11 novembre al
Parco della Musica capitolino, beh...
dovrebbe per penitenza essere costretto ad un anno di ascolto forzato e continuo di Korn e Sepultura.
I suoi solos sono materia di studio
obbligatoria per diplomarsi alla
Berklee di Boston, dove ti fanno rompere le corna sulla trascrizione ritmica
esatta della sua più celebre St. Thomas:
una manciata di poche note messe là a
costruire il principio di una storia da
raccontare, con intervalli desueti piazzati a prolusione di uno dei più intriganti, lucidi e complessi assoli del jazz
(provare per credere). Sarà che il gusto
per il calypso gliel’avevano trasmesso i
genitori delle Isole Vergini, sarà che il
blues l’ascoltava da ragazzino per strada, ma Sonny si ritrovò a 16 anni a
padroneggiare ogni più sottile sfumatura della musica di Harlem e a buttarsi
in uno studio disperato, che - a sentir le
interviste, cui mite e umile si sottomette da altrettanti 65 anni - continua come
se fosse il primo giorno di alfabetizzazione musicale.
Se il nostro Alessandro Manzoni,
tormentato dai dubbi di lingua e di
stile, esponeva le bozze dei suoi sposi
promessi in una casa aperta al pubblico perché le potesse liberamente correggere, il buon Sonny - troppo presto
assediato da un travolgente successo decise di darsi uno stop, basta serate e
basta registrazioni: di giorno studio
del rapporto tra improvvisazione e
struttura armonica, di sera via a sperimentarlo per strada, sul Williamsburg
Bridge, nell’East Side di NYC, per
capire la reazione della gente, perché
la musica jazz è della gente.
Per i cultori delle etichette, il suo fu
presto definito «hard bop», come dire
un bebop più aggressivo, torrenziale,
spesso frammentato e con zero concessioni ai melodici di Saint Louis,
prima, di Chicago, poi, di inizio secolo. Il resto è storia. Collaborazioni
sterminate con i mammasantissima
che, di decennio in decennio, andavano affermandosi. Indomito scopritore
di giovani talenti, Rollins ha sfatato,
tra gli altri, i cliché per cui i sassofonisti «vecchi» non hanno più fiato
(vincerebbe una gara spirometrica con
un quindicenne) e non hanno più idee
(visto che continua a sfornare nuovi
album di una bellezza imbarazzante).
Ripropone all’Auditorium di Roma
una capacità pressoché infinita di
inventare storie che inchiodano alla
poltrona e tolgono il fiato; lui le chiama «creative session», spettacolari
giochi al rilancio con i suoi musicisti,
tutti rivolti a seguire un’idea e a dire
la loro: con Rollins Bob Cranshaw al
contrabbasso, Kobie Watkins alla
batteria, Victor Y See Yuen alle percussioni e Bobby Broom al piano, gli
stessi che hanno suonato nel suo ultimo Sonny, please e che compaiono
anche nel recentissimo Road Show,
Vol. 1 che dovrebbe iniziare a raccogliere le migliori session effettuate
per il mondo, molte delle quali
appartenenti a registrazioni private
del Colosso del Sassofono. Mi correggo, lasciamo a Roma il suo, di
Colosseo, e apriamo il cuore e le
orecchie all’ultimo dei grandi gladiatori del bop.
Post Scriptum. La recensione è finita. Per i più pazienti, spiego la prima
riga. Qualche anno fa, al Saint Louis
College of Music di Roma, il giovane e bravo chitarrista Antonio Nasone
mi diede da ascoltare il Solo Album di
Sonny Rollins: 50 e passa minuti di
improvvisazione completamente da
solo. Un torrente in piena di idee.
Sconvolgente. Non una frase uguale
all’altra, ma un perfetto marchingegno di struttura e melodia. E là, in
quelle circostanze, presi definitivamente atto del canyon che separa un
musicista, pur talentuoso, da un genio.
CLASSICA
MENTE
a cura di FLAVIO FABBRI
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
MARIO BRUNELLO Shuffle Bach Perché nel ‘capannon’, luogo che useremo per dar vita ai pensieri e alle idee, una volta si lavorava il ferro. Lavoro duro, materia di fuoco e terra, che la tenacia, la
passione, l’intelligenza arriva a piegare e dar forma. Non lasciamo la nostra mente alla ruggine
PLACIDO DOMINGO
Eccellenza spagnola a servizio di sua Maestà svedese
di Flavio Fabbri
Viene da pensare che la metafisica è anche ritmica, che le suggestioni sonore e magiche di atmosfere eteree hanno molto
in comune con la modernità aggressiva del Barocco. Si sperimenta - con uno sperimentatore dall’intelligenza vorace,
Mario Brunello - come l’ibridazione, nella sua semplicità naturale, venga crescendo e mutando nell’esecuzione, fino
a lacerare la «pupa» culturale degli ambienti più conservatori, in una prova di volo libero e contaminazione artistica
Il
g enio è sempre moderno. Bach in quattro serate, ma non
solo. L’opera d’arte musicale che Mario Brunello ha fatto
risuonare nel Teatro Palladium della Garbatella romana, è
un fulgido esempio di forza creativa, ibridazioni e rovesciamenti
sonori, con un’idea forte di fondo: raccontare la tradizione classica attraverso la musica contemporanea, quella che nasce a cavallo
tra Ottocento e Novecento, fino ai giorni nostri.
Si chiama Shuffle Bach il suo nuovo lavoro, presentato al
Romaeuropa Festival 2009 e dedicato al Concerto Brandeburghese
di Johann Sebastian Bach. Un singolare quanto originalissimo titolo tecnico, in cui il genio di Eisenach viene fuso, come in un’alchemica pozione di metalli, con un secolo barocco e denso di ritmi per
la musica di Charles Ives e Philip Glass, Alfred Schnittke e Giya
Kancheli, George Crumb e Giovanni Sollima.
Brunello si è presentato al pubblico nelle vesti di violoncellista
e di direttore, accompagnato dall’Orchestra dell’Accademia di
Santa Cecilia. Allo spettatore è toccato il compito di stabilire quali,
tra i brani eseguiti nelle prime tre serate, siano stati i più belli ed
esaltanti e i componimenti più votati hanno dato vita alla serata
finale, entrando di fatto nella ‘top chart’ di Shuffle Bach. È come
immaginare il pubblico e gli esecutori all’interno di in un gigantesco iPod che interagiscono con la struttura e i file virtualizzati dalle
onde sonore, per un risultato assolutamente divertente e unico nel
suo genere: «Prove dove si concerta-scrive Brunello nel suo blogconcerti dove... si riprova». Anche l’aspetto tecnologico e comunicativo, quindi, come in molti altri artisti sensibili al tempo che
vivono, ha avuto il suo peso in questo nuovo progetto.
Mario Brunello prima ancora di essere un artista di fama mondiale è uno sperimentatore dall’intelligenza vorace, in cerca di
soluzioni sempre nuove in grado di soddisfare le proprie curiosità
culturali e artistiche. Fondatore e direttore dell’Orchestra d’archi
italiana, nel 1986 ha vinto il primo premio al Concorso
Internazionale Ciajkovskij di Mosca, nella categoria dedicata al
violoncello, esibendosi poi nelle maggiori sale da concerto di tutto
il mondo, diretto da nomi di grande prestigio quali Claudio
Abbado, Myung-Whun Chung, Valery Gergiev, Carlo Maria
Giulini, Eliahu Inbal, Marek Janowski, Riccardo Muti, Zubin
Mehta e Seiji Ozawa. Molto attivo in formazioni cameristiche, ha
collaborato con diversi solisti di fama, come il pianista Andrea
Lucchesini e i violinisti Gidon Kremer, Salvatore Accardo e Frank
Peter Zimmermann, a cui si aggiungono il progetto tutt’ora in
corso con Vinicio Capossela, Uri Caine e Gian Maria Testa e gli
spettacoli teatrali con Maddalena Crippa e Marco Paolini.
Shuffle Bach, in anteprima assoluta per l’Italia, è il tentativo
coraggioso e difficile di far dialogare e interagire secoli diversi,
culture lontane, intelligenze e sensibilità poco affini, che solo la
passione e l’amore per la musica possono vantare in comune.
Un’opera, ma soprattutto una performance, in cui Brunello fa girare la testa al pubblico del Palladium, mischiando i secoli, riempiendo gli spazi vuoti dell’arte e invitando il pubblico a giocare con la
storia. Ascoltando Unanswered Question di Ives del 1906, o
Violoncelles vibrez! di Sollima del 1993, ma anche Concerto grosso di Al Fred Garryevi Schnittke o i Morning Prayers di Giya
Kanchel, viene da pensare che la metafisica è anche ritmica, che le
suggestioni sonore e magiche di atmosfere eteree hanno molto in
comune con la modernità aggressiva del Barocco.
Si è così sperimentato come l’ibridazione, nella sua semplicità
naturale, venga crescendo e mutando nell’esecuzione, fino a lacerare la «pupa» culturale degli ambienti più conservatori in una
prova di volo libero e contaminazione artistica. «Perché nel
‘capannon’, luogo che useremo per dar vita ai pensieri e alle idee,
una volta si lavorava il ferro. Lavoro duro, materia di fuoco e
terra, che la tenacia, la passione, l’intelligenza arriva a piegare e
dar forma. Non lasciamo la nostra mente alla ruggine».
Musica come antiruggine, insomma, un lubrificante per l’intelligenza, la creatività, la sensibilità, che il maestro di Castelfranco
Veneto diluisce per bene, passa con cura, accertandosi che nessun
meccanismo culturale e sociale sia tralasciato. Solo in questo
modo la musica creativa, le opere d’arte, i linguaggi del futuro
avranno vita assicurata anche in tempi di omologazione e irrigidimenti ideologici.
Bach sarà sempre moderno, incredibilmente più di un iPod.
È la storia di un’amicizia, quella tra il tenore Placido
Domingo e la soprano Birgit Nilsson, e di un premio
da un milione di dollari consegnatogli dal Re di Svezia
PLACIDA MENTE
IL
13 ottobre 2009 il Maestro Placido Domingo ha ricevuto, dalle mani di Re Gustavo di Svezia, il premio di un
milione di dollari assegnato ogni due o tre anni dalla
Fondazione Birgit Nilsson, un premio tra i più alti mai conferiti
nella storia della musica classica, quasi un Nobel, attribuito probabilmente a uno dei maggiori tenori della storia contemporanea. A render solenne l’evento c’erano, oltre alla Regina Silvia
con la famiglia reale al completo, numerose personalità del
mondo musicale ‘colto’, operistico e lirico, tutti a corte del grande Domingo.
Tra discorsi ufficiali, brani di opera eseguiti dalla soprano
Nina Stemme con l’orchestra reale svedese e filmati tratti
dall’Otello e la Turandot, la cerimonia ha dato anche occasione
al tenore di ricordare la Nilsson: «Provo tanta emozione, ma
anche tristezza e rimpianto per una grande artista, una donna
che ha certamente influenzato la mia carriera».
Placido Domingo ha attraversato tutta la storia della concertistica, fin da quel febbraio del 1969 quando al Metropolitan di
New York si trovò a duettare proprio con il soprano Birgit
Nilsson: due voci dalle straordinarie qualità artistiche, unite dal
lavoro e dall’amicizia. Per questo un cenno deve andare, qui, a
lei (1918-2005), che esordì all’Opera di Stoccolma nel 1946. La
sua carriera internazionale ebbe inizio nei primi anni Cinquanta
con i debutti a Glyndebourne, Bayreuth, Vienna e Monaco di
Baviera, a cui ne seguirono altri, pochi anni dopo, in America del
Nord e in America Latina. La sua apertura della stagione 1958
alla Scala di Milano nei panni di Turandot, il suo debutto come
Isotta presso il Metropolitan di New York nel 1959 e le sue esi-
bizioni nei ruoli di Isotta e di Brunilde nelle produzioni di
Wieland Wagner a Bayreuth, sono considerate pietre miliari della
sua carriera e della storia della lirica. Lasciò le scene nel 1982.
Di leggenda si può già parlare in vita anche per Placido
Domingo, uomo cordiale, estroverso, sorridente, amabile con
tutti ma duro e rigoroso con se stesso, considerato a ragione dai
critici e dalla stampa un tenore inarrivabile, per potenza ed eleganza. Una carriera stupenda, ma non senza problemi e momenti drammatici, soprattutto negli anni delle difficoltà economiche,
con una moglie (la soprana Marta Ornelas) anche lei impegnata
nel ‘Bel canto’ e un figlio da crescere.
«Studiavamo ore ed ore, ogni giorno. Dovevamo fermarci a
Tel Aviv sei mesi e ci restammo quasi tre anni. La nostra vita era
miserrima, 330 dollari al mese in due. I soldi ci bastavano appena per sfamarci. Non potemmo mai permetterci uno svago, un
capriccio», ha raccontato Domingo in un’intervista al giornalista
Renzo Allegri. Tanto studio, assoluto impegno, fede e rinuncia,
fino all’agognato e meritato successo planetario. 130 i ruoli operistici sostenuti, più di qualsiasi altro artista. Nel 2009 sono esattamente 40 gli anni che separano Domingo dalla sua prima esibizione al Metropolitan, dove ha poi inaugurato la stagione per ben
21 volte.
Eccellenza artistica e professionale, testimoniata non solo
dalla straordinarietà del suo repertorio e della sua carriera operistica, ma anche dai risultati ottenuti come direttore d’orchestra,
amministratore, responsabile di iniziative umanitarie e ideatore
di concorsi e programmi per giovani artisti, vanta innumerevoli
onorificenze, tra cui la «Medal of Freedom» e il «Kennedy
Center Honors» del governo statunitense, la Legione d’Onore
francese, il titolo di Cavaliere Onorario dell’Impero Britannico,
la Laurea ad honorem dell’Università di Oxford e il Premio
Mikhail Gorbachov per le cause umanitarie.
È stata la stessa Nilsson, prima di morire, a decidere che il
primo vincitore del premio a lei intitolato fosse il celebre tenore,
amico e direttore d’orchestra spagnolo Placido Domingo.
«Desiderava onorare uno dei più grandi cantanti lirici di tutti i
tempi; un artista che ha saputo offrire un contributo senza eguali alla musica operistica e concertistica», ha spiegato Rutbert
Reisch, presidente della Birgit Nilsson Foundation. «Attraverso
la scelta del primo vincitore, Birgit Nilsson ha voluto sottolineare come lo scopo del premio da lei istituito sia il riconoscimento
dell’eccellenza nell’arte dell’esecuzione musicale».
Un premio immaginato dalla mirabile soprano svedese quale
riconoscimento formale e materiale dedicato a tutti quegli artisti
che si sono distinti come cantanti nel campo dell’opera, del concerto e dell’oratorio; come direttori d’orchestra nel campo dell’opera e del concerto; o come produzione specifica di una compagnia operistica, a condizione che questa produzione sia realizzata e diretta in modo magistrale e, soprattutto, che venga rappresentata nello spirito del compositore.
Una serata di metà ottobre indimenticabile, quella alla Royal
Opera House di Stoccolma, in cui un commosso e solare Placido
Domingo ha ricevuto uno dei premi più ‘consistenti’ della storia
della musica classica, ma anche un abbraccio caloroso da parte
di un’amica dalla voce indimenticabile. Investirà la vincita in
giovani artisti, consolidando il concorso per voci nuove
«Operalia» da lui fondato anni fa. A chi gli ha chiesto quali fossero le registrazioni discografiche che preferiva dell’amica
Nilsson, il tenore ha risposto: “Una delle mie preferite di tutti i
tempi è ‘In questa reggia’, ma il disco non regge assolutamente
il confronto con il suono che ho sentito cantando insieme a lei».
Una storia d’amicizia che sfida il tempo e la sorte, dunque,
incompiuta teoria di voci svolta ‘in un tempo di favole’ dove
sempre cantando, come recita la Turandot di Giacomo Puccini:
«... In gioia pura, sfidasti inflessibile e sicura l’aspro dominio e
oggi rivivi in me!».
(Flavio Fabbri)
CLASSICA
MENTE
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
ORCHESTRA J FUTURA Opere per robots Una macchina
non è una macchina, un robot non è un robot, un uomo non è
uomo. Ma tutti suonano, e sognano di diventare musicisti
! CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA
GARR Oggi Lola non è solo un/a amante dei Kinks ma un
sistema audio visuale di LOw LAtency che consente a più
musicisti di suonare insieme essendo fisicamente lontani
ESSERE
IL ROBOT
CHE
VOLEVA
SUONARE
UBIQUI
di FLAVIO FABBRI
Robot che suonano e un’opera pensata per automobile e orchestra: ma riusciremo a convivere davvero con
il rumore tecnologico, le spigolosità, le superfici metalliche, le densità gassose di scarto della nostra band?
e Suguru Goto, è possibile
(...) A Kourliandski
immergersi in ambienti negativi e rabbiosi.
ncora oggi, grazie ad artisti come Dmitri
La Biennale di Venezia 2009 ce ne ha dato la possibilità
quest’anno, ospitando alcune delle più rare performances
musicali di questi tempi, al limite tra sperimentazione e
provocazione, tra avanguardia e creatività: «Il Corpo del
suono», un’arca musicale su cui sono saliti 73 compositori
da tutto il mondo - Stati Uniti, Giappone, Germania,
Svezia, Russia, Norvegia, Grecia, Belgio, Svizzera, Serbia,
Cile, Francia, Spagna, Italia - per 87 esecuzioni, con 26
novità di cui 16 assolute, distribuite nell’arco di 9 giorni.
Nove puntate di un libro fantastico, fatto di installazioni,
incontri, laboratori e convegni, in cui si parla di corpo e di
sue estensioni, di ‘body and machine’, di tentativi di fondere le due dimensioni plurime attraverso la comunicazione emotiva, quindi la musica principalmente.
Niente di nuovo, in fin dei conti, se non un ritorno a
determinate sensibilità che hanno fatto la storia dell’arte e
dell’espressione artistica: futurismo o dadaismo, tanto per
iniziare. Due volani culturali epocali che hanno trasportato, con le macchine e con la fantasia, l’essere umano avanti di 100 anni rispetto alla tabella di marcia degli ultimi millenni. Dal momento che la tecnologia ha fatto ingresso
nella società degli uomini con essi s’innesca un rapporto
indissolubile, fatale, appassionante, moltiplicante potenzialità insite e ignote. Ma questa domanda non se la sono proprio posta i primi pionieri
della musica-macchina, del
rumore come sinfonia del
futuro, della musica concreta od elettronica.
Un primo esempio di
estemporaneità espressiva
e musicale è la Robot
Music di Suguru Goto,
eclettico artista giapponese
affascinato dalla robotica,
dai new media, dalla possibilità di interagire con le
macchine e dalla loro
improbabile attitudine alla
musica e alla lettura delle
note. Tant’è che i suoi
‘musicisti artificiali’ si
sono cimentati con strumenti percussivi, suggerendo lampi di luce colorata e ritmi stravaganti.
Anche i Robot suonano, sentono o si emozionano? Anche
loro sognano di diventare dei musicisti? Una cosa è certa
secondo Goto, già noto per l’invenzione della ‘body suite’
(tuta digitale per danzatori in grado di produrre musica a
partire dai movimenti): la musica delle macchine (fatta
dalle e con le macchine) è l’inizio di una nuova forma
espressiva del suono, per capacità esecutive infinitamente
più grandi delle nostre: «Un giorno presenterò un’intera
orchestra di robot che non si stancherà mai di suonare».
Oltre a due computer e un programma musicale che
garantisce interazione continua con l’ambiente, è stato il
pubblico a dare l’input finale con un ‘click’ del mouse. Un
omaggio al genio musicale e all’ardore futurista di
Giovanni Russolo forse, ma che non ha convinto fino in
fondo il pubblico del teatro. Certo è che presto dovremo
abituarci al fatto che le macchine faranno parte integrante
della nostra vita, assolutamente più di adesso e in modo
decisamente diverso; esse saranno più autonome, interattive e vogliose di comunicare con noi, anche suonando.
Riusciremo a convivere davvero con il loro ‘rumore’ tecnologico, con le loro spigolosità, le superfici metalliche,
con le loro densità gassose di scarto?
Chi ha avuto la fortuna di assistere all’altra grande performance Emergency Survival Guide, di Dmitri
Kourliandski, eseguita in prima assoluta e commissionata
proprio dalla Biennale, probabilmente potrebbe dire la sua
anche su queste tematiche complesse. Un’opera pensata e
realizzata per automobile e orchestra: una Porsche 2000
del 1976 e la meravigliosa Orchestra J Futura. Quale
migliore cornice sonora poteva accogliere le opere in pro-
gramma di Ansgar Beste, Edgar Varése e Georges Antheil,
se non il rombo universale di una Porsche accompagnato
da clacson, frecce, tergicristalli e luci? Nessun’altra, è
ovvio, perché si parla qui di lavori leggendari, come il
Ballet mècanique del 1924, pensato per 16 tastiere meccaniche sincronizzate, 2 pianoforti con pianisti dal vivo,
percussioni (3 xilofoni, 4 grancasse, 1 gong, incudini), 3
eliche d’aeroplano di dimensione e materiali diversi, 7
campane elettriche e, incredibile per il tempo, il clacson.
Ma c’è anche Hyperprism del 1923, composizione basata sull’idea di scomporre i suoni come il prisma con i colori, isolandone i singoli componenti tra frequenza, durata e
intensità. Qualcosa che non fu capita, perché nuova, troppo presto svelata e che per questo ha dovuto pagare lo
scotto di un senso comune della melodia vecchio e in crisi:
«Non è troppo presto, ma forse troppo tardi», amava affermare tristemente Varése.
Dimensioni estreme del pensiero e dell’esecuzione
musicale, senza ritegno alcuno, dedicate a spostare in
avanti le lancette del tempo, vecchie pratiche e tronfi orgogli neoclassici, ma così intense che solo per un attimo
hanno lasciato passare un po’ di luce dal piano orizzontale del futuro. Sonorità ottenute da materiali eterodossi per
il panorama classico, come pettini, vetri, polistirolo, campanelli, sirene e motori d’aereo. Gli oggetti ritrovano uno
spazio fisico riempiendo uno straordinario teatro cinquecentesco, da cui poi si elevano a musica con un arsenale di
inusitati e sorprendenti
effetti percettivi.
Qui, tra autentiche aurore
boreali sonore, trova posto
reale il gesto nuovo di
Kourliandski, la sua «musica oggettiva» e il suo «catastrofismo
tecnologico».
L’artista russo pensa i musicisti e i loro strumenti come
parti di un oggetto monolitico, impegnati a suonare
‘tutti’ dall’inizio alla fine,
come un unico meccanismo. Nella sua musica non
c’è maestro né esecutori, c’è
solo un bottone da premere
per far partire una macchina
in grado di suonare la complessità non robotica dell’anima. Concetti difficili e
semplici allo stesso tempo.
Oggi viviamo l’era del digitale e della riproduzione infinita di un brano, del premi e scrolla sul mouse, nelle molteplici forme del remastering e del mixaggio, ma oltre
all’aspetto tecnico e tecnologico c’è assolutamente una
dimensione spirituale che subisce un’accelerazione eccezionale. Diceva Kourliandski: «Un oggetto trasferito dal
mondo materiale allo spazio artistico diventa un’immagine,
da vedere o da ascoltare, esattamente come la pipa di
Magritte non è assolutamente una pipa». Una macchina
non è una macchina, quindi, un robot non è un robot, un
uomo non è un uomo, ma tutti insieme sono dei suoni e suonano. Un punto di vista non significativamente definitivo,
ma segnato dal senso transitorio di una dimensione musicale temporanea e caratterizzata dall’esigenza e dal caso, una
‘situazione’ tipica dell’Orchestra J Futura.
Un compito per molti sicuramente ingrato, ma per tanti
altri davvero imperdibile, ricco di bizzarrie filosofiche, tecnologiche, poetiche, musicali e artistiche. Qui si è ritrovata
e ha incantato l’Orchestra J Futura, composta da giovani di
età compresa tra i 18 e i 30 anni. ‘J’ sta per Jeunesse, Junior,
Juventud, ma anche Joy, Jump, Joke, Juego, e rappresenta
un modo per rapportarsi al mondo, agli altri e alla vita attraverso un complesso di idee portatrici di grande versatilità
stilistica ed esecutiva. Le stesse da cui discende la sensibilità artistica e la caparbietà imprenditoriale di Paola Stelzer,
fondatrice dell’Orchestra, accompagnata in quest’avventura
dal direttore artistico e co-fondatore Maurizio Dini Ciacci.
‘Futura’, infine, sta proprio per tutto ciò che ancora avremo modo di aspettarci dal mondo della musica ‘colta’ in
trasformazione digitale ed espressiva irreversibile.
Il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste
e la New World Symphony di Miami, collegatisi
in streaming con le istituzioni musicali del Texas, di Seattle,
di Yale e di Barcellona, hanno dimostrato l’efficacia
dei nuovi sistemi EchoDamp e Lola sulla trasmissione sonora
di Flavio Fabbri
U
na grande opportunità per
quanti sono coinvolti nella
produzione di eventi artistici e musicali, una grande speranza per i molti che stanno faticosamente emergendo dall’anonimato e
che vedono nel progresso tecnologico dei prossimi anni una reale
chance professionale. Ad alimentare questo bagaglio di aspettative è
stato il Garr, l’Associazione che
gestisce
la
Rete
Italiana
dell’Università e della Ricerca che,
in un incontro (il «TerenaInternet2-Garr: Performing Arts
Production Workshop») tenuto
presso il Conservatorio di Musica
Giuseppe Tartini di Trieste, ha presentato al pubblico due novità tecnologiche importanti - EchoDamp
e Lola (LOw LAtency audio visual
streaming system) - che consentono la prima di controllare l’audio e
l’eco in modo integrato e digitalizzato; la seconda di ottenere flussi
streaming audiovisivi ad alta definizione, con latenze infinitesimali
tali da garantire performance musicali e artistiche di qualità mai raggiunta prima.
Fino ad oggi per due musicisti
che avessero voluto esibirsi da
‘luoghi’ diversi, ma in una stessa
esecuzione musicale, non c’era
altra via se non la tecnologia Dvts,
che permetteva interazioni multimediali e video a lunghe distanze,
ma con latenze enormi dell’ordine
di 400 millisecondi. Oggi, con
Lola, si può scendere a 30 millisecondi, su distanze di centinaia di
chilometri. Praticamente suonare
insieme essendo fisicamente lontani, molto lontani. «Un sogno nato
nel 2005, assistendo alla prima
MasterClass intercontinentale alla
Conferenza Garr e oggi finalmente
realizzato
qui
dal
nostro
Conservatorio», ha dichiarato
Massimo Parovel, direttore del
Conservatorio di Musica di Trieste.
L’utilizzo di EchoDamp, unitamente alla piattaforma Lola, consente un processo d’integrazione
delle funzioni di un singolo computer, equivalente oggi alle costose
e complesse apparecchiature per
gestione audio di una sala concerto
o di un intero teatro, in grado di eliminare echi ed effetti indesiderati
che le lunghe distanze sulla rete
causano nella gestione dell’audio.
Per meglio calarsi nella dimensione digitale e multimediale del convegno sono stati effettuati diversi
collegamenti streaming con elevatissima capacità di banda tra il
Conservatorio di Musica G. Tartini
e gli Stati Uniti: due dimostrazioni
con la New World Symphony
(NWS) di Miami, una con la TCU
School of Music del Texas e la
Washington University di Seattle,
un’altra con la Yale School of
Music e un’altra ancora con il
Grand Teatre del Liceu di
Barcellona, durante le quali i partecipanti hanno avuto l’occasione di
ascoltare in altissima qualità brevi
performance eseguite da archi, pianoforte e fagotto, oltre a qualche
minuto dell’opera La Cenerentola
di Gioachino Rossini.
Il Garr è stata la prima rete europea dell’Università e della Ricerca
a collaborare in quest’ambito con
Internet2, consorzio non-profit di
207 tra università, imprese e fondazioni, che sviluppa tecnologie e
applicazioni avanzate per la rete e
per trasferimenti ad alta velocità
negli Usa. L’idea animatrice e la
speranza latente di questa prima
edizione europea è stata quella di
immaginare la nascita di una
comunità più ampia di utenti e artisti, che possa beneficiare dello
scambio di esperienze e costruire
nuove e più strette collaborazioni
tra i protagonisti del settore musicale e, più in generale, delle arti
espressive in Europa. La tecnologia
viene qui a mostrarsi come possibilità e opportunità di fare musica,
buona musica, senza limiti geografici e temporali, grazie a piattaforme digitali di alta qualità, diffuse,
orizzontali, culturalmente ‘open
source’, effettivamente aperte a
nuove soluzioni ed applicazioni, in
cui le prossime generazioni possano affacciarsi concretamente.
BEY&further
OND
a cura di ROMINA CIUFFA
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
GIANLUCA PELLERITO Ha 15 anni,
una batteria, nell’iPod la scaletta del suo
prossimo concerto e un po’ di Frank Sinatra
NAKED MUSICIANS Sono folli
creatori rapiti dalla lucida forza
emotiva di un collettivo siciliano
a cura di NICOLA CIRILLO
! CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA
LITTLE DRUMMER BOY
(...) G
ianluca Pellerito si prepara a diventare la nuova stella italiana del jazz. Un adolescente, con amici così,
a ricreazione pensa al futuro in modo diverso dai
suoi coetanei. Tra i prodigi, come lui, oggi c’è lo sbalorditivo e
altrettanto piccolo Igor Falecki, polacco di 6 anni, i cui video già da
qualche anno popolano la rete; ieri c’era il pugliese Michelino Uli,
che a 4 anni debuttava in un live al Kandysky di Foggia con un
grande solo di batteria. Ma ora, davanti a noi, c’è Pellerito.
Gianluca, la tua biografia ufficiale dice che suoni da quando
avevi 4 anni. Ci spieghi come è accaduto?
È stata un’enorme fortuna. Mi sono ritrovato in casa la batteria di
mio padre, che suonava da autodidatta. È cominciata così. A 8 anni
ho partecipato alla Berklee Summer School at Umbria Jazz Clinics
e sono entrato nel circuito del Berklee College of Music di Boston.
Quando sono tornato a Palermo, a 10 anni, alla scuola di musica
internazionale mi hanno accolto a braccia aperte.
I tuoi genitori sono musicisti?
No, mio padre suonava la batteria solo da autodidatta. Mia madre
ascolta tanta musica da sempre, e la mia sorellina più piccola balla
da quando aveva 5 anni. Ora ne ha 10.
Che genere si ascolta in casa?
Funk, jazz e latin. Io preferisco la latin e la funk, ma da quando
sono andato alla Berklee ho cominciato ad apprezzare il jazz, che
è la madre di tutti gli altri generi. Io non sono pop e non sono rock.
Il rock non lo apprezzo, il metal neanche: è pesante e non ho
pazienza nell’ascoltarlo.
La tua popolarità sta crescendo. Forse anche grazie alla tua
presenza nella trasmissione di Fiorello.
È stata l’esperienza più bella della mia vita, grazie alla quale ho
conosciuto Michael Rosen, una persona fantastica, un grande
musicista e un amico. Ed ora anche il mio direttore artistico.
Chi sono i tuoi fan e cosa ti chiedono?
Molti coetanei. Un commento che mi ha colpito, pubblicato di
recente su un social network, diceva: «Non smettere mai di suonare». Non me lo aveva mai detto nessuno. Per ora nessun feedback
Pa rum pum pum pum.
Gianluca Pellerito è un piccolo tamburino,
a soli 15 anni si è già esibito a New York e,
per la ricreazione, ha amici davvero «grandi».
Quando «play» vuol dire davvero due cose
negativo: temo commenti
non veritieri. Un po’ me la
prenderei. Penso di essere
umile: a scuola non si parla
mai della mia attività musicale, anche se tutti lo sanno
e fanno il tifo per me.
Cosa studi?
Secondo anno di liceo
classico. Ho bei voti e le
mie materie preferite sono
storia e italiano.
Come è il rapporto con i
tuoi compagni?
Sono molto «amiciaro»,
come si dice a Palermo. E
questa è una delle poche cose che so in siciliano, che non conosco.
E come vive a Palermo un giovane musicista?
Io ci vivo benissimo. Davvero, non ho nessun tipo di problema.
Credo che Palermo sia una città bellissima, ma non soddisfa tutte
le mie aspirazioni. Vorrei diventare un batterista di livello internazionale e in questo la mia città non può aiutarmi per niente. Dopo
la maturità verrò a Roma, una città che mi piace moltissimo e che
mi dà la possibilità di crescere nella musica. Ci sono molti posti
dove poter studiare bene, poi andrò all’estero.
I tuoi «friends» sono tutti più grandi di te...
Io non ho mai suonato con dei miei coetanei. Proprio mai.
Ti sei mosso spesso per suonare?
Suono soprattutto a Palermo. Certo più grande divento, più le date
crescono e più mi dovrò muovere.
Lo scorso 8 luglio, a New York con il tuo Quartet, sei stato ospite dell’ Istituto Nazionale di Cultura: il più giovane musicista
italiano a suonare a Park Avenue. Vero?
Un grande sogno che si è avverato, perché desideravo vedere la
città. Anche se ho fatto un solo concerto mi sono trattenuto una settimana e mezzo. L’ho presa come una vacanza. Lì ho suonato con
NAKED
IMPR
OVVI
SARE
MUSICIANS
di Luca Bussoletti
Michael Rosen; Giuseppe Milici, grandissimo armonicista; Michael Eknasten al pianoforte e Marco
Panacia al contrabbasso. So che dovrò tornare ma
ancora non so quando. C’è gente che pensa che quando vado via a suonare me ne frego della scuola. Invece
no: quando torno devo studiare il doppio.
Qual è il tuo genere preferito?
Ascolto il mio gruppo preferito, gli Incognito, ma
anche il jazz puro, soprattutto i grandi padri come
Charlie Parker, Duke Ellinghton, Charles Mingus.
Cos’hai ora nel tuo Ipod?
La scaletta del mio prossimo concerto e un po’di Frank
Sinatra. A differenza dei miei coetanei non lo ritengo
un pezzo d’antiquariato. Lo swing è molto piacevole.
Quali sono i tuoi modelli, chi ammiri?
Peter Erskine, uno dei miei batteristi preferiti; con lui
ho suonato il 31 luglio al Teatro di Verdura di Palermo nel «Three
Drums Show», accompagnati dall’Orchestra della Fondazione The
Brass Group. Il terzo «drum» era Alex Acuna: di lui mi affascina la
capacità di poter suonare benissimo sia la batteria che le percussioni. È una cosa che piacerebbe poter fare anche a me. Ci sono
altri due batteristi che adoro: Dave Weckl e Steve Gadd.
Se non avessi trovato una batteria in casa, cosa avresti suonato?
Per il momento penso solo alla batteria. Sicuramente non la tastiera, anche se la studio per una formazione a livello personale.
L’unico strumento che mi potrebbe attirare adesso è il sassofono.
Cosa hai sacrificato per la musica?
Niente. Forse un po’ di gioco, ma la musica per me è anche gioco.
A cosa pensi prima di salire sul palco?
La cosa che faccio sempre è il segno della croce. Può sembrare
strano ma è vero. Sono cattolico e credente e prego sempre che il
Signore mi accompagni. È una cosa che faccio da sempre.
Proprio come nel popolare canto natalizio, quando il little drummer boy, povero e senza doni, decide di regalare al suo piccolo Dio
un concerto. E quegli gli sorride: a lui e al tamburino.
CARMINE TORCHIA
Naked perché sono corpi, poliformi, aperti, porosi, bianchi, neri, rossi e gialli.
Tutta carne da macello e del perché è impossibile che l’uomo sia atterrato sulla Luna
C
BARBONE
Quella che sembra la degenerazione
di un artista in barbonaggio
è in realtà il ritorno fulgido
all’essenza reale di questo mestiere
di Flavio Fabbri
i sono tanti modi di dare nome a un buon
disco, ma ‘Carne da cavallo’ è più una definizione che un semplice titolo. I Naked
Musicians, d’altronde, non sono un gruppo
musicale tradizionale, o per meglio dire normale, visto che nel nome che hanno scelto si fondono tradizioni lontane, metafore accattivanti e
sapori antichi della terra di Sicilia. Naked?
Perché sono corpi, poliformi, aperti, porosi,
bianchi, neri, rossi, gialli. Vivi come il sangue,
la luce, il sole, la terra e la carne degli emisferi
meridionali del mondo.
L’uscita del loro terzo lavoro, Emiliano
Culastrisce, ne è stata la dimostrazione antropologica ed etnomusicale di come all’evoluzione
delle idee segue necessariamente la trasformazione della musica e la trasposizione di un concetto di arte, da verticale a orizzontale, da chiuso ad aperto, da selettivo a contaminato.
Il gruppo di artisti, prodotti dalla vivace etichetta siciliana Improvvisatore Involontario
che conta ormai oltre 30 membri tra Roma,
Bologna, Venezia, Udine, Parigi e New York,
ha scelto inequivocabilmente la strada dell’improvvisazione e della performance teatralmusicale certamente, ma nel delirio delle percezioni visive, uditive e cromatiche del corpo
improvvisatore che si agita tra scrittura, lettura, musica, design, video e fotografia.
Un fronte ‘teatral-visual-performativo di
jazzisti rinomati e rocker rampanti, disturbatori d’ogni sorta e voci angeliche’ (si definiscono), in cui la musica si assaggia come fosse
CARMINE TORCHIA Piazze
d’Italia Il diario di una strampalata discesa nell’Ade della musica
carne di cavallo, da macello anche, esposta al
pubblico, che si narra, si fa notizia, luce,
immagine, urgenza comunicativa.
Un lavoro che segue i precedenti A sicilian
way of cooking mind (2004) e Antivatican
Coalition against the Hippies Resistance
(2008), che vede ancora il poliedrico batterista-compositore-presidente-fondatore
Francesco Cusa dirigere 24 musicisti senza
partitura o note, in preda all’improvvisatore
esaltato, lanciati in un progetto originalissimo
e avanguardista: una conduction: «Un sistema
non convenzionale di direzione semiotica in
cui si utilizzano dei simboli appositamente
creati», un piano espressivo dettato direttamente da uno sguardo destro derivato dalla
tradizione jazzistica e uno sinistro da quella
cameristica e colta.
Si dice «free jazz», ma è fatto anche con
violoncello, clarinetto, pianoforte, tromba,
contrabbasso, viola, chitarra e se non bastasse
ci sono anche gli electric live, i videosaxophonics e i visuals. Ci sono Biagio Guerrera,
Riccardo Pittau, Mauro Schiavone, Carlo
Natoli, Toni e Carlo Cattaneo, Maurizio
Morello e tanti altri artisti-musicisti, che non
sono (solo) dei folli, ma creatori e innovatori
rapiti dalla lucida forza emotiva di un collettivo siciliano entrato a far parte della grande
famiglia dell’Improvvisatore Involontario,
uno degli attori più interessanti della scena
delle etichette e dei collettivi indipendenti italiani. Giustappunto, nessuno di prevedibile.
S
e non v’interessa morire di televoto
e pochi mesi dopo morire artisticamente, vuol dire che forse ancora
credete nel peso delle canzoni originali.
Sicuramente crede nelle sue creazioni
Carmine Torchia, artista che dal
MySpace ha iniziato un lungo viaggio di
note che lo ha fatto passare dai click da
social-network ai la maggiore dei concerti.
Il cantautore calabrese è d’animo nobile e
i suoi brani ne sono uno specchio pulito.
C’è gentilezza e ricercatezza. Non c’è
voglia di urlare né di apparire. È evidente da subito che il percorso promozionale per dare un senso alla sua carriera
debba essere altro da quello che predilige
la major. Spenta la tivù Carmine accende
il computer. Fino a qui è storia di molti.
Il risvolto degno di nota, però, è che
poi anche il computer si spegne magicamente. Forte di un pubblico creato attraverso la rete, il pescatore Torchia infila i
piedi nell’acqua per toccare con mano i
pesci finiti nella sua tonnara dolce. Non
c’è sangue però, ma l’amore della gente
che esce di casa e si infila nei piccoli locali di tutta Italia per ascoltare dal vivo
Trema la foglia e tu e L’astrologo. Ma non
basta. Il cacciatore imbraccia un fucile a 6
corde e si getta nella savana. Non a bordo
di una jeep ma con i treni, non tra i baobab del Kenya ma nelle piazze nostrane. Apre la custodia della chitarra e
canta. La gente si ferma e si stupisce. E
gli compra i dischi. Con la cacciagione
della giornata ci si paga un albergo e da
mangiare e via verso una nuova città.
È una scelta atavica, quasi nostalgica,
ma allo stesso tempo moderna e coraggiosa. Carmine Torchia tiene un diario
di questa strampalata discesa nell’Ade
della musica: Piazze d’Italia consente a
tutti di scoprire che quella che a molti
sembra la degenerazione di un artista in
barbonaggio è in realtà il ritorno fulgido all’essenza reale di questo mestiere.
In fondo scriviamo canzoni e le cantiamo in giro. Nulla di più. «Ho compreso che quando non si muovono le cose intorno a te, devi muoverle tu», commenta il
musico nel frontespizio del libro. Così il
Maometto Carmine ha girato nelle sue
scarpe su e giù per la penisola (o montagna, se vogliamo rimanere nella metafora) e nel frattempo ha scritto, ha disegnato, ha studiato, ha vissuto.
Ora è tornato a casa e forse il computer lo riaccenderà, ma con la dimostrazione pratica - messa su carta stampata
- che il pubblico che si crea attraverso il
web, se coltivato con i concerti, è un
pubblico reale. Più reale di chi preferisce schierarsi con la squadra blu o con
quella rossa pur di non uscire dalle
quattro mura della propria sicurissima
prigione... scusate, volevo dire casa.
TRAINING
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
COORDINAMENTO NAZIONALE PER L’ALTA FORMAZIONE MUSICALE Sta per MICHEL AUDISSO Docet
nascere la TAV della didattica della musica jazz, una linea ad alta velocità con tappe: Civici Corsi Parigi, Verona, Roma, Brindisi,
a passo di danza e sax
di Jazz di Milano - Fondazione Siena Jazz - Saint Louis College of Music di Roma e Brindisi.
LATAVDELJAZZ
DI
MICHELAUDISSO SECONDA PELLE
PAOLO ROMANO
In Europa si sta definendo l’impianto didattico dell’Alta formazione musicale e, con esso,
quello inerente il Jazz. Un sistema di curricula didattici leggibili e comparabili, processi di
verifica e percorsi formativi trasparenti e svolti nella piena condivisione dei risultati di apprendimento attesi, tra l’altro, sono necessari per creare standard riconoscibili e misurabili. A ciò
sono particolarmente attente tre istituzioni private: il Saint Louis College of Music di Roma,
i Civici Corsi di Jazz di Milano e la Fondazione Siena Jazz, che oggi creano il Coordinamento
nazionale delle Scuole dell’Alta formazione jazzistica. E chi c’è, c’è. A Faenza, Palazzo delle
Esposizioni, venerdì 27 novembre 2009, la Jazz Convention «L’Alta Formazione Jazzistica
nelle Istituzioni pubbliche e private in Italia: obiettivi comuni e collaborazioni».
A
a cura di ROBERTA MASTRUZZI
lle 10.10 di una tiepida mattina romana d’ottobre un’agenzia di stampa che recita nel
titolo «Il meeting degli indipendenti apre al
Jazz» scuote il vostro annoiato redattore, che
ancora impigrito la legge, quella e le altre che di
là a pochi minuti inizieranno a tamburellare sul
monitor. Niente male: la notizia, per una volta,
c’è ed è di quelle di cui è bene parlare, di quelle di cui c’è, in qualche misura, bisogno.
Approfondisco un po’ ed eccoci a raccontarlo ai
nostri lettori. Di che si tratta?
Sta per nascere, per così dire, la TAV della
didattica della musica jazz, una linea ad alta
velocità che parte dai Civici Corsi di Jazz di
Milano, passa per la Fondazione Siena Jazz e
arriva a Roma al Saint Louis College of
Music. E mentre parte l’alta velocità di alcuni
dei più prestigiosi istituti di formazione jazzistica nazionale già dotatisi delle adeguate «infrastrutture»,
i
pachidermici
benemeriti
Conservatori (ingessati in una soffocante burocrazia autoreferenziale e in programmi che per
vetustà annoierebbero Orlando di Lasso) continuano felici a viaggiare sullo scarto ridotto,
accumulando ritardi davvero imperdonabili e
chiusure a stento giustificabili.
Un po’ di storia: dieci anni fa a Bologna si
incontrarono ben 29 ministri e dirigenti dell’istruzione da tutta Europa; definirono un percorso attraverso il quale armonizzare i sistemi
di istruzione superiore, spesso disomogenei tra
loro, e arrivare alla creazione di uno standard
qualitativamente misurabile attraverso il quale
agevolare lo scambio culturale, la formazione e
i percorsi di accesso alle professioni. La musicale compresa. Provate a indovinare qual’era la
nazione con il maggior deficit da recuperare per
varietà dell’offerta formativa, programmi e cicli
di studio in tutta Europa? No, non era la
Grecia... poveri noi.
Insomma, queste linee guide, filtrate poi nel
gergo comune come Dichiarazione di Bologna
e ancora parzialmente ignorate dai tanti governi che si sono succeduti (è sempre bene non
investire denari pubblici per progetti solidi di
formazione superiore, o no?), hanno costituito
il preambolo perché i tre suddetti istituti italiani promuovessero tra loro un «Coordinamento
nazionale delle Scuole dell’Alta formazione
jazzistica».
Il Coordinamento ha individuato da subito
dei princìpi e delle linee guida chiare ed inequivoche per consentire, previa presentazione dei
requisiti richiesti, l’adesione di altri istituti
dello stesso genere. Come dire, un protocollo
ISO con obiettivo la realizzazione di programmi didattici condivisi e comparabili per conseguire l’eccellenza degli studenti, l’interscambio
professionale dei giovani musicisti diplomati
presso le istituzioni facenti parte del coordina-
mento stesso e la creazione di uno schema formativo utile ad individuare il riconoscimento di
titoli congiunti fra gli associati.
Detto fuor di tecnicismi, con poca diplomazia
e un tocco di politica: si verrà a formare una
importante lobby (uh, che scandalo, le lobbies
che nel mondo anglosassone sono addirittura
agevolate e favorite dalla legge) che porrà le
fondamenta per un riconoscimento, anche normativo, degli istituti d’eccellenza nella formazione musicale jazzistica.
E il panorama che si va delineando, senza il
bisogno di essere delle grandi «cassandre» di
predittività, è quello di una progressiva erosione dell’autorità formativa dei Conservatori che,
a forza di non voler volgere lo sguardo alla realtà dei fatti, resteranno chiusi nella loro caverna
baronale, mentre opportunamente i risultati
conseguiti e tangibili delle istituzioni del
Coordinamento offriranno un solido percorso di
avviamento professionale ai giovani e talentuosi musicisti (che si suderanno un diploma degno
per davvero degli standard anglosassoni ed
internazionali).
Ed ecco perché l’alta velocità è già partita e
non nasce come un fenomeno «contro», ma nel
segno opposto della progettualità. Effetto: chi
fino ad oggi il dialogo l’ha rifiutato rischia di
trovarsi inesorabilmente al palo a stretto giro di
posta. Basta scorrere i princìpi costituenti del
Coordinamento nazionale per accorgersi quanto
il progetto sia strutturato: anche solo da un
punto di vista logistico gli istituti che vorranno
entrare a far parte di questo nuovo «sistema
didattico formativo» dovranno (oltre ad avere
tutte le certificazioni di agibilità lato sensu prescritte dalla legge) impiegare un corpo docente
qualificato, avere la disponibilità di strutture
qualificate predisposte specificamente per la
musica jazz e fornire, di conseguenza, tutta la
strumentazione idonea per il corretto svolgimento dei corsi jazz e soprattutto dovranno uniformarsi agli stardard qualitativi di verifica delle
competenze e abilità d’ingresso e di uscita dei
propri allievi.
Il Saint Louis College of Music, la Fondazione
Siena Jazz ed i Civici Corsi di Milano raccolgono una sfida importantissima, alla quale si sono
andati preparando nel corso degli anni da un lato
maturando un’esperienza preziosa nel settore
della didattica jazz, dall’altro soffrendo tutti gli
effetti distorsivi legati alla difficoltà tutta italiana
di fare impresa, vuoi per la nefasta congiuntura
economica di medio-lungo periodo vuoi per la
giungla normativa ed impositiva vigente.
La buona, edificante notizia, allora, è la
seguente: in questo Paese c’è ancora qualcuno
che crede che investire nella formazione e
nella cultura può essere una gran buona idea.
E non lo dice solo, lo fa.
a cura di
Rossella Gaudenzi
il
privilegio di inaugurare la Stagione di
Balletto 2009-2010 della Fondazione
Arena di Verona spetta quest’anno a
Michel Audisso, autore delle musiche della
nuova produzione Seconda Pelle del coreografo
canadese di origine haitiana Hans Camille
Vancol, in scena il 7, 8, 13, 14 e 15 novembre al
Teatro Filarmonico. Polistrumentista e compositore francese residente in Italia da quasi 30
anni, vanta un’esperienza musicale diversificata:
jazz, musica leggera, spettacoli teatrali e danza
contemporanea. Fa da tempo parte del corpo
docente del Saint Louis di Roma come coordinatore della sezione fiati, docente di sax e direttore
della promettente, neonata, Marching Band.
«Non conoscevo personalmente Hans Camille
Vancol; mi ha contattato dopo aver apprezzato il
disco del 2004 Petits Voyages del gruppo che
dirigo, Escaping Strings, in cui un quintetto jazz
e un quintetto d’archi si affiancano in un connubio di jazz, musica classica e sonorità elettroniche. Nel dicembre 2008 mi ha proposto di comporre le musiche per un balletto da rappresentare nel giugno 2009. Baudelaire e Les Fleurs du
Mal, erano l’idea originaria, ho inizialmente
ricevuto delle poesie della raccolta; poi mi sono
concentrato sulla suddivisione del balletto in tre
atti: mattino, pomeriggio e sera».
Michel inizia a lavorare; poi incontra a Verona
il coreografo per definire due temi fondamenta-
li ricorrenti nell’opera, di vaga ispirazione
all’Amélie di Yann Tiersen. I musicisti scelti
sono quelli degli Escaping Strings, il sound
degli archi è adatto al genere balletto. La conferma dell’Arena di Verona arriva in estate.
L’impronta al balletto viene data dalle musiche
composte da Michel Audisso. Ha avuto quasi
carta bianca, poche linee guida: qualche indicazione sulla durata e sulla ritmica. Ma l’esperienza del compositore legata alla danza ha
radici remote.
«Lavoro a contatto con la danza dal 1978,
quando a Parigi muovevo i primi passi in duo
con un amico ballerino -sax e danza-. Un paio
di anni dopo ho collaborato con la bravissima
Karine Saporta, divenuta celebre nella danza
contemporanea. L’arrivo in Italia è legato
soprattutto al jazz, ma al 1983 risale l’importante collaborazione con Virgilio Sieni. Nel
1995 torno a far parte delle orchestre, per 10
anni accanto alla compagnia di Aurelio Gatti
(La Fabula di Orfeo, Tango Eros, L’Orfeo dei
Pazzi). Oggi compongo per l’Arena di Verona:
una prova inattesa intensa e gratificante».
Seguirà a breve la produzione del disco delle
musiche del balletto Seconda Pelle, registrate
presso il Saint Louis Recording Studio per l’etichetta Saint Louis Collection. Un nuovo genere
per l’etichetta, quello della musica per balletto,
che va ad ampliare un catalogo già in crescita.
JAZZ
CONTEST
I TALENTI
VANNO PREMIATI
I
talenti vanno premiati. E quale miglior riconoscimento può ricevere un musicista che
non sia quello di suonare su un palco?
Questa è la filosofia che fin dalla sua prima edizione nel 2008 ha ispirato il Jazz Contest, concorso per giovani jazzisti organizzato dal Saint
Louis College of Music. È per questo che i vincitori hanno avuto sempre più di un’occasione
per farsi notare. La prossima? L’European Jazz
Expo di Cagliari, che quest’anno premia la carriera di un ospite d’onore, Enrico Rava, e ascolta esibirsi (il 22 novembre) Laura Lala e il suo
quartetto, vincitrice del Jazz Contest 2008, e gli
Ipocontrio, freschi di «incoronazione» al
Festival estivo di Atina Jazz.
Il meccanismo del concorso musicale è semplice: l’iscrizione è gratuita e aperta a tutti quegli
artisti portatori di un progetto musicale originale
in stile jazzistico. Le selezioni avvengono durante serate nei locali romani - nell’ultima edizione
sono stati ospitati dal Bebop Jazz Club di Roma,
ma per la prossima edizione si prevede una fase
eliminatoria in quattro città (Roma, Milano,
Siena, Brindisi), per dare più spazio ai gruppi
provenienti da tutta Italia - e arrivano alla fase
finale i gruppi selezionati da una giuria tecnica
formata da musicisti come Enzo Pietropaoli,
Maurizio Giammarco, Paolo Damiani, Bruno
Biriaco e giornalisti specializzati, come la storica penna di Adriano Mazzoletti. Al concerto
finale che si svolge nell’ambito dell’Atina Jazz
Festival accede anche il gruppo più votato dalla
giuria popolare, ovvero il pubblico presente alle
varie serate nei locali. Il premio per il vincitore
consiste nella possibilità di pubblicare un cd per
l’etichetta Saint Louis Jazz Collection e in un
contratto di management per un anno con l’opportunità di partecipare ad alcune tra le più
importanti manifestazioni jazzistiche.
Il Laura Lala Quartet è in studio per ultimare
le registrazioni di Pure Songs, dodici composizioni originali incise con la partecipazione straordinaria al piano di Salvatore Bonafede. Gli
Ipocontrio, trio salernitano formato da Bruno
Salicone al piano, Franceseo Galatro al contrabbasso e Armando Luongo alla batteria, sarà
invece impegnato in una serie di concerti che
culmineranno nella partecipazione al concerto
finale presso il Teatro comunale di Cassino nell’ambito dell’Atina Jazz Festival 2010.
Il Jazz Contest non si ferma qui: per la prossima edizione prevede di allargare letteralmente le
sue frontiere, coinvolgendo nel concorso artisti e
festival europei, per dare alla competizione un
respiro assolutamente internazionale, come si
addice a chi è talentuoso. (Roberta Mastruzzi)
speciale
1968
a cura di ROMINA CIUFFA
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
MANGIAR LA FOGLIA In questo contesto nacque il movimento «hippy», parola JOHNNY È il Sessantotto, taciturno in
gergale che stava a significare «uno che ha mangiato la foglia», in seguito ribattezzato un lucido silenzio riflessivo, perché cono«figlio dei fiori». Si distinse per costumi liberali e ampio uso di droghe, soprattutto LSD. sce il futuro e non glielo fanno dire
! CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA
di ADRIANO MAZZOLETTI
di ATTILIO FONTANA e ROMINA CIUFFA
HAMANGIATO68FOGLIE
Il «nostro ‘68» arriverà tardi. Solo negli anni Settanta quando, sotto la spinta politica dell’estrema sinistra, inizieranno le
contestazioni ai grandi del jazz classico. Count Basie, Duke Ellington, Stan Getz, furono accusati di «fascismo» e d’esser
«servi della Cia» da alcuni fra i più accaniti contestatori che frequentavano Umbria Jazz. La quale fu sospesa per tre anni.
(...)
D
iffusa in buona parte del mondo, dall’Occidente
all’Est comunista, la contestazione generale ebbe
come nemico comune il principio dell’autorità.
Nelle scuole gli studenti contestavano i professori, la cultura ufficiale e il sistema scolastico classista. Nelle fabbriche gli operai rifiutavano l’organizzazione del lavoro e i principi dello sviluppo, che mettevano in primo piano il profitto
a scapito dell’elemento umano. In famiglia veniva contestata l’autorità dei genitori. Facevano esordio nuovi movimenti che mettevano in
discussione le discriminazioni di sesso e di razza. Gli obiettivi comuni
dei diversi movimenti erano il principio di uguaglianza, il rinnovamento della politica in nome della partecipazione di tutti alle decisioni,
l’eliminazione di ogni forma di oppressione sociale e di discriminazione e l’estirpazione della guerra.
Negli Stati Uniti già negli anni 50 era venuto maturando un movimento nero per l’eguaglianza, promosso dalle comunità di colore.
Uno dei momenti più significativi fu il boicottaggio nel 1955 degli
autobus di Montgomery (Alabama) per protesta contro la segregazione razziale. Anche gli studenti bianchi del Nord affiancarono le
proprie proteste alla popolazione di colore. Le battaglie per il riconoscimento dei diritti civili ai neri si dividevano in due filoni: il
primo, pacifista, auspicava la progressiva integrazione delle masse
di colore nella società bianca; era guidato da Martin Luther King,
apostolo della «non violenza», che si era dedicato alla lotta contro la
discriminazione razziale. Il suo celebre discorso, «I have a dream»,
in cui auspicava l’uguaglianza tra i popoli, scatenò un’ondata di proteste e di violenze, culminate nel suo assassinio nel 1968.
Il secondo, più intransigente, fu quello delle Black Panther, che
chiedevano la formazione di un potere contrapposto a quello dei bianchi, libertà e occupazione, case e istruzione per tutti, la fine delle
oppressioni verso le minoranze etniche. Il movimento era guidato da
Angela Davis, Elridge Cleaver e Malcolm X, che preferì cancellare il
suo cognome americano «Little» sostituendolo con una «X». Era propenso ad un’alleanza tra tutti i popoli neri e lottava per la superiorità
razziale del proprio. Dopo un viaggio in Egitto ed Arabia Saudita rinnegò le sue teorie e disse che «esistevano dei bianchi sinceri» e che
era «amico di buddisti, cristiani, indù, agnostici, atei, bianchi, neri,
gialli, marroni, capitalisti, comunisti, socialisti, estremisti e moderati». Morì nel 1965 assassinato da tre membri della Nation of Islam.
Negli Stati Uniti le lotte si polarizzarono contro la guerra del
Vietnam, assumendo la forma di un conflitto antimperialista. Essa,
iniziata nella prima parte degli anni 60, cambiò il modo di guardare
l’America. In questo contesto nacque il movimento «hippy», parola
gergale che stava a significare «uno che ha mangiato la foglia», in
seguito ribattezzato «figlio dei fiori». Si distinse per costumi liberali
e ampio uso di droghe, soprattutto LSD, un allucinogeno di cui si
teorizzavano le doti di espansione della mente.
Gli elementi di novità erano molteplici. Innanzitutto era ritenuto
importante il riferimento alle lotte dei popoli del terzo mondo e alla
rivoluzione cubana. Una situazione diversa si stava verificando,
invece, nei Paesi del Patto di Varsavia. Le manifestazioni chiedevano maggiore libertà; la più alta fra di esse fu la rivolta studentesca in
Cecoslovacchia, che condusse alla Primavera di Praga. La presenza
di giovani operai a fianco degli studenti fu la caratteristica del
Sessantotto italiano, il più ampio con quello francese tra tutti quelli
dell’Europa occidentale. In Italia la contestazione era il risultato di
un malessere sociale, accumulato negli anni Sessanta e dovuto al
fatto che il boom economico non era stato accompagnato da un adeguato aumento del livello sociale ed economico della classe operaia.
La contestazione negli anni Settanta degenerò in seguito negli «anni
di piombo» che culminarono con il rapimento e l’assassinio di Aldo
Moro da parte delle Brigate Rosse.
Il jazz in quanto tale inizialmente non venne influenzato da quel
movimento. La sua «rivoluzione» l’aveva già vissuta anni prima con
Miles Davis e John Coltrane, Ornette Coleman e Don Cherry i cui
importanti lavori: Kind of Blue, Something Else e Tomorrow is a
Question furono pubblicati, suscitando perplessità, ma anche grande
interesse, nel 1958 e ‘59. Negli Stati Uniti nel 1968 gli avvenimenti
più significativi furono invece la creazione della World Greatest Jazz
Band, un’orchestra che annoverava al suo interno alcuni fra i migliori esponenti del jazz classico di Chicago e New York, la nascita del
quartetto della tromba Chuck Mangione, l’unione fra Gerry Mulligan
e Dave Brubeck, la nuova Reunion Band di Dizzy Gillespie, ma
soprattutto la cosiddetta «svolta elettrica» di Miles Davis, mentre
Don Cherry, abbandonato Ornette Coleman, iniziava a collaborare
con il pianista sud-africano Dollar Brand, che in seguito assumerà il
nome musulmano di Abdullah Ibrahim.
Se negli Stati Uniti il jazz alla fine degli anni Cinquanta sembrava
non aver ancor assunto connotazioni politiche, alcuni musicisti avevano però preso coscienza dell’annoso problema dei diritti civili e
contribuirono alla lotta dei neri per la conquista della parità. I più
sensibili furono Max Roach, Sonny Rollins e Charles Mingus che
crearono composizioni dedicate al movimento. Fra le molte Original
Fables of Faubus che Mingus indirizzò al governatore razzista
dell’Arkansas, oppure Freedom Suite incisa da Sonny Rollins nel
1958. Fu però il mondo della canzone a prendere posizione con i
maggiori interpreti del pacifismo e della solidarietà tra i popoli, Joan
Baez e Bob Dylan.
In Italia dal punto di vista musicale, le prime tracce della ribellione appaiono nel 1966, quando Franco Migliacci e Mauro Lusini
scrissero C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling
Stones, cantata da Gianni Morandi, anche se per quanto riguarda il
cantante bolognese la sua avventura «politica» terminò presto perché
scoraggiata soprattutto dalla Rai, la cui censura finì con l’abbattersi
JOHNNY
SULLA LUNA
COS’È «’68 ITALIAN ROCK MUSICAL»?
inesorabilmente sul testo. Ma la canzone di Migliacci fu ripresa da
Joan Baez che ne fece un vero e proprio inno alla pace. Altre canzoni cosiddette «di protesta» vennero composte e cantate da Lucio
Battisti, Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini e i Nomadi.
Contrariamente alla canzone, il jazz italiano negli anni precedenti al
‘68 non aveva ancora assunto quelle caratteristiche, non solo musicali, che lo avrebbero contraddistinto in ambito europeo.
Il boom economico, con la ritrovata tranquillità che toccò l’apice
all’inizio degli anni Sessanta, coinvolse anche il mondo del jazz che
ottenne vasta popolarità in quanto tale. Il rock’n’roll apparso in Italia
intorno al 1958, quando la RCA iniziò a pubblicare i primi dischi di
Elvis Presley, non influì negativamente sui gusti del pubblico e non
creò soverchi problemi di lavoro ai musicisti. Affondava le radici nel
rhythm’n’blues che molti musicisti italiani conoscevano per averlo
ascoltato e praticato già nel dopoguerra. Little Richard o Fats
Domino, che si trovavano al centro del movimento, erano epigoni
diretti della tradizione del blues nero, dove non mancavano né swing
né improvvisazione. Musicisti jazz come i sax Gabriele Varano e
Paolo Tomelleri, il pianista Nando De Luca non ebbero soverchie
difficoltà ad inserirsi nei gruppi r’n’r di Peppino Di Capri e Adriano
Celentano.
Per contro, quei primi anni Sessanta furono per il jazz italiano un
momento di grande vivacità e affermazione. Tutti «si buttarono alla
scoperta del jazz». Il jazz passò dalle sale da ballo a quelle da concerto ed anche nei night club i musicisti di jazz erano scritturati come
«attrazione». Quando però, verso il 1965, l’Italia fu invasa dalla
musica inglese, dove la tradizione nero-americana e l’improvvisazione erano assenti e lo strumentario era fatto in gran parte di chitarre e
bassi elettrici, i musicisti jazz ebbero meno lavoro. Molti furono
costretti a riciclarsi. Altri si rifugiarono all’estero in attesa di tempi
migliori. Altri entrarono in complessi che accompagnavano cantanti
di gusto e stile più vicini alla loro sensibilità: Bruno Martino, Gino
Paoli, Bruno Lauzi, Mina, Ornella Vanoni o Fred Bongusto. Alcuni
vennero assunti nelle tre orchestre di musica leggera della RAI. Altri
ancora, soprattutto a Roma, lavorarono negli studi per la sincronizzazione delle colonne sonore cinematografiche.
I gusti del pubblico indirizzati verso la musica dei Beatles e dei
loro innumerevoli imitatori, la conseguente scomparsa dei night,
sostituiti da discoteche con musica riprodotta, la massiccia programmazione di musica cosiddetta «beat» alla radio pubblica, causarono
una lenta ma inarrestabile erosione del favore che il jazz aveva ottenuto presso vasti strati di pubblico. Bisognerà attendere i secondi
anni Settanta, con i grandi festival, per vedere nelle nuove generazioni un rinnovato interesse per il jazz. Il «nostro ‘68» arriverà tardi.
Solo negli anni Settanta quando, sotto la spinta politica dell’estrema
sinistra, inizieranno le contestazioni ai grandi del jazz classico.
Count Basie, Duke Ellington, Stan Getz, furono accusati di «fascismo» e d’essere «servi della Cia» da alcuni fra i più accaniti contestatori che frequentavano Umbria Jazz, che fu costretta a sospendere
la manifestazione per tre anni. Ma questa è un’altra storia.
C’è da registrare che nel 1968 alcuni musicisti romani iniziarono,
con un ritardo di almeno dieci anni, ad interessarsi al «free jazz».
L’atteggiamento di forte reazione di questi musicisti causò inizialmente numerosi problemi alla diffusione del jazz presso molti strati
del pubblico. Per quanto riguarda il jazz, il 1968 non fu certo un anno
di grandi cambiamenti come lo furono il 1917, quando i dischi della
Original Dixieland Jazz Band invasero il mondo, il 1935 quando
esplose «l’era dello swing», il 1945 quando si assistette alla nascita
del «bop» o quando nel 1958 e 1959 «il modale» e il «free jazz»
modificarono il linguaggio del jazz.
Innanzitutto un’epoca. I Beatles, Bob
Dylan, Mina, Guccini ed altri poeti. Le nostre
madri e i padri fumatori, le zampe d’elefante
e il rosso politica. Ma anche un musical per
noi, nuovi pezzi, nuovi artisti, vecchie cose da
gridare: vogliamo esser liberi, vogliamo lavorare, vogliamo contestare etc. Lo facciamo
seguendo Johnny, che è il ‘68: un ragazzo al
confine della gravità, con sogni grandi in un
mondo stretto. Voler andare sulla luna prima
ancora di cambiar le cose, far gridare la chitarra oltre il rumore assordante della vita terrestre, dei quiz, della politica e della famiglia
ossessiva, della borghesia e del proletariato, di
professori, dittatori, laureati e notai. Il sogno di
cambiare bastando solo dita su fili di metallo e
un alfabeto sonoro, quello di una musica
nuova. A noi è piaciuto insegnarla, riscriverla,
a noi piace cantarla e ballarla.
Così abbiamo preso Johnny e lo abbiamo
messo in mezzo a un palco, sempre in silenzio,
con una chitarra in mano e i dubbi affissi negli
occhi. Un trascinatore silenzioso, attento alle
masse ma anche disinteressato, un fatalista se
vogliamo, che non reagisce ma che è causa di
reazioni. Johnny non è solo il 1968, ma anche il
2010, il significante di un contenitore che trasporta merce usata, il «visto uno visti tutti»
emblema del cambiamento necessario e di una
rivoluzione stridente che avviene senza coraggio, in cuor proprio, nella rabbia e nello sdegno
presenti quando i tempi devono di nuovo cambiare e non sono solo maturi, ma scaduti.
Oggi che si rimasterizzano i Beatles, proposti
come unica grande zattera della nostalgia sulla
quale salvarsi dal grande naufragio - mentre la
politica sbiadisce, la tv è lo zoo dei padroni, chi
la guarda pecore impazzite e noi tifosi da
acquario - un gruppo di autori, talent scouts,
musicisti, allievi, insegnanti, ballerini, che si
muovono all’interno del Saint Louis College of
Music, ha ripescato il 1968 facendolo specchiare in una scatola a forma di tv, l’embrione di ciò
che siamo diventati: innocenti sognatori di
scene violente, con pretese semplici che le
menti della comunicazione strumentalizzano e
trasformano in irrinunciabili necessità. Uno
spaesato Johnny - in un lucido silenzio musicale - fa da perno a un’umanità confusa mentre
l’atteso mondo «migliore» woodstockiano si
riversa su un mero «bisogno di nostalgia» e sul
senso di frustrazione che aleggia, soprattutto
tra i giovani, sopra la consapevolezza che un
«meglio» c’è già stato e che non ci sia più spazio per l’arte e le forme innocenti di crescita.
È perché abbiamo ancora argomenti che
abbiamo fatto un musical «contromano».
Prodotto e creato da un team di professionisti
dello spettacolo e da una coraggiosa produzione, con un cast di 22 giovanissimi talenti «non»
provenienti da talent show, Sessantotto vuole
divertire, innanzitutto, ma senza cancellare la
facoltà di pensare, rivedere e rivivere un
momento delicato della storia dei nostri cromosomi senza associarla a qualcosa di pesante
o distante. Dopo il successo dell’anteprima,
debutta ufficialmente a Roma, per poi toccare
Milano e partire in tour nazionale.
Così noi siamo un po’ Malcolm X (siamo
ordigni non scoppiati) ma in un animo di artisti (non scoppiamo, cantiamo).
speciale
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
‘68 ITALIAN ROCK MUSICAL Torna al Teatro
Greco, dal 9 al 20 dicembre. Il servizio di MUSIC IN
VIDEO su www.youtube.com/musicinchannel
FRATELLI FONTANA Labicarte è
una piazza monumentale, loro ne sono
la fontana al centro che zampilla talenti
IL MUSICAL
‘68 Recensione Loro sono
stelle e questo cd un salame
Negroni: vuol dire qualità.
Se le fontane richiamano arte,
allora questa famiglia è come
un monumento, a Roma:
un fontanone che zampilla talenti
e arte, un
F ontana
connubio reso
ufficiale dai fratelli
Maria Grazia e Attilio
Fontana al punto da
creare Labicarte, un
luogo dove esercitare
libera creatività senza
l’ossessione di cercare situazioni definitive. «Quant’abbondanza c’è».
Lei, pianista diplomata al Conservatorio di Santa
Cecilia, a soli 13 anni aveva già prestato la voce
per la colonna sonora di Profondo Rosso, capolavoro horror di Dario Argento; una vita dedicata
all’insegnamento, alla tv, al musical, alla scrittu-
www.youtube.com/musicinchannel
D
al 9 al 20 dicembre al Teatro Greco di
Roma replica il 1968. Tornano gli hippies,
l’hashish, i megafoni, la rabbia, il gioco
della sedia, ma soprattutto una musica di qualità.
Il Saint Louis College of Music fa l’en plein di
talenti: Fabrizio Giorgi (Ernesto), Marco Meccoli
(Johnny), Nicole Di Gioacchino (Lauretta), Elena
Allegri (Patty), Francesco Mantuano (Silvio),
Giovanbattista Mazza (armonica) e tutti gli artisti
che hanno frequentato il corso Andiamo in Scena
di Maria Grazia e Attilio Fontana, Franco Ventura,
Michela Andreozzi, Orazio Caiti e Giulio Costa.
Allievi e autori hanno compiuto un miracolo:
rappresentare l’unico musical italiano in cui
tutti sanno cantare, ballare, recitare, interpretare. Ossia dare. Vivere un ‘68 nel 2009. Ricreare
il bianco e nero. Fare un twist. Mangiare una
Dufour, la caramella che ci piace tanto.
Va detto, manca qualcosa rispetto agli altri
musical. Innanzitutto, la spocchia. Gli artisti di
Sessantotto sono ragazzi normali - non piacerà al
mercato nepotistico ed eccentrico delle grandi
produzioni - e, ancor più grave, studiano. Canto,
ballo, recitazione, storia del musical, regia, backside, coreografia, repertorio, vocal ensemble.
Tale dettaglio li colloca totalmente controcorrente ed è destinato a causar loro disagi nello scontrarsi con la preparazione dei colleghi italiani.
Manca il diavolo: non piacerà all’industria
che gli stessi non s’interessino ai reality e non
vendano l’anima alle majors per scrivere, preparare, ultimare, mandare in scena uno dei
migliori spettacoli musicali degli ultimi anni.
Manca la strumentalizzazione: Sessantotto non
pretende di raccontare ciò che accadde allora per
regalarlo alla politica, ma attraversa con obiettività, in un flusso continuo e corale, tutti gli ambiti
che risentirono del cambiamento - famiglia, università, boom economico, fabbrica, scontri con la
polizia, musica, minigonna e Rischiatutto - senza
macchiarsi di significati da asservire ad altri
scopi. Manca la dipendenza, il fine di lucro.
A questo musical, siamo sinceri, manca il
Musical stesso. È la sua salvezza: in un parallelo
troverebbe perfetta collocazione nel circuito offBroadway e consentirebbe all’industria italiana di
esser rivalutata per qualità e meriti dell’investimento privato. Per questi motivi Sessantotto ha,
come il negativo di una foto d’epoca, tutti i requisiti per entrare in una nuova storia, quella in cui i
giovani riprendono, oggi come allora, possesso di
se stessi e delle proprie, frustrate ambizioni.
di Romina Ciuffa
Carosello sostituiva le benzodiazepine, lo zapping furioso, il branco, l’aperitivo alla milanese, i reality, la politica. Il Carosello non
sostituiva il bacio della buonanotte, una cena in famiglia, la lettura di un libro, il cinematografo, il muretto
sotto casa. Per 20 anni fu trasmesso tutti i
giorni, dalle 20.50 alle 21, interrotto solo della
morte del Papa e dei Kennedy, dalla strage di
Piazza Fontana e dallo sbarco sulla Luna.
Più che pubblicità, un teatrino con palchetto
e sipario. Qualità in bianco e nero, un braccio
di ferro tra il consumismo scalpitante e la
povertà di una guerra da cui facevano capolino
i prodotti pubblicizzati da Carmencita e
Caballero (Carmencita, sei già mia, chiudi il gas
e vieni via), Calimero (Uh Ava, come lava!), la
Linea di Osvaldo Cavandoli. Carosello faceva
rima con manganello e si era tutti, come
Agostino Lagostina, una linea virtualmente infinita di cui si formava parte integrante ma che,
perso il proprio disegnatore, si bloccava su se
stessa, proprio in pizzo.
IL
L’amore è libero e siamo liberissimi
di amare ‘68 Italian Rock Musical
come fosse Mamma mia!. Ci piacerebbe esser giustificati a cantarne i motivi intonare Sfatti, Carosello, Se mi vuoi mi sposi,
Democrato praticità - come quando, dal nulla,
si sente fischiettare Take a chance on me degli
Abba o si vive il «dramma-mia», quella reiterata tentazione, durante una lunga giornata, di
gracchiare «mamma mia» senza pudore.
Simile sindrome colpirà chi darà fiducia a
questo gioiellino di produzione indipendente
(Saint Louis College of Music, D’AltroCanto
Produzioni). Se i nostri tic non ci bastano,
potremo affidarci ai loro. Che, direttamente
dal ‘68, ci consegnano - pronti da canticchiare nel secondo millennio - brani di elevata qua-
lità e testi che si addicono ai grandi parolieri.
Un lavoro che si apprezza ancor di più dinanzi
a un dettaglio: quando nel 2008 iniziò il corso
«Andiamo in Scena» da cui il cd è tratto, per
scelta non si conosceva il leitmotiv del
Musical e lo si affidava alla personalità dell’intero corpo allievi che avrebbe superato le
audizioni e reso questo uno spettacolo cucito
a pennello dal sarto: i fratelli Fontana.
Per la nostra doccia il rock del titolo, coralità, blues e pop, un duo (Emanuela Monni alla
batteria e Alessandro De Panfilis al basso) che
suona dal vivo anche sulle scene, ampie citazioni tematiche e twist intorno alle sedie fino al
Ritorno dalla luna di Johnny (Marco Meccoli),
unico momento in cui il ‘68 da lui rappresentato apre bocca (non sarà un caso che il
Carosello fu interrotto solo per
trasmettere la missione lunare
dell’Apollo 14). Oltre alla luna
lavatrici, mariti, Beghelli, quiz
televisivi, sesso e bigotte.
Dalla luna anche le voci, che
son di stelle: limpide, preparate,
emotive. Talenti che sono come
il salame Negroni: le stelle sono
tante, milioni di milioni, la stella
di Negroni vuol dire qualità. E le
stelle di questo musical sembrano uscir proprio da questo
(Romina Ciuffa)
carosello.
Guarda quant’è bello, guarda il Carosello
mentre tuo fratello muore in piazza!
Johnny perde sangue, il padre sta in
mutande, il fratellino piscia al letto,
la mamma sta in cucina. Arriva l’arrotino,
Agostino è sul pulmino
perché la Polizia se l’è portato via!
MOTEL
POTAREWOODSTOCK
altra faccia di Woodstock. Lo storico conL’
certo che riunì sullo stesso palco il meglio
del rock - Jimi Hendrix, Janis Joplin, Who,
FEED
back
ra, alla ricerca di
talenti, all’accompagnamento artistico
dei grandi nomi
della musica italiana.
Lui, il fratello minore, bravo paroliere
anche nel suo ultimo
cd «A», era uno dei
Ragazzi Italiani che nel 1997 cantavano a
Sanremo Vero amore; Lucio Dalla lo sceglie per
la sua Tosca ed Elisa per il musical Hair; scrive
l’opera Actor Dei insieme alla sorella. Entrambi
collaborano con il Saint Louis College of Music
e sono autori di ‘68 Italian Rock Musical. (RC)
E DOPO IL CAROSELLO
TUTTI A NANNA
ERBA DA
AA.VV. - ‘68 ITALIAN ROCK MUSICAL
CAROSELLO Siamo tutti una
lunga, spezzata Linea di Cavandoli.
FONTANA
di ROMINA CIUFFA
Videointervista
1968
Jefferson Airplane, Grateful Dead e altri - «per 3
giorni di pace e musica» visto da una prospettiva
insolita e finora inesplorata: quella di chi su quel
prato ci è nato e cresciuto e, fiutando l’affare, ha
affittato i propri pascoli agli organizzatori del
mega-raduno. La musica non è solo lo slogan
hippy peace and love, ma è anche guerra di soldi.
Ce lo ricorda uno dei protagonisti di Motel
Woodstock, l’ultimo film di Ang Lee che si rivela un regista eclettico capace di passare da una
sceneggiatura all’altra - da Banchetto di nozze a
Tempesta di ghiaccio, da I segreti di Brokeback
Mountain a Lussuria - senza mai ripetersi, pur
mantenendo lo sguardo disincantato sul mondo
che lo contraddistingue. In Motel Woodstock
svela anche un lato ironico, dando vita ad una
commedia che si regge in equilibrio tra cinismo
e spensieratezza, tra momenti comici e drammi
familiari, tra conformismo e voglia di libertà.
Motel Woodstock è la storia di Elliot, architetto trentenne che lascia New York per aiutare i
genitori a risollevare le sorti di un vecchio motel
nella sconosciuta cittadina di Bethel sulle rive
del White Lake. Quando Elliot scopre che una
vicina località ha rifiutato di accogliere il festival
di Woodstock, contatta gli organizzatori offrendo
loro ospitalità e la sua licenza per organizzare un
festival da camera nei suoi terreni.
Il festival da camera si trasforma nel più grande concerto rock mai organizzato e la tranquilla
vita di provincia viene invasa da migliaia di persone: artisti, musicisti, attivisti pacifisti, giornalisti. L’invasione sarà compensata da un mucchio
di dollari che, da sempre, fanno girare il mondo.
Ma sarà anche l’occasione per entrare in contatto con una cultura diversa che sognava di cambiare il mondo e per tre giorni trasformò una collina nel centro dell’universo di allora.
In un film ambientato nel 1969 ti aspetti come
minimo di ascoltare un riff distorto di Hendrix o
la voce roca di Janis Joplin, ma nel film di Ang
Lee non ce n’è quasi traccia. Come Bob Dylan a
Woodstock, la musica del festival è la grande
assente. Il concerto sarà una eco lontana, che
viene dalla stanza accanto, sogno che non si fa
prendere. Come dicono i saggi, il bello non è la
destinazione ma il viaggio in sé. Nel suo tentativo di raggiungere il concerto, il protagonista sperimenterà il gusto della ricerca e, inciampando in
droghe, amore libero, omosessualità, nuove filosofie di vita, cambierà percorso più volte per
conquistare una nuova consapevolezza di sé.
Alla fine rimane il solito prato da ripulire per
tornare alla normalità, per tornare ognuno al proprio business. Che sia il prossimo concerto da
organizzare o il prossimo affare da concludere
(Roberta Mastruzzi)
poco conta.
ALT
ER
NATIVE
a cura di VALENTINA GIOSA
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
C.O.S. La chitarra-stiletto la colleghiamo ad un pedale e poi al Marshall: que- BLACK HEART PROCESSION I BHP sono
sto strumento è nato dalla mia frustrazione di non poter usare tacchi alti visto «un uomo ubriaco senza scarpe», disse una
che ho dei piedi enormi. Così ho riciclato un paio di scarpe economiche di Zara. volta Pall Jenkins. Tanto per capire il mood.
&
SCALZI
UBRIACHI
CHICKS ON SPEED
PATCHWORK DI ARTE POP
a cura di Valentina Giosa
L’
ppuntamento all’Alpheus il 6
A
dicembre con l’indie d’essai dei
Black Heart Procession, tra i gruppi più
electro pop fem-band più folle sin dal 1997 è tornata a stupire con
un nuovo album e nuovi progetti che, come sempre, riescono a
racchiudere come solo pochi sanno fare musica, moda, sperimentazione. Un gruppo multidisciplinare d’arte o, che dir si voglia, un collettivo dove si fa tutto ciò che è artistico e che ammette in entrata e uscita personalità artistiche di vario tipo, mentre trova nell’australiana Alex
Murray-Leslie e nell’americana Melissa Logan le due anime stabili. Sin
dalle serate nei bar di Monaco di Baviera guidate da un’etica di performances fatte di arte, grafica e collages fatti in casa, queste chicks fan da
sé i costumi di scena al più basso costo e con materiale riciclato, senza
escludere sacchetti di plastica e nastro gaffer.
Con la tedesca Kiki Moorse avevano cantato I don’t play guitar e avevano fatto il botto, un botto fai-da-te. Ma poi videoinstallazioni e progetti fuori norma son ciò che le distingue: le «pollastre veloci», tra l’altro,
hanno disegnato un enorme seno all’esterno di un palazzo di Melbourne
e fatto un concerto in un parco per il principe di Norvegia. «Crediamo in
un nuovo tipo di femminismo: esci e realizza ciò che vuoi. Si tratta di
libertà, e dovrebbe essere possibile per tutti» dichiaravano. Oggi - innovative e sempre al passo con i tempi - le Chicks on Speed raccontano a
Music In com’è nato il quinto lavoro registrato in ben 10 città diverse
tramite il media che ha ormai conquistato il mondo rendendo ogni
distanza un soffio, Skype.
Alex Murray-Leslie e Melissa Logan ci rivelano come nascono i loro
curiosi «oggetti-strumento», anticipandoci inoltre nuove collaborazioni
in vista fra cui quella con Yoko Ono e Brian Eno.
GOLDEN SILVERS
Il vostro quinto album, Cutting The Edge, prende il nome da uno dei
vostri «oggetti-strumento», le forbici elettroniche. Come è nato e
cosa lo differenzia dagli altri vostri lavori?
AML Consideriamo questo album un disco «bubble gum pop intelligente», un mix di pop e arte, diciamo un «patchwork di arte pop». È la definizione giusta per descrivere l’ispirazione che abbiamo preso dagli anni
Sessanta tanto quanto dalle girls-band che abbiamo voluto «sporcare»
un po’. Il bubble gum pop è la radice dell’ondata femminile, alla Kylie
Minogue o alla Madonna, l’opposto delle ‘girl monsters’ (The Slits, The
Raincoats) in cui invece ci riconosciamo molto.
ML Direi che è un album frivolo ma nello stesso tempo con un contenuto, un messaggio. Divertitevi sì, ma andate anche più a fondo se volete.
Gonne-amplificatori, chitarre-stiletto, sassofoni-chitarra elettrica…
Come nascono i vostri «oggetti-strumento»?
AML L’ idea è nata nel corso degli ultimi 5 anni. Abbiamo cominciato
connettendo un microfono su scatole di sigari, pietre e forbici. Poi
abbiamo iniziato a pensare di sviluppare questo discorso soprattutto
dopo aver scoperto Hangar a Barcellona, un media-art space dedicato
solo a questo. È lo spazio più incredibile che abbia mai visto e al mondo
ci sono pochi posti simili. Abbiamo così iniziato a collaborare con il
direttore Pedro Soler, Alex Posada, Merche Blasco e il resto del team. La
chitarra-stiletto è certamente uno degli strumenti che più usiamo dal
vivo. La colleghiamo ad un pedale e poi al Marshall.
Credo che questo strumento sia nato dalla mia frustrazione di non poter
usare tacchi alti visto che ho dei piedi enormi! Perciò è una sorta di
oggetto fetish del desiderio. Ho riciclato un paio di scarpe economiche
di Zara. Fra i nostri progetti c’è anche quello di realizzare un’intera
serie di chitarre-stiletto con Max Kibardin. Vorremmo creare la
«Chitarra-stiletto Orchestra» e fare un concerto per l’apertura della
mostra «The Making of Art» alla Shirn Kunsthalle di Francoforte.
Innovative e sempre al passo con i tempi, avete registrato l’album in
diverse locations tra cui treni, toilettes di gallerie d’arte e stanze
d’albergo utilizzando anche Skype. Com’è andata?
AML Abbiamo letteralmente registrato in 10 Paesi diversi (Vienna, una
fattoria di Oxford, una camera di albergo di New York, un aereo verso
Riga, Lettonia) on line e off line. L’idea di creare uno studio «portatile»
ha influenzato molto il taglio e lo stile dell’album. Nello studio degli
Astrud a Barcellona abbiamo addirittura ballato nude sul tetto e girato
un video mentre registravamo simultaneamente la canzone.
ML Skype è fondamentale per noi, lo usiamo per provare e per sperimentare e serve anche a tenere insieme il gruppo. Inoltre ha contribuito tanto
alla versatilità dell’album. Gli stili e i diversi tipi di musica sono frutto
dei nostri viaggi e delle tante persone con cui abbiamo collaborato.
Infatti il nuovo disco ospita nomi importanti come Fred Schneider e Tina
Weymouth.
LET’S DANCE
rappresentativi della scena a stelle e strisce, in tour per presentare il loro ultimo
album, Six (uscito in ottobre per la
Temporary Residence), già dal titolo
significativo ritorno alle «nude» origini
di 2, del 1999, vero e proprio albumtestamento che segnò la loro ascesa nel
firmamento post-rock accanto agli allora
emergenti Sigur Ros, Elbow e Low. Nati
Come scegliete di solito gli artisti con cui lavorare?
ML Scegliamo sempre di lavorare con amici-artisti che poi diventano
collaboratori e parte della grande «famiglia Chicks» cosi come è stato
con Fred Schneider, che è forse una delle nostre più lunghe conoscenze.
La collaborazione più bizzarra?
AML Mark Stewart. È arrivato, ha urlato nel microfono, lo ha rotto ed
è andato via: eccezionale!
Quella che ancora non avete realizzato?
AML Ci piacerebbe lavorare con Yoko Ono per una performance di
arte e poi ci sarebbe il progetto con Brian Eno insieme alla nostra
Chitarra-stiletto Orchestra. Vorremmo includerlo in una performance
di moda e arte.
Cosa vi ispira da anni e vi fa essere sempre piene di brillanti idee?
AML Prendiamo inputs da diverse cose, arte, musica, moda, new-medias
o anche esperienze di vita quotidiana che contribuiscono in misura uguale alla nostra ispirazione. Per l’ultimo album sono stati fondamentali, per
esempio, Scott Walker, Yoko Ono, The Slits, il bubble gum pop degli anni
Sessanta, il Jpop, Clara Rockmore, Eartha Kitt, Joni Mitchell e l’artista
surrealista Helen Vanel.
La contaminazione di diverse forme d’espressione è molto evidente. Vi
dividete con disinvoltura fra moda, musica e design dando vita ad un
singolare crossover fra le arti. Come vi definireste esattamente?
AML Ci piace chiamare il nostro stile «Objektifications». Siamo molto
ispirate da artisti come Elsa Schiaparelli, Meret Oppenheim, Salvador
Dali, Oscar Schlemmer e anche da Bauhaus e Shiburi per esempio. Il
nostro designer preferito del momento è Pelican Avenue che ha ispirato il
nostro ultimo video «Terrible Twins».
A proposito di moda, avete disegnato collezioni per Crystal Ball e
Yoox, ed ora la collezione Insight on Chicks on Speed…
ML Abbiamo creato trenta capi ispirati al surf; abbiamo anche fatto una
canzone abbinata alla collezione che è poi diventata un video. L’idea è
nata quando ci siamo rese conto che non esisteva un abbigliamento idoneo
per le surfiste, ma tutte dovevano rifarsi all’ immagine maschile stereotipata. Eppure ci sono figure femminili leggendarie che hanno rivoluzionato il
mondo del surf, ad esempio Isabel Letham. Noi le celebriamo così.
Fra gli altri progetti c’è anche la pubblicazione del secondo libro…
ML Sì, ma questo è un segreto.
Avete dichiarato recentemente in un’intervista: «Adoriamo l’Italia ma
nessuno ci invita mai». È vero?
AML Non esattamente. Abbiamo suonato in Italia molto spesso durante la
nostra carriera. Negli ultimi anni Yoox è stato uno dei nostri maggiori
sostenitori, ma anche la Diesel. Ci siamo esibite proprio pochi mesi fa per
il grande anniversario del brand. In Italia torneremo presto, in jeans.
P
robabilmente una delle band
al momento più amate in
Inghilterra, i Golden Silvers
sono stati fra gli headliner del
NME Radar Tour 2009, festival
inglese che ha aperto la strada a
Maximo Park, Glasvegas, Crystal
Castles, La Roux, Friendly Fires,
White Lies, Heartbreak, Blood Red
Shoes, Forward Russia, Howling
Bells. Vincitori della Glastonbury
Festival 2008’s New Talent
Competition e dopo il successo
della disco psycho-pop di True
Romance (True No. 9 Blues) che ha
scatenato tutti in pista, la band ritorna con un nuovo video dal titolo
Please Venus, un tuffo nella spensieratezza e leggerezza della discosoul anni 70 arricchito di un pizzico
di psichedelia di beatlesiana memoria. Semplice e quanto mai attuale
la formula dei Golden Silvers:
intrattenimento, kitsch «intelligente» e (l’oramai immancabile) retro.
(Valentina Giosa)
E funziona.
a San Diego dalle ceneri dei Three Mile
Pilot, formati sulla dorsale della premiata
coppia Pall Jenkins e Tobias Nathaniel, i
BHP hanno dato vita a sei album (da 1,
del 1997, per passare a 3, Amore del
Tropico e The Spell) in una dozzina d’anni, tracciando un percorso tortuoso fatto
di illuminazioni e cadute. Un chiaroscuro
che ben si adatta alle loro atmosfere
minimali e intimiste, giocate su ipnotiche
linee di piano e tesi feedback di chitarra,
violini e fisarmoniche di sapore zigano,
accompagnati dallo straniato canto alla
luna di Jenkins. I BHP sono «un uomo
ubriaco senza scarpe», disse una volta
Jenkins, tanto per capire il mood. Con o
senza scarpe, con Six la processione dei
cuori neri riprende a marciare, e anche
piuttosto spedita. Ascoltare ad esempio
Witching Stone, pilotato sulla progressione batteria-basso-chitarra, e Drugs, per
solo voce e piano, ballata magica e
sospesa con relativo video da «Gabinetto
del Dr. Caligari» e un occhio verso
Mercury Rev e Dresden Dolls. Per restare nei dintorni di fine millennio.
LORENZO BERTINI
ORRORI
MALEDETTI
10
a nni fa cinque ragazzi dal fascino maudit e con la passione per il garage e le
sonorità «oscure» si aggiravano nell’area di Southend suonando The Witch dei The
Sonics e Jack the Ripper degli Screaming Lord
Sutch. Il successo per i The Horrors non tarderà
ad arrivare una volta che i brani originali verranno alla luce.
Con sonorità e atmosfere garage, shoegaze,
post punk e gothic rock e un look già ben definito, la band inglese comincia a farsi un nome già
con il primo disco Strange House, a cui seguiranno importanti esibizioni come il Glastonbury
Festival, il Carling Weekend, diversi festival
scandinavi, il Summer Sonic Festival in
Giappone e Splendour in the Grass in Australia.
La band è ora in tour in Europa (a Roma il 18
novembre al Circolo degli Artisti) per promuovere il secondo album Primary Colours
pubblicato a maggio, prodotto da Craig Silvey,
Geoff Barrow dei Portishead e Chris
Cunningham, e nominato per il 2009 Mercury
(Valentina Giosa)
Prize.
PO
P
C
K
pop&rock
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
PIETRA MONTECORVINO Nascondi la UN TRENO ROCK Senza i limiti delle 4 piste, diffi- FUMETTI POP Ma no, di
mano perché sai che la responsabilità di una cilmente i Beatles e George Martin avrebbero tirato fuori che m’illudo? Ancora è tutto
passione mediterranea non la puoi sostenere le geniali sovraincisioni di «Revolver» e «Sgt. Pepper». nuvole e niente che si afferri.
a cura di ROMINA CIUFFA
!"#$%&'%()*"&(&#"+$,#-%&!"&."#,
a cura di Sabrina Simonetti
e Romina Ciuffa
Videointervista
www.youtube.com/musicinchannel
S
i chiama Barbara D’Alessandro, è conosciuta come Pietra Montecorvino («perché quando si apriva la porta di San
Pietro, che si apre ogni 7 anni, io mi trovavo lì») e siede accanto a Eugenio
Bennato, Sanremo compreso. Questo non vuol
dir nulla: una pietra è una pietra, si provi a lanciarla e lei sarà forte ovunque cada, anche in
fondo a un lago, perché avrà sempre il proprio
spazio. E, soprattutto, a morra cinese la batte
solo la carta: carta canta, appunto.
Da cui una riflessione: ascoltando il suo ultimo
album, Italiana, la signora Montecorvino fa
rimpiangere una Salerno-Reggio Calabria non
ancora pronta, fa cinicamente soffrire perché ce
lo offre ora che è inverno e poi ci spiega: «Di
getto, è venuto di getto». Con la complicità del
tarantico potere di Eugenio che firma la direzione musicale, di Erasmo Petringa agli arrangiamenti e in chitarra battente, e di tutti loro: Luigi
Tenco, Domenico Modugno, Fred Buscaglione,
Lucio Battisti, Mogol e quanti altri, che lei qui
interpreta «mediterraneamente».
E un inedito - Amante italiana, scritto col compagno di una vita Bennato - ancor più mediterraneo in un bel video che parla di mare napoletano e rende Pietra una gemma, ma anche una
fata. Perché (un omaggio al cognato Edoardo
per il suo Pinocchio?) i capelli li ha turchini.
Come nasce la tua carriera artistica?
Nel 1983 in un film di Renzo Arbore, «F.F.S.S.
Che mi ha portato a fare a Posillipo se non mi
PHOTOCREDITS ARIANNA TONDO
vuoi più bene?», la mia prima esperienza.
Cantavo «Sud», scritta da Claudio Mattone e
Renzo Arbore.
Cosa c’è di nuovo oggi in te?
Tanta nicotina in più, ma soprattutto credermi tutti i giorni un’artista alle prime armi.
Chi ha suonato con te in Italiana?
Gli arrangiamenti sono di Eugenio Bennato,
che lavora con me da sempre. Ha curato quasi
tutti i miei dischi tranne uno che ho scritto io, un
disco di tanghi, «La stella nel cammino». Oggi
esce un album di cover anni 60, con un inedito
scritto da me e Eugenio, «Amante italiana».
Che influenze ci sono nella tua musica?
Sicuramente ho il Mediterraneo nelle vene ed è
parte della mia espressione artistica, ma appartengo al mondo e non cesso di esplorarlo. Spero
La storia del rock parte da Abbey Road
e dai limiti delle 4 tracce della Emi
UN TRENO
ROCK
MEMORIE
DI MONDI
NOTTURNI
di Romina
Ciuffa
di Donato Zoppo
«Q
C
osa c’è da raccontare sul rock? Una
domandina del genere me la porto dietro
da anni. Tempi foschi quelli dell’università, quando frequentavo Giurisprudenza per far
contenti i miei, ma per far contento il mio
demone davo sfogo a una malsana passione per
il rock. Ascoltando, studiando, scrivendo a più
non posso. A mio modo, raccontando. Era tanto
simpatico il professore di Economia Politica,
esperto di qualsiasi dettaglio relativo alle curve
dell’offerta e della domanda, all’oligopolio e
alla stagflazione, ma il rock non era pane per i
suoi denti. «E cosa c’è da raccontare sul rock?»,
mi chiese quando gli spiegai che studente non
lo ero a tempo pieno, che dedicavo le mie energie da gavetta come scribacchino in un giornale locale, che già cominciavo a tenere i miei
incontri sulla storia del rock. E questa domanda
si è presentata nuovamente - sotto altre vesti,
con un’altra ben più insidiosa questione - quando sono stato invitato a tenere il workshop
Rock’n’ Roll Train presso il Forum dei Giovani
di Quadrelle il 10 ottobre 2009.
Cosa c’è da raccontare sul rock, ma soprattutto, come narrare i suoi 55 anni? Come farlo in
un’oretta a disposizione, di fronte a giovanissimi che hanno scoperto il celebre riff di Smoke
On The Water perché lo fischiettava il papà?
Non si può che puntare alla sintesi estrema,
esponendo personaggi, decadi e correnti, dagli
anni 50 di Chuck Berry al recente In Rainbows
dei Radiohead. Senza dimenticare, però, che il
rock è una cosa seria, soprattutto per me che
ogni sera, prima di addormentarmi, recito le
giaculatorie a San Jimi, Madonna Janis,
l’Arcangelo Brian Jones e Beato John Lennon.
Perché trattasi di cosa sacra. Come ogni concerto d’altronde. Pensate al rito celebrato dal Gran
Sacerdote Elvis Presley, alla grandiosa liturgia
amministrata dai Led Zeppelin, alla dimensione
mistica di un live degli U2, a quella orgiastica e
dionisiaca dei Mars Volta. Volendo si potrebbe
raccontare il rock attraverso i suoi concerti, e
di somigliare sempre di più a tutto quello che c’è
da vivere, senza rimanere ferma alle mie radici.
Scopriamo nel tuo album miscugli di cori
africani e indiani: da dove provengono?
Da musicisti arrivati coi barconi. Non portano
solo cose brutte come può sembrare, ma arte e un
grandissimo contributo alla musica.
Perché è difficile avere successo in Italia?
Perché non c’è spazio per le cose che durano, ma solo per l’usa e getta. Ormai nella musica c’è un cambio velocissimo tra un artista e
l’altro e, alla fine, non ci si ricorda di nessuno,
solo tanto anonimato.
Quali sono i tuoi prossimi impegni artistici?
Spagna innanzitutto, perché è lì che sta
uscendo il mio disco: sarò presto a Malaga,
Barcellona, Pamplona. Poi in Belgio, in
Francia e in altri Paesi d’Europa.
Come hai scelto le tue cover?
Con naturalezza: andavamo sempre a finire
sui sentimenti e sempre su pezzi degli anni 60,
un momento in cui la musica costituiva una
visione del mondo ben determinata. Ho preferito Tenco, che è un po’ l’eroe di quel periodo, ma
anche Modugno e Battisti (che mi ricorda l’infanzia) e Umberto Balsamo, una canzone poco
nota che si chiama «Tu non mi manchi».
È tutta emozione o anche un briciolo di recitazione?
Un insieme, perché c’è un po’ di tutto.
Presunzione, insicurezza, passione, anche recitazione: ci sono io, io come sono.
E il cinema, quanto ti appartiene?
È una passione che non si spegne, e che vorrei si accendesse sempre di più nella mia vita.
Ho da poco finito di girare un film con John
Turturro, che sarà al Festival di Berlino a febbraio, e spero di aver fatto una bella figura.
non mancano studi del genere. Ma se avete
tempo e pazienza di spulciare, scoprirete che il
mezzo secolo che ci separa dal 5 luglio 1954 Elvis varca la soglia degli studi Sun Records di
Sam Phillips per registrare That’s All Right - è
ricco di eventi, di contatti con altre forme di
arte, di sapere e di attività umane.
Parlare di rock significa parlare di storia contemporanea: è una musica che nasce registrata,
dunque è il prodotto dell’industria discografica, segue e asseconda l’evoluzione del mercato
e della tecnologia. Tanto per intenderci: senza i
limiti delle 4 piste degli studi Emi di Abbey
Road, difficilmente i Beatles e George Martin
avrebbero tirato fuori le geniali sovraincisioni
di Revolver e Sgt. Pepper. La stessa tecnologia
ha consentito ad un Anton Corbjin di realizzare il visionario videoclip di Heart Shaped Box
dei Nirvana e a Woodroffe e Fisher di progettare il trionfale Bridges To Babylon Tour dei
Rolling Stones.
Se poi volessimo parlare del parallelismo tra
l’evolversi del rock’n’roll e del costume, dei
rapporti con l’arte grafica, la letteratura, la fotografia, la spiritualità e le droghe, ci sarebbe da
far spaventare sul serio il docente di Economia
Politica. Caro professore, e se facessimo una
bella cattedra di storia del rock? Nell’attesa,
cordiali saluti.
ui
tutto
pesa poco,
tutto è nebbia, è vapore senza
appiglio, ogni forma
dura appena, come
una nuvola, poi cambia. E come nuvole,
queste forme, a guardare da vicino sono
ancora e solo nebbia.
Vorrei la gravità, vorrei la vecchia terra,
quella pressione antica sui talloni...». Questo è
precipitare durante un sogno.
Graziano Staino racconta, nella collana «ipotalamica» Black Books della casa editrice veneziana Lightbox, «una monocromatica storia a fumetti» in cui sognano i personaggi della scena musicale italiana - Manuel Agnelli degli Afterhours,
Cristina Donà, Morgan, Piero Pelù, Francesco
Bianconi dei Baustelle, Meg, Enzo Moretto di A
Toys Orchestra, Simone Cristicchi, Irene Grandi,
Paolo Benvegnù, The Niro, Stefano Bollani,
Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e Cesare
Basile - intorno a una misteriosa «ombra di
vuoto» che disperatamente vuol capire.
Il racconto è un sogno in sé, con i cambiamenti strutturali che l’inconscio compie - una
macchina a più pedali, una caduta infinita che è
desiderio ma anche paura di volare, luoghi che
mutano senza troppo senso, guerre (i conflitti
del sé) vinte o perse, volti che si intercambiano
e nessuna spiegazione - e con il senso dell’etereo e del pesante insieme. Librarsi e non cadere
mai. Precipitare e ossessionarsi. Ma l’ombra
vuol capire: a Cristicchi viene chiesto, nei testi
di Dario Honnorat, cos’è il sogno lucido, quell’esperienza onirica in cui il sognatore si rende
conto di star sognando, ha percezione cosciente
del suo mondo onirico e, con la pratica, può
esplorarlo, controllarlo e modificarlo a piacere.
«Aspetta! Conosco questo luogo! È qui che
una volta ho visto dei folletti in mezzo alle
La casa editrice
Lightbox fissa
gli incubi
di artisti pop
(CristinaDonà,
Piero Pelù,
Morgan, Meg,
Irene Grandi,
The Niro e
molti altri) in
un fumetto,
che è poi
una domanda:
precipitando
nel sogno,
precipito?
foglie. Nessuno mi ha mai creduto...», ma i folletti gli rompono gli occhiali (una paura che
prende forma onirica) e lui sparisce. «Dove sei
sognatore? Devi spiegarmi i segreti del sogno
lucido, devi insegnarmi a controllare i sogni...»,
invoca l’ombra. Niente da fare, s’è svegliato.
Piero Pelù viene trovato a sognare «un sogno
maledetto che non facevo da millenni», un asino
assorto a contemplare uno strapiombo, «ti prego
allontana l’asino dal precipizio! Io sono legato
a quell’asino da un filo profondo e impalpabile.
È una specie di simbiosi emotiva: tutto quello
che provo lo prova anche lui». In questi mondi
notturni, «io sono un rebetiko», dice l’ex leader
dei Litfiba, «quindi siamo in Grecia», la
Santorini del primo Novecento per l’esattezza.
«Posso suonarti un brano rebetiko», ma
riprendono il cammino («Non c’è gusto a cantare per te, sei troppo rigido e silenzioso», dice
all’ombra) fino a incontrare il «nano greco»: «La
parola sogno non ha senso, i sogni non esistono,
ed io certo non sono un sogno. Ti è mai capitato
di fare un sogno in cui sai che stai sognando?
Nel sonno, bisogna raggiungere lo stadio prelucido, mettere in dubbio la realtà del sogno.
Dubitare che quello che si sta vivendo sia realtà,
ad esempio notando che accadono cose impossibili, come volare, respirare sott’acqua. Allora si
può controllare il mondo onirico».
E precipitare? Un lungo volo e laggiù la terra
amica mi accoglierà come un cuscino. E se
anche mi attende un dolore di roccia dura contro le ossa, sarà realtà, perlomeno. Sarà materia, concretezza, veglia. Ma no, di che m’illudo?
Ancora è tutto nuvole e niente che si afferri, non
c’è niente di fisso, niente di solido. Qui non c’è
nulla che sia coerente. E non sopravvivrei, se
non ci fosse un suolo su cui atterrare.
SOUND
tracking
a cura di ROBERTA MASTRUZZI
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
BASTARDI SENZA GLORIA Quentin Tarantino
Senza mai peccare di snobismo intellettuale ma con l’entusiasmo di un bambino di fronte al suo gioco preferito
MUSIC IN VIDEO Venere, Biorn
Le stanze in cui viviamo ci somigliano. Per questo manca sempre qualcosa
GLORIA
BASTARDO CON
Non mi interessa fare
cartoni animati, ma rendere
autentica la violenza.
di Roberta Mastruzzi
I
l cinema salverà il mondo e
lo farà sacrificando se stesso.
L’ultimo film di Quentin
Tarantino, Bastardi senza gloria, parte da una fattoria nella
campagna francese all’epoca
dell’occupazione nazista e finisce in un piccolo cinema di
Parigi dove una tremenda vendetta sta per essere consumata.
Protagonisti della storia sono
un irreprensibile comandante
delle SS che parla molte lingue
(Christoph Waltz), una ragazza
ebrea riuscita a salvarsi dall’eccidio della sua famiglia e
proprietaria di un cinema parigino (Mèlanie Laurent), un gruppo
di marines infiltrati nelle retrovie - i bastardi del titolo - dediti alla
cattura e all’uccisione dei nazisti, con il vizio di togliere lo scalpo
ai cadaveri per conto del loro comandante (Brad Pitt).
Svelare oltre la trama sarebbe un grave peccato per un film che
tenta di riscrivere la storia, fregandosene di rispettare tempi e
fatti realmente accaduti. Qui Tarantino spinge al massimo il
pedale dell’immaginazione sfruttando a pieno le potenzialità
della settima arte e realizzando un film - il primo in assoluto
nella storia del cinema - con un’anima veramente europea.
Girato in 4 lingue, con tutto
ciò che ne consegue incomprensioni comprese. Questo
sarà il filo conduttore
della
pellicola e in
alcuni punti la
chiave di volta
della narrazione.
Come a dire che
la storia europea
sarebbe stata diversa se avessimo parlato tutti la stessa lingua.
Ma la diversità porta anche ricchezza e ne sa qualcosa il regista americano, cresciuto in una videoteca dove ha potuto assaporare e amare l’intera cinematografia europea, dai registi più
famosi a quelli sconosciuti anche nella loro stessa patria, dagli
spaghetti western alle commedie francesi fino ai melodrammi
tedeschi, senza mai peccare di snobismo intellettuale ma con
l’entusiasmo di un bambino di fronte al suo gioco preferito, da
vero appassionato di cinema. Ed è un pregio non da poco, è raro
trovare un regista che sappia riconoscere il valore del lavoro
altrui. A pensarci bene, è raro trovarlo in qualsiasi settore e non
solo nel cinema. Tarantino invece ne ha fatto il proprio marchio
di fabbrica: come i suoi precedenti lavori,
Bastardi senza gloria è un film nel film,
tante sono le citazioni, a volte trasformate in parodie, altre in ossequiosi omaggi a
registi, attori e sceneggiature di ogni
nazionalità e genere, che se ne consiglia
una visione multipla per poterle individuare ed apprezzare tutte.
Le citazioni sconfinano anche nella
musica, ed è così che nella colonna sonora
molti brani del passato rievocano classici
cinematografici, ma anche semisconosciuti film di serie B. Dal brano che accompagna la prima scena - The green leaves of
summer - tratto da un film di John Wayne (La battaglia di Alamo)
a numerosi brani scritti da Ennio Morricone (The verdict, The surrender e Un amico, scritti per i film di Sergio Sollima La resa dei
conti e Revolver) fino a David Bowie e la sua Cat People (Putting
out the fire) che, estratte dalla pellicola per cui sono nate e trapiantate nel terreno fertile dell’immaginazione tarantiniana, riprendono vita e acquistano nuove sfumature di colore.
In colonna sonora anche brani tratti da vecchie commedie
tedesche, fino al gran finale con di nuovo protagonista
Morricone che con Rabbia e tarantella, scritta per Allònsanfan
dei fratelli Taviani, chiude tutti i giochi: sarà il momento in cui il
cinema riscriverà la storia.
di Roberta Mastruzzi
A
Napoli, un’insegnante di lettere in scuole
serali si trova ad affrontare una gravidanza non prevista. Il suo compagno
rifiuta la paternità e la
bambina nasce prematura,
dopo solo sei mesi di
gestazione. Maria, la
madre interpretata da
Margherita Buy, si troverà
ad affrontare un momento difficile, nell’attesa
che la figlia Irene completi la sua crescita dentro un’incubatrice, senza sapere se la figlia riuscirà a sopravvivere e con quali conseguenze
sulla sua salute.
Lo spazio bianco è un film tratto dall’omonimo libro di Valeria Parrella, diretto da
Francesca Comencini - da non confondere con
la sorella Cristina, ugualmente regista ma con
uno stile più conformista - che sceglie di affrontare il racconto di una maternità vissuta e sofferta da una donna sola in una città estranea, in
preda a dubbi e paure, ferita dagli uomini e
dalla burocrazia italiana per la quale esistono
ancora figli «illegittimi».
È l’attesa di Maria che non sa attendere, è il
difficile percorso della piccola Irene verso la vita,
è la distanza con cui si guarda il mondo quando
si è costretti a guardarlo attraverso un vetro, quel-
lo dell’incubatrice ma
anche quello che separa ed
esclude la propria vita da
quella degli altri.
Un tema così delicato,
che tocca sfere profondamente radicate nell’intimità di un essere umano,
richiedeva una colonna
sonora all’altezza, perché
la musica potesse riempire
con discrezione questo spazio bianco. L’autore
delle musiche originali, Nicola Tescari, ha il
merito di lasciare spazio nella scelta dei brani di
repertorio alle voci femminili. Una scelta non
così scontata, considerato il fatto che quando si
parla di maternità la voce delle donne, indiscutibilmente principali artefici di tale evento, è
messa spesso in secondo piano.
Ad accompagnare l’attesa di Maria la voce
energica di Blondie con Call me, quella struggente di Cat Power e la sua Where is my love?,
quella di Nina Simone che interpreta I wish I
knew how it would be feel to be free, l’indimenticabile voce di Ella Fitzgerald con una malinconica Misty e le sonorità elettriche di Dani
Siciliano in Same. Una colonna sonora tutta al
femminile per un film che non si rivolge solo
alle donne, perché la nascita di una nuova vita
dovrebbe riguardare tutti.
DON GIOVANNI
N
di Roberta Mastruzzi
ella Venezia del Settecento un giovane ebreo
viene battezzato e prende i voti da sacerdote.
Un prete sui generis: si chiama Lorenzo Da
Ponte ed è poeta e libertino. Intimo amico di Giacomo
Casanova, seguirà le sue orme, intrecciando storie e
avventure con centinaia di donne e scrivendo invettive
contro la stessa Chiesa e l’Inquisizione. Esiliato a
Vienna, conoscerà Mozart e per lui scriverà i libretti
delle sue opere in italiano: Le nozze di Figaro, Così fan
tutte e lo stesso Don Giovanni.
Il regista Carlos Saura dirige il suo primo film musicale Io, Don Giovanni, dedicato alla vita finora poco
conosciuta del librettista di Mozart. È la storia vera di
un’amicizia ed il racconto della nascita di un’opera
immortale, il Don Giovanni, nata dall’incontro di tre
grandi personalità: Mozart metterà la musica, Lorenzo
da Ponte le parole e Casanova il suo stile di vita. Il progetto musicale del film è stato seguito da Nicola Tescari,
che ha ricostruito il suono di un’orchestra del 700 utiliz-
IO, DON GIOVANNI
Mozart mette la musica,
Casanova lo stile di vita
zando strumenti antichi e registrando in una piccola
chiesa nella campagna laziale, nel tentativo di ricreare
l’atmosfera della prima esecuzione in pubblico
dell’Opera, avvenuta a Praga nel 1787.
Il regista ha voluto che fossero gli stessi attori impegnati nella messa in scena ad interpretare le celebri arie
mozartiane, e realtà e finzione si mescolano. Il dramma
giocoso (questo il sottotitolo originale dell’opera, in
affiancamento al titolo originale Il dissoluto punito ossia
il Don Giovanni, K 527) di Don Giovanni si confonde
con la storia dello stesso Lorenzo, combattuto tra la sua
vocazione libertina e la tentazione di un amore unico ed
eterno per la sola donna che abbia amato, Annetta.
L’amore per questa donna ritrovata dopo anni di lontananza e la difficile impresa di riconquista, dopo la scoperta di Annetta - proprio come accade nell’opera
mozartiana - del lungo elenco delle sue avventure,
influirà sull’opera dello scrittore e contribuirà a dare
quel tocco di immortalità proprio dei capolavori.
VENERE IN BIORN
L
e stanze in cui viviamo ci somigliano. Parlano di noi, del nostro
stato d’animo. Il video Venere
dei Biorn - gruppo romano emergente
della scena indie rock, un pittore che
realizza piccoli affreschi sonori - è il
primo estratto dall’omonimo album.
Parla di due stanze, un uomo e una
donna e due solitudini, un gatto rosso,
un cucciolo di Labrador. Lei è tornata
da un viaggio e si prepara ad incontrare
lui che è tornato da una rapina ed è ferito. Lei in una stanza rossa ed accogliente, lui in una stanza fredda e spoglia,
affiancate, un muro di separazione,
qualche centimetro che evoca film
come Bound e il cinese The Hole. Ci
sono quadri, un pacco regalo da scartare, un divano bianco e un cavalletto: gli
oggetti si accumulano per colmare un
vuoto. Per quanto una stanza possa
somigliare a noi, sembra mancare qualcosa: «Completami, completalo il mio
mondo». Verso la fine del video ci sono
anche loro, i Biorn, e sono Aure (batteria, percussioni), Blaze (voce, chitarre,
synth), Eddie (voce, basso, contrabbasso) e Manuele (chitarre, synth, pianoforte, fisarmonica), mentre «tutto scorre così leggero senza troppi sé» ma in
un video sorprendente.
SOUND
tracking
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
VIOLA DI MARE Merita d’essere visto solo
perché meritava d’essere letto, per dire «Non c’è
paragone» ascoltando qualcosa della Nannini
CINEMA E STEREOTIPO Ciò
METROPOLIS Nella
che gli americani vogliono farci THE SOLOIST Non città muta le musiche di
credere degli arabi. Aladino a parte lo vedremo mai.
Aljoscha Zimmerman
VIOLA
ARABINMACCHINA
Mio padre lo voleva maschio. Doveva essere per forza
come lui, il figlio del curatolo delle cave di tufo di Cala
di Tramontana. Una femmina è roba di signorine,
tutti sono capaci. Digli che sono una femmina. Sono
nata io. Una femmina, papà. Rassegnati, sono io.
Ecco, io sono nata così. E lo giuro, c’era la luna piena
DI MARE
di Rita Barbaresi
L
a viola di mare è un pesce ermafrodita che
transita nella fase maschile. In Sicilia lo
chiamano anche «minchia di re», da cui
Giacomo Pilati trae il titolo per un romanzo che
racconta dal 2004. Meritava di essere letto per i
temi trattati: pregiudizio, soprusi, la vergogna di
una famiglia per un amore omosessuale vissuto
ME
TRO
PO
LIS
nella Sicilia dell’800. Tematiche ancora al centro di mille dibattiti, molto più semplicemente
una storia popolare satura d’amore.
Merita d’esser visto - Viola di mare - per i
medesimi motivi. La regista Donatella Maiorca
- tornata al cinema 10 anni dopo un film dal titolo simile, Viol@ - porta sul grande schermo questo amore nato tra le zagare di un’isola del
Mediterraneo. Ma il valore aggiunto - accelerazione di cui il film aveva bisogno per non
disperdere l’incanto della storia - è nella colonna sonora, firmata da Gianna Nannini con la
collaborazione di Wil Malone (produttore degli
ultimi due album della rocker senese). È proprio
lei ad affermare che per far arrivare al pubblico
la magia del luogo con l’odore del tufo di
Favignana era indispensabile il suono acustico
della chitarra, suono acido del rock.
Brava la Maiorca a decidere di contrastare le
immagini dolci, drammatiche e romantiche di
una storia popolare con una colonna sonora
fuori dagli schemi classicheggianti; brava la
Nannini a raccogliere la provocazione con un
Q
u a n d o il cinema non aveva voce, erano le
immagini e la musica a raccontare una storia. Questa sinergia ha dato luce a capolavori
che ancora oggi non hanno perso di fascino:
Metropolis di Fritz Lang è uno di questi. Uscito
per la prima volta nelle sale cinematografiche
nel 1927, nel 2001 è stato restaurato e dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco; la sua
sceneggiatura ha ispirato molti compositori a
creare per la pellicola un commento sonoro.
Il primo fu G. Huppertz nel 1926, negli anni
80 fu Giorgio Moroder a realizzare una versione
rock - tra i brani inseriti anche Love Kills di
Freddie Mercury - fino ad arrivare ai nostri giorni e ad Aljoscha Zimmerman, autore di oltre 400
merito: alleggerire un prologo troppo lungo e
lento. Scorre il film e istintivamente la musica
avverte l’inconscio: è fuori contesto, non è affatto in sintonia con il film. Siamo abituati a colonne sonore fedeli e mansuete, suddite della storia;
la senese, invece, rompe l’idillio e superbamente graffia e conduce alle pagine di Minchia di
Re, ad Angela (Valeria Solarino) e Sara (Isabella
Ragonese) che si desiderano consapevoli che
«ci sarà qualcosa nei tuoi occhi viola, ci sarà
qualcosa nella vita per cui valga la pena».
Viene naturale ascoltando Sogno andare alle
immagini del video Attimo (protagonista la stessa Solarino) e capire quanto piaccia alla Nannini
restar fuori dagli schemi musicali (e non).
Solo la presenza spregiudicata della sacerdotessa del rock italiano ha consentito a questo
Viola di mare di non entrare in quella categoria di
film didascalici che, come spesso accade, sono i
figli di una presunzione tipica di alcuni registi,
che si ostinano a rovinare traducendo in immagini pagine di romanzi meritevoli di notorietà a prescindere dal distacco miope dello schermo.
colonne sonore per film muti (da Ernst Lubitsch
a Chaplin e Buster Keaton) presente l’11 novembre all’Auditorium Parco della Musica e il 13
novembre al Teatro Cassia per suonare dal vivo
con la sua orchestra le musiche originali da lui
composte. La storia è storia: Metropolis è una
città immaginaria (ma quanto?) i cui abitanti
vivono su due livelli diversi, rigorosamente
distinti: in superficie vivono quelli che comandano, nella città sotterranea tutti gli altri.
Considerato da molti il capostipite dei film di
fantascienza, Metropolis è molto di più: il racconto attuale dei pericoli insiti in una società
rigidamente divisa in classi sociali, d’incomunicabilità, d’ingiustizia. (Roberta Mastruzzi)
THE SOLOIST
L’ennesimo film che in Italia non vedremo, la colonna sonora di un grande
Dario Marianelli che scaricheremo illegalmente, lo scotto che pagheremo
all’ignoranza di una distribuzione venale che plagia i suoi stessi spettatori
di Flavio Fabbri
«T
he Soloist» è innanzitutto una grande storia di amore per la
musica e per la vita. Una storia che in Italia probabilmente
non vedremo mai al cinema, l’ennesimo caso di ottimo cinema che non troverà mai una distribuzione, l’altra occasione perduta dal
nostro mercato per proporre al pubblico italiano una bella storia: commovente, costruttiva, socialmente impegnata, istruttiva e piena di buoni propositi. Il Joe Wright di Orgoglio e Pregiudizio ed Espiazione, vincitore di
tanti premi ai festival di Boston, Chicago e ai Bafta Awards, non proprio
l’ultimo arrivato, con grandi incassi ai botteghini e al mercato homevideo. Ma allora, perché questo film non è nelle nostre sale?
Negli Usa è uscito ad aprile scorso, in Gran Bretagna a settembre, il
resto delle uscite programmate arriva fino a febbraio 2010, proponendo
il film in ordine di debutto nelle sale tedesche, spagnole, greche, olandesi, francesi e scandinave, compresa l’Europa dell’Est. Non ha incassato
molto, è vero - solo 33 milioni di dollari a fronte di una spesa di produzione di 60 milioni - e forse anche qui sta la ragione di tale ‘svista distributiva’. Di questi tempi non c’è tanta voglia di rischiare.
La storia è bella. Nathaniel Ayers (Jamie Foxx) è un ragazzo di colore
schizofrenico che vive da clochard e suona un violoncello scassato (con
sole due corde) ai bordi delle strade. Steve Lopez (Robert Downey Jr.) è
invece un giornalista nel mezzo di una crisi di nervi, che nella ricerca di
una storia da raccontare s’imbatte nell’artista disabile e a sua volta riesce
a dare un nuovo senso alla propria vita. Ne nasce una storia di grande
amicizia, di amore per il prossimo e di rinnovata voglia di vivere, grazie
anche alla musica.
Ma The Soloist non è solo questo, perché Nathaniel e Steve esistono
per davvero. Le musiche del film, bellissime, sono state scritte da un ottimo Dario Marianelli, al suo terzo lavoro con Wright e già vincitore di un
Golden Globe come miglior colonna sonora per Espiazione, proponendo
(già nel trailer ufficiale) il Prelude Cello Suite No. 1 di John Sebastian
Bach e One Day Like This degli Elbow, attingendo inoltre a piene mani
dalla bravura del violoncellista Ben Hong. Il resto dei componimenti
sono presi da Ludwig van Beethoven, Neil Diamond e Jerry Jeff Walker.
Con tali presupposti, perché la Universal Pictures non distribuirà questo film in Italia? Si parla tanto di contenuti di qualità, di mercato ‘alto’,
di valor aggiunto della musica ai prodotti cinematografici, che poi si finisce sempre a guardare alla fiction televisiva o a gioielli rari del cinema
italico (come gli acclamati Gomorra e Il divo). Se proprio i distributori
non vogliono correre rischi, perché non uscire dal circuito delle sale cinematografiche ed entrare su altre piattaforme di distribuzione?
C’è il web oltre alle sale, ci sono le pay-tv, si potrebbero decidere delle
uscite (windows) in contemporanea o a poca distanza, ovvero su piattaforme scelte (satellite, digitale terrestre, Internet). Soluzioni non mancano per chi voglia (davvero e in cuor suo) combattere la pirateria digitale
del download illegale. Per un buon prodotto c’è sempre un prezzo giusto,
che tutti sono disposti a pagare. Forse ciò che manca in questo Paese è la
voglia di far vedere del buon cinema e di far sentire della buona musica
al di là dei noiosissimi ‘cinepanettoni’ e ‘cinecocomeri’ che tanto piacciono. Soldi facili contro buon gusto e storie avvincenti? Inutile accettare la
sfida, in Italia sappiamo già come va a finire. (Noi lo scaricheremo).
di Alessandra Fabbretti
C
he tipo di immagine offre il cinema made
in Usa degli arabi? «Fatta qualche eccezione, si tratta di un’immagine stereotipata. La società appare retrograda, lontana
dalla modernità, schiava dell’Islam e - peggio
ancora - dell’islamismo», afferma Habib Attia,
produttore televisivo e cinematografico tunisino e direttore generale della Cinetelefilms, la
prima compagnia di produzione tunisina privata che punta sullo sviluppo di co-produzioni
con l’Europa e sta lavorando su un progetto di
co-produzione con l’Italia. Non sbaglia.
Il grande schermo hollywoodiano è popolato
di ricchi sceicchi che dilapidano dollari e giovani danzatrici sempre sorridenti e disponibili. La
cinematografia allude con ripetitività alla cultura arabo-musulmana, ma in modo errato fin
quando la parola arabo voglia suggerire solo, in
un contesto di paesaggi esotici, sinuose fanciulle e pericolosi individui pronti a far saltare in
aria l’Occidente.
Gli appassionati di Indiana Jones non possono
non ricordare la scena ne I predatori dell’arca
perduta in cui Harrison Ford abbatte con un
colpo di pistola il tracotante guerriero arabo
vestito di nero. Altrettanto feroci, ma incapaci,
sono i terroristi contro cui si cimenta Arnold
Schwarzenegger in True Lies (1994), mentre
Doc, l’eccentrico co-protagonista di Ritorno al
futuro (1985), viene preso a colpi di kalashnikov
da alcuni terroristi libici. In Hot Shots 2 (1993)
l’intera missione dell’agente Topper (Charlie
Sheen) si svolge in Iraq per salvare dalla prigionia alcuni soldati americani ed è lo stesso presidente degli Stati Uniti ad affrontare in un duello
stile Star Wars il dittatore Saddam Hussein.
Politically incorrect.
Alan Nadel, docente nella Rutgers University
(Kentuky, Usa) in uno studio analizza il celebre
cartone della Walt Disney Aladdin (1992), e
avanza una teoria: realizzato durante il conflitto del Golfo, esso contro tendenza intendeva
offrire una visione innovatrice degli arabi, dove
i «vecchi» venivano sostituiti con i «nuovi».
Aladdin e Jasmine abbraccerebbero i valori
americani, rifiutando il passato e le tradizioni.
Per avvalorare la propria tesi Nadel cita una
strofa della canzone cantata dagli innamorati
nella famosa scena del volo sul tappeto magico,
A Whole New World: «I can’t go back to where
I used to be», non posso tornare dov’ero.
Nel mondo della musica, invece, una singolare inversione di tendenza. Diversi studiosi
hanno confermato un avvicinamento del pubblico a quella araba proprio in seguito agli
attacchi del 2001: c’è chi li teme, ma c’è anche
chi nutre curiosità e interesse per un universo
tanto lontano e composito. Così numerose star
spiccano il volo proprio dopo la data critica
dell’11-09, come la bella libanese Nancy
Ajram, che nel 2008 vince il World Music
Award per le vendite ed è la prima testimonial
scelta dalla Coca Cola per il mondo arabo.
Dawn Elder, vicepresidente di una delle etichette commerciali che più hanno contribuito al
boom dell’Arab music negli States, Mondo
Melodia, si dimostra molto ottimista: gli appassionati non diminuiranno, tutto il contrario.
Dopo il 9/11 molti concerti furono annullati
dagli stessi musicisti arabi che, per rispetto,
preferirono non esibirsi. «In quel momento li ho
capiti-sostiene Elder-ma mai come ora la gente
dimostra di voler conoscere il Nord Africa e il
Medioriente. È come se ci dicesse: ne vogliamo
sapere di più!». Staremo a vedere se i grandi
della music industry saranno in grado di cogliere questo non sottile messaggio.
BALLET
a cura di ROSSELLA GAUDENZI
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
IPERCORPO Intervista Un sodalizio lega cinque compagnie nazionali multidisciplinari all’avanguardia
FLAMENCO. Il critico si affidi al
pubblico: c’è una sanguigna Fuensanta
La Moneta tra la luna e gli uomini.
IL LAGO DEI CIGNI Rimpiangendo il passato
e sperando nel futuro senza mai essere soddisfatto del presente: così ho trascorso la mia vita.
IPERCORPO
a cura di Rossella Gaudenzi
«Nanou» è innanzitutto un nome di donna; identifica un
prodotto nato dall’unione di tre persone ma che si riassume in una persona terza. È inoltre il titolo di un film del
1986, è il titolo di una canzone, è il nome di un vulcano
australiano, e in dialetto romagnolo significa «mio caro»
C
ominciamo con il parlare di un network: una rete di progetti collegati tra loro per la condivisione di modi, finalità e programmi. Il network in questione nasce nel 2006 e
si chiama IperCorpo, il sodalizio lega 5 compagnie nazionali
multidisciplinari all’avanguardia: Città di Ebla, Santasangre,
Gruppo Nanou, Cosmesi, Ooffouro. «IperCorpo», il festival di
danza, teatro, musica, video e arti visive (Forlì, 18 settembre-3
ottobre), è giunto alla IV edizione: una sede di sperimentazioni e
confronti, un laboratorio creativo senza confini di genere. La
voce di Marco Valerio Amico, attore e danzatore, racconta il
Gruppo Nanou (finalista del Premio Equilibrio all’Auditorium di
Roma nel 2008), che nasce a Ravenna nel 2004 ed è composto,
oltre a lui, da Rhuena Bracci e Roberto Rettura, in scena a Forlì
con Motel (Faccende Personali)-Prima Stanza.
Gruppo Nanou: la prima curiosità che nasce è sulla natura
di questo nome.
Nanou raccoglie una pluralità di significati: è innanzitutto un
nome di donna; identifica un prodotto nato dall’unione di tre
persone, ma che non incarna nessuna delle tre perché si riassume in una persona terza. È inoltre il titolo di un film (C.
Templeman, 1986), è il titolo di una canzone, è il nome di un vul-
cano australiano. Infine, per rimanere radicati alle nostre origini, in dialetto romagnolo significa «mio caro». Gruppo in quanto fa capo a competenze unite in linea orizzontale e non verticale: le mie di attore e danzatore, quelle di Rhuena di danzatrice
ed ex ginnasta, quelle di Roberto di sound designer ed esperto di
post produzione.
Qual’è la natura del network-festival IperCorpo, e quale
tipo di sinergia lega le 5 compagnie che lo compongono?
Il progetto IperCorpo nasce dapprima dall’interazione delle
compagnie Città di Ebla di Forlì e dei romani Santasangre, volto
ad inventare realtà giovani attraverso un’esperienza di scambio;
i Santasangre rappresentavano una realtà isolata a Roma, che
approdando nella città romagnola ha potuto trovare un confronto reale con diversi artisti, basato su un vero rapporto di amicizia. Claudio Angelini della compagnia Città di Ebla ha poi invitato altri gruppi; abbiamo così trovato un contatto artistico che
ci ha permesso di continuare a sviluppare, come singole individualità, i singoli linguaggi. Non si può assolutamente parlare di
una lobby strutturata al fine di ottenere finanziamenti, né proponiamo un «pacchetto» commerciale che abbia un suo riconoscimento artistico. Non esiste, per dirla in breve, una «generazione
ipercorpo».
L’ultimo lavoro del Gruppo Nanou Motel (Faccende
Personali)-Prima Stanza ha ricevuto un paragone lusinghiero da
parte del critico Rodolfo Di Giammarco: Marco Valerio Amico e
Rhuena Bracci sono stati definiti realizzatori di «tableaux
vivants minimalistici che paiono ispirarsi a stupendi quadri
imborghesiti di Hopper». Un tavolo centrale, due sedie, una gab-
bia per uccellini e un tappeto. Due performers che sembrano
sospesi, quasi una sorta di En Attendant Godot del XXI secolo
rafforzato da magistrali effetti di luci e suoni.
«Lo spettacolo Motel (Faccende Personali)-Prima Stanza,
della durata di 30 minuti, è il primo atto di una trilogia suddivisa in stanze. Elementi forti del nostro lavoro sono, da sempre, i
suoni e le luci. Quanto ai suoni, Roberto procede con un lavoro
di microfonatura, utilizziamo perlopiù suoni reali che vengono
campionati e rielaborati digitalmente. Il risultato è una ‘drammaturgia sonora’ in cui c’è un continuo passaggio tra ciò che è
presente in scena e ciò che è evocato. Le luci vogliono essere di
forte effetto e in questo il lavoro di Fabio Sajiz è esemplare, è in
grado di dare l’effetto di un’intimità spiata, più che gettata
addosso. Il motel è un asettico non-luogo, i due personaggi in
scena lasciano intravedere la preparazione di una cena, ma
lasciano anche ad intendere che qualcosa si svolge al di fuori di
quelle quattro mura».
«Non c’è nessun messaggio da esplicitare, bensì un invito. Il
tentativo è quello di lasciare spazio al vuoto narrativo; lo spettatore può e deve metterci del suo, senza essere guidato nella
visione e nell’interpretazione».
IL LAGO DEI CIGNI
IL
orse più spesso il critico, di qualsivoglia forma artistica, dovrebbe affidarsi al pubblico in sala e tenere
in giusta considerazione - ponderare - il riscontro
che questo pubblico esprime.
Come quello per la terza edizione di «Flamenco!», il
festival creato dalla Fondazione Musica per Roma che ha
riunito per 11 giorni autunnali gli appassionati del flamenco tutto, non trascurando nessuna disciplina nelle tre
categorie rappresentate, cante, toque e baile. Per il
primo, tre interpreti: Esperanza Fernàndez, Diego El
Cigala, El Pele; due per il toque (la chitarra accompagnata dal ritmo di palmas y tacones), il sassofonista valenciano Perico Sambeat e il chitarrista Juan Manuel
Canizares.
Quindi, el baile: quale migliore inaugurazione se non
l’irruenta presenza sulla scena della sanguigna Fuensanta
Fresneda Galera «La Moneta»? Uno strepitoso De entre
la luna y los hombres per un’ora e mezza di struggente
interpretazione. Un plauso che doverosamente si estende
ai chitarristi Miguel e Paco Iglesias, alla cantante Eva
Duran, alle capacità percussive di Josè Carrasco. La
padronanza assoluta di una tecnica solida appresa dai
migliori maestri è rafforzata dalla carica drammatica ed
espressiva che solo l’esperienza formativa di chi si è esibito nei tablaos può possedere.
Non un posto vuoto, il pubblico in visibilio palpita
all’unisono con l’artista. Assiste al cambio di vesti e al passaggio tra i colori tradizionali del flamenco: bianco, nero,
rosso. Assiste al passaggio tra ruoli talvolta nettamente
definiti, talvolta talmente sfumati da perdersi, come in un
gioco: così la virilità dell’hombre può sciogliersi in morbide costruzioni e quello della mujer può oscillare tra una
femminilità sfacciata e un’aggressività ed un piglio felini.
Seducente il gioco di simmetrie che proietta su due
grandi teli la ballerina in video in differenti momenti.
Fuensanta la Moneta diviene una e trina: campeggia sulla
scena in carne ed ossa e si ammira e fa ammirare proiettata sul telone. Poi i fantasmi scompaiono e la ballerina,
nuovamente sola in campo, torna a catturare l’attenzione
generale. Sul palco si è affacciato un intero mondo, o
meglio, uno stile di vita. Tanto distante da quello espresso dal balletto classico da poter sembrare al confronto
addirittura sgraziato. O lo si ama o lo si odia, ma quando
lo si ama ed è così ben fatto il consenso è universale. Non
di Livia Oreste
Questo è il Fato, [...] Invincibile, non lo
domini mai. Non resta che rassegnarsi.
Così tutta la vita è un’alternanza ininterrotta di pesante realtà, sogni fugaci e
fantasie di felicità... Non c’è approdo.
Vaga per questo mare, finché esso non ti
avvolge e ti inghiotte nelle sue profondità.
Lago dei Cigni è il primo dei tre
balletti di P. I. Tchaikovsky che
egli compose con grande entusiasmo tra il 1875 e 1876, traendo ispirazione dalla tradizione favolistica tedesca e dalle tematiche romantiche.
Dall’intenso lavoro nacque una musica
ricca di fascino e di colore che, però,
risultò troppo impegnativa per i ballerini che necessitavano di ritmi più semplici: fu quindi modificata per esigenze
coreografiche.
Quello che sarebbe diventato il
«balletto dei balletti» venne accolto
con grande freddezza e, dopo poche
repliche, ritirato dalle scene. Negli
anni successivi alla sfortunata prima,
la massima autorità allora riconosciuta
nel mondo della danza - il marsigliese
Marius Petipa, impareggiabile maestro di danza del Balletto Imperiale di
San Pietroburgo - progettava una
riforma del balletto, convinto che l’insuccesso non fosse da imputare alla
musica ma all’allestimento. Con l’aiuto del suo collaboratore Lev Ivanov e
del maestro Riccardo Eugenio Drigo,
riordinò le sequenze musicali secondo
più giuste esigenze drammaturgiche.
L’opera, come oggi la conosciamo,
si fonda sui due temi fondamentali
della danza ottocentesca: realtà e
sogno. La calda atmosfera romantica e
la perfetta armonia tra la parte lirica e
quella drammatica fa del Lago dei
www.youtube.com/musicinchannel
I nostri cameramen sono lì fuori
Music In Video è videointerviste, riprese, showreels,
musica in movimento e i vostri video in anteprima
Music In Channel > [email protected]
cigni una delle opere più importanti
del repertorio ballettistico. La poesia
del tema d’amore esercita un fascino
durevole rappresentando la romantica
aspirazione verso un ideale irraggiungibile: la donna-cigno bianca, figura
emblematica ed eterea, alla quale si
contrappone la donna cigno nero,
enigmatica e seducente. Le due figure
celano archetipi e dicotomie dell’amor
sacro e dell’amor profano, di Eros e
Thanatos, del bene e del male.
L’opera è il più completo omaggio
alla bravura della prima ballerina, un
cigno, chiamata ad essere di volta in
volta simbolo di estrema dolcezza o di
assoluta malvagità. Sono necessarie
grandi doti tecniche e interpretative
per comunicare al pubblico lo spessore psicologico e la complessità del
doppio personaggio Odette/Odile:
proprio per questo, al Teatro
dell’Opera dal 27 novembre al 2
dicembre, ci si affida all’interpretazione di grandi ètoile internazionali
del calibro di Svetlana Zakarhova.
Con le sue ideali proporzioni, la tecnica cristallina e la delicata intensità si
dimostra interprete d’eccellenza; ogni
piccolo gesto, ogni passo, ogni port de
bras strega il pubblico. Impossibile
distogliere lo sguardo da un corpo etereo che, come suggerisce ogni passo
sulle punte, tende ad innalzarsi al cielo
con emozioni fortemente terrene.
Music In ! Novembre-Dicembre 2009
KATIA LABÈQUE Shape of my Heart La
falda del mio cappello nasconde gli occhi di
una bestia che solo lei, al piano, sa calmare
QUARTETTO NAZIONALE Senza filtro Stanno abituandoci a sonorità melodiche groove che ci spalancano le orecchie
KATIA LABÈQUE - SHAPE OF MY HEART
CLASSICA
Questo album merita non parole, ma silenzi. Per tale motivo tutto ciò
MENTE che sto per dire deve suonarvi come la lavatrice che gira mentre la
radio passa Chick Corea. Appunto: terza traccia, We will meet again
(Bill Evans) riarrangiata da lui e, mentre il duo suona due pianoforti, la lavatrice è in prelavaggio ma non la si sente più. Non voglio, non devo assolutamente cadere nel tranello,
non io, non quello di dire che i primi due brani - Moon over Bourbon Street e Shape of my
heart di Sting - hanno fatto breccia in quel luogo dentro di me dove l’alcol è l’unico appiglio per amare, un luogo in cui prima solo «Leaving Las
Vegas» mi aveva rinchiuso.
È che adoro girare per New Orleans ubriaca quando
c’è luna piena. La falda del mio cappello nasconde gli
occhi di una bestia, ho il viso di un peccatore e le mani
di un prete. Non posso cadere nella tentazione di
recensire Sting se è lei che lo accompagna, la pianista
preferita di Madonna, cui Miles Davis dedica due brani
- Katia Prelude e Katia (You’re under arrest, 1985) -,
francese e un po’ italiana per una madre, Ada Cecchi,
nata a Torre del Lago ed ex-allieva di Marguerite Long.
C’è in quest’album anche una sorella che non c’è,
Marielle, dalla quale pianisticamente solo qui si separa
(la loro Rapsodia in Blu di George Gershwin ha venduto oltre 500mila copie) e con la quale - fraterna sbalorditiva carriera - ha fondato la KML Recordings per lo
sviluppo e la diffusione del repertorio per due pianoforti. La lavatrice è un rombo, i panni sporchi si lavano in casa.
Ma, mentre io sono ancora sotto una finestra di notte a combattere il mio istinto bestiale sotto una pallida luce lunare, tutt’a un tratto al piano con lei va a sedersi Herbie
Hancock per darmi un classico, My Funny Valentine, qui a Bourbon Street con questa bottiglia mezza vuota, mai mezza piena, di whiskey. Provo a ricordare, me lo ripetevo prima
di ubriacarmi, devo amare ciò che distruggo e distruggere ciò che amo - devo amare ciò
che distruggo e distruggere ciò che amo, come una tiritera insisto ma c’è Chopin, ora.
Lei, sola, Chopin, Prélude n. 4, ed io sotto una luna da lampioni. (Centrifuga).
Gli occhi tesi a guardare la stessa finestra, nessuno si affaccia, poi capisce: ci vuole un
pezzo dei Radiohead (sceglie Exit Music), il lunare Notes to the future e, in formazione B
for Bang (la B sta anche per Beatles) Because, Purple Diamond con David Chalmin, il suo
amato Satie con Gnossienne n. 3 e, al piano con Gonzàlo Rubalcaba in persona, Bésame
Mucho in controtempo, bacio sì e bacio no, come fosse stanotte l’ultima volta. L’ultima
volta è stata già, tanti anni fa. Bésame mucho non si dà ai lupi mannari, non ci voleva.
Ripara, la Labèque, cambiando ancora una volta registro, come piace a lei, con una
Meditation di Bernard Hermann da Wuthering Heights. Tempestosissime, queste cime,
ed è meditando che mi ricordo dei panni.
ROMINA CIUFFA
AMBROSE FIELD & JOHN POTTER - BEING DUFAY
BEYOND
I vasti campi della musica
&further elettronica e delle nuove tec-
nologie si riconfermano territorio fertile per una sperimentazione che non
vuole essere simbolo di ricerca instancabile di
novità intellettuale, ma piuttosto fonte di nuove
interpretazioni e letture di un passato storico
che percepiamo come remoto, troppo spesso
dimenticato se non sconosciuto, alla luce di
come si è trasformata la concezione di arte e
musica al cospetto di una modernità quanto
mai conoscitrice e rispettosa.
Ecco allora Guillame Dufay - il più grande compositore franco-fiammingo di polifonia di tutto il
XV secolo, attivissimo anche in diverse corti italiane e autore imprescindibile per i nostri
monumenti nazionali quali Palestrina e
Monteverdi - rivivere nel 2009, tra sacro e profano, come se dal ‘400 avesse potuto continuare a fare musica, attraversando tutti gli sviluppi e le correnti, per giungere sino ai giorni
nostri cambiato, ma memore delle sue origini.
E le strutture complesse della sua polifonia, in
cui ogni cosa è calcolata a puntino, si specchiano nei paesaggi sonori creati dall’elettronica di
Ambrose Field, vero esperto di musica quadrifonica, magnifico nel creare landscapes artificiali con l’ausilio di suoni campionati dalla natura o dal contesto urbano.
Un’elettronica che si avvale della voce del tenore inglese John Potter, membro dell’Hiliard
Ensemble, con esperienza già maturata nel
campo della musica d’avanguardia; un’elettronica che parte da ciò che è tangibile e lo trasforma nel nuovo ed irrealizzabile; un’elettronica che esplora, pesca, riedita, combina, incide,
sovrincide, trasforma, deforma, trasfigura ma
mai assale né prevale; diventa corpo sonoro,
fascio caleidoscopico polimorfo e quasi intangibile per riflettere la volontà di spingersi oltre le
possibilità della vocalità umana e trascenderle.
Sembra come se la tecnica del «cantus firmus», stra-abusata da Dufay, potesse rivivere
ancora e rendere le sue stesse composizioni
«cantus firmus» di una composizione ulteriore,
più ampia, distesa, immensa, che non è tributo
passivo verso un passato la cui immensità si
estende per secoli (come sempre avviene per
gli artisti «da repertorio»), ma un modo nuovo
ed odierno di «essere Dufay».
Gianluca Gentile
PONENTINO TRIO Ruma Però,
si co’ ‘sto canto, io v’ho svejato,
m’aricommanno che me perdonate
Opera prima del
Quartetto nazionale
finalmente, e senza
filtro. Si realizza così
il progetto da tempo
ambito di 4 musicisti
di grande esperienza, legati da tempo ai
più importanti palchi
del pop-rock italiano e internazionale e agli innumerevoli contributi in studio di registrazione.
Punto di partenza: groove, prelevato da trascorsi rhythm’n’blues, jazz e rock. Percorso: scrittura
di composizioni e arrangiamenti articolati,
aggiunta di soli a ispirazione rock (Jimy Hendrix,
Brian Auger) e jazz (Jimmy Smith). Approdo:
forte componente melodica, totalmente origina-
le. I Fantastic4 sono Alessandro Centofanti
(organo e tastiere), Marco Rinalduzzi (chitarra
elettrica e acustica), Marco Siniscalco (basso
elettrico e acustico), Marcello Surace (batteria),
e superpoteri «progressive».
Ottime sonorità blues innanzitutto, fuse a jazz
e rock, le stesse che hanno iniziato a girare
per Roma e a rendersi note, orecchiate, attraverso i concerti degli ultimi mesi (anche
Marcello Rosa come special guest).
Senza filtro (Rinaldo Musica) propone perlopiù
brani inediti strumentali e vi affianca arrangiamenti complessi con soli strepitosi ne che valorizzano il groove: energia, gusto e raffinatezza
dei musicisti. Linee chiare e semplici in copertina come si richiede a chi fa musica, non grafica. Infatti, contenuto articolato e imperdibile.
Rossella Gaudenzi
a cura di ROMINA CIUFFA
PONENTINO TRIO - RUMA
BEYOND
&further
No, non è un refuso. Questo
album si chiama Ruma, una
possibile etimologia - rilevano che risale alla lingua degli Oschi, popolazione
indoeuropea di ceppo sannitico della Campania
antica pre-romana, cui si riconduce una pluralità
di popoli dell’Italia meridionale. Possiamo scegliere tra due significati: «colle» o «zinna» (la zinna
romana è la tetta italiana). Preferiamo la seconda se diamo rilievo alla presenza, nella nostra
romanità, di una lupa che ci ha sfamato (io, personalmente, la compro perché il mio nome deriva da Romolo). Scegliamo colle, invece, se è
domenica e andiamo a Squarciarelli a fa’ ‘na gita
a li Castelli - traccia 12 - ma è chiaro, ci fa comodo utilizzarli entrambi, a seconda che sia giorno
o che sia notte, per due diversi, irrinunciabili vizi.
La dea Rumina o Ruma era una «zinnona» indigena, protettrice dei lattanti e degli armenti, ed
aveva un sacello in riva al Tevere proprio presso
il fico detto «ruminale». Sotto l’ombra del fico,
nella stagione calda, ruminavano i buoi, mentre i
pecorari andavano al sacello ad offrirle latte.
Oggi là sotto a prendere il ponentino ci va questo
Trio, nato durante la Festa de’ Noantri 2004.
Dà la copertina all’album di Cesario Oliva (chitarra e voce), Daniela De Angelis (voce) e
Costantino Pucci (affabulatore, clown) il «naso-
ne», fontana con la quale abbeveriamo i turisti
che ci sfamano. Questo bel Ruma - dopo un precedente Roma, lo senti er Ponentino? scalpitavo
sotto al fico perché Rumina ne benedisse un
secondo - raccoglie ancora repertorio romanesco con le più belle canzoni antiche e moderne e
i testi basati sulle poesie di Trilussa, Belli,
Pascarella etc. (c’è un affabulatore nel gruppo).
Tra cui La povera Cecija, Sinnò me moro, Li
nummeri, Cristo al mandrione, Il walzer della
toppa, Più semo
e mejo stamo,
che ad ascoltarli
«nde ‘sta serata
piena de dorcezza pare che nun
esisteno dolori»
(Nina, si voi dormite).
Loro
cantano
tanto pe’ cantà,
noi li ascoltiamo
perché ce piaceno. E - nostalgia di
Gabriella Ferri - accade un classico: il friccicore
ar core (mettice ‘na pezza).
Romina Ciuffa
MONO - HYMN TO THE IMMORTAL WIND
ALTER
NATIVE
Quinto lavoro in
studio per i Mono,
quartetto capitanato da Takaakira
Goto, composto
da Tamaki Kunishi,
Yasunocri Takada
e Yoda.
Sette le tracce che costituiscono Hymn to the
Immortal Wind (Conspiracy Records, 2009),
concept album vecchio stampo prodotto da
Steve Albini (Nirvana, Sonic Youth, Pixies,
Neurosis, Mogwai), centrato su cupi noises e
un’orchestra di 30 elementi, tra archi tardoromantici, fiati, arrangiamenti sovrapposti e
danze emotive sostenute da percussioni tipi-
camente orientali. Sound dove l’intimità dell’emozione si mostra nuda e impotente di fronte alla forza espressiva del gruppo, alla sua
necessità di suonare, di farsi ascoltare attraverso milioni di mp3 sincronizzati.
I Mono dosano sempre con molta sapienza la
forza dei live, con la cura dei suoni digitali delle
loro produzioni. Ashes in the Snow, Battle to
Heaven o Burial at sea, sono esempi della profonda volontà di rappresentare il dramma dei
corpi e delle note in conflitto, che il ‘vento
immortale’ dei Mono trasforma e doma continuamente. Un post-rock visionario e sinfonico
che in Italia ancora non trova riscontro, forse
anche per la miopia delle corporazioni della
mediocrità targate MTV o X-Factor.
Flavio Fabbri
GRAZIA DI MICHELE - PASSAGGI SEGRETI
PO
PCK
pop&rock
La separazione
vista attraverso
la stortura della
guerra (Anja), la disperazione
dei clandestini, la solitudine del
carcere, le dinamiche dell’amore (Il resto è vita, Fino all’ultima
carezza), ma anche la tensione
erotica che attraversa la vita
nelle sue varie fasi (Allo sbaraglio, Autunno perfetto), fino
all’ironica rappresentazione dei
modelli televisivi.
Grazia Di Michele dà alla luce un album bello e
controcorrente, in un periodo in cui i cantautori scelgono di rifugiarsi nell’intimismo puro.
Argomenti importanti e nessuna vuota retorica: uno sguardo attento sulla realtà, per offrirci una chiave di lettura emotiva. All’intenso lirismo dei testi corrisponde una trama melodica
sapientemente semplice, arricchita da arrangiamenti originali: ottimo il lavoro di Filippo De
Laura che è riuscito a inserire con gusto e ele-
ganza strumenti di altre
terre (tra cui stick, dholak,
tabla, banjo indiano) in un
tessuto armonico tradizionale, ribadendo col suono
l’universalità dei temi trattati (tra tutte si ascolti Il diritto di amare).
Collaborazioni col brindisino Bungaro - nella scrittura di due brani - e con il
poeta Raffaele Pietrangeli
in altri due. Elementi che
uniti alla versatilità interpretativa di Grazia Di
Michele, che si muove con disinvoltura tra
armonizzazioni jazz (Il mare in una stanza), folk
(Caterina) e pura linea melodica (duetta con
un insolito Massimo Ranieri ne L’amore va in
scena), contribuiscono a fare di Passaggi
segreti uno dei migliori album cantautorali italiani degli ultimi tempi.
Nicola Cirillo
MASSIVE ATTACK - SPLITTING THE ATOM
QUARTETTO NAZIONALE - SENZA FILTRO
J AZZ
& blues
FEED
back
ALTNATIVE
ER
C’era una volta il trip hop. Se si
dovesse pubblicare un libro sul
fiabesco suono degli anni 90, il
capitolo sui seminali Massive Attack inizierebbe così. Ma il favoloso stile della band di Bristol
non si smentisce neppure nel nuovo millennio
e il recentissimo Splitting the Atom ne conferma il talento in maniera inequivocabile.
Quattro nuovi brani, usciti
dopo posticipi durati un
anno, preludio di un album
previsto nel 2010.
Gli ingredienti sono ormai
un classico: ritmiche legate
alla dance più urbana,
arrangiamenti eterei, melodie ipnotiche e attitudine
cinematografica. Non mancano le belle voci. Per la
title track il gruppo si è affidato a due personaggi divenuti presenze caratterizzanti di ogni
produzione firmata Massive: Daddy G e
Horace Andy, un uomo che è parte essenziale
dell’intera storia del reggae. In Pray for the
Rain è Tunde Adebimpe dei Tv On The Radio
ad accompagnare il gruppo, mentre le corde
di Martina Topley Bird colorano una nuova versione di
Psyche, curata da Van
Rivers & The Subliminal Kid.
C’è anche un altro remix,
quello di Bulletproof Love,
composto da Christoff
Berg, con tanto di featurig
di Guy Garvey degli Elbow, a
chiudere questo capitolo
della saga.
Stefano Cuzzocrea