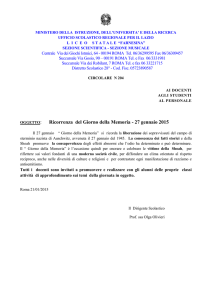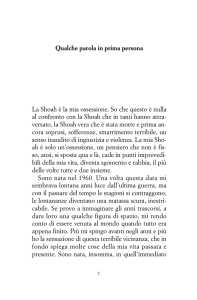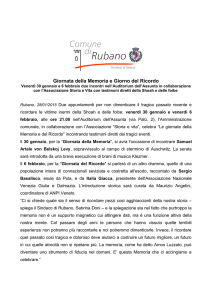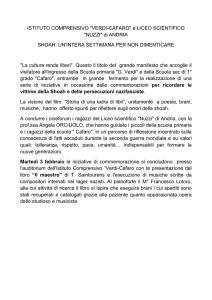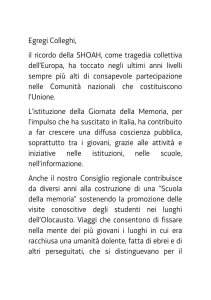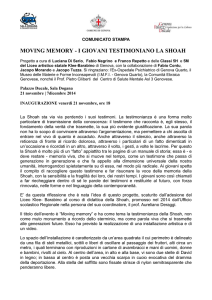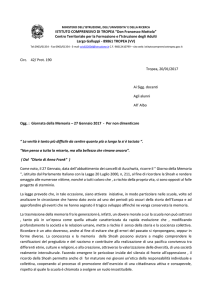DIFENDERSI DALLA MEMORIA?
Appunti per un buon uso del ricordare
Raffaele Mantegazza
Università di Milano-Bicocca
Che ne facciamo della memoria? Già Friedrich Nietzsche ammoniva attorno ai rischi di un eccesso di
passato, di una ipertrofia della memoria: il passato inteso in senso monumentale o archeologico
rischia di seppellirci sotto il suo peso: “l’uomo (…) resiste sotto il grande e sempre più grande carico
del passato: questo lo schiaccia a terra e lo piega da parte, questo appesantisce il suo passo come un
invisibile e oscuro fardello”1. Troppo da ricordare? Più che altro niente che valga la pena ricordare,
niente che riguardi noi e la nostra vita qui ed ora, in questa mole di dati da tenere a mente. Come
quando contempliamo una discarica a cielo aperto ci è difficile scegliere qualcosa da salvare, così
quando la nostra memoria è affollata da oggetti che sembrano tutti uguali è difficile utilizzare la
memoria stessa come elemento di salvezza nei confronti di alcuni oggetti o di alcuni eventi. Ed è nota
la tragedia umana di Ireneo Funes, il giovane immaginato dalla fervida fantasia di Jorge Luis Borges:
caduto da cavallo, egli perde la facoltà dell’oblio ed è condannato e ricordare tutto: “Mi disse: - Ho
più ricordi io da solo, di quanti ne avranno avuti tutti gli uomini messi insieme, da che mondo è
mondo -. Anche disse: - I miei sogni, sono come la vostra veglia -. E anche: - La mia memoria, signore,
è come un deposito di rifiuti”2. Senza la possibilità di cancellare le memorie, senza la salutare spugna
dell’oblio che cancella dalla mente qualche ricordo, il risultato è la pazzia, o l’immobilità perenne:
“Allora vidi il volto di quella voce che aveva parlato tutta la notte. Ireneo aveva diciannove anni; era
nato nel 1886; mi parve monumentale come il bronzo, ma antico come l’ Egitto, anteriore alle
profezie e alle piramidi. Pensai che ciascuna delle mie parole (ciascuno dei miei movimenti)
durerebbe nella sua implacabile memoria; mi gelò il timore di moltiplicare inutili gesti.”3
Il secolo dell’assenza di memoria, della proliferazione di tecnologie che ricordano al nostro posto (in
modo che i ragazzi non ricordano più l’ordine alfabetico perché Wikipedia non richiede tale
competenza, e molti di noi non memorizzano più i numeri di telefono dal momento che il portatile lo
fa per noi) rischia per altri versi di essere il secolo dell’eccesso di memoria: di una memoria obbligata,
del ricordare imposto per decreto, di una memoria che non è scelta ma vincolo. Forse oltre che a
difendersi con la memoria occorre insegnare ai giovani a difendersi dalla memoria: da un suo uso
sbagliato che è spesso legato a una sua ipertrofia, a un trattamento della memoria che la considera
unicamente come magazzino all’interno del quale stipare dati.
Come possiamo pensare che i nostri figli e le nostre figlie ricordino semplicemente perché li
obblighiamo a farlo? Come possiamo pensare ciò soprattutto a proposito della Shoah, di un evento
cioè che non hanno vissuto. E’ possibile ricordare al posto di un altro? E’ possibile fare memoria di
eventi che sono stati vissuti da testimoni che oltretutto lentamente ci stanno lasciando? E quando
l’ultimo o l’ultima testimone della Shoah se ne sarà andato, come faremo a ricordare? Alcune tesi
attorno alla memoria potranno forse aiutarci nel compito di definire un buon uso pedagogico della
memoria medesima.
La memoria è sempre suscitata da un incontro con un evento, una persona o una situazione. Roberto Benigni
afferma che la sua vita non è stata più la stessa dal momento in cui ha iniziato la lavorazione di La vita
è bella. E’ stato l’incontro con la Shoah, avvenuto in età adulta, a suscitare il desiderio di memoria e di
fare memoria in un attore che si era occupato di altro. Benigni sapeva benissimo che la Shoah aveva
1
Friedrich Nietzsche, Sul danno e l’utilità della storia nella vita, cit. pag. 7
Jorge Luis, Borges, Funes o della memoria, in Finzioni ora in Tutte le opere, vol. I, Milano, A. Mondadori
3
Ibidem
2
avuto luogo e ne aveva sicuramente orrore; ma tutto questo a un livello superficiale, finché l’incontro
con la Shoah non ha smosso qualcosa dentro la sua sensibilità. Lo stesso vale per la memoria in sede
educativa. I giovani e le giovani non ricordano solo la Shoah ma ricordano il momento in cui hanno
incontrato la Shoah: e se l’hanno incontrata all’interno di un cinema nel quale veniva proiettato
Schindler’s List tra gli schiamazzi di decine di adolescenti, o se l’incontro è avvenuto per la risposta un
po’ annoiata di un docente all’obbligo di celebrare il 27 gennaio (due esempi ai quali abbiamo
assistito personalmente) è del tutto ovvio che non verrà attivato alcun desiderio di memoria. Anche
l’incontro con il testimone, con l’ex-deportato, di per sé non ha un automatico valore di attivazione
della memoria: le risate con le quali alcuni studenti di un ITIS del circondario milanese hanno
accolto una ex deportata nel 2008 ne sono la triste testimonianza. L’incontro con la Shoah deve
essere preparato educativamente; il che significa in primo luogo che esso deve essere preparato a
livello didattico, attraverso la presentazione delle date e degli eventi che hanno segnato questo
avvenimento: si può essere critici finchè si vuole nei confronti dell’importanza delle date, ma non
sapere collocare un evento nella storia lo trasforma in mito; e la Shoah tutto è stato tranne che un
mito, e chi la vuole trasformare in questo senso le fa perdere il potenziale educativo che essa possiede.
Ma l’importanza della preparazione dell’incontro significa soprattutto che l’incontro deve avvenire
all’interno di una scuola, un gruppo di formazione, un gruppo scout, un oratorio nel quale i ragazzi e
le ragazze sono abituati a incontrare l’altro; è sconcertante il fatto che si pensi di poter trattare la
Shoah in contesti educativi nei quali si verificano episodi di razzismo, di intolleranza, di
marginalizzazione e gli adulti non vogliono o non sanno intervenire. Qual è allora in senso di un
incontro con la Shoah in queste situazioni se non un ipocrita e vago intento moralistico? L’incontro
con la Shoah suscita memoria se fa riflettere sul presente; e allora nelle situazioni sopra descritte esso
avrebbe senso se suscitasse una riflessione sule pratiche di umiliazione che alcuni ragazzi mettono in
atto, e se fosse in grado di far nascere un processo di memoria a proposito di queste pratiche. Occorre
allora preparare il terreno all’incontro con la Shoah come si prepara un incontro tra innamorati:
tenendo conto dei dettagli, preparandosi anche fisicamente (ricordiamo una insegnante di una scuola
superiore monzese che mentre parlava un testimone fece portare alle sue ragazze le pizzette per la
merenda di metà mattina) , capendo che si sta per incontrare qualcosa che scuoterà le nostre attuali
abitudini; e questo è compito specifico e precipuo di insegnanti ed educatori. Crediamo infatti che il
tema dell’incontro sia essenziale a proposito della memoria non solo parlando di Shoah,ma che esso
caratterizzi il lavoro della scuola e dell’insegnamento: che cosa altro significa insegnare se non allestire
e preparare incontri con oggetti di cultura, incontri sufficientemente significativi da stimolare e
suscitare memoria? Crediamo veramente che un bambino possa ricordare in modo profondo “2+2=4”
indipendentemente dal contesto, dall’evento, dal momento nel quale ha incontrato questa
uguaglianza?
La memoria è sempre figlia di un progetto politico. Non c’è alcun obbligo di memoria: possiamo
tranquillamente dimenticare, e per fortuna lo facciamo tutti i giorni. Ma allora, chi decide che cosa
ricordare e che cosa dimenticare? La memoria è sempre legata a un progetto: la memoria individuale è
legata a una progettualità che può essere di breve o medio termine o può coinvolgere un progetto di
vita; la memoria collettiva è legata a un progetto politico: è il tipo di società che vogliamo costruire a
selezionare i ricordi che ci servono, è il modello di convivenza umana che abbiamo in mente per il
futuro a determinare la portata, l’ampiezza e la tipologia della memoria. Anche i totalitarismi fanno
largo uso della memoria: basti pensare al ciarpame pseudo-romano con il quale il fascismo intossicò le
piazze italiane. La democrazia ha fatto proprie alcune memorie e ne ha lasciate per strada altre:
un’analisi delle politiche della memoria in Italia dal 1945 ad oggi parlerebbe della progettualità
politica dei gruppi dominanti molto più dell’analisi dei mezzi di propaganda e di campagna
elettorale. La memoria dunque è sempre una posta in palio in un conflitto politico: e la memoria
della Shoah si nutre di un progetto politico che prevede la costituzione di una società di eguali, libera
dalla violenza e dal dominio, e sa che questo progetto deve lottare per potersi affermare; e deve
lottare contro gli stessi avversari che nel XX secolo hanno scatenato il demone dell’Olocausto. “Solo
quello storico ha il dono di accendere nel passato la favilla della speranza, che è penetrato dall’idea che
anche i morti non saranno al sicuro dal nemico, se egli vince”4. Oggi come e forse più di ieri, il
discorso sulla Shoah è un discorso politico: un discorso che mette in campo la possibilità di vivere in
una società realmente pacificata. Ma questo significa anche che in una democrazia la memoria può
essere solamente plurale: occorre dunque parlare di memorie piuttosto che di memoria; questo però
può accadere solamente a patto di rispettare la regola aurea per la quale nessuna memoria ne può
escludere altre. Le uniche memorie che non hanno diritto di cittadinanza all’interno di una
democrazia sono le memorie che tendono a cancellare altre memorie, a negare loro il diritto ad
esprimersi. Il confronto tra memorie, però, è pubblico e politico, e deve sempre ancorarsi all’uso dei
documenti: il cosiddetto uso pubblico della memoria, ovvero il fatto che la memoria in una
democrazia deve sempre dare luogo a un confronto e un conflitto pubblici, non può fare a meno
dello “zoccolo duro” costituito dalla documentazione. Presentare un documento, sottoporlo a critica,
difenderne l’autenticità o smascherarne la falsità, comprendere le dinamiche che hanno portato alla
sua redazione, alla sua tradizione, alla sua conservazione, capire come mai esso è rimasto sepolto per
anni per poi comparire sulla scena pubblica; questo è fare memoria, purché a tutte queste domande si
affianchi la discussione attorno alla questione principale: qual è l’intento politico, esplicito o
implicito, che giace dietro la presentazione di questo documento da parte dello storico? Anche la
memoria allora necessita di quella domanda di senso che ci sembra sempre più la grande assente nei
processi educativi e formativi; perché e per chi stiamo facendo memoria? Per quali soggetti, per quali
mondi, per quale società, per quale politica?
Esiste una memoria oggettiva. La centralità del documento ci porta a una considerazione che ci sembra
essenziale per qualunque lavoro sulla memoria, e sulla Shoah in particolare: la deleteria moda di
certa ermeneutica bizzarra per la quale tutto è interpretazione se non interpretazione di
interpretazione, e lo zoccolo duro della realtà, della verità oggettiva, è semplicemente un residuo
ideologico, ha portato a perdere del tutto di vista la realtà stessa nel delirio di un universo di discorsi
e di discorsi sui discorsi. E’del tutto paradossale che sia proprio l’ermeneutica a perdere di vista il
testo; soprattutto se si pensa all’ermeneutica biblica, che non solo prevedeva e prevede la materialità
del testo ma che si preoccupa di non variarne “nemmeno una jota”: l’ermeneutica del nulla che
legittima ogni discorso e non vuole creare “gerarchie di verità” (perché la verità per essa altro non è
che un gioco linguistico) porta letteralmente alla perdita del documento che naufraga sotto le parole
che gli vengono sovrapposte; ma insieme al documento va perduto anche l’evento, il fatto, la vita.
Possiamo baloccarci con l’idea che ogni discorso è equidistante da un inesistente centro: ma se ogni
discorso è in realtà un discorso sul discorso e la realtà stessa ha semplicemente una struttura
discorsiva, perché non dovrebbe essere allora preso in considerazione e legittimato il discorso secondo
il quale i Lager furono invenzioni delle potenze alleate e lo ZyKloN B era un gas usato per lo
sterminio dei topi ? Se non consideriamo i documenti che ci parlano di Auschwitz come di una realtà
oggettiva, che cosa distingue in fin dei conti il discorso di un Primo Levi da quello di un David Irving,
principe dei negazionisti? E se prendiamo in considerazione la posizione di fronte alla verità dal
punto di vista dell’equidistanza, che cosa distingue il discorso di un deportato per il quale le camere a
gas erano il punto finale di un processo di annientamento, da quello di un aguzzino che le esalta e le
ritiene essenziali allo sviluppo dell’Umanità? La fragilità della verità non va confusa con la sua
irrilevanza o addirittura inesistenza: esiste infatti una verità dell’oggetto: sospendendo timidamente il
discorso attorno alla possibile esistenza di una verità assoluta dobbiamo ammettere l’esistenza di un
4
Walter Benjamin, Tesi di filosofia della storia, in Angelus Novus. Saggi e frammenti,Torino, Einaudi, 1962, Tesi VI, pag. 78
sottolineature dell’Autore
verità oggettiva per ciascuno tra gli oggetti che ci circondano. E’ oggettivamente vero che il vetro può
rompersi; è oggettivamente vero che sei milioni di esseri umani sono stati massacrati ad Auschwitz.
Nessun relativismo gnoseologico, nessun estremismo ermeneutico, nessun pensiero debole può
essere così idiota da contestare a queste due affermazioni il loro carattere di verità. E finché l’umanità
popolerà la Terra, o almeno finché la Terra sarà popolata da qualcosa che ambisca alla dignità di
umano, nell’oggetto Auschwitz sarà insito il contenuto di verità dei sei milioni di innocenti uccisi.
Altrimenti, è il delirio del relativismo, il laido conato del revisionismo. La testimonianza attorno alla
Shoah è dunque sempre un testo che fa appello a una materialità della memoria, alla memoria
dell’oggetto specifico, a quella memoria che spinge a porre la domanda: “E’ vero quello che dicono?”
“I fatti narrati sono accaduti veramente?”. E le testimonianze che si spacciano per vere non essendolo
vanno smascherat, anche se dovessero porsi dal lato delle vittime: il caso di Binjamin Wilkomirski e
del suo libro Frantumi5, opera di finzione spacciata per autobiografia e poi smascherata, costituisce sia
un monito (operazioni del genere non fanno che rinforzare le menzogne dei negazionisti) sia
un’occasione perduta (Frantumi avrebbe potuto essere un bellissimo romanzo se solo avesse esibito fin
dall’inizio il suo carattere di finzione). Lavorare sulla Shoah significa far rientrare dalla finestra nelle
nostre scuole l’ospite che decenni di iconoclastia antimaterialista e di giochetti pseudo-filosofici da
perditempo hanno contribuito a esiliare: la verità, il racconto documentato, preciso e innegabile di
come sono andate realmente le cose.
La memoria non è il ricordo. “Ricordare” deriva da “ri-accordare”, nel senso di “rimettere nel cuore”; il
ricordo soggettivo sgorga quando un evento, un sapore, un suono fa vibrare le corde del cuore
(“cor/cordis”) all’unisono con la vibrazione che esse sperimentarono anni prima, un po’ come accade
alle corde di due chitarre perfettamente accordate: la corda di una di esse inizia a vibrare quando si
sfiora l’altra. Il ricordo soggettivo non ha bisogno della precisione della memoria: non conta tanto
memorizzare esattamente quale sonata di Brahms mi faceva addormentare, la cosa importante è il
sentimento che provavo e che viene suscitato oggi al limite anche solo un accordo; un accordo che
potrebbe essere stato ripreso da un compositore successivo, per cui quella che sto ascoltando ora non
è la stessa sonata anche se suscita la stessa eccitazione emotiva. E’ la tonalità affettiva a decidere
dell’efficacia del ricordo, che non può essere dunque sottoposto ad alcun processo di validazione dal
punto di vista della verità oggettiva: nessuno si sognerebbe di chiedere a Proust se da piccolo veramente
intingesse la madeleine nel tè a Combray. Freud ci ha insegnato che per l’inconscio è del tutto
indifferente sognare di uccidere nostro padre, fantasticare a occhi aperti di commettere questo
omicidio o commetterlo nella realtà; ma per nostro padre cambia molto a seconda di quale opzione
si sceglie. La memoria dunque non è indifferente alla realtà dell’evento: il ricordo ha tutto il diritto di
essere impreciso, non così la memoria, che invece necessita di precisione per poter tramandare
l’evento stesso. Perché la memoria è legata alla necessità del tramandare, del “tradere” (da cui deriva il
termine “tradizione”), del passare di mano in mano; il ricordo è un fatto privato mentre la memoria è
un fatto sociale, il ricordo può fermarsi all’attimo presente mentre la memoria si proietta sul futuro e
riguarda la trasmissione intergenerazionale, il ricordo fa appello alle emozioni mentre la memoria si
situa allo snodo tra mondo emotivo e mondo razionale. Per questo motivo è alquanto rischioso
ancorare il discorso sulla Shoah unicamente sul versante emotivo; sicuramente anche l’aspetto
emotivo è centrale nell’incontro con la Shoah, e destare la ragione con la scossa delle emozioni è un
inizio della possibile comprensione, ed è del resto il segreto di ogni attività educativa. La cosa
importante è che il matrimonio tra ragione ed emozioni (e le emozioni senza ragione sono cieche, la
ragione senza emozioni è vuota) scuota le coscienze dei ragazzi e delle ragazze facendo loro capire che è
di noi e di loro che si sta parlando quando si tratta il tema della Shoah; e che proprio per questo
motivo occorre una esatta memoria, che si confronti con le cifre e le date, i documenti e i dati. Siamo
5
Binjamin Wilkomirski, Frantumi, Milano, Mondadori, 1988
concordi con chi sostiene che il primo approccio a questi temi può collocarsi sul versante emotivo, ma
subito dopo deve subentrare la ragione, con la sua capacità di analizzare, criticare, catalogare e
confrontare. La memoria sa contare e sa giudicare: sa distinguere la qualità e la quantità degli eventi;
non si confonde attorno all’identità delle vittime e ai nomi dei carnefici. Il crimine peggiore che
possiamo commettere contro la memoria è annacquarla nell’acqua vagamente colorata del ricordo
soggettivo, all’interno del quale non sono possibili distinzioni quantitative, non esistono nomi e dati
e sostanzialmente non esistono più responsabilità. Così la memoria della Shoah annega nel ricordo
all’interno del quale siamo tutti uguali: “non siete più l’altra razza, l’antirazza, il nemico primo del
Reich Millenario: non siete più il popolo che rifiuta gli idoli. Vi abbiamo abbracciati, corrotti,
trascinati sul fondo con noi. Siete come noi, voi orgogliosi: sporchi del vostro sangue come noi.
Anche voi, come noi e come Caino, avete ucciso il fratello. Venite, possiamo giocare insieme”6. Il
principale dovere della memoria è saper distinguere il vero dal falso. E se nel processo analitico non
esistono a rigore ricordi veri e ricordi falsi, ciò non vale per la memoria: le memorie false sulla Shoah
sono state usate da decenni e devono essere combattute sottraendo lo studio della Shoah allo
scivoloso esclusivo appannaggio della dimensione emotiva; perché se le emozioni non si giudicano le
azioni sì, eccome.
La memoria non esisterebbe senza l’oblio. Occorre tempo per comprendere il male, soprattutto per chi
l’ha subito da vittima innocente. Occorre un distanziamento per poterne parlare: lo dimostra il fatto
che molti deportati e molte deportate hanno iniziato a raccontare le loro storie dopo decenni, molti
non l’hanno mai fatto, altri non lo faranno mai; molti non sono più tornati nei luoghi nei quali
hanno subito le torture e annientamenti. Il rispetto del silenzio del testimone della vittima si colloca
in primo piano quando si parla di memoria, soprattutto in una società massmediatica nella quale
l’estorsione della memoria sembra diventata una regola; non c’è strage nella quale non compaia il
giornalista che chiede ai parenti delle vittime “cosa stanno provando; non c’è massacro che non venga
ricostruito nei particolari più macabri dall’imbecille di turno con plastico a seguito. Il rispetto del
pudore di chi non sa o non vuole parlare della propria sofferenza è la base di una politica della
memoria che non si vende al circo mediatico. La necessità di un certo grado di oblio è un dato
costante nelle storie di chi ha subito una violenza; per poter essere in qualche modo oggetto di
discorso, la ferita non può essere provata con la stessa bruciante intensità del momento in cui è stata
aperta. La memoria richiede l’oblio, e non potrebbe sussistere senza quest’ultimo; ovviamente si tratta
dell’oblio salutare che cancella il dolore acuto della ferita ma non la cicatrice. E’ a partire da questa
relazione dialettica tra memoria e oblio che può essere posta la questione del perdono, troppo
disinvoltamente posta sotto il segno ambiguo della “riconciliazione”; Come dimostra lo straordinario
esempio del Sudafrica e della Commissione per la Verità e la Riconciliazione 7, solo l’affiancamento
dei due termini che danno il nome alla Commissione (verità e riconciliazione) rende possibile
l’apertura al futuro e il superamento, almeno parziale, del carico di dolore del quale le testimonianze
sono gravide. Solo se esiste una speranza di futuro e una richiesta esplicita di perdono e di
conversione da parte dei carnefici è possibile che la memoria apra al perdono. E’ importante peraltro
sottolineare che nessuno può perdonare al posto di un altro: gli unici soggetti che possono perdonare
l’offesa sono coloro che l’hanno subita, anche se ciò significa che vi sono sei milioni di offese che non
saranno mai perdonate: il perdono per procura è offensivo prima ancora di essere impossibile. Il
tempo è un elemento essenziale per il perdono proprio perché il tempo apporta quell’elemento di
oblio che l’immediatezza dell’offesa non permette; lo scorrere del tempo sblocca la situazione alla
quale vittima e carnefice rischiano di essere inchiodati e può permettere una nuova relazione
reciproca. Occorre però ricordare che vi sono azioni che sono imperdonabili: si perdona
6
Primo Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1991 pag. 25pag., 41
Verità senza vendetta. Materiali della commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione, Roma, manifesto,
1999
7
eventualmente l’esecutore ma non l’azione, che nel caso della Shoah è talmente fuori dall’umano da
non permettere alcun tipo di riconciliazione8. Educare all’oblio è allora altrettanto importante che
educare alla memoria; il che significa insegnare ai giovani a sbloccare il corso del tempo quando
commettono un’offesa (e dunque imparare a chiedere perdono) e quando la subiscono (e dunque
sottrarsi al cerchio magico delle conseguenze dell’offesa, all’identità rattrappita e bloccata nella quale
essa può imprigionarci). Nessuna offesa subita può cristallizzarci per sempre nell’identità della vittima
così come nessun essere umano può essere bloccato nell’identità che ha assunto quando ha fatto del
male; una persona che ha ucciso non è un assassino e attraverso l’oblio filtrato dall’assunzione di
responsabilità e della richiesta di perdono non può cancellare la sua colpa ma può fare i conti con
essa in una nuova identità. Non è qui in gioco tanto la questione giuridica della imprescrittibilità dei
crimini contro l’umanità ma quella psicologica della possibilità di non continuare a rivivere una
specie di film continuamente riprodotto in loop nel quale sia la vittima sia il carnefice rimangono
bloccati nel’azione che li definisce come tali. L’oblio è la garanzia contro l’ipertrofia della memoria
dal momentoche la politica della memoria può servire per costruire un mondo migliore ma anche per
legittimare ulteriori massacri; lo si nota ad esempio nel modo in cui la memoria conferisce ossigeno al
conflitto israelo-palestinese, da entrambe le parti: se ogni autobomba risveglia negli ebrei il ricorso
della Shoà e ogni casa distrutta riattiva la memoria del Nakhba (la catastrofe della espulsione del
popolo palestinese nel 1948) e soprattutto se c’è nelle elite al potere chi utilizza queste riattivazioni
della memoria per legittimare il prossimo attentato o la prossima operazione militare contro i civili, è
forse allora preferibile una sorta di moratoria sulla memoria, che certo non porti a dimenticare ma
semmai a riattivare la memoria aprendola al suo significato più umano e più solidale.
Compito dell’educazione non è fare memoria ma far fare memoria
“Fare memoria” è compito degli storici: indubbiamente l’educazione può insegnare ai ragazzi e alle
ragazze le metodologie della ricerca e le dimensioni del sapere storico, ma il suo compito primario
non è fare memoria. Non lo è,a rigore, nemmeno nel senso di raccogliere le memorie dei ragazzi e
delle loro famiglie, una operazione che ha senso se è delimitata e studiata nei dettagli in sede di
programmazione: alcuni ragazzi e alcune famiglie possono (legittimamente) non avere alcuna voglia
di raccontare la loro storia, e l’istigazione al discorso propria di certi approcci autobiografici rischiano
di violare questo pudore. Semmai la scuola e le istituzioni educative devono aiutare i ragazzi e le
ragazze a “far fare memoria”, nel senso che il loro compito è aiutare i giovani e le giovani a diventare
dei raccoglitori di memorie. Soprattutto di memorie altrui: perché la questione fondamentale che
mette in scacco il sapere autobiografico è il fatto che la memoria è sempre relazionale e ha bisogno
sempre di un “altro” che la susciti e la raccolga. Le parole di Giorgio Vigolo in questo ci sembrano
fondamentali: nel momento in cui si scrive la propria storia, si ripercorre la propria memoria, non si
attinge mai da soli a una dimensione di verità; solo la finzione coscientemente perseguita mette
l’autobiografia al riparo da tentazioni auto assolutorie o auto colpevolizzanti: “Prova l’invenzione,
quasi fossero fatti altrui: prova a buttarti alla ventura di una favola che tu creda d’andare intessendo
per sola vena di fantasia. Io penso che a quel modo ti riuscirà di sventare il divieto che, a tua
insaputa, ti tiene lontano da quella regione della memoria: il custode ti lascerà passare credendoti un
altro. Ma tu finirai con l’accorgerti che, dove credevi di inventare, lì solo veramente sei riuscito a
ricordare”9. Ma se la nostra memoria può dare luogo a un romanzo, la memoria dell’altro dà luogo a
un percorso di verità. Ecco perché occorre sempre l’altro per fare memoria. I ragazzi e le ragazze che
concludono un percorso sulla memoria devono avere imparato a cercare le memorie: il che significa
che un percorso sulla Shoah non si considera riuscito se i giovani e le giovani manifestano orrore e
8
9
Per la tematica del perdono cfr. Vladimir Janchelevitch, Il perdono, IPL, Milano 1969
Giorgio Vigolo, Autobiografia immaginaria, Milano, Mondadori, pag. 37
sdegno per quanto accaduto, ma se cercano strategie e metodologie per raccogliere le memorie degli
oppressi qui ed ora: se iniziano una ricerca sulla situazione dei disabili nelle nostre città, se entrano in
un campo rom per intervistare le donne a proposito delle loro condizioni di vita, se popolano le case
protette e gli ospedali con i loro taccuini e i loro registratori, se chiedono ai loro coetanei omosessuali
come vivono la loro diversità in una società omofoba. A questo punto dunque ciò che resta da fare
alla scuola e all’educazione è suscitare fame di memoria: il che significa restituire al sapere storico la
sua forza e il suo fascino, renderlo appetibile e gradevole senza farlo scadere a giochino da tavolo e
senza nulla fargli perdere del suo rigore. E infine, lavorare con la memoria, far venire appetito di memoria,
significa anche sapere quando alzarsi da tavola: il lavoro sulla memoria deve finire, deve superare quella
che Freud definirebbe “melancolia”, la patologica fissazione a un evento luttuoso del passato, per
entrare nei territori del lutto, ovvero dell’elaborazione del dolore e del male in direzione di un futuro
possibile. In questo modo la memoria si trasforma da possibile carcere in apertura al possibile.
L’unico modo per difendersi dalla memoria attraverso la memoria è farne un’arma per costruire un
diverso futuro.