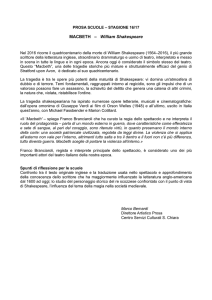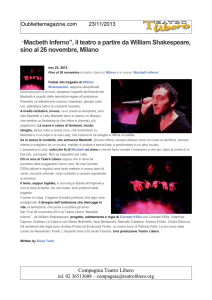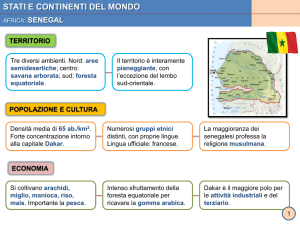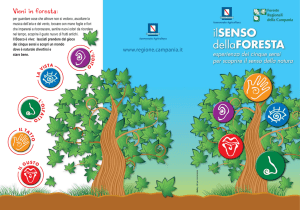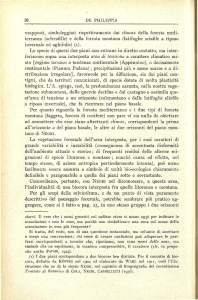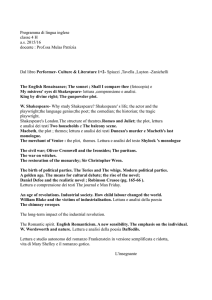9. JOHN BLUMENTHAL
Trono di sangue 1
Trono di sangue di Akira Kurosawa (1957) è la sola operazione che conosca di trasformazione di un
testo shakespeariano in un film, che sia perfettamente riuscita. Quello che è importante è che il film è di
per sé un capolavoro, e il primo di questogenere. Fino ad ora, gli adattamenti da Shakespeare per lo
schermo sono stati perpetrati(questo è l’unico termine che posso usare) principalmente da persone il cui
primo amore era il teatro. Forse è così che deve essere. Forse Trono di sangue è un’aberrazione e
veramente i film-makers di talento cercheranno sempre di liberarsi da quel temibile medium che è la
letteratura, così da potersi concentrare a raccogliere esperienze per farne materia per il cinema.
Suppongo sia anche possibile sostenere che gli adattamenti da Shakespeare per lo schermo debbano
essere lasciati ad artisti come Olivier, così che essi possano portare i loro magnifici soliloqui e le loro
ricostruzioni del Globe Theatre al pubblico di provincia: anche questa è una funzione importante del
cinema. Ma allora, chi può dire dove trovino l’ispirazione registi come Kurosawa (che e l’opposto di un
uomo di teatro), specialmente quando riescono a fare film bellissimi?
Per quanto possa essere facile filmare un’opera teatrale, è veramente un’altra cosa farne un film. Orson
Welles, che ha rivelato il suo genio in entrambi i media, è un buon esempio a riguardo. Egli ha cercato
di fare film tratti da due opere di Shakespeare e ha fallito entrambe le volte - miseramente con
Macbeth, elegantemente con Otello. Il suo Otello, bello com’è, fallisce perché molte delle sue “fioriture
cinematografiche” sono gratuite. Nonostante la bravura di Welles, il suo giocare con il mezzo rimane,
appunto, un gioco. Egli è troppo spesso colpevole di servire delle belle porzioni di puro Shakespeare,
infarcite con inquadrature dai piani o dalla composizione singolari, o montate con tagli arditamente
eleganti. Sebbene tutto ciò sia molto affascinante da guardare, l’esperienza del guardare rimane, al suo
centro, vuota . È cinema come hobby o come ornamento, ma non come espressione.2 Non importa il
taglio dell’inquadratura o il numero di stacchi in una scena, il materiale nella sua forma originale (il
dramma, le singole scene con il dialogo intatto) rimane essenzialmente quello che era. In questi casi il
film è una illustrazione, più o meno gratuita, del soggetto e non quello che inevitabilmente deve essere:
una articolazione di esso.
La foresta
Questo ci riporta a Trono di sangue. Allo stesso tempo, ci porta al profondo impegno di Kurosawa nel
creare significato attraverso la manipolazione della realtà materiale. Senza dubbio questo è per lui sia
una reazione involontaria all’esperienza che un vero e proprio impegno; ma qualunque ne sia la fonte,
la forma di questo film è rilevatrice. Per cominciare, Kurosawa qui fa molto di più che lasciarci
semplicemente vedere le cose che i personaggi di Shakespeare ci descrivono e i posti dove si svolge
l’azione. Questo metodo consacrato dalla tradizione, ma molto riduttivo di filmare un’opera teatrale è
molto lontano dalle sue risorse. 3 Il punto è che Kurosawa davvero pensa in termini di manipolazione
della realtà materiale. La foresta di Birnam, per esempio, che è descritta nel testo in modo sommario, in
poche righe, diventa nelle mani di Kurosawa una presenza fisica forte abbastanza da incarnare nel film
una complessa rete di temi. La foresta di Trono di sangue è nata in Kurosawa insieme con la
1
Da «Sight and Sound», vol. n. 34, autumn 1965, pp. 190 sgg. Traduzione di Alessandra Testoni.
Le immagini di Iago che viene riportato al castello e messo in gabbia, con le quali Welles incornicia l’azione del film, e la
bella sequenza nella cisterna sotterranea costituiscono delle eccezioni in questo senso.
3
Questo è quel che accade, per esempio, a Max Reinhardt (nel Sogno di una notte di mezza estate, 1935): la sua foresta
incantata, abitata da gente vera e il suo palazzo di cartone semplicemente sottolineano la poca duttilità del materiale
drammaturgico.
2
concezione stessa del film. Non è il risultato di un adattamento improvvisato e non è neanche una
visualizzazione di fantasia del dramma. Essa è piuttosto frutto della metamorfosi dell’opera teatrale in
film, ed è in gran parte responsabile di quel principio interiore di movimento che fa di Trono al sangue
un lavoro artistico autonomo.
Potrebbe aiutare guardare al problema dal punto di vista di Kurosawa. Egli si sente profondamente
affine al tema di Macbeth e intende ricavarne un film. Il dramma tratta di un guerriero nobile e molto
ambizioso che si trova di fronte all’orribile compito di recuperare il controllo sulla sua stessa
immaginazione, vivida ma ingannevole. Egli ha bisogno di misurarsi con se stesso e lo può fare solo
liberando le sue più terribili visioni, e accettando completamente tutto quello che di male egli incontra
nella sua anima. Autocontrollo e autodistruzione ben presto diventano la stessa cosa, e questa è la
tragedia. Come deve aver notato Kurosawa, il problema cruciale era cercare un modo naturale per
esternare e rendere oggettivi i pensieri di Macbeth. Per “naturale” io intendo che l’oggetto scelto deve
dare l’impressione di esistere nel mondo reale, di vivere e crescere in esso, proprio come Macbeth. Per
questo non è abbastanza che i pensieri di Macbeth siano fotografati; fotografandoli bisogna farli vivere.
La foresta di Birnam, un simbolo marginale nell’opera originale era perfetta a questo scopo. Anche nel
testo, è solo quando la foresta sfida le leggi della natura (così come Macbeth sovverte l’ordine morale)
che il destino di Macbeth diventa chiaro e lui capisce che il tipo di autocontrollo che cercava era
suicida. Nel film, però, la foresta è più che un marginale oggetto correlato al tema. È sia il terreno di
battaglia dove infuria la lotta, che il motivo profondo di incitamento al conflitto. Se tutto ciò suona
come una buona descrizione di ciò che chiamiamo “il mondo” di un’opera d’arte, ebbene, questo è il
caso.
Questo è precisamente il ruolo della foresta. È la vita al centro del film, quello che cerchiamo
sempre ma raramente troviamo nelle versioni filmate di un’opera teatrale.
Una buona parte di Trono di sangue è dedicata al terrificante spettacolo di Washizu (Macbeth) nella
sua battaglia con la foresta. In una lunga sequenza verso l’inizio del film, lui e Miki (Banquo)
attraversano una densa e oscura foresta in groppa a cavalli non meno spaventati di loro. (La foresta
viene definita “il labirinto” e una buona parte del film, in questa scena e più avanti, consiste nella
difficoltà di trovare una via di uscita da essa). Washizu è chiaramente il capo, lui troverà una via di
uscita, perché non può sopportare il senso di paura e di abbandono che prova di fronte ai sentieri senza
uscita, alle grida e ai lamenti inspiegabili, ai tuoni, ai lampi e alla nebbia. Egli avanza verso quello che
crede uno spirito maligno, sguaina la spada e, con un grido che fa ghiacciare il sangue, mezzo di sfida e
mezzo di isteria, si inoltra nel buio seguito da Miki. La realtà di questa foresta è travolgente. Essa
respira, suda, freme e parla in un linguaggio sconosciuto. È una presenza forte come quella dello stesso
Washizu; e così deve essere, dal momento che per Washizu questo primo incontro con la foresta non è
altro che un tuffo a capofitto dentro di sé.
In questa sequenza Washizu e Miki sono sulla strada verso il Castello della Foresta, dove il loro signore
li sta aspettando per ricompensarli per aver guidato vittoriosamente la battaglia contro le forze ribelli. Il
controllo su questo castello diventerà ben presto un’ossessione per Washizu, che è già assillato dal
pensiero che potrebbe essere veramente invulnerabile se potesse controllare la foresta, l’unica via
d’accesso al castello. In un momento i cavalli impazziti attraversano il sottobosco fino ad un piccola
radura che brilla di una luce sinistra. Qui, attorniato da mucchi di carcasse e di ossa, un demone bianco
come il gesso, di età e sesso indefinibili, siede tessendo al telaio, cantilenando le profezie che
guideranno Washizu alla sfida finale. «Devo tingere la foresta di sangue!» - griderà. La foresta è la
mente di Washizu. Man mano che le sue ambizioni si manifestano, essa non sarà più controllata dal suo
signore. Il suo signore è quindi vulnerabile, ma non più del predestinato Washizu, la cui posizione è,
per ironia della sorte, analoga.
Kurosawa ha, in fin dei conti, molto in comune con tanti altri grandi registi: l’abilità di impregnare un
luogo di tali profondi significati morali che quel luogo spesso finisce per assumere su di sé il compito
di strutturare la narrazione. Non sto dicendo che il luogo e il film sono la stessa cosa. Dico
semplicemente che è necessario che un ambiente diventi vivo e aiuti a dar forma al film. Se esso non
genera conflitto, se non condivide la realtà delle esperienze dei personaggi, rimane un luogo senza
significato. E se il luogo è senza significato, lo è anche il film. Un penoso esempio in questo senso
è
l’
universo da fondale dipinto dell’
Enrico V di Olivier. È come se un romanziere volesse cercare di
fissare una rappresentazione de L’anello del Nibelungo riportando in modo oggettivo tutte le azioni, i
personaggi, i dialoghi e le scene esattamente come appaiono sul palcoscenico. E poi concludesse il suo
scherzo chiedendoci di leggere effettivamente il suo lavoro.
In Trono di sangue, dunque, l’ambiente diventa una realtà autonoma. I cavalli galoppano attraverso la
foresta e Kurosawa, sempre dietro un groviglio di tronchi nodosi e rami secchi, galoppa con essi.4 Tutto
l’insieme - gli uomini e i loro cavalli, la composizione dell’inquadratura, la narrazione e il tema stesso è galvanizzato da questa ambientazione diabolica. Lo stesso avviene anche negli interni, che, con la
loro semplice teatralità costituiscono un mondo all’interno della foresta che tutto avvolge. Dietro muri
inconsistenti l’uomo cerca di tenersi al riparo da una natura amorale; durante tutto il film vediamo la
sua lucida, quieta geometria assaltata e infine frantumata. Verso la fine, prima che la foresta si muova,
un inutile consiglio di guerra tra Washizu e i suoi capitani è gettato nel caos da uno stormo di uccelli
urlanti che improvvisamente, dalla foresta, irrompono in volo nella sala. Washizu capisce anche troppo
bene cosa significa tutto questo. Egli reclama il suo cavallo (alla Riccardo III) e per l’ultima volta va
dal demone in cerca di quelle rassicurazioni che non può avere da altri. La foresta, che è la traduzione
in oggetto della mente di Washizu, controlla e contiene l’azione del film.
E infine, ci sono i tumultuosi andirivieni degli uomini e dei loro cavalli che hanno una funzione così
importante come legame narrativo tra il castello e la foresta. Essi consentono al regista di raccontare la
sua storia con grande economia e forza, riservandosene solo una piccola parte.
I cavalli
Mi ricordo, a questo punto, di quelle due creature sonnolente che avrebbero potuto ragionevolmente
avere la stessa funzione dei due servi ubriachi e che invece sono stati costretti a lavorare come
cavalcature per Macbeth e Banquo all’inizio del film di Welles sullo stesso soggetto. Non che Welles
dovesse fare un film alla Kurosawa, ma avremmo avuto qualche ragione di aspettarci che egli ci
mostrasse il suo gusto per il fantasmagorico non solo in un montaggio sgargiante e in una messa in
scena pretenziosamente simbolica - ma, ad esempio, nella vita che sta attorno ai personaggi.
ROSS E i cavalli di Duncan - cosa invero strana, quanto certa e provata! - dei bei corsieri veloci, rari esemplari della loro
razza, tornarono a un tratto allo stato brado, ruppero i loro stalli e si lanciarono fuori all’aperto rifiutando obbedienza,. come
se volessero far guerra all’umanità.
VECCHIO
M’
hanno p ur detto che si son divo rati l’
un l’
altro.
Ammetto che la precisazione del vecchio avrebbe potuto presentare dei problemi. Ma la descrizione di
Ross è il lavoro di un grande sceneggiatore, e Kurosawa non ha tralasciato di notarlo. Da una lunga
sequenza di Washizu e sua moglie che si ritirano nelle loro stanze, mentre il caos provocato
dall’assassinio sembra finalmente placarsi, si passa, con uno stacco repentino, alla mattina successiva,
quando vediamo i cavalli del re “rifiutare obbedienza”, più di quanto abbiano fatto quelli di Duncan.
L’intero castello si riscuote, come i cavalli, nella loro frenetica corsa per sfuggire ciò che hanno fiutato,
un fuggi fuggi in mezzo a una selva di smisurate bandiere, che sventolano rumorosamente e sono come
trascinate in direzione della foresta.
4
Gli imitatori di Kurosawa hanno finito per fare di questa immagine un cliché, ma questo è un problema loro.
La sequenza è tipica di Kurosawa nella calcolata violenza della sua realizzazione. Tutta l’azione è
ripresa dal basso e in campo stretto; poche fulminee inquadrature di destrieri ribelli e di uomini storditi
e inermi e immediatamente passiamo al corrispondente di Macduff, Noriashu, che tra la confusione
scappa per informare Miki dei suoi sospetti. La narrazione fa un importante passo avanti e niente è
lasciato in sospeso. Il breve tumulto qui non è altro che un effetto cinematograficamente spettacolare.
Noi sappiamo già dalla sequenza iniziale della foresta che Kurosawa sta modellando il suo mondo su
quello di Shakespeare. In questo tipo di mondo, la natura intera è sensibile ai traumi morali, e gli stessi
traumi morali sono spesso di tale grandezza da sconvolgere la natura intera. La grande dote di
Kurosawa è che egli ha il potere come regista di farci sperimentare questo mondo. Se egli avesse
cercato l’astrazione dal processo, cosa che Shakespeare come drammaturgo faceva - se egli ci avesse
dato le reazioni agli eventi al posto degli eventi stessi - tutto sarebbe andato perduto. Non avremmo
avuto né un’opera teatrale né un film.
Voglio fare un ulteriore esempio, un esempio per il quale Kurosawa non si è lasciato ispirare dal genio
di potenziale sceneggiatore di Shakespeare. (Ma forse è proprio qui il cuore della questione. Nel fatto
che Kurosawa ricorre a Shakespeare esclusivamente come ad uno sceneggiatore la cui visione è in
sintonia con la propria e mai come ad un autore di pentametri). Miki decide, a causa delle profezie, di
dividere la sorte con Washizu nonostante sia certo della sua colpa.5 Ora egli è ospite nella nuova
residenza di Washizu, il Castello della Foresta. La sequenza si apre nella camera di Washizu,
con
Lady Washizu che fa la parte dell’
avvocato del diavolo. La donna non si fida di Miki e sa che
neanche il marito si fida, così dà voce a quello che è già un suo desiderio, benché egli non osi neppure
pensarlo: un altro omicidio. Immediatamente passiamo dalla faccia muta, pietrificata di Washizu al
cortile, dove il cavallo di Miki, solitamente docile, sembra come impazzito. Si lancia al galoppo
attraverso il cortile e rifiuta di farsi mettere la sella. Il figlio di Miki interpreta il fatto come un cattivo
presagio e prega il padre di non uscire a cavallo quel pomeriggio ma di restare per il banchetto e di
attendere ai suoi affari la mattina seguente. Miki ride di questo atteggiamento puerile del figlio, e
non
appena si avvia per sellare lui stesso il cavallo, passiamo ad un’inquadratura del cortile presa
dagli spalti del castello. È notte, tutto è tranquillo, il cortile, ripreso in lontananza sulla sinistra dello
schermo, è deserto. Gli uomini di Miki sono seduti in cerchio e discutono sottovoce gli strani
avvenimenti degli ultimi giorni. Improvvisamente ammutoliscono. Hanno udito qualcosa in lontananza.
Il rumore si fa più forte e alla fine si rivela come il galoppo di un cavallo. L’inquadratura è tenuta
ancora per un poco, giusto il tempo di far arrivare nel cortile, al galoppo, il bellissimo stallone bianco
di Miki, senza il cavaliere. Stacco su Washizu al banchetto. Naturalmente egli non dedica nessuna
attenzione alla festa o agli ospiti; non può fare a meno di guardare insistentemente l’unico posto vuoto
nella sala.
Questo passaggio, che dura non più di tre o quattro minuti, è narrazione cinematografica alla massima
potenza. Kurosawa monta con un istinto infallibile, tagliando ogni azione nel suo momento di climax,
così che essa si riverbera per tutto il film, e il suo movimento o la sua posizione sullo schermo sono
sempre trasversalmente al servizio della storia. Ma la sequenza è notevole anche perché ci permette di
cogliere Kurosawa nell’atto di narrare quello che Shakespeare aveva sceneggiato, rivelando così quanto
la narrazione filmica dipenda dalle componenti materiali del mondo che viene descritto.
Kurosawa costruisce l’intera sequenza attorno alle reazioni del cavallo di Miki. I movimenti di questa
creatura sono responsabili di tutte le ellissi caratteristiche della narrazione; esse dicono tutto quello che
deve essere detto finché il corpo e il viso di Washizu ricompaiono di nuovo al banchetto. Allo stesso
tempo esse consentono di eliminare buona parte della storia. Gli elaborati preparativi con gli assassini e
l’omicidio stesso (un materiale cinematografico presumibilmente eccellente) vengono eliminati.
Kurosawa non si serve nemmeno dell’omicidio, perché il mondo che ha creato già ne contiene tutto il
5
I cambiamenti nell’intreccio saranno trattali con maggiore ampiezza più avanti.
potenziale narrativo. È un mondo di oggetti moralmente sensibilizzati (la foresta, i cavalli, i corpi e le
facce dei personaggi), che vivono, nel film, di vita propria. E, nella loro autonomia, chiedono che il
regista aderisca alla loro logica. Se il regista sta veramente facendo un film, e non sta solo filmando
un’opera teatrale, egli è dispostissimo ad acconsentirvi.
Nonostante le apparenze non sto parlando di una nozione da estetica western del cinema. Anche Silver
nitrisce quando c’è pericolo nell’aria, ma a chi non è venuta voglia di zittirlo? Non c’è bisogno di
cavalli, inseguimenti o dello scatenarsi di imponenti forze naturali, con masse che si scontrano sullo
schermo, per fare del vero cinema. Quello che è indispensabile è la capacità di convincere lo spettatore
che le superfici dei corpi, dei volti, dei luoghi sono dotate di terminazioni nervose, e che le sinapsi tra
questi tre elementi producono il significato e controllano la struttura del film.6 Kurosawa nel suo film
fa questo. Spero sia chiaro che tutto ciò non ha niente a che fare con il disperato tentativo di Olivier,
alla fine dell’ Enrico V, di aggiungere alla ricetta un pizzico di “cinema” in forma di equina bizzarria.
I personaggi
Probabilmente il risultato più radicale di questa trasformazione di un’opera teatrale in film è la totale
assenza in quest’ultimo della lingua di Shakespeare. Che nel film di Kurosawa i personaggi parlino
giapponese non è che una parte della questione. L’altra, e la più importante, è che essi parlano solo
quando non possono comunicare in nessun altro modo, e in un linguaggio che è terso, disadorno,
brutalmente funzionale. Per quanto lasciano intendere i sottotitoli, la poesia di Shakespeare non c’è più,
non è solo tradotta e adattata, ma è proprio scomparsa.7 Parlando della foresta e dei cavalli abbiamo
visto alcuni degli elementi che ne prendono il posto. Lì ho messo in luce particolarmente la
fondamentale identità dei problemi che Macbeth e Washizu si trovano a fronteggiare. Ma la cura
scrupolosa con cui Kurosawa evita il verso di Shakespeare è in stretta relazione con alcune differenze
fondamentali nell’intreccio e nella caratterizzazione dei personaggi. Queste differenze meritano
attenzione perché ci aiutano ad approfondire la questione di come un personaggio si sviluppi in un film,
e possono anche fornirci le basi per una speculazione su quali tipi di personaggi eventualmente siano
più congeniali a questo medium.
LADY MACBETH Ho allattato, e so quanta tenerezza si provi nell’amare il bambino che succhia il latte: e tuttavia, proprio
mentre egli si fosse volto a sorridermi, avrei strappato il mio capezzolo dalle sue gengive senza denti, e gli avrei fatto
schizzare fuori il cervello, se l’avessi giurato, così come tu hai giurato di fare questo.
Questo è l’agghiacciante discorso che Shakespeare ha usato per costruire il personaggio di Lady
Macbeth. A Lady Washizu, invece, è negata questa maniera di esprimersi. Ma il suo personaggio è
dotato, in cambio, di un potere squisitamente fisico, un potere che va molto oltre il gesto
immediatamente visibile (anche se lo contiene). Un po’ prima dell’inizio dell’azione del film, la donna
concepisce un figlio di Washizu. Questa gravidanza diventa il pungolo col quale essa incita il marito
sulla via del male, e le bastano poche parole per sfruttare il suo vantaggio. Il bambino, che avrebbe
dovuto essere il vero beneficiario del complotto per uccidere il re e Miki, ne diventa, in seguito
all’aborto di Lady Washizu, una delle vittime, oltre che un’incarnazione del complotto stesso. Dopo
6
Tutto questo risulta molto vicino alla definizione di cinema di Kracauer (cfr. il suo Theory of Film [Film:ritorno alla
realtà fisica, Il Saggiatore, Milano 1962]), ma la sua concezione del cinema come “affermazione della realtà fisica”, così
legato a ciò che egli chiama il “fluire della vita”, avrebbe poco a che fare con Trono di sangue. Kracauer riserverebbe
probabilmente critiche severe all’intreccio serrato e alle ambientazioni medioevali di questo film.
7
In quello che suppongo fosse un tentativo di fedeltà a Shakespeare, in una recente versione cinematografica dell’Otello, si
è arrivati al punto da usare attori anglofoni. Questo tipo di devozione non rientra nelle caratteristiche di Kurosawa.
che Washizu conquista il controllo del Castello della Foresta, Lady Washizu esegue un perverso rito di
fertilità, danzando, pazza di gioia, nella stessa stanza dove è stato ucciso il re. Ma l’avvicinarsi
incalzante del fallimento ben presto provoca alla donna un aborto, che la porterà ad un crollo nervoso.
(La causa della pazzia di Lady Washizu è una delle aggiunte alla storia più brillanti di Kurosawa).
Nella scena della pazzia ella è semplicemente rannicchiata in mezzo alla sua stanza vuota, e si strofina
le mani gemendo. Non la vedremo più, né sentiremo più niente di lei.
Ho parlato più sopra della fervida ma ingannevole immaginazione dell’eroe. Cosicché si sarebbe tentati
di cercare i segni evidenti di una così vivida immaginazione in quello che egli dice. Invece ci troviamo
di fronte ad un muro di sguardi attoniti, grugniti, strilli e sbuffi; e ai movimenti tesi di un animale in
trappola ma ancora pieno di forza. Washizu non può articolare le sue visioni da incubo ma non c’è
dubbio che le abbia. Qualcuna l’abbiamo vista nelle sue reazioni nella foresta. Ma non è tutto. Quando
il fantasma di Miki gli appare al banchetto - e il fatto che esso appaia riguarda una questione che
tratterò tra poco -, egli barcolla avanti e indietro per la stanza, mentre i suoi piedi producono un sordo e
spasmodico scalpiccio sul sottile pavimento di legno che minaccia ad ogni momento di frantumarsi. Le
delicate architetture giapponesi sono usate nel film come un palcoscenico che amplifica la tremenda
violenza dell’uomo. Egli si abbatte sulla parete, respirando a fatica, con gli occhi mezzo fuori dalle
orbite. Ben presto il banchetto finisce e un sicario riferisce che il figlio di Miki è fuggito. Washizu,
sgomento, lo uccide sul posto senza dire una parola; poi getta un urlo, butta via la spada ed esce dalla
stanza. In questa scena Kurosawa ci fa capire che le forze della foresta stanno assaltando il fragile
ordine di questi interni che non sono affatto dei ripari, ma muri di carta velina, labili difese contro la
bestialità che li abita. Questo è ciò che Washizu sente (e che esprime) con ogni fibra del suo corpo,
anche se non può esprimerlo con le parole.
Mai ci è consentito dimenticarci della primitiva fisicità dell’eroe. Quando, alla fine, Washizu vede la
foresta muoversi, rabbrividisce e si acquatta in un angolo degli spalti, incapace di credere ai suoi occhi.
Con grande sforzo fa appello a tutto il suo coraggio per cercare di incitare i suoi uomini. Cammina
sugli spalti come un leone in gabbia, e ruggisce verso la folla spaventata. (La macchina qui lo inquadra
dal basso e panoramica in un continuo andirivieni, imitando il suo moto nervoso). Ma i suoi uomini ne
hanno avuto abbastanza. La foresta si è mossa e ogni gesto di Washizu urla alle loro orecchie il suo
destino di morte; la sua spavalderia non serve a mascherarlo. Essi tendono gli archi, e si rivoltano
contro il loro capo, negandogli l’onore di morire, come Macbeth, «con la corazza sulle spalle [con le
armi in pugno]». Il risultato è raccappricciante: di lì a poco Washizu, fra urla e controcimenti, con
decine di frecce in corpo, viene colpito al collo.8 Cade (al rallentatore) nel cortile e il suo corpo, che
sembra non smettere più di rimbalzare, solleva grandi nugoli di polvere. Tutti i soldati indietreggiano,
nel timore che il demone non sia stato completamente esorcizzato. Lo è invece, e quando il corpo
finalmente diventa immobile, il film finisce.
***
Mi sembra che la principale conseguenza di questi vari cambiamenti sia che il grottesco rapprochement
tra il regno umano e quello animale, comune a entrambe le opere, è più esauriente in Trono di sangue
che in Macbeth. Ai due eroi succedono praticamente le stesse cose, ma non sarebbe stato possibile
raccontarle cinematograficamente se Macbeth non fosse stato trasformato in una creatura più istintiva,
più fisica; una creatura per la quale la dimensione morale dei comportamenti esiste, ma raramente
oltrepassa la soglia della concettualizzazione nelle forme della poesia verbale o della riflessione
Kurosawa, in questa scena, ha fatto tirare all’attore frecce vere. Come scrivono Anderson e Richie nel loro The Japanese
Film, «Non è che gli interessassero le frecce vere in quanto tali, ma perché nel fìlm si otteneva un effetto più riuscito
quando contro Mifune venivano tirate realmente delle vere frecce». La stessa cosa si potrebbe dire della foresta.
8
filosofica. Washizu non è meno sensibile di Macbeth e neanche meno morale. Ma poiché non c’è un
posto nel film (in nessun film) per la poesia di Shakespeare, egli deve per forza essere meno poeta e
meno filosofo, e forse non può essere nemmeno il classico eroe tragico che Macbeth è nell’opera
teatrale.
Persino quando riceve la notizia dell’aborto della moglie e la vede sconvolta, persino quando alla fine
tenta di chiamare a raccolta i suoi uomini, anche allora i suoi pensieri ci vengono comunicati solo
attraverso le reazioni fisiologiche che producono. Data l’eloquenza di Macbeth, Washizu avrebbe
dovuto morire più nobilmente, «con la corazza sulle spalle». Ma questo è confondere i due personaggi.
Il personaggio di Washizu, infatti, è soggetto alle esigenze del medium. I suoi uomini gli si rivoltano
contro perché il suo corpo e il suo viso, benché terrificanti in quest’ultimo tentativo di comandare, non
possono nascondere la sua consapevolezza dell’imminente disfatta. Washizu semplicemente non è
abbastanza articolato per mediare, nel modo elevato del classico eroe tragico, tra le sue percezioni e i
suoi gesti. Se lo fosse, non sarebbe la potente immagine cinematografica che è.9 È comprensibile che
Kurosawa voglia sfruttare questa immagine mettendolo sugli spalti, visibile da tutti e alla mercé di
coloro che egli non può aiutare, ma ai quali può solo rivelare se stesso.
Tutto questo non vuol dire che Washizu non possa pensare. Ma solo che egli pensa in un altro medium.
Quando Macbeth viene a sapere della morte della moglie, recita il famoso monologo che comincia
«Domani, e domani, e domani». Washizu, guardando nella camera della moglie, vede in lei,
raggomitolata al centro della stanza, uno dei risultati della sua follia; tutto il suo essere crolla e
pesantemente egli si allontana dirigendosi verso la propria camera. Noi lo seguiamo. Entra e si accascia
sul pavimento, come uno straccio. «Pazza!», grida. «Pazza!». Queste sono le sue uniche parole. Sullo
schermo, occupato dalla sua figura seduta, ci sono altri due oggetti: la sua spada e il trono. Kurosawa
tiene a lungo questa eloquente inquadratura. È una buona indicazione per farci capire che Washizu non
è un bruto incapace di riflessione. Egli è piuttosto lo spirito di Macbeth ma distillato nella più pura
materialità. Lady Washizu è lo spirito di Lady Macbeth distillato allo stesso modo. Queste operazioni
di distillazione producono la linfa vitale del film. Senza di esse avremmo avuto una narrazione povera
di senso e statica. 10
Anche i personaggi minori ricevono più o meno lo stesso trattamento. Macduff (Noriashu) è un
esempio interessante perché in questo processo di trasformazione perde non solo la sua eloquenza ma
anche il suo glorioso ruolo di vendicatore. Benché, presumibilmente, si trovi con le forze che attaccano
il Castello della Foresta, alla fine, dal momento in cui mette a parte Miki, inutilmente, dei suoi sospetti,
non lo vediamo più. Una conseguenza di questo è che nel film non vengono posti in risalto gli effetti
dell’azione principale sugli affari politici, come avviene invece in Macbeht. Possiamo ringraziare il
cielo per l’assenza di tutti quei noiosi accordi tra Macduff e il mellifluo Malcolm ma chiediamo che le
implicazioni sociali della tragedia, che vi sono connesse, trovino espressione nel film. E non le
troviamo in subdole macchinazioni politiche, ma nel mostruoso tradimento che gli uomini di Washizu
sono costretti a compiere alla fine. Questa è certamente una implicazione sociale fondamentale, che
può essere letta (senza stravolgerne il senso, credo) come un rituale di re-insediamento del vecchio re.
In questo senso il film sembra anche più vicino dell’opera teatrale alle radici dionisiache della tragedia:
9
Anche i personaggi dei film di Anionioni, sofisticati e tremendamente auto-coscienti, hanno spesso delle difficoltà a usare
le parole per esprimere la loro situazione (ammesso che abbiano ancora voglia di farlo). A questa letargia verbale, a questo
senso di frustrazione si deve in molti casi l’impatto, spesso molto forte, che queste figure hanno come immagini
cinematografiche.
10
Se questa affermazione sembra troppo forte, si può dare un’occhiata alla Lady Macbeth di Judith Anderson nella versione
cinematografica della tragedia realizzata da George Schaefer. Si è voluta rendere in modo teatrale la parola di Shakespeare che non avrebbe potuto essere resa efficacemente in nessun’altra maniera - e in questo la Anderson è esperta. Sullo
schermo, però, la sua eccellente interpretazione teatrale diventa convenzionalmente falsa e addirittura ridicola. Il regista che
cerchi di conservare in un film un evento teatrale finisce per sacrificare il meglio di entrambi i media.
e sembra anche discendere, a suo modo, altrettanto profondamente nella parte più oscura della natura e
delle relazioni umane. In questa sua ricerca delle manifestazioni esteriori che gli servivano come
regista di cinema, Kurosawa ha dovuto in parte spaccare la crosta di civilizzazione del dramma.
Macduff e Malcolm facevano parte di quella crosta.
*
Sorge una domanda finale. Ci sono dei personaggi che non si prestano alla narrazione cinematografica?
Lasciate che mi avventuri in queste acque profonde con la considerazione che nessun regista di cinema
potrebbe giovare ad un personaggio come quello di Amleto, ma solo distorcerlo grossolanamente o
semplificarlo eccessivamente. Non sto parlando qui dei problemi che Olivier può aver incontrato nel
cercare di conservare un carattere teatrale nella sua interpretazione del ruolo, ma di coloro che
vorrebbero cercare di affrontare il personaggio in modo cinematografico. E il problema non è la
complessità di Amleto, perché anche Macbeth è un personaggio molto complesso e Kurosawa è stato
capace di ricrearlo cinematograficamente attraverso un processo di distillazione che non ha né distorto
né semplificato il significato fondamentale della sua esperienza. Amleto è intraducibile a causa del
carattere verbale della sua esperienza. Si può essere verbali senza che la propria esperienza lo sia.
Macbeth, che è in fondo un uomo di azione, e anche un grande poeta, ed è quindi un buon esempio in
questo senso. L’esperienza verbale è tipica di quelli che non sono mai pienamente entrati nella loro
esperienza, di quelli che possono solo “recitare” l’azione. È tipica di quelle personalità teatrali, da
attore, di cui Amleto è l’esempio più classico. Macbeth, al contrario, vive sempre le sue esperienze, e in
questo modo mette a disposizione di Kurosawa quell’irriducibile, indiscutibile nucleo di realtà che è
alla base di molti grandi film.
Polonio chiede ad Amleto che cosa stia leggendo. «Parole, parole, parole», gli risponde Amleto. Un
simile gioco di parole potrebbe prestarsi a più di una interpretazione. Io lo leggo come l’esatta
descrizione di quella costruzione verbale, di cui Amleto è consapevole, che costituisce la forma in cui
si manifesta il carattere e l’esperienza del personaggio. È sempre stato il teatro ad alimentare questo
tipo di sensibilità, che sembra destinata a rimanere fuori dai grandi percorsi del cinema.11
Nel suo recente libro, Metateatro, Lionel Abel, con argomenti convincenti, fa risalire le origini della moderna sensibilità
teatrale (“la vita considerata come un sogno, il mondo come un palcoscenico”) all’Amleto. Questa sensibilità ha avuto assai
poca influenza sui grandi registi cinematografici.
11