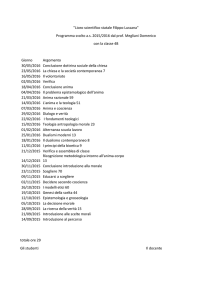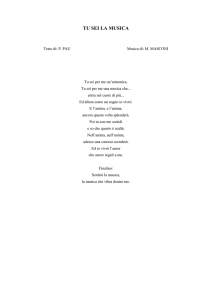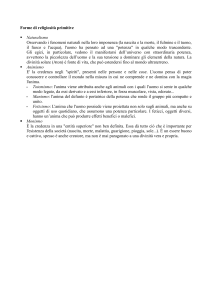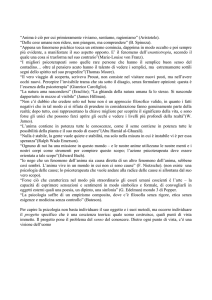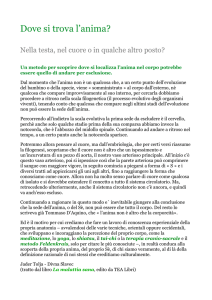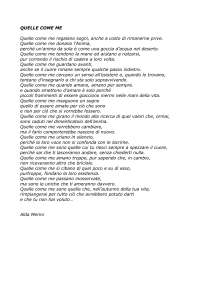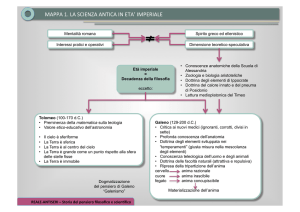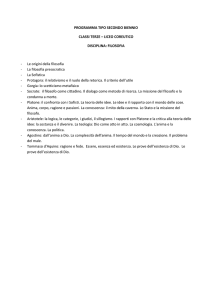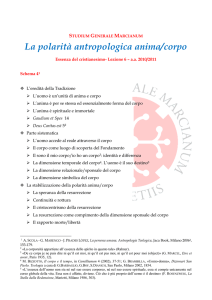Dal sito www.fondazioneveronesi.it della Fondazione Umberto Veronesi Per il progresso delle scienze
Le neuroscienze non hanno ucciso l’anima e la libertà
Enrico Berti e Giulio Giorello: dialogo fra filosofi. Con lo sviluppo delle neuroscienze molti attributi propri dell’essere
umano vengono ricondotti al cervello e alla biologia: cosa resta, allora, dell’anima e della libera volontà?
Pubblicato il 27/09/11Lo leggo dopo
L’anima
Enrico Berti: Molto dipende da come si definisce l’anima. Se la si intende come lo “spettro nella macchina” di
impronta cartesiana, un fantasma che si aggira all’interno del corpo umano, allora la risposta è semplice: non resta
che rispondere con il titolo di un editoriale apparso su un fascicolo di Nature-Neuroscience nel 2002: “Sorry, your
soul just died” (“spiacenti, la vostra anima è appena deceduta”). E non è morta da oggi, ma almeno dal tempo di
Kant.
Questo, però, non è l’unico modo di intendere l’anima. Se si ripensa alla radice del concetto, alla psyche, si giunge
all’idea, di ispirazione aristotelica, ripresa ad esempio da Vito Mancuso nel libro “L’anima e il suo destino” (2007):
l’anima è una forma del corpo vivente, è l’energia che rende possibile la vita, nelle sue manifestazioni più elementari,
come quelle vegetative, fino alla capacità del corpo di svolgere funzioni superiori come pensare, volere, e a dicendo.
Ritorna qui il concetto aristotelico di forma come struttura organizzata capace di svolgere funzioni integrate fra loro.
Al tempo di Aristotele si credeva che l’organo capace di svolgere queste funzioni fosse il cuore, oggi invece la scienza
ci ha insegnato che è il cervello. La presenza nel cervello di questa capacità è l’anima. E’, in ultima analisi, ciò che
distingue un cervello vivo da uno morto, un cervello attivo da uno con elettroencefalogramma piatto. Ebbene, se
l’anima è questo, allora non solo non c’è motivo per dire che è morta, ma proprio le neuroscienze, con gli studi sul
cervello e la coscienza, mostrano che questo concetto di anima ha più titoli per proporsi al dibattito rispetto a quella
di tipo cartesiano-platonico.
Giulio Giorello: Cosa resta dell’anima? E’ un tema che fa tremare le vene ai polsi, non sappiamo tutto del corpo,
figurarsi dell’anima. Mi si attribuisce questa battuta: “Alcuni hanno detto che solo il genere maschile ha un’anima.
Altri – e non fino a molto tempo fa, almeno fino alla Guerra Civile Americana – che solo gli uomini liberi e non gli
schiavi hanno un’anima. Altri sostengono che nessuno ha più un’anima. E almeno in questo modo forme odiose di
apartheid e discriminazione vengono tagliate fuori”. Charles Darwin nei suoi appunti sugli scritti di Platone dedicati
all’anima, scrive che tutto quello che dice Platone è bellissimo purché si sostituisca la parola “soul” (anima) con
“ape” (scimmia). In altri appunti dei suoi taccuini, Darwin scrive che per comune opinione l’anima è sopraggiunta a
un certo punto in noi, non si sa bene quando e come, mentre gli animali non ce l’hanno. Ma se andiamo a vedere le
nostre somiglianze e differenze col mondo animale, scopriamo che gli animali l’anima ce l’hanno e sono nostri
compagni d’avventura in questo mondo.
Questo è un modo vivo per recuperare alla luce delle teorie dell’evoluzione il concetto di anima. Le teorie di oggi
mettono in luce l’emergenza della coscienza, mettono in luce il concetto di anima di Darwin. L’anima, lo spirito, si
evolvono anche nelle diverse lingue. Nella traduzione francese di Cartesio, la parola “mente” non esiste, ma è
l’”âme”, l’anima. Quelle tradizionali grandi domande oggi trovano un modo per avvicinarsi a piccole risposte proprio
grazie all’impresa scientifica, in cui l’apporto tecnologico è fondamentale. Ciò che origina dalla coscienza comincia a
essere chiarito da teorie controllabili, cioè secondo l’onesto lavoro della scienza empirica. So bene che la spiegazione
scientifica tende a ridurre qualunque morfologia osservata. Siamo prigionieri della descrizione scientifica, ma la
nostra libertà è la grammatica, il linguaggio. Inoltre, se l’anima è la presenza nel cervello e nel corpo di una serie di
capacità, allora siamo di fronte a una dilatazione dell’anima. Per dirla con Stephen Dedalus di James Joyce (Ulisse),
un’anima che si estende “fino alla stella più lontana, che puoi raggiungere coi tuoi occhi o con qualche telescopio”.
Lavorare, pensare, gettare la propria coscienza nel mondo in cui viviamo. Ma se è fino all’ultima stella, allora è finita?
No, perché domani vedremo ancora più stelle, andremo più avanti, grazie alla scienza e alla tecnica. In questo modo,
pur ingabbiati nella nostra dimensione individuale, riusciamo a creare questa cosa meravigliosa che è la conoscenza
partecipata.
La libera volontà
Enrico Berti: alcuni filosofi pensano che le neuroscienze abbiano dimostrato che non c’è spazio per la libertà, cioè
che le decisioni sono il risultato di processi fisiologici nel cervello e non della nostra volontà. Ci rendiamo conto delle
conseguenze preoccupanti di questo approccio, che eliminerebbe con la libertà anche la responsabilità e l’etica
stessa. Gli esperimenti di Benjamin Libet, da cui risulta che prendiamo coscienza dai processi che ci portano a
decidere 500 millesimi di secondo più tardi dell’attivazione neurale che predispone alla decisione stessa, hanno
dimostrato che le nostre decisioni sono predeterminate? Non è un problema nuovo, se lo ponevano già gli antichi.
Per Aristotele, la decisione è il risultato di concatenazioni necessarie di cause. Questo è stato interpretato in chiave
determinista. Su questa base è stato introdotto e discusso il concetto di destino, già oggetto di dibattito nel Medio
Evo e nel Rinascimento. Libet riconosce che la capacità cosciente ha perlomeno la possibilità di proseguire o inibire
questi comportamenti. C’è ancora spazio per la libertà. Secondo i vecchi manuali di filosofia, la libertà è un dato di
fatto di cui si abbia esperienza. E’ la percezione mediata del nostro potere di compiere o non compiere certe azioni.
Il senso morale è un indizio di questo, come sa ciascuno di noi quando ha vissuto momenti di pentimento. E non è
un’obiezione richiamarsi alle teorie dell’evoluzione: l’uomo è frutto dell’evoluzione, tutto ciò che fa è risultato da
questo processo. Un esempio: tra le attività dell’uomo c’è la geometria euclidea, anche la geometria è il risultato
dell’evoluzione, ma questo non incide minimamente sulla validità del teorema di Goethe o di Pitagora.
L’affermazione “torturare un bambino è crudele” resta con tutto il suo valore indipendentemente dal processo con
cui è nata.
Giulio Giorello. Non vedo nulla di scandaloso nelle conclusioni di Benjamin Libet, sarebbe curioso che la coscienza
non fosse coscienza di qualcosa di fisico. Il libero arbitrio si può dunque attribuire al nostro cervello? E il cervello può
essere determinato univocamente dagli stimoli? Credo che sia difficile dire che negli uomini o negli animali il cervello
risponde in modo univoco agli stimoli. Penso a un celebre esperimento sui macachi, che a un trattamento negativo
rispondevano con una reazione negativa. Ma tutto dipende dal contesto: se il macaco fosse solo, non ci fossero altri
animali né lo sperimentatore, con chi se la potrebbe prendere? I rapporti sociali influiscono sulla reazione. Forse è la
differenza fra libero arbitrio e la nozione più generale di libertà. Anche il più rigido determinismo non nega che sia
lecito chiedere una imputazione di responsabilità sociale. Come diceva Baruch Spinoza, è la natura di Nerone che lo
spinge a uccidere la madre e dare fuoco a Roma, ma i Romani hanno diritto di chiedere la sua testa. A livello politico
la responsabilità resta in maniera cristallina. Se un individuo dice: “ho commesso questo, è vero, ma è stata la mia
natura” a che cosa rinuncia? Alla sua responsabilità, alla sua cittadinanza nella società. La libertà di azione e
espressione nel mondo esterno non è libero arbitrio e può benissimo coesistere con il più rigido determinismo. La
libertà non è metafisica, ma assenza di vincoli al mio modo di agire ed esprimermi, è la libertà della scienza, della
ricerca, della politica.
Perchè l'uomo è naturalmente buono
Il senso morale è scritto nel cervello, esattamente nella corteccia prefrontale. Molti test sugli animali e sull’uomo
indicano che l’etica nasce con noi
Pubblicato il 26/05/12Lo leggo dopo
Il topolino vede di fronte a sé della bella cioccolata e vede anche un suo simile dolorosamente prigioniero dentro un
tubo trasparente: guarda di qua e di là, che fare? Più di un topolino – non tutti, è vero – corre prima a liberare il suo
simile, poi insieme vanno a mangiare la cioccolata. L’esperimento di Jean Decety all’Università di Chicago suggerisce
che il topo conosca l’altruismo e l’empatia, che è il sapersi mettere nei panni degli altri. Sentimenti innati? O
qualcuno glieli ha insegnati?
Il test di Chicago si inscrive in una serie di linee di ricerca tutte volte a scoprire se sia vero per gli uomini un antico
interrogativo: che l’etica è innata, una legge inscritta nella nostra biologia e dettata dall’”interesse”
dell’evoluzione. E’ nell’indagine su questa lunga strada che ha senso la prova con i topi, alla ricerca di un riscontro
primordiale, “animale”. Che sostanzi l’ipotesi che potessero nutrire questi sentimenti anche gli ominidi delle caverne
che fummo.
LE EMOZIONI “SOCIALI” - «Sì, furono loro a imparare che in gruppo si sopravvive meglio. Per esempio,
condividendo il cibo in tempi di carestia, cosa che se tu fossi egoista ed egocentrico, chiuso, non generoso, non
faresti mai. Dunque le emozioni che chiamiamo di tipo sociale furono via via selezionate come utili alla
sopravvivenza della specie in quanto rafforzavano la coesione del gruppo». Donatella Marazziti, docente del
Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia, Farmacologia dell’Università di Pisa, ha condotto con altri
una reviewpassando in rassegna i dati della letteratura su: ”Esiste una neurobiologia del comportamento morale?” E
gli indizi raccolti (il processo è ancora indiziario) convergono verso un sì.
Considerando i modelli animali, specie nei mammiferi (fondamentali gli apporti dell’etologo Konrad Lorenz), si sono
individuati come emozioni “sociali” del tipo utili alla sopravvivenza la gratitudine, la pietà, il senso di colpa, la
compassione, il disprezzo. «Sono sentimenti con una forte ricaduta sociale e insieme formano un codice universale
che tutti seguono a prescindere dalla società in cui vivono», osserva Marazziti. «Dietro a tutti sta un principio
basilare: non nuocere agli altri. Come è pure innato il disgusto nel vedere far male a un altro. Ora, se queste
emozioni sono sempre esistite, ne consegue che devono avere un substrato biologico, dei sistemi neurali che le
reggono e le regolano»
IL VOLTO DELINQUENTE - La via per trovare “scritti” nel corpo le emozioni sociali parte da Cesare Lombroso e il suo
“L’uomo delinquente” (1876) in cui descrisse forme e misure dei volti come segni certi di criminalità innata, passa
per altri studiosi fino a Henry Maudsley che ipotizzò l’esistenza di un centro cerebrale specifico per i sentimenti
morali, e a Emile Kraepelin che crea nel 1896 il termine “psicopatia” e descrive il disturbo di persone incapaci per la
loro natura di essere morali.
IL CASO PHINEAS GAGE - Un cervello malato alla base della sociopatia, dunque ipotizzano in tanti. Ma malato dove,
in quale parte del cervello? L’indicazione è venuta da un caso clamoroso di metà Ottocento il cui protagonista è il più
famoso malato di tutta la psichiatria. Dunque, Phineas Gage era un addetto alla costruzione di ferrovie nel New
England, Usa, che si occupava di porre gli esplosivi. Giovane molto stimato perché capace e affidabile sul lavoro,
persona retta e solida nella vita quotidiana. Succede che un’esplosione mal fatta gli scaraventa contro la testa una
barra metallica che gli trapassa la fronte ed esce dalla sommità della testa. Benché si fosse nel 1848, le cure salvano
Gage (perde solo un occhio), ma da quel giorno è irriconoscibile: strafottente, offensivo, insofferente di regole e
limiti, il linguaggio diventato osceno, in particolare è aggressivo con le donne. Tanto che, ripresentatosi al lavoro, il
“nuovo” Phineas Gage non viene riassunto.
LA ZONA ETICA - «Fu per la prima volta evidente che nel cervello umano vi sono sistemi che regolano la personalità
e il modo di essere e di sentire individuali e che, come le ferite di Gage dimostravano, la loro posizione è nella
zona frontale», riprende la professoressa Donatella Marazziti. «Da allora si sono accumulati studi, di recente molti
condotti attraverso la Risonanza nucleare magnetica funzionale. Si è arrivati a individuare come aree coinvolte nella
moralità la corteccia prefrontale ventro-mediale e l’adiacente area orbito-frontale, l’amigdala. A parte le
implicazioni etiche delle ricerche, va tenuto presente che al posto della sbarra metallica di Gage possono ledere
queste zone un ictus, un tumore, un’infezione o la rottura di un aneurisma modificando così il senso morale del
malato».
Test su questi temi ha condotto in particolare Antonio Damasio, il neuroscienziato americano di origine portoghese
che scrivendo sulla Repubblica il mese scorso proprio delle emozioni sociali sottolineava più volte che «non sono
state inventate dalla ragione», che «il ragionamento consapevole» è arrivato dopo che la lotta per la sopravvivenza
le aveva già selezionate e inscritte nel cervello come utili. A due giorni di distanza, stavolta sul Corriere della Sera, era
il cognitivista Massimo Piattelli Palmarini a interrogarsi sull’etica innata sotto il paradossale titolo “Siamo pronti alla
pillola della moralità?”, chiamando in causa il perdurare o meno del libero arbitrio.
LA LEZIONE DI ANTIGONE - Per distinguere le norme innate (morale normativa) e le norme scritte in leggi e
costituzioni (morale descrittiva), la professoressa Marazziti nella sua review richiama il personaggio di Antigone
dall’omonima tragedia di Sofocle. Il tiranno di Tebe Creonte non vuole che il fratello di Antigone sia sepolto per
indegnità, ma lei ritiene un dovere morale dargli sepoltura, e lo farà, a rischio della vita, in obbedienza non alle leggi
della città, ma a “leggi non scritte, inalterabili, eterne: quelle che nessuno sa quando comparvero”.
Quelle che Immanuel Kant chiamava la “legge morale dentro di me”, sublime ed esistente a prescindere come il
“cielo stellato sopra di me”.
Serena Zoli