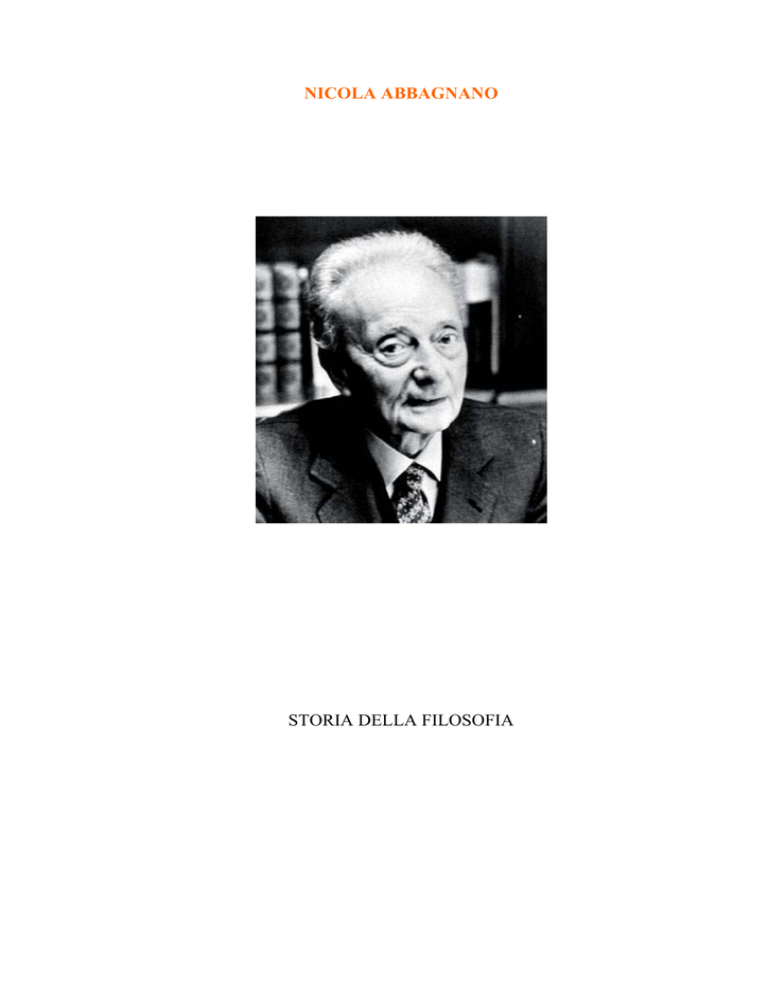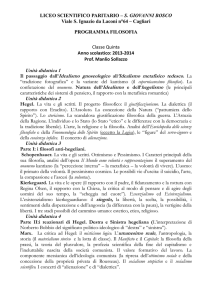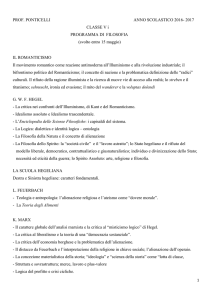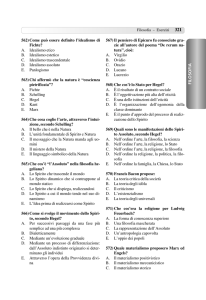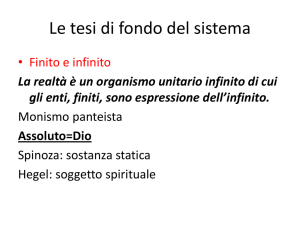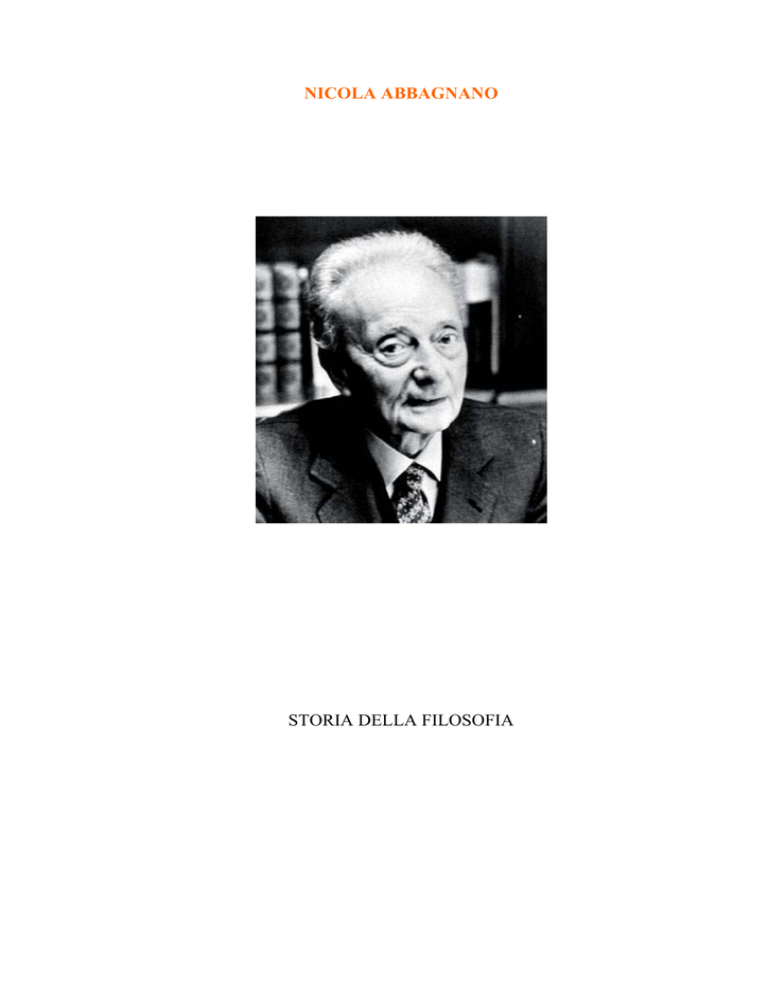
NICOLA ABBAGNANO
STORIA DELLA FILOSOFIA
" Un'opera che, legando strettamente le dottrine alla personalità dei filosofi, e
quindi sottolineando il loro significato esistenziale, rappresentava una netta rottura
rispetto alla storiografia filosofica d'impianto idealistico, quella praticata da Gentile
e dalla scuola gentiliana fino a De Ruggiero" (….) "Essa rimane - a distanza di
quarant'anni, e son molti - la migliore esposizione complessiva dello sviluppo del
pensiero filosofico che sia disponibile nel nostro paese e una delle migliori, a detta di
Quine, nella letteratura internazionale".
Nicola Abbagnano (1901-1990), in "Rivista di filosofia", vol. LXXXI, n.3, 1990.
p.327.
Questa Storia della filosofia è intesa a mostrare l'essenziale umanità dei filosofi.
Perdura ancora oggi il pregiudizio che la filosofia si affatichi intorno a problemi che
non hanno il minimo rapporto con l'esistenza umana e rimanga chiusa in una sfera
lontana e inaccessibile dove non giungano le aspirazioni e i bisogni degli uomini. E
accanto a questo pregiudizio è l'altro, che la storia della filosofia sia il panorama
sconcertante di opinioni che si accavallano e si contrappongono, prive di un filo
conduttore che serva di orientamento per i problemi della vita. Questi pregiudizi sono
indubbiamente rafforzati da quegli indirizzi filosofici che, per amore di un malinteso
tecnicismo, hanno preteso ridurre la filosofia a una disciplina particolare accessibile a
pochi e ne hanno misconosciuto così il valore universalmente umano. Si tratta
tuttavia di pregiudizi ingiusti, fondati su false apparenze e sulla ignoranza di ciò che
condannano. A dimostrarli è diretta quest'opera. La quale muove dalla convinzione
che nulla di ciò che è umano è estraneo alla filosofia e che anzi questa è l'uomo
stesso, che si fa problema a se stesso e cerca le ragioni e il fondamento dell'essere che
è suo. L'essenziale connessione tra la filosofia e l'uomo è la prima base dell'indagine
storiografica istituita in questo libro. Su tale base, questa indagine prende a
considerare che la ricerca che da 26 secoli gli uomini dell'occidente conducono
intorno al proprio essere e al proprio destino. Attraverso lotte e conquiste, dispersioni
e ritorni, questa ricerca ha accumulato un tesoro di esperienze vitali, che occorre
riscoprire e far rivivere al di là della veste dottrinale, che molto spesso le cela anziché
rivelarle. Giacché la storia della filosofia è profondamente diversa da quella della
scienza. Le dottrine passate e abbandonate non hanno più per la scienza significato
vitale; e quelle ancora valide fanno parte del suo corpo vivente e non c'è bisogno di
rivolgersi alla storia per apprenderle e farle proprie. In filosofia la considerazione
storica è invece fondamentale; una filosofia del passato, se è stata veramente
filosofia, non è un errore abbandonato e morto, ma una fonte perenne di
insegnamento e di vita. In essa si è incarnata ed espressa la persona del filosofo, non
solo in ciò che aveva di più suo, nella singolarità della sua esperienza di pensiero e di
vita, ma nei suoi rapporti con gli altri e col mondo in cui egli visse. E alla persona
dobbiamo rivolgerci per scoprire il senso vitale di ogni dottrina. Dobbiamo fissare in
ogni dottrina il centro intorno al quale gravitarono gli interessi fondamentali del
filosofo, e che è insieme il centro della sua personalità di uomo e di pensatore.
Dobbiamo far rivivere davanti a noi il filosofo nella sua realtà di persona storica per
intendere chiaramente, attraverso l'oscurità dei secoli obliosi o le tradizioni
deformanti, la sua parola autentica che ancora può servirci di orientamento e di guida.
Non saranno perciò presentati, in quest'opera, sistemi o problemi, quasi sostanziati e
considerati come realtà indipendenti; ma figure o persone vive, fatte emergere dalla
logica della ricerca in cui vollero esprimersi e considerate nei loro rapporti con altre
figure e persone. La storia della filosofia non è né il dominio di dottrine impersonali
che si seguano disordinatamente o si concatenino dialetticamente, né la sfera d'azione
di problemi eterni, di cui le singole dottrine siano manifestazioni contingenti. E' un
tessuto di rapporti umani, che si muovono sul piano si una comune disciplina di
ricerca, e che perciò trascendono gli aspetti contingenti o insignificanti, per fondarsi
su quelli essenziali o costitutivi. Essa rivela la solidarietà fondamentale degli sforzi
che mirano a rendere chiara per quanto è possibile la condizione e il destino
dell'uomo; solidarietà che si esprime nell'affinità delle dottrina come nella loro
opposizione, nella loro concordanza come nella loro polemica. La storia della
filosofia riproduce nella tecnica delle indagini rigorosamente disciplinate lo stesso
tentativo che è la base e il movente di ogni rapporto umano: comprendersi e
comprendere. E lo riproduce nelle stesse vicende di riuscite e di disinganni, di
illusioni risorgenti e di chiarezze orientatrici, e di sempre rinascenti speranze. La
disparità e l'opposizione delle dottrine perdono così il loro carattere sconcertante.
L'uomo ha tentato e tenta tutte le vie per comprendere se stesso, gli altri e il mondo.
Vi è riuscito e vi riesce più o meno. Ma deve e dovrà rinnovare il tentativo, dal quale
dipende la sua dignità di uomo. E non può rinnovarlo se non rivolgendosi al passato e
attingendo dalla storia l'aiuto che gli altri possono dargli per l'avvenire. Non si
troveranno perciò in quest'opera critiche estrinseche, che pretendano mettere in luce
gli errori dei filosofi. La pretesa di impartire ai filosofi lezioni di filosofia è ridicola,
come quella di fare di una determinata filosofia il criterio e la norma di giudizio delle
altre. Ogni vero filosofo è un maestro o compagno di ricerca, la cui voce ci giunge
affievolita attraverso il tempo, ma può avere per noi, per i problemi che ora ci
occupano, un'importanza decisiva. Bisogna disporsi alla ricerca con sincerità e
umiltà. Noi non possiamo raggiungere, senza l'aiuto che ci viene dai filosofi del
passato, la soluzione dei problemi dai quali dipende la nostra esistenza singola ed
associata. Noi dobbiamo perciò proporre storicamente tali problemi; e nel tentativo di
intendere la parola genuina di Platone o di Aristotele, di Agostino o di Kant e di
quanti altri, piccoli o grandi, abbiano saputo esprimere un'esperienza umana
fondamentale, dobbiamo vedere il tentativo stesso di mettere in chiaro e portare alla
soluzione i nostri problemi. Il problema di ciò che noi siamo e dobbiamo essere è
fondamentalmente identico col problema di ciò che furono e vollero essere, nella loro
sostanza umana, i filosofi del passato. La separazione dei due problemi toglie al
filosofare il suo nutrimento e alla storia della filosofia la sua importanza vitale.
L'unità dei due problemi garantisce l'efficacia e la forza del filosofare e fonda il
valore della storiografia filosofica. La storia della filosofia salda insieme il passato e
l'avvenire della filosofia. Questa saldatura è l'essenziale storicità della filosofia. Ma
appunto perciò la preoccupazione dell'oggettività, la cautela critica, la ricerca
paziente dei testi, l'aderenza alle intenzioni espresse dai filosofi, non sono nella
storiografia filosofica altrettanti sintomi di rinuncia all'interesse teoretico, ma le prove
più sicure della serietà dell'impegno teoretico. Giacché chi si attende dalla ricerca
storica un aiuto effettivo, chi vede nei filosofi del passato maestri e compagni di
ricerca, non ha interesse a travisarne l'aspetto, a camuffarne la dottrina, a metterne in
ombra tratti fondamentali. Ha invece tutto l'interesse a riconoscerne il volto vero, così
come chi intraprende un difficile viaggio ha interesse a conoscere la vera natura di
chi gli serve da guida. Ogni illusione o inganno è in questo caso rovinoso. La serietà
dell'indagine condiziona e rivela l'impegno teoretico. E' evidente, da questo punto di
vista, che non ci si può aspettare di trovare nella storia della filosofia un continuo
progresso, la formazione graduale di un unico e universale corpo di verità. Questo
progresso quale si verifica nelle singole scienze, che una volta impostate sulle loro
basi si accrescono gradualmente per il sommarsi dei contributi singoli, non può
ritrovarsi in filosofia; giacché qui non ci sono verità oggettive e impersonali che
possano sommarsi e integrarsi in un corpo unico, ma persone che dialogano intorno al
loro destino; e le dottrine non sono che espressioni di questo dialogare ininterrotto,
domande e risposte che talora si richiamano e si corrispondono attraverso i secoli. La
più alta personalità filosofica di tutti i tempi, Platone, ha espresso nella stessa forma
letteraria delle sue opere - il dialogo - la natura vera del filosofare. Nella storia della
filosofia non c'è neppure, d'altra parte, una semplice successione disordinata di
opinioni che si accavallano e distruggano a vicenda. I problemi sui quali verte
l'incessante dialogare dei filosofi hanno una loro logica, che è la disciplina stessa cui i
filosofi liberamente sottopongono la loro ricerca: sicché certe direttive rimangono a
dominare un periodo o un'epoca storica, perché hanno gettato una luce più viva su un
problema fondamentale. Acquistano, allora, una impersonalità apparente, che fa di
esse il patrimonio comune di intere generazioni di filosofi (si pensi all'agostinismo o
all'aristotelismo nella scolastica); ma poi decadono e tramontano, e tuttavia la persona
vera del filosofo non tramonta mai e tutti possono e debbono interrogarlo per
attingerne lume La storia della filosofia presenta così uno strano paradosso. Non c'è,
si può dire, dottrina filosofica che non sia stata criticata, negata, impugnata e distrutta
dalla critica filosofica. Ma chi vorrebbe sostenere che l'obliterazione definitiva di uno
solo dei grandi filosofi antichi o moderni non sarebbe un impoverimento
irrimediabile per tutti gli uomini? E' che il valore di una filosofia non si misura alla
stregua del quantum di verità oggettiva che essa contiene, ma solo alla stregua della
sua capacità di servire come punto di riferimento (magari soltanto polemico) per ogni
tentativo di intendere se stessi e il mondo. Quando Kant riconosce a Hume il merito
di averlo svegliato dal "sonno dogmatico" e di averlo avviato al criticismo, formula
nel modo più immediato ed evidente il rapporto di libera interdipendenza che lega
tutti insieme i filosofi nella storia. Una filosofia non ha valore in quanto suscita
l'accordo formale di un certo numero di persone su determinate dottrine, ma solo in
quanto suscita ed inspira negli altri quella ricerca che li conduce a trovare ognuno la
propria via, così come l'autore trovò in essa la sua. Il grande esempio è ancora qui
quello di Platone e di Socrate: per tutta la vita Platone cercò di realizzare il significato
della figura e dell'insegnamento di Socrate procedendo, quando era necessario, al di
là dell'involucro dottrinale in cui apparivano chiusi; e così la più alta e bella filosofia
è nata da un atto ripetuto di fedeltà storica Tutto ciò esclude che nella storia della
filosofia si possa vedere soltanto disordine o sovrapposizione di opinioni; ma esclude
pure che si possa vedere in essa un ordine necessario dialetticamente concatenato, per
il quale la successione cronologica delle dottrine equivalga allo sviluppo razionale di
momenti ideali costituenti una verità unica che compaia nella sua pienezza alla fine
del processo. La concezione hegeliana fa della storia della filosofia il processo
infallibile di formazione di una determinata filosofia. E così toglie la libertà della
ricerca filosofica, che è condizionata dalla realtà storica della persona che cerca; nega
la problematicità della storia stessa e ne fa un ciclo concluso, senza avvenire. Gli
elementi che costituiscono la vitalità della filosofia vanno così tutti perduti. In verità
la storia della filosofia è storia nel tempo, quindi problematica; ed è fatta non da
dottrine o da momenti ideali, ma da uomini solidalmente legati alla comune ricerca.
Non ogni dottrina successiva nel tempo è, perciò solo, più vera delle precedenti.
Incombe il rischio che insegnamenti vitali vadano perduti od obliati, come spesso è
accaduto ed accade; e quindi il dovere di ricercare incessantemente il loro significato
genuino A questo dovere obbedisce, nei limiti che mi sono concessi, l'opera presente.
In tale spirito, voglia intenderla e giudicarla ogni lettore.
Nicola Abbagnano, Torino, 1946
INDICE VOLUME 3°
Capitolo 1: Figure e movimenti della Filosofia tedesca di fine secolo.
Dalla crisi dell’Illuminismo ai prodromi del Romanticismo
Capitolo 2: Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo
Capitolo 3: Dal kantismo all’Idealismo
Capitolo 4: Johann Gottlieb Fichte
Capitolo 5: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
Capitolo 6: Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Capitolo 7: Schopenhauer ed Herbart
Capitolo 8: Sören Kierkegaard
Capitolo 9: La sinistra hegeliana e Feuerbach
Capitolo 10: Karl Marx
Capitolo 11: Tradizionalismo, Romanticismo e Spiritualismo
Capitolo 12: Sviluppi e tendenze della scienza ottocentesca
Capitolo 13: Il Positivismo sociale
Capitolo 14: Il Positivismo evoluzionistico
Capitolo 15: Friedrich Nietzsche
Capitolo 16: Lo Spiritualismo, la filosofia dell'azione e Bergson
Capitolo 17: Il Neo-criticismo e lo storicismo tedesco contemporaneo
Capitolo 18: Benedetto Croce
Capitolo 19: Il Pragmatismo
Capitolo 20: Lo sviluppo critico delle matematiche
Capitolo 21: Sviluppi delle scienze umane
Capitolo 22: La Rivoluzione psicanalitica
Capitolo 23: Filosofia, scienza e linguaggio da Mach a Wittgenstein
Capitolo 24: Neopositivismo, filosofia analitica e dibattito epistemologico
STORIA DELLA FILOSOFIA
di Nicola Abbagnano.
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
PARTE PRIMA: FILOSOFIA E CULTURA DEL ROMANTICISMO
Mio malgrado l'infinito mi tormenta. (De Musset).
Capitolo 1: FIGURE E MOVIMENTI DELLA FILOSOFIA TEDESCA DI FINE
SECOLO.
DALLA CRISI DELL'ILLUMINISMO AI PRODROMI DEL ROMANTICISMO
1. La filosofia della fede di Hamann e lo storicismo di Herder.
In Germania, negli ultimi decenni del Settecento, si va sempre più
rafforzando un filone di pensiero apertamente polemico verso
l'illuminismo e verso il kantismo.
Le reaazioni all'illuminismo e al kantismo.
Le esigenze dalle quali queste polemiche mossero furono in generale
quelle della fede e della tradizione religiosa. La filosofia
kantiana appariva muta o ostile di fronte a tali esigenze
perché era una filosofia della ragione: alla ragione si contrappose
allora, come organo di conoscenza, la fede, l'intuizione mistica, il
sentimento, o in generale qualche facoltà postulata ad hoc e ritenuta
capace di procedere al di là dei limiti della ragione, verso quella
realtà superiore che sembra l'oggetto specifico dell'esperienza mistica o
in generale della religione.
Hamann e il tema della fede.
La filosofia della fede in questo senso s'inizia con l'opera di un
concittadino di Kant, Johann Georg Hamann (1730-1788), un impiegato di
dogana che fu in rapporti di amicizia con Kant, Herder e Jacobi e
fu chiamato il «mago del nord». Hamann batte in breccia le
pretese della ragione. «Cos'è l'arcilodata ragione con la sua
universalità, infallibilità, esaltazione, certezza e evidenza? Un ens
rationis, un idolo, cui la superstizione sfacciata e irrazionale assegna
attributi divini». Non la ragione ma la fede costituisce l'uomo nella sua
totalità. Hamann si rifà in ciò a Hume che aveva riconosciuto nella
credenza l'unica base della conoscenza. Ma la credenza di Hume è una
credenza empirica che ha per oggetto le cose e i loro legami causali. La
credenza di Hamann è invece una fede mistica, un'esperienza misteriosa
nella quale trovano posto non soltanto i fatti naturali e le
testimonianze dei sensi ma anche i fatti storici, le testimonianze della
tradizione e i fatti divini testimoniati dalla rivelazione. La fede di
Hamann è la rivelazione immediata della natura e di Dio. E Hamann non fa
nessuna divisione o distinzione tra ciò che è sensibile e ciò che è
religioso, tra ciò che è umano e ciò che è divino. Egli riconosce con
Bruno il più alto principio del sapere nella coincidentia oppositorum.
Nell'uomo coincidono tutti gli opposti princìpi del mondo; e per quanto
egli cerchi con la filosofia di intendere ed afferrare la loro unità, non
potrà mai comprenderla attraverso concetti o raggiungerla con la
ragione. La fede soltanto può rivelargliela, in quanto è un rapporto
diretto tra l'uomo e Dio; un rapporto che non è mediato da concetti, ma
individuato e singolo e in virtù del quale io, nella mia individualità,
mi trovo di fronte al mio Dio.
Herder.
Sulla stessa linea si muove il pensiero di Johann Gottfried Herder (25
agosto 1744-18 dicembre 1803) che fu scolaro di Kant e amico di Hamann.
A Kant, Herder rimprovera (Metacritica alla critica della ragion pura,
1799) il dualismo di materia e di forma, di natura e di libertà; e a
questo dualismo contrappone l'essenziale unità dello spirito e della
natura che egli vede attuata nella dottrina di Spinoza (alla quale
dedicò un dialogo intitolato Dio).
La filosofia della storia.
Ma la più notevole dottrina filosofica di Herder è il suo concetto del
cristianesimo come di una religione dell'umanità, e della storia umana
come di un progressivo sviluppo verso la compiuta realizzazione
dell'umanità stessa. Nelle Idee per una filosofia della storia dell'umanità
(1784-1791) Herder afferma il principio che nella storia, come nella
natura, ogni sviluppo è sottoposto a determinate condizioni naturali e a
leggi immutabili. La natura è un tutto vivente, che si sviluppa secondo
un piano totale di organizzazione progressiva. In essa agiscono e
lottano forze diverse ed opposte. L'uomo, come ogni altro animale, è un
suo prodotto: ma esso è al culmine dell'organizzazione, perché con lui
nasce l'attività razionale, e quindi l'arte e il linguaggio che lo portano
all'umanità e alla religione. La storia umana non fa che seguire la
stessa legge di sviluppo della natura, che procede dal mondo inorganico
e organico fino all'uomo per portarlo alla sua vera essenza. Natura e
storia lavorano entrambe per l'educazione dell'uomo all'umanità. E tale
educazione è frutto non della ragione, ma della religione, che si
connette alla storia umana sin dai primordi e rivela all'uomo ciò che c'è
di divino nella natura.
A questo concetto di un progresso continuo e necessario del genere umano
nella sua storia, Herder è condotto dall'analogia fra il mondo della
natura e il mondo della storia, analogia fondata sulla profonda unità di
questi due mondi che entrambi sono creazione e manifestazione di Dio.
Dio, che ha ordinato nel modo più saggio il mondo della natura e ne
garantisce in modo infallibile la conservazione e lo sviluppo, potrebbe
permettere che la storia del genere umano si svolgesse senza un piano
qualsiasi, al di fuori della sua saggezza è della sua bontà? A questa
domanda deve rispondere la filosofia della storia; la quale deve
dimostrare che il genere umano non è un gregge senza pastore e che per
esso valgono quelle stesse leggi che determinano l'organizzazione
progressiva del mondo naturale. «Come vi è un Dio nella natura vi è
anche un Dio nella storia; giacché l'uomo è parte della natura e deve,
anche nelle sue più selvagge intemperanze e passioni, seguire leggi che
non sono meno belle ed eccellenti di quelle secondo le quali si muovono
tutti i cieli e i corpi terrestri». Il fine a cui le leggi della storia
indirizzano l'uomo è la sua stessa umanità. « A questo scopo evidente è
organizzata la nostra natura; per esso ci sono dati sensi e impulsi più
raffinati, per esso ci sono date la ragione e la libertà, una salute
delicata e durevole, il linguaggio, l'arte e la religione. In ogni
condizione e in ogni società, l'uomo non può avere altro in vista né può
altro costruire che l'umanità, così come la pensa in se stesso».
2. Jacobi e la «polemica sullo spinozismo».
La filosofia della fede, quale era sviluppata da Hamann e Herder,
conduceva ad una conclusione panteistica: sembrava cioè rendere
impossibile una distinzione qualsiasi tra natura e Dio e far propria
così la tesi classica del panteismo di cui scorgeva i precedenti in
Bruno, Spinoza e Shaftesbury. La filosofia della fede di Jacobi è invece
da lui sviluppata nel senso di un rigoroso teismo: Jacobi intende
dividere Dio dalla natura così risolutamente come altri li avevano uniti.
Lo scopo della speculazione di Jacobi (1743-1819) è quello di difendere la
validità della fede come sentimento dell'incondizionato, cioè di Dio. Egli
rigetta la speculazione «disinteressata»; vuol difendere non la verità,
ma «una determinata verità». «Voglio rendermi chiaro con l'intelletto una
sola cosa, egli dice (Lettere su Spinoza, traduzione italiana, pagina 4),
cioè la mia devozione naturale a un Dio incognito ». A questo scopo
la ragione non serve. Jacobi si pone la domanda cruciale: è l'uomo che ha
la ragione o è la ragione che ha l'uomo? E per lui non c'è dubbio: la
ragione è uno strumento, non è la stessa esistenza umana. Questa risulta
di due rappresentazioni originarie: quella dell'incondizionato, cioè di Dio,
e quella del condizionato, cioè di noi stessi; ma quest'ultima presuppone
la prima. Abbiamo quindi dell'incondizionato una certezza assai maggiore
di quella che abbiamo del condizionato, cioè della nostra stessa
esistenza. Ma questa certezza non è data dalla ragione e non si fonda
sulle prove o sulle dimostrazioni che essa può fornire. è una certezza
di fede. A dimostrare l'esistenza di una divinità creatrice, la ragione non
può giungere mai e non può giungervi mai una filosofia che si avvalga di
essa. Cartesio ha voluto dimostrare l'esistenza di un creatore del mondo;
ma in realtà ciò che ha dimostrato è soltanto l'unità di tutte le cose,
la totalità del mondo. Spinoza ha reso chiaro il significato implicito
della dimostrazione cartesiana nell'espressione stessa di cui si serve:
«Deus sive Natura ». E ciò che vale per lo spinozismo vale per qualunque
sistema che faccia appello alla ragione per giungere a Dio: compreso
quello di Leibniz.
Il rifiuto dello spinozismo.
La dottrina di Spinoza rappresenta per Jacobi l'essenza di ogni dottrina
razionalistica sicché ogni dottrina di questo genere, se sviluppata
coerentemente, si identifica con lo spinozismo. E lo spinozismo è
ateismo, in quanto l'ateismo non è che l'identificazione di Dio col mondo,
dell'incondizionato col condizionato.
Tagliare i ponti con l'ateismo significa tagliare i ponti col
razionalismo e far appello alla fede. Soltanto la fede ci rende certi
dell'esistenza di noi stessi, delle altre cose e di Dio: «Noi tutti siamo
nati nella fede, dice Jacobi (ivi, traduzione italiana, pagina 123), e
nella fede dobbiamo restare, come tutti siamo nati nella società e nella
società dobbiamo restare». Ma fede è rivelazione.
3. Fra «Sturm und Drang», Classicismo e Romanticismo: Schiller e Goethe.
Lo Sturm un Drang.
La filosofia della fede si può considerare nel suo complesso come
l'espressione filosofica di quel movimento letterario-politico che si
chiamò (dal titolo di un dramma di Maximilian Klinger del 1776) Sturm
und Drang, cioè «tempesta e impeto». La ragione contro cui questa
filosofia polemizza è la ragione finita cioè la ragione di cui Kant aveva
segnato le competenze ed i limiti; alla quale contrappone la fede come
organo capace di cogliere ciò che ad essa è inaccessibile.
Alle idee dello Sturm und Drang parteciparono nella loro giovinezza
Schiller e Goethe: sui quali tuttavia la conoscenza della filosofia
kantiana influì in modo positivo, indirizzandoli al riconoscimento della
funzione della ragione anche nella comprensione e nel chiarimento di ciò
che ragione non è, cioè della vita, del sentimento, dell'arte e della
natura, per cui, questi due autori da un lato confluiscono nel Classicismo
e dall'altro lato stimolano e riflettono alcuni temi del nascente
Romanticismo.
Schiller e il tema dell'educazione etica.
Il poeta Friedrich Schiller (1759-1805) fu condotto alla filosofia dalla
speculazione di Kant. Fin dalla giovinezza egli si era dedicato alla
ricerca filosofica, ma si era ispirato soprattutto all'ottimismo
panteistico di Shaftesbury, scorgendo nell'universo una totalità
armonica, sorretta da un'unica vita. Il pensiero di un'armonia che
conciliasse la natura e lo spirito, la vita morale e quella sensibile,
trovò poi nelle opere di Kant e specialmente nella Critica del giudizio
l'incentivo ad approfondirsi e a chiarirsi. Nello scritto Sulla grazia e
la dignità (composto nel 1793) Schiller prospetta l'esigenza che la
dignità dell'azione morale non elimini o distrugga la grazia che deriva
all'azione dall'essere la manifestazione spontanea di tutte le attività
umane, quelle naturali comprese. E questo pensiero diventa dominante e
trova la sua migliore espressione nel capolavoro filosofico di Schiller,
Le lettere sull'educazione estetica (1793-1795), nelle quali il principio
che armonizza insieme la natura e lo spirito viene riconosciuto nell'arte.
L'uomo, dice Schiller, ha un istinto sensibile, che deriva dal suo essere
fisico e lo lega alla materia ed al tempo; e un istinto della forma, che
deriva dal suo essere razionale e tende a farlo libero. Se l'uomo
sacrifica l'istinto razionale a quello materiale, non sarà mai un io,
perché rimarrà disperso nella materia e nel tempo se sacrifica l'istinto
materiale a quello formale, sarà pura forma senza realtà, cioè un nulla.
Deve dunque conciliare i due istinti, in modo che l'uno limiti l'altro; e
dar luogo all'istinto del giuoco che porterà la forma nella materia e la
realtà nella pura forma razionale. L'oggetto di questo istinto sarà la
forma vivente, cioè la bellezza. In tal modo luomo si sottrae sia alla
determinazione della natura sensibile sia a quella della ragione, e
raggiunge una condizione di pura problematicità, che è lo stato
estetico. Questo stato, che è una seconda creazione dell'uomo, è la
condizione di ogni creazione artistica, perché conferisce a tale
creazione la sua indipendenza dall'intelletto e dalla volontà e ne
garantisce quindi il disinteresse. Per opera di Schiller le analisi
kantiane della Critica del giudizio aprivano nuove e feconde possibilità
alla considerazione dell'arte.
Goethe e il tema della Natura.
La stessa idea di un accordo intrinseco o sostanziale tra la natura e lo
spirito il mondo e Dio, animò l'attività filosofica di Wolfgang Goethe
(1749-1832) che tuttavia, a differenza di Schiller, ne fece il punto di
partenza non di una teoria della poesia ma di ricerche, osservazioni e
ipotesi naturalistiche. Non l'arte ma la natura stessa fu il tema che
ispirò la riflessione filosofica di Goethe. Egli è convinto che la
natura e Dio sono strettamente congiunti e fanno tutt'uno. « Tutto ciò
che l'uomo può raggiungere nella vita è che il Dio-natura gli si riveli»,
egli dice. La natura non è che «l'abito vivente della divinità». Perciò
non si può giungere a Dio se non attraverso la natura, come non si può
giungere all'anima se non attraverso il corpo.
Se Goethe è contrario ai materialisti che fanno della natura un puro
sistema di forze meccaniche è altrettanto contrario a Jacobi che pone Dio
assolutamente al di là della natura. «Chi vuole l'essere supremo deve
volere il tutto; chi tratta dello spirito deve presupporre la natura,
chi parla della natura deve presupporre lo spirito. Il pensiero non si
lascia separare da ciò che viene pensato, la volontà non si lascia
separare da ciò che viene mosso». L'esistenza di Dio come di una forza
spirituale, di una ragione, che pervade l'intero universo non ha bisogno di
dimostrazioni. «L'esistenza è Dio stesso» egli dice in una lettera
a Jacobi (del 9 giugno 1785).
Il finalismo.
A questa concezione panteistica s'ispirano le ricerche e le ipotesi
naturalistiche di Goethe, dirette a rintracciare nella natura il
fenomeno originario (Urphänomenon) nel quale si manifesta e si
concreta, in un determinato tipo o forma, la forza divina che regge il
tutto. Perciò egli non condivide il punto di vista di Kant, secondo il
quale la finalità della natura appartiene a una considerazione puramente
soggettiva del mondo, ma non ha valore oggettivo. Per lui la finalità è
la struttura stessa dei fenomeni naturali e le idee che la esprimono
sono i simboli di essa. Arte e natura si distinguono soltanto per gradi
non per qualità; il fine, che l'arte o l'artista persegue, agisce in modo
meno consapevole, ma egualmente efficace, nella natura.
La vita morale come armonia.
Un'altra espressione dell'unità fra natura e spirito, che è la fede di
Goethe, è l'equilibrio, che egli difese esplicitamente e che costituisce
la caratteristica della sua personalità fra sensibilità e ragione. La
vita morale non è per lui, come per Kant, il predominio della ragione
sugli impulsi sensibili, ma l'armonia di tutte le attività umane, il
rapporto equilibrato tra le forze contrastanti che costituiscono l'uomo.
Solo in questo equilibrio egli riconosce la normalità della natura umana.
Per quanto riguarda il Faust, si è già accennato al fatto che esso,
nella ricchezza di motivi che lo costituiscono, esprime quella
concezione dell'uomo in termini di Streben o sforzo che è peculiare
dell'età romantica (vedi capitolo 2, paragrafo 6).
4. Humboldt: la storia, il linguaggio e lo Stato.
All'ideale umanistico di Schiller e Herder si ispira l'opera di Wilhelm
Humboldt (22 giugno 1767-8 aprile 1835), che è il creatore della moderna
scienza del linguaggio.
Lo spirito dell'umanità.
Il principio fondamentale di Humboldt è che, negli uomini e nella loro
storia, viva, agisca e si realizzi gradualmente la forma e lo spirito
dell'umanità, che vale come ideale e criterio valutativo di
ogni individualità e di ogni manifestazione umana. Come
Schiller e Herder, Humboldt ritiene che lo scopo degli uomini è negli
uomini stessi, nella loro formazione progressiva, nello sviluppo e nella
realizzazione della forma umana che è loro propria. Sotto questo aspetto
lo studio dell'uomo dev'essere l'oggetto di una scienza - l'antropologia che, pur muovendo a determinare le condizioni naturali dell'uomo
(temperamento, sesso, nazionalità, eccetera), mira a scoprire, attraverso
di esse, l'ideale stesso dell'umanità, la forma incondizionata, alla quale
nessun individuo si adegua mai perfettamente, ma che rimane lo scopo cui
tutti gli individui tendono ad avvicinarsi. Humboldt chiama spirito
dell'umanità l'ideale forma umana che non si trova mai realizzata
empiricamente, sebbene sia il termine di ogni attività umana; e
riconosce in questo spirito dell'umanità la forza spirituale dalla quale
dipendono tutte le manifestazioni dell'uomo nel mondo. I grandi uomini
sono stati quelli nei quali più potentemente si è affermato lo spirito
dell'umanità, come per esempio è avvenuto in Goethe; e i grandi popoli
quelli che più si sono avvicinati nel loro sviluppo alla realizzazione
integrale di quello spirito, come è stato il caso dei Greci.
La storia.
La storia appare a Humboldt come «lo sforzo dell'idea per conquistare la
sua esistenza nella realtà». L'idea si manifesta nella storia in una
individualità personale, in una nazione, e in generale in tutti gli
elementi necessari e determinanti che lo storico ha il còmpito di
sceverare e mettere in luce nell'insieme degli aspetti insignificanti o
accidentali. Per l'uomo che non può conoscere il piano totale del
governo del mondo, l'idea può rivelarsi soltanto attraverso il corso
degli eventi, di cui essa costituisce nello stesso tempo la forza
produttiva e lo scopo finale.
Il linguaggio.
All'idea dell'umanità si collega il linguaggio. Il linguaggio è l'attività
stessa delle forze spirituali dell'uomo. E poiché non vi è nessuna forza
dell'anima che non sia attiva, non c'è nell'interno dell'uomo nulla di così
profondo o di così nascosto che non si trasformi nel linguaggio e non si
riconosca in esso. Per questa loro comune radice umana, tutti i
linguaggi hanno nella loro organizzazione intellettuale qualche cosa di
simile. La diversità interviene, per ciò che riguarda questa
organizzazione, sia per il grado in cui la forza creatrice del linguaggio
si è esplicata, grado che è diverso da popolo a popolo e in tempi
diversi, sia perché altre forze agiscono nella creazione del linguaggio,
oltre l'intelletto, e cioè la fantasia e il sentimento. Fantasia e
sentimento, come determinano la diversità dei caratteri individuali,
così determinano la diversità dei caratteri nazionali e quindi la
molteplicità dei linguaggi. Il linguaggio è lo stesso senso interno in
quanto via via giunge alla conoscenza e all'espressione; esso perciò è
legato alle fibre più intime dello spirito nazionale; e nella
diversificazione di questo spirito trova l'ultima radice delle sue
divisioni. Esso è inoltre un organismo che vive soltanto nella totalità
e nella connessione delle sue parti: la prima parola di una lingua la
preannuncia e presuppone tutta. Humboldt ha potuto, in virtù di questa
sua idea, trasformare lo studio del linguaggio da una pura opera di
raccolta ad una comprensione del fenomeno del linguaggio nella sua totalità.
I limiti dello Stato.
L'esigenza di garantire la libera realizzazione dello spirito e
dell'umanità nell'uomo porta Humboldt a restringere i limiti dell'azione
dello stato. L'opera Sui limiti dello Stato (scritta a 25 anni, ma
pubblicata soltanto nel 1851) riduce il còmpito positivo dello stato
alla garanzia della sicurezza interna ed esterna, ma esclude, come
eccedente i limiti dello stato, ogni azione positiva diretta a
promuovere il benessere e la vita morale e religiosa dei cittadini. Ciò
che concerne direttamente lo sviluppo fisico, intellettuale, morale e
religioso dell'uomo cade fuori dei limiti dello stato, ed è il còmpito
proprio degli individui e delle nazioni. Lo stato può favorire tale
còmpito solo garantendo le condizioni in cui esso possa svolgersi con
sicurezza, ma ogni suo intervento positivo è dannoso perché contrario
alla condizione indispensabile per il raggiungimento dello sviluppo
completo dei singoli individui, cioè alla libertà.
Indicazioni bibliografiche
Per le figure e i movimenti di quest'età cfr. la bibliografia generale
riportata al capitolo 2.
STORIA DELLA FILOSOFIA
NICOLA ABBAGNANO
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
VOLUME TERZO
PARTE PRIMA: FILOSOFIA E CULTURA DEL ROMANTICISMO
Capitolo 2: Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo
(Questo capitolo (a cura di (G. Fornero), che costituisce una novità
rispetto ai testi tradizionali, è stato scritto ai fini di un possibile
approfondimento, di tipo interdisciplinare, dell'universo culturale
romantico. Come tale esso viene affidato alle scelte degli insegnanti.)
1. Il Romanticismo come «problema».
Con il termine «Romanticismo», che in origine faceva riferimento al
romanzo cavalleresco, ricco di avventure e di amori, si indica il
movimento filosofico, letterario, artistico eccetera che, nato in Germania
negli ultimi anni del secolo 18esimo, ha poi trovato la sua massima
fioritura, in tutta Europa, nei primi decenni dell'Ottocento, improntando
di sé la mentalità di gran parte del secolo.
La delucidazione critica del concetto di «Romanticismo» risulta ancor
più complessa di quella relativa alle nozioni di «Rinascimento» o di
«Illuminismo» e sembra urtare contro ostacoli veramente insormontabili,
che derivano innanzitutto dalla difficoltà di definire adeguatamente
l'ambito storiografico di esso.
L'accezione ristretta di Romanticismo.
A questo proposito sono state elaborate due interpretazioni di fondo.
Per una prima lettura, che risale in parte ai romantici stessi, e che è
stata codificata da Hegel, il Romanticismo sarebbe quell'indirizzo
culturale che trova la sua nota qualificante nell'esaltazione del
«sentimento» e che si concretizza nei rappresentanti del circolo tedesco
di Jena e in tutti i letterati europei seguaci delle loro idee
anti-classicistiche. è indubbio che questo modo di considerare il
Romanticismo abbia avuto, sino ai giorni nostri, notevole fortuna,
sedimentandosi anche nell'uso comune, dove il termine «romantico» si
identifica quasi sempre con gli aggettivi «sentimentale», «poetico»
eccetera.
Il Romanticismo come «atmosfera».
Tuttavia, quest'accezione « ristretta» di Romanticismo, pur cogliendo un
aspetto indubbiamente basilare del movimento, con il tempo ha finito per
apparire troppo angusta. Infatti il suo rischio oggettivo è di privilegiare
esclusivamente l'aspetto letterario ed artistico del Romanticismo,
mettendone in ombra le componenti filosofiche, oppure risolvendo queste
ultime negli scritti di F. Schlegel, Novalis o di qualche altro
autore del cenacolo di Jena, di Heidelberg, di Monaco eccetera. Di
conseguenza, per una seconda interpretazione, di origine più recente, il
Romanticismo tende invece a configurarsi come una «temperie» o
«un'atmosfera» storica, ossia come una situazione mentale generale, che
si riflette nella letteratura come nella filosofia, nella politica come
nella pittura eccetera, e di cui fa parte integrante la corrente
dell'idealismo post-kantiano: «Noi siamo abituati a vedere il fenomeno
romantico concretato in alcune opere d'arte, e questo ci può indurre a
pensarlo esclusivamente come una manifestazione artistica. Ma se si scava
più a fondo l'argomento, si riconosce senza difficoltà che il Romanticismo
è più largamente e in primo luogo un grande fenomeno culturale, che entra
in parte preponderante nella vita morale e nella storia del costume e
delle idee del mondo moderno» (M. Vinciguerra).
Questo significato, più ampio del precedente, ha il vantaggio di prospettare
il Romanticismo in seno storico-culturale, vedendo in esso una
«costellazione» di idee e di atteggiamenti che sorge in relazione a
determinate situazioni socio-politiche (il fallimento della Rivoluzione, il
cesarismo napoleonico, la Restaurazione, i moti nazionali eccetera) e che
si nutre di un tipo di cultura diversa o antitetica a quella dell'età
illuministica. Infatti, mentre nella prima interpretazione si discorre
soprattutto, e unilateralmente, di «scuola romantica», nella seconda si
parla di preferenza di «epoca romantica», di «civiltà romantica» e di
«cultura romantica».
Tuttavia, se si accetta quest'ultima accezione, che è il risultato di un
lavoro di critica e di approfondimento storiografico di oltre un secolo,
sembra sia ancora più difficile elencare i tratti costitutivi del
Romanticismo. Tant'è vero che parecchi studiosi odierni vi rinunciano
programmaticamente, parlando della «pratica impossibilità di racchiudere
in una definizione o in una serie di formule l'essenza del Romanticismo» e
insistendo, non senza fondate ragioni, sui «mille volti» di esso. In altre
parole, accade per il Romanticismo la stessa cosa che per il Rinascimento e
l'Illuminismo, con, in più, l'aggravante dell'ancor maggior «complessità»
ed «asistematicità» oggettiva di tale fenomeno spirituale. Ma, forse, anche
qui si rasenta talora una forma di dogmatismo alla rovescia.
è possibile parlare del Romanticismo?
Infatti, che non sia possibile formulare una definizione esauriente ed
universalmente accettabile del Romanticismo è una tesi su cui vige unanime
consenso, e che già Paul Valéry aveva espresso con tutta la desiderabile
chiarezza polemica affermando che: « Bisognerebbe aver perso ogni esigenza
di rigore intellettuale per osare definire il Romanticismo». Ma tutto questo
non equivale ancora, a nostro avviso, alla pregiudiziale esclusione di ogni
discorso generale su di esso e sulla sua specifica visione del mondo.
Infatti fra il tutto e il nulla, esiste pur sempre il qualcosa che, fuor
di metafora, costituisce il campo effettivo su cui lavora lo storico
delle idee. In altre parole: fra la pretesa di racchiudere «l'essenza» del
Romanticismo in una serie di definizioni e di formule chiuse e la pratica
risoluzione di esso in taluni autori romantici (che non si sa bene con quali
criteri siano stati scelti) esiste la possibilità di tratteggiare alcune
tendenze tipiche della «mentalità romantica».
Certo il Romanticismo, come vedremo fra poco, è pieno di «ambivalenze»,
poiché in esso coesistono ad esempio il primato dell'individuo e quello
della società, l'esaltazione del passato e l'attesa messianica del futuro,
l'evasione nel fantastico e il realismo, il titanismo e il vittimismo, il
sentimentalismo e il razionalismo eccetera. Ma ciò non toglie, guardando
più nel profondo, che tutti questi motivi, pur nella loro antitetica natura,
cadano in un medesimo «orizzonte» complessivo e siano espressione di
un'«aria comune» che circola simultaneamente in essi, caratterizandoli in
modo inequivocabilmente «romantico». Per cui, o si ha la coerenza di
espellere il concetto di Romanticismo dal dizionario culturale corrente,
ritenendolo «un'invenzione degli storici», o si deve per forza ammettere
che esso sottintende un fondato riferimento a taluni atteggiamenti
ricorrenti, che caratterizzano i letterati e i filosofi della prima metà
dell'Ottocento.
La ricerca di talune note ricorrenti della pluriforme cultura romantica.
Ad esempio, l'esaltazione del sentimento da un lato, e la celebrazione
idealistica ed hegeliana della «ragione dialettica» dall'altro, non sono
due posizioni totalmente contrapposte, perché scaturiscono da un analogo
atteggiamento, che è tipico della cultura romantica: la polemica contro
l'intelletto illuministico. Tant'è vero che tutti e due mirano a risolvere
il medesimo problema, ovvero il ritrovamento di una via per l'Assoluto.
Ora è soltanto sulla base della constatazione di tali atteggiamenti
similari che possiamo catalogare alcuni autori come «romantici»,
individualizzandoli nei confronti di quelli di altre età, e che possiamo
dire, ad esempio, che mentre Voltaire e Diderot sono degli « illuministi»,
Novalis, Schelling e Schleiermacher sono invece dei «romantici».
Di conseguenza, a nostro giudizio, l'autentico e concreto problema
storiografico circa il Romanticismo non è quello di fornire una
fotografia onnicomprensiva e definitiva di esso, o di limitarsi a
denunciare sterilmente l'impossibilità di ogni discorso introduttivo;
bensì quello di delineare uno schema tipico-ideale capace di «stringere»
o di «raccogliere» talune note ricorrenti della pluriforme e
pluridirezionale Weltanschauung (visione del mondo) romantica.
Ovviamente si tratta di un'impresa mai conclusa e sempre aperta a nuove
acquisizioni, conferme, smentite, riformulazioni - ma su cui ogni epoca ed
ogni storico non può fare a meno di cimentarsi.
La connessione romantica fra poesia e filosofia.
Chiarito il concetto sintetico o «globale» di Romanticismo e legittimata
la possibilità di un discorso «aperto» sui suoi caratteri enerali, nasce
un altro problema: dove andranno cercati quei tratti che formano la
«filosofia», o meglio, la concezione romantica del mondo? Nei filosofi
in senso stretto e tecnico o anche nei letterati? Ovviamente, avendo
interpretato il Romanticismo come «atmosfera culturale», in cui circola
una comune forma mentis, riteniamo che i tratti in questione andranno
rintracciati sia negli artisti, sia nei filosofi che li esprimono, gli
uni in maniera più disorganica, e gli altri in modo più sistematico.
Del resto, la stretta connessione fra poesia e filosofia è una
caratteristica oggettiva del Romanticismo, esplicitamente proclamata e
teorizzata da Schlegel:
«Tutta la storia della poesia moderna è un continuo commento al breve
testo della filosofia... poesia e filosofia debbono essere unite».
Siccome la Germania costituisce l'anima ed il centro, soprattutto
filosofico, del Romanticismo europeo, ci soffermeremo in particolare sul
Romanticismo tedesco, accennando in seguito alle altre nazioni (vedi
paragrafo 13).
2. Il circolo di Jena.
Il gruppo di Jena.
Storicamente il Romanticismo tedesco, cuore e centro propulsore del
movimento, ha come luogo di formazione la città di Jena e trova i suoi
animatori ed esponenti di punta in Friedrich Schlegel (1772-1829),
teorico della corrente; in August Wilhelm Schlegel (1767-1845), fratello
di Friedrich; in Karoline Michaelis (1769-1809), donna di notevole fascino
e personalità, moglie di W. Schlegel e, in seguito, di Schelling; in
Friedrich von Hardenberg, detto Novalis (1772-1801), una delle menti più
rappresentative di tutto il Romanticismo tedesco e poeta d'avanguardia
del circolo jenese. Nel 1797, nel corso di un'aspra polemica con
Schiller, F. Schlegel si trasferisce a Berlino, dove fonda la rivista
«Athenaeum», edita fra il 1798 e il 1800, che rappresenta il primo
strumento di diffusione delle nuove idee. A Berlino F. Schlegel entra in
contatto, da un lato, con il filosofo Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher (1768-1834) e dall'altro con la scuola d'arte rappresentata
da Johann Ludwig Tieck (1793-1853) e da Wilhelm Heinrich
Wackenroder (1773-1798). Rientra inoltre nell'atmosfera intellettuale del
circolo, nonostante sia rimasto in disparte, il grande poeta
Friedrich Hölderlin (1770-1843). Gli Schlegel furono in rapporto anche
con Fichte, conosciuto a Jena nel 1796 e di cui subirono l'influsso
filosofico, attribuendogli la paternità ideale dello stesso movimento
romantico; nonché con Schelling, che ad un certo punto parve la maggiore
incarnazione filosofica delle nuove idee. Hegel stesso, amico, negli
anni giovanili, di Hölderlin e di Schelling, ebbe modo di conoscere le
dottrine estetiche e filosofiche del cenacolo degli Schlegel, che in
seguito criticò aspramente, pur essendo influenzato dal generale clima
romantico. Nel 1801, alla morte di Novalis, il gruppo si sciolse, ma le
sue idee si diffusero rapidamente in altri centri della Germania
(Monaco, Dresda, Heidelberg eccetera) e all'estero.
3. Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco.
Motivi tipici del Romanticismo tedesco.
Sulla base delle norme metodologiche sopraccitate, analizziamo adesso
alcuni tratti del Romanticismo tedesco, che ricorrono, con verificabile
frequenza, negli autori che vengono definiti «romantici», rappresentando
le coordinate di fondo dell'intero movimento. Ovviamente, ed è bene
precisarlo subito per evitare possibili equivoci, non è detto che i
tratti sottoelencati si trovino tutti, e contemporaneamente, in tutti
gli autori, poiché si tratta di motivi la cui presenza, in un
determinato scrittore, autorizza a parlare di «aspetti» più o meno
accentuatamente «romantici» della sua opera.
Un esempio illuminante può essere quello di Hegel. Il fatto che tale
filosofo abbia polemizzato contro il primato del sentimento e contro
determinate posizioni del circolo di Jena non implica che egli, come
afferma qualche studioso, non abbia più nulla a che fare con il
Romanticismo. Infatti, pur non rientrando nella «scuola romantica» in
senso stretto, Hegel risulta profondamente parecipe del clima culturale
romantico, del quale condivide soprattutto il tema dell'infinito anche se
ritiene che esso non possa venir colto tramite il sentimento o la fede,
ma in virtù della « ragione dialettica» (vedi paragrafo 4.2). Per cui la
sua contrapposizione ai romantici costituisce un capitolo del Romanticismo
stesso.
Siccome l'unità culturale del periodo romantico, come si è puntualizzato,
non esclude, ma presuppone, pur all'interno di atteggiamenti e motivi
comuni, un'ovvia molteplicità di interpretazioni e di soluzioni,
cercheremo di differenziare subito le alternative più importanti,
rimandando alle esposizioni dei singoli autori per la loro trattazione
analitica.
4. Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie
d'accesso alla realtà e all'Assoluto.
Si afferma talora, sulla scorta di una lunga consuetudine storiografica,
che i romantici ripudiano la ragione. Poiché questo, come avremo modo di
rilevare, non è sempre vero, per essere più precisi ed aderenti al
movimento nella sua globalità, si dovrebbe dire che i romantici, pur
nella varietà delle loro posizioni, sono tutti d'accordo nel respingere
la ragione illuministica.
La polemica contro la ragione illuministica.
Infatti, come si è visto, il Romanticismo, geneticamente e storicamente
parlando, nasce proprio con il ripudio di quel tipo di ragione della
quale l'Illuminismo aveva fatto la propria bandiera ed il proprio
strumento interpretativo del mondo. Già incriminata del «bagno di sangue»
della Rivoluzione e del militarismo napoleonico, la ragione dei philosophes
viene anche ritenuta incapace di comprendere la realtà profonda dell'uomo,
dell'universo e di Dio.
Di conseguenza, messa da parte la ragione prevalentemente
empiristico-scientifica dell'Illuminismo e del criticismo, che aveva
sbarrato le porte alla metafisica, i romantici cercano altre vie di
accesso alla realtà e all'infinito. A questo proposito, le strade
percorse, pur all'interno del comune denominatore anti-illuministico, sono
molteplici.
4.1. L'esaltazione del sentimento e dell'arte.
Il tema del sentimento.
Da taluni, soprattutto dai poeti e dagli artisti, l'organo più funzionale
per rapportarsi alla vita e per penetrare nell'essenza più riposta
dell'universo viene rintracciato nel sentimento: una categoria spirituale
che l'antichità classica aveva per lo più ignorato o disprezzato, che il
Settecento illuministico aveva cominciato a riconoscere nella sua forza
e che nel Romanticismo acquista valore predominante. Questo valore
predominante è la principale eredità che il Romanticismo riceve dallo
Sturm und Drang (vedi capitolo 1), il quale aveva contrapposto il sentimento
alla ragione, ritenuta incapace, nei limiti che ad essa aveva prescritto
Kant, di attingere la sostanza delle cose e le realtà superiori e divine.
Sebbene il sentimento di cui parlano i romantici sia qualcosa di più
profondo ed «intellettuale» del sentimento comunemente inteso e risulti
nutrito e potenziato di «riflessione» e di filosofia (tant'è vero che il
geistiges Gefühl di cui parla Schlegel si può tradurre con «sentimento
spirituale»), esso appare come un'ebbrezza indefinita di emozioni, in cui
palpita la vita stessa al di là delle strettoie della ragione, che nei
suoi confronti scade a pallido riflesso:
«Il pensiero è soltanto un sogno del sentimento» (Novalis).
Per queste sue caratteristiche, il sentimento viene ritenuto in grado di
aprire a nuove dimensioni della psiche e di risalire alle sorgenti
primordiali dell'essere. Anzi, il sentimento appare talora come l'infinito
stesso, o meglio come l'infinito nella forma dell'indefinito. In ogni caso
esso si configura come il valore supremo. Tant'è che Goethe, partecipe,
sotto questo aspetto, dell'atmosfera romantica, nel suo Faust (parte prima,
versi 3453-3457) scrive:
« Quando in cotesto sentire ti senti veramente felice,
chiamalo pure allora come vuoi:
chiamalo felicità, cuore, amore, Dio.
Per questo io non ho nome alcuno.
Sentimento è tutto!
La parola è soltanto suono e fumo... ».
E Hölderlin, racchiudendo nel giro di una frase felice la vena
antirazionalistica che serpeggia nel nascente movimento romantico,
nell'Iperione (1,1) esclama:
«Un Dio è l'uomo quando sogna, un mendicante quando pensa».
L'arte come «sapienza del mondo».
L'esaltazione del sentimento procede parallelamente al culto dell'arte,
vista come come «sapienza del mondo» e «porta aurorale» della conoscenza,
ossia come ciò che precede ed anticipa il discorso logico e nello stesso
tempo lo completa, giungendo là dove questo non può arrivare e
configurandosi come ciò da cui nasce e a cui finisce sempre per
ritornare la filosofia (secondo una concezione che ai giorni nostri è
stata ripresa da Heidegger, che infatti è venuto attribuendo sempre più
importanza ai poeti, soprattutto romantici). Al poeta si conferiscono
delle doti quasi sovraumane e profetiche, che fanno di lui un
«esploratore dell'invisibile», con poteri di intuizione superiori a
quelli degli uomini comuni e della ragione logica. Tipiche, in questo
senso, alcune affermazioni dei Frammenti di Novalis o di Schlegel:
«Soltanto un artista può indovinare il senso della vita» (Novalis).
«Il poeta comprende la natura meglio che lo scienziato» (Novalis).
«Il filosofo poeta, il poeta filosofo, è un profeta» (Schlegel).
«Il senso per la poesia ha molto in comune col senso per il
misticismo... Rappresenta l'irrappresentabile, vede l'invisibile, sente il
non sensibile» (Novalis).
Come vedremo, questo concetto dell'arte come meta-filosofica intuizione
capace di attingere le profondità originarie della vita e di possedere
l'Infinito, trova la sua più nota concettualizzazione in Schelling, che
in essa individua l'organo tramite cui avviene la rivelazione
dell'Assoluto a se medesimo (vedi capitolo 5). In molti autori il
privilegiamento dell'arte comporta anche una preminenza del modello
estetico, poiché essa, che rappresenta il fulcro di tutte le esperienze
romantiche, finisce per configurarsi come il modello ermeneutico per
eccellenza, ossia come la principale chiave di lettura della realtà, che
infatti viene interpretata alla luce delle note qualificanti
dell'attività artistica: creatività, libertà, organicità,
consapevolezza-inconsapevolezza eccetera. Per cui, quando Schelling
arriva a dire che l'universo è nient'altro che un'immensa opera d'arte
generata da quel «poeta cosmico» che è l'Assoluto (di cui il poeta umano
è il riflesso), non fa che portare alla sua massima espressione metafisica
un pensiero che circola sin dall'inizio fra i romantici, i quali scoprono
nell'arte gli attributi stessi di Dio: l'infinità e la creatività.
L'estetica romantica.
Ripudiato il principio di «imitazione» e le regole classicistiche,
l'estetica romantica si configura infatti, nel modo più esplicito ed
impegnato, come un'estetica della creazione, poiché se all'uomo morale si
riconosce ancora la necessità di un limite, di un ostacolo, al poeta è
attribuita una libertà sconfinata e all'arte una spontaneità assoluta,
che ne fa un'attività in perenne «divenire», ossia dotata di inesauribile
dinamicità creativa.
«La poesia romantica è ancora in divenire... essa sola è infinita, come
essa sola è libera, e riconosce come sua legge prima questa: che
l'arbitrio del poeta non soffre legge alcuna» (F. Schlegel).
La celebrazione della musica.
Questo primato dell'arte creativa implica anche un primato del linguaggio
poetico e musicale, visto come « parola magica » in cui si concretizza
l'essenza stessa dell'arte. Per quanto concerne la musica, fra i primi a
celebrarne i «miracoli» troviamo Wackenroder:
«La musica mi appare come l'araba fenice, che, leggera e ardita, s'innalza
a volo... e con lo slancio delle ali rallegra gli dèi e gli uomini...
ora larte dei suoni è per me proprio come il simbolo della nostra vita:
una commovente breve gioia, che s'alza e s'inabissa, non si sa perché;
un'isola piccola, lieta, verde, con splendore di sole, con canti e suoni...».
E nei romantici successivi la musica diviene la «regina delle arti»,
anzi l'arte romantica per eccellenza, poiché sprofondando l'ascoltatore in
un flusso indeterminato di emozioni e di immagini gli fa vivere
l'esperienza stessa dell'infinito.
«La musica è la più romantica di tutte le arti, il suo tema è l'infinito,
essa è il misterioso sanscrito della natura espresso in suoni, che
riempie di infinito desiderio il petto dell'uomo, il quale solo in essa
intende il sublime canto degli alberi, dei fiori, degli animali, delle
pietre, delle acque! » (E.T.A. Hoffmann).
«La musica è la più romantica di tutte le arti, si potrebbe quasi dire
che essa sola è romantica, poiché solo l'infinito è il suo tema» (E.T.A.
Hoffmann).
«La musica di Beethoven... risveglia quel desiderio infinito che è
l'essenza del romanticismo» (E.T.A. Hoffmann).
Idee analoghe troviamo anche in Schopenhauer, il quale, come vedremo
(vedi capitolo 8), individua nella musica l'autorivelazione della volontà
di vivere: oppure in Leopardi, secondo cui, grazie alla musica:
«Per mar delizioso, arcano
erra lo spirito umano».
(G. Leopardi, Sopra il ritratto di una bella donna (versi 43-44), Canti.
Strumento privilegiato di conoscenza, organo dell'infinito, modello di
ogni realtà ed esperienza, libera creatività, parola magica, per questo
filone del Romanticismo (sostanzialmente rappresentato dal circolo di
Jena e da Schelling) l'arte è anche un modo per ergersi sopra la
caoticità e dolorosità del mondo. Ciò risulta evidente da un passo poco
noto, ma estremamente significativo, di Wackenroder:
«Oh, questo interminabile monotono giro di migliaia di giorni e di
notti... tutta la vita dell'uomo, tutta la vita dell'intero universo, non è
altro che un interminabile giuoco di scacchi sui due campi: bianco e
nero; giuoco nel quale nessuno vince se non l'infausta morte... tutto
questo potrebbe in certe ore far perdere la testa! E invece ci si deve
sostenere con braccia coraggiose in mezzo al caos delle rovine, nel
quale la nostra vita è sminuzzata, e attaccarci fortemente all'arte, alla
grande, alla duratura arte, che, al di sopra di ogni caos, attinge
l'eternità - l'arte che dal cielo ci porge una mano luminosa, così che noi
stiamo sospesi in ardita posizione, sopra un abisso deserto, fra cielo e
terra» (Fantasie sull'arte).
L'assolutismo dell'arte.
Tuttavia, questa assolutizzazione conoscitiva ed esistenziale dell'arte,
questo tentativo di evadere, in virtù di essa, dai limiti del finito e
della sofferenza, doveva rivelare inevitabilmente i suoi limiti. Da ciò
una certa crisi, all'interno del Romanticismo tedesco, di quell'estetismo
entusiasticamente affermato nell'Iperione di Hölderlin:
«O voi che cercate il sommo bene nella profondità della scienza, nel
tumulto dell'azione, nell'oscurità del passato, nel labirinto del futuro,
nelle fosse e sopra le stelle, sapete voi il suo nome? Il suo nome è
bellezza!».
Estetismo che in Novalis si conclude con l'infinitizzazione dell'arte,
definita «l'assoluto reale».
4.2. La celebrazione della fede religiosa e della «ragione dialettica».
La «religiosità» romantica.
Accanto all'arte e strettamente intrecciata con essa («artista può essere
solo chi ha una sua religione, un'intuizione originale dell'infinito»,
afferma Schlegel) un'altra esperienza decisiva dei romantici è stata la
religione, vista anch'essa come via d'accesso privilegiata al reale e come
un sapere immediato, che, andando oltre i confini della ragione
illuministico-kantiana, riesce a cogliere il Tutto nelle parti, l'Assoluto
nel relativo, il Necessario nel contingente, l'Unità nella molteplicità,
l'Eterno nel tempo eccetera (vedi Schleiermacher). Tuttavia, mentre alcuni
romantici, in virtù della loro interpretazione panteistica dell'infinito
(vedi paragrafo 5), si sono mantenuti nell'ambito di una religiosità
meta-confessionale, altri si sono avvicinati alle religioni positive.
Il recupero delle fedi positive.
Infatti la polemica contro l'«astratta» ed «impersonale» divinità
dell'Illuminismo, il rifiuto di identificare l'uomo con Dio, ossia con lo
Spirito idealisticamente inteso, la crisi dell'estetismo, ha condotto
taluni romantici non solo ad accentuare il momento religioso delle loro
teorie, ma a riavvicinarsi alle fedi storiche, dando luogo ad una serie
di «conversioni» alle religioni tradizionali. Tipico, in questo senso,
il caso di F. Schlegel, che aderisce al cattolicesimo, preferendolo al
protestantesimo, anche in virtù del suo apparato esteriore (sfarzo
cerimoniale, liturgia eccetera) e del suo bagaglio storico-tradizionalistico.
La teoria del primato conoscitivo dell'arte o della fede, pur essendo la
più caratteristica del movimento romantico, non è l'unica, poiché nel
Romanticismo, inteso come epoca culturale, troviamo anche la posizione
di quei filosofi che, pur condividendo le critiche all'intelletto
illuministico, ritengono che solo un rinnovato esercizio della ragione
abbia la possibilità di fornirci quelle spiegazioni dell'essere e
dell'Assoluto invano cercate attraverso l'intuizione estetica ed il
rapimento mistico.
La ragione «dialettica».
Tale è il caso di Hegel, che giunge a prendere una drastica posizione
polemica contro le varie filosofie del sentimento e della fede
(vedi capitolo 3) affermando che solo mediante la logica e la
ragione, e non attraverso le nebulosità del pensiero poetico o mistico,
risulta possibile fare un discorso fondato sull'infinito.
Infatti, utilizzando la distinzione kantiana fra intelletto e ragione,
Hegel tende ad addossare al primo tutti i difetti che i romantici
avevano attribuito alla scienza «analitica» ed empiristica
dell'Illuminismo, e ad assegnare alla seconda, intesa alla maniera
«dialettica» (vedi capitolo 6), tutte le prerogative che i poeti avevano
ascritto all'arte o alla fede, ossia:
a) la virtù di andare oltre la superficie del reale e di coglierne le
strutture profonde;
b) l'idoneità a captare l'infinito e l'Assoluto;
c) l'attitudine a pensare in modo sintetico ed organico, ossia a spiegare
le parti in relazione al Tutto;
d) la predisposizione ad afferrare la dimensione processuale, cioè storica,
della realtà.
5. Il senso dell'Infinito.
Il teme romantico dell'infinito.
Contrariamente a Kant, che aveva costruito una filosofia del finito e
aveva fatto valere in ogni campo il principio del limite, i romantici
cercano ovunque, dall'arte all'amore, l'oltre-limite, ovvero ciò che rifugge
dai contorni definiti e si sottrae alle leggi dell'ordine e
della misura. Per cui l'anti-classicismo dei romantici, prima di essere
un fatto letterario ed un criterio estetico, è una tendenza
generale della loro sensibilità e del loro spirito.
Infatti «l'ebbrezza dell'infinito» colora di sé tutte le esperienze dei
romantici, che sono, in genere, anime assetate di Assoluto, bramose di
trascendere le barriere del finito, e di andare oltre lo spazio, il
tempo, il dolore, la caducità, la morte eccetera. Tutto questo fa sì che i
romantici tendano, da un lato, ad infinitizzare determinate esperienze
umane: ad esempio la poesia (vedi paragrafo 4) o l'amore (vedi paragrafo 8),
e, dall'altro, siano portati ad avvertire fortemente la presenza
dell'Infinito nel finito.
I vari modi di intendere l'infinito.
In ogni caso, l'Infinito si qualifica come il protagonista principale
dell'universo culturale romantico. Tutti d'accordo nell'assegnare
all'Infinito questo ruolo primario, i romantici si differenziano invece
per il diverso modo di intendere l'Infinito stesso e di concepirne i
rapporti con il finito (l'uomo, la natura, la Storia eccetera). Il modello
più caratteristico e maggiormente seguito dai poeti e dai filosofi
tedeschi è quello panteistico (che si trova ad esempio nel primo Fichte
come nei Frammenti del primo Schlegel, in Schleiermacher come nel primo
Schelling, in Hölderlin come in Hegel eccetera). Infatti il sentimento
della Einfühlung (immedesimazione) fra Infinito e finito è così forte da far
sì che i romantici, almeno all'inizio, tendano a concepire il finito come
la realizzazione vivente dell'Infinito, sia esso inteso, quest'ultimo,
alla maniera di un panteismo naturalistico di stampo spinoziano-goethiano,
che identifica l'Infinito con il ciclo eterno della Natura, oppure di un
panteismo idealistico che identifica l'Infinito con lo Spirito, ossia
con l'Umanità stessa e fa della natura un momento della sua
realizzazione (vedi capitolo 3).
Modello panteistico e modello trascendentistico.
Sebbene prevalente, il modello panteistico non è, tuttavia, l'unico,
poiché accanto ad esso, nei romantici, troviamo anche un'altra concezione
dei rapporti fra finito ed Infinito: una concezione per la quale
l'Infinito viene in qualche modo a distinguersi dal finito, pur
manifestandosi o rivelandosi in esso. In questo caso il finito (l'uomo e
il mondo) non appare più la realtà stessa dell'Infinito ma come la sua
manifestazione più o meno adeguata. Per cui, se il primo modello,
sostenendo l'identità tra finito e Infinito, è una forma di immanentismo
e di panteismo, il secondo modello, affermando la distinzione tra finito
ed Infinito, è una forma di trascendentismo e di teismo, che ammette la
trascendenza dell'Infinito rispetto al finito e considera l'Infinito
stesso come un Dio che è al di là delle sue manifestazioni mondane.
Ovviamente, mentre il panteismo si accompagna ad una religiosità
cosmica, diversa dalle fedi positive, il trascendentismo suole
accompagnarsi, per lo più, all'accettazione di qualche religione storica,
come succede nel secondo Schlegel, in cui teismo e cristianesimo vanno
di pari passo e si concretizzano in una conversione alla Chiesa
cattolica. Come vedremo, nel Romanticismo tedesco i vari autori
esprimono la tendenza a passare dal modello panteistico a quello
trascendentistico.
6. La vita come inquietudine e desiderio.
6.1. La «Sehnsucht», «l'ironia» e il «titanismo».
Un altro dei motivi ricorrenti della cultura romantica, presente nei
poeti e nei filosofi, è la concezione della vita come inquietudine,
aspirazione, brama, sforzo incessante. I romantici ritengono infatti che
l'uomo sia in preda ad un «demone dell'infinito», il quale fa sì che
egli - insofferente di ogni limite e mai pago della realtà così com'è risulti in uno stato di irrequietezza e di tensione perenne, che lo porta a
voler sempre trascendere gli orizzonti del finito.
Due fra le più note esemplificazioni di questo modo dessere sono lo
«spirito faustiano», delineato da Goethe, oppure lo «Streben» (sforzo)
teorizzato da Fichte, che vede l'io impegnato in un infinito superamento
del finito, coincidente con una battaglia mai conclusa per la conquista
della propria umanità.
Di conseguenza, si può dire che l'intuizione romantica dell'uomo sia in
funzione di quell'anelito all'infinito che è proprio di tale corrente
culturale. Infatti è solo in relazione alla «brama di infinito» che si
comprendono alcuni dei più emblematici «stati d'animo» romantici, che
formano l'oggetto preferito delle rappresentazioni letterarie.
La Sehnsucht.
L'espressione germanica Sehnsucht, che può essere tradotta in italiano
con «desiderio», «aspirazione struggente», «brama appassionata» eccetera,
costituisce forse, a detta del germanista Ladislao Mittner, «la più
caratteristica parola del Romanticismo tedesco», poiché sintetizza
l'interpretazione dell'uomo come desiderio e mancanza, ossia come
desiderio frustrato verso qualcosa (l'infinito, la felicità...) che sempre
sfugge. Infatti la romantica Sehnsucht si identifica con quell'aspirazione
verso il più e l'oltre, che non trovando confini e mète precise si risolve
inevitabilmente, come scrive un altro germanista, Sergio Lupi, in un
«desiderio di avere l'impossibile, di conoscere il non conoscibile, di
sentire il soprasensibile» (Sergio Lupi, Il romanticismo tedesco, Sansoni,
Firenze, 1933 pagina 52). Tant'è vero che la Sehnsucht, la quale
etimologicamente deriva dal verbo sehnen, che vuol dire desiderare, e dal
sostantivo Sucht, che significa esso pure desiderio, finisce per
configurarsi come « un desiderio innalzato alla seconda potenza, un
desiderio del desiderio e quindi un desiderare che si esaurisce in sé
per il piacere del desiderio» (L. Mittner, Ambivalenze romantiche, D'Anna,
Messina-Firenze, 1954, pagina 275 nota).
Infatti Schlegel, nella Lucinde, dice del suo personaggio Giulio: «Tutto
poteva eccitarlo, niente poteva bastargli... Era come se volesse
abbracciare il mondo e non potesse afferrare niente») (Questo spiega perché
la Sehnsucht tenda spesso a capovolgersi nel sentimento della noia, ossia
del vuoto o della nullità delle cose e delle esperienze umane.) e nei
Frammenti osserva: «Chi vuole qualcosa d'infinito non sa ciò che
vuole ». Analogamente, Novalis nel suo Heinrich von Ofterdingen, dipinge
il proprio personaggio alla ricerca del «Fiore azzurro», simbolo, tra
l'altro, di quel misterioso ed irraggiungibile « non so che» il quale
attrae perpetuamente l'animo inquieto dell'uomo.
L'ironia.
La situazione esistenziale implicita nella Sehnsucht o nello
schlegeliano « Streben nach dem Unbedingten» (tensione verso l'Assoluto)
si accompagna a quelle due tonalità psichiche e a quei due
atteggiamenti che sono l'ironia e il titanismo. L'ironia consiste nella
«superiore» coscienza del fatto che ogni realtà finita, e quindi ogni
impresa umana, grande o piccola, risulta ìmpari di fronte all'infinito.
Come tale, l'ironia è una conseguenza diretta del principio romantico che
l'infinito può avere infinite manifestazioni, senza che nessuna gli sia
veramente essenziale. L'ironia prende atto di ciò, poiché consiste nel non
prendere «sul serio» e nel rifiutarsi di considerare, come cosa salda, le
manifestazioni particolari dell'infinito (la natura, le opere, l'io) in
quanto queste non sono altro che provvisorie espressioni di esso.
«La filosofia è la vera patria dell'ironia, che potrebbe venir definita
bellezza logica » (Schlegel).
« La filosofia scioglie ogni cosa, relativizza l'universo. Come il
sistema copernicano, essa scardina i punti fissi e rende sospeso nel
vuoto ciò che prima posava sul solido. Essa insegna la relatività di
tutti i motivi e di tutte le qualità... » (Novalis).
«è la più libera (l'ironia) di tutte le licenze perché attraverso essa ci
mettiamo al di sopra di noi medesimi; e nello stesso tempo la più
legittima...» (Schlegel).
«L'ironia è chiara coscienza dell'agilità eterna, del caos infinitamente
pieno» (Schlegel).
Il titanismo.
Se l'ironia palesa una sorta di filosofico humor, scaturente dalla
coscienza dei limiti del finito in quanto tale, il titanismo esprime
invece un atteggiamento di sfida e di ribellione, proprio
di chi si propone di combattere, pur sapendo che alla fine risulterà
perdente e incapace di superare le barriere del finito. Tant'è vero che
il titanismo, talora, mette capo al suicidio, visto come atto di sfida
estrema verso il destino (Atteggiamento opposto ma complementare del
titanismo è il vittimismo, ossia la tendenza a sentirsi schiacciati da
forze superiori (il Destino, la Società, la Natura eccetera).
Il titanismo è detto anche prometeismo perché i romantici lo
personificano nel mitico titano greco che avendo rotto l'ordine fatale
del mondo per donare agli uomini l'uso del fuoco, viene condannato da
Zeus ad avere perennemente il fegato divorato da un'aquila. Mettendo tra
parentesi i possibili significati umanistico-illuministici del mito, i
romantici tendono a vedere in Prometeo il simbolo della ribellione in
quanto tale (cfr. la lirica Prometheus di Goethe e il dramma Prometheus
unbound di Shelley).
6.2. L'«evasione» e la ricerca dell'«armonia perduta».
La tendenza all'evasione e l'amore per l'eccezionale.
L'anelito verso l'infinito, che è proprio dell'anima romantica, genera
anche un altro atteggiamento tipico del movimento: la tendenza
all'evasione e l'amore per l'eccezionale. Infatti i romantici,
mal sopportando il finito e disprezzando tutto ciò che è
abitudinario e mediocre, aspirano a evadere dal quotidiano e a vivere
esperienze fuori della norma, capaci di produrre emozioni intense e
travolgenti. Da ciò la predilezione romantica per tutto ciò
che è «meraviglioso», «atipico», «irregolare», «lontano», «misterioso»,
«magico», «fiabesco», «primitivo», «notturno», «lugubre», «spettrale»
eccetera - ossia per tutto ciò che essendo al di là del comune può offrire
sensazioni diverse e sconosciute.
Espressione di questo desiderio di fuga e di eccezionalità è l'evasione
in mondi remoti nel tempo e nello spazio, che si concretizza ad esempio
nel culto dell'Ellade, nella riscoperta del Medioevo e nell'esotismo. Da
Hölderlin, che dipinge «il paradiso sereno» della Grecia, a Novalis, che
vagheggia il Medioevo cristiano e tedesco, da Chateaubriand, che
descrive le verdi foreste dell'America, a Byron, che canta l'azzurro del
Mediterraneo, da Humboldt, che va alla scoperta del misterioso popolo
dei Baschi di Spagna, ai fratelli Schlegel, che studiano il sanscrito e
attirano l'attenzione sulla cultura dell'India e dell'Oriente, i romantici
sono andati costantemente alla ricerca di mondi «diversi», capaci di
eccitare la fantasia e di garantire una fuga dal presente e dall'abituale.
Il sogno.
Ma l'evasione più significativa i romantici l'hanno compiuta nei mondi
del sogno e dell'arte, ossia nello spazio senza limite dell'immaginazione
e della rêverie.
«Sicuri, come il fiore vive di luce, così vivono della
bella immagine, paghi, sognando e felici, e di null'altro
ricchi, i poeti» (Hölderlin).
E infatti molta parte dell'arte romantica si muove in un'atmosfera
rarefatta e quasi transmateriale, più simile al sogno che alla veglia:
«la realtà di Hölderlin - scrive ad esempio L. Mittner - è tutta poetica
perché tutta immersa in un bagno di luce, tutta vivificata dall'etere,
che rende translucide, nitide insieme ed immateriali, le cose concrete,
creando intorno ad esse un'atmosfera rarefatta che non sembra di questa
terra perché tutta vibrante di luce...» (L. Mittner, Ambivalenze
romantiche, citato, pagine 3-4, ove si parla di Hölderlin come
«cantore dell'etere»). Ovviamente, la dimensione del sogno può anche
assumere le tinte del macabro, come accade ad esempio nel cosiddetto
«Romanticismo nero», che popola le sue fantasie di cadaveri, scheletri
eccetera.
Nell'ambito della letteratura inglese, una delle manifestazioni più
emblematiche dell'evasione nello «strano» è il Kubla Khan di Coleridge
(1798). In questo componimento, che sembra essere stato scritto o ideato
sotto l'effetto dell'oppio, il poeta, trasfigurando i dati del reale in
una dimensione visionaria e allucinatoria, immagina un misterioso paese
dove uno sconosciuto personagio fa edificare un fantastico palazzo
(simbolo, forse, del mondo dell'arte) con giardini, abissi, caverne di
ghiaccio eccetera, su cui risuona il canto inebriante di una vergine nera.
Il viandante romantico.
Collegata al motivo dell'evasione è anche la figura romantica del
«viandante» (Wanderer), che in fondo è un'altra manifestazione della
«Sehnsucht». Differenziandosi dal «viaggiare» cosmopolitico e
pratico-interessato degli illuministi, curiosi dei costumi stranieri e
delle loro istituzioni politiche, l'«errare» romantico assume infatti la
fisionomia di un «vagare» inquieto e morboso verso un «non so che» di
irraggiungibile e di inevitabilmente illusorio.
Il tema dell'«armonia perduta».
Un altro tema caratteristico del Romanticismo tedesco, che costituisce
argomento di importanti rappresentazioni artistiche (come lo Heinrich
von Ofterdingen e i Discepoli di Sais di Novalis) è quello della
«immediatezza felice» e della «armonia perduta», che scaturisce dal
diffuso convincimento, di lontana ascendenza rousseauiana, secondo cui
la civiltà e l'intelletto avrebbero sradicato l'uomo da una situazione di
primitiva spontaneità e simbiosi con la natura - nella quale corpo e
spirito non erano in lotta e la ragione non si opponeva allistinto rendendo l'individuo schiavo della società e delle sue convenzioni
alienanti. In altre parole, secondo questa teoria, l'uomo (in un'età non
ben precisata, posta talora alle origini della storia oppure in una
determinata epoca, come ad esempio quella della Grecia classica)
si sarebbe allontanato da una situazione originaria di contatto con la
natura, separandosi così dal fondamento ontologico del suo essere e
rendendosi infelice ed «inautentico», e quindi desideroso di ricomporre
la scissione uomo-mondo e di ricongiungersi con la madre-Natura, della
quale Schiller, ad esempio, parla come un malato parlerebbe della salute:
«Nella natura irrazionale allora vediamo soltanto una sorella più
fortunata che restò indietro nella casa materna, da cui noi, spinti
dall'arroganza della nostra libertà, ci slanciammo fuori, verso paesi
stranieri. Con doloroso rimpianto bramiamo di ritornare indietro, non
appena abbiamo cominciato a provare le angustie della cultura e udiamo,
nella lontananza della terra straniera dell'arte, la voce toccante della
madre. Fintanto che eravamo semplici figli della natura, eravamo felici
e perfetti; diventati liberi, abbiamo perduto l'uno e l'altro stato... »
(Poesia ingenua e poesia sentimentale, 1706).
Concretizzazione estetica di questa dottrina è la nota antitesi
schilleriana fra naive Dichtung (la poesia ingenua) e sentimentalistische
Dichtung (la poesia sentimentale dei moderni), ove la prima è propria
degli artisti antichi, che erano natura, mentre la seconda è tipica degli
artisti moderni, per i quali la natura è solo oggetto di ricordo, di
riflessione e di aspirazione sentimentale:
«Il poeta o è natura o la cercherà» (ivi).
Dall'armonia perduta all'armonia ritrovata.
Questa teoria, variamente presupposta da altri autori, implica dunque
che la storia del mondo proceda da un'armonia perduta ad un'armonia
ritrovata, secondo uno schema triadico comprendente: 1) un'armonia
iniziale; 2) una scissione intermedia; 3) la ricostruzione di un'armonia
futura basata sul ricupero del passato. Come si può notare, questa
posizione, che anticipa in parte gli schemi della dialettica hegeliana
(vedi capitolo 6), comporta una concezione della storia come regresso e
come progresso al tempo stesso, anche se l'accento batte piuttosto sulla
dimensione del futuro che del passato. Ciò avviene esplicitamente in
Schiller, il quale mostra di ritenere che l'uomo, attraverso la cultura,
che gli ha permesso di dispiegare le sue potenzialità, sia superiore
rispetto allo stato di partenza.
Nei romantici troviamo invece una decisa mitizzazione del «passato felice»,
che Hölderlin, come si è visto, pone nella Grecia, descritta come
«terra visitata dagli dèi». Questo non esclude che lo sguardo romantico
finisca anch'esso per essere rivolto più verso ciò che sarà che
verso ciò che è stato, come risulta evidente dalle suggestive metafore
di Hölderlin sulla «notte» e sul «mattino», nonché sul poeta come
«messaggero degli dèi».
La nostra epoca come «tempo di povertà».
La nostra epoca, che egli chiama «dürftige Zeit», ossia « tempo di
povertà » (Brot und Wein, 7), corrisponde al momento culminante della
scissione, poiché gli dèi sono scomparsi e il giorno è tramontato
(allusione alla perdita di un autentico rapporto con la Natura, Dio,
l'Essere, il Principio eccetera). Ma il poeta, diversamente dagli altri
uomini, ormai avvolti nell'oblio dell'autentico e dell'originario,
continua a vegliare, aspettando, «nella mezzanotte del mondo», le prime
luci dell'alba, preludio di un nuovo splendente meriggio, in cui si avrà
il ricupero dell'originario e il ritorno del divino.
Questa «filosofia della notte e del mattino» (come la si potrebbe
definire), nel nostro secolo è tornata ad ispirare le complesse
meditazioni di Martin Heidegger, che ha visto in Hölderlin un «poeta
dell'Essere» e nel tempo della povertà estrema, di cui egli parla, il
tempo del nichilismo moderno, ossia «il tempo in cui l'uomo, rotto il
rapporto autentico coll'essere, si abbandona al proprio volere
soggettivo, alla strumentalizzazione tecnica della natura, si fa
mercante da angelo che è chiamato ad essere, si crede padrone dell'ente
anziché il pastore dell'essere, filosofa anziché pensare, considera il
linguaggio come strumento di baratto e di dominio, dimentica gli Dèi che
fuggono dal mondo. è la notte del mondo, notte che raggiunge la sua
estrema povertà a mezzanotte quando l'uomo, obliatosi, oblia l'oblio»
(P. Chiodi, L'ultimo Heidegger, Taylor, Torino 1969, pagina 132).
7. Infinità e creatività dell'uomo nei filosofi e nei poeti.
Individualismo e anti-individualismo.
I tratti che abbiamo delineato nel paragrafo precedente sono tipici,
anche se non esclusivi, del Romanticismo letterario. Dalla filosofia, e
precisamente dall'idealismo post-kantiano, scaturisce invece quella
nozione dell'uomo come «Spirito», che rappresenta una delle «figure»
centrali dell'intero Romanticismo tedesco.
L'uomo come spirito.
Rimandando a più tardi la delucidazione tecnica ed analitica di tale
concetto (per il quale vedi capitolo 3, paragrafo 2.2),al momento basti
dire che con il termine «Spirito» gli idealisti intendono sostanzialmente
l'uomo, inteso: 1) come attività infinita ed inesauribile, che si
autocostituisce od autocrea liberamente, superando di continuo i propri
ostacoli, e 2) come soggetto in funzione di cui esiste e trova un senso
l'oggetto, e quindi la natura.
Questa teoria dell'uomo come attività incessante e ragion d'essere di ogni
cosa, che mette capo all'equazione Io = Dio, si trova per la prima volta
nella Dottrina della scienza (1794) di Fichte, che rappresenta lo
scopritore del concetto romantico dell'infinito e dello Spirito. Tant'è
vero che Schlegel lo proclama esplicitamente l'iniziatore del
Romanticismo tedesco. Tuttavia, l'infinito fichtiano è ancora un'attività
che presuppone un limite e che si esercita soltanto attraverso un
infinito superamento del finito (vedi capitolo 4). Infatti l'io di Fichte è
fondamentalmente compito morale, e la moralità (secondo il concetto
kantiano) implica uno sforzo e perciò la presenza del limite.
Dall'idealismo etico di Fichte all'idealismo «magico» dei poeti.
Invece la scuola romantica (Schlegel, Novalis, Tieck eccetera), trasferendo
il principio dell'attività infinita dal piano etico a quello estetico, fa
sparire il limite, poiché inteso come principio della creazione estetica
l'infinito non esige, anzi esclude e rende impossibile ogni limite o
resistenza alle manifestazioni della sua attività. Per cui, mentre lo
spirito infinito, in Fichte, è costretto ad obbedire ad una intrinseca
necessità razionale, che prevede l'ostacolo, lo spirito infinito, nei
poeti appare libero dalle sue determinazioni limitatrici, e viene posto
non più nella forma della ragione, ma in quella del sentimento. In altre
parole, se Fichte esalta la potenza infinita dell'azione, che tuttavia
implica strutturalmente il limite e l'ostacolo, gli artisti esaltano la
potenza assoluta del sentimento e del sogno. L'affermazione di Novalis,
secondo cui
«Tutto è fiaba»
esprime in modo emblematico il passaggio dall'idealismo etico di Fichte a
quell'idealismo « magico» - fondato sulla sovranità dell'io sul mondo - di
cui è teorico Novalis:
« Lo svolgimento che Fichte dà della sua idea è certamente la prova
migliore dell'idealismo. Ciò che voglio posso» (Novalis).
«La vita non dev'essere un romanzo impostoci, bensì un romanzo fatto da
noi» (Novalis).
«Tutto ciò che io credo di osservare fuori di me, può solamente esistere
in me stesso. Tutto ciò che mi viene incontro è soltanto un fantasma
della mia fantasia... Tutto si sottomette alla mia volontà, io posso
chiamare ogni apparenza, ogni fatto come mi piace; il mondo vivente e il
morto pendono ad una catena che è retta dal mio spirito, tutta la mia
vita è un sogno le cui varie forme si modellano secondo il mio volere.
Io sono la sola legge nell'intera natura, e tutto a questa legge dà
ascolto».(Tieck)
«Gli esseri esistono perché noi li pensammo, il mondo giace in fosca
lontananza» (Tieck).
«(Dottrina dell'avvenire della vita). La nostra vita non è un sogno, ma
deve diventarlo e forse lo diventerà» (Novalis).
Del resto, il contrasto tra filosofia e letteratura romantica, in
Germania, è solo apparente, poiché si verifica all'interno di un comune
principio, che è quello dell'infinita potenza dello spirito, che da un
lato si manifesta come sorgente necessaria di produzioni reali (l'io che
pone il non-io in Fichte o la dialettica triadica in Hegel)
e dall'altro lato si estrinseca come libertà altrettanto assoluta di
produzioni fantastiche (il «tutto è fiaba» di Novalis).
Romanticismo filosofico e Romanticismo letterario.
Di conseguenza, il Romanticismo letterario non è la negazione né la
degradazione del Romanticismo filosofico, ma soltanto un altro modo
attraverso cui viene fatto valere il principio romantico dell'infinità
dello spirito, che in questo caso viene assunto a giustificazione assoluta
del mondo dell'arte.
La diversa concezione del dinamismo creativo dello spirito si riflette
anche nel parallelo individualismo e anti-individualismo dell'età
romantica. Che il Romanticismo abbia contribuito ad un ulteriore
riconoscimento del valore della personalità individuale e del suo
groviglio di problemi (amore, dolore, morte eccetera) è un fatto su cui
esiste unanime accordo. Mai, come nel Romanticismo, si è parlato tanto
di «io», di «persona», di «soggetto» eccetera. Mai come in esso si sono
onorati i «geni» e gli «eroi», ossia le individualità eccezionali. Come
scrive Novalis nei Frammenti
«La personalità è l'elemento romantico dell'io».
Individualismo ed anti-individualismo romantico.
Ciò ha condotto taluni studiosi a schematizzare il Romanticismo come una
forma di individualismo per eccellenza. In realtà il discorso è più
complesso, poiché il Romanticismo germanico (come quello europeo)
presenta tendenze individualistiche ed anti-individualistiche nello stesso
tempo, che talora coesistono nello sviluppo mentale di uno stesso autore.
In parecchi artisti, almeno in una fase del loro pensiero e della loro
opera, prevalgono atteggiamenti spiccatamente individualistici, connessi
al riconosciuto primato del sentimento ed al principio secondo il quale
se la ragione eguaglia ed uniforma, il sentimento specifica e distingue,
poiché se tutti possono «pensare» le medesime realtà, nessuno le «sente»
alla stessa maniera. Anzi, questo individualismo (che rappresenta una
delle eredità più decisive dello Sturm und Drang) in taluni autori si
esaspera talora in forme di soggettivismo radicale e di chiusura voluta
nel cerchio dell'io:
«Quanto più solo - tanto più potente».
«Si è soli con tutto ciò che si ama» (Novalis).
Dall'altro lato, in antitesi a questo atteggiamento, che trova riscontro
in consimili modelli del Romanticismo letterario europeo (e che sarà
ereditato da parte del Decadentismo) troviamo pure, soprattutto nei
filosofi, ma anche nei letterati, delle tendenze esplicitamente
comunitarie. Fichte, per esempio, proclama esplicitamente la missione
sociale del dotto e difende il principio che «l'uomo non è uomo se non in
mezzo ad altri uomini», ed Hegel scorge nella vita sociale e nello Stato
l'estrinsecazione massima dello Spirito, polemizzando aspramente contro
«l'individualismo astratto» dei poeti romantici, estranei al «corso
oggettivo del mondo». Nello stesso Novalis, accanto ad una prospettiva
individualistica troviamo una prospettiva organicistico-comunitaria,
incentrata sulla tesi per cui la società risulta «un'unica persona
indivisibile che pensa e che sente». E lo stesso concetto romantico di
nazione (vedi paragrafo 10) è già di per sé un forte motivo
anti-individualistico .
«Ambivalenze» romantiche.
Tutto ciò significa che il Romanticismo tedesco, e questa è una delle
tante «ambivalenze», ospita in sé l'individualismo più spinto come lo
statalismo più accentuato, oscillando fra il culto dell'io e l'esaltazione
di entità sovra-individuali misticamente concepite: il Popolo, la
Nazione, lo Spirito del Mondo eccetera (vedi paragrafo 10). Per cui si
può dire che il Romanticismo tenda a passare da un'assolutizzazione dell'io
all'assolutizzazione della Società e dello Stato, esattamente come tende
ad oscillare fra un'assolutizzazione dell'evasione (« un dio è l'uomo
quando sogna »), ad un'assolutizzazione della dimensione comunitaria e
dell'impegno sociale. Questo processo lo ritroviamo anche in letteratura,
in cui, accanto ad un filone sentimentalistico, soggettivistico e
fantastico (tipico della produzione nordica) abbiamo un filone realistico,
storico, nazionale e popolare (dominante soprattutto in Italia: si veda
il caso Manzoni).
8. L'amore come anelito di fusione totale e cifra dell'Infinito.
L'esaltazione romantica dell'amore.
L'amore costituisce un altro dei temi prediletti del Romanticismo
tedesco, su cui si sono soffermati poeti e filosofi: da F. Schlegel a
Fichte, da Hölderlin a Schleiermacher, da Novalis ad Hegel eccetera.
L'esaltazione romantica dell'amore discende soprattutto dal privilegiamento
del sentimento e dalla ricerca di un'evasione dal grigiore del quotidiano.
Infatti l'amore appare ai romantici come il sentimento più forte e come
l'estasi suprema, ovvero come la vita della vita stessa.
« Vita e amore significano la stessa cosa... C'è tutto nell'amore:
amicizia, cordialità, sensualità e anche passione... e l'un elemento
lenisce e rinforza, anima ed accresce l'altro, viviamo ed amiamo fino
all'annientamento. Soltanto l'amore ci rende uomini veri e perfetti, esso
solo è la vita della vita... » (Schlegel).
«La vera vita è amore: come amore ha e possiede la cosa che ama,
l'abbraccia, la penetra, è unita e fusa in essa» (Fichte).
«Per noi, o Amore, tu sei l'alfa e l'omega» (Schleiermacher).
«Dobbiamo immaginarci l'età dell'oro come quella in cui amore e genio
erano universalmente diffusi» (Schlegel).
«L'amore è lo scopo finale della storia del mondo, l'amen dell'universo»
(Novalis, Frammenti).
L'amore come fatto globale.
La prima caratteristica dell'amore romanticamente inteso è la globalità,
ovvero la ricerca di una sintesi fra anima e corpo, spirito e istinto,
sentimento e sensualità: «Tutto è anima nell'amore, quando l'amore è tale
che anima e corpo vi hanno eguale e reciproca partecipazione. Il
desiderio verso l'unità è appagato: l'atto di amore, pur rimanendo
integro, pur non arrestandosi di fronte a nessuna audacia del godimento,
non turba le pure regioni dello spirito, ma sale ad esse e non è dallo
spirito disgiunto. Non sta a sé, ma è un simbolo di quanto avviene
nell'interiore degli individui; l'amplesso dei corpi esprime quello delle
anime» (G.V. Amoretti, introduzione a F. Schleiermacher, L'amore romantico,
Laterza, Bari 1928pagina 11 (traduzione italiana delle Lettere intime
sulla «Lucinde» di Schlegel).
Infatti nella Lucinde, in cui l'amore romantico trova una delle
manifestazioni più radicali, ma più espressive, F. Schlegel afferma
l'unità inscindibile dei due elementi dell'amore uomo-donna,
contrapponendo all'idea neoplatonico-cristiana della sessualità come
«vergogna» l'idea greca della sessualità come innocenza e gioco naturale.
Un nuovo ideale di donna.
Nello stesso tempo Schlegel vagheggia l'idea di una donna che,
abbandonati falsi pudori ed emancipata dal paradigma matrimoniale
tradizionale (che il poeta J.J. W. Heinse sosteneva dover essere
lasciato solo ad un'umanità inferiore), sappia personificare, come la
greca Diotima, esaltata nel Convito platonico, il modello di una donna
nuova e superiore, capace di amare con la pienezza del proprio essere,
senza altri freni alla passione all'infuori della sua «fedeltà
interiore». Tant'è che Giulio, rivolgendosi a Lucinde, le dice:
«Attraverso tutti gli scalini dell'umanità tu vai con me dalla sensualità
più sfrenata alla più spirituale spiritualità, e solo in te io vidi vera
superbia e vera femminile umiltà». Ovviamente a questo tipo di donna
viene riconosciuta parità di diritti con l'uomo, nella vita come nella
cultura. E in questo senso, il Romanticismo - che fu rappresentato anche da
donne come Carolina Schlegel, Bettina Brentano, Dorotea Veit, Carolina
di Günderode eccetera e, a livello europeo, da Madame de Staël - si
configura come una tappa ulteriore della rivendicazione moderna della
dignità femminile.
Tuttavia, come nel campo politico (vedi paragrafo 10) si assiste, nel
Romanticismo tedesco, al passaggio da una fase
individualistico-liberaleggiante ad una statalistico-conservatrice, così,
per ciò che riguarda l'amore e la donna, si assiste al passaggio da una
fase estetizzante ad una moraleggiante. Infatti mentre nella Lucinde e
negli altri scritti romantici, l'amore, non senza un evidente influsso di
Rousseau, viene esaltato come strumento di emancipazione femminile e
libera scelta, al di sopra e al di là di tutte le convenzioni sociali,
in un secondo tempo viene ricondotto ad elemento di conservazione delle
strutture della tradizione. Ad esempio Hegel, rispecchiando posizioni
che si trovano anche nell'ultimo Schlegel, afferma, nelle Lezioni sulla
filosofia del diritto del 1821, che «il destino della fanciulla sta,
essenzialmente, soltanto nel matrimonio», e che l'amore è un momento
«soggettivo», che esige di essere inquadrato e disciplinato nelle
istituzioni giuridiche ed «oggettive» della società.
(cfr. R. di Chio, Uomo, amore, felicità, Bulgarini, Firenze 1981, volume 3)
La ricerca dell'unità degli amanti.
La seconda caratteristica dell'amore romantico risiede nella ricerca
dell'unità assoluta degli amanti, ossia della completa fusione delle
anime e dei corpi, in modo tale che «ciò che è due possa diventare uno».
Presente nei poeti e negli artisti in generale, quest'aspetto
dell'idealizzazione romantica dell'amore è stato espresso da Hegel con le
formule più rigorose e significative. Negli scritti giovanili, ad esempio,
il «vero» amore viene identificato con la «vera unificazione», che supera
ogni molteplicità ed antitesi, armonizzando il diverso e l'opposto. E nelle
opere della maturità, ad esempio nelle Lezioni di Estetica, Hegel scrive:
«Lamore è identificazione del soggetto con un'altra persona», è « il
sentimento per cui due esseri non esistono che in un'unità perfetta e
pongono in questa identità tutta la loro anima e il mondo intero»;
«Questa rinuncia a se stesso per identificarsi con un altro,
quest'abbandono nel quale il soggetto ritrova tuttavia la pienezza del
suo essere, costituisce il carattere infinito dell'amore».
L'amore come cifra dell'Assoluto.
La terza caratteristica dell'amore romantico è la sua tendenza a
caricarsi di significati simbolici e metafisici. Infatti i romantici
pensano che lamore, pur rivolgendosi a cose e creature finite, scorga in
esse manifestazioni o cifre dell'Assoluto, sia inteso panteisticamente
nella forma dell'Uno-Tutto, sia interpretato trascendentisticamente nella
forma di un Dio Creatore. Infatti nell'amplesso degli innamorati,
espressione del misterioso fondersi di due creature diverse, essi vedono
il mistero stesso della vita e il simbolo dell'universale Armonia, ovvero
della congiunzione uomo-natura, finito-infinito eccetera. Il maggior
teorico di questa concezione è Schleiermacher, che difendendo l'amico
F. Schlegel dai fulmini del clero protestante, a motivo delle tesi
«audaci» sostenute nella Lucinde, così scrive:
«Nell'anima degli amanti dev'esservi la divinità, che essi nel loro
amplesso realmente sentono di stringere tra le loro braccia e che poi
sempre invocano. Nell'amore non ammetto nessuna voluttà senza questo
entusiasmo e senza l'elemento mistico (das Mystische) che ne deriva».
Tutto ciò significa che nell'amore, l'Assoluto, più che cercato, è, almeno
in parte, già trovato e posseduto. Tant'è che Giacinto, il protagonista
dei Discepoli di Sais, partito alla ricerca della misteriosa divinità
Isis, finisce per trovare, sotto il velo della dea, Fiorellin di rosa,
cioè la fanciulla amata, che egli aveva lasciato per muovere alla
ricerca della dea sconosciuta. E Fichte, nella Introduzione alla vita
beata, rifacendosi al Cristianesimo afferma: «Non è un'audace metafora, ma
la pura verità quel che dice lo stesso Giovanni: "Chi rimane nell'amore,
rimane in Dio, e Dio in lui"».
9. La nuova concezione della storia.
L'interesse per la storia.
Un altro degli aspetti caratterizzanti del Romanticismo tedesco è
l'interesse e il culto per la storia, che fin dall'inizio tende a prendere
le forme di uno « storicismo» antitetico all'«anti-storicismo»
illuministico. In realtà, come si è visto (nel volume 2), anche
l'Illuminismo si era esplicitamente occupato del mondo storico ed aveva
elaborato una specifica concezione di esso.
Tuttavia, fin dal suo nascere, la cultura romantica procede alla
teorizzazione di una nuova filosofia generale della storia, che, pur
affondando le sue radici nel tardo Illuminismo tedesco, finisce per
presentare dei caratteri oggettivamente antitetici a quella professata
nell'età dei lumi. Infatti, mentre per l'illuminismo il soggetto della
storia è l'uomo, per il Romanticismo risulta essere la Provvidenza
Il provvidenzialismo romantico.
L'esito fallimentare della Rivoluzione francese e dell'impresa napoleonica
aveva contribuito a generare l'idea che a «tirare le fila» della storia
non fosse l'uomo, ovvero l'insieme degli individui sociali, bensì una
potenza extraumana e sovra-individuale, concepita (vedi il tema
dell'Infinito) come forza immanente o trascendente. Per cui, sia che
venisse riportata all'idea dell'Umanità di Herder, all'Io trascendentale
di Fichte, al Dio cattolicamente inteso del secondo Schlegel o
all'hegeliano Spirito del mondo o ad altro ancora, la storia appariva, in
ogni caso, come il prodotto di un soggetto provvidenziale assoluto, che
si viene progressivamente rivelando o realizzando nella molteplicità
degli avvenimenti, dei quali costituisce il momento unificatore e
totalizzante. Guardata da questo punto di vista, la storia prende le
sembianze di un processo globalmente positivo, in cui non vi è nulla di
irrazionale o di inutile e nel quale ogni regresso è soltanto apparente.
Infatti la storia o è un progresso necessario e incessante, nel quale il
momento successivo supera il precedente in perfezione e razionalità, o è
una totalità perfetta, in cui tutti i momenti sono egualmente razionali e
perfetti (Hegel).
Il rifiuto della visione illuministica della storia.
Ovviamente, sulla base di questa serie di postulati «storicistici», o
meglio, di questa specifica interpretazione della storicità umana in
termini provvidenzialisti, l'Illuminismo, agli occhi dei romantici, appare
decisamente anti-storicista. Infatti la pretesa dei philosophes di
«giudicare» la storia, rifiutandone alcuni momenti, viene ad essere
romanticamente insostenibile. In primo luogo, perché voler giudicare la
storia equivale ad intentare un «processo a Dio», che nella storia si
manifesta o si realizza. In secondo luogo, perché ogni momento della
storia costituisce l'anello necessario di una catena processuale
complessivamente positiva. In terzo luogo, perché giudicare il passato
alla luce dei valori del presente (che per gli illuministi erano i valori
stessi dell'uomo: pace, benessere, pubblica felicità, libertà eccetera)
significa misconoscere l'individualità e l'autonomia delle singole epoche,
che hanno ognuna una specifica ragion d'essere in relazione alla totalità
della storia, e che perciò si sottraggono ad ogni giudizio critico e
comparativo nei loro confronti.
Il giustificazionismo e il tradizionalismo romantico.
Tutto ciò spiega perché lo storicismo romantico si accompagni, per lo
più, ad una forma di tradizionalismo, che non solo giustifica, ma in
qualche modo «santifica» il passato, ritenendolo espressione del «corso
di Dio nella storia» e linfa vitale del presente e del futuro. Anche su
questo punto, la spaccatura fra Illuminismo francese e Romanticismo
tedesco è netta e radicale. L'Illuminismo, che guardava al mondo storico
in maniera umanistica e problematicistica, era stato una filosofia
critica e riformatrice, che voleva liberarsi del passato poiché in esso
scorgeva, quasi esclusivamente, errori, pregiudizi, violenze eccetera. Il
Romanticismo, che guarda alla storia secondo schemi provvidenzialistici
e necessiaristici, si configura invece come una filosofia
giustificazionistica e tradizionalistica, che carica di un valore
assoluto le istituzioni basilari del passato: la famiglia, i ceti
sociali, la monarchia, lo Stato, la Chiesa eccetera. Inoltre esso trasforma
il Medioevo - che per gli illuministi era l'età della fame, dell'ignoranza,
dei soprusi, della superstizione popolare - in un'epoca di fede, di unità
spirituale, di fantasia e di imprese cavalleresche, in cui si forgiano
le energie che daranno origine alle nazionalità moderne.
10. La filosofia politica romantica.
La primissima fase del Romanticismo politico.
Strettamente connessa allo storicismo è la filosofia politica romantica,
anch'essa profondamente diversa da quella degli illuministi.
Inizialmente, gli autori del Romanticismo tedesco passano attraverso una
fiammata filo-rivoluzionaria e appaiono portatori, come già i
partecipanti allo Sturm und Drang e i teorici liberali alla Humboldt (vedi
capitolo 1, paragrafo 4), di istanze individualistiche ed
anti-statalistiche, che si esprimono talora non solo in forme di
radicalismo repubblicano, ma anche di ribellismo anarchico (F. Baader e
Schelling) o amoralistico (come testimonia la Lucinde di Schlegel). Lo
stesso Fichte, nelle Lezioni sulla missione del dotto (1794), esprime il
convincimento che lo scopo di ogni governo sia di «rendere superfluo il
governo». Questa fase del Romanticismo tedesco trova un riscontro in quel
tema della lotta dell'individuo contro la società, che costituisce uno
dei motivi ricorrenti della letteratura romantica europea, e che oltre
Manica trova la sua incarnazione in figure come Byron.
La seconda fase - quella più caratteristica - del Romanticismo politico.
Tuttavia, in una seconda fase, quella più propriamente «romantica», gli
intellettuali germanici, in virtù del loro storicismo provvidenzialistico
e tradizionalistico, cominciano ad elaborare degli schemi politici sempre
più statalistici e conservatori, convinti, da un lato, che l'individuo sia
tale soltanto all'interno di una comunità storica sovrapersonale ed in
virtù della sua appartenenza alle istituzioni tradizionali quali la
famiglia, lo Stato eccetera, e persuasi, dall'altro, che il disordine delle
forze umane sia destinato a produrre soltanto anarchia e caos, qualora non
intervengano, a porvi ordine, Iddio o la Chiesa da lui istituita. Partito
dall'anarchismo dello «Sturm und Drang», il Romanticismo perviene dunque
al culto dell'Autorità (cfr. paragrafo 7), finendo inevitabilmente per
convergere nell'alveo della Restaurazione. Infatti, in questo secondo
periodo, il Romanticismo offre degli strumenti teorici di legittimazione
delle istituzioni assolutistico-feudali, ergendosi contro le tendenze
riformatrici e liberaleggianti scatenate in tutt'Europa dalla Rivoluzione
francese e dalle guerre anti-napoleoniche.
Questo non significa, come si è già accennato, che il Romanticismo possa
essere ridotto a ideologia della Restaurazione europea. Infatti una
certa anima individualistica e libertaria del Romanticismo originario ha
continuato ad essere attiva, coniugandosi, soprattutto negli altri paesi,
alle istanze liberaleggianti ed anti-metternichiane.
Bifrontismo politico del Romanticismo.
Per cui, se da un lato, in Europa, «romantico» ha potuto essere sinonimo
di «conservatore», dall'altro ha potuto divenire l'equivalente di
«liberale» e di « patriota ».
Questo bifrontismo politico della corrente romantica nel suo complesso
risulta particolarmente evidente nella diversa portata teorico-pratica di
uno dei concetti più originali e decisivi dello storicismo romantico:
quello di «nazione».
L'idea di nazione.
Mentre l'idea settecentesca di «popolo» era definita in termini di volontà
e di interessi comuni e veniva concepita come risultato di un contratto e
di una libera convenzione, il concetto romantico di «nazione» risulta
definito in termini di elementi tradizionali come razza, lingua, costume,
religione eccetera. Per cui, se il «popolo», in senso settecentesco, è
la coesistenza di individui che vogliono vivere insieme, la nazione, in
senso ottocentesco, è la coesistenza di individui che devono vivere insieme,
nel senso che non possono non farlo senza rinnegarsi o tradire se stessi.
In tal modo, dalla «volontà generale» di Rousseau, pensata in termini
di «contratto sociale», si passa, nel Romanticismo tedesco, al concetto
di nazione, intesa anche come «spirito di popolo» (Volksgeist).
Anticipata in parte dall'inglese Edmund Burke (1729-1797), l'autore delle
Reflections on Revolution in France (1790), e formulata principalmente dalla
«scuola storica del diritto», in particolare da Friedrich Karl
Savigny (1779-1861) e dai fratelli Grimm, la teoria dello spirito del
popolo asserisce che gli organismi sociali non sono costituiti dall'insieme
delle volontà dei singoli, ma da una misteriosa «anima popolare», ossia da
un principio creativo inconscio ed extra-razionale, identificantesi con il
cosiddetto «genio della nazione», che sottostà alle molteplici
manifestazioni sociali, politiche e culturali di un popolo.
Differenze fra Illuminismo e Romanticismo.
Sulla base di questi presupposti, l'universalismo degli enciclopedisti
viene bollato di «antistoricismo» e di «astrattismo», e sostituito da uno
«storicistico» e «concreto» richiamo alla pluralità irriducibile delle
nazioni e delle espressioni culturali dei popoli. In tal modo, al
cosmopolitismo giuridico e politico dell'Illuminismo e di Kant, che
proclamava diritti naturali comuni e vagheggiava pacifici organismi
internazionali, viene contrapposto un nazionalismo giuridico e politico
esaltante il diritto «storico» e la politica «specifica» degli stati.
Analogamente, all'universalismo religioso degli illuministi, che perseguiva
l'ideale di una religione naturale e razionale, viene contrapposta la
molteplicità delle religioni positive e dei loro culti. Così, al
cosmopolitismo linguistico dell'Illuminismo, ed al suo progetto di una
lingua universale, viene contrapposto il nazionalismo linguistico e così via.
Si noti come anche in questo caso la polemica romantica contro
l'«astrattismo antistoricistico» degli illuministi si riveli oggettivamente
carica di equivoci. Infatti l'universalismo sognato dagli enciclopedisti e
da Kant non esclude affatto, anzi presuppone strutturalmente, l'esistenza
di un'umanità divisa in una molteplicità caotica e conflittuale di
credenze, costumi, lingue, istituzioni eccetera, delle quali gli autori
del Settecento, amanti dei viaggi e curiosi delle civiltà extra-europee,
ebbero lucida consapevolezza, anche se vi insistettero in misura minore
dei romantici. E ciò perché ad essi non interessava il mantenimento di ciò
che divide gli uomini (i particolarismi locali, le differenze linguistiche,
le credenze, i pregiudizi eccetera), ma la ricerca di ciò che può unirli,
nel segno della ragione e della scienza. In altre parole, la differenza fra
gli illuministi e i romantici non risiede tanto nella percezione o meno
della molteplicità e specificità delle culture umane, e quindi
nell'«astrattezza antistoricistica» degli uni e nella «concretezza
storicistica» degli altri, ma nel fatto che ai primi premeva di andare
oltre di esse, in nome dell'ideale di un'umanità sempre più «cosmopolita»
e «pacifica », mentre ai secondi interessava la loro conservazione in
nome del dato della tradizione storica.
La visione della vita sociale in termini di nazione e la sua considerazione
in chiave organicistica (= lo Stato è come un organismo in cui il tutto è
superiore alle parti, ossia agli individui che lo compongono, i quali hanno
la loro ragion d'essere solo nello Stato ed in funzione di esso) fanno sì
che la filosofia politica del Romanticismo tedesco tenda sempre più a
svilupparsi in una direzione statalistica e statolatrica, lungo una linea
teorica che da Novalis e da Schlegel giunge sino alla teorizzazione
dello «stato etico» di Hegel (vedi capitolo 6). Anzi, il pensiero politico
tedesco, esaltando, sin da Herder, il mito della «nazione missionaria»,
ossia del popolo «civilizzatore ed educatore», avente il compito di
condurre intellettualmente gli altri, e celebrando, sin da Fichte, il
«primato» moderno della Germania (vedi capitolo 4), finisce per gettare
le basi delle successive esaltazioni nazionalistiche dei tedeschi, sino
al loro tragico compimento nel nazismo. E la stessa guerra fra le nazioni,
aborrita dagli illuministi, finisce per trovare in Hegel una sua
giustificazione filosofica. Diremo dunque che il Romanticismo è una forma
di statalismo organicistico e nazionalistico?
Romanticismo, liberalismo, democrazia e patriottismo.
Anche in questo caso il Romanticismo non tollera schematizzazioni
unilaterali, poiché il culto della nazione, come si è già
accennato, assume anche, negli altri paesi europei, un
significato prevalentemente liberal-democratico. Soprattutto in Italia
si assiste ad una saldatura fra il concetto di nazione e quello di
libertà, intesa, quest'ultima, non solo come libertà dallo straniero, ma
anche come libertà dal potere assoluto, e quindi come libertà nello stato.
Infatti, come si può osservare in Mazzini, che rappresenta uno dei
principali esponenti della cultura romantica italiana (vedi capitolo 12),
il culto della nazione, nel nostro paese, fa tutt'uno con il
liberalismo (= la salvaguardia dei diritti individuali), con la
democrazia (= la teoria del popolo come detentore di sovranità), con
il patriottismo (= la battaglia affinché lo stato coincida con la nazione,
ossia affinché l'Italia, in quanto manzonianamente «una d'arme, di lingua
d'altare / di memorie, di sangue e di cor», cessi di essere divisa in tanti
staterelli e sottomessa allo straniero) e con il principio
dell'autodeterminazione nazionale (= ogni nazione deve essere padrona del
proprio destino politico).
Questa diversa maniera di rapportarsi al concetto di nazione fa sì che
in Germania si tenderà sempre di più ad accentuare gli aspetti
naturalistici e biologistici di essa, considerandola come un'entità
indipendente dalla volontà degli individui e identificantesi con il
legame di «sangue>, di «territorio» e di «lingua» (nazionalità
incosciente), mentre in Italia si tenderà piuttosto ad accentuarne gli
aspetti democratico-volontaristici, fondandola, oltreché sulla comunanza
di tradizioni, sulla volontà cosciente di un popolo (secondo il detto di
Renan per cui la nazione risulta «il plebiscito di tutti i giorni»).
Individualismo anti-statalistico, statalismo organicistico e nazionalista,
nazionalismo liberal-democratico e patriottico costituiscono dunque le
tre coordinate di fondo in cui si muove la filosofia sociale romantica,
tedesca ed europea.
11. La nuova concezione della Natura.
Il ritorno a Spinoza.
Un altro dei grandi temi del Romanticismo tedesco è la Natura. Infatti
l'amore ed il fascino per essa, che affondano le loro radici nel clima
culturale dello Sturm und Drang e si alimentano della «riscoperta di
Spinoza» (vedi capitolo 1, paragrafo 2), costituiscono uno dei dati più
caratteristici del movimento. Fra i documenti più significativi, atti
ad introdurre nell'«atmosfera» del neo-spinozismo romanticheggiante di fine
secolo, vi è innanzitutto un frammento che si trova fra le carte di Goethe
e che si intitola La Natura (Che questo inno (1781-1782) sia davvero del
Goethe, come si è tradizionalmente creduto, oppure appartenga ad altri, ad
esempio al pastore Georg Christoph Tobler (1757-1812), è qualcosa che non
incide sul suo valore di attestato della «mentalità» del periodo).
«Natura! - esclama il poeta. - Noi siamo da essa circondati e avvinti,
senza poter da essa uscire e senza poter entrare in essa più profondamente.
Non invitati e non avvertiti, essa ci prende nel giro della sua danza e ci
attrae nel vortice, finché, stanchi, cadiamo nelle sue braccia. - Essa crea
eternamente nuove forze: ciò ch'è ora non era ancora, ciò che era non
torna; tutto è nuovo, e nondimeno è sempre antico. - Noi viviamo nel mezzo
di essa, e le siamo estranei. Essa parla incessantemente con noi, e non ci
palesa il suo segreto. Noi operiamo costantemente su di essa, e tuttavia
non abbiamo su di essa nessun potere. - Pare che la natura tutto abbia
indirizzato verso l'individualità, eppure non sa che farsene degl'individui.
Artista incomparabile, senza apparenza di sforzo passa dalle opere più
grandi alle minuzie più esatte. E ognuna delle sue opere ha una propria
esistenza, ognuna delle sue manifestazioni un proprio concetto; ma nel
tempo stesso tutto è uno! - V'è una vita eterna, un divenire e un moto
incessante in essa, ma nel suo complesso non si espande. - Anche l'innaturale
è natura: chi non la vede dovunque, non la vede veramente in nessuna parte.
- Essa si compiace dell'illusione, e punisce come un tiranno chi la
distrugge in sé e negli altri, mentre stringe come un figlio al suo cuore
chi l'asseconda. - I suoi figli sono innumerevoli. Verso nessuno è avara,
ma ha i suoi preferiti, ai quali prodiga molto e molto sacrifica. - Essa fa
uscire le sue creature dal nulla, e non dice loro donde vengono e dove
vanno: esse debbono soltanto camminare; lei sola sa la via. - Il suo teatro
è sempre nuovo, perché essa crea sempre nuovi spettatori. La vita è la sua
più bella invenzione, e la morte è il suo artifizio per avere più vita.
- Essa dà bisogni, perché ama il movimento, ed è mirabile vedere con che
scarsi mezzi riesca ad ottenere tanto moto. - Essa non ha lingua né parla,
ma crea lingue e cuori, mediante i quali parla e sente. La sua corona è
l'amore: solo con questo ci si avvicina ad essa. - è intera, e nondimeno
è sempre incompiuta. Non conosce passato e futuro; il presente è la sua
eternità».
Un altro scritto emblematico del nuovo culto per la Natura è un noto passo
dell'Iperione (1, l) di Hölderlin, fra i più belli di tutta la
letteratura romantica:
Ma tu ancora risplendi o sole del cielo e tu ancora sei verde o santa
terra, ancora scorrono i fiumi verso il mare e nel meriggio frusciano gli
alberi ombrosi.
Il canto voluttuoso della primavera invita al sonno i miei pensieri
mortali. La pienezza del mondo vibrante di vita nutre e sazia di ebbrezza
il mio povero essere.
O natura santa! Io non so cosa mi avvenga quando alzo i miei occhi
dinnanzi alla tua bellezza, ma tutta la gioia del cielo è nelle lacrime
che piango innanzi a te, come l'amante alla presenza dell'amata.
Tutto il mio essere ammutolisce e si tende, quando il soffio delicato
dell'aria gioca sul mio petto. Perduto nell'azzurro sconfinato, io volgo
spesso il mio sguardo in alto, verso l'etere e in basso nel sacro mare
ed è come se uno spirito affine mi aprisse le braccia, come se il dolore
della solitudine si dissolvesse nella vita degli dèi.
Essere uno col tutto, questa è la vita degli dèi, questo è il cielo
dell'uomo.
Essere uno con tutto ciò che ha vita, fare ritorno, in una beata
dimenticanza di sé, nel tutto della natura: ecco il vertice dei pensieri e
delle gioie, la sacra vetta del monte, il luogo della quiete perenne, dove
il meriggio perde la calura e il tuono perde la sua voce; dove il mare
ribollente somiglia all'ondeggiare di un campo di spighe.
Il rifiuto degli schemi illuministici e materialistici.
Questo sentimento della natura si esprime anche, in età romantica, in
una nuova concezione complessiva di essa, che accomuna filosofi, poeti,
uomini di scienza eccetera, che si definisce per antitesi nei confronti di
quella emersa con la Rivoluzione scientifica e teorizzata dall'Illuminismo,
soprattutto dal materialismo francese. Tant'è vero che lo stesso Goethe,
ricordando da anziano, nel 1811, la lettura giovanile del Système de
la Nature di D'Holbach, esprime un giudizio rivelatore di tutto un
mondo culturale:
«Come ne restai deluso! Quanto mi parve vuoto e triste quel crepuscolo
ateo, nel quale scomparivano la terra con tutti i suoi esseri e il cielo
con le sue stelle luminose! Se un danno mi produsse quel libro, fu di
rendermi odiosa la filosofia e soprattutto la metafisica, e di spingermi
con nuova e più grande passione verso la scienza sperimentale, verso la
vita e la poesia che sgorga dal cuore».
Il mutamento di rotta rispetto alla rivoluzione scientifica moderna e il
nuovo modo di concepire la natura.
Come si è visto, da Galileo in poi, la Natura era stata prevalentemente
considerata come un ordine oggettivo e come un insieme di relazioni
fattuali legate fra di loro da cause efficienti, mentre la scienza era
stata interpretata come un'indagine matematizzante ed analitica sui
fenomeni osservabili. Ciò aveva prodotto un rifiuto della concezione
rinascimentale - e quindi greca e medioevale - del cosmo, generando ciò
che va sotto il nome di «meccanizzazione del quadro del mondo», ossia
un'interpretazione della natura come un sistema di materia in movimento
retto da un insieme di leggi meccaniche, escludenti ogni riferimento a
presunti «fini» o «scopi».
Ricollegandosi da un lato ad un filone di pensiero «vitalista» e
«dinamicista» (da Leibniz a Charles Bonnet e allo stesso Kant, fautore,
nei Princìpi metafisici della natura del 1786, di un «sistema dinamico») e
riprendendo dall'altro la visione antico-rinascimentale della Physis, i
romantici, non senza influenze di tipo mistico e teosofico, pervengono
ad una filosofia della natura organicistica (= la natura è una totalità
organizzata nella quale le parti vivono solo in funzione del Tutto),
energetico-vitalista (= la natura è una forza dinamica, vivente ed
animata), finalistica (= la natura è una realtà strutturata secondo
determinati scopi, immanenti o trascendenti), spiritualistica ( = la
natura è anch'essa qualcosa di intrinsecamente spirituale, ossia uno
«spirito colato» o uno «spirito in divenire») e dialettica (= la natura
è organizzata secondo coppie di forze opposte, formate da un polo
positivo ed uno negativo, e costituenti delle unità dinamiche).
Reagendo alla disantropomorfizzazione e alla despiritualizzazione del
cosmo effettuate dalla moderna scienza della natura, i romantici
ritengono che la natura e l'uomo posseggano una medesima struttura
spirituale, la quale autorizza un'interpretazione psicologica dei
fenomeni fisici ed una interpretazione fisica dei fenomeni psichici.
Infatti, posta la stretta unità uomo-natura, si deduce che ciò che
risulta vero dell'uno deve esserlo anche dell'altra, e viceversa.
Il principio romantico dell'analogia.
Anzi, vedendo nell'uomo «l'esemplare sintetico» e «il compendio vivente del
Tutto», in cui «dorme l'intera storia del mondo», si pensa che conoscere
equivalga a discendere in noi stessi, per trovarvi, secondo il principio
dell'analogia, la chiave di spiegazione dei fenomeni. Presentando in modo
fantasioso e intuitivo ciò che soprattutto Schelling, il maggior
filosofo romantico della natura (vedi capitolo 5, paragrafo 4), esprimerà
in modo speculativo e filosofico, Schiller scrive:
« Tutto ciò che è in me e fuori di me è soltanto il geroglifico di una
forza che mi è affine. Le leggi della natura sono i segni cifrati che
l'Essere pensante ha combinato allo scopo di rendersi comprensibile
all'essere pensante.
Se vuoi convincertene, cerca all'indietro. A ogni stato dell'anima umana
corrisponde una qualche immagine nella creazione fisica, immagine con
cui esso viene designato; e ad attingere da questo ben fornito deposito
sono stati anche i pensatori più astratti, non soltanto gli artisti e i
poeti. Un'attività piena di animazione viene da noi detta fuoco; il tempo
è una corrente che trascina con sé; l'eternità è un circolo; un segreto
si nasconde nel buio di mezzanotte, e la verità ha sede nel sole. Anzi,
io comincio a credere che perfino il destino futuro dello spirito umano
sia preannunciato nell'oscuro oracolo della creazione corporea. L'avvento
di ogni primavera, che fa uscire dal grembo della terra i germogli delle
piante, mi dà elementi per interpretare quell'imbarazzante enigma che è la
morte, e confuta l'incubo angoscioso che è per me il sonno eterno. La
rondine che d'inverno troviamo intirizzita, e che in marzo vediamo
rianimarsi, il morto bruco che, rinato, torna a levarsi nell'aria come
farfalla, ci offrono una pertinente allegoria della nostra immortalità...»
(Philosophische Briefe, in Werke, volume 1, La traduzione di questo brano
è tratta da C. Cesa, Le origini dell'idealismo tra Kant e Hegel, Loescher,
Torino 1981, pagine 49-51.)
«Solo il Tutto vive».
Inoltre, reagendo alle tendenze analitiche ed antimetafisiche della
scienza galileiana, i romantici, partendo dalla persuasione che «solo
il Tutto vive» (come afferma ad esempio Franz Baader), ritengono che
ogni fondata filosofia della natura debba prendere in considerazione
l'ordinamento complessivo del cosmo, poiché soltanto in relazione ad esso
si possono comprendere le parti nei loro rapporti di coordinazione e
subordinazione. Tale convincimento si accompagna pure al recupero di
figure metafisiche del passato, come ad esempio «l'Anima del mondo»
(vedi capitolo 5, paragrafo 4). La scoperta della pila voltaica (1800) e i
progressi del chimismo e del magnetismo parvero, ad un certo punto,
confermare talune intuizioni romantiche, come ad esempio quelle relative
alla «dialetticità» dei fenomeni naturali, facendo sì che pensatori
speculativi e sperimentalisti, occultisti e chimici, cristiani e panteisti,
guardassero tutti con interesse alla filosofia romantica della natura.
Questo facilitò la diffusione delle nuove idee, che tuttavia, pur non
essendo prive di meriti storici oggettivi, consistenti nella correzione di
certi limiti del meccanicismo - soprattutto la pretesa di «imbrigliare»
negli schemi della meccanica tutti i fenomeni - finirono per apparire
«fantastiche» e portatrici di una «mentalità» qualitativa, sostanzialista e
finalista antitetica alla strada maestra, matematizzante e fenomenistica,
della scienza moderna.
12. L'ottimismo al di là del pessimismo.
I temi pessimistici del dolore e della malinconia.
Considerato sotto certi punti di vista, il Romanticismo sembra segnare
il trionfo del pessimismo più esasperato. Infatti nella letteratura
romantica dominano gli stati d'animo tristi e melanconici e abbondano i
protagonisti inquieti e delusi, alla ricerca di una felicità sempre sognata
e mai raggiunta. Del resto, com'è stato rilevato tante volte dagli
studiosi, il Romanticismo nasce proprio da una coscienza d'infelicità e da
un anelito verso l'infinito, ossia da un desiderio di andare oltre gli
ostacoli che stringono l'esistenza da ogni parte.
Si noti come «personaggi del dolore» siano anche taluni degli stessi geni
romantici, spiriti eletti e precoci, ma vittime di tragici destini:
Wackenroder muore a soli 25 anni, Novalis, ammalato di tubercolosi,
scompare a 29 anni, Hölderlin finisce la sua vita racchiuso in una torre
solitaria e in preda alla follia. E molti altri rappresentanti del
Romanticismo europeo - da Byron e Shelley - hanno avuto un'esistenza
tempestosa e tragica, generando la persuasione romantica dell'infelicità
fatale del genio, espressa dal leopardiano:
«Vivi, e sii grande e infelice»
(G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un'anima, in Operette morali (1824).
L'espressione citata risale in realtà al D'Alembert, anche se spetta a
Leopardi l'averla usata e resa famosa, almeno nel nostro paese, in senso
tipicamente romantico.)
Anzi, Romanticismo e dolore sono così legati, che in questo movimento
culturale nasce persino la voluptas dolendi, ossia l'autocompiacimento
della sofferenza stessa, intesa come il prezzo che deve pagare ogni
individuo per entrare nella schiera dei grandi.
Tuttavia la concezione romantica del mondo, globalmente intesa, è
ottimistica, in quanto tende a risolvere il negativo nel positivo.
Diremo allora, sulla scorta di parecchie storie della letteratura, che
il Romanticismo è sostanzialmente pessimista? Come si spiega, allora, la
tesi delle storie della filosofia, secondo le quali il Romanticismo è
sostanzialmente ottimista? In realtà, l'apparente antitesi fra
Romanticismo letterario e Romanticismo filosofico (Antitesi che obbliga
talora il medesimo studente - e lo sa bene chi vive nel mondo della
scuola - a «recitare» al professore di letteratura italiana e straniera
che il Romanticismo è pessimista, e al professore di filosofia che
il Romanticismo è ottimista.) nasce solo da una mancata distinzione fra la
predisposizione romantica verso gli stati d'animo melanconici (nonché
verso la rappresentazione artistica del dramma della sofferenza) e la
visione complessiva del mondo effettivamente professata dai poeti e dai
filosofi di quest'età.
Infatti, anche se nella letteratura romantica ha molta parte il tema del
dolore, il pessimismo, inteso propriamente come concezione globale
dell'essere, è piuttosto un'eccezione (ad esempio di Schopenhauer in
Germania e del De Vigny in Francia), e in ogni caso non è certo la
posizione tipica del Romanticismo, che è portato a scoprire, al di là
del negativo, la realtà del positivo. Infatti, come nella Nona Sinfonia
di Beethoven, le note dell'inno alla gioia si levano trionfali dagli
abissi della sofferenza (Cfr. M. Puppo, Il Romanticismo, Studium, Roma
1975, pagine 147-148, ove il noto studioso, che tiene presente soprattutto,
anche se non esclusivamente, gli aspetti letterari del Romanticismo,
perviene alla conclusione, coincidente con la tesi che stiamo esponendo,
secondo cui l'arte romantica « non vuole eliminare nessun aspetto, anche
negativo, della realtà: né il brutto, né il male, né il dolore; ma tutti
redimerli in una sfera più alta, nella quale le opposizioni si compongano
e la luce brilli più fulgida».), così il Romanticismo, per una delle sue
caratteristiche ambivalenze, al di là del pessimismo, tende sempre,
soprattutto presso i tedeschi, a sfociare nell'ottimismo. E del resto non
potrebbe essere diversamente: la sua visione provvidenzialistica del
reale e la sua mentalità a sfondo religioso presuppongono, in vario
modo, un'accettazione di fondo dell'essere. Come scrive Hölderlin in un
abbozzo dell'Iperione:
«Alles muss kommen, wie es kommt. Alles ist gut».
«Tutto avviene come deve avvenire. Tutto è bene» (2, 63).
E anche quando manchi un'apertura religiosa (ma è abbastanza raro),
oppure questa non sia sufficientemente forte, i romantici tendono a
«sublimare» il negativo nella dimensione dell'arte, oppure in quella della
storia e della politica.
L'infelicità e il male come manifestazioni parziali di un Tutto
globalmente pacificato e felice.
Di conseguenza, si può dire che nei romantici tedeschi vi sia sempre una
tendenziale risoluzione del negativo nel positivo, in quanto essi, al di
là della caoticità e dolorosità del mondo, sono portati a ricercare un
senso o un piano capace di riscattare il male e di trasformarlo in
un momento del farsi complessivo del bene:
« Che cos'è dunque la morte e tutto il dolore degli uomini? Ah! molte
vane parole han fatte gli uomini strani. Scaturisce pur tutto dalla gioia
e termina pur tutto nella pace» (Hölderlin, Iperione, finale).
Qualunque sia la vita percorsa - panteistica, idealistica, cristiana o
semplicemente estetica o politica - i romantici finiscono dunque per
approdare ad una forma di ottimismo cosmico o storico che nel dolore,
nell'infelicità e nel male scorge delle manifestazioni parziali e
necessarie di un Tutto che è sempre, nella sua globalità, pacificato
e felice. Ancora una volta, i versi di Hölderlin hanno il potere di
riassumere tutto lo spirito di un'età, e forse di un secolo:
« Come le discordie degli amanti sono le dissonanze del mondo.
Conciliazione è in mezzo alla stessa discordia e tutto ciò ch'è disgiunto
si ritrova» (ivi).
Infatti questo schema mentale, che consiste nel percepire l'armonia
oltre la disarmonia, sta alla base delle più disparate esperienze
artistiche e filosofiche del Romanticismo tedesco. Lo si ritrova ad
esempio in quegli abbozzi di « filosofia della sera e del mattino» dei
poeti, ai quali si è già accennato (vedi paragrafo 6.2)
«Più angosciosi i sogni - più vicina la mattina consolatrice.
Siamo prossimi al risveglio quando sogniamo di sognare » (Novalis).
Tuttavia, la celebrazione massima dell'ottimismo romantico è rappresentata
dall'idealismo panlogistico di Hegel (vedi capitolo 6), secondo cui il
mondo è la manifestazione di un'unica infinita Ragione che abita in ogni
momento della vita e della storia, facendo sì che la realtà sia sempre ciò
che deve essere, ossia razionalità e perfezione. Esprimendo in termini
speculativi ciò che in Hölderlin, come si è visto, è detto in termini
lirici, Hegel fa della dialettica (vedi capitolo 6, paragrafo 6) la legge
stessa della realtà, ritenendo che in essa, al di là della possibile
«coscienza infelice» dell'individuo, tutto sia positivo.
La «redenzione» del negativo.
Anche negli altri paesi europei, il Romanticismo presenta le stesse
caratteristiche di un «pensiero ottimista al di là del pessimismo»,
ossia la medesima forma mentis, portata a cercare un qualche riscatto o una
qualche redenzione al negativo, sia di tipo trascendentistico (Dio),
panteistico (la Natura), idealistico (lo Spirito), estetico (la poesia e la
bellezza), storico-politico (il progresso dell'umanità) eccetera.
La controprova di come il Romanticismo si accompagni ad una concezione
globalmente più ottimistica che pessimistica, per quanto riguarda la
visione generale del mondo, è offerta pure, per ciò che riguarda l'Italia,
dal caso Leopardi da un lato e dal caso Manzoni dall'altro. Infatti
Leopardi, più legato, sul piano filosofico, alla cultura settecentesca e
illuministica (Che Leopardi possa essere considerato, almeno per certi
aspetti della sua opera e della sua poesia, un « romantico » è questione
assai dibattuta dagli studiosi. Che il suo pensiero sia di formazione
settecentesca e risulti più vicino, soprattutto nel «periodo napoletano»,
alla cultura illuministica, è invece qualcosa su cui esiste, fra gli
interpreti, un sostanziale accordo. (Cfr. W. Binni, La protesta di
Leopardi, Sansoni, Firenze 1973), elabora una visione pessimistica
della realtà, antitetica ad ogni forma di provvidenzialismo religioso o
laico (quello delle «magnifiche sorti e progressive» di romantici come
Mamiani o Mazzini) e ostile ad ogni «soluzione» filosofica o fideista
del problema del male.
Invece Manzoni, profondamente partecipe della cultura romantica, parla di
«provvida sventura» e crede in una finale redenzione della sofferenza e
della negatività attraverso la fede in Dio e nella Provvidenza (messaggio
che costituisce il «sugo» dell'Adelchi e soprattutto dei Promessi Sposi).
13. La diffusione del Romanticismo in Europa.
La diffusione delle idee del Romanticismo tedesco in Europa è dovuta, in
parte, ai fratelli Schlegel, che, grazie a lunghi soggiorni a Parigi e ad
una serie di viaggi in Italia, in Inghilterra e in Scandinavia, hanno modo
di incontrare i letterati di quelle nazioni, in alcune delle quali il
Romanticismo risulta qualcosa di già avviato per proprio conto. Tale,
soprattutto, è il caso dell'Inghilterra, in cui il Romanticismo ha origini
autoctone e trova un background «preparatorio» nella letteratura
«sepolcrale» ed «ossianica» del Settecento e nella cosiddetta «ideologia
anti-industriale».
Il preromanticismo.
La prima, rappresentata principalmente da Thomas Grey (1716-1771 ), con
la nota Elegia scritta su un cimitero di campagna (1751), e da Edward
Young, con i Pensieri notturni (risalenti al 1742-1745), risulta
impregnata dei temi della morte, della notte, del tempo e del mistero,
mentre la seconda, che trova il suo rappresentante in James
Macpherson (1736-1796), traduttore e divulgatore degli antichi canti epici
scozzesi (1760), appare caratterizzata dai paesaggi nebbiosi delle
brughiere, dall'errare inquieto dei cavalieri per lande solitarie, dalla
visione allucinata dei fantasmi degli avi sotto il chiarore lunare, dai
lamenti di spiriti imprigionati nelle caverne, dagli amori fra guerrieri
coraggiosi e trasognate fanciulle destinate a piangere sulla tomba dei
loro innamorati, dalle imprese eroiche dei naviganti nei burrascosi mari
del Nord eccetera, e quindi da temi e figure visibilmente vicini a certo
modo di sentire «romantico».
Il Romanticismo in Inghilterra.
La data ufficiale dell'inizio del Romanticismo inglese è il 1798, anno di
quel «manifesto romantico» che è la Prefazione di Wordsworth alle Lyrical
Ballads, in Inghilterra pubblicata in collaborazione con Coleridge, e
nella quale alla poesia romantica è affidato il compito di «manifestare
il mistero nascosto anche nelle più umili cose di ogni giorno», o, secondo
quanto scriverà in seguito Shelley (1792-1822) nella Difesa della
poesia (1821), di «lacerare il velo della pigra abitudine dalla faccia
del mondo e di mostrare ingenuamente la nuda dormiente beltà che è lo
spirito delle sue forme». Fra gli esponenti del Romanticismo inglese,
oltre a quelli già menzionati, ricordiamo George Byron (1788-1824),
John Keats (1795-1821), Walter Scott (1771-1832) e Jane Austen (1775-1817).
Il Romanticismo in Francia.
In Francia la nuova moda romantica è lanciata da Madame de
Staël (1766-1817), che, con la sua opera famosa De l'Allemagne (1810, ma
edita a Londra nel 1813), risulta la principale mediatrice fra Romanticismo
nordico e Romanticismo latino, e la più appassionata divulgatrice delle
nuove idee. Posteriore a quello inglese e tedesco, il Romanticismo francese,
che si nutre anche di temi rousseauiani e trova un anticipatore in René
de Chateaubriand (1768-1848), si costituisce abbastanza tardi. Solo
nel 1823 troviamo un primo cenacolo romantico attorno a Charles
Nodier (1783-1844) e solo nel 1827 abbiamo la Prefazione di Victor Hugo al
suo dramma Cromwell, che suole essere considerato un po' come il manifesto
del Romanticismo francese - fra i cui esponenti più noti possiamo ricordare
i poeti Alphonse de Lamartine (1790-1869), Alfred de Vigny (1797-1863),
Alfred de Musset (1810-1857) e i romanzieri Stendhal (1783-1842),
Honoré de Balzac (1799-1850), George Sand (1804-1876) e Victor
Hugo (1804-1885).
Il Romanticismo in Italia.
Tramite Madame de Staël la nuova corrente letteraria arriva anche in
Italia e trova nella Lettera semiseria del Berchet (1816) il suo primo
manifesto. Altri documenti importanti della nuova cultura sono
Il Conciliatore (settembre 1818 ottobre 1819) e gli scritti manzoniani
quali la Prefazione al Conte di Carmagnola (1820), la Lettera a
M. Chauvet (1820) e la Lettera sul romanticismo a Cesare D'Azeglio (1823).
Massimo esponente del Romanticismo letterario italiano è il Manzoni,
attorno a cui ruotano figure minori, come il Prati e l'Aleardi, che però
rappresentano già la crisi del movimento. Più o meno contemporaneamente
il Romanticismo si estende agli altri paesi: dalla Scandinavia (con
Henrik Steffens e Adam Gottlob Oehlenschlüger, il più grande poeta
romantico danese) alla Russia (con Aleksandr Puskin e Michail Lermontov).
Più tardi esso si diffonde anche in America.
Il Romanticismo letterario europeo - di cui abbiamo ricordato i dati
essenziali - ha uno spessore teorico assai più limitato di quello tedesco
e appare meno intriso di temi filosofici e metafisici. Questo non significa
tuttavia, come si finisce talora per credere, che la «rivoluzione
romantica», al di fuori della Germania, abbia un carattere esclusicamente
letterario. Infatti non bisogna dimenticare che, anche negli altri paesi,
il Romanticismo assume il volto di una «situazione culturale globale» che
influenza e si concretizza in tutte le attività spirituali e che perciò
investe anche la filosofia.
Valenze filosofiche del Romanticismo in Inghilterra.
Per quanto riguarda l'Inghilterra, il Romanticismo letterario presenta
delle esplicite valenze filosofiche nell'opera di S. T Coleridge (1772-1834),
che T. H. Green tenterà di comporre in modo organico, in Spiritual
philosophy (Londra 1865), riunendo gli sparsi e asistematici appunti
coleridgiani. Polemizzando contro il materialismo meccanicistico degli
illuministi francesi, Coleridge, pur essendo attratto da un cristianesimo
più interiormente vissuto e razionalisticamente inteso, finisce per
approdare ad una forma di panteismo naturalistico a sfondo mistico, nutrito
di suggestioni provenienti dal neoplatonismo antico, da Spinoza (della cui
filosofia fu ammiratore) e da Schelling. Anche H. Wordsworth (1770-1850)
si interessa alla filosofia. Nel periodo giovanile, appare anch'egli
attratto da una visione panteistico-naturalistica del Tutto, di ascendenza
spinoziana (vedi volume 2) e passa un momento di entusiasmo per la
Rivoluzione francese, tant'è vero che accorre in Francia in aiuto dei
Girondini.
In seguito, in particolare nel poema The excursion (1814), Wordsworth amareggiato per la perdita dei figli, per la rovina dì Coleridge ad opera
degli stupefacenti e per l'involuzione sanguinaria e dittatoriale della
Rivoluzione francese e del regime napoleonico - manifesta un ritorno
alla fede e ai valori tradizionali, sviluppando un pensiero politico
di stampo conservatore, che addita nell'Inghilterra, e nella robustezza
delle sue istituzioni statali ed ecclesiastiche, un baluardo contro lo
sgretolamento della vita politica e spirituale del tempo.
Interessi filosofici presenta anche T. Carlyle (1795-1881), che dopo alcuni
saggi e studi, con cui si preoccupa di far conoscere al pubblico inglese
la letteratura romantica tedesca, pubblica il Sartor resartus che è insieme
una satira allegorica della società contemporanea e l'espressione dei
suoi princìpi filosofici.
Il tema romantico degli «eroi» in Carlyle.
In un lavoro storico, La rivoluzione francese (1837), egli esalta
liricamente le grandi figure di quella rivoluzione; e nell'opera
Gli eroi (1841) concepisce la storia come il campo d'azione delle grandi
personalità e studia le varie manifestazioni dell'eroismo umano. In
numerosi saggi posteriori egli rivolge una critica mordente alla società
meccanica esaltando liricamente, in contrasto con essa, l'ideale di una
vita spirituale dominata dalla volontà e dai valori morali. In Sartor
resartus l'universo è un abito, cioè un simbolo o un'apparizione della
potenza divina che si manifesta ed opera in gradi diversi in tutte le cose.
Carlyle esalta il mistero che avvolge «il più strano di tutti i mondi
possibili ». L'universo non è un magazzino o un fantastico bazar, ma
il mistico tempio dello spirito. La sicurezza della scienza di possedere
la chiave del mondo della natura è illusoria. Il miracolo che viola una
cosiddetta legge di natura non può essere invece l'azione di una legge più
profonda, diretta a mettere la forza materiale al servizio dell'energia
spirituale? In realtà tutte le cose visibili sono segni o emblemi: la
materia esiste solo per lo spirito: non è che l'incarnazione o la
rappresentazione esterna di un'idea. Nel mondo della storia la potenza
divina si manifesta in quelle grandi personalità che Carlyle chiama eroi.
Gli eroi sono «gli individui della storia universale» di cui parlava Hegel,
cioè gli strumenti della provvidenza divina che domina la storia. E tutto
ciò che nella storia umana si realizza di grande e di duraturo è dovuto
alla loro azione.
Nella seconda metà del secolo il filone romantico-idealista inglese trova
la sua manifestazione più originale in T. H. Green. E nello stesso
positivismo evoluzionistico di Spencer operano taluni schemi concettuali
che, sebbene presentati in un linguaggio scientificizzante, rivelano aperti
o sotterranei influssi del pensiero idealistico tedesco. Rimarchevoli
espressioni filosofiche di tipo romantico-idealistico, attraverso la
mediazione della cultura inglese, troviamo anche in America.
In Francia, rientrano nell'«atmosfera» romantica fenomeni come il
«tradizionalismo», l'eclettismo di Cousin e lo spiritualismo di Maine de
Biran (per i quali vedi il capitolo 11). Lo stesso positivismo comtiano,
come vedremo (vedi capitolo 13) non è immune da forti influssi romantici.
In Italia, si inserisce esplicitamente nell'alone romantico la filosofia di
Gioberti e Mazzini, che costituisce un momento decisivo della cultura
risorgimentale del nostro paese (vedi capitolo 12).
In conclusione, anche se il Romanticismo non ha trovato, al di fuori
della Germania, delle manifestazioni paragonabili a quelle germaniche, e
soprattutto all'idealismo di Fichte, Schelling ed Hegel, esso ha pur
sempre caratterizzato la filosofia dei vari paesi europei (e della
stessa America) influendo anche sul positivismo della prima e della
seconda metà del secolo. Questa affermazione ci porta ad esaminare un
ultimo decisivo problema storiografico: il rapporto Romanticismo-Ottocento.
14. Romanticismo e filosofia ottocentesca.
Lo «spirito romantico».
Come si è visto, prima di identificarsi con questa o quella dottrina, il
Romanticismo è innanzitutto un'«atmosfera» e una «mentalità», ossia una
struttura culturale globale, che investe la molteplicità
delle manifestazioni spirituali della prima metà dell'Ottocento.
Per questo, si può parlare di uno «spirito romantico» che
circola nell'arte come nella filosofia, nella politica come nel costume e
che tende a concretizzarsi nella costellazione di atteggiamenti e di
temi che abbiamo cercato di sintetizzare nei paragrafi precedenti.
La «brama dell'infinito».
Fra tutti i motivi sopraelencati, il più tipico, poiché costituisce al
tempo stesso l'inizio storico del fenomeno romantico (con Fichte) ed il
suo nucleo ideale, vi è l'insofferenza dei limiti del finito e
l'aspirazione all'assoluto. Infatti, è proprio «la brama dell'infinito» che
mette in moto, e rende adeguatamente comprensibile, la polemica contro
la ragione illuministica, il privilegiamento del sentimento e dell'arte,
l'esaltazione della fede e della ragione «dialettica», il predominio di
stati d'animo quali la Sehnsucht, l'ironia, il titanismo, l'evasione, la
ricerca di una nuova armonia uomo-mondo, la dottrina idealistica dello
Spirito come attività creatrice, la celebrazione dell'amore, la dottrina
della storia come sviluppo provvidenziale, il culto della tradizione o
del progresso, l'interpretazione della Natura come ciclo inesauribile, il
prevalere finale dell'ottimismo sul pessimismo eccetera. Ed è proprio
«l'infinito desiderio di infinito » che porta i romantici a caricare il
finito di significati infiniti, ossia a fare dell'uomo il portatore
dell'infinito stesso e ad assolutizzare determinate attività o modi
d'essere: la poesia, l'amore, la storia, la politica eccetera, generando
talora un «fanatismo dell'infinito» che finisce per smarrire o tradire il
finito e l'infinito come tali: l'uno in quanto acriticamente assolutizzato
e l'altro in quanto relativizzato alla dimensione umana e mondana.
Ora, pensare che questa forma mentis, con tutto ciò che essa comporta, si
sia concretizzata solo nella filosofia tedesca dell'età romantica, e
quindi nell'idealismo, significa muoversi in un'ottica storiografica
angusta. Infatti, andando oltre la superficie e le etichette, e scavando
più a fondo, ci si accorge che talune forme mentali romantico-idealistiche
sono presenti non solo nello spiritualismo francese o italiano, da Maine de
Biran a Mazzini, ma anche in filosofie a prima vista antitetiche al
Romanticismo e all'idealismo, ad esempio nel positivismo di Comte
(vedi capitolo 13) e di Spencer (vedi capitolo 14), nell'irrazionalismo
pessimistico di Schopenhauer (vedi capitolo 7), e, attraverso Hegel,
nello stesso marxismo (vedi capitolo 10), per cui si può dire che la
filosofia ottocentesca risulti in buona parte impregnata di Romanticismo.
Aspetti «romantici» della cultura ottocentesca.
Infatti sono rimasti tratti tipici del secolo, e quindi non
necessariamente presenti in blocco in tutti gli autori, ma rinvenibili,
in modo variabile, in parecchi di essi:
1) la mentalità assolutistica, ossia la tendenza a parlare in nome di
certezze assolute (estetiche, speculative, scientifiche, storico-politiche
eccetera), sulla cui base costruire delle visioni totalizzanti del mondo e
del progresso sociale.
2) La tendenza a concepire la realtà naturale ed umana come manifestazione
di una Forza infinita che ne rappresenta la struttura ed il senso.
L'Io puro di Fichte, l'Assoluto di Schelling, l'Idea di Hegel,
l'Umanità di Comte, il Dio-provvidenza degli spiritualisti, l'Inconoscibile
di Spencer, la Natura di Engels, l'Indistinto di Ardigò, l'Inconscio E.
Hartmann eccetera, sono altrettanti esempi dell'infinitismo
romanticheggiante che circola in buona parte delle filosofie dell'Ottocento.
Ovviamente i vari sistemi divergono radicalmente fra di loro nel modo di
intendere la natura del principio infinito e i suoi rapporti con il finito.
Secondo alcuni di essi il Principio è uno Spirito immanente, per altri è
l'Ignoto che si manifesta nell'evoluzione universale, per altri un Dio
trascendente le sue creature mondane eccetera. E il finito appare, di volta
in volta, come realizzazione necessaria dell'infinito oppure come una sua
libera rivelazione temporale. Ma tutto questo non esclude il comune
convergere di tali filosofie in un medesimo orizzonte concettuale,
costituito dall'interpretazione della realtà come manifestazione graduale
di una totalità assoluta.
3) L'uso della categoria della necessità come strumento intepretativo
privilegiato e la propensione a considerare la realtà o la storia come
una linea ascendente di passaggi obbligati, mettenti capo ad un risultato
finale (la pacificazione dello Spirito con se stesso, la libertà delle
nazioni, il comunismo, la civiltà della scienza eccetera) garantito da
forze immanenti o trascendenti quali il piano di sviluppo dell'Idea,
la Provvidenza, la dialettica della storia, l'evoluzione cosmica...
4) La polemica contro «l'individualismo» settecentesco e la tendenza a
risolvere gli individui in dimensioni o processi sovra-personali
(la Natura, lo Spirito, la Nazione, lo Stato, la Società, l'Evoluzione
della specie...) «dissolvendo» in una di queste totalità le
situazioni-limite e gli aspetti drammatici dell'esistenza: la singolarità,
lo scacco, l'angoscia, la morte eccetera.
5) Questi vari punti confluiscono tutti in una generale concezione
ottimistica della realtà e della storia, che fa dell'Ottocento il secolo
delle grandi fedi e delle grandi speranze dell'umanità moderna. Sentenziando
che «tutto avviene come deve avvenire. Tutto è bene», Hölderlin è stato,
in fondo, il profeta del secolo.
Il necessitarismo e l'ottimismo.
Infatti, trascrivendo nei registri più disparati (compresi quelli
sedicenti «scientifici») tale convinzione, gran parte dei pensatori
ottocenteschi è stata portata a credere non solo alla necessità di ciò che
accade, ma anche alla sua bontà d'insieme e a vedere nel mondo, al di là
di ogni tragedia, l'attuazione di una sostanziale commedia (comunque intesa
e denominata: dialettica dello Spirito verso il proprio autoriconoscimento,
evoluzione della Materia verso forme più complesse di esistenza, marcia
verso il comunismo eccetera. E in questo senso il concetto di progresso
costituisce veramente la sintesi e il suggello di tutta la mentalità del
secolo.
Questa costellazione di tratti tipico-ideali, che abbiamo esposto in
maniera volutamente formalizzata e generalizzata, acquistano tutta la loro
corporea concretezza in vari sistemi che studieremo. Infatti nei prossimi
capitoli li vedremo in atto, nelle loro espressioni più paradigmatiche, nei
romantici e nei filosofi dell'idealismo tedesco. In seguito continueremo
a trovare tracce consistenti della loro presenza in buona parte delle
sintesi dottrinali del secolo, dallo spiritualismo francese ed italiano al
positivismo. Segno evidente che l'arco di effetti del Romanticismo si
estende praticamente a tutto l'Ottocento (Cfr. G. Fornero, «Concetto e
critica del Romanticismo ottocentesco nel pensiero di Nicola Abbagnano»
in Rivista di storia della filosofia, terzo, 1984, pagine. 551-570, in cui
svolgiamo un'analisi dettagliata di questa tesi. Facciamo presente che
l'intepretazione del Romanticismo in termini di «spirito della filosofia
ottocentesca siluppata da Abbagnano sin dal Compendio di Storia della
filosofia, Paravia, Torino 1947 e dalla Storia della filosofia Utet,
Torino 1950, ed implicitamente presupposta, almeno in parte, anche da
altri autori, costituisce, di fatto, una delle proposte interpretative
più originali sviluppate nell'ambito della storiografia italiana ed estera
del nostro secolo.)
15. Figure del Romanticismo tedesco.
15.1. Hölderlin.
Una delle più significative personalità del romanticismo letterario è il
poeta Friedrich Hölderlin (1770-1843), che fu amico di Schelling e di
Hegel e ammiratore di Fichte.
L'Iperione.
Il suo romanzo Iperione, nel quale egli esprime i suoi ideali e le sue
convinzioni filosofiche, è la storia di un Greco moderno, che vive il
sogno dell'infinita bellezza e perfezione della Grecia antica. Egli trova
quella bellezza incarnata nella persona di una fanciulla di cui s'innamora,
Diotima; abbandona Diotima per tradurre in realtà il suo ideale di
perfezione spirituale e va a combattere per ricondurre la sua patria a
questo ideale. Ma incontra la sconfitta e la delusione; rinunzia allora
alla sua amata, si ritira nella solitudine, si pasce del suo sogno e finisce
per godere ed esaltare il suo stesso dolore. Già in questa trama l'Iperione
porta tutti i tratti della concezione romantica. Ma l'opera è disseminata
di considerazioni filosofiche che rivelano chiaramente l'influsso di Fichte
e Schelling. L'ideale ellenizzante di Iperione è in realtà l'ideale
romantico.
«Essere uno col tutto»
«Essere uno col tutto, questa è la vita degli dèi, e il cielo dell'uomo».
Questo tutto, che è uno, è l'infinito e vive e si rivela nell'uomo. Ma
l'uomo non può raggiungerlo soltanto col pensiero o con la ragione. Solo
la bellezza gli rivela l'infinito; e la prima figlia della bellezza è
l'arte, la seconda figlia è la religione, che è amore della bellezza.
La filosofia nasce dalla poesia perché solo attraverso la bellezza l'uomo
è in rapporto con l'Uno infinito. «La poesia è il principio e il termine
della filosofia. Come Minerva dal capo di Giove, la filosofia sorge dalla
poesia di un essere infinito, divino». «Dal solo intelletto non scaturisce
alcuna filosofia perché filosofia è più che non limitata conoscenza del
contingente. Dalla sola ragione non scaturisce alcuna filosofia, perché
filosofia è più che la cieca esigenza di un infinito progresso nella
sintesi o nell'analisi di una data materia». In queste parole il principio
dell'infinito di Fichte trova già la sua critica e la sua correzione
romantica. E si trova in Hölderlin l'altra caratteristica dello spirito
romantico: l'esaltazione del dolore. «Non deve tutto soffrire? Quanto più
è eccellente tanto più soffrire? Non soffre la sacra natura?... La volontà
che non soffre è sonno, e senza morte non vi è vita». Iperione finisce con
l'esaltare il suo stesso dolore. Per cui, quella conciliazione con il mondo
che Hegel realizza nella dialettica dell'Idea, Hölderlin la realizza nel
sentimento della bellezza infinita.
15.2. Schlegel.
La formazione del romanticismo letterario, nella sua derivazione
fichtiana, si può scorgere chiaramente nella figura di Friedrich Schlegel
(1772-1829). Infatti il concetto della poesia romantica, così come viene
espresso da Schlegel, non è altro che il trasferimento nel dominio della
poesia, considerata come mondo a sé, del principio fichtiano dell'infinito.
La poesia romantica come poesia infinita.
La poesia romantica è la poesia infinita. Essa è universale e progressiva.
«Il suo fine non è solo quello di riunire nuovamente i separati generi
poetici e di porre in contatto la poesia con la filosofia e con la
retorica. Essa vuole e deve anche, ora mescolare, ora combinare poesia e
prosa, genialità e critica, poesia d'arte e poesia ingenua, render viva e
sociale la poesia, poetica la vita e la società, poetizzare l'arguzia,
riempire e saturare le forme dell'arte col più vario e schietto materiale
di cultura e animarle con vibrazioni di humour». Identificata con
l'infinito, la poesia assorbe in sé tutto il mondo e si accolla i compiti
che appaiono frammentati e dispersi nei vari aspetti della cultura.
«Essa sola è infinita come essa sola è libera».
L'idea dell'infinito accomuna poesia, filosofia e religione in modo tale
che nessuna di queste attività può sussistere senza l'altra. « Poesia e
filosofia sono, secondo che s'intenda, sfere e forme diverse o anche i
fattori della religione. Provate infatti a congiungerle veramente insieme e
non otterrete altro che religione». Nel Dialogo sulla poesia, il romantico
è definito come «ciò che ci rappresenta una materia sentimentale in una
forma fantastica»: definizione in cui per sentimentale s'intende
soprattutto il movimento spirituale dell'amore. Il sentimento implica poi
un'altra cosa, che caratterizza la tendenza della poesia romantica:
l'indistinzione tra apparenza e verità, tra il serio e lo scherzoso.
Implica, in una parola, e giustifica, l'ironia.
Il Romanticismo fu in questa forma l'aspirazione degli anni giovanili di
Schlegel; dopo la morte di Novalis, egli si andò sempre più avvicinando al
cattolicesimo e intese di fare della sua filosofia una difesa della
rivelazione, della Chiesa e dello Stato. Nelle Lezioni sulla filosofia
della vita (1828) e nelle Lezioni sulla filosofia della storia (1829), egli
riconosce come principio del sapere la rivelazione che Dio fa di sé nel
mondo della natura, nel mondo della storia, e nelle Sacre Scritture.
L'unità del finito e dell'infinito veniva da Schlegel, in quest'ultima
fase della sua speculazione, intesa come rivelazione dell'infinito nel
finito, e questo concetto doveva acquistare, nell'ulteriore sviluppo
dello spirito romantico, una sempre maggiore importanza.
15.3. Novalis.
Assieme a Friedrich Schlegel, Tieck e Novalis sono gli araldi del
Romanticismo letterario. Ludwig Tieck (1773-1853) fu poeta e letterato e
rappresentò nei personaggi dei suoi romanzi lo spirito del Romanticismo.
L'ironia trova nel suo William Loveel la sua più risoluta incarnazione.
«Noi siamo, egli dice, il destino che regge il mondo». Questa concezione
dell'uomo come di un mago evocatore di mondi, creatore e annientatore della
realtà, trova la sua migliore espressione nell'opera di Friedrich von
Hardenberg, detto Novalis (1772-1801). In un romanzo, Heinrich von
Hofterdingen, in un altro romanzo rimasto incompiuto, I discepoli di
Sais, e nei Frammenti, di cui alcuni furono pubblicati nell'«Athenaeum »,
Novalis celebra con parole entusiastiche il potere infinito dell'uomo sul
mondo. Come Schlegel, egli prende le mosse da Fichte; ma si rifiuta di
riconoscere al non-io un qualsiasi potere sull'io. «Agli uomini, egli dice,
nessuna cosa è impossibile: quello che io voglio lo posso». Il mondo è
infatti per Novalis «un indice enciclopedico e sistematico del nostro
spirito, una metafora universale, un'immagine simbolica di esso». Esso ha
quindi un'originaria capacità ad essere vivificato dallo spirito. «Esso è
vivificato da me a priori, è tutta una cosa con me, e io ho una tendenza
e una capacità originaria di vivificarlo». Questa vivificazione del
mondo è la trasformazione del sistema della natura nel sistema della
morale, trasformazione di cui l'uomo è l'autore. «Il sentimento morale,
dice Novalis, è in noi il sentimento della potenza assoluta di creare,
della libertà produttiva, della personalità infinita del microcosmo,
della divinità propriamente detta in noi».
«L'idealismo magico».
Questo dilatarsi dell'uomo sino all'infinito, questo suo trasformarsi in
volontà infinita creatrice della natura e onnipotente, è il fondamento
dell'idealismo magico di Novalis. Mago infatti è colui che sa dominare la
natura sino al punto da farla servire ai suoi fini arbitrari. Questo è il
punto a cui, secondo Novalis, l'uomo può giungere mediante la poesia.
15.4. Schleiermacher.
Il concetto della religione viene elaborato nello spirito del
Romanticismo da Friedrich Schleiermacher (1768-1834), che fu predicatore
e professore di teologia a Berlino, e autore dei Discorsi sulla
religione (1799), dei Monologhi (1800), nonché di un'opera sulla Fede
cristiana, di Prediche e di scritti di morale e di dialettica. Egli
inoltre tradusse in tedesco i dialoghi di Platone.
L'autonomia della religione.
Schleiermacher difende l'originalità e l'autonomia della religione nei
confronti delle altre forme della vita spirituale. La religione non è
la moralità, perché anche chi non è religioso puo essere morale.
Non è sapere, perché la misura del sapere non è la misura della santità.
Essa è piuttosto un sentimento: è «la coscienza immediata che ogni essere
finito è nell'Infinito e attraverso l'Infinito, che ogni essere temporale
è nell'Eterno e attraverso l'Eterno».
Così Schleiermacher riconosce l'essenza della religiosità in quell'unità del
finito e dell'infinito, che era l'aspirazione dominante del Romanticismo.
Il sentimento di dipendenza dall'infinito.
Col sentimento dell'unità con l'infinito è legato quello della
dipendenza dall'infinito. Quel sentimento implica quindi la stretta
connessione tra Dio e il mondo, al quale noi apparteniamo. Dio e il
mondo non sono, secondo Schleiermacher, né identici né separati. Dio non
può essere senza il mondo né il mondo senza Dio. Perciò Dio può essere
solo raggiunto attraverso le cose che ne dipendono, e un'immediata
intuizione di lui, come il miracolo, non è possibile. La religione vera
pone dunque capo al panteismo; e non riconosce a Dio l'attributo della
personalità. Di questa religione, le religioni positive sono aspetti
parziali e più o meno incompiuti.
L'unità del finito e dell'infinito, che è propria della religione, non
conduce, per Schleiermacher, all'annullamento della personalità umana
come tale. L'individuo, la persona, è, esso stesso, l'infinito. Nei
Monologhi egli riconosce in ciascun individuo un'espressione e uno
specchio dell'universo e pone il più alto compito morale nello sviluppo
dell'individualità personale. «Diventare sempre di più ciò che sono
questa è la mia propria volontà». Ora la più alta rappresentazione
dell'individualità è l'arte, e segnatamente il romanzo. Questo esprime nel
modo più compiuto la natura interiore dell'artista. Schleiermacher
giustificava così pienamente la tipica forma d'arte del Romanticismo.
Schleiermacher è importante non solo per la sua teoria della religione,
ma anche per la storia dell'ermeneutica (cfr., a questo proposito, il
capitolo sull'ermeneutica).
Indicazioni bibliografiche:
Opere di carattere generale in cui si trovano anche esaurienti profili
di singoli autori:
O. Walzel, Il Romanticismo tedesco, Vallecchi, Firenze 1924.
V. S. Lupi, Il Romantuismo tedesco, Sansoni, Firenze 1933.
A. Farinelli, Il romanticismo in Germania, Bocca, Milano 1945.
M. Vinciguerra, Il romanticismo, Laterza, Bari 1947.
L. Mittner, Ambivalenze romantiche. Studi sul romanticismo tedesco, D'Anna,
Messina-Firenze 1954.
A. Pupi, Alle soglie dell'età romantica, Vita e Pensiero, Milano 1962.
B. Magnino, Romanticismo e Cristianesimo, La Scuola, Brescia 1963.
M. Puppo, Il romanticismo, Studium, Roma 1963.
L. Mittner, Storia della letteratura tedesca. Dal Pietismo al Romanticismo
(1700-1820), Einaudi, Torino 1964.
R. Haym, Il Romanticismo tedesco, Ricciardi, Milano-Napoli 1965 (edizione
originale 1870).
N. Hartmann, La filosofia dell'idealismo tedesco, Mursia, Milano 1972
(edizione originale 1923-1929).
P. Szondi, Poetica dell'idealismo tedesco, Einaudi, Torino 1974.
L. Marino, I maestri della Germania, Einaudi, Torino 1975.
H. M. Abrams, Lo specchio e la lampada. La teoria romantica e la
tradizione critica, Il Mulino, Bologna 1976.
L. Formigari, La logica del pensiero vivente. Il linguaggio nella filosofia
della «Romantik», Laterza, Bari 1977.
U. Cardinale (a cura di), Problemi del romanticismo, Shakespeare and
Company, Milano 1983.
S. Givone, Ermeneutica e romanticismo, Mursia, Milano 1983.
Autori Vari, Mito e utopia nel romanticismo tedesco (a cura di M. Freschi),
Aion, Napoli 1984.
M. Cometa, Iduna. Mitologie della ragione, Novecento, Palermo 1984.
A. De Paz, La rivoluzione romantica, Liguori, Napoli 1984.
G. Moretti, Heidelberg romantica, Itinerari, Lanciano 1984.
L. Zagari, Mitologia del segno vivente. Una lettura del romanticismo
tedesco, Il Mulino, Bologna 1985.
Autori vari, Figure del romanticismo (a cura di M. Cottone), Marsilio,
Venezia 1987.
R. Bodei, Scomposizioni. Forme dell'individuo moderno, Einaudi, Torino 1987.
A. De Paz, Il romanticismo europeo, Liguori, Napoli 1987.
P. Quaglia, Invito a conoscere il Romanticismo, Mursia, Milano 1987.
S. Zecchi, Romanticismo, Unicopli, Milano 1987.
STORIA DELLA FILOSOFIA
di Nicola Abbagnano
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
VOLUME TERZO
PARTE SECONDA: L'IDEALISMO ROMANTICO TEDESCO
CAPITOLO 3: DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO
"Intendere ciò che è, è il compito della filosofia, poiché ciò che è, è
la ragione". (Hegel)
1. I critici immediati di Kant e il dibattito sulla " cosa in sé".
La massima incarnazione del Romanticismo filosofico è l'idealismo che,
infrangendo i limiti conoscitivi posti da Kant, inaugura una nuova metafisica
dell'infinito.
Reinhold, Schulze, Maimon e Beck.
Sebbene nasca solo con Fichte, l'idealismo risulta
preparato dai cosiddetti seguaci immediati di Kant, ossia da quel gruppo
di pensatori, da Reinhold (1758 -1823) a Schulze (1761-1833), da Maimon
(1753-1800) a Beck (1761-1840), che criticano i dualismi lasciati dal
criticismo, cercando di trovare un principio unico sulla Maimon e Beck
cui base fondare una nuova, salda filosofia. In particolare, tali
studiosi appuntano le loro critiche su quel dualismo di tutti i dualismi
che è la distinzione tra fenomeno e noumeno.
Critica della "cosa in sé"
Partendo dalla presunta " contraddizione " di base di Kant, che avrebbe
dichiarato esistente, e al tempo stesso inconoscibile, la cosa in sé,
essi prendono di mira soprattutto quest'ultimo concetto,
giudicandolo filosoficamente inammissibile. Tant'è vero
che Jacobi, sin dal saggio Sull'idealismo trascendentale (1787), e in
scritti successivi, insinua che quello di noumeno è un presupposto
"realistico", senza di cui non è possibile entrare nel regno del
criticismo, ma con il quale non è possibile rimanerci concludendo o il
criticismo è vero, e allora bisogna abolire la cosa in sé e ricondurre
tutto al soggetto, o il criticismo è falso, e allora si deve ammettere
la cosa in sé e tornare al realismo.
Al di là delle loro specifiche posizioni e dottrine speculative, il
ragionamento generale cui pervengono i critici immediati di Kant è il
seguente: ogni realtà di cui siamo consapevoli esiste come
rappresentazione della coscienza, la quale ultima funge, a sua volta, da
condizione indispensabile del conoscere. Ma se l'oggetto risulta
concepibile solo in relazione ad un soggetto che lo rappresenta, come
può venir ammessa l'esistenza di una cosa in sé, ossia di una realtà non
pensata e non pensabile, non rappresentata e non rappresentabile?
Evidentemente la cosa in sé, dal punto di vista di questo tipo di
argomentazioni, non può configurarsi che come un concetto impossibile,
simile, come dirà Maimon, ad una grandezza matematica quale: radice
quadrata di -a.
Si osservi come agli occhi di questi critici il kantismo tenda a
configurarsi come una forma di idealismo coscienzialistico basato sulla
doppia riduzione del fenomeno a rappresentazione e della
rappresentazione a coscienza. Questa interpretazione trova vistosi
agganci soprattutto nella prima edizione della Critica della ragion
pura, in cui Kant, nella Deduzione trascendentale:
1)- parla come di " un semplice gioco delle nostre rappresentazioni, che
si riducono infine a determinazione del senso interno", e quindi come di
un'idea o di una rappresentazione in senso cartesiano-berkeleyano, la cui
realtà consiste solo nell'essere pensata, e
2)- discorre della cosa in sé come di un "oggetto della rappresentazione ".
Differenze in Kant fra la prima e la seconda edizione della Ragion pura.
Che questo fosse davvero il punto di vista di Kant, appare oggi, sulla
scorta di una più approfondita conoscenza filosofica e critica della Ragion
pura, quasi sicuramente da escludere. Infatti nella seconda edizione della
Critica, Kant, soprattutto in taluni passi decisivi della Deduzione
trascendentale, identifica il fenomeno non con la "rappresentazione" ma
con "l'oggetto della rappresentazione", e parla del noumeno come di un
semplice concetto-limite, facendo intendere che il fenomeno, dal punto
di vista criticistico, non è una rappresentazione o un'idea, che giace dentro
la coscienza, ma un oggetto reale, anche se appreso tramite il corredo
mentale delle forme a priori, in virtù delle quali esso risulta appunto un
"fenomeno". Ma poiché in Kant questo punto di vista non viene difeso in modo
organico ed esplicito, anzi coesiste equivocamente (nella prima edizione
della Critica, ma anche nella seconda) con un apparato terminologico
coscienzialistico e cartesiano, si spiega la "lettura" in chiave
tendenzialmente berkeleyana della sua opera, sebbene in Kant stesso si trovi
un'esplicita "confutazione dell'idealismo"
(Questo discorso sull'interpretazione idealistico-coscienzialistica del
criticismo (la quale ha informato di sé non solo le correnti idealistiche,
ma anche quelle neocriticistiche) è tratto da appunti (inediti) dei corsi
accademici su Kant tenuti da Abbagnano, il quale è andato elaborando, sin
dagli anni Quaranta, una precisa visione anti-idealistica del criticismo,
cui si sono ispirati altri studiosi, primo fra tutti Pietro Chiodi,
contribuendo in tal modo alla liberazione della cultura italiana dal
" monopolio " della lettura idealistica di Kant attuata dal Gentile (presente
anche nella sua traduzione laterziana della Critica della Ragion pura, cui
P. Chiodi ha contrapposto la propria traduzione, anti-idealistica presso
la Utet).
Presunta auto-contradditorietà del concetto di cosa in sé.
Un altro appunto mosso a Kant, anche questo risalente a Jacobi, consiste nella
tesi secondo cui il filosofo, asserendo che la cosa in sé è causa delle nostre
sensazioni, si sarebbe contraddetto, applicando il concetto di causa ed
effetto, valido soltanto per il fenomeno, al noumeno stesso.
Anche in questo caso la questione risulta più complessa di quanto apparve a
questi primi studiosi, poiché in Kant, accanto alla rappresentazione
"realistica " del noumeno, inteso come realtà fungente da causa produttrice
delle impressioni, abbiamo anche una rappresentazione più criticistica
e guardinga, secondo cui il noumeno, per noi, non costituisce una realtà cui
applicare delle categorie, ma un semplice memento critico, o un " promemoria
trascendentale ", il quale ci ricorda costantemente che l'oggetto ci è dato
(e non creato) attraverso una rete di forme a priori. In questo senso, la
cosa in sé, invece di essere una corposa realtà, si configura piuttosto,
secondo quanto si dice nell'Opus postumum, come "un puro pensiero senza
realtà" (Gedankending ohne Wirklichkeit), ossia come un ens rationis
(Cfr. Volume 2, capitolo 26, paragrafo 11.5, e soprattutto la Storia della
Filosofia della Utet, capitolo 15, paragrafo 522)
rationis (2).
Dalla gnoseologia alla metafisica.
Nonostante questa serie di critiche, volte a demolire la nozione di cosa in
sé, i seguaci immediati di Kant si muovono ancora in un orizzonte
prevalentemente gnoseologico, non ancora sistematicamente incentrato sulla
tesi metafisica di un io creatore ed infinito. Questo passaggio, che coincide
con la nascita dell'idealismo, è opera di Fichte.
2. L'idealismo romantico tedesco.
2.1. Significati del termine "idealismo".
La parola "idealismo" presenta una varietà di significati. Nel linguaggio
comune si denomina idealista colui che è attratto da determinati "ideali"
o "valori" - etici, religiosi, conoscitivi, politici ecc. - e che sacrifica
per essi la propria vita (in questo senso si dice ad esempio che Mazzini e i
mazziniani erano "idealisti").
Accezioni filosofiche del termine idealismo.
In filosofia, invece, si parla di "idealismo", in senso lato, a
proposito di quelle visioni del mondo, come ad esempio il platonismo e
il cristianesimo, che privilegiano la dimensione "ideale" su quella
"materiale" e che affermano il carattere "spirituale" della realtà
"vera". In questo senso il termine idealismo viene introdotto nel
linguaggio filosofico verso la metà del Seicento e viene usato
soprattutto in riferimento al platonismo e alla sua teoria delle "idee"
(vedi vololume 1). Sebbene, in seguito, sia stata usata anche da altri (da
Dilthey ai marxisti sovietici), quest'accezione di idealismo non ha avuto
molta fortuna. Infatti, in filosofia, la parola è usata prevalentemente
per alludere:
1) alle varie forme di idealismo gnoseologico;
2) all'idealismo romantico o assoluto.
L'idealismo gnoseologico.
Per idealismo gnoseologico si intendono tutte quelle posizioni di
pensiero che finiscono per ridurre l'oggetto della conoscenza a idea o
rappresentazione.
In questa accezione, il termine idealismo serve a raccogliere, a torto o
a ragione, tutte quelle dottrine (da Cartesio a Berkeley, da Kant ai
neocriticisti) per le quali vale in qualche modo la tesi, enunciata da
Schopenhauer, secondo cui "il mondo è la mia rappresentazione".
L'idealismo romantico.
Nel secondo senso, l'idealismo costituisce il nome della grande corrente
filosofica post-kantiana che si originò in Germania nel periodo romantico
e che ha avuto numerose ramificazioni nella filosofia moderna e
contemporanea di tutti i paesi. Dai suoi stessi fondatori, Fichte e
Schelling, questo idealismo fu chiamato "trascendentale" o "soggettivo"
o "assoluto". L'aggettivo trascendentale tende a collegarlo con il punto
di vista kantiano, che aveva fatto dell'" io penso " il principio
fondamentale della conoscenza. La qualifica di soggettivo tende a
contrapporre questo idealismo al punto di vista di Spinoza, che aveva
bensì ridotto la realtà ad un principio unico, la Sostanza, ma aveva
inteso la Sostanza stessa in termini di oggetto o di natura. Infine
l'aggettivo assoluto mira e sottolineare la tesi che l'Io o lo Spirito è
il principio unico di tutto e che fuori di esso non c'è nulla. Ed è
proprio di questa affermazione chiave dell'idealismo romantico che
intendiamo occuparci adesso, mostrandone la genesi e i significati.
2.2. Dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell'idealismo.
Come si è visto (cfr. volume 2), in Kant l'io era qualcosa di finito, in
quanto non creava la realtà, ma si limitava ad ordinarla secondo proprie
forme a priori. Per questo, sullo sfondo dell'attività dell'io si
stagliava il concetto di cosa in sé, ossia di una ics ignota, che il
filosofo della Critica aveva ammesso per spiegare la recettività del
conoscere e la presenza di un dato di fronte all'io. I seguaci immediati
di Kant (vedi parte 1 di questo capitolo) avevano messo in discussione la
cosa in sé, ritenendola gnoseologicamente e criticamente inammissibile.
L'abolizione della cosa in sé e l'infinitizzazione dell'io.
L'idealismo sorge allorquando Fichte, spostando il discorso dal piano
gnoseologico (o di dottrina del conoscere) al piano metafisico (o di
dottrina dell'essere), abolisce lo "spettro" della cosa in sé, ovvero la
nozione di qualsivoglia realtà estranea all'io, che in tal modo diviene
un'entità creatrice ( = fonte di tutto ciò che esiste) ed
infinita ( = priva di limiti esterni). Da ciò la tesi tipica dell'idealismo
tedesco, secondo cui "tutto è Spirito".
Inche senso "Tutto è Spirito".
Per comprendere adeguatamente tale affermazione, che rappresenta il cuore
genetico e strutturale di tutto l'idealismo post-kantiano bisogna tener
presente che con il termine "Spirito" (o con i sinonimi "Io", "Assoluto",
"Infinito" ecc.) Fichte intende, in ultima istanza, la realtà umana,
considerata come attività conoscitiva e pratica e come libertà creatrice
(Quando si afferma che per Fichte e per gli idealisti lo Spirito coincide
con l'Umanità, non si intende quest'ultima come razza biologgica particolare,
ma come un'entità autocosciente, razionale e libera, che potrebbe anche
esistere in altre zone dell'universo. Infatti, per gli idealisti, vi è
spirito là dove c'è intelligénza e libertà).
Questa puntualizzazione preliminare lascia tuttavia irrisolti due
quesiti di base, che tendono ad affacciarsi alla mente di chi affronta per
la prima volta lo studio dell'idealismo:
1) in che senso lo Spirito e quindi il soggetto conoscente ed agente,
rappresenta la fonte creatrice di tutto ciò che esiste?;
2) Che cos'è dunque, per gli idealisti, la Natura o la materia?
La risposta a questi due problemi interconnessi risiede innanzitutto nel
conto di dialettica, cioè in quella concezione secondo cui non essendoci
mai, nella realtà, il positivo senza il negativo, la tesi senza l'antitesi,
lo Spirito, proprio per essere tale, ha "bisogno" di quella sua antitesi
vivente che è la Natura. Infatti, argomenta l'idealismo, poiché un soggetto
senza oggetto, un io senza non-io, un'attività senza ostacolo, sarebbero
entità vuote ed astratte, e quindi impossibili. Di conseguenza, mentre le
filosofie naturalistiche e materialistiche avevano sempre concepito la
Natura come causa dello spirito, asserendo che l'uomo è un prodotto o un
effetto di essa, Fichte, capovolgendo tale prospettiva, dichiara che è
piuttosto lo Spirito ad essere causa della natura, poiché quest'ultima esiste
solo per l'io ed in funzione dell'io, essendo semplicemente il materiale o la
scena della sua attività, ossia il polo dialettico del suo essere.
La Natura come momento dialettico necessario alla vita dello Spirito.
In altri termini, per Fichte:
1) lo Spirito crea la realtà nel senso che l'uomo rappresenta la ragion
d'essere dell'universo, che in esso trova appunto il suo scopo;
2) la Natura esiste non come realtà a sé stante, ma come momento dialettico
necessario della vita dello Spirito. Queste due tesi di fondo dell'intuizione
idealistica del mondo trovano una sorta di esemplificazione artistica nel
racconto di Novalis I discepoli di Sais, dove, nelle aggiunte finali, si dice
che:
"Accadde ad uno
di alzare il velo della dea di Sais.
Ma cosa vide? Egli vide
- meraviglia delle meraviglie - se stesso".
Secondo l'interpretazione idealistica, la dea velata sarebbe il simbolo
del mistero dell'universo; quell'uno che giunge a scoprirla è il filosofo
idealista, che dopo una lunga ricerca si rende conto che la chiave di
spiegazione di ciò che esiste, vanamente cercata dai filosofi fuori
dell'uomo, ad esempio in un Dio trascendente o nella natura, si trova invece
nell'uomo stesso, ovvero nello Spirito.
L'uomo è Dio.
Ma se l'uomo è la ragion d'essere e lo scopo dell'universo, che sono gli
attributi fondamentali che la filosofia occidentale ha riferito alla
divinità, vuol dire che egli coincide con l'Assoluto e con l'Infinito, cioè
con Dio stesso (e questo ci serve a capire, tra l'altro, perché gli idealisti
scrivano le parole Io o Spirito con le lettere maiuscole e perché l'idealismo
romantico sia definito idealismo "assoluto").
A questo punto risultano evidenti anche i rapporti che uniscono e dividono
l'idealismo dalla tradizione ebraico-cristiana. Gli idealisti pensano
anch'essi, da un lato, che l'uomo sia il " re del creato ", ossia per usare
ancora una volta un'immagine di Novalis, che la natura sia
"l'impietrita città magica, di cui l'uomo è il messia".
Tuttavia l'idealismo tedesco, laicizzando il biblico "Dio creò i cieli e
la terra per l'uomo", conclude che l'uomo stesso è Dio. Tant'è vero che la
figura classica di un Dio trascendente e staticamente perfetto, per il
primo Fichte, è solo una "ciarla scolastica" o una "chimera", in quanto
presupporrebbe l'esistenza di un positivo senza il negativo. Invece, per
gli idealisti, l'unico Dio possibile è lo Spirito dialetticamente inteso,
ovvero il soggetto che si costituisce tramite l'oggetto, la libertà che
opera attraverso l'ostacolo, l'io che si sviluppa attraverso il non-io.
Panteismo, spiritualismo e monismo dialettico.
Per cui, con l'idealismo ci troviamo di fronte, per la prima volta nella
storia del pensiero, ad una forma di panteismo spiritualistico (= Dio è
lo Spirito operante nel mondo, cioè l'uomo), che si distingue sia dal
panteismo naturalistico (= Dio è la Natura), sia dal trascendentismo di
tipo ebraico e cristiano (= Dio è una Persona esistente fuori dell'universo).
Come tale, l'idealismo è anche una forma di monismo dialettico (= esiste
un'unica sostanza: lo Spirito, inteso come realtà positiva realizzante se
medesimo attraverso il negativo: la natura, il non-io ecc.). Monismo che si
contrappone a tutti i dualismi metafisici e gnoseologici della storia del
pensiero, dai greci a Kant (Spirito e Natura, Dio e mondo, soggetto ed
oggetto, libertà e necessità, fenomeno e cosa in sé...).
Pur essendo d'accordo sull'interpretazione della realtà mediante le categorie
di Spirito e di Infinito, gli idealisti (Fichte, Schelling ed Hegel) si
differenziano fra di loro, come vedremo in dettaglio nei prossimi capitoli,
per la specifica maniera di intendere l'Infinito e i suoi rapporti con il
finito (la natura e la storia). Inoltre, Fichte e Schelling, ad un certo
sviluppo del loro pensiero, si allontanano, almeno in parte, dalle originarie
tesi idealistiche, elaborando dei nuovi organismi sistematici che pervengono
talora ad un recupero, sia pure originale e creativo, di schemi metafisici
della tradizione. L'incarnazione più tipica, coerente e storicamente decisiva
dell'idealismo tedesco, è invece rappresentata da Hegel.
Indicazioni Bibliografiche:
N. Hartmann, La filosofia dell'idealismo tedesco, Mursia, 1972
Per i singoli autori dell'idealismo si vedano i capitoli seguenti.
STORIA DELLA FILOSOFIA
di Nicola Abbagnano
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
VOLUME TERZO
CAPITOLO QUARTO: Fichte
1. La vita.
Johann Gottlieb Fichte nacque a Rammenau il 19 maggio 1762 da famiglia
poverissima. Compì i suoi studi di teologia a Jena e a Lipsia lottando
con la miseria. Fece poi il precettore in case private in Germania e a
Zurigo, dove conobbe Johanna Rahn che in seguito divenne sua moglie (1793).
Nel 1790, Fichte ritornò a Lipsia; e qui venne per la prima
volta in contatto con la filosofia di Kant che decise della sua
formazione filosofica.
La «scoperta» di Kant.
« Io vivo in un mondo nuovo, scriveva entusiasticamente in una lettera,
dacché ho letto la Critica della ragion pratica. Princìpi che credevo
inconfutabili mi sono stati smentiti; cose che io non credevo potessero
mai essere dimostrate, per esempio il concetto dell'assoluta libertà,
del dovere eccetera, mi sono state dimostrate ed io mi sento per
ciò assai più contento. è inconcepibile quale rispetto per l'umanità, quale
forza, ci dà questo sistema».
L'anno dopo, il 1791, Fichte si reca a Königsberg per far leggere a Kant
il manoscritto della sua prima opera, Ricerca di una critica di ogni
rivelazione. Lo scritto è composto interamente nello spirito del
kantismo, sicché quando comparve anonimo nel 1792 fu scambiato per uno
scritto di Kant; e Kant intervenne a rivelare il vero nome dell'autore.
Ma nello stesso 1791, mentre a Danzica Fichte attendeva a stendere una
difesa degli editti del governo prussiano che limitavano la libertà di
stampa e istituivano la censura, gli fu rifiutato il nullaosta per la
stampa della sua Ricerca; e mesi dopo fu rifiutata anche la pubblicazione
della seconda parte della Religione entro i limiti della ragione di Kant.
Indignato, Fichte passò immediatamente dalla difesa del
regime paternalistico alla difesa della libertà; e pubblicava anonima
una Rivendicazione della libertà di pensiero (1793).
Nel 1794 Fichte divenne professore a Jena e vi rimase fino al 1799.
Appartengono a questo periodo le opere cui è dovuta limportanza storica
della sua speculazione (Dottrina della scienza, Dottrina morale,
Dottrina del diritto) .
La polemica sull'ateismo.
Nel 1799 scoppiò la cosiddetta «polemica sull'ateismo» che doveva condurre
all'allontanamento di Fichte dalla cattedra.
In seguito ad un articolo pubblicato nel «Giornale filosofico» di Jena
Sul fondamento della nostra credenza nel governo divino del mondo (1798),
il quale identificava Dio con l'ordine morale nel mondo,
Fichte fu accusato di ateismo in un libello anonimo. Il governo
prussiano proibì il giornale e chiese al governo di Weimar di punire
Fichte e il direttore del giornale, Forberg, con la minaccia che in
mancanza avrebbe proibito ai suoi sudditi la frequenza dell'Università di
Jena. Il governo di Weimar avrebbe voluto che il Senato accademico
formulasse un rimprovero almeno formale contro il direttore del
giornale. Ma Fichte venuto a conoscenza di questo progetto scriveva il
22 marzo 1799 una lettera altezzosa a un membro del governo, avvertendo che
se il rimprovero fosse stato formulato si sarebbe congedato dall'Università
e aggiungendo la minaccia che in questo caso anche altri professori
avrebbero lasciato con lui l'Università. In seguito a questa lettera il
governo di Jena col parere favorevole di Goethe (che si dice abbia detto
in questa occasione: «Un astro tramonta, un altro ne nasce»), invitò Fichte
a dare le dimissioni nonostante che nel frattempo egli avesse lanciato un
Appello al pubblico e nonostante una petizione degli studenti in suo favore.
Gli professori rimasero al loro posto.
Il periodo berlinese.
Allontanatosi da Jena, Fichte si recò a Berlino dove strinse rapporti con i
romantici Friedrich Schlegel, Schleiermacher, Tieck. Nominato professore
a Erlangen nel 1805, si recò a Königsberg al momento dell'invasione
napoleonica e di lì ritornò a Berlino dove pronunciò, mentre la città era
ancora occupata dalle truppe francesi, i Discorsi alla nazione
tedesca (1807-1808): nei quali additava, come mezzo di risollevamento
della nazione germanica dalla servitù politica, una nuova forma di
educazione e affermava il primato del popolo tedesco. In seguito fu
professore a Berlino e rettore di quella Università. Morì il
29 gennaio 1814 per una febbre infettiva contagiatagli dalla moglie, che
l'aveva contratta curando i soldati feriti.
La caratteristica della personalità di Fichte è costituita dalla forza
con cui egli sentì l'esigenza dell'azione morale. Fichte stesso dice
di sé: « Io ho una sola passione, un solo bisogno, un solo sentimento pieno
di me stesso: agire fuori di me. Più agisco, più mi sento felice».
Nella seconda fase, all'esigenza dell'azione morale si sostituisce quella
della fede religiosa; e la dottrina della scienza vien fatta servire a
giustificare la fede. Ma da un capo all'altro della sua speculazione e
nella stessa frattura dottrinale che questa speculazione presenta nelle
sue fasi principali, Fichte appare come una personalità etico-religiosa.
L'interesse etico-religioso.
«Io sono chiamato, egli scrive, a rendere testimonianza alla verità... Io
sono un prete della verità; sono al suo soldo, mi sono obbligato a fare
tutto, ad arrischiare tutto, a soffrire tutto per essa».
2. Gli scritti.
La vocazione filosofica di Fichte è stata, come si è detto, occasionata
dagli scritti di Kant. Ma Fichte si è fermato assai poco agli insegnamenti
del maestro. Kant aveva voluto costruire una filosofia del finito; Fichte
vuol costruire una filosofia dell'infinito: dell'infinito che è nell'uomo,
che è, anzi, l'uomo stesso.
I primi scritti.
L'influenza kantiana si può scorgere solo nel primo periodo della sua
attività letteraria: periodo al quale appartengono la Ricerca di una
critica di ogni rivelazione (1793), la Rivendicazione della libertà di
pensiero dai Prìncipi di Europa che l'hanno finora oppressa (1792), il
Contributo alla rettifica del giudizio pubblico sulla rivoluzione
francese (1793), e pochi scritti minori. La Critica di ogni rivelazione
è scritta interamente nello spirito del kantismo. La rivelazione è
possibile, ma non è dimostrabile, e può quindi solo essere oggetto di
una fede, che tuttavia non deve mancare a nessuno.
Il distacco dal kantismo è già chiaro nella Recensione all'Enesidemo di
Schulze, che Fichte pubblicò nel 1794. In essa, egli dichiara che la cosa
in sé è «un ghiribizzo, un sogno, un non pensiero» e stabilisce i princìpi
della sua dottrina della scienza.
Le opere della maturità.
A questa recensione seguì un lungo saggio Sul concetto della dottrina
della scienza o della cosiddetta filosofia (1794) e l'opera fondamentale
di questo periodo Fondamenti di tutta la dottrina della scienza, che Fichte
pubblicò come «manoscritto per i suoi uditori» nello stesso anno 1794.
Seguirono: Schizzo delle proprietà della dottrina della scienza rispetto
alle facoltà teoretiche (1795); Prima introduzione alla dottrina della
scienza (1797); Seconda introduzione alla dottrina della scienza (1797);
Ricerca di una nuova rappresentazione della dottrina della scienza (1797);
che sono esposizioni e rielaborazioni più brevi. Nello stesso tempo Fichte
estendeva i suoi princìpi al dominio dell'etica, del diritto e della
politica; e pubblicava nel 1796 i Fondamenti del diritto naturale
secondo i princìpi della dottrina della scienza; nel 1798 il Sistema
della dottrina morale secondo i princìpi della dottrina della scienza;
nel 1800 Lo Stato commerciale chiuso; e alcuni scritti morali minori:
Sulla dignità degli uomini (1794); Lezioni sulla missione del dotto (1794).
L'ultimo Fichte.
Nel frattempo Fichte veniva lentamente modificando i capisaldi della sua
filosofia e di qui nascevano le nuove esposizioni della
dottrina della scienza che egli dava nei corsi universitari del 1801,
1804, 1806, 1810, 1812, 1813; nonché nei corsi su I fatti della coscienza
(1810, 1811, 1813) e nelle sue rielaborazioni del Sistema della dottrina
del diritto (1812) e Sistema della dottrina morale (1812). Questi
corsi e lezioni rimasero inediti e furono pubblicati dal figlio
(I. H. Fichte) dopo la sua morte. Tuttavia l'indirizzo che essi
rappresentano trova riscontro nelle esposizioni popolari della sua
filosofia che Fichte pubblicava contemporaneamente alla loro
composizione: La missione degli uomini (1800); Introduzione alla vita
beata (1806); Tratti fondamentali dell'epoca presente (1806).
3. L'infinità dell'Io.
Da Kant a Fichte.
Kant aveva riconosciuto nell'io penso il principio supremo di tutta la
conoscenza. Ma l'io penso è un atto di autodeterminazione esistenziale,
che suppone già data l'esistenza; è quindi attività («spontaneità» dice
Kant), ma attività limitata e il suo limite è costituito dall'intuizione
sensibile. Nell'interpretazione data al kantismo da Reinhold nasce il
problema dell'origine del materiale sensibile. Schulze, Maimon e Beck
hanno dimostrato impossibile la derivazione di esso dalla cosa in sé ed
hanno anzi dichiarata chimerica la stessa cosa in sé in quanto esterna
alla coscienza e indipendente da essa. Maimon e Beck avevano quindi già
tentato di attribuire all'attività soggettiva la produzione del materiale
sensibile e di risolvere nell'io l'intero mondo della conoscenza.
Fichte trae per la prima volta le conseguenze di queste premesse. Se l'io
è l'unico principio, non solo formale ma anche materiale del conoscere,
se alla sua attività è dovuto non solo il pensiero della realtà
oggettiva, ma questa realtà stessa nel suo contenuto materiale, è
evidente che l'io è non solo finito, ma infinito.
L'infinitizzazione dell'io.
Tale è il punto di partenza di Fichte. Il quale è il filosofo
dell'infinità dell'Io, della sua assoluta attività e spontaneità, quindi
della sua assoluta libertà.
La deduzione assoluta.
La deduzione di Kant è una deduzione trascendentale, cioè diretta a
giustificare la validità delle condizioni soggettive della conoscenza.
La deduzione di Fichte è una deduzione «assoluta» o metafisica, perché
deve far derivare dall'Io sia il soggetto sia l'oggetto del conoscere.
La deduzione di Kant mette capo ad una possibilità trascendentale
(tale è appunto l'io penso) che implica sempre un rapporto tra l'io
e l'oggetto fenomenico. La deduzione di Fichte mette capo ad un
principio assoluto, che pone o crea il soggetto e l'oggetto
fenomenici in virtù di un'attività creatrice, cioè di un'intuizione
intellettuale (cfr. il Glossario). La Dottrina della scienza ha lo scopo
di dedurre da questo principio l'intero mondo del sapere; e di dedurlo
necessariamente, in modo da dare il sistema unico e compiuto di esso.
Non deduce tuttavia il principio stesso della deduzione, che è l'Io.
E il problema in cui urta è appunto quello che verte sulla natura dell'Io.
Le successive elaborazioni della Dottrina della scienza si differenziano
sostanzialmente nel rapporto che stabiliscono tra l'infinito e l'uomo.
4. La «Dottrina della scienza » e i suoi tre princìpi.
L'ambizione di Fichte è di costruire un sistema grazie al quale la
filosofia, cessando di essere semplice ricerca del sapere (secondo
l'etimologia greca del termine), divenga finalmente un sapere assoluto e
perfetto. Infatti il concetto della Dottrina della scienza è quello di una
scienza della scienza, cioè di un sapere che metta in luce il principio su
cui si fonda la validità di ogni scienza e che a sua volta si fondi, quanto
alla sua validità, sullo stesso principio.
L'Io e l'Autocoscienza.
Il principio della dottrina della scienza è l'Io o l'Autocoscienza. Nella
Seconda introduzione alla dottrina della scienza (1797) Fichte introduce
nel modo più chiaro questo principio. Noi possiamo dire che qualcosa
esiste, afferma il filosofo, solo rapportandolo alla nostra coscienza,
ossia facendone un essere-per-noi. A sua volta la coscienza è tale solo in
quanto è coscienza di se medesima, ovvero autocoscienza. In sintesi:
l'essere per noi (l'oggetto) è possibile soltanto sotto la condizione
della coscienza (del soggetto) e questa soltanto sotto la condizione
dell'autocoscienza. La coscienza è il fondamento dell'essere,
l'autocoscienza è il fondamento della coscienza.
La prima Dottrina della scienza è il tentativo sistematico di dedurre
dal principio dell'autocoscienza la vita teoretica e pratica dell'uomo.
Fichte comincia in essa con lo stabilire i tre princìpi o momenti
fondamentali di questa deduzione. Il primo principio è ricavato da una
riflessione sulla legge d'identità (per cui A = A), che la filosofia
tradizionale aveva considerato come base universale del sapere.
Il primo principio del sapere non è la legge d'identità, ma l'Io.
In realtà, osserva Fichte, tale legge non rappresenta il primo principio
della scienza, poiché essa implica un principio ulteriore che è l'Io.
Infatti, tale legge presuppone che se A è dato, deve essere formalmente
uguale a se stesso (A = A; esempio « il triangolo è triangolo»). In tal modo
essa assume ipoteticamente la presenza di A. Ora l'esistenza iniziale di A
dipende dall'Io che la pone, poiché senza l'identità dell'Io (Io = Io)
l'identità logica (A = A) non si giustifica. In altri termini, il rapporto
d'identità è posto dall'Io, perché è l'Io che giudica di esso. Ma l'Io non
può porre quel rapporto, se non pone se stesso, cioè se non si pone
esistente. L'esistenza dell'Io ha dunque la stessa necessità del rapporto
puramente logico A = A, in quanto l'Io non può affermare nulla senza
affermare in primo luogo la propria esistenza.
L'Io è auto-posizione e auto-creazione, ovvero intuizione intellettuale
(Cfr. il Glossario)
Di conseguenza, il principio supremo del sapere non è quello d'identità,
che è posto dall'Io, ma l'Io stesso. Questi, a sua volta, non è posto da
altri, ma si pone da sé. Infatti la caratteristica dell'Io consiste
nell'auto-creazione. Mentre le cose sono quelle che sono, in quanto la loro
natura è fissa e predeterminata, l'Io è ciò che egli stesso si fa.
Rivolgendosi all'esperienza diretta di ogni persona, Fichte scrive:
«Pensaci, costruisci il concetto di te stesso, e nota come fai. Ognuno che
fa così troverà che l'attività dell'intelligenza costruisce se stessa»
(Seconda introduzione alla Dottrina della Scienza). Tale auto-creazione
coincide con l'intuizione intellettuale che l'Io ha di se stesso.
Per cui, se la metafisica classica sosteneva che operari sequitur esse,
intendendo dire che gli individui agiscono in conformità della loro natura
o del loro essere, la nuova metafisica idealistica, capovolgendo l'antico
assioma, afferma che esse sequitur operari, in quanto l'essere dell'Io
appare il frutto della sua azione e il risultato della sua libertà.
La nozione di Tathandlung.
Questa prerogativa dell'Io viene denominata da Fichte Tathandlung.
Con questo termine, che assieme a quello di Streben (sforzo) è forse il
più caratteristico della Dottrina della scienza, il filosofo intende
appunto dire che l'Io è, nello stesso tempo, attività agente (Tat) e
prodotto dell'azione stessa (Handlung).
Si noti come Fichte, con questo basilare principio, non faccia che
portare alla sua massima espressione metafisica la visione rinascimentale
e moderna dell'uomo come «libero e sovrano artefice di se stesso», ovvero
come essere che costruisce o inventa se medesimo tramite la propria libertà.
Come vedremo, questo concetto tende a ritornare, anche indipendentemente
dall'idealismo, in gran parte delle filosofie posteriori, sino ai giorni
nostri. Goethe lo ha reso con i versi del Faust (Libro 1, 5. 1237):
«In principio era l'azione».
«L'Io pone se stesso».
Il primo principio della Dottrina della scienza stabilisce quindi che
«l'Io pone se stesso», chiarendo come il concetto di Io in generale si
identfichi con quello di un'attività auto-creatrice ed infinita.
«L'Io pone il non-io».
Il secondo stabilisce che «l'Io pone il non-io», ovvero che l'Io non solo
pone se stesso, ma oppone anche a se stesso qualcosa che, in quanto gli è
opposto, è un non-io (oggetto, mondo, natura). Tale non-io è tuttavia
posto dall'Io ed è quindi nell'Io. Questo secondo principio, osserva
Fichte, non è, a rigore, deducibile dal primo «poiché la forma
dell'opporre è così poco compresa nella forma del porre, che le è anzi
piuttosto opposta». Ciò non toglie, come appare chiaro dall'ultima parte
della Dottrina della scienza, che «questo fatto deve accadere, affinché
una coscienza reale sia possibile». Infatti, che senso avrebbe un Io
senza un non-io, cioè un soggetto senza oggetto, un'attività senza un
ostacolo, un positivo senza un negativo? (per i testi di Fichte cfr. il
Glossario).
«L'Io oppone nell'Io all'Io divisibile un non-io divisibile».
Il terzo principio mostra come l'Io, avendo posto il non-io, si trovi ad
essere limitato da esso, esattamente come quest'ultimo risulta limitato
dall'Io. In altri termini, con il terzo principio perveniamo alla
situazione concreta del mondo, nella quale abbiamo una molteplicità di
io finiti che hanno di fronte a sé una molteplicità di oggetti a loro
volta finiti. E poiché Fichte usa l'aggettivo «divisibile» per denominare
il molteplice e il finito egli esprime il principio in questione con la
seguente formula: «L'Io oppone nell'Io all'io divisibile un non-io
divisibile ».
4.1. Chiarificazioni.
Questi tre princìpi delineano i capisaldi dell'intera dottrina di Fichte,
perché stabiliscono:
a) l'esistenza di un Io infinito, attività assolutamente libera e creatrice;
b) l'esistenza di un io finito (perché limitato dal non-io), cioè di un
soggetto empirico (l'uomo come intelligenza o ragione);
c) la realtà di un non-io, cioè dell'oggetto (mondo o natura), che si
oppone all'io finito, ma è ricompreso nell'Io infinito, dal quale è posto.
Nello stesso tempo essi costituiscono il nerbo della deduzione idealistica
del mondo, ossia di quella spiegazione della realtà alla luce dell'Io, che
contrapponendosi all'antica metafisica dell'essere o dell'oggetto mette
capo ad una nuova metafisica dello spirito e del soggetto.
Realtà logica e non cronologica.
Per facilitare la comprensione del processo descritto è bene aggiungere
talune note:
1) I tre princìpi non vanno interpretati in modo cronologico, bensì logico,
in quanto Fichte, con essi, non intende dire che prima esista l'Io infinito,
poi l'io che pone il non-io ed infine l'io finito, ma semplicemente che
esiste un Io che, per poter essere tale, deve presupporre di fronte a sé
il non-io, trovandosi in tal modo ad esistere concretamente sotto forma
di io finito. Allora Fichte avrebbe delineato tutto questo processo
teorico, che si serve di un armamentario linguistico astruso, unicamente
per arrivare a dire ciò che anche l'uomo comune e la filosofia tradizionale
sanno da sempre, ossia che la scena del mondo è composta da una
molteplicità di io o di individui finiti che hanno dinanzi a sé una
molteplicità di oggetti, che nel loro insieme costituiscono la Natura? In
verità, con la sua deduzione, Fichte ha voluto mettere bene in luce come
la natura non sia una realtà autonoma, che precede lo spirito, ma
qualcosa che esiste soltanto come momento dialettico della vita dell'Io, e
quindi per l'Io e nell'Io.
L'Io è finito e infinito al tempo stesso.
2) In virtù di questa dottrina, l'Io, per Fichte, risulta finito e
infinito al tempo stesso: finito perché limitato dal non-io, infinito
perché quest'ultimo, cioè la natura, esiste solo in relazione all'Io e
dentro l'Io, costituendo il polo dialettico o il « materiale»
indispensabile della sua attività.
3) L'Io «infinito» o «puro» di cui parla Fichte non è qualcosa di diverso
dall'insieme degli io finiti nei quali esso si realizza, esattamente come
l'umanità non è qualcosa di diverso dai vari individui che la compongono,
anche se l'Io infinito perdura nel tempo, mentre i singoli io finiti
nascono e muoiono.
Rapporti fra l'Io infinito e gli io finiti.
4) L'Io infinito, più che la sostanza o la radice metafisica degli io
finiti, è la loro mèta ideale. In altri termini, gli io «finiti» sono
l'Io infinito e gli io empirici sono l'Io «puro», solo in quanto tendono ad
esserlo. Detto altrimenti, l'infinito, per luomo, anziché consistere in una
«essenza» già data, è, in fondo, un dover-essere e una missione. Queste
formule «tecniche» (che già ai tempi di Fichte rendevano «ostica» la sua
filosofia) si comprendono meglio se si pone mente al fatto che per Io
«infinito» o «puro» Fichte intende un Io libero, ossia uno spirito
vittorioso sui propri ostacoli e quindi privo o scevro («puro») di
limiti. Situazione che per l'uomo rappresenta un semplice ideale. Di
conseguenza, dire che l'Io infinito è la « natura» e la « missione dell'io
finito» significa dire che l'uomo è uno sforzo infinito verso la libertà,
ovvero una lotta inesauribile contro il limite, e quindi contro la natura
esterna (le «cose») ed interna (gli « istinti» irrazionali e « l'egoismo»).
In altri termini, sotto le rigide formule della Dottrina della scienza
si cela un «messaggio» tipico della modernità: il compito proprio
dell'uomo è l'umanizzazione del mondo, ossia il tentativo incessante, da
parte nostra, di «spiritualizzare» le cose e noi stessi, dando origine,
da un lato, ad una natura plasmata secondo i nostri scopi e dall'altro ad
una società di esseri liberi e razionali.
La missione inesauribile dell'Io.
5) Ovviamente questo compito si staglia sull'orizzonte di una missione
mai conclusa, poiché se l'Io, la cui essenza è lo sforzo (lo Streben dei
romantici) riuscisse davvero a fagocitare tutti i suoi ostacoli,
cesserebbe di esistere, e invece del movimento della vita, che è lotta
ed opposizione, subentrerebbe la stasi della morte. Al posto del
concetto statico di perfezione, tipico della filosofia classica, con
Fichte subentra quindi un concetto dinamico, che pone la perfezione
nello sforzo indefinito di auto-perfezionamento: «Frei sein, sostiene
Fichte, ist nichts, frei werden ist der Himmel» («essere libero è niente,
divenirlo è cosa celeste»).
La deduzione delle categorie.
6) I tre princìpi sovraesposti rappresentano anche la piattaforma della
deduzione fichtiana delle categorie. Infatti il porsi dell'Io (tesi),
l'opposizione del non-io all'Io (antitesi) e il limitarsi reciproco dell'io
e del non-io (sintesi), corrispondono alle tre categorie kantiane di
qualità: affermazione, negazione e limitazione. Dal concetto di un io
divisibile e di un non-io divisibile, ossia molteplice (terza
proposizione), derivano le categorie di quantità: unità, pluralità e
totalità. Dalla terza proposizione, dove abbiamo un io che è il soggetto
auto-determinantesi dell'intero processo (sostanza), un non-io che determina
(causa) e un io empirico che è determinato (effetto) ed un reciproco
condizionarsi fra io e non-io (azione reciproca), scaturiscono anche le
tre categorie di relazione: sostanza, causa-effetto e azione reciproca.
5. La struttura dialettica dell'Io.
Dire che la storia «filosofica» del mondo si articola nei tre momenti
dell'autoposizione dell'Io (tesi), della opposizione del non-io (antitesi)
e della determinazione reciproca fra Io e non-io (sintesi), significa
dire che l'Io, per usare una terminologia che avrà grande fortuna con
Hegel, presenta una struttura triadica e «dialettica» articolata nei tre
momenti di tesi-antitesi-sintesi e incentrata sul concetto di una «sintesi
degli opposti». Per esemplificare didatticamente questo punto, riteniamo
utile riportare un passo dello storico idealista Guido de Ruggiero:
(L'attività ritmica e dialettica dell'io.)
«Vista nel suo principio ispiratore, questa dialettica esprime il tema
dominante dell'idealismo postkantiano... Ridotta in formule, essa
rassomiglia spesso a un vano gioco di concetti, ma rifusa nell'esperienza
viva di ciascuno di noi, essa coglie l'intima essenza della nostra vita
spirituale. Non basta la mera idea dell'attività a caratterizzare
quest'ultima; bisogna specificarla con l'idea di un'attività ritmica, che
si svolge in virtù dell'opposizione che le è immanente e che la propria
forza espansiva spinge a sorpassare. Provatevi a pensare qualunque atto
mentale, senza opposizione, senza critica, senza riflessione su se
stesso: esso è destinato a esaurirsi e a disperdersi. La natura del
nostro spirito è tale, che ogni dire esige un contraddire, ogni tesi
suscita un'antitesi, non come punto di arresto o come un disfare quel che
s'è fatto, ma come un limite fecondo che fa fermentare gli elementi vivi
della tesi, permeandoli di sé. Di modo che la sintesi, che si realizza
attraverso questo lavoro di negazione e di critica, non è la pura e
semplice ripetizione della tesi iniziale, ma è la riaffermazione di
essa, arricchita e rafforzata dal superamento dell'antitesi; è un
possesso fatto più sicuro e consapevole, in cui lo spirito ritrova
un'equazione più alta della propria natura. Ciò che s'è detto per
l'attività teoretica vale egualmente per l'attività morale, estetica,
religiosa eccetera.
(Lo spirito vive di opposizioni.)
Dovunque lo spirito si attua, esso vive di opposizione e
di lotta, e le sue affermazioni, per essere veramente tali, debbono
essere vittorie. Lo schema triadico non fa che simboleggiare questo
vitale processo, ma non riesce ad esprimerlo compiutamente nella sua
intensità psicologica; bisogna saperlo reinterpretare nel più complesso
linguaggio dello spirito, leggendo nella tesi l'esordio spontaneo, ma
ancora malcerto e circonfuso di mistero, della ricerca teoretica o
dell'intuizione artistica o dell'atto volontario; nelle antitesi il
dubbio, l'obiezione, la negazione sconfortante, insomma tutto l'intimo
travaglio della riflessione e della critica; nella sintesi finalmente la
riconquista, la sicurezza del possesso, la catarsi teoretica o morale.
(Ogni traguardo è il punto di partenza di una nuova lotta.)
Si potrebbe ancora falsamente immaginare che, raggiunta la sintesi, il
fecondo travaglio dello spirito subisca un arresto e il moto interno
sfoci in una stagnante immobilità. E senza dubbio, ogni sintesi segna
una pausa e un riposo, di cui lo spirito gode e ha diritto di godere; ma
pausa e riposo sono momenti di tregua e di raccoglimento che preludono a
un nuovo slancio, sono stati di equilibrio instabile, in vista di un
nuovo squilibrio. In effetti la sintesi è, come si è visto, un atto di
limitazione che non può pareggiare l'attività infinita da cui il moto si
alimenta. Di qui nasce nello spirito un vitale scontento delle soluzioni
volta a volta conseguite, dei risultati del lavoro già compiuto, che è
sprone a nuove ricerche e a nuovi cimenti. Se non si dà questa
insoddisfazione, se l'opera compiuta pareggia in tutto l'energia
dell'autore, allora è la morte. Ma la morte stessa non sta che per
l'individuo, che è una sintesi sempre in qualche modo limitata
dell'attività totale dello spirito; ma l'umanità sorpassa le sue
incarnazioni particolari ed esprime nell'infinità della
sua vita l'infinità dell'energia spirituale che la suscita. La visione
dialettica del reale è perciò una visione dinamica e progressiva, che,
contro il sostanzialismo inerte delle filosofie dogmatiche, afferma in
tutta la sua pienezza il concetto del divenire »
(Storia della Filosofia, «L'età del romanticismo», Laterza, Bari 1968,
Volume 1, pagine 175-176).
6. La «scelta» fra idealismo e dogmatismo.
In uno scritto successivo alla Dottrina della scienza del 1794, che va
sotto il nome di Prima introduzione alla dottrina della scienza (1797),
Fichte, dopo aver affermato che idealismo e dogmatismo sono gli unici due
sistemi filosofici possibili, cerca di illustrare i motivi che spingono
alla «scelta» dell'uno o dell'altro.
Idealismo e dogmatismo.
Fichte sostiene che la filosofia non è una costruzione astratta, ma una
riflessione sull'esperienza che ha come scopo la messa in luce del
fondamento dell'esperieza stessa. Ora, poiché nell'esperienza sono in
gioco «la cosa» (l'oggetto) e «lintelligenza» (l'io o il soggetto), la
filosofia può assumere la forma dell'idealismo (che consiste nel puntare
sull'intelligenza, facendo una preliminare astrazione dalla cosa) o del
dogmatismo (che consiste nel puntare sulla cosa in sé facendo una
preliminare astrazione dall'intelligenza). In altri termini, l'idealismo
consiste nel partire dall'Io o dal soggetto, per poi spiegare, su questa
base, la cosa o l'oggetto. Viceversa, il dogmatismo consiste nel partire
dalla cosa in sé o dall'oggetto, per poi spiegare, su questa base, l'io o
il soggetto: «Il contrasto tra l'idealista e il dogmatico consiste
propriamente in ciò: se l'autonomia dell'io debba essere sacrificata a
quella della cosa o viceversa».
La scelta fra le due filosofie deriva da una differenza di «inclinazione»
e di «interesse».
Secondo Fichte, nessuno di questi due sistemi riesce a confutare
direttamente quello opposto, in quanto non può fare a meno di presupporre,
sin dall'inizio, il valore del proprio principio (l'Io o la cosa in sé).
Che cos'è mai, allora, ciò che induce «un uomo ragionevole» a dichiararsi a
favore dell'uno piuttosto che dell'altro? A questo interrogativo Fichte
risponde che la scelta fra i due massimi sistemi del mondo deriva da una
differenza di «inclinazione» e di «interesse», ovvero da una presa di
posizione in campo etico. Vediamo in che senso. Secondo Fichte, il
dogmatismo, che si configura come una forma di realismo in gnoseologia e
di naturalismo o di materialismo in metafisica, finisce sempre per rendere
nulla o problematica la libertà: «Ogni dogmatico conseguente è per
necessità fatalista. Non che contesti, come dato di coscienza, il fatto
che noi ci reputiamo liberi... Egli non fa che dedurre dal suo principio
la falsità di questa attestazione... Egli nega del tutto quell'autonomia
dell'Io, su cui l'idealista costruisce, e fa dell'Io nient'altro che un
prodotto delle cose, un accidente del mondo: il dogmatico conseguente è
per necessità anche materialista». Al contrario, l'idealismo, facendo
dell'Io un'attività auto-creatrice in funzione di cui esistono gli oggetti,
finisce sempre per strutturarsi come una rigorosa dottrina della libertà.
Queste due filosofie hanno, come corrispettivo esistenziale, due tipi di
umanità. Infatti, da un lato, vi sono individui che non si sono ancora
elevati al sentimento della propria libertà assoluta, e che, trovando se
stessi soltanto nelle cose, sono istintivamente attratti dal dogmatismo e
dal naturalismo, che insegna loro che tutto è deterministicamente dato e
fatalisticamente predisposto.
L'individuo «attivo» sceglie l'idealismo.
Dall'altro, vi sono individui che avendo il senso profondo della propria
libertà e indipendenza dalle cose, risultano spontaneamente portati a
simpatizzare con l'idealismo, che insegna loro come esser-uomini sia sforzo
e conquista, e come il mondo ci sia non per essere passivamente contemplato,
ma solo per essere attivamente forgiato dallo spirito. In sintesi: «La
scelta di una filosofia dipende da quel che si è come uomo, perché un
sistema filosofico non è un'inerte suppellettile, che si possa prendere
o lasciare a piacere, ma è animato dallo spirito dell'uomo che l'ha.
Un carattere fiacco di natura o infiacchito e piegato dalle frivolezze,
dal lusso raffinato e dalla schiavitù spirituale, non potrà mai elevarsi
all'idealismo».
Superiorità etica e teoretica dell'idealismo.
Tuttavia, benché Fichte, nello scritto citato, parli in termini di
«scelta di fondo », dal contesto del suo sistema si deduce che l'opzione
tra le due filosofie, pur rimandando ad una presa di posizione
esistenziale e morale, non sia affatto, secondo il filosofo,
teoreticamente immotivata. Anzi, come si è visto, tutta la Dottrina
della scienza di Fichte è volta a dimostrare che solo muovendo dall'io
si riesce a spiegare, in termini di «scienza», sia l'Io sia le cose.
ln sintesi, l'Io èla realtà originaria e assoluta che può spiegare
sia se stesso, sia le cose, sia il rapporto tra se stesso e le
cose. Per cui, è proprio questa doppia superiorità etica e teoretica
dell'idealismo sul dogmatismo che spinge Fichte ad intraprendere
quella via originale del pensiero umano che è l'idealismo.
7. La dottrina della conoscenza.
Dall'azione reciproca dell'io e del non-io nasce sia la conoscenza (la
rappresentazione) sia l'azione morale. Il realismo dogmatico ritiene che
la rappresentazione sia prodotta dall'azione di una cosa esterna sull'io;
ed ammette con ciò che la cosa sia indipendente dall'io ed anteriore ad
esso. Fichte ammette anch'egli che la rappresentazione sia il prodotto di
un'attività del non-io sull'io; ma poiché il non-io è a sua volta posto o
prodotto dall'Io, l'attività che esso esercita deriva in ultima analisi
proprio dall'Io, ed è un'attività riflessa che dal non-io rimbalza all'io.
Realismo e idealismo di Fichte.
Di conseguenza, Fichte si proclama realista e idealista al tempo stesso:
realista perché alla base della conoscenza ammette un'azione del non-io
sull'io, idealista perche ritiene che il non-io sia, a propria volta, un
prodotto dell'Io. Tuttavia questa dottrina genera un problema non certo
irrilevante nell'economia del sistema: perché il non-io, pur essendo un
effetto dell'io, appare alla coscienza comune qualcosa di sussistente di
per sé, anteriormente ed indipendentemente dall'io stesso? Come si spiega
che l'io è causa di una realtà di cui non ha esplicita coscienza, e che
solo la riflessione filosofica, dopo uno sviluppo plurisecolare, è riuscita,
con Fichte, a portare alla luce? Ed inoltre, eliminata la consistenza
autonoma del non-io, questo non rischia di ridursi a sogno o parvenza?
La teoria della immaginazione produttiva.
Al primo tipo di problemi Fichte risponde con la teoria
dell'immaginazione produttiva, che Kant aveva concepito come la facoltà
attraverso cui l'intelletto schematizza il tempo secondo le categorie, e
che egli intende come l'atto attraverso cui l'Io pone, crea, il non-io. Per
cui, mentre in Kant l'immaginazione produttiva fornisce solo le
condizioni formali dell'esperienza, in Fichte essa produce i materiali
stessi del conoscere. Per quanto riguarda il carattere inconsapevole
dell'immaginazione produttiva, essa deriva dal fatto che la coscienza
presuppone sempre una situazione polarizzata in cui c'è un soggetto che
ha già dinanzi a sé l'oggetto. Ora, poiché l'immaginazione produttiva è
l'atto stesso con cui il soggetto (l'Io infinito) si dispone a creare
l'oggetto, risulta evidente che essa non potrà che essere inconscia.
Per quanto riguarda il secondo problema, Fichte ha già risposto
asserendo che il non-io, pur essendo un prodotto dell'Io, non è una parvenza
ingannatrice, ma una realtà di fronte a cui si trova ogni io empirico.
I gradi di conoscenza.
Sul piano teoretico, la riappropriazione umana del non-io avviene attraverso
una serie di gradi della conoscenza, che vanno dalla semplice sensazione
alle più alte speculazioni del filosofo, mediante una progressiva
interiorizzazione dell'oggetto, che alla fine si rivela opera del soggetto.
Fichte denomina questo processo di graduale riconquista conoscitiva
dell'oggetto «storia prammatica dello spirito umano», e lo articola in
sensazione (in cui l'io empirico avverte fuori di sé l'oggetto, come un
dato che gli si oppone), in intuizione (in cui si ha la distinzione fra
soggetto-oggetto ed il coordinamento del materiale sensibile tramite
lo spazio e il tempo), in intelletto (che fissa la molteplicità fluttuante
delle percezioni spazio-temporali mediante rapporti categoriali stabili),
in giudizio (che fissa e articola a propria volta la sintesi intellettiva:
«se nell'intelletto non c'è nulla non c'è giudizio; se non c'è giudizio,
nell'intelletto non c'è nulla per l'intelletto, non c'è pensiero del
pensato come tale»), in ragione (che essendo la facoltà di «astrarre da
ogni oggetto in generale», rappresenta il massimo livello conoscitivo
raggiungibile dal soggetto).
8. La dottrina morale.
8.1. Il «primato» della ragion pratica.
La conoscenza presuppone l'esistenza di un io (finito) che ha dinanzi a sé
un non-io (finito), ma non spiega il «perché» di tale situazione. In altri
termini, perché l'Io pone il non-io, realizzandosi come io conoscente
finito?
L'io pratico costituisce la ragion d'essere dell'io teoretico.
Il motivo, risponde Fichte in coerenza con le premesse del sistema, è di
natura pratica. L'Io pone il non-io ed esiste come attività conoscente solo
per poter agire: «Noi agiamo, scrive il filosofo, perché conosciamo, ma
conosciamo perché siamo destinati ad agire». Detto altrimenti: l'io pratico
costituisce la ragione stessa dell'io teoretico. In tal modo, Fichte ritiene
di avere posto su solide basi il primato della ragion pratica sulla ragion
teoretica enunciato da Kant. Da ciò la denominazione di idealismo etico
dato al pensiero di Fichte, che si può sintetizzare nella doppia tesi
secondo cui noi esistiamo per agire e il mondo esiste solo come teatro
della nostra azione: « Il mio mondo è oggetto e sfera dei miei doveri e
assolutamente niente altro».
Caratteri dell'agire morale.
Ma che cosa significa «agire»? E in che senso l'agire assume un aspetto
«morale»? La risposta a queste due domande discende da quanto si è detto
sinora. Agire significa imporre al non-io la legge dell'Io, ossia foggiare
noi stessi e il mondo alla luce di liberi progetti razionali. Il carattere
morale dell'agire consiste nel fatto che esso assume la forma del «dovere»,
ovvero di un imperativo volto a far trionfare lo spirito sulla materia, sia
mediante la sottomissione dei nostri impulsi alla ragione, sia tramite la
plasmazione della realtà esterna secondo il nostro volere.
Tutto ciò fornisce la spiegazione definitiva del perché l'Io abbia «bisogno»
del non-io. Spiegazione che possiamo globalmente sintetizzare in
questo modo. Per realizzare se stesso, l'Io, che è costituzionalmente
libertà, deve agire ed agire moralmente. Ma, come Kant aveva insegnato, non
c'è attività morale là dove non c'è sforzo; e non c'è sforzo là dove non
c'è un ostacolo da vincere.
Il non-io come condizione della moralità dell'Io.
Tale ostacolo è la materla, l'impulso sensibile, il non-io. La posizione
del non-io è quindi la condizione indispensabile affinché l'Io si
realizzi come attività morale. Ma realizzarsi come attività morale
significa trionfare sul limite costituito dal non-io, tramite un processo
di autoliberazione dell'Io dai propri ostacoli. Processo grazie al quale
l'Io mira a farsi «infinito», cioè libero da impedimenti esterni.
Ovviamente, l'infinità dell'Io, come già sappiamo, non è mai una realtà
conclusa, ma un compito incessante: « L'io non può mai diventare
indipendente fino a che dev'essere Io; lo scopo finale dell'essere
razionale si trova necessariamente nell'infinito ed è tale che non lo
si può raggiungere mai sebbene ci si debba incessantemente avvicinare
ad esso...».
In tal modo, Fichte ha riconosciuto nell'ideale etico il vero significato
dell'infinità dell'Io. L'Io è infinito (sia pure tramite un processo esso
stesso infinito) poiché si rende tale, svincolandosi dagli oggetti che
esso stesso pone. E pone questi oggetti perché senza di essi non potrebbe
realizzarsi come attività e libertà.
8.2. La «missione» sociale dell'uomo e del dotto.
Secondo Fichte, il dovere morale può essere realizzato dall'io finito
solo insieme agli altri io finiti. Anzi, nell'ultima parte del Sistema
della dottrina morale (1798), egli arriva a «dedurre» filosoficamente
l'esistenza degli altri io in base al principio per cui la sollecitazione
e l'invito al dovere possono venire soltanto da esseri fuori di me, che
siano, come me, nature intelligenti. Ora, ammessa l'esistenza di altri
esseri intelligenti, io sono obbligato a riconoscere ad essi lo stesso
scopo della mia esistenza, cioè la libertà. In tal modo, ogni io finito
risulta costretto non solo a porre dei limiti alla sua libertà
(sanzionati dal contratto statale) ma anche ad agire in modo tale che
l'umanità nel suo complesso risulti sempre più libera.
Il fine ultimo dell'uomo e della società.
Farsi liberi e rendere liberi gli altri in vista della completa
unificazione del genere umano: ecco il senso dello « Streben » (sforzo)
sociale dell'Io: « L'uomo ha la missione di vivere in società; egli deve
vivere in società; se viene isolato, non è un uomo intero e completo, anzi
contraddice a se stesso». «Il fine supremo ed ultimo della società è la
completa unità e l'intimo consentimento di tutti i suoi membri...».
Il dotto come «maestro» del genere umano.
Ora, per realizzare adeguatamente questo scopo, si richiede, secondo
Fichte, una mobilitazione di coloro che ne possiedono la maggior
consapevolezza teorica, cioè dei «dotti». Infatti, sostiene Fichte nelle
Lezioni sulla missione del dotto (1794), gli intellettuali non devono
essere degli individui isolati e chiusi nella torre della loro scienza,
ma devono essere delle persone pubbliche e con precise responsabilità
sociali: « Il dotto è in modo specialissimo destinato alla società; in
quanto tale egli esiste propriamente mediante e per la società», egli
«deve condurre gli uomini alla coscienza dei loro veri bisogni e
istruirli sui mezzi adatti per soddisfarli... ». Tanto più che c'è in
tutti gli uomini un sentimento del vero, che certo da solo non basta, ma
dev'essere sviluppato, saggiato, raffinato. In altri termini, il dotto,
che per Fichte deve essere luomo moralmente migliore del suo tempo, deve
farsi maestro ed educatore del genere umano.
In conclusione, e questa è la proposta di fondo dell'idealismo etico
fichtiano, «Il fine supremo di ogni singolo uomo, come della società
tutta intera, e per conseguenza di tutta l'operosità sociale del dotto è
il perfezionamento morale di tutto l'uomo».
9. La filosofia politica di Fichte.
9.1. Rivoluzione francese, Stato liberale e società autarchica.
Le varie «fasi» della filosofia politica di Fichte.
Il pensiero politico fichtiano si svolge attraverso fasi evolutive
diverse, sulle quali esercitano il loro influsso le vicende storiche
contemporanee, dalla Rivoluzione francese, che Fichte, agli inizi,
difende dagli attacchi del pensiero reazionario alle guerre napoleoniche e
all'invasione della Germania, che stimolano lo sviluppo della sua filosofia
in senso nazionalistico, parallelamente alla sempre maggior importanza
attribuita allo Stato e alla vita comunitaria.
In due scritti del 1793, comparsi anonimi e intitolati, l'uno,
Rivendicazione della libertà di pensiero dai prìncipi d'Europa che l'hanno
finora repressa, l'altro, Contributo per rettificare il giudizio del
pubblico sulla Rivoluzione francese, Fichte mostra di condividere una visione
contrattualistica ed antidispotica dello Stato, particolarmente sensibile
al tema della libertà di pensiero («No, o popoli, a tutto voi potete
rinunciare, tranne alla libertà di pensiero... »).
Libertà e Rivoluzione.
In particolare, simpatizzando con gli eventi francesi e civettando con
posizioni giacobine e rousseauiane (filtrate in modo kantiano), Fichte, nel
secondo saggio, afferma che lo scopo del contratto sociale è l'educazione alla
libertà, di cui è corollario il diritto alla rivoluzione. Infatti, se lo stato
non permette l'educazione alla libertà, ciascuno ha il diritto di rompere il
contratto sociale e di formarne un altro, che possa fornire migliori
garanzie e che sia in grado di garantire un sistema politico giusto. Un
sistema, tra l'altro, dove la proprietà risulta essere il frutto del lavoro
produttivo («chi non lavora non deve mangiare»).
Lo Stato come semplice «mezzo».
Nell'abbozzo di discorso politico contenuto nelle Lezioni sulla missione
del dotto (1794), Fichte scorge il fine ultimo della vita comunitaria nella
«società perfetta», intesa come insieme di esseri liberi e ragionevoli, e
considera lo Stato come un semplice mezzo in vista di essa, finalizzato al
«proprio annientamento, in quanto lo scopo di ogni governo è di rendere
superfluo il governo» (lezione seconda). In altri termini, come il compito
dei genitori è di rendere superflui loro stessi, formando individui adulti
e autonomi, così il fine dello Stato è di rendere inutile se medesimo, a
favore di una società di persone libere e responsabili. E sebbene Fichte
riconosca che ciò rappresenta più un auspicabile ideale-limite che una
realizzabile situazione di fatto, egli ritiene che lo Stato non possa
fare a meno di proporselo come obbiettivo.
Nei Fondamenti del diritto naturale secondo i princìpi della dottrina
della scienza (1796), in cui Fichte si sofferma più organicamente sul
problema giuridico-politico, egli fa dello Stato il garante del diritto. A
differenza della moralità, che è fondata soltanto sulla buona volontà, il
diritto vale anche senza la buona volontà: esso concerne esclusivamente le
manifestazioni esterne della libertà nel mondo sensibile, cioè le azioni,
ed implica perciò una costrizione esterna, che la moralità esclude. In
virtù dei rapporti di diritto, l'io pone a se stesso una sfera di libertà,
che è la sfera delle sue possibili azioni esterne, e si distingue da tutti
gli altri io, che hanno ognuna la propria sfera. In questo atto esso si pone
come persona o individuo. Ora la persona individuale non può agire nel
mondo se il suo corpo non è libero da ogni costrizione, se non può disporre
per i suoi scopi di un certo numero di cose e se non è garantita la
conservazione della sua esistenza corporea. I diritti originari e
naturali dell'individuo sono perciò tre: la libertà, la proprietà e la
conservazione. Ma questi diritti non possono essergli garantiti se non da
una forza superiore, che non può essere esercitata da un individuo, ma
soltanto dalla collettività degli individui, cioè dallo Stato. Lo Stato,
dunque, non elimina il diritto naturale, ma lo realizza e garantisce.
Le idee dello Stato commerciale chiuso.
Questa prospettiva individualistica, che avvicina Fichte allo schema
politico liberale, trova una sua integrazione, e al tempo stesso
parziale correzione, nello Stato commerciale chiuso (1800), opera nella
quale il filosofo afferma che lo Stato non deve limitarsi soltanto alla
tutela dei diritti originari, ma deve anche rendere impossibile la povertà,
garantendo a tutti i cittadini lavoro e benessere. Polemizzando contro il
liberismo e il mercantilismo e difendendo il principio secondo cui nello
Stato secondo ragione tutti devono essere subordinati al tutto sociale e
partecipare con giustizia ai suoi beni, Fichte perviene ad una forma di
statalismo socialistico (perché basato su di una regolamentazione statale
della vita pubblica) ed autarchico (perché autosufficiente sul
piano economico).
Il socialismo statalistico di Fichte non implica, propriamente,
comunismo, ossia eliminazione della proprietà privata dei mezzi di
produzione. Egli ritiene infatti che gli strumenti di lavoro (che dalla
sua ottica ancora prevalentemente agricolo-artigianale si identificano
con forze produttive quali zappe o forconi, martelli, fucine eccetera)
debbono appartenere a chi li usa. Per cui, mentre in Locke il diritto al
lavoro è derivato dal diritto di proprietà, in Fichte il diritto alla
proprietà è fatto scaturire dal dovere etico al lavoro.(Cfr. K. SChilling,
Geschichte der sozialen Ideen, Stuttgart, 1965 (traduzione italiana presso
Garzanti, MIlano, 1965)
LO statalismo socialistico ed autarchico.
Dopo aver «dedotto» le varie classi sociali degli agricoltori e dei
lavoratori dell'industria mineraria (i produttori di base della
ricchezza), degli artigiani, degli operai e degli imprenditori
(i trasformatori della ricchezza) e dei commercianti, degli insegnanti,
dei soldati e dei funzionari (i diffusori della ricchezza materiale e
spirituale, i loro difensori e gli amministratori della vita socio-politica),
Fichte dichiara che lo Stato ha il compito di sorvegliare l'intera
produzione e distribuzione dei beni, fissando ad esempio il numero degli
artigiani e dei commercianti, in modo tale che il loro numero sia
matematicamente proporzionato alla quantità dei beni prodotti, e
programmando gli orari e i salari di lavoro, i prezzi delle merci eccetera.
Per svolgere il suo compito in tutta libertà ed efficienza, regolando
secondo giustizia la distribuzione dei redditi e dei prodotti, lo Stato
deve organizzarsi come un tutto chiuso, senza contatti con l'estero,
sostituendo in tal modo l'economia liberale di mercato ed il commercio
mondiale con un'economia pianificata e con l'isolamento degli stati.
Tale «chiusura commerciale» risulta possibile quando lo Stato ha, nei
suoi confini, tutto ciò che occorre per la fabbricazione dei prodotti
necessari; là ove questo manchi, lo Stato può avocare a sé il commercio
estero e farne un monopolio. Questa autarchia, che abolisce ogni
contatto dei cittadini con l'estero (fatta eccezione per gli intellettuali
e per gli artisti, per motivi culturali) ha pure il vantaggio, secondo
Fichte, di evitare gli scontri fra gli stati, che nascono sempre da
contrapposti interessi commerciali.
In questo scritto si rispecchia, sia pure in forma filosofico-utopistica,
un'esigenza storica reale, consistente nella necessità, da parte dello
Stato moderno, di un intervento attivo nella vita sociale, volto ad
evitare povertà, disoccupazione ed ingiustizie. In questo senso l'opera
fichtiana, che risulta un'ibrida mescolanza di individualismo e di
statalismo, esprime un'inconsapevole ed irrisolta sovrapposizione di due
concezioni dello Stato: quella liberale classica e quella socialista. E
se questa ultima, date le condizioni storiche, rischia senz'altro di
assumere una fisionomia utopistica, senza presa sulla realtà e sui
contemporanei (che accolsero con freddezza e disinteresse le proposte
fichtiane), la prima rischia di essere oggettivamente sacrificata sull'altare
del «superiore interesse» della comunità.
9.2. Lo Stato-Nazione e la celebrazione della miissione civilizzatrice della
Germania.
La fase «nazionalistica».
La battaglia di Jena e l'occupazione napoleonica della Prussia contribuiscono
a far sì che la filosofia politica di Fichte si evolva in senso
nazionalistico, concretizzandosi (nell'inverno 1807-1808) nei celebri
Discorsi alla nazione tedesca, « una delle opere più singolari che siano
apparse sulla scena filosofica... in cui variamente si intrecciano elementi
di scienza politica, filosofia della storia, pensiero religioso, teoria
dell'educazione, dottrina morale, filosofia del diritto e della
società... uno dei capolavori della letteratura tedesca per la limpidezza
dell'espressione, l'impeto oratorio, il vigore del ragionamento, lo slancio
prorompente del pensiero, l'efficacia della convinzione e della persuasione»
(L. Pareyson, Introduzione a Fichte, in Grande antologia filosofica,
Volume 17, pagina 875.)
In breve: uno dei documenti intellettuali più rilevanti della storia della
Germania moderna.
Il tema fondamentale dei Discorsi, che ne velò la pericolosità agli
occupanti, è l'educazione. Fichte ritiene infatti che il mondo moderno
richieda una nuova azione pedagogica, capace di mettersi al servizio non
già di una élite, ma della maggioranza del popolo e della nazione, e di
trasformare alle radici la struttura psichica, e anche fisica, delle persone.
La missione del popolo tedesco.
Tuttavia i Discorsi passano ben presto dal piano pedagogico a
quello nazionalistico, in quanto Fichte argomenta che soltanto il popolo
tedesco risulta adatto a promuovere la «nuova educazione», in virtù di ciò
che egli chiama «il carattere fondamentale» e che identifica nella lingua.
Infatti i tedeschi sono gli unici ad aver mantenuto la loro lingua, che sin
dall'inizio si è posta come espressione della vita concreta e della cultura
del popolo, a differenza, ad esempio, della Francia e dell'Italia, nelle
quali i mutamenti linguistici e la formazione dei dialetti neolatini hanno
provocato una scissione fra popolo, lingua e cultura. Per questo, i
tedeschi, il cui sangue non è commisto a quello di altre stirpi, sono
l'incarnazione dell'Urvolk, cioè di un popolo «primitivo» rimasto integro e
puro, e sono gli unici a potersi considerare un popolo, anzi come il popolo
per eccellenza (tant'è vero che egli fa notare come deutsch, preso nel suo
senso letterale, significhi originariamente «volgare» o «popolare»).
Di conseguenza, i tedeschi sono anche gli unici ad avere una patria, nel
senso più alto del termine, e a costituire un'unità organica, che, al di là
dei vari stati e di tutte le barriere politiche, si identifica con la
realtà profonda della nazione. A questo punto il discorso di Fichte si fa
decisamente patriottico, auspicando, almeno esplicitamente, non già la
lotta contro lo straniero (non si dimentichi la censura prussiana,
preoccupata di una ritorsione dei francesi!), bensì l'avvento di una nuova
generazione di tedeschi, educati e rinnovati secondo princìpi tratti
dal grande pedagogista G. Enrico Pestalozzi (1746-1827). Tuttavia,
incanalando nuovamente il discorso patriottico in senso nazionalistico,
Fichte proclama che solo la Germania, sede della Riforma protestante di
Lutero («il tedesco per eccellenza») e patria di Leibniz e di Kant, nonché
epicentro della nuova arte romantica e della nuova filosofia idealistica,
risulta la nazione spiritualmente «eletta» a realizzare
«l'umanità fra gli uomini», divenendo, per gli altri popoli, ciò che il
vero filosofo è per il prossimo: «sale della terra» e forza trainante:
«Il genio straniero sparpaglierà fiori nei sentieri battuti
dall'antichità... lo spirito tedesco, al contrario, aprirà nuove miniere,
farà penetrare la luce del giorno negli abissi e farà saltare enormi
massi di pensiero, di cui le età future si serviranno per costruire le
loro dimore. Il genio straniero sarà... l'ape che, accorta e industriosa,
bottina il miele... Ma lo spirito tedesco sarà l'aquila che, con ala
possente, eleva il suo corpo pesante e, con un volo vigoroso e
lungamente esercitato, sale sempre più in alto per avvicinarsi al sole,
la cui contemplazione la incanta». (J.G. Fichte, Renden an die deutsche
Nation, Berlino 1807-1808, discorso 5 (traduzione italiana, Discorsi alla
nazione tedesca, a cura di Barbara Allason, Utet, Torino, 1942,
pagine 104-105).
E tale «missione» di guida e di esempio, da parte della Germania,
risulta così importante, sostiene il filosofo nella Conclusione, che se
essa fallisse l'umanità intera perirebbe: «Non vi sono vie di uscita: se
voi cadete, l'umanità intera cade con voi, senza speranza di riscatto
futuro». (J.G. Fichte, Discorsi alla nazione tedesca, opera citata, 14,
pagina 269)
Si osservi, per controbilanciare quanto si è detto:
1) come il «primato» che Fichte assegna al popolo germanico non sia di
tipo politico-militare, ma piuttosto di tipo «spirituale» e culturale;
2) come Fichte ritenga che il popolo tedesco debba avere come interesse
ultimo l'umanità intera;
3) come il fine di quest'ultima siano i valori etici della ragione e
della libertà. Tutto ciò, se da un lato scagiona i Discorsi da
un'afrettata - e testualmente scorretta - interpretazione di essi in senso
pangermanista o razzista, dall'altro lato non toglie che la loro influenza
storica maggiore si sia esercitata proprio in questo senso.
Fortuna dei «Discorsi».
Infatti i Discorsi (che all'inizio ebbero poco seguito, ma nei quali già
il romanziere e filosofo Jean Paul Richter sentiva «battere il cuore
stesso della nazione tedesca»), parlando di «primato», di «missione», di
«popolo integro», in seguito hanno potuto costituire un testo-chiave non
solo del patriottismo, ma anche dello sciovinismo tedesco, portato ben
presto a trasformare la fichtiana «supremazia spirituale» in una
supremazia di razza e di potenza, lungo un processo che ha trovato il
suo epilogo oggettivo nel nazismo del Terzo Reich.
Il diritto come condizione preparatoria alla moralità.
Nel 1812, nell'ambito di lezioni e conferenze accademiche tenute
all'Università di Berlino, Fichte scrive il Sistema della dottrina del
diritto, in cui tenta di ricondurre il diritto alla moralità. Infatti,
mentre nella Dottrina del diritto del 1796 la sfera del diritto veniva
caratterizzata indipendentemente dalla vita morale, nell'opera del 1812
risulta caratterizzata come il tratto d'unione che collega la natura alla
moralità. Il diritto è la condizione preparatoria della moralità. Se
questa fosse universalmente realizzata, il diritto sarebbe superfluo; ma
poiché non è universalmente realizzata e affinché possa esserlo, bisogna
assicurare a ciascuna persona le condizioni della sua realizzazione con
una disciplina obbligatoria; questa disciplina è il diritto. In
quest'ultima fase del suo pensiero politico, Fichte tende inoltre ad
accentuare la missione «educatrice» dello Stato e a risolvere l'io
empirico nel «Noi spirituale» della Nazione.
10. La seconda fase della filosofia di Fichte (1800-1814)
10.1. La «crisi» del sistema.
La prima Dottrina della scienza (e le opere che le si collegano e la
estendono al campo del diritto e della morale) intende mantenersi fedele
allo spirito del criticismo. Essa pone bensì un io infinito, come
autocoscienza assoluta; ma riconosce pure che l'infinità dell'io non può
realizzarsi che attraverso la finitudine, cioè attraverso la posizione di
un non-io. L'io infinito è dunque pur sempre l'uomo: la sua vera sostanza
spirituale e pensante. Il concetto di una «divinità, nella quale tutto
fosse posto per il solo fatto che l'io fosse posto» è dichiarato
«impensabile». Come si è visto, Fichte ripete più volte queste
dichiarazioni nella prima Dottrina della scienza: e le opere che sono ad
essa seguite si mantengono fedeli a questo principio.
Ma gradualmente, a partire dalla polemica sull'ateismo (1798), Fichte si
evolve verso una sempre maggiore considerazione della vita religiosa.
L'interesse morale che domina nel suo primo periodo si complica di motivi
teosofici, che finiscono per prevalere.
La «seconda» filosofia di Fichte.
Fichte ritorna incessantemente a rielaborare la dottrina della scienza a
partire dal 1801; e mentre esplicitamente dichiara (per esempio, nella
prefazione all'Introduzione alla vita beata) di non aver nulla da mutare
nelle sue primitive affermazioni, le sue conclusioni dottrinali si
allontanano in realtà sempre più da esse. Evidentemente il senso di
queste dichiarazioni è che il principio stesso della dottrina della scienza
(al quale sono dedicate quasi esclusivamente le successive rielaborazioni)
presentava di fronte ai suoi occhi un problema, che egli cercò di
risolvere successivamente. Qual è questo problema? Esso si può facilmente
riconoscere nel rapporto tra l'infinito e il finito. La prima Dottrina della
scienza ha identificato i due termini in quanto ha posto e riconosciuto
l'infinito nell'uomo. Essa quindi esclude ogni considerazione teologica e
dichiara impensabile lo stesso concetto di Dio. Ma quella stessa identità
fa nascere il problema della sua propria estensione. Se il finito si
identifica con l'infinito, ciò ancora non dice che l'infinito si
identifichi col finito. Se l'uomo è in qualche misura partecipe della
divinità ed è (in certi limiti) la stessa divinità, ciò non significa che la
divinità si esaurisca nell'uomo e viva in lui solamente. Ci può essere
nell'infinito e nel divino un margine (a sua volta infinito) che è al di là
di ciò che di esso si realizza o si rivela nell'uomo.
Frattura e continuità fra la prima e la seconda fase.
Questa possibilità Fichte cerca di afferrare e definire filosoficamente
nelle diverse elaborazioni che dà alla dottrina della scienza a partire dal
1801. Non si può quindi far a meno di riconoscere una frattura nella
filosofia di Fichte tra la prima e la seconda sua fase. Nella prima fase,
questa filosofia è una dottrina dell'infinito nell'uomo. Nella seconda fase
è una dottrina dell'infinito fuori dell'uomo. Nella prima fase l'infinito
(o Assoluto, che è lo stesso) viene identificato con l'uomo. Nella seconda
fase l'infinito o assoluto viene identificato con Dio. La frattura
dottrinale è dunque innegabile. Ma questa frattura è indubbiamente dovuta
allo stesso interesse etico-religioso che domina da un capo all'altro
l'opera di Fichte.
10.2. L'io come immagine di Dio e il filosofare religioso.
Il tentativo di avvalersi del sapere per raggiungere un Assoluto che è
al di fuori e al di là del sapere è compiuto per la prima volta da Fichte
nella Dottrina della scienza del 1801. Qui egli parte dal principio che il
sapere umano non è l'Assoluto poiché quest'ultimo «riposa su e in se
medesimo assolutamente senza mutamento né oscillazione, saldo, completo e
chiuso in se stesso» (Werke, 2, pagine 12-13).
Mentre l'Assoluto e il sapere vengono così contrapposti, il mondo viene
invece collegato con il sapere e ridotto da Fichte ad una sua manifestazione
o copia. Come tale, appare a Fichte privo di realtà propria. «Se si parla,
egli dice, del miglior mondo e delle tracce della divinità buona che si
trovano in questo mondo, la risposta è questa: il mondo è il peggiore di
tutti quelli possibili perché esso, in se stesso, è addirittura nulla». Di
conseguenza, sembra che l'ultimo esito della metafisica fichtiana sia di
tipo schiettamente mistico e religioso: «Nel sollevarsi al di sopra di
ogni sapere, egli dice, sino al puro pensiero dell'Essere assoluto e
dell'accidentalità del sapere di fronte ad esso, è il punto più alto
della Dottrina della scienza ».
L'orientamento religioso
Lorientamento mistico, che tende a negare ogni valore al mondo e allo
stesso sapere umano, si accentua ancora nella Dottrina della scienza
esposta nel 1804. Se nello scritto del 1801 l'Assoluto è il limite iniziale
o superiore del sapere, sicché questo lo raggiunge intuendo la sua propria
origine o il non essere da cui emerge, nello scritto del 1804 l'Assoluto è
addirittura il principio di distruzione di ogni sapere possibile e perciò
si coglie solo nell'annullamento del sapere, quindi della coscienza e
dell'io, nella luce divina.
Fichte ripete qui il movimento dialettico di cui s'era valso nella prima
Dottrina della scienza a proposito del non-io. Come il non-io dev'essere
posto affinché l'io possa toglierlo di mezzo e trionfare su di esso con
l'azione morale, così ora il sapere concettuale dev'essere posto affinché
l'evidenza della luce divina possa distruggerlo e realizzarsi in questa
distruzione. La quale coinvolge l'io, che è il principio del sapere, ma
non è opera dell'io, ma della stessa luce divina.
Le varie rielaborazioni della Dottrina della scienza.
Delle successive elaborazioni della dottrina della scienza la più
notevole è quella del 1810 intitolata: La dottrina della scienza nel
suo disegno generale, dalla quale non si allontanano sostanzialmente
le rielaborazioni del 1812-1813. In essa l'essere è identificato con Dio,
in quanto è uno, immutabile, indivisibile. Il sapere, che sostituisce
all'unità divina la separazione di soggetto e oggetto, non è Dio ed è
fuori di Dio. Ma poiché l'essere divino è tutto in tutto, il sapere è
l'essere di Dio fuori di Dio, cioè l'esteriorizzazione di Dio. Esso non
è l'effetto di Dio, perché ciò introdurrebbe un mutamento nell'essere
divino, ma l'immediata conseguenza dell'essere assoluto, cioè l'immagine
o schema di lui. A sua volta l'autocoscienza è l'immagine o l'ombra del
sapere sicché, rispetto a Dio, viene ad essere l'ombra di un'ombra.
Siamo molto lontani, come si vede, dalla tesi della prima Dottrina della
scienza secondo la quale l'autocoscienza è il principio di ogni realtà.
Tranne lo scritto del 1810 (La Dottrina della scienza nei suoi tratti
generali), tutte le altre esposizioni e rielaborazioni del sistema di
Fichte rimasero inedite. Bisogna anche dire che sono di lettura assai
ingrata e che in esse il procedimento di Fichte appare lento e tortuoso.
Questi difetti dovettero apparire evidenti allo stesso Fichte che,
mentre trascurava di pubblicare quegli scritti, ne pubblicava altri,
destinati a esporre in forma popolare il nuovo orientamento del suo
pensiero. Questi scritti popolari sono: La missione degli uomini (1800);
L'introduzione alla vita beata o dottrina della religione (1806);
Sull'essenza del dotto e le sue manifestazioni nel campo della
libertà (1805); Cinque lezioni sulla missione del dotto (1811).
In questi scritti, l'orientamento religioso e misticheggiante dell'ultima
speculazione di Fichte trova una libera manifestazione e viene espresso
con le parole appropriate. Così lo scritto sulla Missione dell'uomo è
diviso in tre parti: il dubbio, la scienza e la fede, e Fichte descrive
la liberazione dell'uomo dalla costrizione del mondo naturale mediante la
scienza, e il passaggio dalla scienza alla fede.
Ancora più spiccatamente religioso è il tono dell'altro scritto (il più
importante fra quelli ora nominati), Introduzione alla vita beata.
Fichte pone qui la beatitudine nell'unione con Dio, in
quanto uno e assoluto, ma avverte contemporaneamente che anche in
quest'unione Dio non diventa il nostro essere, ma rimane fuori di noi che
ne abbracciamo solo l'immagine. Alla religione si arriva negando il
valore della realtà sensibile, vedendo nel mondo la semplice immagine di
Dio e sentendo agire e vivere Dio in noi stessi. All'unione con Dio,
Fichte si preoccupa di togliere il significato contemplativo che essa
sembra implicare. La religione non è un sogno devoto: è l'intimo spirito
che purifica il pensiero e lazione, ed è quindi moralità operante. Il
pensiero raggiunge l'esistenza,di Dio, cioè la sua rivelazione o la sua
immagine: l'essere di lui rimane al di là. L'esistenza di Dio s'identifica
col sapere o autocoscienza delluomo; ma il modo in cui essa deriva
dall'essere di Dio rimane inconcepibile. «L'esistenza deve comprendersi da
sé come pura esistenza, riconoscersi e formarsi come tale, e, di fronte
a se stessa, deve porre e formare un Essere assoluto, di cui essa sia
semplice esistenza: attraverso il proprio essere deve annientarsi di
fronte ad un'altra esistenza assoluta: ed appunto ciò forma il carattere
della pura immagine, dell'idea o della coscienza dell'essere».
Idealismo e cristianesimo.
Fichte vede nell'evangelo di S. Giovanni esposta una dottrina analoga e ne
deduce l'accordo del suo idealismo col cristianesimo. Là infatti è detto che
in principio era la Parola o Logos: e nella Parola o Logos Fichte riconosce
ciò che egli ha chiamato esistenza o rivelazione di Dio: il sapere, l'io,
l'immagine, di cui la vita divina è a fondamento. In tal modo, il ciclo
di sviluppo della dottrina di Fichte era concluso. Partito dal
riconoscimento dell'Io infinito come principio di deduzione della natura
finita dell'uomo, Fichte è giunto da ultimo a riconoscere il principio
infinito al di là dell'io, nell'Essere o Dio.
11. La filosofia della storia.
L'opera pubblicata da Fichte nel 1806, Tratti fondamentali dell'epoca
presente, espone una filosofia della storia che riproduce a suo modo e
non senza spunti polemici (come troppo spesso Fichte ha fatto nelle
ultime opere) le idee esposte da Schelling nel Sistema dell'idealismo
trascendentale (1800) e nelle Lezioni sull'insegnamento accademico (1802).
Fichte comincia col dichiarare che «lo scopo della vita dell'umanità sulla
terra è quello di conformarsi liberamente alla ragione in tutte le sue
relazioni» (Opere, 7, pagina 7).
I due stadi fondamentali della storia.
Rispetto a questo fine si distinguono nella storia dell'umanità
due stadi fondamentali: uno è quello in cui la ragione è ancora
incosciente, istintiva, ed è l'età dell'innocenza; l'altro è quello in
cui la ragione si possiede interamente e domina liberamente, ed è l'età
della giustificazione e della santificazione, il kantiano regno dei fini.
Le varie «epoche».
L'intero sviluppo della storia si muove tra queste due epoche ed è il
prodotto dello sforzo della ragione di passare dalla determinazione
dell'istinto alla piena libertà. Le epoche della storia sono determinate,
in modo puramente a priori e indipendentemente dall'accadimento dei fatti
storici, proprio da questo sforzo. La prima epoca è quella dell'istinto,
in cui la ragione governa la vita umana senza la partecipazione della
volontà. La seconda epoca è quella dell'autorità in cui l'istinto della
ragione si esprime in personalità potenti, in uomini superiori, che
impongono con la costrizione la ragione ad un'umanità incapace di
seguirla per conto suo. La terza epoca è quella della rivolta contro
l'autorità ed è la liberazione dall'istinto, di cui l'autorità stessa è
un'espressione. Sotto l'impulso della riflessione si sveglia nell'uomo il
libero arbitrio; ma la sua prima manifestazione è una critica negativa
di ogni verità e di ogni regola, un'esaltazione dell'individuo al di sopra
di ogni legge e di ogni costrizione. La quarta epoca è quella in cui la
riflessione riconosce la propria legge e il libero arbitrio accetta una
disciplina universale; è l'epoca della moralità. La quinta epoca è
quella in cui la legge della ragione cessa di essere un semplice ideale
per divenire interamente reale in un mondo giustificato e santificato,
nell'autentico regno di Dio. Le prime due epoche sono quelle del
dominio cieco della ragione, le due ultime quello del dominio
veggente della ragione. In mezzo, è l'epoca della liberazione, nella
quale la ragione non è più cieca ma non è ancora cosciente.
A quest'epoca appunto appartiene l'età presente, secondo Fichte;
la quale ha dietro di sé il dominio cieco della ragione ma non
ha ancora raggiunto il dominio veggente della ragione stessa. Il
paradiso è perduto, l'autorità è infranta, ma la conoscenza della ragione
non ancora domina. E questa l'età dell'Illuminismo che Fichte chiama
quella del volgare intelletto umano; è l'età in cui prevalgono gli
interessi individuali e personali e in cui perciò si fa continuamente
appello all'esperienza, perché l'esperienza soltanto manifesta quali sono
questi interessi e quali sono gli scopi ai quali essi tendono.
La storia come sviluppo della coscienza e del sapere.
Come progressivo realizzarsi della ragione nella sua libertà, la storia è
lo sviluppo della coscienza o del sapere. Ora il sapere è l'esistenza,
l'espressione, l'immagine compiuta della potenza divina. Considerato nella
totalità e nell'eternità del suo sviluppo, il sapere non ha altro oggetto
che Dio. Ma per i singoli gradi di questo sviluppo Dio è inconcepibile e
il sapere quindi si rompe nella molteplicità degli oggetti empirici che
costituisce la natura o nella molteplicità degli eventi temporali che
costituisce la storia. L'esistenza di fatto nel tempo appare tale da
poter essere diversa e perciò accidentale; ma questa apparenza deriva
soltanto dall'inconcepibilità dell'Essere che è a suo fondamento:
inconcepibilità che condiziona l'infinito progresso della storia. In
realtà né nella storia né altrove c'è nulla di accidentale ma tutto è
necessario e la libertà dell'uomo consiste nel riconoscere questa
necessità. Dice Fichte: « Nulla è com'è perché Dio vuole arbitrariamente
così, ma perché Dio non può manifestarsi altrimenti che così.
Riconoscere questo, sottomettersi umilmente ed essere beati nella
coscienza di questa nostra identità con la forza divina, è compito di
ogni uomo».
12. Fichte nella filosofia moderna.
Fichte e i contemporanei.
L'influenza di Fichte nella filosofia moderna è stata vasta e multiforme.
Ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi della sua «presenza»
culturale, ricordiamo innanzitutto come Fichte venga additato da
F. Schlegel come lo scopritore del concetto romantico di infinito e come
l'ispiratore ideale del nuovo movimento. Tant'è che lo stesso Schlegel non
tarda a sostenere che la Dottrina della scienza si configura, insieme
con la Rivoluzione francese e con il Wilhelm Meister di Goethe, come una
delle tre grandi «tendenze» del secolo. Analogamente, Jacobi non esita a
dire che se Kant è il Giovambattista della nuova età della cultura,
Fichte ne è indiscutibilmente il Messia. E Hölderlin scrive con tono
profetico all'amico Hegel: «Fichte è un titano che lotta per l'umanità e
il suo raggio di azione non resterà limitato alle pareti della sua aula».
Tutte «voci» che documentano dal vivo l'immediato successo dell'autore dei
Fondamenti di tutta la dottrina della scienza (1794), la cui fama varca
ben presto i confini dell'Università di Jena, suscitando l'interesse e il
plauso di molti personaggi del mondo politico e culturale: fra gli altri
di Schiller e di Goethe. I suoi più fervidi ammiratori sono comunque i
romantici, che traggono da lui alcune delle loro più importanti
convinzioni: il principio dell'infinito e della creatività dello spirito,
la dottrina della libertà dell'io e della sua potenza sul mondo, la tesi
dell'oggetto come «posizione» del soggetto, il titanismo, la concezione
della vita come Streben o sforzo infinito di superamento del finito, e
così via. Tuttavia il successo di Fichte presso i membri del circolo
dura abbastanza poco, poiché «il Romanticismo era qualcosa di troppo
complesso per poter essere imprigionato nelle formule del soggettivismo
fichtiano; esso includeva, almeno potenzialmente, altri interessi
mentali estranei a Fichte: l'amore goethiano del classico, e poi del
medievale, il sentimento della natura, il fervore dell'esperienza
religiosa, il senso della storia. La direzione degli spiriti passò ben
presto ad altre mani: Goethe, Schelling, Schleiermacher, Hegel,
detronizzarono Fichte dal suo effimero trono; e invano egli cercò di
mettersi alla pari col movimento degli altri e di esprimere, nel suo
linguaggio, le altrui esigenze». (G. De Ruggiero, Storia della filosofia,
L'età del Romanticismo, volume 1, capitolo 4, pagina 153.)
Fichte e l'idealismo.
La parabola involutiva delle fortune di Fichte presso i contemporanei
non toglie che egli, fondatore indiscusso dell'idealismo, abbia
spalancato le porte alla nuova «filosofia dello spirito» germanica,
influendo radicalmente su Schelling (vedi capitolo 5) e su Hegel (vedi
capitolo 6), dai quali è stato considerato come l'antesignano del
movimento, e nello stesso tempo bollato come il pensatore della
«soggettività», incapace di attingere l'oggetto e la natura (Schelling),ù
oppure la storia e l'Assoluto (Hegel). In particolare, Hegel, nella sua
costruzione storiografica, interpreta l'idealismo «soggettivo» di Fichte
come il momento della tesi, l'idealismo «oggettivo» di Schelling come il
momento dell'antitesi e il proprio idealismo «assoluto» come il momento
della sintesi, considerando il fichtismo come una filosofia ancora
prigioniera dell'ottica del finito, e per la quale l'infinito è solo
aspirazione impotente o meta irraggiungibile.
Il punto di vista hegeliano, e degli storici tedeschi od europei che a
lui si sono richiamati, ha fatto sì che Fichte abbia finito per essere
considerato soltanto in funzione di Hegel, e che di lui si sia preso in
considerazione quasi esclusivamente la prima filosofia, riducendone il
sistema religioso a tendenziale ripresa di schemi metafisici di natura
realistica e dogmatica. Tuttavia a cominciare dalla pubblicazione, a
cura del figlio Immanuel Hermann Fichte, degli inediti (1834-1835) e
delle opere complete (1845-1846), anche la sua filosofia religiosa ha
cominciato ad attirare l'attenzione degli studiosi: dapprima dei
rappresentanti dello stesso «teismo speculativo tedesco» di Fichte
junior (1797-1871) e di Christian Hermann Weisse (1801-1866), che si sono
richiamati a Fichte in funzione anti-hegeliana (Cfr. M. Ravera, Studi sul
teismo speculativo tedesco, Mursia, Milano 1974, nel quale si afferma che
una delle caratteristiche del discorso del cosiddetto Fichte junior è
«il richiamo, in funzione anti-hegeliana, dei temi dominanti l'ultima fase
dell'opera paterna, da lui profondamente studiata ed assimilata»
capitolo 1, pagina 22), e in seguito degli interpreti novecenteschi,
soprattutto di quelli che hanno scorto in essa il travagliato ma coerente
esito del filosofare fichtiano (Fra i contributi in questo senso
ricordiamo soprattutto quello del già citato L. Pareyson, il maggior
studioso italiano di Fichte, che nella sua monografia del 1950 (e riedita
recentemente, vedi le Indicazioni bibliografiche) si è battuto contro la
tesi tradizionale di un Fichte continuatore di Kant e anticipatore di
Hegel, e contro la tesi della presenza, in Fichte, di due filosofie
totalmente contrapposte e prive di motivi comuni. Uno dei nuclei della
presentazione pareysoniana consiste nell'immagine di Fichte come pensatore
che, pur all'interno di una «filosofia del finito», avrebbe tenuto fermo,
sin dall'inizio, la presenza dell'Assoluto, dapprima prospettato come
idealità etica e in seguito come realtà ontologica. Di conseguenza,
secondo Pareyson, la nuova filosofia religiosa non si configurerebbe come
una «negazione» o una «smentita» della prima, ma come un «approfondimento»
e «arricchimento» della medesima: «tutto lo sforzo di Fichte consisterà
nel trovare il modo di affermare l'assoluto evitando a un tempo
l'assolutizzazione del finito» (Fichte, Edizioni di Filosofia, Torino 1950,
volume 1, pagina 135).
Fichte e il neoidealismo.
Alcuni fra i temi più caratteristici del primo Fichte, soprattutto la
concezione dello spirito come attività autocreatrice ed eticità
intrinseca, tornano invece, in tutta la loro pregnanza, nel neoidealismo
di Giovanni Gentile (e seguaci), il quale, a torto o a ragione, è
apparso talora come una sorta di «Fichte redivivus», per la sua capacità
di recuperare in modo originale, al di là della stessa dialettica di
Hegel, la dialettica fichtiana di io e non-io, di atto e di fatto. I
critici hanno scorto tracce fichtiane anche ne L'Essere e il nulla di
Jean Paul Sartre, il cui esistenzialismo coscienzialistico, sebbene
orientato in senso anti-idealistico, appare dualisticamente strutturato
secondo la coppia del per sé (= la coscienza come libertà e potere
significante) e dell'in sé (= il dato opaco che riceve senso e valore in
virtù della coscienza).
Fichte come rappresentante tipico della concezione moderna dell'uomo.
In realtà, come dimostra il caso di Sartre (e di altri che potrebbero
essere citati), la presenza di Fichte nella filosofia successiva, al di
là dell'influsso diretto su questo o quel pensatore idealista,
spiritualista o coscienzialista, va ricercata soprattutto nella sua
visione attivistica ed etica dell'esistenza, che fa di lui il
rappresentante tipico della concezione moderna dell'uomo, ossia di quella
interpretazione del vivere come impegno, sforzo, missione, dover-essere,
libertà e movimento, che è tipica, ancor oggi, dell'Occidente.
Indicazioni bibliografiche
E. Severino, Per un rinnovamento nell'interpretazione della filosofia
fichtiana, La Scuola, Brescia 1960.
P. Salvucci, Dialettica e immaginazione in Fichte, Argalia, Urbino 1963.
G. Duso, Contraddizione e dialettica nella formazione del primo Fichte,
Argalia, Urbino 1974.
C. Cesa, Fichte e il primo idealismo, Sansoni, Firenze 1975.
L. Pareyson, Fichte, Ed. di Filosofia, Torino 1950; nuova edizione Mursia,
Milano 1976.
F. Moiso, Natura e cultura nel giovane Fichte, Mursia, Milano 1979.
C. Luporini, Fichte e la destinazione del dotto, in Filosofi vecchi e
nuovi, Editori Riuniti, Roma 1981.
M. Ivaldo, Fichte. L'assoluto e l'immagine, Studium, Roma 1983.
G. Di Tommaso, Dottrina della scienza e genesi della filosofia della
storia nel primo Fichte, Japarade, L'Aquila 1986.
R. Lauth, La filosofia trascendentale di J. G. Fichte, traduzione italiana,
Guida, Napoli 1986.
N. Ivaldo, I princìpi del sapere. La visione trascendentale di Fichte,
Bibliopolis, Napoli 1987.
Glossario e riepilogo:
- La dottrina della scienza è quel sapere «assolutamente certo e
infallibile» che si identifica con l'esposizione del «sistema dello
spirito umano» (Sul concetto della dottrina della scienza o della così
detta filosofia, sezione 2, paragrafo 7). Tale sapere prende la forma di
una scienza della scienza, ossia di una teoria volta a mettere in luce il
principio primo (vedi) su cui si fonda ogni scienza, per poi dedurre (vedi)
da esso tutto lo scibile.
- Il principio primo del sapere è, per Fichte, l'Io (vedi) stesso. Infatti,
ogni altro preteso principio (ad esempio la legge di identità: A = A)
presuppone l'Io ed è posto dall'Io: «Noi siamo partiti dalla proposizione:
A = A, non come se da essa si potesse dedurre la proposizione: Io sono,
ma perché dovevamo partire da una qualunque proposizione certa, data
nella coscienza empirica. Ma anche nella nostra spiegazione si è visto
che non la proposizione: A = A è il fondamento della proposizione: Io
sono, ma che piuttosto quest'ultima è il fondamento della prima»
(Fondamenti dell'intera dottrina della scienza, parte prima, paragrafo 1).
A sua volta, l'Io non è posto da altri, ma si configura come un'attività
auto-creatrice (vedi) che si pone da sé.
- La deduzione fichtiana è la dimostrazione e la giustificazione
sistematica di tutte le proposizioni della filosofia per mezzo dell'Io.
A differenza di quella kantiana, che è una deduzione trascendentale o
gnoseologica, cioè diretta a giustificare le condizioni soggettive della
conoscenza (le categorie), la deduzione fichtiana è una deduzione
assoluta o metafisica, poiché intende servirsi dell'Io, che a sua volta è
indeducibile, essendo dato a se stesso tramite un atto di intuizione
intellettuale (vedi), per spiegare l'intero sistema della realtà: «Tutto il
dimostrabile deve essere dimostrato - tutte le proposizioni debbono essere
dedotte tranne quel primo e supremo principio» (Concetto Della Dottrina
della Scienza, sezione 2, parte 7). Hegel vedrà in questo procedimento un
punto d'onore della filosofia di Fichte: «Alla filosofia fichtiana spetta
il profondo merito di aver fatto avvertire che le determinazioni del
pensiero son da dimostrare nella loro necessità; che sono essenzialmente
da dedurre, (Enc., paragrafo 42).
- L'Autocoscienza di cui parla Fichte si identifica con l'Io (vedi), ovvero
con la consapevolezza che il soggetto ha di se medesimo. Consapevolezza
che sta alla base di ogni conoscenza. Infatti, io posso avere coscienza
di un oggetto qualsiasi solo in quanto ho nello stesso tempo coscienza
di me stesso: «Non si può pensare assolutamente nulla senza pensare in
pari tempo il proprio Io come cosciente di se stesso; non si può mai
astrarre dalla propria autocoscienza» (Fondamenti della Dottrina della
Scienza, parte prima, paragrafo 1,7). In quanto Autocoscienza, l'Io
risulta quindi, per definizione, un'attività che ritorna sopra di sé:
«io e agire ritornante in sé sono concetti affatto identici, (Seconda
introduzione alla Dottrina della Scienza). Il concetto di
Autocoscienza è strettamente collegato a quello di intuizione
intellettuale (vedi).
- Per intuizione intellettuale Fichte intende l'auto-intuizione immediata
che l'Io ha di se stesso in quanto attività auto-creatrice. Attività per
la quale conoscere qualcosa (se medesimi o gli oggetti) significa fare o
produrre tale qualcosa ed esserne, implicitamente o esplicitamente
consapevoli. Ecco, a tale proposito, uno dei testi più significativi ed
accessibili di Fichte: «chiamo intuizione intellettuale quest'intuizione
di se stesso di cui è ritenuto capace il filosofo, nell'effettuazione
dell'atto con cui insorge per lui l'io. Essa è la coscienza immediata che
io agisco, e di ciò che agisco: essa è ciò per cui so qualcosa perché la
faccio. Che una tale facoltà dellintuizione intellettuale esista, non si
può dimostrare per concetti, né si può sviluppare da concetti quello che
essa è. Ognuno deve trovarla immediatamente in se stesso, altrimenti
non imparerà mai a conoscerla. La richiesta di dimostrargliela per
ragionamenti è ancor più sorprendente di quella, ipotetica, di un cieco
nato di spiegargli, senza ch'egli debba vedere, che cosa sono i colori.
E però possibile dimostrare a ciascuno nella sua esperienza personale da
lui stesso ammessa che quest'intuizione intellettuale è presente in tutti
i momenti della sua coscienza. Io non posso fare un passo, muovere una
mano o un piede, senza l'intuizione intellettuale della mia autocoscienza
in queste azioni; solo mercé quest'intuizione so di essere io a compierli,
solo in forza di essa distinguo il mio agire, e me in esso, dall'oggetto,
in cui m'imbatto, dell'azione. Chiunque si attribuisce un'attività fa
appello a qust'intuizione. In essa è la fonte della vita, e senza di essa
è la morte» (Seconda introduzione alla Dottrina della Scienza).
N.B.
1) L'intuizione intellettuale, come risulta dal passo citato, è presente
a ciascuno, sebbene raggiunga la piena coscienza di sé solo nel filosofo.
2) Con il concetto di intuizione intellettuale Fichte attribuisce all'uomo
quell'intuito creatore che Kant attribuiva solo a Dio.
- Per Io Fichte intende il principio assolutamente primo, assolutamente
incondizionato, di tutto l'umano sapere (F.D.S., sezione 1, paragrafo 1),
ovvero un'attività autocreatrice (vedi), libera (vedi), assoluta (vedi)
ed infinita (vedi). In Fichte assistiamo quindi ad una sorta di
enfatizzazione metafisica dell'Io, che da semplice condizione del conoscere
(com'era l'Io penso di Kant) diviene la fonte del reale, cioè Dio.
- L'Io è un'attività autocreatrice poiché esso, a differenza delle cose,
che sono quello che sono, pone o crea se stesso: «Ciò il cui essere (o la
cui essenza) consiste puramente nel porsi come esistente, è l'Io come
soggetto assoluto» (F.D.S.,sezione 1, paragrafo 1), «L'Io è quel che esso
si pone» (ivi, 1, 9). Questa prerogativa dell'Io viene illustrata da
Fichte con il concetto di Tathandlung (vedi).
- Tathandlung è un termine caratteristico che usa Fichte per alludere al
fatto che l'Io è, nello stesso tempo, attività agente (Tat) e il prodotto
dell'azione stessa (Handlung), ovvero che l'Io è ciò che egli stesso si
crea o produce (esse sequitur agere: noi siamo quel che ci facciamo).
«L'Io pone se stesso ed è in forza di questo puro porsi per se stesso (...)
Esso è, in pari tempo, l'agente e il prodotto dell'azione; ciò che è
attivo e ciò che è prodotto dell'attività, (F.D.S, 1, 6).
- In quanto attività auto-creatrice, l'Io risulta strutturalmente libertà.
«L'assoluta attività, scrive Fichte, la si chiama anche libertà. La
libertà è la rappresentazione sensibile dell'auto-attività».
- In quanto attività creatrice ed auto-creatrice, l'io è, per definizione,
un essere assoluto, ovvero un ente in-condizionato ed in-finito che non
dipende da altro, ma da cui tutto il resto dipende.
- In quanto assoluto, l'Io è infinito. Infatti, tutto ciò che esiste esiste
soltanto nell'Io e per l'Io, il quale, di conseguenza, ha tutto dentro di
sé e nulla fuori di sé: «In quanto è assoluto l'Io è infinito e
illimitato. Esso pone tutto ciò che è; e ciò che esso non pone, non è
(per esso; e fuori di esso non cè nulla)... Quindi, in questo riguardo,
l'Io abbraccia in sé tutta la realtà... (F.D.S., 3, 5; 2).
- L'Io è detto anche, con linguaggio kantiano, Io puro, poiché esso si
identifica con un'attività scevra (= pura) da condizionamenti empirici.
- I princìpi della Dottrina della scienza, ossia le cosiddette
«proposizioni fondamentali (Grundsätze) della deduzione fichtiana, sono
tre. La prima afferma che «l'Io pone se stesso» (das Ich setzt sich selbsf).
La seconda che «l'Io pone un non-io» (das Ich setzt ein Nicht-Ich). La
terza che «l'Io oppone nell'Io ad un io divisibile un non-io divisibile»
(das Ich setzt im Ich dem teilbaren Ich ein teilbares Nicht-Ich entgegen).
In altri termini, la prima proposizione stabilisce come il concetto di Io
in generale si identifichi con quello di un'attività auto-creatrice (vedi)
ed infinita (vedi). La seconda stabilisce che l'Io non solo pone se stesso,
ma oppone anche a se stesso qualcosa che, in quanto gli è opposto è
non-io (vedi). Tale non-io è tuttavia posto dall'Io ed è quindi nell'Io.
Il terzo principio mostra come l'Io, avendo posto il non-io, si trovi ad
essere limitato da esso, ovvero ad esistere sotto forma di un io
"divisibile" (= molteplice e finito) avente di fronte a sé altrettanti
oggetti divisibili.
N.B. Il secondo principio, osserva Fichte, non risulta, a rigore,
deducibile dal primo «poiché la forma dell'opporre è così poco compresa
nella forma del porre, che le è anzi piuttosto opposta» (Fondamenti
dell'intera D.S.,1,2). Il che è un modo per dire che il finito non risulta
deducibile dall'infinito, ossia che «fra l'assoluto e il finito v'è un
intervallo, uno iato, una soluzione di continuità» (L. Pareyson). Tutto
ciò non toglie, come risulta chiaro soprattutto dalla terza ed ultima parte
della Dottrina della scienza che il non-io funzioni da «urto»
indispensabile per mettere in moto l'attività dell'Io e si configuri
quindi come condizione necessaria affinché vi sia un soggetto reale:
«l'attività dell'Io procedente all'infinito deve essere urtata in un punto
qualunque e respinta in se stessa (...). Che questo accada, come fatto,
non si può assolutamente dedurre dall'Io, come più volte è stato
ricordato; ma si può certamente dimostrare che questo fatto deve
accadere, affinché una coscienza reale sia possibile» (Fondamenti
dell'intera D.S., 3, 5,2). In altri termini, pur essendo indeducibile,
in assoluto, dall'equazione Io = Io, il non-io risulta indispensabile per
spiegare l'esistenza di una coscienza concreta, la quale postula
necessariamente la struttura bipolare soggetto-oggetto, attività-ostacolo,
posizione-opposizione: «quell'opposto non fa se non mettere in movimento
l'Io per l'azione, e senza tale primo motore al di fuori di esso, l'Io non
avrebbe mai agito; e poiché la sua esistenza non consiste se non
nell'attività, non sarebbe neppure esistito» (ivi).
- Non-io. Con questo termine Fichte intende il mondo oggettivo in quanto è
posto dall'Io ma opposto all'Io: «Nulla è posto originariamente tranne
l'Io; questo soltanto è posto assolutamente. Perciò soltanto all'Io si può
opporre assolutamente. Ma ciò che è opposto all'Io è = Non-io»
(Fondamenti dell'intera D.S., 1, 2, 9).
N.B. «Non-io», «oggetto», «ostacolo», «natura», «materia», eccetera in
Fichte sono tutti termini equivalenti. In concreto, il non-io si identifica
con la natura interna (il nostro corpo e i nostri impulsi) ed esterna
(le cose prive di ragione).
- L'io finito o «divisibile» o «empirico» è l'Io, il quale, avendo posto
il non-io, si trova ad essere limitato da esso, cioè ad esistere
concretamente sotto forma di un individuo condizionato dalla natura
(interna ed esterna) e per il quale la purezza (vedi) dell'Io assoluto
rappresenta solo un ideale o una missione (vedi la voce seguente).
- Il rapporto fra l'Io infinito e gli io finiti può essere descritto
dicendo che l'Io non è tanto la sostanza o la radice metafisica degli io
finiti, quanto la loro mèta ideale. Anzi, l'infinito, per l'uomo, più che
consistere in un'essenza già data, si configura come dover-essere e
missione. Tanto più che l'Io infinito coincide con un Io assolutamente
libero, ossia con uno spirito scevro di ostacoli e di limiti. Situazione
che per l'uomo rappresenta una semplice aspirazione. Di conseguenza, dire
che l'Io infinito è la missione o il dover-essere dell'io finito significa
dire che l'uomo è uno sforzo infinito (vedi) verso la libertà, ovvero una
lotta inesauribile contro il limite. Infatti, se l'uomo riuscisse davvero
a vincere tutti i suoi ostacoli, si annullerebbe come Io, cioè come
attività.
- Dialettica. Con questo termine, tipico di Hegel, si intende il
principio - già presente in Fichte sin dalla Dottrina della scienza del
1794 - della struttura triadica della vita spirituale (tesi - antitesi -
sintesi) e il concetto di una «sintesi degli opposti per mezzo della
determinazione reciproca» (F.D.S., 2, 4). Gli opposti o i contrari di cui
parlava Fichte erano l'Io (la tesi) ed il non-io (l'antitesi) e la
sintesi loro reciproca determinazione.
- Il dogmatismo, secondo Fichte, è quella posizione filosofica che consiste
nel partire dalla cosa in sé e dall'oggetto per poi spiegare, su questa
base, l'Io o il soggetto. In virtù delle sue premesse, l'idealismo, che è
una forma di realismo in gnoseologia e di naturalismo in metafisica,
finisce sempre per sfociare nel determinismo e nel fatalismo: «ogni
dogmatico conseguente è per necessità fatalista (...) nega del tutto
quell'autonomia dell'Io, su cui l'idealista costruisce, e fa dell'Io
nient'altro che un prodotto delle cose, un accidente del mondo: il
dogmatico conseguente è per necessità anche materialista (Prima
introduzione alla D.S.).
- L'idealismo, secondo Fichte, è quella posizione filosofica che consiste
nel partire dall'Io e dal soggetto per poi spiegare, su questa base, la
cosa o l'oggetto: «Il contrasto tra l'idealista e il dogmatico consiste
propriamente in ciò: se l'autonomia dell'io debba essere sacrificata a
quella della cosa o viceversa» (Prima introduzione alla D.S.); «l'essenza
della filosofia critica consiste in ciò, che un Io assoluto viene posto
come assolutamente incondizionato e non determinabile da nulla di più
alto» (Fondamenti dell'intera D.S., 1, 3, D,7); « Nel sistema critico la
cosa è ciò che è posto nell'Io; nel dogmatico, ciò in cui l'Io stesso è
posto» (ivi).
N.B. La difesa della autonomia e incondizionatezza dell'Io fa sì che
l'idealismo si configuri, per definizione, come una dottrina della libertà.
- La scelta fra idealismo e dogmatismo secondo Fichte dipende da come si è
come uomini, ossia da un'opzione etica di fondo, in quanto l'individuo
fiacco e inerte sarà spontaneamente portato al dogmatismo e al
naturalismo, mentre l'individuo solerte e attivo sarà spontaneamente
portato all'idealismo: «La ragione ultima della differenza fra idealista e
dogmatico è (...) la differenza del loro interesse. L'interesse supremo,
principio di ogni altro interesse, è quello che abbiamo per noi stessi.
Il che vale anche per il filosofo (...). La scelta di una filosofia
dipende da quel che si è come uomo, perché un sistema filosofico non è
un'inerte suppellettile, che si può lasciare o prendere a piacere, ma è
animato dallo spirito dell'uomo che l'ha. Un carattere fiacco di natura o
infiacchito e piegato dalle frivolezze, dal lusso raffinato e dalla
servitù spirituale, non potrà mai elevarsi all'idealismo».(Prima
introduzione alla D.S.).
- Per conoscenza Fichte intende l'azione del non-io sull'io. Egli si
proclama realista e idealista al tempo stesso: realista perché ammette
un'influenza del non-io sull'io; idealista perché ritiene che il non-io sia
un prodotto dell'Io. Prendendo le distanze sia dall'idealismo dogmatico
(che vanifica l'oggetto), sia dal realismo dogmatico (che vanifica il
soggetto), Fichte scrive: «La dottrina della scienza è dunque realistica.
Essa mostra che è assolutamente impossibile spiegare la coscienza delle
nature finite se non si ammette l'esistenza di una forza indipendente da
esse, affatto opposta a loro, e dalla quale quelle nature dipendono per
ciò che riguarda la loro esistenza empirica (...). Tuttavia, malgrado il
suo realismo, questa scienza non è trascendente, ma resta trascendentale
nelle sue più intime profondità. Essa spiega certo ogni coscienza con
qualcosa, presente indipendentemente da ogni coscienza; ma anche in
questa spiegazione non dimentica di conformarsi alle sue proprie leggi;
ed appena essa vi riflette su, quel termine indipendente diventa di
nuovo un prodotto della sua propria facoltà di pensare, quindi qualcosa
di dipendente dall'Io, in quanto deve esistere per l'Io (nel concetto
dell'Io)»; «Questo fatto, che lo spirito finito deve necessariamente porre
al di fuori di sé qualcosa di assoluto (una cosa in sé), e tuttavia,
dall'altro canto, riconoscere che questo qualcosa esiste solo per esso
(è un noumeno necessario), è quel circolo che lo spirito può
infinitamente ingrandire, ma dal quale non può mai uscire. Un sistema
che non bada punto a questo circolo è un idealismo dogmatico, poiché
propriamente solo il circolo indicato ci limita e ci rende esseri
finiti; un sistema che immagini di esserne uscito è un dogmatismo
trascendentale realistico. La dottrina della scienza tiene precisamente
il mezzo tra i due sistemi ed è un idealismo critico che si potrebbe
chiamare un real-idealismo, o un ideal-realismo... »(Fondamenti
dell'intera D.S., 3, 5, 2).
- Per immaginazione produttiva Fichte intende l'atto inconscio attraverso
cui l'Io pone, o crea, il non-io, ovvero il mondo oggettivo di cui l'io
finito ha coscienza: «ogni realtà - ogni realtà per noi, si capisce, come
del resto non può intendersi altrimenti in un sistema di filosofia
trascendentale non è prodotta se non dall'immaginazione» (Fondamenti
dell'intera D.S., 2, 4, E, 3, 13), «nella riflessione naturale, opposta
a quella artificiale della filosofia trascendentale (...) non si può
indietreggiare se non fino all'intelletto, e in questo si trova poi,
certamente, qualcosa di dato alla riflessione, come materia della
rappresentazione; ma del modo come ciò sia venuto nell'intelletto, non si
è coscienti. Da qui la nostra salda convinzione della realtà delle cose
fuori di noi e senza alcun intervento nostro, perché non siamo coscienti
della facoltà che le produce. Se nella riflessione comune noi fossimo
coscienti, come certo possiamo esserlo nella riflessione filosofica, che
le cose esterne vengono nell'intelletto solo per mezzo dell'immaginazione,
allora vorremmo di nuovo spiegare tutto come illusione, e per questa
seconda opinione avremmo torto non meno che per la prima, (ivi, Deduzione
della rappresentazione, 3).
- La morale, per Fichte, consiste nell'azione dell'Io sul non-io e assume
la forma di un dovere volto a far trionfare, al di là di ogni ostacolo,
lo spirito sulla materia. Dovere che esprime il senso di quello sforzo
(vedi) che è l'Io: «Il mio mondo è oggetto e sfera dei miei doveri, e
assolutamente niente altro...» (La missione dell'uomo).
- Lo sforzo (Streben), che Fichte definisce un concetto importantissimo
per la parte pratica della dottrina della scienza, coincide con l'essenza
stessa dell'uomo, inteso come compito infinito di auto-liberazione dell'Io
dai propri ostacoli: «L'io è infinito, ma solo per il suo sforzo; esso si
sforza di essere infinito. Ma nel concetto stesso dello sforzo è già
compresa la finità...» (Fondamenti, 3, 5, 2).
N.B. In altri termini, Fichte riconosce nell'ideale etico il vero
significato dell'infinità dell'Io. L'Io è infinito (sia pure tramite un
processo esso stesso infinito) poiché si rende tale, svincolandosi dagli
oggetti che esso stesso pone. E pone questi oggetti perché senza di essi
non potrebbe realizzarsi come attività e libertà.
- Primato della ragion pratica. Con questa espressione Kant aveva
designato il fatto che la morale ci dà, sotto forma di postulati, ciò
che la scienza ci nega (la libertà, l'immortalità e Dio). Fichte intende
invece, con essa, il fatto che la conoscenza e l'oggetto della conoscenza
esistono solo in funzione dell'agire: «La ragione non può essere neppure
teoretica, se non è pratica» (Fondamenti), «Tu non esisti per contemplare
e osservare oziosamente te stesso o per meditare malinconicamente le tue
sacrosante sensazioni; no, tu esisti per agire; il tuo agire e soltanto
il tuo agire determina il tuo valore» (La missione dell'uomo), «Noi agiamo
perché conosciamo, ma conosciamo perché siamo destinati ad agire; la
ragion pratica è la radice di ogni ragione» (ivi).
N.B. Di conseguenza, il criticismo etico di Kant diviene, con Fichte, una
forma di moralismo metafisico che vede nell'azione la ragion d'essere e lo
scopo ultimo dell'universo.
- Il pensiero del primo Fichte è stato denominato idealismo soggettivo ed
etico in quanto fa dell'Io o del soggetto il principio da cui tutto deve
essere dedotto e concepisce l'azione morale come la chiave di
interpretazione della realtà (= moralismo).
- Secondo Fichte il fine dell'uomo in società è quello di farsi liberi e
di rendere liberi gli altri, in vista della completa unificazione e
concordia di tutti gli individui: «è uno degli impulsi fondamentali
dell'uomo quello di poter riconoscere fuori di sé esseri razionali simili
a lui (...). Luomo è destinato a vivere in società, deve vivere in
società; se vivesse isolato non sarebbe uomo compiutamente...» (La
missione del dotto), «è la missione della nostra schiatta quella di unirsi
in un corpo unico, completamente noto a se stesso in tutte le sue parti e
progredito ovunque allo stesso modo» (La missione dell'uomo).
- La missione del dotto, in quanto educatore e maestro dell'umanità, è
quella di additare i fini essenziali del vivere insieme e di segnalare i
mezzi idonei per il loro conseguimento, in vista del perfezionamento
progressivo della specie.
- In conclusione, il compito supremo dell'uomo (come singolo, come essere
sociale e come dotto) è quello di avvicinarsi indefinitamente alla
perfezione: «Il fine ultimo dell'uomo è quello di sottomettere ogni cosa
irrazionale e dominare libero secondo la sola sua legge, fine che non è
affatto raggiungibile e tale deve eternamente rimanere se l'uomo non deve
cessare di essere uomo per diventare Dio. Dallo stesso concetto di uomo
ricaviamo che il suo fine è irraggiungibile e la via che porta ad esso
infinita. Non è dunque il raggiungimento di questo fine la missione
dell'uomo. Ma egli può e deve perpetuamente avvicinarsi ad esso e questo
infinito avvicinarsi al fine è la sua missione di uomo, cioè di essere
razionale eppur finito, sensibile eppur libero. Quel pieno accordo con
se stesso si chiama perfezione nel più alto significato della parola; la
perfezione è dunque il più alto e irraggiungibile fine dell'uomo e il
perfezionamento all'infinito è la sua missione. Egli esiste per divenire
sempre migliore e per rendere tale tutto ciò che materialmente e
moralmente lo circonda; di conseguenza per divenire sempre più felice»
(La missione del dotto).
STORIA DELLA FILOSOFIA
NICOLA ABBAGNANO
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
VOLUME TERZO
PARTE SECONDA: L'IDEALISMO ROMANTICO TEDESCO
CAPITOLO 5: Schelling
1. La vita.
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling nacque a Leomberg il 21 gennaio 1775.
A 16 anni entrò nel seminario teologico di Tubinga; e in questa città si
legò di amicizia con Hölderlin e Hegel, dei quali era più giovane di
cinque anni. In seguito studiò matematica e scienze naturali a Lipsia e
fu anche per un certo periodo a Jena, dove ascoltò le lezioni di Fichte.
A Jena.
Nel 1798 (a 23 anni) Schelling fu, per l'appoggio di Goethe, nominato
coadiutore di Fichte a Jena, e l'anno dopo, in seguito alle dimissioni di
Fichte, subentrava al suo posto. A Jena visse gli anni più fecondi della
sua vita ed ebbe contatti culturali con i romantici A. W. Schlegel,
Tieck, Novalis. Qui sposò Caroline Schlegel (1803), dopo che ella ebbe
divorziato dal marito A. W. Schlegel.
A Würzburg.
In seguito, Schelling passò a insegnare a Wurzburg (1803) dove rimase fino
al 1806, anno in cui, essendo la città stata assegnata a un principe
austriaco, il soggiorno dei professori protestanti all'Università divenne
impossibile.
A Monaco.
Si recò allora a Monaco dove divenne segretario dell'Accademia delle Belle
Arti e in seguito segretario della classe filosofica dell'Accademia delle
Scienze. Nel frattempo, Schelling rompe l'amicizia con Hegel (da cui era
stato attaccato nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, 1807)
e assiste amareggiato al suo trionfo, che segna anche il declino delle
fortune schellinghiane. A Monaco vive, in questo periodo, isolato e
quasi oscuro. Si lega di amicizia col naturalista teosofo Baader che
attira la sua attenzione sull'opera di Jacob Boehme. Nel 1809 gli muore la
moglie Caroline e tre anni dopo si sposa con la figliuola di un'amica di lei.
A Erlangen e a Monaco.
Nel 1820 Schelling ritorna all'insegnamento a Erlangen e nel 1827
passa a insegnare a Monaco dove rimane sino al 1841. In quest'anno fu
chiamato a succedere a Hegel nella cattedra di Berlino e capitanò, in
qualche modo, la reazione contro l'hegelismo che si andava profilando in
Germania. Nel 1847 smise di tenere i suoi corsi pubblici; e il 20 agosto
1854 moriva a Ragaz, in Svizzera, dove si era recato per motivi di cura.
Gli interessi.
L'interesse dominante di Schelling è rivolto alla natura ed all'arte e,
in seguito, al problema metafisico-religioso. Situata tra il soggettivismo
assoluto di Fichte e il razionalismo assoluto di Hegel, la speculazione
di Schelling ha dovuto combattere su due fronti e, accettando lo stesso
principio dell'infinità che è la base dell'uno e dell'altro, ha dovuto
tentare di garantire a questo principio un carattere di oggettività o di
realtà capace di renderlo adatto a spiegare il mondo della natura e
dell'arte. In un secondo tempo, dopo la svolta religiosa, ha preso ancor
più radicalmente le distanze dai presupposti panlogistici ed
immanentistici dell'hegelismo, pervenendo ad un nuovo tipo di filosofia.
2. Fasi del pensiero e scritti principali.
I momenti del filosofare schellinghiano.
Lo sviluppo del pensiero di Schelling risulta estremamente complesso e
oggetto di discussioni critiche. In generale gli studiosi tendono a
distinguere sei momenti o tappe del suo filosofare:
1) l'iniziale momento «fichtiano» (1795-1796)
2) la fase della «filosofia della natura» (1797-1799)
3) il periodo dell'«idealismo trascendentale» (1800)
4) lo stadio della «filosofia dell'identità» (1801-1804)
5) il periodo «teosofico» e della «filosofia della libertà » (1804-1811)
6) la fase della «filosofia positiva» e della «filosofia della religione»
(1815-1854).
Gli scritti.
La produzione filosofica di Schelling, abbondantissima negli anni della
gioventù (sino al 1804) in seguito fu assai scarsa. Gli scritti
principali sono: Idee per una filosofia della natura (1797); Intorno
all'anima del mondo (1798); Primo progetto di un sistema della filosofia
della natura (1799); Sistema dell'idealismo trascendentale (1800), che è
la sua opera più sistematica; Bruno, dialogo (1802); 14 lezioni
sull'insegnamento accademico( 1803); Ricerche filosofiche sull'essenza
della libertà umana (1809). Dopo questo scritto, negli ultimi 45 anni
della sua vita, Schelling non pubblicò che 4 brevi scritti. I corsi che
tenne a Berlino e che rappresentano l'ultima fase, che egli chiamò
positiva, del suo pensiero, Filosofia della mitologia e Filosofia della
rivelazione, furono pubblicati dal figlio, dopo la sua morte.
3. L'Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a Fichte.
Il principio che aveva assicurato il successo della filosofia di Fichte
è quello dell'infinito: infinita attività che spiega ad un tempo l'Io e il
non-io, lo spirito e la natura. Il riconoscimento e l'affermazione
dell'infinito determinano l'entusiasmo che la dottrina di Fichte suscitò,
perché esprimono l'aspirazione dell'epoca.
L'idea fichtiana e romantica dell'infinito.
La filosofia di Kant è una filosofia del finito e si muove perciò,
come Kant stesso riconobbe, nell'ambito dell'Illuminismo. La filosofia di
Fichte è una filosofia dell'infinito dentro e fuori l'uomo ed
apre l'epoca del Romanticismo. Schelling e i romantici vedono chiaramente
che la filosofia di Fichte apre un nuovo indirizzo, o, come essi dicono,
una nuova èra della speculazione; e, per quanto divengano ben presto
impazienti di dare al principio fichtiano nuovi sviluppi, incompatibili
con la dottrina di Fichte, non è meno vero che questi sviluppi muovono
tutti da quel principio che, proprio con tale dottrina, aveva fatto la
sua clamorosa comparsa in filosofia.
Per ciò che riguarda Schelling, fin dalla prima entusiastica accettazione
del fichtismo, egli cerca di volgerlo all'illustrazione e alla difesa
degli interessi che più gli stanno a cuore, quelli naturalistico-estetici.
Fin da principio egli riporta, con assai maggior energia di Fichte, l'Io
assoluto alla sostanza di Spinoza: la sostanza di Spinoza è il principio
dell'infinità oggettiva, l'Io di Fichte è il principio dell'infinità
soggettiva.
L'Assoluto Schellinghiano.
Schelling vuole unire le due infinità nel concetto di un Assoluto che
non è riducibile né al soggetto né all'oggetto, perché dev'essere il
fondamento dell'uno e dell'altro. Ben presto egli si accorge che una pura
attività soggettiva (l'Io di Fichte) non potrebbe spiegare la nascita del
mondo naturale, e che un principio puramente oggettivo (la Sostanza
spinoziana) non potrebbe spiegare l'origine dell'intelligenza e dell'io.
Il principio supremo dev'essere quindi un Assoluto o Dio che sia insieme
soggetto e oggetto, ragione e natura; cioè che sia l'unità, l'identità o
l'indifferenza di entrambi.
Il rifiuto del concetto fichtiano di natura.
In realtà se Fichte si rivolgeva alla natura soltanto per scorgervi il
teatro dell'azione morale o addirittura per dichiararla (da un punto di
vista religioso) « un puro nulla», Schelling si rifiuta di sacrificare
la realtà della natura e con essa quella dell'arte, che alla natura è
strettamente congiunta. La natura, secondo Schelling, ha vita,
razionalità, e quindi valore, in se stessa. Deve avere in sé un
principio autonomo che la spieghi in tutti i suoi aspetti. E questo
principio dev'essere identico a quello che spiega il mondo della ragione
e dell'io, quindi la storia. Il principio unico dev'essere insieme
soggetto e oggetto, attività razionale e attività inconsapevole,
idealità e realtà. Tale è infatti l'Assoluto per Schelling.
Le due direzioni del pensiero schenllinghiano.
Il riconoscimento del valore autonomo della natura e la tesi
dell'Assoluto come identità o indifferenza di natura e spirito (che
rappresentano i due punti chiave su cui egli si differenzia da Fichte)
conducono Schelling ad ammettere due possibili direzioni della ricerca
filosofica: l'una, la filosofia della natura, diretta a mostrare come la
natura si risolva nello spirito, l'altra, la filosofia trascendentale,
diretta a mostrare come lo spirito si risolva nella natura. Poiché non
c'è una natura che sia puramente natura (cioè pura oggettività) e non c'è
uno spirito che sia puramente spirito (cioè pura soggettività), così
un'indagine che sia diretta alla natura giunge necessariamente allo
spirito e un'indagine che sia diretta allo spirito giunge necessariamente
alla natura.
4. La filosofia della Natura.
4.1. La struttura finalistica e dialettica del reale.
La filosofia della natura di Schelling è una costruzione tipicamente
«romantica» (cfr. capitolo 2), la quale, prendendo spunto dai problemi
sollevati dalla Critica del Giudizio di Kant (a proposito della finalità
degli organismi viventi) e dalla Dottrina della scienza di Fichte (cfr.
paragrafo 3), si nutre di suggestioni disparate, che provengono sia dalla
scienza dell'epoca (in particolare dalla chimica e dagli studi
sull'elettricità e sul magnetismo) sia dalla cultura filosofica del
passato (dal pensiero greco e cristiano, dal naturalismo rinascimentale,
da Spinoza e da Leibniz).
Il rifiuto del meccanicismo e del finalismo tradizionale.
Alla base di tale filosofia, che si trova esposta in varie opere (alle
quali accenneremo di volta in volta) sta il rifiuto dei due tradizionali
modelli esplicativi della natura: quello meccanicistico-scientifico da un
lato e quello finalistico-teologico dall'altro. Il primo, parlando in
termini di materia, movimento e causa si trova in difficoltà, come aveva
già notato Kant, a spiegare gli organismi viventi. Il secondo,
ricorrendo alla «magia» di un Intelletto divino agente dall'esterno del
mondo, finisce per compromettere l'autonomia e l'autarchia dei processi
naturali. A questi due modelli Schelling contrappone il proprio organicismo
finalistico e immanentistico, ossia uno schema secondo cui:
l) ogni parte ha senso solo in relazione al tutto e alle altre
parti (= organicismo);
2) l'universo non si riduce ad una «miracolosa collisione di atomi »,
poiché al di là del meccanismo delle sue forze si manifesta una finalità
superiore («oggettiva e reale») che, tuttavia, non deriva da un
intervento esterno, ma è interno alla Natura stessa (= finalismo
immanentistico).
La «terza via» schellinghiana.
Infatti, argomenta Schelling, dal punto di vista della
sua terza via fra meccanicismo e finalismo tradizionale, sebbene in
natura esista una connessione preordinata fra parte e tutto, mezzo e
fine, tale connessione non è prima conosciuta da una mente e poi
realizzata nelle cose, come accade nel caso delle produzioni artificiali
o del Dio-Architetto. In altri termini, la Natura è un «organismo che
organizza se stesso» e non gia «un opera d'arte il cui concetto stia
fuori di essa, nella mente dell'artista» (Introduzione alle Idee per
una filosofia della natura, 1797).
La Natura come parte spirituale inconscia.
Ora, parlare in termini di «organizzazione» e di «scopo» significa
ammettere che la Natura obbedisce ad un «concetto» (come diceva Kant),
ovvero ad una «programmazione intelligente». Da ciò l'idea di uno
«Spirito» o di una entità spirituale inconscia (si ricordi l'agire
extra-coscienziale della «immaginazione produttiva» di Fichte) immanente
nella Natura a titolo di «forza» organizzatrice e vivificatrice dei
fenomeni. Entità o forza che Schelling, rifacendosi agli antichi,
denomina anche con il termine di «Anima del mondo», precisando che la
natura costituisce un Tutto vivente, ovvero un immenso Organismo in cui
ogni cosa, compresa la sfera inorganica, risulta dotata di vita (cfr.
Intorno all'anima del mondo, 1798).
Essendo spirito, sia pure inconscio, la Natura presenta gli stessi
caratteri di fondo che Fichte aveva attribuito all'Io. Essa è infatti
un'attività spontanea e creatrice che esplica se stessa in una serie
infinita di creature (cfr. Primo progetto di un sistema della filosofia
della natura, 1799).
Attrazione e repulsione.
E come l'Io fichtiano non poteva realizzare se stesso se non a patto di
dualizzarsi in soggetto ed oggetto, così la Natura schellinghiana non può
fare a meno di polarizzarsi o dialettizzarsi in due princìpi di base:
l'attrazione e la repulsione.
Difatti, ogni fenomeno è l'effetto di una forza che è come tale limitata
e perciò condizionata dall'azione di una forza opposta; sicché ogni
prodotto naturale si origina da un'azione e da una reazione e la natura
agisce attraverso la lotta di forze opposte. Se queste forze si
considerano già date nei corpi, la loro azione è condizionata o dalla
quantità (massa) o dalla qualità dei corpi stessi; nel primo caso le
forze operano meccanicamente, nel secondo chimicamente. In meccanica
l'attrazione prende il nome di gravitazione, in chimica di affinità. Se la
lotta fra le due forze opposte si considera nei rispetti del prodotto,
sono possibili tre casi: che le forze siano in equilibrio e si hanno
allora i corpi non viventi; che l'equilibrio venga rotto e sia
ristabilito, e si ha allora il fenomeno chimico; che l'equilibrio non
venga ristabilito e che la lotta delle forze sia permanente, e si ha
allora la vita (cfr. Idee eccetera).
4.2. La Natura come «preistoria» dello Spirito.
Magnetismo, elettricità e chimismo.
Secondo Schelling, le tre manifestazioni universali della Natura, nelle
quali si concretizza la polarità attrazione-repulsione, sono il
magnetismo, l'elettricità e il chimismo. Il magnetismo esprime la
coesione grazie alla quale le varie parti dell'universo gravitano le
une verso le altre. L'elettricità esprime quella polarità dialettica
che fa del mondo la sede di un'opposizione di forze di segno contrario.
Il chimismo esprime quella incessante metamorfosi dei corpi che
fa dell'universo una grande fucina in cui si fabbricano per sintesi le
più svariate realtà. A queste tre forze corrispondono, nel mondo organico,
la sensibilità, l'irritabilità (che è la proprietà di reagire agli stimoli
del mondo esterno) e la riproduzione.
Le «potenze» della Natura.
Con l'intento di ricostruire unitariamente la storia della natura,
Schelling articola la storia dell'universo in tre diverse «potenze» o
livelli di sviluppo (cfr. Deduzione universale del processo dinamico,
1800), sottolineando come in ognuna di esse operino le tre sopraccitate
forze del magnetismo, dell'elettricità e del chimismo. La prima potenza è
rappresentata dal mondo inorganico; la seconda dalla luce, in cui la
Natura si fa visibile a se stessa, la terza dal mondo organico, nel
quale, con la sensibilità, abbiamo il preannuncio aurorale
dell'autocoscienza.
La Natura come «preistoria» e «odissea» dello Spirito.
Complessivamente riguardata, la Natura si configura quindi come uno
spirito inconscio in moto verso la coscienza, cioè come un processo in
cui si ha una progressiva smaterializzazione della materia ed un
progressivo emergere dello Spirito. In altri termini, la Natura, lungo
un percorso che va dai minerali all'uomo, appare come la «preistoria
dello spirito» o come il passato trascendentale della coscienza, ovvero
(per usare unimmagine già presente in Schelling e che sarà cara a Ernst
Bloch) come un'«odissea» dello spirito il quale « si cerca » attraverso
le cose, per giungere finalmente presso di sé, con l'uomo. Ecco un passo
emblematico in materia, tratto dalla Introduzione al Sistema dell'idealismo
trascendentale:
«I morti e inconsci prodotti della natura non sono se non dei conati
falliti della natura per riflettere sé medesima; la cosiddetta natura
morta è soprattutto un'intelligenza immatura; perciò ne' suoi fenomeni già
traluce, ancora allo stato inconscio, il carattere intelligente. La
natura attinge il suo più alto fine, che è quello di divenire
interamente obbietto a sé medesima, con l'ultima e la più alta
riflessione, che non è altro se non l'uomo, o, più generalmente, ciò che
noi chiamiamo ragione; in tal modo per la prima volta si ha il completo
ritorno della natura a se stessa, e appare evidente che la natura è
originariamente identica a ciò che in noi viene riconosciuto come
principio intelligente e cosciente» (traduzione italiana, Laterza,
Bari 1990, pagina 9).
Ed ecco un passo meno noto, ma non meno significativo, tratto dalla
Esposizione del mio sistema filosofico (1801): « Come la pianta si
chiude nel fiore così tutta la terra si chiude nel cervello dell'uomo,
che è il sommo fiore di tutta la metamorfosi organica».
4.3. Fisica «speculativa» e pensiero scientifico.
L'idea di una fisica «a priori» e il suo significato preciso.
Schelling ha definito la propria filosofia della natura fisica
«speculativa» o «a priori». Queste espressioni non significano, come si
intende talora, che egli abbia voluto costruire un'immagine della natura
che prescinde dall'esperienza. Infatti, nel linguaggio di Schelling, dire
che la fisica procede a priori significa dire che essa procede
sistematicamente, ossia mostrando come ogni fenomeno naturale
testimoniato dall'esperienza faccia parte di una totalità organica da cui
necessariamente deriva ed entro cui necessariamente si colloca. Ecco
alcuni testi in proposito, tratti dalla Introduzione all'abbozzo di un
sistema della filosofia della natura (1799), che servono a dissipare ogni
equivoco:
«Non solo non sappiamo questo o quello, ma in generale originariamente
non sappiamo nulla se non per esperienza e tramite l'esperienza, ed in
questo senso tutto il nostro sapere è costituito di proposizioni
d'esperienza. Proposizioni che diventano a priori solo in quanto ci si
rende conto della loro necessità...», «Ora, deve però essere in generale
possibile conoscere ogni originario fenomeno naturale come assolutamente
necessario; se infatti in natura non v'è posto per il caso, nessun
originario fenomeno naturale può essere casuale, anzi, già per il fatto
che la natura è un sistema, dev'esserci per tutto ciò che in essa accade
o si realizza una connessione necessaria... », « La natura è a priori,
cioè ogni singolo fenomeno in esso è determinato in anticipo dal tutto o
dall'idea di una natura in generale. Ma se la natura è a priori deve
anche essere possibile conoscerla come qualcosa che è a priori».
«Limiti» della fisica schellinghiana...
In altri termini, la fisica speculativa di Schelling non intende essere
una deduzione «a tavolino», incurante dell'esperienza, ma uno sforzo di
tradurre l'a posteriori in a priori, ossia un tentativo di organizzare
sistematicamente e secondo necessità il materiale offerto dall'esperenza
e dalla scienza. Ovviamente, un procedimento di questo tipo cela il
pericolo di una manipolazione arbitraria dei dati della scienza. Questo
è appunto il rilievo dei critici e degli scienziati, che hanno finito
per accusare Schelling di essersi sterilmente allontanato dalla
metodologia galileiano-newtoniana e di aver costruito una sorta di
«romanzo della natura».
...e i suoi meriti storici.
Ciò non toglie che la fisica speculativa di Schelling abbia avuto taluni
«meriti storici», su cui hanno insistito soprattutto i critici odierni.
Uno di essi è di essere riuscito a «stimolare nella gioventù tedesca
dell'epoca l'interesse per i fenomeni naturali, specie per quelli allora
meno conosciuti, come l'elettricità e il magnetismo, e più ancora per i
fenomeni totalmente trascurati dalla scienza illuministica, come il
sogno, l'ipnotismo, la telepatia eccetera» (L. Geymonat). Un altro merito è
di aver mostrato i limiti del meccanicismo tradizionale e di aver posto
l'esigenza di studiare la natura, in particolare il mondo organico, con
schemi più appropriati. Un altro titolo è di aver contribuito ad
alimentare le ricerche di morfologia comparata (fra gli scienziati che
subirono l'influenza diretta di Schelling in questo settore di studi
ricordiamo Lorenz Oken, che pubblicò nel 1809-1811 un Trattato di filosofia
della natura). Un altro pregio è di aver contribuito a preparare una
mentalità «evoluzionistica» in senso lato.
Schelling e l'evoluzionismo.
Intendiamoci bene. Pur parlando di evoluzione e pur concependo la natura
in modo «piramidale», ovvero come una serie di gradi mettenti capo
all'uomo, Schelling non può essere considerato un «evoluzionista».
Infatti, le «potenze» o le «epoche» della Natura di cui egli parla non
sono, presumibilmente, dei gradi temporalmente successivi dell'Universo,
ma dei momenti ideali, e quindi simultanei, della sua eterna dialettica
ed organizzazione. Analogamente, la natura e l'uomo non rappresentano due
tempi successivi della storia del mondo, ma due momenti ideali di
ununità originaria (l'Assoluto) che è da sempre natura e spirito. In
altri termini, «Ad una prima considerazione sembra che Schelling usi
concetti (come quello di evoluzione) che saranno propri della scienza
del 19esimo secolo. Ma in realtà niente è più estraneo alla filosofia
schellinghiana del concetto di evoluzione» (N. Badaloni). Tuttavia, non
bisogna neppure dimenticare che «la teoria dell'evoluzione di quel tempo
si è appoggiata, presso una serie di ricercatori illustri, a questa
concezione metafisica, e che da essi è stata guidata alle sue scoperte
più importanti » (N. Hartmann). Infatti, era sufficiente prospettare in
termini temporali ciò che in Schelling era ancora pensato in termini
ideali e metafisici, per trovarsi in un sistema teorico di stampo
evoluzionista.
L'idea originale di una finalità immanente e inconscia.
Infine è bene ricordare che l'idea di una finalità immanente della
natura, ossia l'originale concetto di un fine inconscio interno ai
fenomeni naturali (senza che essi siano stati consapevolmente ed
esternamente programmati in vista di uno scopo), continua a suscitare
l'interesse di quei filosofi e di quegli scienziati che, pur rifiutando
l'ottica meccanistica, non accettano, per questo, il finalismo teologico
tradizionale (ossia la nozione di un Dio-Artefice e Programmatore del
mondo).
5. Lidealismo trascendentale.
5.1. La filosofia teoretica.
a) Il problema.
Nel 1800 Schelling scrive il Sistema dell'idealismo trascendentale. In
tale opera, che rappresenta uno dei testi più ardui di tutta la
filosofia moderna, egli si propone di delineare quella filosofia dello
spirito che, nei piani del sistema, avrebbe dovuto costituire la
controparte della filosofia della natura. Vediamo in che senso.
Il compito della filosofia trascendentale.
Se la filosofia della natura parte dall'oggettivo per derivarne il
soggettivo (= lo spirito), mostrando il progressivo farsi intelligenza
della natura, la filosofia trascendentale parte dal soggettivo per
derivarne l'oggettivo, mostrando il progressivo farsi natura
dell'intelligenza. In altre parole, se la prima ha il compito di
illustrare come la natura si risolva nello spirito e sia, in se stessa,
uno «spirito visibile», la seconda ha il compito di illustrare come lo
spirito si risolva nella natura, e sia, in se stesso, una «natura
invisibile». Detto in termini kantiani: se la prima risale dalla materia
alla forma, chiarendo come le leggi dell'oggetto siano le leggi stesse
del soggetto, la seconda discende dalla forma alla materia, chiarendo
come le leggi del soggetto siano le leggi stesse dell'oggetto. Detto in
altre parole ancora (Schelling esprime il suo pensiero di fondo in
svariate maniere) se la filosofia della natura parte dal realismo
(dall'oggetto, dal reale e dal materiale) per giungere all'idealismo (al
soggetto, all'ideale e al formale), la seconda parte dall'idealismo (dal
soggetto, dall'ideale e dal formale) per giungere al realismo
(all'oggetto, al reale e al materiale): «Come la scienza della natura
cava l'idealismo dal realismo, spiritualizzando le leggi naturali in
leggi dell'intelligenza, ossia accoppiando al materiale il formale; così
la filosofia trascendentale cava il realismo dall'idealismo, in quanto
materializza le leggi dell'intelligenza in leggi naturali, ossia aggiunge
al formale il materiale» (opera citata, pagina 22). In sintesi, la filosofia
trascendentale ha il compito, analogo a quello affrontato da Fichte
nella Dottrina della scienza, di dedurre l'oggetto dal soggetto, facendo
vedere come i modi di auto-costituzione dello spirito (cioè le strutture
e le leggi del soggetto) siano identici ai modi di auto-costituzione
della natura (cioè alle strutture e alle leggi dell'oggetto).
b) L'Io e le sue «epoche».
L'autocoscienza e l'intuizione intellettuale.
Il punto di partenza della deduzione schellinghiana è l'autocoscienza,
ovvero la coscienza o il sapere che l'Io ha di se stesso. Tale coscienza
ha la forma di una «intuizione intellettuale» (cfr. il Glossario), ossia
di un'attività autocreatrice in virtù della quale l'Io, proprio nel
momento in cui conosce o intuisce se stesso, produce o istituisce se
stesso (e, tramite sé, tutti gli oggetti). Secondo Schelling,
nell'autocoscienza esistono due attività: una reale ed una ideale.
Attività reale e ideale.
L'attività reale consiste nel fatto che l'Io, nel suo libero ed infinito
porsi, incontra il limite e risulta quindi limitabile. L'attività ideale
consiste nel fatto che l'Io, nel suo infinito intuirsi ed autoprodursi,
procede oltre ogni limite dato e risulta quindi illimitabile.
Ovviamente, le due attività si implicano a vicenda, in quanto l'Io può
configurarsi come ideale (= illimitabile) solo in quanto è reale
(= limitabile) e viceversa. Detto altrimenti, l'Io o l'autocoscienza
presenta una struttura interna di tipo dialettico-fichtiano, in quanto si
configura come un'attività non-limitabile, che esiste soltanto in presenza
di un limite che essa stessa pone ed oltrepassa continuamente: «L'Io non
è per noi ideale, se non in quanto oltrepassa il limite, già mentre lo
avverte. Ma esso non può riconoscere se stesso come ideale... senza
contrapporre la sua attività, che oltrepassa il limite, a quella
ritenuta entro il limite, o reale». (pagina 92)
Le varie «epoche» dell'Io.
Tracciando una sorta di storia filosofica dell'Io, volta a mostrare come
il soggetto giunga progressivamente a prendere coscienza di sé come
attività produttrice e come intelligenza che determina se medesima,
Schelling distingue tre «epoche» o fasi di sviluppo dell'Io. La prima
epoca procede dalla sensazione (in cui l'Io trova dinanzi a sé un dato
che lo limita ed avverte il suo sentire solo come un patire)
all'intuizione produttiva (in cui l'Io, equilibrando il proprio patire con
il proprlo agire, si coglie come senziente e non solo come sentito,
cominciando a prendere coscienza della propria attività, che prevede,
come si è visto, il limite ed il superamento incessante del limite). La
seconda epoca va dall'intuizione produttiva (in cui l'Io, pur intuendo se
stesso, risulta ancora immerso negli oggetti) alla riflessione (in cui
l'Io, riflettendo su se medesimo, si eleva all'intelligenza differenziata
di sé). La terza epoca, che va dalla riflessione alla volontà, è quella in
cui il processo iniziato nella seconda fase perviene al suo culmine, in
quanto l'Io, astraendo dagli oggetti, si coglie come volontà e spontaneità,
ovvero come intelligenza auto-determinantesi.
Schelling si sforza di mostrare come l'articolazione di questi momenti
dell'Io coincida, nella seconda e nella terza epoca, con la formazione
del tempo (senso interno dell'Io), dello spazio (senso esterno dell'Io) e
delle categorie di relazione, qualità, quantità e modalità. Egli tenta
pure di mostrare come le varie epoche e le varie categorie dell'Io
corrispondano ad altrettante potenze della natura e ad altrettante
categorie della fisica. Ad esempio, egli fa corrispondere la struttura
dialettica e polare dell'Io alla struttura dialettica e polare della
materia, dominata, come sappiamo, dalle forze di attrazione e di
repulsione.
Perché l'oggetto non appare sin dall'inizio una produzione del soggetto?
A parte questi forzati parallelismi, ispirati dall'ideale di una
«deduzione» della materia, dal discorso di Schelling emerge un
interrogativo di fondo, su cui è bene soffermarsi. Come mai l'oggetto,
che risulta una produzione del soggetto, non appare tale nella
sensazione? Perché la coscienza comune ritiene che gli oggetti
provengano da una dimensione estranea all'Io, ovvero dalla cosiddetta
cosa in sé? La risposta di Schelling è analoga a quella di Fichte e può
venir riassunta in questo modo. Se il soggetto producesse
consapevolmente i propri oggetti, non potrebbe pensarli in seguito come
delle cose in sé. Se ciò avviene è perché l'Io li genera inconsciamente
tramite la fichtiana «immaginazione produttiva», ovvero con ciò che
Schelling denomina, più semplicemente, «produzione inconscia».
Il produrre «inconscio» dello Spirito.
In conclusione, l'idealismo trascendentale di Schelling si configura come
una sorta di anamnesi filosofica dell'Io, ovvero come una presa di
coscienza di quel produrre inconscio dello Spirito in cui è da
ricercarsi la radice soggettiva degli oggetti. Presa di coscienza che
equivale quindi, nella terminologia di Schelling, a spiegare la
cosiddetta idealità del limite, ossia il fatto che il limite che l'io
conoscente trova davanti a sé sia un prodotto dello spirito stesso.
5.2. La filosofia pratica e i periodi della storia.
La filosofia pratica inizia con il culmine dell'attività teoretica, ossia
con la terza epoca, nella quale lo spirito si pone come volontà.
Questultima, realizzandosi in una pluralità di soggetti coscienti e
volenti, si concretizza nella morale, che accentua soprattutto la libertà
e la spontaneità dell'agire, e nel diritto, che accentua soprattutto
il momento della legalità e della necessità. In tal modo, nel mondo umano,
nasce un'antitesi fra libertà è necessità, che richiede di essere composta
in una sintesi superiore. Una prima composizione dell'antitesi è
rappresentata dalla storia.
La storia come sintesi di libertà e necessità.
La filosofia della storia di Schelling parte dal presupposto che essendo
unico il principio assoluto che agisce sia nella natura, sia nella
storia, anche in quest'ultima debba ritrovarsi quella connessione di
attività consapevole e inconsapevole che si è rintracciata nella natura.
Difatti la storia è sintesi di libertà (consapevolezza) e necessità
(inconsapevolezza), poiché mentre gli uomini credono di operare liberamente,
nasce in maniera inconscia, e in virtù di una forza superiore, che si
presenta come destino o come natura o come provvidenza, ciò che essi
non si proponevano. In altri termini, collocandosi nell'orizzonte del
provvidenzialismo romantico, Schelling sostiene l'esistenza di un disegno
che si va attuando gradualmente nel tempo, precisando che la storia è come
un dramma nel quale tutti recitano la loro parte in piena libertà e secondo
il proprio capriccio, e al quale solo lo spirito del poeta dà unità di
svolgimento. Ma il vero poeta della storia - l'Assoluto o Dio - non è
indipendente dal suo dramma: attraverso la libera azione degli uomini egli
stesso si attua e si rivela, sicché gli uomini sono collaboratori di tutta
l'opera e inventori della parte speciale che recitano.
I tre periodi della storia.
In particolare, la rivelazione storica dell'Assoluto avviene in tre
periodi. Il primo è quello in cui la potenza superiore appare sotto
forma di destino, cioè di una forza totalmente cieca (« a questo periodo
della storia, che possiamo chiamare il tragico, appartiene il tramonto
dello splendore e delle meraviglie del mondo antico, la caduta di quei
grandi imperi, dei quali ci è rimasto appena il ricordo»). Il secondo
periodo è quello in cui ciò che precedentemente appariva come destino si
rivela come natura e «legalità meccanica». Tale periodo ha inizio con
l'espansione della repubblica romana, la quale, spinta da una naturale
brama di conquista, finì per servire quell'altro piano di natura che
consiste nella lega di tutti i popoli e nello «stato universale». Il terzo
periodo sarà quello in cui ciò che precedentemente appariva come destino e
come natura si rivelerà esplicitamente come provvidenza. Quando comincerà
questo periodo, scrive Schelling, «non possiamo dirlo». Tuttavia, aggiunge
il filosofo, se questo periodo sarà, allora sarà anche Dio e il regno di
Dio, ossia la definitiva realizzazione della sintesi fra libertà e
necessità, consapevolezza e inconsapevolezza.
La «federazione planetaria».
In questo «regno» si avrà pure quella federazione planetaria e quella
costituzione giuridica universale, in grado di garantire la pace, che
Kant aveva sognato e che anche per Schelling costituisce, dal punto di
vista politico, il fine ultimo della storia.
5.3. La teoria dell'arte.
Nella filosofia e nella storia Spirito e Natura appaiono ancora distinti.
Nella filosofia teoretica e pratica Spirito e Natura, Conscio e
Inconscio, nonostante la loro puntuale corrispondenza, continuano a
configurarsi come due poli distinti, separati da una divaricazione
originaria, che è quella fra soggetto ed oggetto. La storia, a sua volta,
non fa che rimandare al futuro l'armonia fra i termini in gioco. Di
conseguenza, l'unità (e la conciliazione) fra spirito e natura risulta
più postulata che effettivamente dimostrata e attinta. Secondo Schelling,
l'unica maniera per risolvere questo nodo è di rintracciare un'attività
nella quale si armonizzino completamente spirito e natura, il produrre
inconscio e quello conscio - ovvero un'attività nella quale si manifesti
immediatamente ciò che nella storia si va attuando progressivamente, a
titolo di tappa finale di un processo in corso. L'attività che compie
tale «miracolo» è l'arte.
L'arte come organo di rivelazione dell'Assoluto.
Inserendosi nel quadro dell'estetismo romantico (vedi capitolo 2,
paragrafo 4.1), Schelling ritiene che l'arte si configuri come l'organo di
rivelazione dell'Assoluto nei suoi caratteri di infinità, consapevolezza e
inconsapevolezza al tempo stesso.
Infatti, nella creazione estetica l'artista risulta in preda ad una forza
inconsapevole, che lo ispira e lo entusiasma, facendo sì che la sua
opera si presenti come sintesi di un momento inconscio o spontaneo
(= l'ispirazione) e di un momento conscio e meditato (= l'esecuzione
cosciente). Inoltre il «genio» concretizza la sua vocazione formativa in
forme finite, le quali, essendo rivelazione dell'infinitezza
dell'ispirazione, hanno infiniti significati, che il poeta stesso non
riesce a penetrare pienamente, e che sono suscettibili di una lettura
senza fine. L'intero fenomeno dell'arte, che è un produrre spirituale in
modo naturale o un produrre naturale in modo spirituale, rappresenta
quindi la miglior chiave per intendere la struttura dell'Assoluto come
sintesi differenziata di natura e spirito: «l'arte è per il filosofo
quanto vi ha di più alto, poiché essa gli apre quasi il santuario, dove
in eterna ed originaria unione arde come in una fiamma quello che nella
natura e nella storia è separato...» (Sistema dell'idealismo trascendente,
pagina 301).
Anzi, se l'Assoluto è una sorta di poeta cosmico che genera le cose del
mondo in maniera inconsapevole e consapevole al tempo stesso,
caratterizzandosi come una forza infinita che si specifica in infinite
figure finite, il poeta umano, nella prospettiva schellinghiana, si
configura oggettivamente come colui che incarna e concretizza meglio il
modo d'essere dell'Assoluto. In altre parole, dal punto di vista della
filosofia di Schelling, nella creazione estetica si ripete il mistero
stesso della creazione del mondo da parte dell'Assoluto.
L'idealismo estetico.
Con questa dottrina di Schelling, l'arte viene ad assumere per la prima
volta nella storia della filosofia un significato universale e totale.
Kant aveva visto nell'arte un atteggiamento possibile dell'uomo di fronte
alla natura; Schiller la forma originaria e suprema dell'uomo. Schelling
vede in essa la vita stessa dell'Assoluto e la radice di ogni realtà.
L'esaltazione romantica del valore dell'arte trova quindi, in Schelling,
la sua più significativa espressione filosofica. Per questo motivo,
l'idealismo di Schelling, oltreché «oggettivo», per l'importanza attribuita
alla natura, è anche denominato «estetico».
5.4. Approfondimento: il problema più «elevato> della filosofia
trascendentale.
Un «arduo» problema.
In virtù della sua teoria dell'Assoluto come unità di conscio ed
inconscio (esemplificata dall'attività estetica) Schelling è in grado di
risolvere un problema che per lui è « non il primo, bensì il più elevato
compito della filosofia trascendentale » (Sistema dell'idealismo
trascendentale, pagina 17). Tale problema, che abbiamo tralasciato di
proposito, per non rendere didatticamente troppo «pesante» un pensiero
già strutturalmente complesso, è il seguente: Com'è possibile, secondo
quanto insegna la filosofia teoretica (prospettiva A) che vi sia un
predominio dell'oggetto sul soggetto e, nello stesso tempo, secondo quanto
insegna la filosofia pratica (prospettiva B), un predominio del soggetto
sull'oggetto? In altri termini: «in qual modo possono ad un tempo le
rappresentazioni esser pensate come determinate dagli obbietti, e gli
obbietti come determinati dalle rappresentazioni?» (ivi). Infatti, commenta
Schelling:
« Secondo B si esige un predominio del pensiero (dell'ideale) sul mondo
sensibile: ma si può concepire un fatto simile, se (in virtù di A) la
rappresentazione è nella sua origine soltanto la schiava dell'obbiettivo?
Per converso, se il mondo reale è qualcosa da noi affatto indipendente,
a cui deve (come a suo modello) volgersi la nostra rappresentazione
(secondo A), non si riesce a comprendere come poi il mondo reale possa
dirigersi giusta le nostre rappresentazioni (secondo B). In una parola,
per la certezza teoretica veniamo a perdere la pratica, per la pratica
la teoretica...» (ivi).
L'«armonia prestabilita» fra soggetto ed oggetto garantita dalla
medesima attività (conscia-inconscia) dello Spirito.
Per risolvere il suo problema, Schelling afferma che non si può
concepire come il mondo obbiettivo possa accomodarsi alle nostre
rappresentazioni e queste al mondo obbiettivo senza ammettere che tra i
due mondi, l'ideale e il reale, esista «un'armonia prestabilita». Tale
armonia, a sua volta, non è neanche pensabile se l'attività per cui si
produce il mondo obbiettivo non è originariamente identica a quella che
si manifesta nel volere: «Ora è senza dubbio un'attività produttiva quella
che si manifesta nel volere; ogni libero agire è produttivo, produttivo
soltanto con coscienza. Se si pone ora che, siccome le due attività
devono essere solo nel principio una sola, quella medesima attività, la
quale nel libero agire è produttiva con coscienza, nella produzione del
mondo sia produttiva senza coscienza, quell'armonia prestabilita è reale,
e la contraddizione è sciolta» (pagina 18). In altri termini, lo Spirito è
sempre attività e libertà, con la differenza che nel primo caso (quello
della creazione del mondo obbiettivo) lo spirito è produttivo in modo
inconscio, mentre nel secondo caso (quello del volere) è produttivo in
modo conscio. Tant'è che, se l'oggetto, in sede teoretica, condiziona il
soggetto, è perché quest'ultimo ha già posto, fichtianamente, l'oggetto. E
se il soggetto, in sede pratica, condiziona l'oggetto, è perché il volere
non è che la continuazione e la realizzazione, a livello conscio, della
libertà e della creatività dello Spirito, mediata dalla presenza
dell'oggetto (il quale, idealisticamente, esiste solo per essere tolto).
Ma in quale luogo preciso andrà rinvenuta la postulata identità fra
produttività inconscia e produttività conscia? Come già sappiamo, tale
luogo è rappresentato dall'attività estetica, la quale opera senza
consapevolezza nel mondo reale e con consapevolezza nell'uomo: «Il mondo
ideale dell'arte e quello degli obbietti sono perciò i prodotti di una
sola e medesima attività; la combinazione dell'uno e dell'altro (del
conscio e dell'inconscio), senza coscienza, dà il mondo reale; con la
coscienza, dà il mondo estetico» (pagine 18-19).
6. La filosofia dell'identità e il problema del passaggio dall'infinito al
finito.
Una nuova fase del pensiero schellinghiano.
La filosofia della natura e della storia hanno come presupposto
la teoria dell'Assoluto come identità o indifferenza di soggetto-oggetto.
Per cui, ad una prima considerazione, sembra che quella fase di pensiero
(1801-1804) che Schelling stesso denomina «filosofia dell'identità»,
«filosofia dell'indifferenza» o «filosofia dell'unitotalità», sia nientaltro
che una ripresa o una continuazione della fase precedente. In realtà,
la filosofia dell'identità mette capo ad una prospettiva nuova, che pone
le basi dei successivi sviluppi del pensiero schellinghiano. Infatti,
mentre precedentemente Schelling partiva dalla natura e dallo spirito
(dal finito e dal relativo) per giungere all'Assoluto o all'Infinito,
adesso intende muovere da quest'ultimo per poi discendere al finito e
al relativo, convinto che la vera difficoltà non sia quella di cercare
l'unità (divina) degli opposti, ma quella di dedurre gli opposti
dall'unità (divina).
Come si spiega il passaggio dall'Uno ai molti, da Dio al mondo,
dall'infinito al finito?
In altre parole, Schelling si trova di fronte all'antico problema di
spiegare come dall'Uno discendano i molti e come dall'Eterno nasca il
tempo, ossia come da Dio derivi il mondo. Problema che fa tutt'uno con
quello che sarà ulteriormente stimolato ed evidenziato dalla critica di
Hegel a Schelling (vedi capitolo 6, paragrafo 7), e che consiste nello
spiegare come da un Assoluto indifferente e identico possa sgorgare la
molteplicità e la differenziazione delle cose. Gli scritti in cui
Schelling oltreché ribadire il punto di vista dell'identità, comincia ad
accennare o a dibattere questi problemi, sono principalmente le due
Esposizioni del sistema (del 1801 e del 1802), e, soprattutto, il
dialogo Bruno o sul principio divino e naturale delle cose (1802).
Il finito e le idee.
In quest'ultimo scritto egli afferma che dall'infinito al finito non vi è
passaggio, se non a patto di ammettere che il finito, in qualche modo, è
già in Dio. Ma il finito può essere nell'Assoluto solo a patto di esservi
in modo infinito ed eterno, ossia sottratto ai limiti di spazio e di
tempo. Ed è quanto Schelling sostiene dichiarando che il finito è
presente in Dio sotto forma di un sistema di idee. Tuttavia, con questa
teoria, egli lascia insoluto il problema del perché l'infinito sistema di
idee divine si specichi nella molteplicità delle creature finite e
viventi. In altri termini, il fatto che in Dio si specifichino delle
idee non dà ancora ragione di come mai queste ultime si specifichino a
loro volta nelle cose. Come si può notare, il problema del salto
dall'essenza all'esistenza rimane aperto. La questione è tanto più
complessa se si pensa che Schelling rifiuta la soluzione creazionistica,
di tipo ebraico-cristiano, secondo cui il passaggio dalle idee alle cose
è dovuta ad un fiat creatore di Dio, poiché una risposta di questo genere,
a suo parere, sposta o elude soltanto il problema.
Questa serie di interrogativi metafisici, nel momento stesso in cui
portano Schelling ad indagare sui più oscuri misteri di Dio e del mondo,
lo conducono anche ad una «svolta» decisiva di pensiero, che taluno ha
giudicato coerente con le premesse iniziali ed altri più o meno
antitetica rispetto ad esse (come si vede, si riproduce anche per
Schelling, sia pure in modo meno marcato e criticamente controverso, il
problema delle «due filosofie» di cui si è parlato a proposito di Fichte).
7. Il finito come «caduta» e la teoria del «Dio che diviene».
Un'altra fase del pensiero di Schelling.
Gli scritti principali della nuova fase del pensiero schellinghiano,
quella cosiddetta «teosofica» o della «filosofia della libertà», sono
Filosofia e religione (1804) e le Ricerche filosofiche sull'essenza della
libertà umana (1809). La prima opera, che riprende il nucleo di
questioni sollevate dal Bruno, afferma decisamente che dall'Infinito al
finito e dall'Assoluto al relativo non vi può essere passaggio, ma solo
«rottura», «salto» e «caduta». Ma come si spiega tale rottura?
Schelling, recuperando schemi tratti dalla religione giudaico-cristiana,
afferma che essa deriva dalla libertà umana, che, operando il male,
provoca il distacco del finito dall'Assoluto, attraverso un cosmico
processo che contempla una caduta ed una redenzione, o, come egli stesso
scrive, un'Iliade ed un'Odissea della storia del mondo. Tuttavia, in
questo modo, Schelling non fa che presupporre già l'esistenza
del finito, della libertà e del male, ossia di ciò che vorrebbe
spiegare.
Da dove derivano il finito, il male e la libertà?
Infatti, come si giustifica a sua volta la possibilità metafisica di
tali realtà? Per cui, di fronte alla mente di Schelling si
stagliano ormai, con tutta chiarezza, tre interrogativi di fondo:
1) da dove la possibilità ontologica del finito e del mondo?;
2) da dove la possibilità ontologica del male?;
3) da dove la possibilità ontologica della libertà?
Gli inconvenienti del creazionismo, dell'emanazionismo e dal panteismo.
Di fronte a queste domande il teismo creazionista (= la tesi di un Dio
personale e creatore), l'emanazionismo di stampo neoplatonico (= la tesi
di un Dio super-essente da cui emana l'universo) e il panteismo
tradizionale (= la tesi dell'identità Dio-mondo) appaiono, agli occhi di
Schelling, impotenti e inutilizzabili. Infatti il primo, pensando Dio
come un Atto puro, e quindi come una perfezione statica, non riesce a
spiegare perché l'Assoluto, essendo originariamente perfetto, possa dar
vita all'imperfetto, ossia perché dall'unità e dalla pace divina sgorghi,
sia pure attraverso un libero fiat, un mondo molteplice e in divenire.
Inoltre il teismo tradizionale, riducendo il male ad un non-essere, non
riesce a giustificare veramente la possibilità e lo spessore del male
nel mondo, e la conseguente possibilità di una scelta umana di esso,
ossia la libertà. L'emanazionismo neoplatonico, a sua volta, non fa che
ripetere gli stessi inconvenienti del creazionismo. Anche il panteismo
classico (e qui Schelling ha presente soprattutto Spinoza, di cui fu
appassionato studioso) non riesce a spiegare né il salto dall'infinito al
finito, né l'esistenza del male, che esso è costretto a ridurre ad
apparenza.
La realtà dinamica e dialettica di Dio.
Di conseguenza, Schelling ritiene di dover imboccare una sorta di terza
via al di là del teismo e del panteismo, che, pur non dissolvendo Dio
nel mondo (in base al principio che se il mondo è tutto in Dio, Dio non
è tutto nel mondo), sia in grado di mostrare come Dio non sarebbe tale
senza il mondo. Nelle Ricerche, in cui mette in atto la nuova
prospettiva, egli afferma che se il concetto di Dio come identità
statica e perfezione già tutta realizzata non riesce a dar ragione del
finito e del male, non rimane altra soluzione che quella di cambiare
radicalmente il concetto stesso dell'Assoluto, interpretando Dio come una
realtà in divenire e come sede di una contrapposizione dialettica di
contrari. Ciò porta il filosofo a ritenere che in Dio vi sia una serie
di opposti - irrazionalità e razionalità, necessità e libertà, egoismo e
amore eccetera - che danno luogo ad un processo, avente come teatro il
mondo, in cui si ha un progressivo trionfo del positivo sul negativo.
In altri termini, come in noi esiste da un lato un volere inconscio e
irrazionale, e dall'altro un volere permeato di ragione, così, in Dio, vi
è un fondo abissale inconsapevole, un'oscura brama o desiderio d'essere
(che Schelling, sulle orme di Böhme, denomina «substrato», «natura» o
«abisso») e dall'altro una ragione consapevole (che Schelling denomina
«l'essere»).
L'«essere» e la «natura» in Dio.
Ma come nell'uomo lo spirito affiora dalla vittoria sull'impulso, o come
la luce si afferma in virtù del dissolvimento delle tenebre, o come, in
generale, il positivo si rivela solo in rapporto al negativo, così, in Dio,
«l'essere» o la ragione consapevole emerge dalla «natura» irrazionale,
che è appunto il fondamento a partire dal quale Dio si fa Dio. In tal
modo l'Assoluto schellinghiano cessa di essere un Atto puro o un primo
motore immobile per configurarsi come un Dio vivente, ossia come un Dio
che non è, ma diviene, e nello stesso tempo si rivela a se stesso,
facendosi persona, tramite una progressiva vittoria della razionalità
sull'irrazionalità, della libertà sulla necessità, dell'amore sull'egoismo,
ossia mediante un cosmico processo coincidente con la storia stessa del
mondo, che è una vivente teofania (= manifestazione di Dio).
Il mondo, il male e la libertà sono un momento necessario della vita divina.
Secondo Schelling, solo questa concezione dinamica di Dio può spiegare
l'origine e il destino del mondo e del finito. Infatti la creazione, che
sgorga dal volere inconscio di Dio e dal suo oscuro «desiderio d'essere»,
e che trova la sua redenzione nella graduale realizzazione e rivelazione
di Dio a se stesso, rappresenta un momento necessario della vita divina,
che non può fare se stessa se non facendo, al tempo stesso, il mondo.
Secondo Schelling questa concezione ha pure il vantaggio di spiegare
l'origine e la possibilità del male e della libertà, senza, con ciò
stesso, attribuirne la causa a Dio. Alla tesi polemico-ironica del medico
e filosofo Adam K. A. Eschenmayer (1770-1852), secondo cui l'Assoluto
schellinghiano sarebbe un misto di Dio e di Satana, il filosofo ribatte
che fra l'aspetto inconscio e abissale di Dio e il suo essere razionale
(e quindi fra necessità e libertà, egoismo e amore, desiderio e
intelletto) non vi è antitesi irrisolta, bensì armonica compenetrazione,
in quanto il primo è semplicemente la condizione del trionfale
esplicarsi del secondo: «Infatti ogni essere può rivelarsi solo per
mezzo del suo contrario; l'amore solo nell'odio, l'unità solo nella lotta.
Se non ci fosse separazione dei princìpi, l'unità non potrebbe mostrare
la sua onnipotenza; se non ci fosse la discordia, l'amore non potrebbe
diventare reale» (Ricerche, in Werke, Volume 4, pagine. 265-266).
Il male e la libertà in relazione all'uomo.
Nella teofania cosmica di Schelling, la vera possibilità del male sorge
soltanto in relazione all'uomo, allorquando egli, turbando il piano
divino e alterando perversamente, con la sua libertà, l'ordine e il corso
dell'essere, trasceglie il negativo, ossia separa il bene dal male,
isolando il finito dall'infinito e ribellandosi a Dio. Ma anche nella
caduta l'uomo sente il richiamo della redenzione, e quindi il bisogno di
far coincidere il proprio destino con quello di Dio, che è un'eterna
vittoria del positivo sul negativo, o, in termini religiosi, della Luce
sulle Tenebre.
8. La filosofia positiva.
Le Ricerche (1809) interrompono l'attività letteraria di Schelling il
quale si chiuse da quella data in uno sdegnoso mutismo, assistendo al
trionfo di Hegel, che identificava risolutamente la realtà con la
ragione e sviluppava su questo fondamento tutte le parti di un sistema
organizzato e compiuto. Schelling ruppe il suo silenzio solo dopo tre anni
dalla morte di Hegel, con una pubblicazione occasionale: una breve
prefazione alla traduzione tedesca dei Frammenti filosofici di Cousin (1834).
Ma già in questo scritto si annuncia il nuovo indirizzo della sua filosofia,
che egli chiamò positivo ed espose nei corsi rimasti inediti che tenne
all'Università di Berlino.
L'ultima fase del pensiero schellinghiano.
Schelling non era mai giunto a identificare il reale col razionale.
Anche designando l'Assoluto col nome di Io o di Ragione, aveva sempre
incluso in esso un riferimento alla realtà, all'oggetto, all'esistente
come tale e l'aveva perciò sempre riconosciuto come indifferenza di
idealità e di realtà. La dottrina di Hegel gli appare quindi come una
caricatura, un'esagerazione unilaterale del suo sistema. Hegel ha
distrutto la distinzione tra il razionale e il reale, ha posto il
razionale al posto del reale, ha ridotto tutto al concetto, e ha avuto
la pretesa di derivare da concetti astratti tutta la realtà, l'esistenza
del mondo come quella di Dio. Questo procedimento è impossibile, secondo
Schelling, perché un conto sono le condizioni negative della pensabilità
logica del reale e un conto le condizioni positive della sua esistenza.
Filosofia « negativa» e filosofia « positiva».
Da ciò la distinzione fra una «filosofia negativa», che si limita a
studiare l'essenza o la possibilità logica delle cose (cioè il quid sit),
ed una «filosofia positiva» che concerne invece la loro esistenza o
realtà effettiva (cioè il quod sit). Prendendo le difese della seconda,
Schelling afferma che l'esistenza, derivando dalla libera ed
imprevedibile volontà di Dio, non può (in virtù della sua radicale
contingenza) venir (logicamente) dedotta, ma solo (fattualmente)
indotta. In altri termini, poiché l'esistenza non può venir «costruita»
dalla ragione (come pretenderebbe Hegel), il filosofo ha il più modesto
ufficio di constatare e di interpretare speculativamente la rivelazione
che Dio fa di se stesso nel mondo. E poiché Dio si manifesta dapprima
nella sua natura e nella sua necessità (come accade nella religione
naturale o mitologia) e poi nella sua assoluta personalità e libertà
(come accade nella religione rivelata), la filosofia positiva finisce per
concretizzarsi, secondo il titolo di due opere di Schelling, in una
Filosofia della mitologia e in una Filosofia della rivelazione.
Ovviamente, «il Dio di cui questa filosofia positiva si occupa è ormai il
Dio-persona che crea il mondo, si rivela e redime l'uomo dalla sua caduta:
è, insomma, il Dio considerato in quella concretezza religiosa che le
filosofie moderne non hanno quasi mai considerato quale oggetto
specifico della propria riflessione» (Reale-Antiseri), anche se «i dogmi
cristiani della Trinità e dell'Incarnazione sono interpretati, in
funzione di un "cristianesimo eterno", cioè di una religiosità
universale, che deve attuarsi nell'avvenire in un pancristianesimo, che
accoglierà, al di fuori di sette e di dogmi, tutti i credenti nello
Spirito» (G. Faggin).
9. Schelling nella filosofia moderna.
Un «astro» del Romanticismo.
Genio precoce (docente universitario a soli 24 anni e autore del Sistema
dell'idealismo trascendentale a soli 25 anni), Schelling ottiene immediato
ascolto ed influenza presso i contemporanei e giunge ben presto ad
oscurare la gloria dello stesso Fichte («un astro tramonta ed un nuovo
astro sorge», aveva sentenziato Goethe). Infatti il gruppo dei fratelli
Schlegel, dopo il fallimento delle speranze suscitate da Fichte (vedi
capitolo 4, paragrafo 2), si rivolge a lui come al filosofo capace di
interpretare le esigenze più profonde della nuova cultura romantica.
E in effetti «Schelling è stato il filosofo più congeniale con lo spirito
dei romantici. Il suo sentimento della natura, la sua visione estetica
dell'universo, e più tardi, il suo orientamento religioso, hanno segnato
le tappe successive dell'evoluzione romantica» (G. De Ruggiero, Storia della
filosofia, opera citata, pagina 376).
La decadenza.
Tuttavia anche Schelling decade in fretta dal suo trono culturale. In
astiosa polemica con Fichte, suo antico maestro, e in rapporti sempre
più freddi con i romantici, Schelling assiste a sua volta alla
irrefrenabile ascesa di Hegel, suo antico collaboratore e seguace, e ne
subisce di malanimo le critiche filosofiche al proprio concetto
dell'Assoluto come sintesi indifferenziata di spirito e natura (vedi
capitolo 6, paragrafo 7). Comincia allora un nuovo periodo dell'esistenza
di Schelling, che pur continuando a studiare e a scrivere, pubblica
pochissimo, vivendo per circa un quarantennio come un isolato,
completamente sopraffatto dai successi e dal potere culturale di Hegel.
Un nuovo effimero successo.
Soltanto nel 1841, l'ormai vecchio filosofo, chiamato ad insegnare a
Berlino sulla cattedra di Hegel (morto dieci anni prima), torna a fare
la sua comparsa nel mondo intellettuale tedesco, suscitando, sul momento,
estremo interesse. Tant'è vero che alle sue lezioni assistono nomi
celebri o destinati ben presto a divenirlo, come ad esempio Strauss,
Savigny, Michelet, Feuerbach, Kierkegaard, Engels e Bakunin.
Ma ancora una volta la gloria di Schelling è piuttosto effimera e non
priva di amarezze, ed il filosofo esce umanamente ed intellettualmente
deluso anche da quest'ultima esperienza. Sul piano filosofico-culturale,
Schelling subisce una serie di attacchi concentrici. A parte le
stroncature di Herbart e di Schopenhauer, (quest'ultimo parla di
«delirio»), oppure degli scienziati, che respingono gli elementi
«fantastici» della sua filosofia della natura, Schelling viene duramente
criticato dalla Sinistra hegeliana. Feuerbach scorge in Schelling un
pensatore di vecchia mentalità idealistico-teologica, « truccato » da
filosofo realista e naturalista, e nell'Essenza del Cristianesimo (1841)
bolla il suo sistema come una «filosofia del cattivo sapere». Engels
(Schelling und Hegel, 1841), pur sottolineandone la polemica
anti-soggettivistica, lo ritiene inferiore ad Hegel, disprezzandone, con
Marx, l'irrazionalismo misticheggiante e le tendenze politiche
reazionarie. Da parte sua Kierkegaard, pur rilevando la sottolineatura
schellinghiana del momento dell'«esistenza» nei confronti di quello
dell'«essenza» e pur «ringraziando» il filosofo per essere tornato ad
usare il termine «realtà», lo accusa di «chiacchierare
insopportabilmente» e di non pervenire alla singolarità concreta dell'uomo.
L'interpretazione di Schelling come «ponte di passaggio» verso Hegel.
Dopo la sua morte (1854), Schelling torna nell'ombra, e i grandi storici
tedeschi della filosofia, come Rosenkranz, Fischer, Zeller ed Erdmann,
procedono ad «imbalsamare» il suo sistema nella storia del pensiero,
interpretandolo tuttavia (ironia della sorte!) sulla falsariga delle
Lezioni sulla storia della filosofia dell'odiato Hegel, il quale aveva
fatto dell'idealismo oggettivo di Schelling il «superatore» dell'idealismo
soggettivo di Fichte ed il «superato» dal proprio idealismo assoluto. In
altre parole, con questo tipo di storiografia, si afferma quell'immagine
di Schelling come «ponte di passaggio verso Hegel», che troverà la sua
manifestazione più esasperata nel Von Kant bis Hegel (1921-1924) di
Richard Kroner.
Il privilegiamento del «primo» Schelling.
Parallelamente a questo tipo di operazione, si ha quel
privilegiamento pressoché esclusivo del primo Schelling e quella
«discriminazione» dell'ultimo Schelling, che avrebbero pesato a lungo
sulla cultura europea, sostanzialmente ferma all'immagine delineata da
Hegel e dagli hegeliani (accettata e diffusa, nel nostro paese, da
Bertrando Spaventa).
Questo non significa tuttavia, come si è scritto talora, che la
filosofia dell'ultimo Schelling, nell'Ottocento, sia stata completamente
priva di considerazione o di influenze. Infatti la presenza dell'ultimo
Schelling appare determinante nel «teismo speculativo tedesco» di
Immanuel H. Fichte e di Christian Weisse, che si rapportano ad esso in
funzione anti-hegeliana ed anti-immanentistica. Influenze e suggestioni
dell'ultimo Schelling si ritrovano pure nello spiritualismo francese ed
europeo, lungo una linea che da Secrétan arriva sino a Bergson. Sempre
per quanto riguarda l'Ottocento, l'ultimo Schelling risulta presente,
soprattutto per i temi della volontà e dell'inconscio, anche in Eduard
von Hartmann, che contribuisce ad una lettura storiografica del suo
pensiero svincolata dagli schemi interpretativi hegeliani.
La «Schellin Renaissance».
Ma è soltanto nel Novecento, e precisamente con l'esistenzialismo, che
abbiamo una vera e propria Schelling-Renaissance, che si è accompagnata
ad un dibattito circa il rapporto fra l'idealismo classico tedesco e le
prospettive cristiane e circa il carattere «esistenzialistico» della
filosofia schellinghiana. Fra gli interventi più rilevanti di questo
nuovo capitolo della fortuna culturale di Schelling, che ha segnato un
rinato interesse per le speculazioni dell'ultima fase del suo pensiero,
citiamo quelli di Karl Jaspers, autore di un grosso volume sul filosofo
(Schelling, Grösse und Verhängnis, 1955), e di Gabriel Marcel, che ha
visto nellultimo Schelling un anticipatore di temi heideggeriani ed
esistenzialistici. L'immagine di Schelling come pre-esistenzialista è
stata invece contestata da altri studiosi, che hanno considerato
l'esperienza speculativa schellinghiana irriducibile alla linea della
Existenz-philosophie kierkegaardiana e novecentesca.
Nel frattempo l'influenza di Schelling si è estesa anche a quelle
correnti del pensiero teologico (ad esempio Paul Tillich) che hanno
cercato di ripensare la realtà di Dio secondo schemi diversi dalla
teologia tradizionale. In campo marxista, sebbene Lukács, nella
Distruzione della ragione (1955), abbia fatto di Schelling il padre
dell'irrazionalismo contemporaneo e l'espressione ideologica della
reazione feudale ed antiborghese, non sono mancati pensatori, come
ad esempio Ernst Bloch, più sensibili alle istanze del suo complesso
e multiforme filosofare. In ogni caso, dal dopoguerra ai giorni nostri,
l'attenzione per l'ultimo Schelling è andata progressivamente aumentando,
al punto che l'interesse per esso ha finito per oscurare la
considerazione del primo Schelling.
Questo capovolgimento radicale di prospettiva - tuttora in corso - ha fatto
sì che all'antica immagine del filosofo come momento di transizione verso
Hegel, sia subentrata la nuova figura di Schelling come pensatore del
dopo Hegel.
Indicazioni bibliografiche
A. Massolo, Il primo Schelling, Sansoni, Firenze 1953.
G. Semerari, Interpretazione di Schelling, volume 1, Libreria
Scientifica, Napoli 1958.
L. Pareyson, L'estetica di Schelling, Giappichelli, Torino 1964.
A. Bausola, Metafisica e rivelazione nella filosofia positiva di Schelling,
Vita e Pensiero, Milano 1965.
C. Cesa, La filosofia politica di Schelling, Laterza, Bari 1969.
G. Semerari, Introduzione a Schelling, Laterza, Bari 1971.
X. Tilliette, Attualità di Schelling, Mursia, Milano 1972.
A. Bausola, F. W. J. Schelling, La Nuova Italia, Firenze 1975.
C. Ciancio, Il dialogo polemico tra Schelling e Jacobi, Edizioni di
Filosofia, Torino 1975.
Autori Vari, Schelling, Cedam, Padova 1976.
Autori vari, Romanticismo, esistenzialismo, ontologia della Libertà,
Mursia, Milano 1979.
W. Kasper, L'Assoluto nella storia nell'ultima filosofia di Schelling,
Jaca Book, Milano 1986.
F. Moiso, Vita, natura, libertà. Schelling (1795-1809), Mursia, Milano 1990.
G. Riconda, Schelling storico della filosofia (1794-1820), Mursia,
Milano 1990.
GLOSSARIO E RIEPILOGO
- Per Assoluto Schelling intende il Principio infinito e creatore della
realtà, cioè Dio stesso. Tale Principio non è riducibile né al soggetto
(allo spirito) né all'oggetto (alla natura). Infatti, essendo il
fondamento di entrambi, è unità o identità dei medesimi, ossia spirito e
natura, soggetto e oggetto, consapevolezza e inconsapevolezza, libertà e
necessità, idealità e realtà. Del resto, argomenta Schelling, un
Assoluto puramente soggettivo (come l'Io di Fichte) non riuscirebbe a
spiegare la Natura, mentre un Assoluto puramente oggettivo (come la
Sostanza di Spinoza) non potrebbe spiegare lo spirito. Di conseguenza,
la filosofia, intesa come scienza dell'Assoluto, si dividerà in quei due
grandi tronconi che sono la filosofia della natura (vedi) e la filosofia
trascendentale (vedi) o filosofia dello spirito, cercando, in entrambe, di
cogliere quell'identità fra soggetto e oggetto che costituisce l'Assoluto
stesso: «Un sapere assoluto è soltanto quello in cui il Soggettivo e
l'Oggettivo non sono unificati come opposti, ma in cui tutto il
Soggettivo è tutto l'Oggettivo, o viceversa. L'assoluta identità del
Soggettivo e dell'Oggettivo come principio della Filosofia la si è intesa
(...) o in senso puramente negativo (come semplice non-differenza) o come
mera unione di due momenti in sé opposti in un terzo, che dovrebbe
essere l'Assoluto. L'opinione giusta sarebbe piuttosto questa, che il
Soggettivo e l'Oggettivo, considerati ciascuno per sé, siano una sola
cosa, non semplicemente raccolti in un'unità che ad essi sia o
accidentale o per lo meno estranea. In generale per descrivere questa
somma idea non si dovrebbe presupporre il Soggettivo e l'Oggettivo, ma
piuttosto si dovrebbe mostrare che entrambi, in quanto opposti o
riuniti, non devono venir concepiti che prendendo le mosse da questa
identità» (Aggiunta all'Introduzione alle Idee per una filosofia della
natura in L'empirismo filosofico e altri scritti, a cura di G. Preti, La
Nuova Italia, Firenze 1967, pagine 53-54).
- Filosofia della Natura
Secondo Schelling il compito della filosofia della natura è di porre
come primo l'obbiettivo e ricavare da esso il subbiettivo (Sistema
dell'idealismo trascendentale, traduzione italiana, Laterza, Bari,
1990, pagina 10), ossia di mostrare come la natura si risolva nello
spirito e sia, in se stessa, Spirito: «Una teoria perfetta della natura
sarebbe quella per cui la natura si risolvesse in intelligenza» (ivi,
pagina 9), «La scienza della natura toccherebbe il sommo della perfezione
se giungesse a spiritualizzare perfettamente tutte le leggi naturali in
leggi dell'intuizione e del pensiero. I fenomeni (il materiale) debbono
scomparire interamente, e rimanere soltanto le leggi (il formale)»
(ivi, pagina 8).
- La filosofia della natura di Schelling, che si muove in una sorta di
«terza via» fra meccanicismo e finalismo tradizionale è una forma di
organicismo (= ogni parte ha senso solo in relazione al tutto e alle
altre parti) e di finalismo immanentistico (= nell'universo esiste una
finalità «oggettiva e reale» che non deriva da un intervento esterno, di
tipo divino, ma che risulta immanente alla natura stessa): «questo
assoluto finalismo della totalità della natura è un'idea che pensiamo non
arbitrariamente, ma necessariamente. Ci sentiamo spinti a riferire ogni
singolo a tale finalità del tutto; quando troviamo nella natura qualcosa
che sembra essere senza scopo o addirittura contrario ai fini, crediamo
che sia rotta l'intera economia delle cose (...). è dunque una massima
della ragione riflettente che nella natura si debba ovunque presupporre
un rapporto di fine e mezzo (...) che la natura risponderà, per così
dire, con spontanea cortesia al nostro sforzo di scoprire in essa una
finalità assoluta (...). Che è dunque quel legame segreto che unisce il
nostro spirito con la natura, o quell'organo nascosto in virtù del quale
la Natura parla al nostro spirito o il nostro spirito alla Natura? Vi
facciamo subito grazia di tutte le vostre spiegazioni (...). Perché lo
spiegare questa finalità dicendo che un intelletto divino ne è l'autore
non è filosofare, ma fare pie considerazioni (...). Perché noi vogliamo
non già che la natura concordi accidentalmente (e magari per la
mediazione di una terza cosa) con le leggi del nostro spirito, ma che in
se stessa necessariamente ed originariamente non soltanto esprima ma
realizzi veramente le leggi del nostro spirito (...). La Natura deve
essere lo Spirito visibile, lo Spirito la Natura invisibile».
(Introduzione alle Idee per una filosofia della natura, citatat,
pagine 45-47).
- Secondo Schelling, alla base del grande organismo del mondo, concepito
come «organismo che organizza se stesso», vi è uno Spirito o un'entità
spirituale inconscia che funge da forza strutturante e vivificatrice dei
fenomeni. Forza che Schelling denomina anche con il termine antico di
Anima del mondo e che definisce come «ciò che sostiene la continuità del
mondo organico e inorganico e unisce tutta la natura in un solo
organismo universale», dichiarando di scorgere in essa una «ipotesi
superiore» per la spiegazione del Tutto.
- Attrazione e repulsione, concentrazione ed espansione, rappresentano,
secondo Schelling, i due princìpi di base della Natura, la quale,
essendo spirito, sia pure inconscio, presenta (analogamente all'Io di
Fichte) una struttura dialettica e polare scaturente dall'esistenza di
attività contrapposte.
- Magnetismo, elettricità e chimismo rappresentano, secondo Schelling, le
tre manifestazioni universali della natura nelle quali si concretizza
(cfr. il testo) la polarità attrazione-repulsione. A tali forze
corrispondono, nel mondo organico, la sensibilità, l'irritabilità e la
riproduzione.
- Per potenze della Natura Schelling intende i tre livelli di sviluppo
della realtà rappresentati dal mondo inorganico, dalla luce e dal mondo
organico.
- Con il concetto di preistoria dello spirito Schelling intende
sottolineare come la natura sia il «passato trascendentale» dell'Io, ovvero
uno spirito inconscio in moto verso la coscienza: «la natura comincia in
maniera inconscia e finisce coscientemente». Da ciò la metafora (di
origine leibniziana) di uno spirito «dormiente» nelle cose e destinato a
«svegliarsi» con l'uomo: «I morti e inconsci prodotti della natura non
sono se non dei conati falliti della natura per riflettere se medesima
(...). La natura attinge il suo più alto fine, che è quello di divenire
interamente obbietto a se medesima, con l'ultima e la più alta
riflessione, che non è altro se non l'uomo, o, più generalmente, ciò che
noi chiamiamo ragione...» (Sistema, pagina 9), «Come la pianta si schiude
nel fiore, così tutta la terra si chiude nel cervello dell'uomo, che è il
sommo fiore di tutta la metamorfosi organica» (Esposizione del mio sistema
filosofico, paragrafo 156, Aggiunta 2).
- Parlando di fisica «speculativa» o «a priori», Schelling non intende
alludere ad un pensiero incurante dell'esperienza o dei dati raccolti
dalla scienza, ma al metodo specifico della propria filosofia naturale,
la quale procede sistematicamente, ossia mostrando come ogni fenomeno
testimoniato dall'esperienza faccia parte di una totalità organica
necessaria da cui necessariamente deriva ed entro cui necessariamente si
colloca: «tutto il nostro sapere è costituito di proposizioni
d'esperienza. Proposizioni che diventano a priori solo in quanto ci si
rende conto della loro necessità...», «la natura è a priori, cioè ogni
singolo fenomeno in essa è determinato in anticipo dal tutto... Ma se
la natura è a priori deve anche essere possibile conoscerla come
qualcosa che è a priori (Introduzione all'abbozzo di un sistema della
filosofia della natura).
- Filosofia trascendentale.
- La filosofia trascendentale, per Schelling, è quel tipo di sapere,
opposto ma complementare alla filosofia della natura, il cui scopo è:
«partire dal subbiettivo come dal primo ed assoluto, e farne derivare
l'obbiettivo (Sistema, pagina 10). In altri termini, la filosofia
trascendentale è quella scienza che parte dal soggetto, dall'ideale e
dal formale, per farne scaturire l'oggetto, il reale e il materiale,
mostrando in tal modo «l'obbiettivarsi del subbiettivo».
- L'autocoscienza, ovvero «la coscienza di noi stessi» (Sistema, pagina 25),
rappresenta, secondo Schelling, il punto luminoso di tutto il sistema
del sapere, cioè il principio primo ed assoluto da cui muove la
filosofia trascendentale nelle sue deduzioni.
- Per intuizione intellettuale Schelling intende il sapere che l'Io ha di
se stesso tramite l'autocoscienza (vedi), ossia una forma di sapere in cui
coincidono soggetto ed oggetto, intuente ed intuito e per la quale l'Io,
conoscendo se stesso, costruisce, nello stesso tempo, se stesso.
Infatti, parlando di una intuizione che mette capo ad una «produzione del
suo obbietto», e nella quale il producente è «una medesima cosa con il
prodotto», Schelling così commenta: «Una intuizione siffatta, in
opposizione alla sensibile, che non apparisce come produzione del suo
obbietto, e in cui l'intuire stesso è differente dall'intuìto, si chiama
intuizione intellettuale» (Sistema, pagina 40). Di conseguenza, l'intuizione
intellettuale finisce per coincidere, analogamente a quanto accadeva in
Fichte (vedi), con la nozione della libera autocreatività dello Spirito.
Nozione che per l'idealismo fichtiano-schellinghiano sta alla base di
tutta la filosofia: «Come senza l'intuizione dello spazio sarebbe
assolutamente incomprensibile la geometria, perché tutte le sue
costruzioni non sono che forme e maniere svariate di limitare
quell'intuizione, così pure senza l'intuizione intellettuale, qualunque
filosofia, perché tutti i suoi concetti non sono che limitazioni
svariate del produrre che ha per obbietto se stesso, cioè dell'intuizione
intellettuale».
- Attività reale e attività ideale. Con la prima Schelling intende il
fatto che l'Io, nel suo libero ed infinito porsi, incontra il limite e
risulta quindi limitabile. Con la seconda il fatto che l'Io, nel suo
infinito intuirsi ed autoprodursi, procede oltre ogni limite dato e
risulta quindi illimitabile: «L'autocoscienza (l'Io) è una lotta di
attività assolutamente contrapposte. L'una, che va originariamente
all'infinito, sarà da noi chiamata la reale, obbiettiva, limitabile;
l'altra, cioè la tendenza a intuirsi in quella infinità, si dirà ideale,
subbiettiva, illimitabile» (Sistema, pagina 70). Ovviamente, nella
dialettica concreta dell'Io, queste due attività sono strettamente
congiunte, sino a dare luogo ad una sorta di «terza attività, che sia
insieme ritenuta entro il limite e l'oltrepassi, che sia insieme ideale
e reale», ovvero alla situazione concreta dello Spirito, il quale è,
fichtianamente, una eterna vicenda di incontro con il limite e di
superamento del limite.
- Per epoche dell'Io Schelling intende i momenti attraverso cui l'Io giunge
progressivamente a prendere coscienza di sé e a porsi come attività
produttrice o intelligenza che determina se stessa. Tali «epoche» che
vanno dalla sensazione alla riflessione (vedi il testo), corrispondono ad
altrettanti momenti di auto-costituzione della natura.
- Per produzione inconscia o produzione originaria Schelling intende
l'attività irriflessa (corrispondente all'«immaginazione produttiva» di
Fichte) attraverso cui il soggetto pone quegli oggetti che alla
coscienza comune appaiono, in seguito, delle cose in sé. Filosofare,
secondo Schelling, significa appunto prendere coscienza dell'origine
soggettiva degli oggetti: «Infatti, non appena la riflessione si rivolge
alla produzione inconscia come tale e la rende perciò consapevole, gli
oggetti vengono guardati, con la medesima necessità, come prodotti
dell'Io... Con ciò è dimostrata "l'idealità del limite"...» (N. Hartmann).
- Secondo Schelling la filosofia pratica si fonda su
«Quell'auto-determinazione dell'intelligenza» che chiamasi «volere»
(Sistema, pagina 205). E poiché quest'ultima, realizzandosi in una
pluralità di soggetti coscienti e volenti, si concretizza nella morale
e nel diritto, nasce, nel mondo umano, un'antitesi fra libertà e
necessità che richiede di essere composta in una sintesi superiore.
Una prima composizione è rappresentata dalla storia (vedi).
- Secondo Schelling «la storia nel suo complesso è una rivelazione
dell'Assoluto, continua e gradatamente svolgentesi» (Sistema, pagina 274),
che avviene tramite la libera azione degli individui, i quali sono, al
tempo stesso, i «collaboratori» dell'opera divina e gli «inventori» della
parte speciale che essi eseguono. In virtù di questa sua struttura - che
spiega come «l'uomo sia bensì libero per quanto spetta all'operare in sé,
ma che, per quanto spetta al risultato finale delle sue operazioni, sia
dipendente da una necessità, che è superiore a lui» - la storia si pone
come sintesi fra libertà e necessità, consapevolezza e inconsapevolezza.
- L'arte, secondo Schelling, costituisce l'«organo» della filosofia, ossia
l'attività privilegiata grazie alla quale si può cogliere l'Assoluto nella
sua unità (o identità) di spirito e natura. Infatti, la creazione
artistica, che si presenta come sintesi di un momento inconsapevole o
spontaneo (l'ispirazione) e di un momento consapevole e riflesso
(l'elaborazione cosciente dell'ispirazione), manifesta, nella sua
struttura, la Forza conscia-inconscia che opera nel mondo, a guisa di un
Poeta cosmico di cui il poeta umano è l'immagine: «s'intende di per sé che
l'arte sia l'unico vero ed eterno organo e documento insieme della
filosofia, il quale sempre e con novità incessante attesta quel che la
filosofia non può rappresentare esternamente, cioè l'inconscio
nell'operare e nel produrre, e la sua originaria identità col cosciente.
Appunto perciò l'arte è per il filosofo quanto vi ha di più alto, perché
essa gli apre quasi il santuario, dove in eterna ed originaria unione
arde come in una fiamma quello che nella natura e nella storia è
separato...» (Sistema, pagina 301).
- Il pensiero del primo Schelling è stato denominato idealismo oggettivo
per l'importanza attribuita alla natura e idealismo estetico per
l'importanza attribuita all'arte.
-Dalla filosofia dell'«identità» alla «filosofia positiva »
- Per filosofia dell'identità si intende, in generale, la teoria
schellinghiana dell'Assoluto (vedi) come identità o indifferenza di
soggetto ed oggetto, spirito e natura, conscio e inconscio eccetera.
Più in particolare, con questa espressione si intende il sistema abbozzato
da Schelling nel periodo che va dal 1801 al 1804. Sistema che ruota intorno
al problema di spiegare come, partendo dall'Assoluto e dall'Infinito, si
possa derivare, da esso, il finito ed il relativo (vedi il testo).
- Per teoria del Dio che diviene si intende la dottrina sviluppata da
Schelling nelle Ricerche filosofiche sull'essenza della libertà umana
(1809). Secondo tale concezione, Dio non è una perfezione statica e già
tutta realizzata (poiché in tal caso non si riuscirebbe a spiegare
l'esistenza del finito e del male), ma una realtà in divenire che ospita
in se medesima una serie dialettica di contrari - irrazionalità e
razionalità, necessità e libertà, egoismo e amore eccetera - che danno
luogo ad un processo cosmico in cui si ha un progressivo trionfo del
positivo sul negativo.
- Per filosofia negativa l'ultimo Schelling intende un pensiero che si
limita a studiare l'essenza o la possibilità logica delle cose (il quid
sit), mentre per filosofia positiva intende un pensiero che studia la
loro esistenza o realtà effettiva (il quod sit). Prendendo le difese
della seconda, Schelling afferma che l'esistenza, derivando dalla libera
ed imprevedibile volontà di Dio, non può venir logicamente dedotta, ma
solo fattualmente indotta o constatata. Di conseguenza, secondo
Schelling, la filosofia non ha il compito di costruire la realtà, ma
solo quello di constatare e di interpretare speculativamente la
rivelazione che Dio fa di sé nel mondo. Da ciò il programma di una
filosofia della mitologia e di una filosofia della rivelazione.
(Vedi testo).
STORIA DELLA FILOSOFIA
NICOLA ABBAGNANO
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
VOLUME TERZO
PARTE SECONDA: L'IDEALISMO ROMANTICO TEDESCO
CAPITOLO 6: Hegel
1. La vita.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel nacque il 27 agosto 1770 a Stuttgart.
Seguì i corsi di filosofia e teologia all'Università di Tubinga
(1788-1793), dove si legò di amicizia con Schelling e Hölderlin.
Entusiasmi giovanili per la Rivoluzione e Napoleone.
Gli avvenimenti della Rivoluzione francese suscitarono in lui un grande
entusiasmo ed esercitarono sul suo pensiero un'influenza duratura. Con
gli amici di Tubinga, piantò un albero della libertà e fu tra essi
l'oratore più acceso in difesa dei princìpi rivoluzionari della libertà e
dell'eguaglianza. Quando Napoleone entrò a Jena (il 13 ottobre 1806),
Hegel scrisse in una lettera:
«Ho visto l'Imperatore - quest'anima del mondo - cavalcare attraverso la
città per andare in ricognizione: è davvero un sentimento meraviglioso la
vista di un tale individuo che, concentrato qui in un punto, seduto su
di un cavallo, abbraccia il mondo e lo domina ». Né questo entusiasmo
diminuì quando Hegel ebbe dato la sua adesione allo Stato prussiano.
Paragonava infatti, più tardi, la rivoluzione a un levarsi superbo di
sole, un intenerimento sublime, un entusiasmo di spirito che han fatto
tremare il mondo di emozione, come se solo in quel momento la
riconciliazione del divino e del mondo si fosse compiuta».
A Berna, Francoforte e Jena.
Terminati gli studi, Hegel fece, com'era d'uso, il precettore in case
private e fu per qualche tempo a Berna (1793-1796). Al tempo del suo
soggiorno a Berna appartengono i primi scritti, che rimasero inediti:
una Vita di Gesù (1795) e un saggio Sulla relazione della religione
razionale con la religione positiva (1795-1796). Dopo tre anni di
soggiorno in Svizzera, Hegel tornò in Germania ed ebbe un posto di
precettore privato a Francoforte sul Meno (1797). Nel 1798-1799 Hegel
compose alcuni scritti, tutti rimasti inediti, di natura teologica; nel
1800 il primo breve abbozzo del suo sistema che anch'esso rimase inedito.
Frattanto essendogli morto il padre, che gli aveva lasciato un piccolo
capitale, si recò a Jena e qui esordì pubblicamente con la Differenza dei
sistemi di filosofia di Fichte e Schelling (1801). Nel frattempo,
componeva e lasciava inediti altri scritti politici. Nel 1801 pubblicò
la dissertazione De orbitis planetarum e nel 1802-1803 collaborò con
Schelling al «Giornale critico della filosofia». Nel 1805 divenne
professore a Jena e fu redattore capo di un giornale bavarese ispirato
alla politica napoleonica.
A Norimberga, Heidelberg e Berlino.
Nel 1808 divenne direttore del Ginnasio di Norimberga e rimase in questo
ufficio fino al 1816. In quest'anno fu nominato professore di filosofia
a Heidelberg; e nel 1818 fu chiamato all'Università di Berlino. Cominciò
allora il periodo del suo massimo successo. Hegel moriva a Berlino, forse
di colera, il 14 novembre 1831.
2. Gli scritti.
Gli scritti del periodo giovanile dimostrano (com'è stato posto in luce
da Dilthey) un prevalente interesse religioso-politico. Questo interesse
si trasforma nelle grandi opere della maturità in un interesse
storico-politico. La realtà che sta dunque continuamente dinanzi a Hegel
e nei cui confronti egli formula le sue categorie interpretative è quella
della storia umana e della vita dei popoli.
I primi scritti.
Gli scritti giovanili (composti tra il 1793 e il 1800) rimasero inediti e
sono quasi tutti di natura teologica: Religione di popolo e cristianesimo;
Vita di Gesù; La positività della religione cristiana, Lo spirito del
cristianesimo e il suo destino. Inediti rlmasero pure un primo abbozzo
di Sistema, composto a Jena nel 1800: una Logica e metasica, una Filosofia
della natura e un Sistema della moralità. Il primo scritto
filosofico pubblicato da Hegel è, come si è detto, la Diferenza dei
sistemi di filosofia di Fichte e Schelling (1801) nel quale Hegel si
pronuncia in favore dell'idealismo di Schelling che, in quanto è
soggettivo ed oggettivo ad un tempo, gli appare come il vero e assoluto
idealismo. Dello stesso 1801 è la dissertazione per l'abilitazione alla
libera docenza De orbitis planetarum. Con Schelling Hegel collaborò nei
due anni successivi al «Giornale critico della filosofia».
Le opere della maturità.
La prima grande opera di Hegel è la Fenomenologia dello spirito (1807)
nella cui prefazione (1806) egli dichiarava il suo distacco dalla
dottrina di Schelling. A Norimberga Hegel pubblicò la Scienza della
logica, le cui due parti apparvero rispettivamente nel 1812 e nel 1816.
A Heidelberg apparve, nel 1817, l'Enciclopedia delle scienze filosofiche
in compendio che è la più compiuta formulazione del sistema di Hegel.
Nelle due successive edizioni del 1827 e del 1830, Hegel stesso aumentò
molto la mole dell'opera. Un'ulteriore edizione in tre volumi (nota sotto
il nome di «Grande Enciclopedia») fu fatta dagli allievi, dopo la morte
del Maestro, fra il 1840 e il 1845, tramite l'aggiunta di lunghe
annotazioni ricavate dagli appunti o dalle lezioni di lui. A Berlino
Hegel pubblicava quella che, in certo senso, è l'opera più significativa,
Lineamenti di filosofia del diritto ossia diritto naturale e scienza dello
stato in compendio (1821). Dopo la sua morte gli scolari raccolsero,
ordinarono e pubblicarono i suoi corsi di Berlino: Lezioni sulla filosofia
della storia; Estetica; Lezioni sulla filosofia della religione; Lezioni
sulla storia della filosofia. Recentemente sono state pubblicate anche
le Lezioni di filosofia del diritto (cfr. paragrafo 16).
3. Il giovane Hegel (a cura di Mario Trombino).
Importanza degli scritti giovanili.
a) Rigenerazione etico-religiosa e rigenerazione politica.
Gli scritti giovanili comprendono la produzione letteraria dal 1793 al
1800. Essi rimasero inediti per tutto l'Ottocento e la loro importanza
per intendere la personalità di Hegel e il percorso di formazione della
sua filosofia è stata messa in luce solo nel nostro secolo. In questi
scritti l'argomento dominante è teologico, ma è molto netta la
connessione con la politica. Hegel studia infatti un tema profondamente
connesso con la rivoluzione francese, della quale in Germania arrivavano
echi sempre più intensi: il tema della rigenerazione morale e religiosa
dell'uomo come fondamento della rigenerazione politica.
Religione e politica.
Egli era convinto che non si potesse realizzare alcuna autentica
rivoluzione politica se non basata su una rivoluzione del cuore, su
quella che oggi chiameremmo una rivoluzione culturale, una rigenerazione
della persona nella sua vita interiore e del popolo nella sua cultura.
Per questo motivo negli scritti giovanili non è possibile distinguere in
modo netto il tema religioso da quello politico. Essi formano una unità
inscindibile.
Il contesto culturale e politico tedesco.
Hegel, del resto, aveva ricevuto una educazione profondamente ancorata
alla teologia del suo tempo allo Stift di Tubinga, e privatamente aveva
letto con passione il progetto di rivoluzione culturale e politica
dell'Emilio e del Contratto sociale di Rousseau, nonché il Nathan il
saggio di Lessing e le opere di Spinoza in quegli anni tornate al centro
del dibattito filosofico dopo le Lettere sulla dottrina di Spinoza di
Jacobi. Per le particolari condizioni della Germania, poi, religione e
politica avevano una connessione profonda. I paesi tedeschi, infatti,
erano stati al centro del movimento della riforma protestante, sicché le
Chiese riformate e i principati tedeschi costituivano un insieme
politico-religioso omogeneo. Religione e politica erano quindi parte di
un unico quadro d'insieme per tutti coloro che studiavano progetti di
riforma nella seconda metà del Settecento in Germana.
Si osservi, ad esempio, l'idea di fondo delle poche pagine di argomento
specificamente politico che abbiamo del giovane Hegel prima del
trasferimento a Jena, i frammenti Sui rapporti interni del Württemberg e
sulla Costituzione della Germania (su quest'ultimo testo Hegel riprenderà
a lavorare a Jena).
Mondo interiore e mondo esteriore.
L'aspirazione dei popoli ad una vita migliore ed alla
libertà deve diventare realtà vivente attraverso la realizzazione di
progetti di riforma che spazzino via il vecchio impianto sociale fondato
sulla stabilità delle classi e sulla supremazia del potere nobiliare.
Perché questo accada, è necessario che l'ansia di libertà del popolo,
così forte nel mondo interiore degli uomini, produca un nuovo ordine
giuridico esteriore, nel quale la libertà interiore possa essere «dotata
di forza», possa cioè incarnarsi in istituzioni sociali nuove, fondate
sulla eguaglianza. Hegel è dunque convinto che la rivoluzione nelle
istituzioni possa avvenire solo come conseguenza esteriore di una
maturazione avvenuta all'interno della coscienza del popolo.
L'esigenza di una nuova religione fondata sulla «comunanza dei cuori».
Nei frammenti più ampi (e in lettere private) Hegel chiarisce il nesso
tra religione e politica. Perché giungano i «tempi migliori» occorre una
nuova forma di religione, che permetta a ciascuno dei cittadini di
partecipare con la propria vita interiore alla vita dello Spirito di
Dio, che si incarna nella storia non attraverso leggi e precetti morali,
ma attraverso la stessa vita degli uomini. Potrà nascere un ordine
politico egualitario quando i cittadini avranno imparato a vivere la
religione come comunanza dei cuori, quando ciascuno di essi avrà
imparato a riconoscere nella vita interiore del suo vicino il riflesso
dell'unica vita di Dio.
b) Cristianesimo, ebraismo e mondo greco: perdita e nostalgia dello
«spirito di bellezza».
A Berna, tra il 1795 e il 1797, Hegel scrive la Vita di Gesù e la
Positività della religione cristiana. In quest'ultimo scritto critica
duramente, con accenti profondamente rivoluzionari, le strutture delle
Chiese cristiane storicamente affermatesi dopo la morte di Gesù ed
ancora dominanti. In esse sarebbe sparito il senso profondo del
messaggio religioso del maestro. Gesù infatti ha predicato l'amore e la
comunanza dei cuori, la fratellanza come precetto di vita. Ha predicato
il superamento della vecchia legge esteriore, fatta di precetti e
comandi, attraverso la nuova legge dell'amore, fatta di intensa vita
interiore.
La «positività» della religione cristiana.
Le Chiese invece hanno costruito una religione positiva, cioè una religione
determinata attraverso criteri di verità oggettivamente fissati (i dogmi),
attraverso leggi morali codificate e precetti del tutto esteriori. Il
sentimento religioso profondo del divino, che non può essere vissuto se
non soggettivamente, è sparito, sommerso da questo carico di istituzioni
e comandi esteriori (positivi, nel linguaggio dello Hegel di Berna).
A Francoforte, tra il 1798 e il 1799, Hegel scrive il più complesso e
maturo degli scritti giovanili, lo Spirito del cristianesimo e il suo
destino (Cfr. M. Pancaldi e M. Trombino (a cura di), «Lo spirito del
cristianesimo e il suo destino» di Hegel e il problema della religione
nel pensiero post-hegeliano, Paravia, Torino 1990.).
Lo scritto ha un impianto storico, come poi avranno molte
opere di Hegel. Attraverso la riflessione filosofica sulla Bibbia, la
storia degli ebrei viene ripercorsa a partire dal diluvio sino alla
distruzione del Tempio ed alla diaspora. Hegel nota, in pagine di grande
efficacia, ma estremamente dure nella forma e nel contenuto, che gli
ebrei hanno reagito al diluvio ancorando la salvezza dalla natura, che
minaccia la loro morte, alla fede nella potenza del loro Dio. Il diluvio
è letto dagli ebrei come un tradimento della natura nei confronti dei
suoi figli; Dio è pensato come il Signore del tutto estraneo alla
natura, a cui essa, come ogni cosa, è sottomessa. Gli ebrei hanno dunque
pensato Dio contrapponendolo alla natura: Egli è tutto, l'uomo e la
natura sono niente. (Si osservi come il Dio personale ebraico, per
Hegel, sia solamente un «pensato», qualcosa di costruito con l'intelletto
ipostatizzando in un essere personale il divino che è immerso
nella vita del Tutto).
L'ebraismo e il suo destino di infelicità.
Per questo motivo gli ebrei hanno scelto di vivere in inimicizia con la
natura e in ostilità con gli altri uomini: essi infatti ripongono la
salvezza nel loro lontano Dio trascendente, di cui sono il popolo
eletto. E il loro Dio è «geloso»: ogni rapporto di serena amicizia con
gli altri uomini contraddice il rapporto di fedeltà esclusiva al loro
Dio ed implica una commistione con gli dèi di altri popoli. Vi sono
stati, in verità, momenti in cui con i popoli vicini gli ebrei «insieme
godevano del sole, insieme guardavano la luna e le stelle», cioè
ricostruivano un tessuto di serena fiducia all'interno di una natura
pacificata. Poi però tutto questo veniva considerato tradimento ed essi
ritornavano alla loro antica scelta di fedeltà al loro Signore e di
inimicizia contro i popoli stranieri e la natura.
Gli ebrei sono dunque vittima del destino che essi stessi hanno aizzato
contro di loro. Sul concetto hegeliano di destino, per evitare
fraintendimenti, è opportuno fare chiarezza. Hegel interpreta il destino
di un popolo in questi termini: data la realtà storica e naturale, che
possiede una sua intima necessità ed una sua precisa logica interna, il
destino è la forza con cui la natura reagisce quando l'uomo o il popolo
le si pongono contro.
L'unità della vita e l'amore.
Hegel studia quindi la figura di Gesù, che ha rifiutato la scelta del
suo popolo e ha predicato la legge dell'amore, cioè del superamento
dell'ostilità in nome della profonda unità di vita che lega tutti gli
esseri viventi. Questo concetto di vita è fondamentale nello Spirito del
cristianesimo. Hegel parte infatti dall'idea - di matrice in parte
spinoziana, in parte mistica - che la vita sia una: inimicarsi gli altri
popoli, come fanno gli ebrei, significa inimicarsi dei viventi, e dunque
porsi contro la vita stessa che si esprime in loro. Poiché una sola vita
accomuna i viventi - tutti i viventi, ebrei e stranieri - allora la stessa
vita degli ebrei è in sé lacerata: la vita offesa si vendica, condannando
gli ebrei ad un destino di infelicità. L'amore di Gesù ricostituisce
l'unità della vita e permette il superamento della lacerazione.
Il mondo greco.
La figura di Gesù è quindi vicina al mondo greco, che ha fatto una
scelta diametralmente opposta a quella ebraica. I greci
hanno vissuto il loro rapporto con la natura in spirito di bellezza,
godendo cioè di un sereno accordo con essa (la loro morale è in accordo
con i loro desideri, i loro dèi sono immersi nella natura espressione
delle stesse forze naturali, e così via). Nel mito greco, dopo la
distruzione del genere umano, Deucalione e Pirra non hanno reagito come
Noè, ma hanno sottoscritto un nuovo patto di fiducia nei confronti della
natura e della vita. I greci non hanno creato alcuna scissione tra sé e
l'unica vita del tutto.
Tuttavia tanto i greci quanto Gesù sono stati storicamente sconfitti. Lo
spirito di amicizia tipico del mondo greco è stato storicamente superato
da nuove esperienze della civiltà occidentale. Parallelamente Gesù muore
ucciso dal suo popolo, incapace di capire il sublime messaggio dell'amore
come unità degli spiriti viventi.
La speranza in un nuovo spirito di bellezza.
Muore, tuttavia, testimoniando la sua fede nel divino che è in ogni cosa,
e dunque sperando che risorga dopo di lui un nuovo spirito di bellezza.
Muore senza avere nemici, cioè senza sentire i suoi uccisori come nemici.
Ma i suoi seguaci hanno tradito il suo messaggio d'amore: hanno solo
costruito delle sette, delle Chiese, riproponendo tutti gli errori e
tutto lo spirito di separazione e di inimicizia degli ebrei. Le Chiese
moderne come istituzioni storiche, anche quelle nate dalla riforma
protestante, sono condannate da Hegel perché pensano Dio come lo pensavano
gli ebrei, invece di riproporre l'autentico messaggio dell'amore. Occorre
dunque una nuova religione, un nuovo messaggio d'amore.
Hegel, poi, lascia l'incarico di precettore a Francoforte e nel 1800 si
trasferisce a Jena, dove lavora come professore universitario a stretto
contatto con Schelling. Lì pubblica i primi scritti, dai quali appare
subito che la sua ricerca ha mutato profondamente direzione. Egli non si
attende più che la rivoluzione dello spirito dell'uomo e dei popoli nasca
dalla religione, ma dalla oggettiva evoluzione storica e dalla
filosofia, in quanto capace di pensare scientificamente, secondo la sua
intima necessità, il corso del mondo.
4. I capisaldi del sistema.
Le tesi di fondo.
Per poter seguire proficuamente lo svolgimento del pensiero di Hegel
risulta indispensabile aver chiare, sin dall'inizio, le tesi di fondo del
suo idealismo:
1) la risoluzione del finito nell'infinito;
2) l'identità fra ragione e realtà;
3) la funzione giustificatrice della filosofia.
a) Finito e infinito.
L'infinito come unica realtà.
Con la prima tesi Hegel intende dire che la realtà non è un insieme di
sostanze autonome, ma un organismo unitario di cui tutto ciò che esiste
è parte o manifestazione. Tale organismo, non avendo nulla al di fuori
di sé e rappresentando la ragion d'essere di ogni realtà, coincide con
l'Assoluto e con l'Infinito, mentre i vari enti del mondo,
essendo manifestazioni di esso, coincidono con il finito. Di
conseguenza, il finito, come tale, non esiste, perché ciò
che noi chiamiamo finito è nient'altro che un'espressione parziale
dell'infinito. Infatti, come la parte non può esistere se non in
connessione con il Tutto, in rapporto al quale soltanto ha vita e senso,
così il finito esiste unicamente nell'infinito e in virtù dell'infinito.
Detto altrimenti: il finito, in quanto è reale, non è tale, ma è lo
stesso infinito.
L'infinito si identifica con un Soggetto spirituale in divenire che
soltanto alla fine, cioè con l'uomo, si rivela per ciò che è veramente.
L'hegelismo si configura quindi come una forma di monismo panteistico,
cioè come una teoria che vede nel mondo (= il finito) la manifestazione
o la realizzazione di Dio (= l'infinito). A questo punto sembrerebbe che
l'hegelismo sia una forma di spinozismo. In verità, la differenza fra i
due sistemi è notevole. Mentre per Spinoza l'Assoluto è una Sostanza
statica che coincide con la Natura, per l'idealista Hegel si identifica
invece con un Soggetto spirituale in divenire, di cui tutto ciò che
esiste è un «momento» o una «tappa» di realizzazione. Infatti, dire che
la realtà non è «Sostanza», ma «Soggetto», significa dire, secondo Hegel,
che essa non è qualcosa di immutabile e di già dato, ma un processo di
auto-produzione che soltanto alla fine, cioè con l'uomo (= lo Spirito),
giunge a rivelarsi per quello che è veramente: «Il vero - scrive Hegel
nella Prefazione alla Fenomenologia dello Spirito - è l'intiero. Ma
l'intiero è soltanto l'essenza che si completa mediante il suo sviluppo.
Dell'Assoluto devesi dire che esso è essenzialmente Risultato, che solo
alla fine è ciò che è in verità...» (Traduzione italiana di E. De Negri,
La Nuova Italia, Firenze 1960, volume 1, pagina 15).
b) Ragione e realtà.
L'aforisma di Hegel...
Il Soggetto spirituale infinito che sta alla base della realtà viene
denominato da Hegel con il termine di Idea o di Ragione, intendendo con
queste espressioni (per le quali cfr. il Glossario) l'identità di
pensiero ed essere, o meglio, di ragione e realtà. Da ciò il noto
aforisma, contenuto nella Prefazione ai Lineamenti di filosofia del
diritto, in cui si riassume il senso stesso dell'hegelismo: « Ciò che è
razionale è reale; e ciò che è reale è razionale».
...e il suo significato.
Con la prima parte della formula, Hegel intende dire che la razionalità
non è pura idealità, astrazione, schema, dover-essere, ma la forma stessa
di ciò che esiste, poiché la Ragione «governa» il mondo e lo costituisce.
Viceversa, con la seconda parte della formula, Hegel intende affermare
che la realtà non è una materia caotica, ma il dispiegarsi di una
struttura razionale (l'Idea o la Ragione) che si manifesta in modo
inconsapevole nella natura e in modo consapevole nell'uomo. Per cui, con
il suo aforisma, Hegel non esprime la semplice possibilità che la realtà
sia penetrata o intesa dalla ragione, ma la necessaria, totale e
sostanziale identità di realtà e ragione.
Identità fra essere e dover-essere.
Tale identità implica anche l'identità fra essere e dover-essere, in quanto
ciò che è risulta anche ciò che razionalmente deve essere. Tant'è vero che
le opere di Hegel sono costellate di osservazioni piene di ironia e di
scherno a proposito dell'«astratto» e moralistico dover-essere che non è,
dell'ideale che non è reale. E tutte quante insistono sul fatto che il
mondo, in quanto è, e così com'è, è razionalità dispiegata, ovvero ragione
reale e realtà razionale - che si manifesta attraverso una serie di momenti
necessari che non possono essere diversi da come sono.
La necessità del reale.
Infatti, da qualsiasi punto di vista guardiamo il mondo, troviamo ovunque,
secondo Hegel, una rete di connessioni necessarie e di «passaggi obbligati
che costituiscono l'articolazione vivente dell'unica Idea o Ragione. In
altri termini, Hegel, secondo uno schema tipico della filosofia romantica,
ritiene che la realtà costituisca una totalità processuale necessaria,
formata da una serie ascendente di «gradi» o «momenti», che rappresentano,
ognuno, il risultato di quelli precedenti ed il presupposto di quelli
seguenti.
c) La funzione della filosofia.
Coerentemente con il suo orizzonte teorico, fondato sulle categorie di
totalità e di necessità, Hegel ritiene che il compito della filosofia
consista nel prendere atto della realtà e nel comprenderne le strutture
razionali che la costituiscono: «Comprendere ciò che è, è il compito
della filosofia, poiché ciò che è, è la ragione». A dire come dev'essere
il mondo, la filosofia arriva sempre troppo tardi; giacché sopraggiunge
quando la realtà ha compiuto il suo processo di formazione. Essa,
afferma Hegel con un paragone famoso, è come la nottola di Minerva che
inizia il suo volo sul far del crepuscolo, cioè quando la realtà è già
bell'e fatta. La filosofia deve dunque « mantenersi in pace con la realtà
e rinunciare alla pretesa assurda di determinarla e guidarla. Deve
soltanto portare nella forma del pensiero, cioè elaborare in concetti il
contenuto reale che l'esperienza le offre, dimostrandone, con la
riflessione, l'intrinseca razionalità.
Il compito della filosofia è di giustificare razionalmente ciò che esiste.
Questi chiarimenti delineano il tratto essenziale della filosofia e
della personalità di Hegel. L'autentico còmpito che Hegel ha inteso
attribuire alla filosofia (e ha cercato di realizzare con la sua
filosofia) è la giustificazione razionale della realtà, della
presenzialità, del fatto. Questo còmpito egli l'ha affrontato con
maggiore energia proprio là dove esso sembra più rischioso: cioè nei
confronti della realtà politica, dello Stato:
«Su diritto, eticità, stato la verità è altrettanto antica, quanto
apertamente esposta e nota nelle pubbliche leggi, nella pubblica morale
e religione. Di che cosa abbisogna ulteriormente questa verità, in
quanto lo spirito pensante non è pago di possederla così a portata di
mano, se non anche di comprenderla, e di conquistare al contenuto già in
se stesso razionale anche la forma razionale, affinché esso appaia
giustificato per il pensiero libero...?» (Lineamenti di filosofia del
diritto, traduzione italiana di G. Marini, Laterza, Roma-Bari 1990).
d) Il dibattito critico intorno al «giustificazionismo» hegeliano.
Una puntualizzazione di Hegel.
Che la filosofia di Hegel implichi un atteggiamento programmaticamente
giustificazionista nei confronti della realtà risulta evidente da quanto
si è detto sinora. Ciò non toglie che Hegel, onde evitare che la sua
filosofia potesse essere scambiata per una banale accettazione della
realtà in tutti i suoi aspetti, anche in quelli più immediati,
abbia sentito la necessità di puntualizzare:
«Nella vita ordinaria si chiama a casaccio realtà ogni capriccio,
l'errore, il male e ciò che è su questa linea, come pure ogni qualsiasi
difettiva e capricciosa esistenza. Ma già anche per l'ordinario modo di
pensare un'esistenza accidentale non merita l'enfatico nome di
reale: - l'accidentale è un'esistenza che non ha altro maggior valore di un
possibile; che può non essere allo stesso modo che è. Ma, quando io ho
parlato di realtà, si sarebbe pur dovuto pensare al senso nel quale
adopero quest'espressione, giacché in una mia estesa Logica... l'ho
accuratamente distinta non solo dall'accidentale, che pure ha esistenza,
ma altresì dall'essere determinato, dall'esistenza e da altri concetti »
(Enc., paragrafo 6).
Secondo taluni critici, questo passo starebbe a dimostrare come
l'hegelismo non sia riducibile ad una forma di giustificazionismo. In
verità, se si prende in considerazione tutto il paragrafo 6
dell'Enciclopedia, ci si rende conto di come Hegel, con il suo intervento
«difensivo» non avesse affatto intenzione di sconfessare la tesi della
sostanziale razionalità del reale, ma solo di escludere, dall'accezione
filosofica di «realtà» (Wirklichkeit, «realtà in atto», o, come traduce
Valerio Verra, «realtà elettiva».) gli aspetti «superficiali» o
«accidentali» (Tra l'altro, come in una realtà razionale e necessaria
possa esistere l'accidentale, è qualcosa che in Hegel risulta oscuro.
Tant'è vero che nel concetto hegeliano di «accidente» alcuni critici
vedono un semplice «stratagemma speculativo» per poter parlare di ciò
che non si lascia ridurre alla Ragione (cioè alla sua filosofia)
dell'esistenza immediata.
La «realtà» di cui parla Hegel non coincide con il lato accidentale e
superficiale delle cose. Ciò non toglie che essa si identifichi pur
sempre con la loro trama essenziale.
Infatti, nel resto del paragrafo, Hegel, lasciando intendere
come il corso o la trama del mondo non possa mai fare a meno, negli
aspetti essenziali (cioè in quelli che contano) di essere
necessariamente razionale, polemizza ancora una volta contro «la
separazione della realtà dall'idea» e, alla fine, inequivocabilmente,
conclude:
«Chi non possederebbe la sapienza di scoprire, in ciò che lo circonda,
molte cose che in fatto non sono come debbono essere? Ma questa sapienza
ha torto quando immagina di aggirarsi, con sifatti oggetti e col loro
dover essere, nella cerchia degli interessi della scienza filosofica.
Questa ha da fare solo con l'Idea, che non è tanto impotente da
restringersi a dover essere solo, e non esser poi effettivamente: ha da
fare perciò con una realtà, di cui quegli oggetti, istituzioni,
condizioni eccetera, sono solo il lato esterno e superficiale».
Un noto filone interpretativo, che va da Engels a Marcuse, pur
ammettendo gli aspetti «conservatori» del pensiero hegeliano, ha
tuttavia cercato di mostrare come esso possa venir letto anche in modo
dinamico e rivoluzionario. Infatti, secondo tali autori, l'aforisma di
Hegel significherebbe, in sostanza, che il reale è destinato a
coincidere con il razionale, mentre l'irrazionale è destinato a perire.
Letture tendenziose di Hegel.
Ora, che una lettura siffatta, più che un'«interpretazione» di Hegel,
rappresenti una sorta di «correzione» del suo sistema alla luce degli
ideali rivoluzionari dei suoi propugnatori, è qualcosa che risulta
manifesto da un esame non ideologicamente pregiudicato dei già citati
testi del filosofo. Tant'è vero che essa è riuscita a darsi una parvenza
di legittimità storiografica solo a patto di distinguere
engelsianamente, nel filosofo tedesco, il cosiddetto metodo
(classificato come «rivoluzionario») dal cosiddetto sistema
(classificato come «conservatore»). Distinzione che oggi è stata
contestata da più parti e che, tra l'altro, non troviamo neppure nel
giovane Marx, « per il quale non ha senso parlare di contraddizione fra
metodo e sistema in Hegel, ché anzi è proprio il metodo (ipostatizzante)
di Hegel a spiegare le conclusioni reazionarie della sua filosofia» (G.
Bedeschi). Infatti il giovane Marx (certamente meno hegeliano, su questo
punto, di Engels e di tanti marxisti successivi) ha esplicitamente
contestato la «canonizzazione» o la «santificazione» dell'esistente
operata dall'autore dei Lineamenti di filosofia del diritto. E se la sua
maniera di rapportarsi ad Hegel ha trovato meno seguito di quella
engelsiana, ciò è dovuto a ben precise circostanze storico-culturali (in
primo luogo al fatto che i suoi scritti filosofici sono stati conosciuti
molto tardi) e non certo alla minore fondatezza della sua esegesi.
Il sostanziale giustificazionismo di Hegel.
In conclusione (è bene insistere su questo punto anche contro le
ambiguità e gli equivoci perpetuati da certa manualistica) ci sembra che
i testi di Hegel, al di là di ogni «costruzione» interpretativa,
documentino in modo chiaro ed inequivocabile il suo atteggiamento
fondamentalmente giustificazionista nei confronti della realtà.
5. Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia.
Hegel ritiene che il farsi dinamico dell'Assoluto passi attraverso i tre
momenti dell'Idea «in sé e per sé» (tesi), dell'Idea «fuori di sé»
(antitesi) e dell'Idea che «ritorna in sé» (sintesi). Tant'è vero che il
disegno complessivo dell'Enciclopedia hegeliana è quello di una
grande triade dialettica.
I tre momenti dell'Assoluto: Idea, Natura, Spirito.
L'Idea «in sé e per sé» (Enc., paragrafo 18) o Idea «pura» (Enc.,
paragrafo 19) è l'Idea considerata in se stessa, a prescindere dalla sua
concreta realizzazione nel mondo. Da questo angolo prospettico, l'Idea,
secondo un noto paragone teologico di Hegel, è assimilabile a Dio «prima
della creazione della natura e di uno spirito finito», ovvero, in termini
meno equivocanti (visto che l'Assoluto hegeliano è un infinito immanente,
che non crea il mondo, ma è il mondo) al programma o all'ossatura
logico-razionale della realtà. L'Idea «fuori di sé» o Idea «nel suo
esser altro» è la Natura, cioè l'estrinsecazione o l'alienazione
dell'Idea nelle realtà spazio-temporali del mondo. L'Idea che «ritorna in
sé» è lo Spirito, cioè l'Idea che dopo essersi fatta natura torna «presso
di sé» (bei sich) nell'uomo. Ovviamente, questa triade non è da
intendersi in senso cronologico, come se prima ci fosse l'Idea in sé e
per sé, poi la Natura e infine lo Spirito, ma in senso ideale. Infatti ciò
che concretamente esiste nella realtà è lo Spirito (la sintesi), il
quale ha come sua coeterna condizione la Natura (l'antitesi) e come suo
coeterno presupposto il programma logico rappresentato dall'Idea pura (la
tesi).
Le tre sezioni della filosofia: logica, filosofia della natura e filosofia
dello spirito.
A questi tre momenti strutturali dell'Assoluto Hegel fa corrispondere le
tre sezioni in cui si divide il sapere filosofico:
1) la logica, che è «la scienza dell'Idea in se e per sé» (Enc.,
paragrafo 18), cioè dell'Idea considerata nel suo essere implicito (= in sé)
e nel suo graduale esplicarsi (= per sé), ma a prescindere, come si è
visto, dalla sua concreta realizzazione nella natura e nello spirito;
2) la filosofia della natura, che è «la scienza dell'Idea nel suo alienarsi
da sé» (ivi);
3) la filosofia dello spirito, che è «la scienza dell'Idea, che dal suo
alienamento ritorna in sé » (ivi).
Ecco un primo schema generale (cui seguiranno altri più analitici):
Logica (Tesi dell'Idea in sé per sé):
1) dottrina dell'essere;
2) dottrina dell'essenza;
3) dottrina del concetto.
Filosofia della Natura (Antitesi, Idea fuori di sé):
1) meccanica;
2) fisica;
3) organica.
Filosofia dello Spirito (Sintesi, Idea che ritorna in sé):
1) soggettivo (a: antropologia; b: fenomenologia; c: psicologia);
2) oggettivo (a: diritto; b: moralità; c: eticità);
3) assoluto (a: arte; b: religione; c: filosofia).
6. La Dialettica.
Come si è visto, l'Assoluto, per Hegel, è fondamentalmente divenire. La
legge che regola tale divenire è la «dialettica», che rappresenta, al
tempo stesso, la legge (ontologica) di sviluppo della realtà e la legge
(logica) di comprensione della realtà. Hegel non ha offerto, della
dialettica, una teoria sistematica, limitandosi, per lo
più, ad utilizzarla nei vari settori della filosofia. Ciò non esclude la
possibilità (che in sede didattica diventa una improrogabile necessità) di
fissare qualche tratto generale di essa.
Nel paragrafo 79 dell'Enciclopedia Hegel distingue tre momenti o aspetti
del pensiero:
a)«l'astratto o intellettuale»; b) «il dialettico o negativo-razionale»;
c) «lo speculativo o il momento positivo-razionale».
Il momento «astratto o intellettuale».
Il momento astratto o intellettuale consiste nel concepire l'esistente
sotto forma di una molteplicità di determinazioni statiche e separate le
une dalle altre. In altri termini, il momento intellettuale (che è il
grado più basso della ragione) è quello per cui il pensiero si ferma
alle determinazioni rigide della realtà, limitandosi a considerarle
nelle loro differenze reciproche e secondo il principio di identità e
di non-contraddizione (secondo cui ogni cosa è se stessa ed è assolutamente
diversa dalle altre).
Il momento «negativo-razionale».
Il momento dialettico o negativo-razionale consiste nel mostrare come
le sopraccitate determinazioni siano unilaterali ed esigano di essere
messe «in movimento», ovvero di essere relazionate con altre determinazioni.
Infatti, poiché ogni affermazione sottintende una negazione, in quanto per
specificare ciò che una cosa è bisogna implicitamente chiarire ciò che
essa non è (già Spinoza aveva sentenziato che omnis determinatio est
negatio), risulta indispensabile procedere oltre il principio di identità
e mettere in rapporto le varie determinazioni con le determrnazioni
opposte (ad esempio il concetto di «uno», non appena venga smosso dalla sua
astratta rigidezza, richiama quello di «molti» e manifesta uno stretto
legame con esso. E così dicasi di ogni altro concetto: il particolare
richiama l'universale, l'uguale il disuguale, il bene il male eccetera).
Il momento «positivo-razionale».
Il terzo momento, quello speculativo o positivo-razionale, consiste invece
nel cogliere l'unità delle determinazioni opposte, ossia nel rendersi conto
che tali determinazioni sono aspetti unilaterali di una realtà più alta che
li ri-comprende o sintetizza entrambi (ad esempio si scopre che la realtà
vera non è né l'unità in astratto né la molteplicità in astratto, bensì
un'unità che vive solo attraverso la molteplicità).
L'affermazione (tesi), la negazione (antitesi) e la ri-affermazione (sintesi).
Globalmente e sinteticamente considerata, la dialettica consiste quindi:
1) nell'affermazione o posizione di un concetto «astratto e limitato», che
funge da tesi;
2) nella negazione di questo concetto come alcunché di limitato o di finito
e nel passaggio ad un concetto opposto, che funge da antitesi;
3) nella unificazione della precedente affermazione e negazione in una
sintesi positiva comprensiva di entrambe. Sintesi che si configura come
una ri-affermazione potenziata dell'affermazione iniziale (tesi), ottenuta
tramite la negazione della negazione intermedia (antitesi).
L'Aufhebung.
Riaffermazione che Hegel focalizza con il termine tecnico di Aufhebung
(cfr. il Glossario) il quale esprime l'idea di un «superamento» che è,
al tempo stesso, un togliere (l'opposizione fra tesi ed antitesi) ed un
conservare (la verità della tesi, dell'antitesi e della loro lotta).
6.1. Puntualizzazioni circa la dialettica.
La dialettica è la totalità dei tre momenti.
1) Come si può notare, la dialettica non comprende soltanto il secondo
momento (quello che Hegel chiama dialettico in senso stretto) ma la
totalità dei tre momenti momenti elencati.
Dialettica e crisi del finito.
2) La dialettica non fa che illustrare il principio fondamentale della
filosofia hegeliana: la risoluzione del finito nell'infinito. Infatti essa
ci mostra come ogni finito, cioè ogni spicchio di realtà, non possa
esistere in se stesso (poiché in tal caso sarebbe un assoluto, ovvero un
infinito autosufficiente) ma solo in un contesto di rapporti. Infatti,
per porre se stesso il finito è obbligato ad opporsi a qualcos'altro,
cioè ad entrare in quella trama di relazioni che forma la realtà e che
coincide con il tutto infinito di cui esso è parte o manifestazione.
E poiché il tutto di cui parla Hegel, ovvero l'Idea, è una entità dinamica,
la dialettica esprime appunto il processo mediante cui le varie parti o
determinazioni della realtà perdono la loro rigidezza, si fluidificano e
diventano «momenti» di un'Idea unica ed infinita. Detto altrimenti, la
dialettica rappresenta la crisi del finito e la sua risoluzione necessaria
nell'infinito: «ogni finito ha questo di proprio, che sopprime se medesimo.
La dialettica forma, dunque, l'anima motrice del progresso scientifico... in
essa, soprattutto è la vera, e non estrinseca elevazione sul finito»
(Enc., paragrafo 81).
Dialettica e ottimismo.
3) La dialettica ha un significato globalmente ottimistico, poiché essa
ha il compito di unificare il molteplice, conciliare le opposizioni,
pacificare i conflitti, ridurre ogni cosa all'ordine e alla perfezione
del Tutto. Molteplicità, opposizione, conflitto sono senza dubbio reali
secondo Hegel, ma solo come momenti di passaggio. In altri termini, il
negativo, per Hegel, sussiste solo come un momento del farsi del
positivo e la tragedia, nella sua filosofia, è solo l'aspetto
superficiale e transeunte di una sostanziale commedia (nel senso
letterale di vicenda avente un epilogo positivo).
Il carattere «chiuso» della dialettica hegeliana...
4) Appurato che pensare dialetticamente significa pensare la realtà come
una totalità processuale che procede secondo lo schema triadico di tesi,
antitesi e sintesi, ci si può chiedere se la dialettica hegeliana sia a
sintesi aperta o a sintesi chiusa. Infatti, poiché ogni sintesi
rappresenta a sua volta la tesi di un'altra antitesi, cui succede
un'ulteriore sintesi e così via, sembrerebbe, a prima vista, che la
dialettica esprima un processo costitutivamente aperto. In verità, Hegel
pensa che in tal caso si avrebbe il trionfo della «cattiva infinità»,
ossia un processo che, spostando indefinitamente la meta da raggiungere,
toglierebbe allo spirito il pieno possesso di se medesimo. Di
conseguenza, egli opta per una dialettica a sintesi finale chiusa, cioè
per una dialettica che ha un ben preciso punto di arrivo:
«Mentre nei gradi intermedi della dialettica prevale la rappresentazione
della spirale, nella visione complessiva e finale del sistema prevale la
rappresentazione del circolo chiuso, che soffoca la vita dello spirito,
dando al suo progresso un termine, al di là del quale ogni attività
creatrice si annulla, perché, avendo lo spirito realizzato pienamente se
stesso, non gli resta che ripercorrere il cammino già fatto...L'impetuosa
corrente sfocia in uno stagnante mare, e nell'immohile specchio trema
la vena delle acque che vi affluiscono... » (Guido de Ruggiero).
...e i suoi critici.
5) E in effetti, tutti i filosofi che si sono rifatti in qualche modo
all'hegelismo (da Engels a Croce e ai neomarxisti) hanno criticato l'idea
di uno «stagnante epilogo» della storia del mondo, recuperando invece
l'idea di un processo che, pur coincidendo ad ogni istante con se stesso,
risulta costitutivamente aperto. Inoltre, più che sul momento della
«conciliazione», tali filosofi hanno insistito sul momento
dell'«opposizione» e della «contraddizione», ossia su ciò che Hegel,
nella Fenomenologia, chiama «il travaglio del negativo».
7. La critica alle filosofie precedenti.
Dopo aver definito in positivo i capisaldi dell'hegelismo, è venuto il
momento di illustrarli in negativo, ossia di vedere a quali filosofie
esso storicamente si contrapponga.
a) Hegel e gli illuministi.
La filosofia di Hegel (Come risulta soprattutto dai Lineamenti della
filosofia del diritto e dalle Lezioni sulla filosofia della storia
(Cfr. Introduzione generale, traduzione italiana, pagine 1-190),
implica un oggettivo rifiuto della maniera illuministica di rapportarsi
al mondo.
Carattere astratto e parziale della razionalità illuministica.
Infatti, gli illuministi, facendo dell'intelletto il giudice della storia,
sono costretti a ritenere che il reale non è razionale, dimenticando così
che la vera ragione (= lo Spirito) è proprio quella che prende corpo nella
storia ed abita in tutti i momenti di essa. Invece la ragione degli
illuministi esprime solo le esigenze e le aspirazioni degli individui: è
una ragione finita e parziale, ovvero un «intelletto astratto», che
pretende di dare lezione alla realtà e alla storia, stabilendo come essa
dovrebbe essere e non è, mentre la realtà è sempre necessariamente ciò
che deve essere:
«La separazione della realtà dall'idea è specialmente cara all'intelletto,
che tiene i sogni delle sue astrazioni per alcunché di verace ed è tutto
gonfio del suo dover essere, che anche nel campo politico va predicando
assai volentieri: quasi che il mondo avesse aspettato quei dettami per
apprendere come dev'essere e non è; che, se poi fosse come dev'essere,
dove se ne andrebbe la saccenteria di quel dover essere?
(Enc., paragrafo 6).
b) Hegel e Kant.
L'avversione di Hegel per l'Illuminismo si accompagna alla sua tenace
opposizione a Kant. Questi aveva voluto costruire una filosofia del
finito, e l'antitesi tra il dover essere e l'essere (tra la ragione e la
realtà) fa parte integrante di una tale filosofia.
Con i suoi «dualismi», Kant non riesce a cogliere l'infinito.
Per Kant, le idee della ragione sono meri ideali, regole impegnative che
spingono la ricerca scientifica all'infinito, verso una compiutezza e una
sistemazione che essa non raggiunge mai. Inoltre, nel dominio morale, la
volontà non coincide con la ragione e non raggiunge mai la santità, che
è il termine di un progresso all'infinito, ma che nella sua attualità è
propria soltanto di Dio. In una parola, l'essere non si adegua mai al
dover essere, la realtà alla razionalità. Secondo Hegel, invece, questa
adeguazione è in ogni caso necessaria. A Kant Hegel rimprovera anche la
pretesa di voler indagare la facoltà del conoscere prima di procedere a
conoscere. Pretesa che egli assimila all'assurdo «proposito di quel tale
Scolastico, d'imparare a nuotare prima di arrischiarsi nell'acqua»
(Enc., paragrafo 10).
c) Hegel e i romantici.
Le critiche di Hegel ai romantici.
Hegel è anche un critico severo delle posizioni del «circolo» romantico,
del quale, nel periodo francofortese (1797-1800), aveva subito
l'influenza. Schematizzando, si può dire che il dissenso di Hegel nei
confronti dei romantici verta essenzialmente su due punti. In primo
luogo, Hegel contesta il primato del sentimento, dell'arte o della fede,
sostenendo che la filosofia, in quanto scienza dell'Assoluto, non può che
essere una forma di sapere mediato e razionale. In secondo luogo, Hegel
contesta gli atteggiamenti individualistici dei romantici (o meglio, si
dovrebbe dire, di certi romantici in una certa fase del loro pensiero,
perché nel Romanticismo, come si è già detto, coesistono atteggiamenti
individualistici ed anti-individualistici al tempo stesso), affermando
che l'intellettuale non deve narcisisticamente ripiegarsi sul proprio io
od invocare le «leggi del cuore», ma tener docchio soprattutto
l'oggettivo «corso del mondo», cercando di integrarsi nelle istituzioni
socio-politiche del proprio tempo. Taluni studiosi, accettando la
riduzione (hegeliana) del Romanticismo al circolo romantico, hanno
considerato il filosofo come un anti-romantico. In realtà, come abbiamo
già accennato nel primo capitolo, Hegel, pur non rientrando nella
«scuola romantica» in senso stretto, risulta profondamente partecipe del
clima culturale romantico, del quale oltre a numerosi motivi particolari
(il concetto della creatività dello Spirito, dello sviluppo
provvidenziale della storia, della spiritualità incosciente della natura
eccetera) condivide soprattutto il tema dell'infinito, anche se ritiene,
come si è visto, che ad esso si acceda speculativamente e non attraverso
vie «immediate».
Pur avendo polemizzato con i romantici, Hegel risulta partecipe del loro
stesso clima culturale.
Di conseguenza Hegel, rigorosamente parlando, non costituisce un
«superamento» del Romanticismo, ma solo il diverso esito di una
determinata direzione di sviluppo della cultura romantica.
Per cui la sua filosofia non cade fuori della civiltà intellettuale
romantica, bensì all'interno di essa.
d) Hegel e Fichte.
Il rifiuto del «soggettivismo» fichtiano e della sua concezione
dell'infinito come mèta irraggiungibile.
Hegel muove a Fichte due rilievi fondamentali. In primo luogo (cfr.
soprattutto il saggio del 1801 intitolato Differenza del sistema
fichtiano e di quello schellinghiano) accusa il soggettivismo di Fichte
di non riuscire ad assimilare adeguatamente l'oggetto, ovvero di ridurlo
a semplice ostacolo esterno dell'Io, con il rischio di un nuovo dualismo,
di tipo kantiano, fra spirito e natura, libertà e necessità. In secondo
luogo, accusa Fichte di aver ridotto l'infinito a semplice mèta ideale
dell'io finito. Ma in tal modo il finito, per adeguarsi all'infinito e
ricongiungersi con esso, è lanciato in un progresso all'infinito che non
raggiunge mai il suo termine. Ora questo progresso all'infinito è,
secondo Hegel, il falso o «cattivo infinito» o l'infinito negativo; non
supera veramente il finito perché lo fa continuamente risorgere, ed
esprime soltanto l'esigenza astratta del suo superamento. Di conseguenza,
Fichte si troverebbe ancora, dal punto di vista di Hegel, in una
filosofia incapace di attingere quella piena coincidenza fra finito e
infinito razionale e reale, essere e dover-essere, che costituisce la
sostanza dell'idealismo.
e) Hegel e Schelling.
L'Assoluto di Schelling è un'unità vuota ed astratta.
Hegel critica Schelling perché quest'ultimo concepisce l'Assoluto in modo
a-dialettico, cioè come un'unità indifferenziata e statica da
cui derivano in modo inesplicabile la molteplicità e la
differenziazione delle cose. Infatti, nella prefazione
alla fenomenologia dello Spirito Hegel critica crudamente il concetto
schellinghiano dell'Assoluto come identità o indifferenza, ravvisando in
esso un «abisso vuoto» nel quale si perdono tutte le determinazioni
concrete della realtà, e paragonandolo alla notte «nella quale - come suol
dirsi - tutte le vacche sono nere». In altri termini, l'Assoluto di
Schelling è un'unità astratta che, essendo priva di vita e concretezza
interiore, risulta incapace di dar ragione della molteplicità delle cose.
8. La Fenomenologia dello spirito.
Il principio della risoluzione del finito nell'infinito, o dell'identità
di razionale e reale, è stato illustrato da Hegel in due forme diverse.
Dapprima Hegel si è fermato a illustrare la via che per giungere fino ad
esso ha dovuto percorrere la coscienza umana; o, il che è lo stesso, la via
che quello stesso principio ha dovuto percorrere, attraverso la coscienza
umana, per giungere a se stesso. In secondo luogo, Hegel ha illustrato quel
principio quale appare in atto in tutte le determinazioni fondamentali
della reltà.
Il posto fenomenologia all'interno del sistema.
La prima illustrazione è quella che Hegel ha dato nella Fenomenologia
dello spirito; la seconda è quella che ha dato nella Enciclopedia delle
scienze filosofiche e nelle opere che estendono le singole parti di essa
(Scienza della logica, Filosofia dell'arte, Filosofia della religione,
Filosofia del diritto, Filosofia della storia). è evidente che anche la
via che lo spirito infinito ha dovuto seguire per riconoscersi nella sua
infinità attraverso le manifestazioni finite fa parte della realtà, e che
pertanto la fenomenologia dello spirito deve ripresentarsi come parte del
sistema generale della realtà e precisamente della filosofia dello spirito.
Come tale, infatti, Hegel la ripresenta nella Enciclopedia. La confusione
che lo stesso Hegel ha fatto sorgere includendo la fenomenologia (per la
storia e il significato del termine cfr. il Glossario)come una sezione
della filosofia dello spirito vien subito eliminata se si tiene presente
l'intento esplicito di Hegel nella Fenomenologia dello spirito. Le vicende
dello spirito in quest'opera sono le vicende del principio hegeliano
dell'infinito nelle sue prime apparizioni o barlumi nel suo progressivo
affermarsi e svilupparsi attraverso una serie di figure (cfr. il Glossario)
esprimenti i settori più disparati della vita umana (la conoscenza, la
società, la religione, la politica eccetera).
La fenomenologia come storia delle vicissitudini della coscienza.
E difatti la fenomenologia è la storia romanzata della coscienza, che
attraverso erramenti, contrasti, scissioni, e quindi infelicità e dolore,
esce dalla sua individualità, raggiunge l'universalità e si riconosce
come ragione che è realtà e realtà che è ragione. Perciò l'intero ciclo
della fenomenologia si può vedere riassunto in una delle sue figure
particolari che non per nulla diventata la più popolare:
quella della coscienza infelice. La coscienza infelice è quella che non
sa di essere tutta la realtà, perciò si ritrova scissa in differenze,
opposizioni o conflitti dai quali è internamente dilaniata e dai quali
esce solo arrivando alla coscienza di essere tutto.
Funzione introduttiva e propedeutica della fenomenologia.
La fenomenologia ha pertanto uno scopo introduttivo e pedagogico:
« Il singolo, dice Hegel, deve ripercorrere i gradi di formazione dello
spirito universale, anche secondo il contenuto, ma come figure dello
spirito già deposte, come gradi di una via già tracciata e spianata.
Similmente noi, osservando come nel campo conoscitivo ciò che in precedenti
età teneva all'erta lo spirito degli adulti è ora abbassato a cognizioni,
esercitazioni e fin giuochi da ragazzi, riconosceremo nel progresso
pedagogico, quasi in proiezione, la storia della civiltà». In altri
termini, poiché non c'è altro modo di elevarsi alla filosofia come
scienza se non mostrandone il divenire, la fenomenologia, come divenire
della filosofia prepara e introduce il singolo alla filosofia: cioè tende
a far sì che esso si riconosca e si risolva nello spirito universale.
La prima parte della Fenomenologia si divide in tre momenti: Coscienza
(tesi), Autocoscienza (antitesi) e Ragione (sintesi). Nella fase della
coscienza predomina l'attenzione verso l'oggetto. Nella fase
dell'autocoscienza predomina l'attenzione verso il soggetto. Infine,
nella fase della ragione si arriva a riconoscere l'unità profonda
fra soggetto ed oggetto, io e mondo, interno ed esterno, sintetizzando
in tal modo i momenti della coscienza e dell'autocoscienza.
8.1. Coscienza.
La certezza sensibile.
Il punto di partenza della coscienza è la certezza sensibile. Questa
appare a prima vista come la certezza più ricca e più sicura; in realtà
è la più povera. Essa non rende certi che di una cosa singola, questa cosa,
ma la cosa può essere un albero, una casa eccetera, di cui siamo certi,
non in quanto albero o casa, ma in quanto questo albero o questa casa,
cioè in quanto presenti qui e ora davanti a noi. Ciò implica che la
certezza sensibile non è certezza della cosa particolare, ma del questo,
al quale la particolarità della cosa è indifferente e che perciò è un
universale (un generico questo).
La percezione.
Ora il questo non dipende dalla cosa ma dall'io che la considera. Perciò
in fondo la certezza sensibile non è che la certezza di un io anch'esso
universale, giacché anch'esso non è che questo o quell'io, un io in
generale. Se dalla certezza sensibile si passa alla percezione si ha lo
stesso rinvio all'io universale: un oggetto non può essere percepito come
uno, nella molteplicità delle sue qualità (per esempio, bianco, cubico,
sapido), se l'io non prende su di sé l'affermata unità, se cioè non
riconosce che l'unità dell'oggetto è da lui stesso stabilita.
L'intelletto.
Se infine si passa dalla percezione all'intelletto, questo riconosce
nell'oggetto solo una forza che agisce secondo una legge determinata.
è condotto perciò a vedere nell'oggetto stesso un semplice fenomeno, a cui
si contrappone l'essenza vera dell'oggetto, che è ultrasensibile. Poiché il
fenomeno è soltanto nella coscienza e ciò che è al di là del fenomeno o
è un nulla o è qualcosa per la coscienza, la coscienza a questo punto ha
risolto l'intero oggetto in se stessa ed è diventata coscienza di sé,
autocoscienza.
8.2. Autocoscienza.
Le figure più celebri della Fenomenologia.
Con la sezione dell'autocoscienza, che contiene le figure più celebri
della Fenomenologia, il centro dell'attenzione si sposta dall'oggetto al
soggetto, ovvero all'attività concreta dell'io, considerato nei suoi
rapporti con gli altri. Di conseguenza, tale sezione non si muove più in
un ambito astrattamente «gnoseologico», ma concerne settori più vasti,
quali la società, la storia della filosofia e la religione.
a) Signoria e servitù.
La necessità di un reciproco riconoscimento fra le autocoscienze.
L'autocoscienza postula la presenza di altre autocoscienze in grado di
darle la certezza di essere tale. In altri termini, l'uomo,
secondo Hegel, è autocoscienza solo se riesce a farsi
«riconoscere» da un'altra autocoscienza (ovvero da un altro essere
libero e pensante). Infatti, in quanto appetito o desiderio (Begierde),
l'autocoscienza non può limitarsi a cercare il proprio appagamento
negli oggetti sensibili, ma ha costitutivamente bisogno degli altri:
«L'autocoscienza raggiunge il suo appagamento solo in un'altra
autocoscienza»(traduzione italiana, citata, volume 1, pagina 151).
A tutta prima, si potrebbe pensare che «il reciproco riconoscersi delle
autocoscienze» debba avvenire tramite l'amore, il quale - come Hegel aveva
romanticamente sostenuto negli scritti giovanili - è il miracolo per cui
ciò che è due diviene uno, senza per altro implicare l'eliminazione della
dualità. Nella Fenomenologia il filosofo sceglie invece un'altra strada,
in quanto l'amore rappresenta ancora un'unità attinta a buon mercato
(Cfr. Jean Hyppolite, Genesi e struttura della «Fenomenologia dello
Spirito» di Hegel, traduzione italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1972,
pagine 200-201).
Infatti l'amore, non insistendo abbastanza sul carattere drammatico della
separazione fra le autocoscienze e sulle peripezie per giungere al loro
reciproco riconoscimento, è pur sempre qualcosa cui mancano, per usare
le parole di Hegel, «la serietà, il dolore, la pazienza e il travaglio
del negativo» (pagina 14).
Il conflitto fra le autocoscienze e il rapporto servo-signore.
Per cui, il riconoscimento non può che passare attraverso un momento
di lotta e di sfida, ossia attraverso il conflitto fra le autocoscienze.
Tale conflitto, nel quale ogni autocoscienza, pur di affermare la propria
indipendenza, deve essere pronta a tutto, anche a rischiare la vita, non
si conclude con la morte delle autocoscienze contendenti (poiché in
tal caso sarebbe annullata l'intera dialettica del riconoscimento) ma con il
subordinarsi dell'una all'altra nel rapporto servo-signore. Il signore è
colui che, pur di affermare la propria indipendenza, ha messo valorosamente
a repentaglio la propria vita, sino alla vittoria, mentre il sevo è colui
che, ad un certo punto, ha preferito la perdita della propria indipendenza,
cioè la schiavitù, pur di avere salva la vita.
L'inversione dialettica dei ruoli.
Tuttavia, argomenta Hegel con una penetrante analisi dialettica, la dinamica
del rapporto servo-signore (che corrisponde al tipo di società del mondo
antico) è destinata a mettere capo ad una paradossale inversione di ruoli,
ossia ad una situazione per cui il signore diviene servo del servo e il
servo signore del signore. Infatti, il signore, che inizialmente appariva
indipendente, nella misura in cui si limita a godere passivamente del
lavoro altrui, finisce per rendersi dipendente dal servo. Invece
quest'ultimo, che inizialmente appariva dipendente, nella misura in cui
pradroneggia e trasforma le cose da cui il signore riceve il proprio
sostentamento, finisce per rendersi indipendente: «Come la signoria
mostrava che la propria essenza è l'inverso di ciò che vuol essere
(cioè si mostrava dipendente), così anche la servitù nel proprio compimento
diventerà piuttosto il contrario di quel ch'essa è immediatamente... e si
volgerà nell'indipendenza vera» (pagina 161).
I momenti della progressiva acquisizione di indipendenza del servo.
Più in particolare, questo processo di progressiva acquisizione di
indipendenza da parte del servo avviene attraverso i tre momenti della
paura della morte, del servizio e del lavoro. Infatti, lo schiavo è tale
perché ha «tremato» dinanzi alla morte. Ma proprio in virtù di siffatta
paura, che non è paura di questo o di quello, ma della perdita assoluta
della propria essenza, lo schiavo ha potuto sperimentare il proprio essere
come qualcosa di distinto o di indipendente da quel mondo di realtà e di
certezze naturali che prima gli apparivano come qualcosa di «fisso» e con
le quali, in qualche modo, si identificava. Ecco la maniera con cui Hegel
descrive il «fluidificarsi» della realtà per mezzo dell'angoscia della
morte e la correlativa conquista da parte dell'individuo, della propria
auto-coscienza:
«Tale coscienza non è stata in ansia (hat Angst gehabt, a éprouvé
l'angoisse, come suona la traduzione francese) per questa o quella cosa
e neppure durante questo o quell'istante, bensì per l'intiera sua essenza;
essa ha infatti sentito paura della morte, signora assoluta. è stata,
così, intimamente dissolta, ha tremato nel profondo di sé, e ciò che in
essa v'era di fisso ha vacillato. Ma tale puro e universale movimento,
tale assoluto fluidificarsi di ogni momento sussistente, è l'essenza
semplice dell'autocoscienza, è l'assoluta negatività, il puro
esser-per-sé che, dunque, è in quella coscienza» (pagina 162).
N.B. Per capire il significato del termine «negatività»; si tenga presente
che esso serve a definire l'autocoscienza o il «per sé», la quale è
negatività in quanto, per affermare se stessa e la propria interiorità,
tende a negare l'esteriorità degli oggetti.
Il valore «formativo» del lavoro.
Nel servizio in generale la coscienza si autodisciplina e impara a vincere,
in tutti i singoli momenti, i suoi impulsi naturali. Infine, nel lavoro,
il servo, trattenendo il proprio appetito e non usufruendo dell'oggetto,
imprime nelle cose una forma, dando luogo ad un'opera che permane e che ha
una sua indipendenza o autonomia, la quale rappresenta il riflesso, nelle
cose, della raggiunta indipendenza o autonomia del servo rispetto agli
oggetti. In altre parole, «formando e coltivando (bilden) le cose, il servo
non solo forma e coltiva se stesso ma ancora imprime nell'essere quella
forma che è dell'autocoscienza, e così trova se stesso nella propria
opera» (J. Hyppolite, opera citata, pagina 214). In tal modo, egli
giunge ad intuirsi come essere-indipendente. Detto nei termini non
facili di Hegel:
«Il lavoro... è un appetito tenuto a freno, è un dileguare trattenuto;
ovvero: il lavoro forma. Il rapporto negativo verso l'oggetto diventa
forma dell'oggetto stesso, diventa qualcosa che permane e ciò perché
proprio a chi lavora l'oggetto ha indipendenza. Tale medio negativo o
l'operare formativo costituiscono in pari tempo la singolarità o il puro
essere-per-sé della coscienza che ora, nel lavoro, esce fuori di sé
nell'elemento del permanere; così, quindi, la coscienza che lavora giunge
all'intuizione dell'essere indipendente come di se stessa» (pagine 162-163).
Letture marxiste ed esistenzialiste.
La figura hegeliana del servo-signore, che è senz'altro « tra le cose più
belle della Fenomenologia» (N. Hartmann), presenta una
notevole ricchezza tematica, che è stata apprezzata soprattutto dai
marxisti, i quali hanno visto in essa un'intuizione sia pure ancora a
livello «speculativo» dell'importanza del lavoro e della configurazione
dialettica della storia, nella quale, grazie all'esperienza della
sottomissione, si generano le condizioni per la liberazione. Ciò non
significa (e sono i marxisti stessi a rilevarlo) che si possa leggere
Hegel pensando di fatto a Marx. Infatti, la figura hegeliana non si
conclude con una rivoluzione sociale o politica, ma con la coscienza
dell'indipendenza del servo nei confronti delle cose e della dipendenza
del signore nei confronti del lavoro servile. La figura in questione
contiene anche taluni spunti di tipo esistenzialistico: ad esempio il
raggiungimento della consapevolezza di sé tramite l'angoscia della morte
(Heidegger) o il rapporto originariamente conflittuale che lega le
coscienze fra di loro (Sartre).
b) Stoicismo e scetticismo.
L'«astratta» libertà stoica.
Il raggiungimento dell'indipendenza dell'io nei confronti delle cose, che
è il risultato della dialettica fra servo e signore, trova la sua
manifestazione filosofica nello stoicismo, ossia in un tipo di visione
del mondo che celebra l'autosuffficienza e la libertà del saggio nei
confronti di ciò che lo circonda. Ma nello stoicismo, l'autocoscienza, la
quale pretende di svincolarsi dai condizionamenti della realtà
(passioni, affetti, ricchezze eccetera), ritenendo di essere libera «sul
trono o in catene», raggiunge soltanto una «astratta» libertà interiore,
giacché quei condizionamenti permangono e la realtà esterna non è
affatto negata. Chi pretende di mettere completamente tra parentesi quel
mondo esterno da cui lo stoico si sente indipendente (e che lascia
invece sussistere) è lo scetticismo, ossia un tipo di visione del mondo
che sospende l'assenso su tutto ciò che è comunemente ritenuto per vero e
reale (di conseguenza, lo scetticismo è per sé, ossia in modo
consapevole, ciò che lo stoicismo è in sé, ossia in modo inconsapevole;
esattamente come lo stoicismo è per sé ciò che la servitù è in sé).
Autocontradditorietà dello scetticismo.
Tuttavia, in virtù del suo esasperato «atteggiamento negativo verso
l'alterità», lo scetticismo dà luogo ad una situazione contraddittoria ed
insostenibile, che si manifesta nella scissione fra una coscienza che
vorrebbe innalzarsi sull'accidentalità e non-verità della vita ed una
coscienza che si scopre vittima, essa stessa, della inessenzialità e
non-verità della vita: «profferisce l'assoluto dileguare; ma il profferire
è... profferisce la nullità del vedere, dell'udire eccetera, ed è proprio
lei che vede, ode eccetera; profferisce la nullità delle essenze etiche,
e ne fa le potenze del suo agire. Il suo operare e le sue parole si
contraddicono sempre... » (pagina 173). In altri termini, Hegel non fa che
usare, contro lo scetticismo, l'argomento tradizionale: quello secondo
cui lo scettico si autocontraddice poiché da un lato dichiara che tutto
è vano e non-vero, mentre dall'altro pretende di dire qualcosa di reale e
di vero. Paradosso tanto più grave se si pensa che la coscienza di cui
parla lo scettico è una coscienza singola, la quale non può fare a meno
di entrare in urto con altre coscienze singole: «In effetti il suo
chiacchierare è un litigio da ragazzi testardi, dei quali luno dice A
quando l'altro dice B, per dir B quando l'altro dice A; e così ciascuno,
restando in contraddizione con se stesso, si paga la soddisfazione di
restare in contraddizione con gli altri» (ivi).
c) Le coscienza infelice.
La scissione, presente nello scetticismo, fra una coscienza immutabile
ed una mutevole diviene esplicita (o «per sé») nella figura della
coscienza infelice ed assume la forma di una separazione radicale fra
l'uomo e Dio. Tale separazione si manifesta dapprima sotto forma di
un'antitesi fra «l'intrasmutabile» e il «trasmutabile».
L'ebraismo.
è questa la situazione propria dell'ebraismo, nel quale l'essenza,
l'Assoluto, la realtà vera è sentita come lontana dalla coscienza ed
assume le sembianze di un Dio trascendente padrone assoluto della vita
e della morte, ovvero di un Signore inaccessibile di fronte a cui l'uomo
si trova in uno stato di dipendenza (come si può notare, la coscienza
infelice ebraica rappresenta la traduzione, in chiave religiosa, della
situazione sociale espressa dal rapporto servo-signore).
Il cristianesimo.
Nel secondo momento l'intrasmutabile assume la figura di un Dio
incarnato. è questa la situazione propria del cristianesimo medioevale, il
quale, anziché considerare Dio come un Padre o un Giudice lontano, lo
prospetta sotto forma di una realtà «effettuale». Tuttavia, la pretesa
di cogliere l'Assoluto in una presenza particolare e sensibile è
destinata al fallimento. Fallimento di cui sono un simbolo eloquente le
Crociate, nelle quali l'inquieta ricerca di Dio si conclude con la
scoperta di un sepolcro vuoto. Inoltre Cristo, di fronte alla coscienza,
continua a rimanere qualcosa di diverso e di separato. Tanto più che
egli, come Dio trascendente, esprime pur sempre «il momento dell'aldilà»
(pagina 178) e, come Dio incarnato, vissuto in uno specifico ed irripetibile
periodo storico, risulta pur sempre, per i posteri, inevitabilmente
lontano: «accade necessariamente ch'esso sia dileguato nel tempo e nello
spazio, e che sia stato lungi e senz'altro lungi rimanga» (ivi). Di
conseguenza, con il cristianesimo, la coscienza continua ad essere
«infelice» e Dio continua a configurarsi come un «irraggiungibile al di
là che sfugge», anzi, che è «già sfuggito nell'atto in cui si tenta
d'affermarlo» (pagina 180).
La devozione.
Manifestazioni di questa infelicità cristiano-medioevale sono le
sottofigure della devozione, del fare e della mortificazione di se. La
devozione è quel pensiero a sfondo sentimentale e religioso che non si è
ancora elevato al concetto (e quindi alla coscienza speculativa
dell'unità tra finito e infinito). In altri termini, come scrive Hegel
con una sorta di prosa poetica volta a ricreare certa «atmosfera»
medioevale dalle tinte romantiche, il pensare della devozione « resta un
vago brusio di campane o una calda nebulosità, un pensare musicale che
non arriva al concetto...» (ivi).
Il fare e l'operare.
Il fare o l'operare della coscienza pia è il momento in cui la
coscienza, rinunciando ad un contatto immediato con Dio,
cerca di esprimersi nell'appetito e nel lavoro. Tuttavia la
coscienza cristiana non può fare a meno di avvertire il frutto del
proprio lavoro come un dono di Dio. Anzi, essa avverte come dono di Dio
anche le proprie forze e le proprie capacità, che le sembrano concesse
dall'alto «affinché ne faccia uso». In tal modo essa si umilia e
riconosce che chi agisce è soltanto Dio.
La mortificazione di sé.
Tale vicenda prosegue e si esaspera con la mortificazione di sé, in cui
si ha la più completa negazione dell'io a favore di Dio. Infatti, con
l'ascetismo e le sue pratiche di umiliazione della carne, ci troviamo di
fronte ad una personalità tanto misera quanto infelice e «limitata a sé
e al suo fare meschino», ovvero come aggiunge caratteristicamente Hegel,
ad una personalità «che non riesce se non a covare se stessa» (pagina 186).
Ma il punto più basso toccato dal singolo (il quale cerca un estremo punto
di contatto fra sé e l'immutabile nella figura mediatrice della Chiesa) è
destinato a trapassare dialetticamente nel punto più alto allorquando
la coscienza, nel suo vano sforzo di unificarsi con Dio, si rende conto
di essere, lei stessa, Dio, ovvero l'Universale o il Soggetto assoluto
(pagina 193). Ciò non avviene nel Medioevo, ma nel Rinascimento e nell'età
moderna. Anche la figura della coscienza infelice ha avuto una notevole
fortuna. Tant'è vero che talora, come si è già accennato, si è visto in
essa non una semplice figura, ma la chiave di volta di tutta la
Fenomenologia.
8.3. Ragione.
Come Soggetto assoluto l'autocoscienza è diventata Ragione ed ha assunto
in sé ogni realtà. Mentre nei momenti anteriori la realtà del mondo le
appariva come alcunché di diverso e di opposto (come la negazione di
sé), ora invece può sopportarla: perché sa che nessuna realtà è niente
di diverso da essa. « La ragione, dice Hegel, è la certezza di essere
ogni realtà».
La ragione osservativa...
Questa certezza tuttavia per divenire verità deve giustificarsi; e il
primo tentativo di giustificarsi è «un inquieto cercare», che si rivolge
da principio al mondo della natura. è questa la fase del naturalismo del
Rinascimento e dell'empirismo. Qui la coscienza crede, bensì, di cercare
l'essenza delle cose, ma in realtà non cerca che se stessa; e quella
credenza deriva dal non aver fatto ancora della ragione l'oggetto della
propria ricerca. Si determina così l'osservazione della natura che,
partendo dalla semplice descrizione, si approfondisce con la ricerca
della legge e con l'esperimento; e che si trasferisce poi nel dominio
del mondo organico, per passare infine a quello stesso della coscienza
con la psicologia. Hegel esamina lungamente a questo proposito
due sedicenti scienze che erano di moda ai suoi tempi: la fisiognomica
di J. K. Lavater (1741-1801) che aveva la pretesa di determinare il
carattere dell'individuo attraverso i tratti della sua fisionomia e
la frenologia di F. J. Gall (1758-1828) che pretendeva di conoscere il
carattere dalla forma e dalle protuberanze del cranio. In tutte queste
ricerche, la ragione, pur cercando apparentemente altra cosa, cerca in
realtà se stessa: cerca di riconoscersi nella realtà oggettiva che le
sta dinanzi.
...e la sua crisi.
Ma in questa ricerca esasperata di sé che, nella frenologia, arriva al
punto di proclamare che «l'essere dello spirito è un osso» (pagina 287),
la ragione osservativa sperimenta, alla fine, la propria crisi,
riconoscendosi di nuovo come qualcosa di distinto dal mondo.
La ragione attiva...
Ma a questo punto si passa a ciò che Hegel chiama «l'attuazione
dell'autocoscienza razionale mediante se stessa», ossia ad una ragione
attiva, in virtù della quale « non più la coscienza si vuole immediatamente
trovare, anzi vuole produrre se stessa mediante la sua attività»
(pagina 289). In altri termini, dalla ragione osservativa si passa a
quella attiva, allorquando ci si rende conto che l'unità di io e mondo
non è qualcosa di dato e di contemplabile, ma qualcosa che deve venir
realizzato.
...e il suo scacco.
Tuttavia tale progetto, finché assume la forma di uno sforzo individuale,
cioè di un'iniziativa scaturiente dalla singola coscienza, è destinato
anch'esso a fallire - come testimoniano le tre figure della ragione attiva.
Il piacere e la necessità.
La prima, che Hegel denomina «Il piacere e la necessità», è quella in cui
l'individuo, faustianamente deluso dalla scienza e dalla ricerca
naturalistica, si getta nella vita e va alla ricerca del proprio
godimento: « Le ombre della scienza, delle leggi, dei princìpi (...)
scompaiono come inerte nebbia (...) l'autocoscienza prende la vita a quel
modo che vien colto un frutto maturo...» (pagina 302). Ma nella ricerca
del piacere l'autocoscienza incontra la necessità del destino, che,
incurante delle sue personali esigenze di felicità, lo travolge
inesorabilmente. «Egli prendeva la vita, ma con ciò afferrava piuttosto
la morte», scrive Hegel (pagina 305), evidenziando il limite e la
finitudine dell'individuo.
La legge del cuore e il delirio della presunzione.
L'autocoscienza cerca allora di opporsi al corso ostile del mondo
appellandosi alla «legge del cuore» (qui il filosofo allude probabilmente
al filone sentimentalistico che va da Rousseau ai romantici). Nasce in
tal modo la seconda figura della ragione attiva, che Hegel denomina
«la legge del cuore e il delirio della presunzione», nella quale
l'individuo, dopo aver cercato di individuare e di abbattere i
responsabili dei mali nel mondo («preti fanatici, despoti corrotti»),
entra in conflitto con altri presunti portatori del vero progetto di
miglioramento della realtà: «La coscienza che propone la legge del suo
cuore avverte dunque la resistenza da parte di altri, perché essa
contraddice alle leggi altrettanto singole del cuore loro...» (pagina 315).
La virtù e il corso del mondo.
Ai vari fanatismi di parte, l'individuo contrappone allora la virtù,
ossia un agire in grado di procedere oltre l'immediatezza del sentimento
e delle inclinazioni soggettive. Nasce in tal modo la terza figura della
ragione attiva, che Hegel denomina « La virtù e il corso del mondo ». Ma
il contrasto tra la virtù, che è il bene astrattamente vagheggiato
dall'individuo nella sua speranza di « riinvertire l'invertito corso del
mondo» (pagina 318) e la concreta realtà non può che concludersi con la
sconfitta del «cavaliere della virtù» e dei suoi donchisciotteschi
propositi di moralizzazione dell'esistente (vedi Robespierre).
L'individualità in sé e per sé reale.
Alle sezioni della ragione osservativa e della ragione attiva Hegel fa
seguire una terza sezione, che denomina «L'individualità che è a se
stessa reale in se stessa e per se stessa». In essa egli mostra come
l'individualità, pur potendo raggiungere la propria realizzazione,
rimane, in quanto tale, astratta e inadeguata.
Il regno animale dello spirito.
La prima figura è quella che Hegel denomina « il regno animale dello
spirito e l'inganno, o la cosa stessa». Con questa formula, Hegel intende
dire che agli sforzi e alle ambizioni universalistiche della virtù
succede l'atteggiamento della "onesta" dedizione ai propri compiti
particolari (familiari, professionali eccetera). Ora, alla base di questo
regno animale dello spirito - animale perché la vita dello spirito viene
completamente risolta nella cura dei propri compiti o affari - vi è un
"inganno", in quanto l'individuo tende a spacciare la sua opera come "la
cosa stessa", cioè come il dovere morale stesso, mentre essa esprime
soltanto il proprio interesse (tant'è vero che Lukács ha visto, in questa
figura, la traduzione filosofica della mentalità "borghese").
La ragione legislatrice.
La seconda figura è quella della «ragione legislatrice». Infatti
l'autocoscienza, avvertendo l'"inganno" di cui si è detto, cerca in se
stessa delle leggi che valgano per tutti. Tuttavia, tali leggi universali,
in virtù della loro origine individuale, si rivelano autocontraddittorie.
Ad esempio, la massima secondo cui «ognuno ha il dovere di dire la verità»
non tiene presente, osserva Hegel, che la verità, per l'individuo, si
traduce nella «cognizione e persuasione ch'egli a volta a volta ne ha »
(pagina 350), in modo tale che « l'universalmente necessario, il valevole
in sé, che la proposizione voleva esprimere, si è piuttosto invertito in
una completa accidentalità» (ivi).
La ragione esaminatrice delle leggi.
Tali contraddizioni spingono l'autocoscienza a farsi «ragione esaminatrice
delle leggi», cioè a cercare delle leggi assolutamente valide. Tuttavia,
nella misura in cui sottomette (razionalisticamente e illuministicamente)
le leggi al proprio esame, essa appare costretta a porsi al di sopra delle
leggi e quindi a ridurne, simultaneamente, l'intrinseca validità e
incondizionatezza: « Se chiedo del loro nascimento e le limito al punto
della loro origine, io son già oltre di loro; ché io sono ormai
l'universale, ma esse il condizionato e limitato. Se debbono legittimarsi
al mio sguardo, io ho già smosso il loro incrollabile esser-per-sé e le
considero come qualcosa che per me forse è vero, forse non vero»
(pagina 360).
Dall'individuo allo spirito, inteso come «sostanza etica» entro la quale
soltanto l'individuo trova concretezza e realtà.
Con tutte queste figure Hegel intende quindi farci capire che se ci si
pone dal punto di vista dell'individuo si è inevitabilmente condannati a
non raggiungere mai l'universalità. Quest'ultima si trova soltanto nella
fase dello «spirito», ovvero di ciò che Hegel nella fase sistematica del
suo pensiero, denominerà « spirito oggettivo» ed « eticità »,
intendendo, con queste espressioni, la ragione che si è realizzata
concretamente nelle istituzioni storico-politiche di un popolo e
soprattutto dello Stato «l'intelligente ed essenziale far del bene è
(...) l'intelligente, universale operare dello Stato, - operare al cui
paragone l'operare del singolo come singolo diviene qualcosa di così
meschino che non val quasi la pena di parlarne» (pagina 352). Tant'è che le
leggi etiche più indubitabili («dire la verità», «amare il prossimo»)
risultano pure astrazioni se manca lo Stato a determinarne il contenuto.
In altri termini, la ragione «reale» non è quella dell'individuo, ma
quella dello spirito o dello Stato, che per Hegel sono « sostanza »
proprio nel senso etimologico di sub-stantia, cioè di « sostrato che
regge e rende possibile ogni atto della vita individuale» (G. Vattimo).
Infatti, proclamare che noi siamo sempre «dentro la sostanza etica»
(pagina 361), equivale a sostenere che l'individuo risulta fondato
dalla realtà storico-sociale e non viceversa. Ma con la nozione di
«spirito» siamo già in un momento ulteriore della Fenomenologia.
Tuttavia, prima di procedere, è bene offrire uno schema riepilogativo
delle figure esaminate sinora:
1) Coscienza:
La certezza sensibile;
La percezione;
L'intelletto.
2) Autocoscienza:
a) Indipendenza e dipendenza dall'autocoscienza: signoria e servitù;
b) Liberazione dell'autocoscienza: stoicismo, scetticismo e la coscienza
infelice;
3) Ragione
a) ragione osservativa:
1) osservazione della natura;
2) osservazione dell'autocoscienza nella sua purezza e nel suo rapporto con
l'effettualità esterna: leggi logiche e psicologiche;
3) osservazione del rapporto dell'autocoscienza con la sua effettualità
immediata (fisiognomica e frenologia).
b) attuazione dell'autocoscienza razionale mediante se stessa (ragione
attiva):
1) il piacere e la necessità;
2) la legge del cuore e il delirio della presunzione;
3) la virtù e il corso del mondo.
c) L'individualità in sé e per sé:
1) il regno animale dello spirito;
2) la ragione legislatrice;
3) la ragione esaminatrice delle leggi.
8.4. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto.
La seconda parte della Fenomenologia comprende tre sezioni (lo spirito,
la religione e il sapere assoluto), che anticipano il contenuto della
filosofia dello spirito e, per certi aspetti, della filosofia della storia.
Hegel stesso, in una redazione più concisa del processo fenomenologico,
contenuta nell'Enciclopedia, ha eliminato tale parte. Per queste ragioni,
ci limiteremo ad accennare sinteticamente alle tematiche che riteniamo più
importanti.
Lo «spirito».
Come si è visto, per «spirito», Hegel intende l'individuo nei suoi
rapporti con la comunità sociale di cui è parte. La sezione dello spirito
comprende tre tappe fenomenologiche:
a) «lo spirito vero; l'eticità»;
b) «lo spirito che si è reso estraneo a sé; la cultura»;
c) «lo spirito certo di se stesso; la moralità».
Il primo momento corrisponde alla fase dell'eticità classica, ossia
alla polis greca, in cui abbiamo una fusione armonica fra l'individuo e
la comunità, in quanto il singolo appare profondamente immerso nella vita
del proprio popolo. Il secondo momento corrisponde alla fase della frattura
fra l'io e la società, ossia ad una situazione di scissione e di
«alienazione», che, già iniziata nel mondo antico e con l'Impero romano,
trova il proprio culmine nel mondo moderno. In quest'ultimo troviamo
infatti un tipo di «cultura» corrosiva che, con l'Illuminismo, tende a
criticare e a distruggere tutto, rivolgendosi, alla fine, contro se
medesima. Manifestazione politica di questa vicenda intellettuale è la
Rivoluzione francese, che volendo instaurare il regno della libertà, ha
invece dato origine ad una società del Terrore, dove gli stessi esponenti
della Rivoluzione finiscono per ghigliottinarsi a vicenda. Il terzo momento
è quello di una riconquistata eticità ed armonia fra individuo e comunità,
in cui lo Spirito, dopo aver attraversato le figure ancora imperfette
della «moralità astratta», dell'«anima bella romantica» (che non vuole
«sporcarsi nella realtà) e della filosofia della fede, si riconosce nella
sostanza etica dello Stato. Infine con la religione, e soprattutto con la
fiosofia, l'individuo acquista la piena, totale ed esplicita coscienza di
sé come Spirito.
A questo punto, dopo aver trovato la «pace» nello Stato e la «verità» nella
filosofia idealistica (di Hegel), le romanzesche vicende dell'autocoscienza
sono concluse ed il ciclo della Fenomenologia appare esaurito.
9. La logica.
L'oggetto della logica.
In quanto «scienza dell'idea pura, cioè dell'Idea nell'elemento astratto del
pensiero» (Enc., paragrafo 19), la logica - alla quale Hegel ha dedicato la
seconda delle sue opere fondamentali, la Scienza della logica (1812-1816),
che ha poi ricapitolato nella prima parte della Enciclopedia - prende in
considerazione la struttura programmatica o l'impalcatura originaria del
mondo. Tale impalcatura si specifica in un organismo dinamico di «concetti»
o di «categorie» (Hegel usa preferibilmente il primo termine) i quali, in
virtù della posta equazione fra pensiero ed essere, costituiscono
altrettante determinazioni della realtà. In altre parole, i «concetti»
di cui tratta la logica di Hegel non sono pensieri soggettivi, ai quali la
realtà rimanga esterna e contrapposta, ma pensieri oggettivi, che esprimono
la realtà stessa nella sua essenza.
La concezione hegeliana delle categorie.
Come si può notare, la dottrina hegeliana delle categorie risulta
profondamente diversa da quella di Kant. Infatti, mentre per quest'ultimo
le categorie sono funzioni mentali che valgono soltanto in riferimento
al fenomeno, per Hegel le categorie sono, al tempo stesso, determinazioni
del pensiero e della realtà in sé.
Le varie posizioni del pensiero rispetto all'oggettività.
Allo scopo di evidenziare meglio il suo modo di intendere il rapporto
pensiero-essere, concetto-realtà, Hegel, nell'Enciclopedia, fa una rassegna
delle principali posizioni del pensiero logico rispetto all'oggettività. La
prima posizione è data dal procedere ingenuo, il quale ritiene che da una
parte vi sia il pensiero e dallaltra le cose e che il pensiero, mediante la
riflessione, possa conoscere « ciò che gli oggetti veramente sono»
(Enc., paragrafo 26). è questa la posizione della «vecchia metafisica
dogmatica», la quale considerava «le determinazioni del
pensiero come le determinazioni fondamentali delle cose» (Enc.,
paragrafo 28).
La seconda posizione è quella dell'empirismo, il quale, elevando il
contenuto della percezione a rappresentazione, fa di quest'ultima la
norma e la misura dell'oggettività, riducendo tuttavia la realtà vera
delle cose ad una x impenetrabile dal pensiero, il quale risulta quindi
costretto a cadere nello scetticismo. Di questa vicenda risulta
documento emblematico il kantismo (che costituisce uno svolgimento più
profondo dell'empirismo) il quale, dopo aver fatto dell'io penso il
legislatore della natura, lascia sussistere, sullo sfondo, il mistero
della cosa in sé. La terza posizione è quella della filosofia della
fede, a cui Hegel riconosce il pregio di porre l'esigenza di «saltare»
(contro ogni scetticismo) dal pensiero all'essere, ma il demerito di
ritenere che ciò sia possibile mediante il sentimento o la fede. In
realtà, osserva ironicamente Hegel altrove, il «salto mortale» di Jacobi
è letale solo per la filosofia. In alternativa a queste posizioni, Hegel
fa valere l'esigenza di un pensiero che non sia astrattamente separato
dalle cose, ma si identifichi con l'essenza stessa del reale e sia
oggetto di un sapere razionale e speculativo.
Identità fra logica e metafisica.
Da quanto si è detto sinora, risulta evidente come la logica (= lo
studio del pensiero) e la metafisica (= lo studio dell'essere) siano per
Hegel la stessa cosa. Tant'è vero che nella Logica di Hegel confluisce
non solo gran parte della tradizione logica greca e moderna, ma anche
gran parte del pensiero metafisico e teologico dell'Occidente (il
filosofo tedesco, pur contestando gli aspetti dogmatici e
intellettualistici della metafisica, ha un alto concetto di essa, sino
ad arrivare a sostenere, anti-kantianamente, che «un popolo senza
metafisica è come un tempio senza altare»). In concreto, la logica
hegeliana - che si divide in logica dell'essere, dell'essenza e del
concetto - procede mostrando come, partendo dai concetti più poveri ed
astratti (essere, nulla e divenire) si giunga, sotto l'assillo di una
ragione dialettica che ne svela la parzialità e l'inevitabile trapassare
in altre categorie, ai concetti più ricchi e concreti (sino a quel Concetto
di tutti i concetti o Categoria di tutte le categorie che è l'Idea).
Essere, nulla e divenire.
Il punto di partenza della logica è il concetto più vuoto ed astratto,
quello dell'essere, dell'essere assolutamente indeterminato, privo di ogni
possibile contenuto. In questa astrazione, l'essere è identico al nulla;
e il concetto di questa identità, cioè dell'unità dell'essere e del nulla,
è il divenire, che già gli antichi definivano come passaggio dal nulla
all'essere.
Qualità, quantità e misura.
L'essere e il nulla, come pura astrazione, sono l'opposto dell'essere
determinato, che proprio da tale opposizione viene richiamato e posto in
luce; e l'essere determinato è tale in virtù della qualità che lo
specifica e lo rende finito, della quantità e infine della misura, la
quale determina la quantità della qualità. Tutte queste categorie
considerano l'essere nel suo isolamento, cioè fuori di ogni relazione.
Dall'essere si passa all'essenza quando l'essere, riflettendo su se stesso,
scorge le proprie relazioni; si riconosce cioè identico e diverso e
scopre la propria ragion sufficiente.
Le categorie dell'essenza.
Le categorie fondamentali dell'essenza sono: l'essenza come ragione
dell'esistenza, il fenomeno e la realtà in atto. Riconoscendosi identica
a se stessa e diversa dalle altre essenze, l'essenza scopre la propria
ragion d'essere; e in virtù di questa ragion d'essere diventa esistenza.
L'apparizione della sua esistenza è il fenomeno, che è, secondo Hegel, non
mera parvenza, ma la manifestazione adeguata e piena dell'essenza di ciò
che esiste. Ciò che esiste, la realtà in atto, è quindi l'unità
dell'essenza e dell'esistenza cioè dell'interno e dell'esterno. Le tre
relazioni che la caratterizzano sono la sostanzialità, la causalità e
l'azione reciproca (le categorie kantiane della relazione).
La dottrina del concetto.
Così determinato e arricchito dalla riflessione su di sé, l'essere
diventa concetto: che non è più il concetto dell'intelletto, diverso
dalla realtà e opposto ad esso, ma il concetto della ragione, cioè
«lo spirito vivente della realtà. Il concetto è in primo luogo concetto
soggettivo o puramente formale; poi concetto oggettivo quale si manifesta
negli aspetti fondamentali della natura; infine è Idea, unità dell'oggettivo
e del soggettivo, ragione autocosciente. Il concetto soggettivo si determina
dapprima nei suoi tre aspetti di universalità, particolarità, individualità;
poi si esprime ed articola nel giudizio e infine si organizza nel
sillogismo il quale esprime, da un punto di vista formale, la razionalità
del tutto. Ogni cosa è sillogismo perché ogni cosa è razionale; ma di
questa razionalità il sillogismo esprime solo l'aspetto formale e
soggettivo, che si concreta e si attua solo passando nel concetto
oggettivo. Il concetto come oggettività costituisce le categorie
fondamentali della natura: meccanismo, chimismo e teleologia, la quale
ultima è la categoria fondamentale della natura organica.
L'Idea.
L'ultima categoria della logica è l'Idea. « L'idea, dice Hegel, può
essere concepita come la ragione (questo è il proprio significato
filosofico di ragione); inoltre come il soggetto-oggetto, come l'unità
dell'ideale e del reale, del finito e dell'infinito, dell'anima e del
corpo.» L'idea è così la totalità della realtà in tutta la ricchezza delle
sue determinazioni e relazioni interiori. Nella sua forma immediata
l'idea è la vita, cioè un'anima realizzata in un corpo; ma nella sua forma
mediata, e tuttavia finita, è il conoscere; nel quale il soggettivo e
l'oggettivo appaiono distinti (giacché il conoscere si riferisce sempre a
questa realtà diversa da sé) tuttavia uniti (giacché esso si riferisce
sempre a questa realtà). Il contrasto tra il soggettivo e l'oggettivo
costituisce appunto la finalità del conoscere; che può assumere o la
forma teoretica, nella quale la spinta è data dalla verità, o la forma
pratica (il volere) in cui la spinta è data dal bene. Al di là della
vita e del conoscere e come loro unità, c'è l'Idea assoluta, cioè l'idea
che si riconosce nel sistema totale della logicità. Essa è l'identità
dell'idea teoretica e dell'idea pratica ed è vita che ha però superato
ogni immediatezza ed ogni finitudine. «Tutto il resto è errore, torbidezza,
opinione, sforzo, arbitrio e caducità». In altri termini, l'Idea nella
sua forma assoluta non è altro che la logica stessa di Hegel nella
totalità e nell'unità delle sue determinazioni. Ecco uno schema
riepilogativo:
1) Dottrina dell'essere:
a) Qualità;
b) Quantità;
c) Misura.
2) Dottrina dell'essenza:
a) Essenza come ragione dell'esistenza;
b) Fenomeno;
c) Realtà in atto.
3) Dottrina del concetto:
a) Il concetto soggettivo: 1) Il concetto come tale; 2) il giudizio; 3) Il
sillogismo.
b) L'oggetto: 1) il meccanismo; 2) il chimismo; 3) teleologia.
c) L'Idea: 1) la vita; 2) il conoscere; 3)l'idea assoluta.
10. La filosofia della natura.
Il testo fondamentale della filosofia della natura di Hegel è la seconda
parte dell'Enciclopedia che, come le altre parti, fu arricchita
nell'edizione delle opere curata dai suoi immediati scolari da numerose
aggiunte tratte dalle lezioni di Hegel. Un primo abbozzo di questa
filosofia della natura è la brevissima esposizione (7 pagine circa) del
Corso propedeutico (1808-1811) che Hegel scrisse per gli studenti del
ginnasio di Norimberga.
Filosofia e fisica empirica.
Hegel ammette che la filosofia della natura abbia per presupposto e
condizione la fisica empirica; ma questa deve limitarsi a fornirle il
materiale e a fare il lavoro preparatorio, di cui essa poi si avvale
liberamente per mostrare la necessità con la quale le determinazioni
naturali si concatenano in un organismo concettuale. Per loro conto, i
risultati dellindagine empirica non fanno testo.
La natura come «esteriorità» spazio-temporale dell'idea.
Secondo Hegel, che da un certo punto di vista si ispira più a Fichte che
a Schelling, la natura è «l'idea nella forma dell'essere altro» e come tale
è essenzialmente esteriorità. Considerata in sé, cioè nell'idea, è divina;
ma nel modo in cui essa è, il suo essere non corrisponde al concetto:
essa è quindi la contraddizione insoluta. Il suo carattere proprio è di
essere negazione, non ens. Essa è la decadenza dell'idea da se stessa,
perché l'idea nella forma dell'esteriorità è inadeguata a se stessa. Tant'è
vero che Hegel parla di una «impotenza della natura», che pone dei
limiti anche al discorso filosofico su di essa.
Il problema del «passaggio» dall'Idea alla Natura.
Il «passaggio » dall'Idea alla Natura costituisce comunque, nell'ambito
dell'hegelismo, un autentico rompicapo critico, poiché da un lato il
filosofo presenta tale passaggio come una sorta di «caduta» dell'Idea e
dall'altro come una sorta di suo «potenziamento». In altre parole, sembra
che nella natura ci sia qualcosa di meno, oppure di più dell'Idea; che
cosa precisamente, e come possa trovarcisi, non è affatto chiaro. Una
cosa è invece certa: ossia che per Hegel risulta assurdo voler conoscere
Dio dalle opere naturali, in quanto le più basse manifestazioni dello
Spirito servono meglio allo scopo.
La Natura come «pattumiera» del sistema.
Il concetto della natura ha tuttavia nella dottrina di Hegel una
funzione-chiave e non potrebbe essere eliminato o tolto senza eliminare o
togliere l'intera dottrina. Il principio stesso dell'identità di realtà e
ragione pone infatti a questa dottrina l'obbligo di giustificare e
risolvere nella ragione tutti gli aspetti della realtà. Hegel respinge
fuori della realtà, quindi nell'apparenza, ciò che è finito, accidentale
e contingente, legato al tempo e allo spazio, e la stessa individualità
in ciò che ha di proprio e di irriducibile alla ragione. Ma tutto ciò
deve pur trovare un qualche posto, una qualche giustificazione, sia pure
a mero titolo di apparenza, se, almeno come apparenza, è reale; e trova
posto e giustificazione appunto nella natura, che da questo punto di
vista si configura come una sorta di «pattumiera» del sistema.
Divisioni della filosofia della Natura.
Le divisioni fondamentali della filosofia della natura sono: la
meccanica, la fisica e la fisica organica. La meccanica considera
l'esteriorità che è l'essenza propria della natura, o nella sua astrazione
(spazio e tempo), o nel suo isolamento (materia e movimento), o nella
sua libertà di movimento (meccanica assoluta).
La seconda grande divisione della filosofia della natura, la fisica,
comprende la fisica dell'individualità universale, cioè degli elementi
della materia, la fisica dell'individualità particolare, cioè delle
proprietà fondamentali della materia (peso specifico, coesione, suono,
calore) e la fisica dell'individualità totale, cioè delle proprietà
magnetiche, elettriche e chimiche della materia.
La terza divisione, fisica organica, comprende la natura geologica, la
natura vegetale e l'organismo animale.
11. La filosofia dello Spirito.
La filosofia dello Spirito, che Hegel definisce la conoscenza «più alta
e difficile» (Enc., paragrafo 377), è lo studio dell'Idea che, dopo essersi
estraniata da sé, sparisce come natura, cioè come esteriorità e
spazialità, per farsi soggettività e libertà, ovvero auto-creazione ed
auto-produzione.
I momenti dello Spirito.
Lo sviluppo dello Spirito avviene attraverso tre momenti principali:
lo spirito soggettivo (che è lo spirito individuale nell'insieme delle
sue facoltà), lo spirito oggettivo (che è lo spirito sovra-individuale
o sociale), lo spirito assoluto (che è lo spirito il quale sa e conosce
se stesso nelle forme dell'arte, della religione e della filosofia).
Nello Spirito ogni grado è compreso e risolto in quello superiore.
Anche lo spirito, osserva Hegel, procede per gradi, ma diversamente da
quanto accade nella Natura, nella quale i gradi sussistono l'uno accanto
all'altro (come ad esempio il mondo vegetale e quello animale), nello
spirito ciascun grado è compreso e risolto nel grado superiore, il quale,
a sua volta, è già presente nel grado inferiore (ad esempio l'individuo
non esiste accanto alla società, ma è ricompreso nella società, la quale,
a sua volta, è presente nell'individuo fin dall'inizio).
12. Lo spirito soggettivo.
Lo spirito soggettivo è lo spirito individuale, considerato nel suo
lento e progressivo emergere dalla natura, attraverso un processo che va
dalle forme più elementari di vita psichica alle più elevate attività
conoscitive e pratiche. La filosofia dello spirito soggettivo si divide
in tre parti: antropologia, fenomenologia e psicologia.
Antropologia.
L'antropologia studia lo spirito come anima, la quale si identifica con
quella fase aurorale della vita cosciente che rappresenta una sorta di
dormiveglia dello spirito. In altri termini, l'anima (che si articola in
anima naturale, senziente e reale) indica «tutto quel complesso di
legami tra spirito e natura che nell'uomo si manifesta come carattere,
come temperamento, come le varie disposizioni psicofisiche connesse alle
diverse età della vita e alle differenze di sesso; è la vita del sonno e
della veglia, dello sviluppo mentale regolare o delle sue deviazioni
nella pazzia; è la vita psichica infine che culmina nell'abitudine...»
(V. Verra).
Le età della vita e il loro significato filosofico.
A proposito delle diverse età della vita, nel paragrafo 396
dell'Enciclopedia, Hegel (con un tipo di discorso che si configura come
un significativo documento del suo atteggiamento globale verso la realtà),
afferma che l'infanzia (tesi) è il momento in cui l'individuo si trova
in armonia con il mondo circostante; la givinezza (antitesi) il momento
in cui l'individuo, con i suoi ideali e le sue speranze, entra in
contrasto con il proprio ambiente; la maturità (sintesi) è il momento in
cui l'indi viduo, dopo l'urto adolescenziale con il mondo, si riconcilia
con esso, tramite il «riconoscimento della necessità oggettiva e della
razionalità del mondo già esistente e fatto». Riconciliazione che in quella
estrema fase della maturità che è la vecchiaia «trapassa nell'inattività
dell'abitudine, che ottunde».
Fenomenologia.
La fenomenologia studia lo spirito in quanto «coscienza», «autocoscienza»
e «ragione» (cfr. paragrafo 8).
Psicologia.
Infine, la psicologia studia lo spirito in senso stretto, cioà in quelle
sue manifestazioni universali, che sono il conoscere teoretico, l'attività
pratica e il volere libero. Il conoscere viene inteso da Hegel come la
totalità di tutte quelle determinazioni - intuizione, rappresentazione,
pensiero - che costituiscono il processo concreto attraverso il quale la
ragione trova se stessa nel suo contenuto. L'attività pratica è intesa
come l'unità di quelle manifestazioni (sentimento pratico, impulsi,
felicità) attraverso le quali lo spirito giunge in possesso di sé e quindi
diviene libero, determinandosi indipendentemente dalle condizioni
accidentali e limitatrici nelle quali vive l'individuo. Lo spirito libero è
la volontà di libertà divenuta essenziale e costitutiva dello spirito.
13. Lo spirito oggettivo.
Importanza decisiva di questa sezione del pensiero hegeliano.
Questa volontà di libertà trova tuttavia la sua realizzazione soltanto
nella sfera dello spirito oggettivo, in cui lo Spirito si manifesta
in istituzioni sociali concrete, ovvero in quell'insieme di determinazioni
sovra-individuali che Hegel raccoglie sotto il concetto di diritto
in senso lato (come vedremo, egli usa il concetto di diritto in varie
accezioni: cfr. il Glossario). I momenti dello spirito oggettivo - che è
la sezione storicamente più importante del pensiero hegeliano - sono tre:
il diritto astratto, la moralità e l'eticità. Di tali argomenti lo Hegel
della maturità si è occupato non solo nell'Enciclopedia, ma anche nei
Lineamenti di filosofia del diritto (1821). Ecco uno schema dello
spirito oggettivo che è bene tenere continuamente sottocchi mentre si
studiano i singoli paragrafi:
Diritto astratto (tesi):
a) La proprietà;
b) Il contratto;
c) Il diritto contro il torto.
Moralità (antitesi):
a) Il proponimento;
b) L'intenzione e il benessere;
c) Il bene e il male.
Eticità (sintesi):
Famiglia (tesi): a) il matrimonio; b) il patrimonio; c) L'educazione dei
figli.
Società civile (antitesi): a) il sistema dei bisogni; b) l'amministrazione
della giustizia; c) La polizia e la corporazione.
Stato (sintesi):
a) Il diritto interno (potere del principe; potere governativo; potere
legislativo);
b) Il diritto esterno;
c) La storia del mondo.
13.1. Il diritto astratto
L'esistenza esterna della libertà.
Il volere libero si manifesta anzitutto come volere del singolo
individuo, considerato, alla maniera romana, come persona fornita di
capacità giuridiche. Il diritto astratto o formale - che coincide con il
diritto privato e con una parte di quello penale - riguarda appunto
l'esistenza esterna della libertà delle persone, concepite come puri
soggetti astratti di diritto, indipendentemente dai caratteri specifici
e dalle condizioni concrete che diversificano i vari individui fra di loro.
La proprietà.
La persona trova il suo primo compimento in una «cosa esterna», che
diventa sua proprietà (definita come «sfera esterna» del libero volere).
Il contratto.
La proprietà diviene però effettivamente tale soltanto in virtù del
reciproco riconoscimento fra le persone, ossia tramite l'istituto
giuridico del contratto (cfr. Lineamenti, paragrafo 71 e seguenti).
Il torto e la pena.
Ovviamente, l'esistenza del diritto rende possibile l'esistenza del
suo contrario, cioè la comparsa del torto (o dell'illecito), che nel
suo aspetto più grave è il delitto. Ma la colpa richiede una sanzione o una
pena, che si configura, dialetticamente, come un ripristino del diritto
violato (secondo lo schema: diritto = tesi, delitto = antitesi,
pena = sintesi).
La pena, intesa come una riaffermazione potenziata del diritto, ovvero
come una negazione del delitto, il quale è a sua volta una negazione del
diritto, appare quindi, agli occhi di Hegel, come una necessità oggettiva
del nostro razionale e giuridico vivere insieme (tant'è vero che egli,
sviluppando per suo conto la teoria fichtiana secondo cui, in virtù della
pena, si ha il ripristino del «cittadino» nel criminale, giunge a scrivere
che, grazie alla pena, il delinquente risulta «onorato come essere
razionale»). Tuttavia, perché la pena sia efficacemente punitiva e
formativa (e non «vendicativa») occorre che essa sia riconosciuta
interiormente dal colpevole. Ma questa esigenza, oltrepassando l'ambito del
diritto, che concerne l'esteriorità legale, richiama dialetticamente la
sfera della moralità.
13.2. La moralità.
Il proponimento, l'intenzione, il benessere e il bene.
La moralità è la sfera della volontà soggettiva, quale si manifesta
nell'azione. Quest'ultima ha una portata morale solo in quanto sgorga da un
proponimento (infatti il soggetto riconosce come «sue» soltanto le azioni
che rispondono ad un suo deliberato e responsabile proposito: Enc.,
paragrafo 504 e Lineamenti, paragrafi. 115-118). In quanto procede da un
essere «pensante», il proponimento prende la forma dell'intenzione.
Il fine cui mira l'azione è il benessere (Hegel è avverso al rigorismo
etico e ritiene che la morale non debba entrare in contrasto con i nostri
bisogni e la nostra aspirazione alla felicità). Quando l'intenzione e il
benessere si sollevano all'universalità, il fine assoluto della volontà
diventa il bene in sé e per sé. Ma il bene qui è ancora un'idea astratta,
che non risulta esistente per suo conto, ma attende di passare
all'esistenza per opera di una altrettanto astratta volontà soggettiva,
che può anche essere «cattiva», ossia incapace di realizzare il dovere.
Limiti della morale.
In altri termini, il dominio della moralità è caratterizzato dalla
separazione tra la soggettività, che deve realizzare il bene, e il
bene che deve essere realizzato. Bene che assume inevitabilmente l'aspetto
di un dover-essere, ovvero, come scrive Hegel, di un «essere assoluto,
che tuttavia insieme non è » (Enc., paragrafo 511).
Da ciò la contraddizione fra essere e dover-essere, che è tipica della
morale, soprattutto di quella kantiana, che Hegel (nelle varie opere)
critica per la sua formalità ed astrattezza, cioè per la sua mancanza di
contenuti concreti e per la sua impotenza a realizzarsi nella realtà.
La morale del cuore e l'ironia.
Manifestazioni estreme del soggettivismo astratto che mina alla base la
morale (rendendola una sorta di impresa donchisciottesca) sono pure,
secondo Hegel, la morale del cuore, che fa consistere il bene nelle
inclinazioni arbitrarie del soggetto (cfr. La Fenomenologia dello Spirito)
e l'ironia romantica, la quale, non prendendo «sul serio» nessuna realtà
finita, finisce per abbassare la legge etica a trastullo dell'io, ossia
per fare del soggetto il signore del bene e del male.
13.3. L'eticità.
L'eticità e le sue forme.
La separazione fra la soggettività ed il bene, che è tipica della moralità,
viene annullata e risolta nell'eticità, nella quale il bene si è attuato
concretamente ed è divenuto esistente. Infatti, mentre la moralità è la
volontà soggettiva, cioè interiore e privata, del bene, l'eticità è la
moralità sociale, ovvero la realizzazione del bene in quelle forme
istituzionali che sono la famiglia, la società civile e lo Stato.
In quanto moralità sociale o concreta, cioè attuata visibilmente nel mondo,
l'eticità rappresenta il superamento della spaccatura fra interiorità ed
esteriorità che è propria della morale del dovere. Nello stesso tempo,
configurandosi come una sorta di morale che ha assunto le forme del
diritto (cioè della esteriorità istituzionale) o di diritto che ha assunto
le forme della morale (cioè del perseguimento del bene universale),
l'eticità risulta in grado di superare le opposte unilateralità del diritto
e della morale: «il bene, che qui è il fine universale, non deve restare
semplicemente nel mio interno, ma deve anche realizzarsi. La volontà
soggettiva cioè esige che il suo interno, il fine, consegua esistenza
esterna, e che quindi il bene debba essere compiuto nell'esistenza
esteriore. La moralità e il momento precedente del diritto formale sono
due astrazioni, la cui verità è solamente l'eticità...» (Lin., paragrafo
33, Agg.).
a) La famiglia.
La famiglia e le sue articolazioni.
Il primo momento dell'eticità è la famiglia, nella quale il rapporto
naturale dei sessi assume la forma di «un'unità spirituale» fondata
sull'amore e sulla fiducia. La famiglia si articola nel matrimonio, nel
patrimonio e nell'educazione dei figli (educazione che Hegel definisce come
una loro «seconda nascita»). Ma una volta cresciuti e divenuti
personalità autonome, i figli escono dalla famiglia originaria per dare
origine a nuove famiglie, aventi, ognuna, interessi propri. In tal modo
si passa al secondo momento dello spirito oggettivo.
b) La società civile.
Natura della società civile.
Con la formazione di nuovi nuclei familiari il sistema unitario e
concorde della famiglia (tesi) si frantuma nel sistema «atomistico» e
conflittuale della società civile (antitesi), che si identifica
sostanzialmente con la sfera economico-sociale e giuridico-amministrativa
del vivere insieme, ovvero con il luogo di scontro, ma anche di
incontro, di interessi «particolari» e «indipendenti», i quali si
trovano a dover coesistere fra di loro. Infatti, contro troppe
presentazioni riduttive di Hegel, è bene tener presente, alla luce della
critica più recente, che la società civile, pur rappresentando «il campo
di battaglia dell'interesse privato e individuale di tutti contro tutti»
(Lin., paragrafo 289, Ann.), cioè il momento antitetico o negativo
dell'eticità, è pur sempre parte dell'eticità. Analogamente, non bisogna
dimenticare che la società civile (cfr. il Glossario) non si riduce alla
sola « base economica », in quanto il sistema economico moderno
presuppone, secondo Hegel, una serie di meccanismi giuridico-amministrativi
che fanno parte integrante della vita sociale.
La società civile si articola in tre momenti:
1) il sistema dei bisogni;
2) l'amministrazione della giustizia;
3) la polizia e le corporazioni.
Il sistema dei bisogni.
Il sistema dei bisogni nasce dal fatto che gli individui, dovendo
soddisfare i propri bisogni mediante la produzione della ricchezza
e la divisione del lavoro, danno origine a differenti classi:
« Dove si ha la società civile e quindi lo Stato, hanno luogo le classi
nella loro distinzione; giacché la sostanza universale, in quanto
vivente, non esiste se non si particolarizza organicamente» (Enc.,
paragrafo 527). Le classi o i ceti (Stände) distinti da Hegel sono tre:
1) la classe « sostanziale » o « naturale » degli agricoltori (che
«ha il suo patrimonio nei prodotti naturali di un terreno che essa lavora»);
2) la classe «formale» degli artigiani, dei «fabbricanti» e dei
commercianti («che ha per sua occupazione il dar forma al prodotto
naturale»);
3) la classe «universale» dei pubblici funzionari (che «ha per sua
occupazione gli interessi universali della situazione sociale»).
L'amministrazione della giustizia.
L'amministrazione della giustizia concerne la sfera delle leggi e della
loro tutela giuridica e si identifica sostanzialmente con il diritto
pubblico.
La polizia e le corporazoni.
La polizia e le corporazioni provvedono alla sicurezza sociale. Nel
sistema di Hegel le corporazioni di mestiere rivestono un ruolo
particolare, in quanto esse, attuando una sorta di unità fra la volontà
del singolo e quella della categoria lavorativa cui egli appartiene circostanza che obbliga l'individuo ad uscire «fuori dal suo interesse
singolo e privato» (Enc., paragrafo 534)- prefigurano, sia pure in modo
relativo ed imperfetto, il momento dell'universalità statale, fungendo
in tal modo da cerniera dialettica fra la società civile e lo Stato.
L'idea di porre, fra l'individuo e lo Stato, quella sorta di terzo termine
che è la società civile è stata ritenuta una delle maggiori intuizioni di
Hegel (cfr. il Glossario). Infatti tale idea sarà largamente utilizzata
dagli studiosi di problemi economici e sociali e troverà in Marx un
originale interprete.
Altre intuizioni hegeliane che sono state apprezzate soprattutto dai
marxisti (cfr. ad esempio, il giovane Hegel di Lukács) sono l'importanza
attribuita al lavoro e all'economia politica; la constatazione che il mondo
moderno produce ricchezza e simultaneamente miseria; la consapevolezza
degli aspetti alienanti e frustranti scaturienti dalla divisione e
dalla meccanizzazione del lavoro eccetera.
Lo Stato.
Lo Stato come famiglia in grande.
Lo Stato rappresenta il momento culminante dell'eticità, ossia la
ri-affermazione dell'unità della famiglia (tesi) al di là della dispersione
della società civile (antitesi). Lo Stato, che è una sorta di famiglia in
grande, nella quale l'ethos di un popolo esprime consapevolmente se stesso,
sta infatti alla società civile come l'universale (= la ricerca del bene
comune) sta al particolare (= la ricerca dell'utile privato): «Lo Stato è
la sostanza etica consapevole di sé, la riunione del principio della
famiglia e della società civile» (Enc., paragrafo 537). Di conseguenza,
lo Stato non implica una soppressione della società civile (che è un momento
necessario, e quindi ineliminabile, della vita dello Spirito), ma uno
sforzo di indirizzarne i particolarismi verso il bene collettivo.
La concezione etica dello Stato. Il rifiuto del modello liberale...
Questa concezione etica dello Stato, visto come incarnazione suprema della
moralità sociale e del bene comune, si differenzia nettamente dal
modello politico elaborato da autori come Locke, Kant, Humboldt eccetera,
ossia dalla teoria liberale dello Stato come strumento volto a garantire
la sicurezza e i diritti degli individui. Infatti dal punto di vista di
Hegel, una teoria di questo tipo comporterebbe una confusione fra società
civile e Stato, ovvero una sorta di riduzione dello Stato a semplice tutore
dei particolarismi della società civile: «Se lo Stato vien confuso con la
società civile e la destinazione di esso viene posta nella sicurezza e
nella protezione della proprietà e della libertà personale, allora
l'interesse degli individui come tali è il fine estremo per il quale essi
sono uniti. . . » (Lin., paragrafo 258, Ann. ).
... e di quello democratico
Lo Stato di Hegel si differenzia pure dal modello democratico
(vedi Rousseau), ovvero dalla concezione secondo cui la sovranità
risiederebbe nel popolo. A ben vedere, scrive Hegel, la nozione di
sovranità popolare «appartiene ai confusi pensieri» (Lin., paragrafo 279,
Ann.), in quanto il popolo, al di fuori dello Stato, è soltanto una
moltitudine informe: « I molti come singoli, la qual cosa si intende
volentieri per popolo, sono certamente un insieme, ma soltanto come
una moltitudine, una massa informe...» (Lin., paragrafo 303, Ann.).
Priorità dello Stato rispetto all'individuo.
A simili « astrazioni », Hegel contrappone la teoria secondo cui la
sovranità dello Stato deriva dallo Stato medesimo, il quale ha dunque in
se stesso, e non al di fuori di sé, la propria ragion d'essere ed il
proprio scopo. Il che equivale a dire che lo Stato non è fondato sugli
individui, ma sull'idea di Stato, ossia sul concetto di un bene
universale. La polemica anti-liberale ed anti-democratica di Hegel ha
perciò, come suo presupposto teorico, la persuasione «organicistica»
(cfr. il Glossario) secondo cui non sono tanto gli individui a fondare
lo Stato, ma lo Stato a fondare gli individui, sia dal punto di vista
storico-temporale (in quanto lo Stato è cronologicamente «prima» degli
individui, che già nascono nell'ambito di esso), sia dal punto di vista
ideale ed assiologico (in quanto lo Stato è «superiore» agli individui,
esattamente come il tutto è superiore alle parti che lo compongono).
Rifiuto del modello contrattualistico...
L'ottica organicistica si accompagna ad un simultaneo rifiuto del modello
contrattualistico, ovvero della teoria di coloro che vorrebbero far
dipendere la vita associata da un contratto scaturiente dalla «volontà»
arbitraria degli individui. Teoria che per Hegel rappresenta un insulto
alla «assoluta autorità e maestà» dello Stato ed un attentato al
«diritto supremo» che esso possiede nei confronti dei cittadini.
...e di quello giusnaturalistico.
Hegel contesta pure il giusnaturalismo, ossia l'idea di diritti naturali
esistenti prima ed oltre lo Stato, affermando che «la società è la
condizione in cui soltanto il diritto ha la sua realtà» (Enc.,
paragrafo 502). Tuttavia, come ha mostrato Norberto Bobbio (Studi
hegeliani, Einaudi, Torino 1981), Hegel condivide con il giusnaturalismo
sia la tendenza a fare dello Stato il punto culminante del processo
storico, sia la tesi della supremazia della legge, concepita come la più
alta manifestazione della volontà razionale dello Stato.
Lo Stato hegeliano è sovrano ma non «dispotico» ed ha la forma di uno
«Stato di diritto» (senza essere, per questo uno Stato liberal-democratico).
Infatti, lo Stato di Hegel, pur essendo assolutamente sovrano, non è,
per questo, uno Stato «dispotico», ossia illegale, in quanto il filosofo
tedesco, conformemente ad una tradizione che va da Hobbes a Rousseau,
ritiene che lo Stato debba operare soltanto attraverso le leggi e nella
forma delle leggi. E ciò in omaggio al principio secondo cui a governare
non devono essere gli uomini, ma le leggi (cfr. Lin., paragrafo 278, Ann.).
Di conseguenza, lo Stato hegeliano si configura come «quello che la
giurisprudenza tedesca chiamò più tardi un Rechtstaat» (George H. Sabine),
ovvero uno Stato di diritto fondato sul rispetto delle leggi e sulla
salvaguardia della libertà «formale» dell'individuo e della sua proprietà
(da ciò l'ammirazione hegeliana per la codificazione napoleonica).
Il concetto di costituzione.
Coerentemente con la sua ottica storicistica, Hegel sostiene che la
costituzione, cioè «l'organizzazione dello Stato», non è il frutto di una
elucubrazione a tavolino, ma qualcosa che sgorga necessariamente dalla
vita collettiva e storica di un popolo: «Ciò che si chiama fare una
costituzione non è mai... accaduto nella storia; come non si è mai fatto
un codice: una costituzione si è soltanto svolta dallo spirito» (Enc.,
paragrafo 540), «ogni popolo ha quindi la costituzione che gli è adeguata»
(Lin., paragrafo 274). Tant'è vero, esemplifica Hegel, che se si vuole
imporre a priori una costituzione ad un popolo (come fece ad esempio
Napoleone con gli spagnoli) inevitabilmente si fallisce, anche se la
costituzione proposta è senz'altro migliore di quella esistente.
La monarchia costituzionale e i suoi poteri.
Hegel identifica la costituzione «razionale» con la monarchia
costituzionale moderna, ossia con un organismo politico che prevede una
serie di poteri distinti, ma non divisi, tra di loro. Tali poteri
sono: il potere legislativo, governativo e principesco (manca, come si
può notare, il potere giudiziario, in quanto l'amministrazione della
giustizia fa parte della società civile).
Il potere legislativo.
Il potere legislativo consiste nel «potere di determinare e di stabilire
l'universale» e «concerne le leggi come tali». A tale potere concorre
«l'assemblea delle rappresentanze di classi», che trova la propria
espressione in una Camera alta e in una Camera bassa.
L'agire politico dei ceti e i suoi limiti.
Pur insistendo sull'importanza mediatrice dei ceti - che «stanno tra il
governo in genere da un lato, e il popolo dissolto in individui e sfere
particolari dall'altro» (Lin., paragrafo 302) - Hegel si mostra diffidente
nei confronti del loro agire politico, ritenendo che questi, per loro
natura, siano inclini a far valere gli interessi privati «a spese
dell'interesse generale». Inoltre, esplicitando ancora una volta la propria
lontananza dal pensiero democratico, Hegel annovera fra le «storte e false»
opinioni correnti, quella per cui «i deputati del popolo o magari il popolo
debba intendere nel miglior modo quel che torni al suo meglio» giungendo
persino ad affermare che i membri del governo «possono fare ciò che è il
meglio senza i ceti», in quanto essi possiedono una «profonda conoscenza e
intellezione» dei bisogni e degli affari dello Stato, mentre il popolo
«non sa ciò che vuole» (Lin., paragrafo 301, Ann.). Coerentemente con
queste premesse, Hegel dichiara che l'assemblea dei ceti è soltanto una
parte, quella meno determinante, del potere legislativo, poiché a
quest'ultimo concorrono anche, in funzione preminente, gli altri due poteri
di cui dobbiamo ancora parlare: quello governativo e quello principesco.
Il potere governativo.
Il potere governativo, o esecutivo, che comprende in sé i poteri
giudiziari e di polizia operanti a livello di società civile, consiste
nella «sussunzione delle sfere particolari e dei casi singoli sotto
l'universale» (Lin., paragrafo 273), ossia nello sforzo di tradurre in
atto, in riferimento ai casi specifici, l'universalità delle leggi.
A questo compito sono adibiti i funzionari dello Stato.
Il potere monarchico.
Il potere del principe rappresenta l'incarnazione stessa dell'unità dello
Stato, cioè il momento in cui la sovranità di quest'ultimo si concretizza
in un'individualità reale, cui spetta la decisione «ultima» circa gli affari
della collettività: «la personalità dello Stato è reale soltanto se intesa
come una persona, il monarca» (Lin., paragrafo 279, Ann.). Tuttavia, al
di là dell'enfasi posta da Hegel sulla figura-simbolo del monarca, la sua
funzione sembra consistere in ultima istanza, nel «dire sì, e mettere il
puntino sull'i» (Lin., paragrafo 280, Agg.). Per cui, «Il vero potere
politico, nel modello costituzionale hegeliano, è il potere del
governo... Vera classe politica sono i ministri e i pubblici funzionari»
(M. Bovero, Hegel il problema politico moderno, Franco Angeli, Milano
1985, pagina 47).
In ogni caso, la monarchia costituzionale rappresenta, per il filosofo
tedesco, la «costituzione della ragione sviluppata, rispetto alla quale
tutte le altre appartengono a gradi più bassi» (Enc., paragrafo 542).
Inoltre, essa risolve organicamente in se stessa le forme classiche di
governo: monarchia, aristocrazia e democrazia: «il monarca è uno, con il
potere governativo intervengono alcuni e con il potere legislativo
interviene la pluralità in genere» (Lin., paragrafo 273, Ann.).
La «volontà divina » dello Stato.
Il pensiero politico hegeliano mette capo ad una esplicita divinizzazione
dello Stato: «Lo stato è volontà divina, come spirito presenziale, come
spirito esplicantesi e reale figura e organizzazione di un mondo»
(Lin., paragrafo 270, Ann.), «L'ingresso di Dio nel mondo è lo Stato»
(Lin., paragrafo 258, Agg.).
Taluni studiosi, per difendere Hegel dall'accusa di «statolatria», hanno
cercato di minimizzare anzi di « rettificare », le affermazioni testuali
del filosofo, ricordando che, stando alle premesse del suo pensiero
Dio in senso stretto, non si identifica con lo Stato, ma con lo spirito
assoluto, il quale, attraverso l'arte e la religione, culmina nella
filosofia (cfr. paragrafo 15) . Ciò è in parte vero, anche se non bisogna
dimenticare che l'arte, la religione e la filosofia esistono soltanto
nello Stato e in virtù dello Stato, il quale rappresenta quindi proprio
come scrive Hegel, «l'entrata» concreta e visibile di Dio (= dello Spirito)
nel mondo.
Indipendenza dello Stato dai comuni princìpi morali.
Come vita divina che si realizza nel mondo, lo stato non può trovare,
nelle leggi della morale, un limite o un impedimento alla sua azione.
Infatti, scrive Hegel, «il benessere di uno Stato ha una giustificazione
del tutto diversa che non abbia il benessere dell'individuo» e non può
dipendere da quei «pensieri universali» che vanno sotto il nome di
«princìpi morali» (Lin., paragrafo 337, Ann.).
Inesistenza di un diritto internazionale.
Soffermandosi specificamente sul diritto esterno dello Stato e sulla
storia del mondo, Hegel dichiara che non esiste un organismo superiore
in grado di regolare i rapporti interstatali e di risolvere i loro
conflitti. In altri termini, non esiste alcun giudice o pretore che
possa esaminare le pretese degli Stati (Lin., paragrafo 333, Ann.). Il solo
giudice o arbitro è lo Spirito universale, cioè la Storia (vedi
paragrafo 14), la quale ha come suo momento strutturale la guerra.
La giustificazione filosofica della guerra.
Muovendosi in un orizzonte di pensiero completamente diverso dal
cosmopolitismo pacifista ed illuminista di Kant, Hegel attribuisce
alla guerra non solo un carattere di necessità ed inevitabilità
(allorquando non vi siano le condizioni per un accomodamento delle
controversie fra Stati) ma anche un alto valore morale. Infatti, sostiene
il filosofo tedesco con un paragone famoso, come «il movimento dei venti
preserva il mare dalla putredine, nella quale sarebbe ridotto da una quiete
durevole, così la guerra preserva i popoli dalla fossilizzazione alla quale
li ridurrebbe una pace durevole o perpetua (Lin., paragrafo 324, Ann.).
N.B. Per la discussione su Hegel politico vedi l'appendice paragrafo 16.
14. filosofia della storia.
Hegel non nega che la storia possa apparire, da un certo punto di vista,
un tessuto di fatti contingenti, insignificanti e mutevoli e quindi
priva di ogni piano razionale o divino e dominata dallo spirito del
disordine, della distruzione e del male. Ma tale può apparire soltanto
dal punto di vista dell'intelletto finito, cioè dell'individuo, che misura
la storia alla stregua dei suoi personali, se pur rispettabili, ideali e
non sa elevarsi al punto di vista puramente speculativo della ragione
assoluta.
La razionalità della storia.
In realtà «il grande contenuto della storia del mondo è razionale, e
razionale dev'essere: una volontà divina domina poderosa nel mondo, e
non è così impotente da non saperne determinare il gran contenuto. La
stessa fede religiosa nella provvidenza, cioè nel governo divino del
mondo, implica la razionalità della storia; senonché questa fede è
generica e si trincera spesso dietro l'incapacità umana di comprendere
i disegni provvidenziali. Essa deve essere sottratta a questa limitazione,
secondo Hegel, e portata alla forma di un sapere che, della provvidenza
divina, riconosca le vie e sia in grado di determinare perciò il fine,
i mezzi e i modi della razionalità della storia.
Il fine della storia.
Il fine della storia del mondo è che «lo spirito giunga al sapere di ciò
che esso è veramente, e oggettivi questo sapere, lo realizzi
facendone un mondo esistente, manifesti oggettivamente se stesso.
Questo spirito che si manifesta e realizza un mondo esistente - cioè
nella presenzialità, nel fatto, nella realtà storica - è lo spirito
del mondo che s'incarna negli spiriti dei popoli che si succedono
all'avanguardia della storia.
I mezzi della storia.
I mezzi della storia del mondo sono gli individui con le loro passioni.
Hegel è ben lontano dal condannare o dall'escludere le passioni; afferma
anzi che «nulla di grande è stato compiuto nel mondo senza passione. Ma le
passioni sono semplici mezzi che conducono nella storia a fini diversi da
quelli a cui esse esplicitamente mirano. Ma poiché lo spirito del mondo è
sempre lo spirito di un popolo determinato, l'azione dell'individuo sarà
tanto più efficace quanto più sarà conforme allo spirito del popolo cui
l'individuo appartiene. «Ogni individuo è figlio del suo popolo, in un
momento determinato dello sviluppo di questo popolo. Nessuno può saltare
oltre lo spirito del suo popolo più di quanto possa saltare via dalla
terra. Ma la tradizione non è solo conservazione, ma anche progresso; e
come la tradizione trova i suoi strumenti negli individui conservatori,
così il progresso trova i suoi strumenti negli eroi o individui della
storia del mondo. Questi sono i veggenti: sanno quale sia la verità del
loro mondo e del loro tempo, quale sia il concetto, l'universale prossimo
a sorgere; e gli altri si riuniscono intorno alla loro bandiera perché
essi esprimono ciò di cui è giunta l'ora. «Gli altri debbono loro obbedire,
perché lo sentono». Soltanto a tali individui Hegel riconosce il diritto
di avversare la condizione di cose presenti e di lavorare per l'avvenire.
Il segno del loro destino eccezionale è il successo: resistere ad essi è
impresa vana.
L'«astuzia della Ragione».
Apparentemente tali individui (Alessandro, Cesare, Napoleone)
non fanno che seguire la propria passione e la propria ambizione; ma si
tratta, dice Hegel, di un'astuzia della Ragione che si serve degli
individui e delle loro passioni come di mezzi per attuare i suoi
fini. L'individuo a un certo punto perisce o è condotto a rovina
dal suo stesso successo: l'idea universale, che l'aveva suscitato, ha già
raggiunto il suo fine. Rispetto a tale fine, individui o popoli sono
soltanto mezzi. Il disegno provvidenziale della storia si rivela nella
vittoria che di volta in volta consegue il popolo che ha concepito il più
alto concetto dello spirito.
Si è detto che il fine ultimo della storia del mondo è la realizzazione
della libertà dello spirito. Ora questa libertà si realizza, secondo Hegel,
nello Stato; lo Stato è dunque il fine supremo. La storia del mondo è, da
questo punto di vista, la successione di forme statali che costituiscono
momenti di un divenire assoluto.
I tre momenti della realizzazione della libertà nel mondo.
I tre momenti di essa, il mondo orientale, il mondo greco-romano, il
mondo germanico, sono i tre momenti della realizzazione della libertà
dello spirito del mondo. Nel mondo orientale uno solo è libero; nel
mondo greco-romano alcuni sono liberi; nel mondo cristiano-germanico
tutti gli uomini sanno di essere liberi. Infatti la monarchia moderna,
abolendo i privilegi dei nobili e pareggiando i diritti dei cittadini,
fa libero l'uomo in quanto uomo. Ovviamente, questa libertà che viene
rivendicata dall'uomo,e che accomuna gli individui nel riconoscimento
della loro comune dignità, secondo Hegel si può realizzare soltanto nello
«Stato etico, che risolve l'individuo nell'organismo universale della
comunità, e non certo in uno Stato di tipo liberale, in cui il singolo
pretenda di far valere il suo «arbitrio» ed i suoi bisogni «particolari».
Infatti, per Hegel, «il diritto, la morale, lo Stato, e solo essi sono
la positiva realtà e soddisfazione della libertà. L'arbitrio del singolo
non è libertà» (Filosofia della storia, traduzione italiana, volume 1,
pagina 104).
15. Lo spirito assoluto.
Le forme dello spirito assoluto.
Lo spirito assoluto è il momento in cui l'Idea giunge alla piena
coscienza della propria infinità o assolutezza (cioè del fatto
che tutto è Spirito e che non vi è nulla dello spirito al di fuori dello
Spirito). Tale auto-sapersi assoluto dell'Assoluto non è qualcosa di
immediato, ma il risultato di un processo dialettico rappresentato
dall'arte, dalla religione e dalla filosofia. Queste attività non si
differenziano per il loro contenuto, che è identico, ma soltanto per
la forma nella quale ciascuna di esse presenta lo stesso contenuto, che è
l'Assoluto o Dio. L'arte conosce l'assoluto nella forma dell'intuizione
sensibile, la religione nella forma della rappresentazione, la filosofia
nella forma del puro concetto.
15. 1. Larte.
Il concetto dell'arte.
L'arte rappresenta il primo gradino attraverso cui lo spirito acquista
coscienza di se medesimo, in quanto, tramite essa, l'uomo
acquista consapevolezza di sé o di situazioni che lo riguardano
mediante forme sensibili (figure, parole, musica eccetera). Inoltre
nell'arte lo spirito vive in modo immediato ed intuitivo quella fusione fra
soggetto ed oggetto, spirito e natura che la filosofia idealistica
teorizza concettualmente, sostenendo che la natura è nient'altro che una
manifestazione dello spirito. Ciò accade perché nell'esperienza del bello
artistico: ad esempio di fronte ad una statua greca, spirito e natura
vengono recepiti come un tutt'uno, in quanto nella statua l'oggetto (il
marmo) è già natura spiritualizzata, cioè la manifestazione sensibile di
un messaggio spirituale, ed il soggetto (l'idea artistica) è già spirito
naturalizzato, ovvero concetto incarnato e reso visibile.
Hegel dialettizza la storia dell'arte in tre momenti: l'arte simbolica,
l'arte classica e l'arte romantica.
L'arte simbolica.
Larte simbolica, tipica dei popoli orientali, è caratterizzata dallo
squilibrio fra contenuto e forma, ossia dall'incapacità di esprimere
un messaggio spirituale secondo forme sensibili adeguate. Espressione
vivente di questo squilibrio e di questa incapacità è il ricorso al
simbolo e la tendenza allo sfarzoso e al bizzarro, che testimoniano appunto
l'immaturità ed il travaglio di questo primo momento dell'arte.
L'arte classica
L'arte classica è caratterizzata da un armonico equilibrio fra contenuto
spirituale e forma sensibile, attuato mediante la figura umana,
che è la sola forma sensibile in cui l'arte riesce e rappresentarsi e
manifestarsi compiutamente. Come tale, l'arte classica si configura come
il culmine della perfezione artistica.
L'arte romantica.
L'arte romantica è caratterizzata da un nuovo squilibrio fra contenuto
spirituale e forma sensibile, in quanto lo spirito acquista coscienza che
qualsiasi forma sensibile è ormai insufficiente ad esprimere in modo
compiuto l'interiorità spirituale, che infatti preferisce volgersi alla
filosofia, o fare dell'arte stessa una sorta di filosofia, in cui il
contenuto trabocca dalla forma. In altre parole, se nell'arte simbolica
il messaggio spirituale è così povero da non trovare la sua espressione
figurativa adeguata, nell'arte romantica è così ricco da trovare inadeguata
ogni figurazione sensibile.
Tutto ciò determina la cosiddetta «crisi» moderna dell'arte. I bei giorni
dell'arte greca e l'età doro del Medio Evo avanzato sono tramontati.
Nessuno vede più nelle opere d'arte l'espressione più elevata dell'Idea; si
rispetta l'arte e la si ammira, ma la si sottomette all'analisi del
pensiero per riconoscerne la funzione ed il posto. L'artista stesso non
può sottrarsi all'influsso della cultura razionale, dalla quale dipende
in un'ultima analisi il giudizio sulla sua opera. «Sotto tutti questi
rapporti, dice Hegel, l'arte è e rimane per noi, quanto al suo supremo
destino, una cosa del passato».
La «morte» dell'arte.
Questa «morte dell'arte» non va tuttavia interpretata (come ad esempio
farà Croce) alla stregua di un suo funerale di fatto, ma come una sua
inadeguatezza ad esprimere la profonda spiritualità moderna. Infatti
ciò che è sparito e non può più tornare è, secondo Hegel, il valore supremo
dell'arte, quella considerazione che faceva di essa la più alta e compiuta
manifestazione dell'assoluto. Non può più tornare, in altri termini, la
forma classica dell'arte. Ma l'arte è e rimane una categoria dello spirito
assoluto.
15.2. La religione.
Filosofia della religione e religione.
La religione è la seconda forma dello spirito assoluto, quella in cui
l'assoluto si manifesta nella forma della rappresentazione (vedi oltre).
Le Lezioni di filosofia della religione si aprono con la discussione del
problema del rapporto tra la filosofia della religione e la religione
stessa. La soluzione di Hegel è che la fìlosofìa della religione non deve
creare la religione, ma semplicemente riconoscere la religione che c'è già,
la religione determinata, positiva, presente. L'oggetto della religione è
Dio, il soggetto di essa è la coscienza umana indirizzata a Dio, il termine
o lo scopo è l'unificazione di Dio e della coscienza, cioè la coscienza
riempita e penetrata da Dio.
Sentimento, intuizione e rappresentazione di Dio.
Poiché alla religione è essenziale il rapporto tra Dio e la coscienza,
la prima forma della religione è l'immediatezza di questo rapporto, che è
propria del sentimento. Ma il sentimento, sebbene dia la certezza
dell'esistenza di Dio, non è in grado di giusticare questa certezza e di
trasformarla in verità oggettivamente valida. Un passo in avanti sul
sentimento è già rappresentato dall'intuizione di Dio che si ha nell'arte.
Un passo in avanti ulteriore è dato dalla rappresentazione, che è il modo
tipicamente religioso di pensare Dio, e che sta a metà strada fra
l'intuizione sensibile dell'arte ed il concetto razionale della filosofia.
Secondo Hegel è proprio della rappresentazione (cfr. il Glossario)
intendere le sue determinazioni come giustapposte, quasi fossero
indipendenti l'una dall'altra, e riunirle in modo puramente accidentale.
Si ha così la rappresentazione degli attributi divini singolarmente presi,
delle relazioni tra Dio e il mondo nella creazione, della relazione tra Dio
e la storia del mondo nella provvidenza eccetera. Tutte queste
rappresentazioni vengono unite in modo puramente esteriore, sicché si
giunge a riconoscere l'inconcepibilità dell'essenza divina che le unifica.
In altri termini, la religione non è in grado di pensare Dio dialetticamente
e finisce per arenarsi di fronte ad un presunto mistero dell'Assoluto.
Lo sviluppo storico dell'idea di Dio: dalla religione naturale a quella
assoluta.
Lo sviluppo della religione è lo sviluppo dell'idea di Dio nella coscienza
umana. Nel primo stadio di questo sviluppo troviamo la religione naturale
in cui Dio appare ancora come «sepolto» nella natura. Le forme più
basse di religione naturale sono la stregoneria ed il feticismo delle tribù
primitive dell'Asia e dell'Africa. Le forme più alte di religione naturale
sono quelle in cui Dio appare come la potenza o la sostanza assoluta dei
fenomeni. Tali sono le religioni panteistiche dell'estremo Oriente (cinese,
indiana, buddistica). Nel secondo stadio troviamo le religioni naturali
che trapassano in religioni della libertà, cioè le religioni che già
preludono alla visione di Dio come spirito libero, ma che si muovono
ancora in un orizzonte naturalistico (come accade nella religione persiana,
siriaca ed egiziana). Nel terzo stadio troviamo le religioni
dell'individualità spirituale (giudaica, greca, romana) in cui Dio appare
in forma spirituale (o in sembianze umane). Nel quarto stadio troviamo la
religione assoluta, cioè la religione cristiana, in cui Dio appare come
puro spirito.
La superiorità del cristianesimo e i suoi limiti.
Sebbene il cristianesimo sia la religione più alta e la più vicina, con
i suoi dogmi, alle verità della filosofia (Cristo, l'Uomo-Dio, esprime
ad esempio l'identità di finito e infinito; la Trinità di Padre, Figlio
e Spirito Santo la triade dialettica di Idea, Natura e Spirito eccetera),
essa presenta pur sempre dei limiti che sono propri di ogni religione.
Infatti, secondo Hegel, l'unico sbocco coerente della religione è la
filosofia, che ci parla anch'essa di Dio e dello Spirito, ma non più
nella forma inadeguata della rappresentazione, ma in quella adeguata
del «concetto».
15.3. Filosofia e storia della filosofia.
Nella filosofia, che è l'ultimo momento dello spirito assoluto, l'Idea
giunge alla piena e concettuale coscienza di se medesima, chiudendo il
ciclo cosmico. Hegel ritiene che la filosofia, al pari della realtà, sia
una formazione storica, ossia una totalità processuale che si è
sviluppata attraverso una serie di gradi o momenti concludentisi
necessariamente nell'idealismo. In altre parole, la filosofia è nient'altro
che l'intera storia della filosofia giunta finalmente a compimento con
Hegel.
La storia della filosofia come storia dell'avvento progressivo della
verità (idealistica).
Di conseguenza, i vari sistemi filosofici che si sono succeduti
nel tempo non devono essere considerati come un insieme disordinato ed
accidentale di opinioni mutuamente escludentisi e distruggentisi, in
quanto ognuno di essi costituisce una tappa necessaria del farsi della
Verità, che supera quello che precede ed è superato da quello che segue.
Coerentemente con questa impostazione, la sua storia della filosofia,
che inizia dalla filosofia greca (Hegel accenna alle filosofie
orientali, cinese e indiana, ma ritiene di doverle escludere dalla vera
e propria tradizione filosofica) e termina con quelle di Fichte e
Schelling, si conclude veramente nella sua stessa filosofia. «La
filosofia che è ultima nel tempo, è insieme un risultato di tutte le
precedenti e deve contenere i princìpi di tutte: essa è perciò - bene
inteso se è davvero una filosofia - la più sviluppata, ricca e concreta»
(Enc., paragrafo 13). L'ultima filosofia è quella di Hegel.
«L'attuale punto di vista della filosofia è che l'idea sia conosciuta
nella sua necessità... A questo punto è pervenuto lo spirito universale,
e ogni stadio ha, nel vero sistema della filosofia, la sua forma specifica.
Niente si perde, tutti i princìpi si conservano; la filosofia ultima è
difatti la totalità delle forme. Quest'idea concreta è la conclusione dei
conati dello spirito, in quasi due millenni e mezzo di lavoro serissimo, per
diventare oggettivo a se stesso, per conoscersi » (Lezioni di storia della
filosofia,volume 3, pagine 410-411).
16. Appendice: il dibattito sulle teorie politiche di Hegel.
La filosofia politica di Hegel è stata variamente discussa ed ha dato
origine ad una serie di interpretazioni diverse e talora opposte fra di
loro. Vediamo sinteticamente alcuni dei punti più controversi.
a) Portavoce della Restaurazione o della Rivoluzione?
Come è stato osservato di recente, «della filosofia politica hegeliana
non è difficile rintracciare un'interpretazione storicamente prevalente
sulle interpretazioni rivali, e ancor oggi diffusa, se pur non più tra
gli specialisti: quella che la considera come un'apologia dello stato
della restaurazione, o peggio come un'espressione di un atteggiamento
di servile ossequio nei confronti dello stato prussiano» (M. Bovero,
opera citata, pagina 63).
L'immagine corrente di Hegel come «filosofo dello Stato prussiano» e le
critiche di E. Weil.
Tale interpretazione, divenuta una sorta di communis opinio intorno ad
Hegel e tuttora trionfante nella manualistica corrente, risale alla
monografia di Rudolf Haym (1821-1901) Hegel e il suo tempo (Berlino 1857),
il quale, oltre che accusare Hegel di essere stato «il dittatore filosofico
della Germania», definiva il suo pensiero «dimora speculativa della
restaurazione prussiana», accusandolo di essersi posto al servizio
«della giustificazione scientificamente formulata del sistema poliziesco
inaugurato a Karlsbad».
Nel nostro secolo questa interpretazione è stata duramente contestata da
Erich Weil (1904-1977), che in Hegel e lo Stato (Parigi, 1950) ha cercato di
dimostrare documenti alla mano, come la struttura istituzionale tracciata da
Hegel non si una copia fedele di quella prussiana dell'epoca, ma risulti
complessivamente più «avanzata». Come si è accennato, la tesi di Weil,
sfrondata da certi suoi aspetti «apologetici», è stata sostanzialmente
accettata dagli specialisti, i quali, pur ammettendo che lo Stato
prospettato da Hegel rispecchi alcune caratteristiche di fondo
della Prussia prequarantottesca e risenta dei legami di Hegel con le
autorità politiche (denunciate dai contemporanei: si pensi ad esempio a
Schopenhauer), rifiutano la rigida equazione: Stato hegeliano = Stato
prussiano. Inoltre, il pensiero di Hegel, pur nella sua impronta
anti-illuministica, non può affatto venir confuso con quello del
romanticismo reazionario.
La critica di Hegel ai teorici del romanticismo reazionario.
Infatti, egli ha incessantemente polemizzato sia con i teorici della
contro-rivoluzione e della restaurazione (soprattutto con Carl Ludwig von
Haller) sia con la Scuola storica del diritto (soprattutto con Friedrich
Karl von Savigny). In particolare, contro lo storicismo giuridico di
quest'ultima - la quale, affermando che il diritto non è un prodotto
artificiale degli organi legislativi, ma il frutto della storia dei popoli,
invitava i legislatori a favorire lo sviluppo del diritto
consuetudinario - Hegel esalta la volontà razionale incarnata dalle
leggi e l'esigenza di una codificazione.
Il rifiuto di uno Hegel «reazionario» e «filosofo della restaurazione»
ha spinto taluni autori ad interpretare la sua teoria politica in chiave
«progressista», sino a scorgere in lui più un teorico della società civile
che non dello Stato, più un fautore del mutamento e delle riforme che non
della stasi e della conservazione, più un portavoce della Rivoluzione
francese che non un ideologo della Restaurazione.
La tesi di un Hegel «rivoluzionario»...
Tale è, ad esempio, la posizione espressa da Joachim Ritter (1903-1974),
che in Hegel e la rivoluzione francese (1957) sottolinea il ruolo centrale
che «il grande evento » avrebbe esercitato sulla formazione intellettuale
di Hegel, anche se il filosofo, dopo un iniziale entusiasmo, avrebbe avuto,
nei suoi confronti, una posizione «ambivalente» non tale, comunque, da
portarlo a patrocinare (neppure negli anni di Berlino) un ristabilimento
puro e semplice dell'Ancien Régime.
...e i suoi critici.
Questo capovolgimento di prospettive è sembrato eccessivo a tutti
quegli studiosi i quali, pur rifiutando la «leggenda» di uno Hegel
prussiano, non si sentono di condividere l'opposta «leggenda» di uno Hegel
rivoluzionario. Insistendo sugli aspetti storicamente «conservatori» della
filosofia politica hegeliana, Bobbio scrive ad esempio: « Hegel non è un
reazionario ma non è neppure, quando scrive la Filosofia del diritto, un
liberale: è puramente e semplicemente un conservatore, in quanto pregia più
lo stato che l'individuo, più l'autorità che la libertà, più l'onnipotenza
dei diritti soggettivi, più la coesione del tutto che l'indipendenza delle
parti, più l'obbedienza che la resistenza, più il vertice della piramide
(il monarca) che la base (il popolo)...» (opera citata, pagine 189-190).
Del resto, come si è visto, lo Stato di diritto di Hegel, pur non essendo
uno Stato «dispotico» e pur garantendo la libertà «formale» della persona
e della sua proprietà, è pur sempre uno Stato dichiaratamente ostile a
quelle idee di suffragio e di rappresentanza parlamentare che, a cominciare
dall'Inghilterra, stavano cambiando il volto politico dell'Europa.
b) Teorico della borghesia?
Stato borghese o Stato hegeliano.
Secondo un'altra interpretazione corrente, che ha trovato seguito
soprattutto nel nostro Paese, Hegel sarebbe un teorico e ideologo dello
Stato «borghese» e la sua filosofia rappresenterebbe il punto di vista
più alto raggiunto dalla borghesia moderna. Questa lettura è
stata presentata in forme svariate e talora contraddittorie, risultando
tuttora argomento di dibattito se la società borghese di cui Hegel
sarebbe l'interprete e l'apologeta sia quella arretrata della Germania o
quella industriale avanzata. A questa impostazione si oppongono invece
quegli studiosi che fanno notare come la quintessenza della concezione
borghese dello Stato sia l'idea di uno Stato minimo, ben diverso da
quello etico (o massimo) teorizzato da Hegel. Anzi, quest'ultimo si
configurerebbe piuttosto, in virtù dei suoi presupposti
anti-individualistici, come l'esatta antitesi dello Stato «borghese»,
inteso, in senso stretto e rigoroso, come un meccanismo istituzionale
garante del libero gioco degli interessi privati, ovvero, secondo la
polemica definizione di Marx, come il comitato d'affari della borghesia.
«Come una concezione siffatta, antiprivatistica, antiatomistica,
antindividualistica - scrive Bobbio parlando della dottrina hegeliana -
abbia potuto essere scambiata per l'apologia dello Stato borghese
resta... un mistero» (opera citata, pagina 111). Più fedele
rappresentazione della società borghese, quale era di fatto e quale la
concepivano i pensatori liberali, sarebbe invece la «società civile», così
come la intende Hegel. Ma quest'ultima, avendo come scopo la «sicurezza
indisturbata della persona e della proprietà» (Lin., paragrafo 230), non
deve venir «confusa», secondo quanto afferma testualmente il filosofo
tedesco, con lo Stato, a meno di fare dell'interesse «particolare» dei
singoli, come appunto desideravano i teorici della borghesia, il fine
ultimo dello Stato.
c) «Profeta del totalitarismo» o «filosofo della libertà»?
Un'altra interpretazione - che ha trovato in Karl Popper la sua voce più
nota (La società aperta e i suoi nemici, traduzione italiana, Armando,
Roma 1973. Sebbene Popper sia il rappresentante più autorevole di tale
interpretazione, essa, in particolare nel mondo anglosassone, risulta
condivisa da parecchi studiosi. Di conseguenza, la nostra esposizione
tiene presente soprattutto, ma non esclusivamente, Popper.) - è quella
che scorge nello Hegel politico un «nemico della società aperta» ed
un «profeta del totalitarismo». Poiché tale lettura viene spesso
divulgata in modo riduttivo, è bene tener presente che, con essa,
non si intende affermare:
1) che le forme dello Stato hegeliano siano puntualmente identiche alle
forme dello Stato fascista o nazista;
2) che le teorie di Hegel siano puntualmente coincidenti con quelle
fasciste o naziste.
Infatti, per quanto concerne il primo punto, sappiamo ad esempio come
lo Stato del filosofo tedesco, pur non essendo uno Stato di tipo
liberal-democratico, sia pur sempre uno Stato costituzionale e di
diritto. Analogamente, per quanto riguarda il secondo punto, è risaputo
come i principali teorici del Terzo Reich abbiano esplicitamente preso
le distanze dal nostro autore, ritenendo che l'entità più alta e decisiva
non sia lo Stato, ma il Sangue, il Popolo, la Razza (in rapporto ai
quali lo Stato decade da fine a mezzo).
In che senso Hegel sarebbe un «profeta» del totalitarismo.
In realtà, con la tesi di uno Hegel «profeta» del totalitarismo, si intende
sostenere che il filosofo tedesco avrebbe lasciato «in eredità», alle
dittature del Novecento (non solo di destra, ma anche di sinistra), alcune
idee, o meglio, talune forme mentali atte a giustificarne la politica.
Fra le tesi «incriminate» ricordiamo le seguenti:
1) lo Stato rappresenta un prius logico, storico ed assiologico al di
fuori del quale l'individuo non ha consistenza e valore: «Tutto ciò
che l'uomo è, egli lo deve allo Stato: solo in esso egli ha la sua essenza.
Ogni valore, ogni realtà spirituale, luomo l'ha solo per mezzo dello Stato»
(Filosofia della storia, volume 1, pagina 105);
2) lo Stato non ricava la sovranità da quella «moltitudine informe» che è
il popolo, ma da se medesimo;
3) la sovranità statale si incarna in una classe di funzionari dedita al
pubblico bene. Classe che, platonicamente, «pensa» e «sa quello che vuole»,
mentre il popolo «non sa quello che vuole» e risulta privo della
possibilità di controllare "dal basso", mediante istituzioni e procedure
democratiche, i propri governanti (ciò fa sì che anche a proposito
della «classe universale» di Hegel, e del monarca che ne costituisce il
vertice, sorga l'interrogativo che già ci si poneva a proposito dei
filosofi-re di Platone, ovvero il problema, cruciale per ogni teoria
non-democratica, "chi custodirà i custodi?");
4) lo Stato deve permeare tutte le manifestazioni della vita in comune,
subordinando a sé ed alla propria «organizzazione» globale l'insieme dei
rapporti sociali;
5) lo Stato è un ente che non riconosce, al di là del proprio essere,
alcuna idea etica;
6) lo Stato è l'Assoluto stesso, ovvero il «Dio reale»;
7) non esiste, al di sopra degli Stati, alcun diritto internazionale;
8) la guerra è un inevitabile strumento di composizione dei conflitti
interstatali e giova alla «salute etica» dei popoli.
L'utilizzazione dell'«arsenale teorico» hegeliano da parte dei fautori del
totalitarismo.
Questi (ed altri) punti costituirebbero, secondo i critici in questione,
una sorta di «arsenale teorico» da cui avrebbero attinto a piene mani (anche
al di là delle specifiche posizioni e intenzioni di Hegel) i fautori del
totalitarismo («Il totalitarismo politico, scrivono Reale-Antiseri, ha
desunto le armi concettuali per la propria autolegittimazione in larga
misura da Hegel. E se è vero che questo è stato un abuso, resta però vero
che Hegel fornisce effettivamente un ampio materiale disponibile a tale
abuso» (Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, La Scuola, Brescia,
1983, volume 3, pagina 119). In particolare, la filosofia statalistica
e statolatrica del pensatore tedesco sarebbe servita a diffondere e a
giustificare l'idea del primato assoluto del Collettivo (comunque inteso:
lo Stato, la Nazione, la Razza, la Classe, il Partito eccetera)
sull'individuale (« Mossa, in origine, dall'impulso a superare ogni
alienazione, a conquistare la libertà assoluta anche di tronte a Dio,
questa filosofia di Hegel ha creato e anche giustificato la più enorme
alienazione di sé della persona umana, l'asservimento volontario a
qualsiasi Stato, Partito, Capo, che si presenti come strumento
infallibile della Storia» (C. Antoni, Lo storicismo, E.R.I, Torino 1957,
pagina 122).
Emblematica, a questo proposito, la voce « Dottrina del fascismo »
redatta da Gentile per l'Enciclopedia Treccani e firmata da Mussolini.
Voce in cui si legge tra l'altro: «Caposaldo della dottrina fascista è
la concezione dello Stato, della sua essenza, dei suoi compiti, della
sua finalità. Per il fascismo lo Stato è un assoluto, davanti al quale
gli individui e i gruppi sono il relativo. Individui e gruppi sono
pensabili in quanto siano nello Stato. Lo Stato liberale non dirige
il gioco e lo sviluppo materiale e spirituale della collettività, ma si
limita a registrarne i risultati; lo Stato fascista ha una sua
consapevolezza, una sua volontà, per questo si chiama Stato etico».
Hegel come filosofo della ragione e della libertà.
Altri studiosi, rifiutando polemicamente l'immagine di uno Hegel profeta
della forma mentis totalitaria, hanno invece cercato di accreditare, presso
gli specialisti e il largo pubblico, l'opposta figura di uno Hegel paladino
della ragione e della libertà. Fra gli interventi più significativi a questo
riguardo citiamo Ragione e rivoluzione (1941) di Herbert Marcuse, il quale,
dopo aver insistito sulle potenzialità critiche e liberatrici della ragione
idealistica, enumera le differenze concrete esistenti fra lo Stato
hegeliano (che prevede la distinzione società civile-Stato e la salvaguardia
dei diritti) e lo Stato totalitario (che si fonda su di una politicizzazione
integrale della società e sulla sottomissione delle masse attraverso il
terrore).
L'idea di un Hegel «diverso» (o «segreto»).
In anni più recenti, l'immagine di uno Hegel «alternativo»
rispetto a quello tradizionale ha trovato un suo rappresentante di
spicco in Karl Heinz Ilting (1925-1984), il quale, servendosi di appunti
presi da uditori, ha curato la pubblicazione dei corsi hegeliani di
filosofia del diritto (raccolti nei quattro volumi delle Lezioni di
filosofia del diritto 1818-1831, Stuttgart 1973-1974). Secondo Ilting,
tali corsi rivelerebbero l'esistenza di uno Hegel «diverso» rispetto ai
Lineamenti di filosofia del diritto del 1821. Infatti, mentre nell'opera
«ufficiale» Hegel avrebbe in parte «falsificato» e in parte celato il
proprio pensiero effettivo - per non incorrere nelle noie della censura
prussiana - nei corsi di lezione tenuti in altri periodi avrebbe invece
sostenuto un pensiero per il quale Ilting non esita ad usare definizioni
come «liberale-progressista», «socialista-liberale»,
«democratico-repubblicano».
Agli occhi di molti studiosi questo Hegel «diverso» (già Jacques d'Hondt
aveva parlato nel 1968 di uno Hegel «segreto» e «massone») è apparso
poco verosimile.
...e le perplessità in proposito.
Come osserva ad esempio Bobbio, «Di fronte alle curiose ma tenui rivelazioni
di fatti sconosciuti o di nuovi testi restano quei due monumenti di
sapienza politica e di intelligenza storica che sono le lezioni di
filosofia del diritto e di filosofia della storia: monumenti così
maestosi ed eloquenti, e così coerenti e risoluti nella critica del
liberalismo, del contrattualismo, dell'individualismo, del
parlamentarismo, della tradizione costituzionale inglese, così
indifferenti di fronte alle libertà dei moderni, da indurre ancora una
volta a considerare comparse conclusionali più abili che convincenti le
nuove interpretazioni liberaleggianti» (opera citata, pagina 18esima).
E come puntualizza Claudio Cesa «Se fosse vero, poi, che Hegel avesse
simpatizzato, sia pure a suo modo, per l'ala più avanzata dell'opinione
liberale, non si giustificherebbero né le testimonianze, quasi univoche,
dei contemporanei, né, soprattutto le sue reazioni nei confronti della
rivoluzione del luglio 1830 e delle agitazioni inglesi per la riforma
elettorale » (Autori Vari, Il pensiero politico di Hegel. Guida
storicaa e critica, a cura di. C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1979,
pagina 30esima).
Per cui, quegli studiosi odierni che non accettano l'esistenza di uno
Hegel «diverso» o «rivoluzionario» sembrano essere concordi fra di loro
(al di là dell'accettazione o meno delle tesi radicali di un Popper)
nell'escludere che la strada maestra del pensiero liberal-democratico
moderno passi attraverso Hegel. Tanto più che «I soli Stati in cui
almeno sino ad ora la società civile è stata completamente assorbita in
quella "organizzazione del tutto", in cui Hegel vedeva l'essenza dello
Stato, sono gli Stati totalitari» (N. Bobbio, opera citata, pagina 114).
N.B. Per la presenza di Hegel nella filosofia moderna si confrontino i
capitoli «Destra e Sinistra hegeliana», «Marx», «Il neoidealismo
novecentesco», «Gli sviluppi novecenteschi della filosofia marxista»,
«La Scuola di Francoforte e Habermas».
Indicazioni bibliografiche
M. Rossi, Da Hegel a Marx, 2 voumi, Feltrinelli, Milano 1970.
T. W. Adorno, Tre studi su Hegel, Il Mulino, Bologna 1971.
B. De Giovanni, Hegel e il tempo storico della società borghese, De Donato,
Bari 1972.
J.Hyppolite, Genesi e struttura della «Fenomenologia dello Spirito» di Hegel,
La Nuova Italia, Firenzel972
H. Küng, Incarnazione di Dio. Introduzione al pensiero teologico di Hegel,
Queriniana, Brescia 1972.
J. Wahl, La coscienza infelice nella filosofia di Hegel, I.L.I., Milano 1972.
A. Avineri, La teoria hegeliana dello Stato, Laterza, Bari 1973.
G. Bedeschi, Politica e storia in Hegel, Laterza, Bari 1973.
H. G. Gadamer, La dialettica di Hegel, Marietti, Torino 1973.
L. Lugarini, Hegel dal mondo storico alla filosofia, Armando, Roma 1973.
Autori vari, L'opera e l'eredità di Hegel a due secoli dalla nascita,
Laterza, Roma-Bari 1974.
V. Cerroni, Società civile e Stato politico in Hegel, De Donato, Bari 1974.
Autori vari, Hegel e l'economia politica, a cura di S. Veca, Marzotto,
Milano 1975.
R. Bodei, Sistema ed epoca in Hegel, Il Mulino, Bologna 1975.
G. Lukács, Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica,
Einaudi, Torino 1975.
R. Racinaro, Realtà e conciliazione in Hegel, De Donato, Bari 1975.
C. Cesa, Hegel filosofo e politico, Guida, Napoli 1976.
S. Landucci, Hegel: la coscienza e la storia, La Nuova Italia, Firenze 1976.
F. Rosenzweig, Hegel e lo Stato, Il Mulino, Bologna 1976.
K. H. Ilting, Hegel diverso, Laterza, Roma-Bari 1977.
M. Paolinelli, G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, 2 volumi.,
Vita e Pensiero, Milano 1977.
G. Marini, Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella «Filosofia del
diritto » hegeliana, Bibliopolis, Na 1978.
F. Biasutti, Assolutezza e soggettività. L'idea di religione in Hegel,
Verifiche, Trento 1979.
D. Marconi, La formalizzazione della dialettica. Hegel, Marx e la logica
contemporanea, Rosenberg-Sellier, Torino 1979.
V. Vitiello, Dialettica ed ermeneutica: Hegel ed Heidegger, Guida,
Napoli 1979.
F. Chiereghin, Dialettica dell'assoluto e ontologia della soggettività
in Hegel, Verifiche, Trento 1980.
N. Bobbio, Studi hegeliani. Diritto, società civile, stato, Einaudi,
Torino 1981.
M. Borghesi, La figura di Cristo in Hegel, Studium, Roma 1982.
F. Menegoni, Moralità e Morale in Hegel, Liviana, Padova 1982.
L. Lugarini, Prospettive hegeliane, Janua, Roma 1986.
A. Negri, Hegel nel Novecento, Laterza, Bari 1987.
J. van der Meulen, Hegel. Il medio infranto, Morano, Napoli 1987.
A. Peperzak, Autoconoscenza dell'assoluto. Lineamenti della filosofia
dello spirito hegeliana, Bibliopolis, Napoli, 1988.
V. Verra, Introduzione a Hegel, Laterza, Roma-Bari 1988.
E. Weil, Hegel e lo Stato e altri scritti hegeliani, Guerini, Napoli 1988.
J. D'Hondt, Hegel segreto, Guerini, Napoli 1989.
G. Varnier, Ragione, negatività, autocoscienza. La genesi della dialettica
hegeliana a Jena, Guida, Napoli 1990.
Glossario e riepilogo
termini-chiave del sistema:
- Per idealismo Hegel intende la teoria dell'idealità (= non-realtà) del
finito, ossia la propria dottrina della risoluzione dialettica del
finito nell'infinito: «La proposizione che il finito è ideale
costituisce l'idealismo... L'idealismo della filosofia consiste soltanto
in questo: nel non riconoscere il finito come un vero essere (Scienza
della logica, pagine 169-170).
- L'Assoluto è l'Infinito (vedi), il Soggetto (vedi), l'Idea (vedi),
la Ragione (vedi), lo Spirito (vedi), cioè Dio, idealisticamente e
panteisticamente inteso come realtà immanente nel mondo, come un
Infinito-che-si-fa-mediante-il-finito.
- L'Infinito è l'Assoluto, in quanto Totalità autosufficiente in cui si
risolve ogni realtà finita. Hegel distingue fra una «falsa» infinità,
che, pur dichiarando «contraddittorio» il finito, esprime soltanto
l'esigenza o il «dover-essere» del suo superamento (vedi Fichte), ed una
«vera» infinità, la quale consiste nella «unità del finito e
dell'infinito», o meglio, visto che in questa formula il finito appare
ancora «come lasciato intatto» e «non vien espressamente espresso come
superato (Enc., paragrafo 95), con la totale e completa risoluzione del
finito nell'infinito.
- Il Soggetto è l'Assoluto, concepito non come una Sostanza statica (alla
maniera di Spinoza), ma come una realtà in divenire che produce se
stessa e che soltanto alla fine si rivela come ciò che è veramente,
ossia come Spirito (vedi): «tutto dipende dall'intendere e dall'esprimere
il vero non come sostanza, ma altrettanto decisamente come soggetto»
(Fenomenologia), « il soggetto è questo: che esso si dà a se stesso
l'esser altro e che mediante la negazione di sé ritorna a se stesso,
ossia produce se stesso (Filosofia della Religione).
- Per Idea (Idee) in generale Hegel intende l'Assoluto («l'assoluto è
l'idea», Enc., paragrafo 213), concepito come Ragione (vedi) in atto,
ovvero come unità dialettica di pensiero ed essere, concetto e cosa,
ragione e realtà, soggetto e oggetto, infinito e finito eccetera: «L'idea
è il vero in sé e per sé, l'unità assoluta del concetto e dell'oggettività»
(ivi), «L'idea può esser concepita come la ragione... come il
soggetto-oggetto, come l'unità dell'ideale e del reale, del finito e
dell'infinito... », (Enc., paragrafo 214). N.B. Hegel parla di Idea
anche in un significato più ristretto, che è quello dell'Idea «pura»
o Idea «in sé e per sé» (vedi).
- Per Ragione (Vernunft) Hegel intende non la ragione finita dell'individuo,
ma la realtà stessa in quanto Idea (vedi), ossia in quanto unità fra
pensiero ed essere: « La ragione è la certezza della coscienza di essere
ogni realtà» (Fenomenologia, volume 1, pagina 194), «L'autocoscienza, ossia
la certezza che le sue determinazioni sono tanto oggettive, - determinazioni
dell'essenza delle cose, - quanto suoi propri pensieri, è la ragione»
(Enc., paragrafo 439).
- «Ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale». Con questa
formula Hegel intende dire: 1) che la razionalità non è pura idealità,
astrazione, schema, dover-essere, ma la sostanza stessa di ciò che
esiste, poiché la Ragione «governa» il mondo; 2) che la realtà non è una
materia caotica, ma il dispiegarsi di una struttura razionale (Idea) che
si manifesta in modo inconsapevole nella natura e in modo consapevole
nell'uomo.
- Panlogismo (dal greco pan, tutto, e lógos, ragione) è un termine coniato
dal filosofo tedesco J. E. Erdmann (1805-1892) per indicare la dottrina
hegeliana della identità fra reale e razionale. Dottrina che fa
dell'hegelismo una forma di ottimismo metafisico corroborato dalla teoria
dialettica (vedi) del negativo come momento del farsi del positivo.
- Giustificazionismo. è un termine usato dai critici per indicare
l'atteggiamento generale di Hegel di fronte alla realtà e, in particolare,
la sua dottrina della filosofia come giustificazione della necessità
e razionalità sostanziale del mondo.
- Necessità. è la modalità fondamentale dell'esistente: « la vera realtà è
necessità: ciò che è reale è in sé necessario». Tale necessità si manifesta
nella struttura processuale ed ascendente del mondo, che è composto di
una serie di gradi o momenti che rappresentano, ognuno, il risultato
obbligato di quelli precedenti ed il presupposto obbligato di quelli
seguenti.
- L'«Idea pura» (Enc., paragrafo 19) o «Idea in sé e per sé »
(Enc., paragrafo 18) - accezione ristretta del termine generale di Idea
(vedi) - è l'Assoluto considerato in se stesso, cioè a prescindere dalla
sua concreta realizzazione nella natura e nello spirito. In altre
parole, l'Idea « pura», oggetto specifico della Logica (vedi), si
identifica con il programma o l'ossatura logico-razionale della
realtà. N.B. In questa accezione ristretta, il termine hegeliano tende ad
avvicinarsi alla concezione tradizionale dell'idea come archetipo o modello
del mondo. Tant'è vero che Hegel parla talora dell'Idea pura come del
« mondo delle essenzialità semplici, liberate da ogni concrezione
sensibile.» Ovviamente, nel caso di Hegel, il modello archetipo del
mondo non è trascendente il mondo (come avviene nella metafisica
platonico-cristiana), bensì immanente ad esso.
- La Natura (Natur) è l'dea «fuor di sé» o l'idea «nella forma
dell'esser altro» (Enc., paragrafo 247), ossia l'estrinsecazione
alienata dell'Idea nelle realtà spazio-temporale del mondo.
- Lo Spirito (Geist) è l'idea che, dopo essersi alienata nella Natura,
torna presso di sé nell'uomo: « lo spirito è essenzialmente questo: che,
fuori dal suo esser altro e con il superamento di quest'esser altro,
perviene a se stesso mediante la negazione della negazione» (Filosofia
della Religione). E poiché l'Assoluto è «Risultato», in quanto «soltanto
alla fine esso è quel che è in verità», Hegel vede nello Spirito il
senso ultimo dell'Assoluto: « l'assoluto è lo spirito: questa è la più
alta definizione dell'assoluto (Enc., paragrafo 384).
- In sé (An sich) e Per sé (Für sich). Con il termine « in sé » Hegel
intende, in generale ciò che è astratto, immediato, implicito, possibile,
privo di sviluppo e di relazioni, inconsapevole eccetera. Al contrario,
con il termine « per sé » intende ciò che è concreto, mediato, esplicito,
attuale, effettuale, relazionato, consapevole eccetera. Talora, l'in sé
viene fatto corrispondere al primo momento della dialettica (la tesi),
il per sé al secondo momento (l'antitesi) e l'in sé per sé al terzo momento
(la sintesi). N.B. l'uso hegeliano di questi termini non è univoco e tende
a mutare a seconda dei contesti.
Dialettica e fenomenologia:
- Il concetto di dialettica, nella tradizione filosofica, ha ricevuto
significati diversi, variamente imparentati fra di loro, ma irriducibili
l'uno all'altro. In Platone la dialettica è la scienza delle idee, che
procede secondo il metodo dicotomico. In Aristotele denota il procedimento
dimostrativo che parte da premesse probabili, cioè generalmente ammesse.
Negli Stoici e nei medioevali è sinonimo di logica. Per Kant è l'arte
«sofistica» di costruire ragionamenti capziosi, basati su premesse che
sembrano probabili, ma che in realtà non lo sono. In Fichte è « la sintesi
degli opposti per mezzo della determinazione reciproca». In Hegel la
dialettica è, al tempo stesso, la legge di sviluppo della realtà e la
legge di comprensione della medesima. Globalmente e sinteticamente
considerata, la dialettica consiste: 1) nell'affermazione o posizione
di un concetto «astratto e limitato che funge da tesi; 2) nella negazione
di questo concetto come alcunché di limitato e di finito e nel passaggio
ad un concetto opposto, che funge da antitesi; 3) nella unificazione della
precedente affermazione e negazione in una sintesi comprensiva di entrambe.
Sintesi che si configura come una riaffermazione potenziata
dell'affermazione iniziale (tesi), ottenuta tramite la negazione della
negazione intermedia (antitesi). Hegel denomina questi tre momenti,
rispettivamente, « astratto o intellettuale» , « dialettico o
negativo-razionale» , « speculativo o positivo-razionale».
- Per intelletto Hegel intende un modo di pensare «statico» ed «astratto»,
che, attenendosi al principio di identità e di non-contraddizione,
«immobilizza» gli enti nelle loro determinazioni «rigide» e
reciprocamente escludentesi. All'intelletto si contrappone la ragione
(vedi) in senso stretto.
- Per ragione Hegel intende quel modo di pensare che, fluidificando la
fissità e la rigidezza delle determinazioni intellettuali, riesce a
cogliere la concretezza vivente del reale. Il sopraccitato momento
«dialettico» o « negativo-razionale» consiste appunto nel negare le
determinazioni astratte dell'intelletto e nel metterle in rapporto con le
determinazioni opposte, mentre il momento «speculativo o
«positivo-razionale» consiste nel cogliere l'unità delle determinazioni
opposte ed il positivo che emerge dalla loro composizione sintetica. La
ragione speculativa rappresenta quindi l'organo attraverso cui avviene
quella risoluzione del finito nell'infinito che rappresenta l'alfa e
l'omega della filosofia hegeliana. N.B. « Intelletto, ragione negativa,
ragione positiva sono distinzioni che non vanno intese come facoltà
mentali diverse. Si tratta, in fondo, della stessa ragione, in
differenti fasi o funzioni. L'intelletto non è che la ragione che,
dimenticando il suo compito più alto, s'irrigidisce nelle distinzioni...»
(G. de Ruggiero).
- Aufhebung (superamento) è un termine tecnico adoperato da Hegel per
indicare il procedimento della dialettica, che abolisce, e nello stesso
tempo conserva, ciascuno dei suoi momenti: « La parola superamento,
scrive Hegel nella Scienza della logica, ha nella lingua (tedesca) un
duplice senso per cui significa da un lato conservare, ritenere, e
dall'altro far cessare, metter fine. Il conservare racchiude già in sé il
negativo, che qualcosa sia tolto alla sua immediatezza... Così il
superato è insieme un conservato il quale ha perduto soltanto la sua
immediatezza ma non perciò è annullato» (pagine 105-106). L'Aufhebung allude
di conseguenza ad un progresso che ha fatto proprio quello che c'era di
vero nei momenti precedenti della tesi e dell'antitesi, portandolo, nel
contempo, alla sua migliore e più alta espressione.
- Contraddizione. A differenza della filosofia tradizionale, che escludeva
la contraddizione dall'ambito della realtà e della ragione, Hegel scorge
in essa il pungolo o la molla grazie a cui la realtà si sviluppa e dalla
tesi si passa all'antitesi. Infatti, secondo Hegel, la proprietà del
finito è quella di auto-contraddirsi e quindi di sollecitare la propria
risoluzione nell'infinito. La scoperta del valore della contraddizione e
del cosiddetto «travaglio del negativo» rappresenta una delle idee più
interessanti e storicamente influenti dell'hegelismo.
- Per fenomenologia (dal greco phainómenon, «fenomeno, «apparenza» e lógos,
«discorso, «dottrina) si intende la descrizione o la scienza di ciò che
appare. Il termine, che è stato probabilmente coniato nell'ambito della
scuola wolfiana, presenta molti significati. Oggigiorno indica il
programma della corrente che fa capo ad E. Husserl (1859-1938). In Hegel
denota l'apparire progressivo dello spirito a se stesso e fa tutt'uno con
il concetto di «fenomenologia dello spirito» (vedi).
- Per fenomenologia dello spirito Hegel intende la storia romanzata della
coscienza che, dalle sue prime manifestazioni sensibili, giunge ad
apparire a se stessa nella sua vera natura, cioè come Coscienza infinita o
universale. In questo senso, fenomenologia dello Spirito coincide con il
«divenire della scienza o del sapere», e si configura come la via attraverso
la quale il singolo individuo ripercorre i gradi di formazione dello
Spirito universale come figure (vedi) già deposte o tappe di una via già
tracciata e spianata. La prima parte della Fenomenologia hegeliana si
divide in coscienza, in cui predomina l'attenzione verso l'oggetto,
autocoscienza, in cui predomina l'attenzione verso il soggetto, e in
ragione, nella quale l'individuo arriva scorgere l'unità profonda di
soggetto ed oggetto, io e mondo, sintetizzando in tal maniera i momenti
della coscienza e dell'autocoscienza.
- Le figure di cui parla la Fenomenologia non sono né entità puramente
ideali, né entità puramente storiche, ma entità ideali-e-storiche al tempo
stesso, in quanto esprimono delle tappe ideali dello Spirito che hanno
trovato una loro esemplificazione tipica nel corso della storia (come è
stato osservato da taluni studiosi, Hegel, nella Fenomenologia, ha voluto
delineare una filosofia trascendentale della coscienza e, simultaneamente,
una storia complessiva dello sviluppo culturale dell'umanità). Inoltre,
le figure rappresentano un materiale eterogeneo che riflette o rimanda
ai settori più disparati della vita dello spirito (gnoseologia, società,
storia della filosofia, religione, politica eccetera).
- Coscienza infelice. L'intero ciclo della fenomenologia si può vedere
riassunto in una delle sue figure particolari, che non per nulla è
diventata la più celebre: quella della coscienza infelice. La coscienza
infelice è quella che non sa di essere tutta la realtà e che perciò si
ritrova scissa in differenze, opposizioni o conflitti dai quali è
internamente dilaniata (come accade nella coscienza religiosa medioevale) e
dai quali esce solo tramite «la certezza di essere ogni realtà» (per
l'illustrazione analitica di questa ed altre figure vedi il testo).
Logica e filosofia della natura:
- La logica è la scienza dell'Idea «pura» (vedi) o dell'Idea «in se e
per sé», cioè lo studio dell'Idea considerata nel suo essere implicito e
nel suo graduale esplicarsi, ma a prescindere dalla sua concreta
realizzazione nella natura e nello spirito. In quanto tale la logica
esamina i «concetti» (vedi) o le « categorie» (vedi) che formano il
programma o l'impalcatura originaria del mondo. Essa si divide in logica
dell'essere, dell'essenza e del concetto (per le articolazioni
interne vedi il testo).
- I concetti o le categorie di cui tratta la logica di Hegel non sono
pensieri soggettivi, ai quali la realtà rimanga estranea e contrapposta,
ma pensieri oggettivi che esprimono la realtà stessa nella sua essenza.
- Posizioni del pensiero rispetto all'oggettività. Per evidenziare meglio
il suo modo di intendere il rapporto pensiero-essere, concetto-realtà,
Hegel, nell'Enciclopedia (paragrafo 26-78), fa una rassegna delle principali
posizioni del pensiero logico rispetto all'oggettività, distinguendo:
1) una posizione di tipo realistico-ingenuo, la quale pensa di conoscere
«ciò che gli oggetti veramente sono» (paragrafo 26);
2)una posizione di tipo empiristico-criticistico, la quale fa della
rappresentazione la misura dell'oggettività, riducendo tuttavia la
realtà vera delle cose ad una x impenetrabile al pensiero, che, nel
caso di Kant, prende la forma di una fantomatica «cosa in sé»;
3) una posizione di tipo fideistico, la quale prende la forma di un
sapere immediato che pretende di «saltare» (contro ogni scetticismo)
dal soggetto all'oggetto, dal finito all'infinito, risolvendosi in una
teoria che « si contrappone al filosofare» (paragrafo 64, nota). A tutte
queste posizioni Hegel contrappone l'esigenza di un pensiero che non sia
astrattamente separato dalla realtà, ma si identifichi con la realtà
stessa - e come tale risulti speculativamente dimostrabile.
- L'identità fra logica e metafisica discende dalla posta equazione
ragione = realtà (vedi). Equazione in virtù di cui lo studio del
pensiero (logica) equivale di fatto allo studio dell'essere (metafisica):
« La Logica coincide perciò con la Metafisica, con la scienza delle cose
poste in pensieri; i quali pensieri perciò appunto si tennero atti ad
esprimere le essenze delle cose» (Enc., paragrafo 24).
- Suddivisioni della logica. Hegel articola la sua logica in tre momenti
fondamentali: la dottrina dell'essere (vedi), la dottrina dell'essenza
(vedi) e la dottrina del concetto (vedi).
- La dottrina dell'essere parte dall'essere, che è il concetto più povero ed
astratto, e studia le categorie di qualità, quantità e misura.
- La dottrina dell'essenza prende in considerazione l'essenza, che
rappresenta l'auto-ripiegarsi e l'auto-riflettersi dell'essere su se
medesimo, ovvero quell'essere mediato e approfondito che Hegel definisce
come «la verità dell'essere» (Logica, 2, pagina 5). La logica dell'essenza
studia:
a) l'essenza come ragione dell'esistenza;
b) il fenomeno;
c) la realtà in atto.
In essa si mostra come il fenomeno (Erscheinung) non sia mera parvenza, ma
la manifestazione o l'apparizione piena e adeguata dell'essenza
(« l'essenza è quel che esiste» , Enc., paragrafo 131 ) e come la
realtà in atto (o « realtà effettiva», come traduce V. Verra) sia l'unità
dell'essenza e dell'esistenza, cioè dell'interno e dell'esterno.
- La dottrina del concetto prende in esame il concetto, cioè l'essere, che
dopo essersi auto-riflesso nell'essenza, si pone come soggetto o spirito.
In altri termini, il concetto di cui parla Hegel non è il concetto
dell'intelletto, diverso dalla realtà e opposto ad esso, ma il concetto
della ragione, ossia « lo spirito vivente della realtà»
(Enc., paragrafo 162). La logica del concetto studia dapprima il
concetto soggettivo (cioè la soggettività in sé o il concetto quale si
manifesta in se stesso, nel giudizio e nel sillogismo), poi « l'oggetto»
(cioè la soggettività oggettivata, quale si manifesta negli aspetti o nelle
categorie fondamentali della natura) e infine «l'Idea» (vedi) che, come
sappiamo, è l'unità di soggetto-oggetto, ideale e reale, ovvero l'Assoluto
in atto.
- La filosofia della natura è quella «considerazione teoretica, e cioè
pensante, della natura» (Enc., paragrafo 246) che ha come oggetto di studio
l'idea nella sua estrinsecazione spazio-temporale. Essa si divide in
meccanica, fisica e fisica organica.
Filosofia dello spirito:
- La filosofia dello spirito, che Hegel definisce « la più concreta delle
conoscenze, e perciò la più alta e difficile» (Enc., paragrafo 377), è lo
studio dello Spirito (vedi) considerato come libertà (vedi) e secondo la
triade di spirito soggettivo (vedi), oggettivo (vedi) e assoluto (vedi).
- Libertà. è « l'essenza dello spirito» (Enc., paragrafo 382), in quanto
essere indipendente ed auto-producentesi: « Lo spirito... è proprio questo
avere il suo centro in se stesso... La materia ha la sua sostanza fuori
di sé; lo spirito invece è l'esser presso di sé, e ciò appunto è la
libertà... », « L'occupazione dello spirito è quella di prodursi, di farsi
oggetto di sé, di sapere di sé; così esso è per se stesso. Le cose della
natura non sono per se stesse; perciò esse non sono libere. Lo spirito
produce, realizza se stesso in conformità del suo sapere di sé: esso fa sì
che ciò che esso sa di sé, anche si realizzi» (Lezioni di filosofia della
storia, 1, pagine 38-39). Ovviamente, dire che lo Spirito è libertà
significa anche dire (vedi Fichte) che esso è sforzo di auto-liberazione,
ossia lotta contro gli ostacoli che ne limitano l'attività.
- Lo spirito soggettivo è lo spirito individuale, considerato nel suo
lento emergere dalla natura e nel suo progressivo porsi come libertà. Lo
spirito soggettivo si articola in anima (oggetto dell'antropologia),
coscienza (oggetto della fenomenologia) e in spirito in senso stretto
(oggetto della psicologia, che studia l'uomo come conoscenza azione e
libertà).
- Lo spirito oggettivo è lo spirito fattosi «mondo» a livello sociale,
ossia in quell'insieme di determinazioni sovra-individuali che Hegel
raccoglie sotto il concetto di diritto (vedi) in senso lato.
- Diritto (Recht). In Hegel questo termine « è adoperato per indicare
tanto una parte del sistema - il diritto astratto, che è poi il diritto
propriamente detto, il diritto, per intenderci, dei giuristi, - quanto il
sistema nel suo complesso, comprendente, oltre il diritto in senso
stretto, tutte le materie tradizionalmente comprese nella filosofia
pratica (ovvero, economia, politica e morale). Quando Hegel dice che
"il sistema del diritto è il regno della libertà realizzata" usa il termine
in senso ampio e improprio, tanto da comprendervi, oltre il diritto in
senso proprio, la moralità e l'eticità. "Diritto" dunque indica, secondo i
contesti, ora una parte ora il tutto" (N. Bobbio). Ovviamente, questa
schema «comporta poi o, quanto meno, si traduce in uno smembramento e in
una ridistribuzione del tutto particolare delle diverse discipline
giuridiche e delle loro parti» (V. Verra).
- Il Diritto astratto (abstrakte Recht) o « formale» concerne l'esistenza
esterna della libertà delle persone, concepite come puri soggetti
astratti di diritto e si identifica cor il diritto privato e con una
parte di quello penale (mentre il diritto di famiglia, altri elementi del
diritto penale, il diritto pubblico e quello internazionale rientrano
nella sfera dell'eticità). Il diritto astratto si articola nei momenti
della «proprietà», del «contratto» e del «diritto contro il torto,
(vedi il testo).
- La moralità (Moralität) è la sfera della volontà soggettiva, quale si
manifesta nell'azione. Le sue articolazioni interne sono: « il
proponimento» « l'intenzione e i benessere» « il bene e il male».
Secondo Hegel il dominio della moralità è caratterizzato dalla
separazione fra la soggettività, che deve realizzare il bene, ed il
bene che deve essere realizzato. Da ciò la contraddizione fra essere
e dover-essere che è tipica della morale, soprattutto di quella kantiana,
che Hegel critica per la sua formalità ed astrattezza, cioè per la sua
mancanza di contenuti concreti e per la sua impotenza a realizzarsi
nella realtà.
- Per eticità (Sittlichkeit, da Sitte = costume, corrispondente al greco
ethos, costume) Hegel intende la moralità sociale, ovvero la realizazione
del bene in quelle forme istituzionali che sono la famiglia (vedi), la
società civile (vedi) e lo Stato (vedi). Essendo la più alta manifestazione
dello spirito oggettivo e della volontà di libertà che ne sta alla base,
l'eticità rappresenta «il concetto della libertà divenuto mondo
sussistente e natura dell'autocoscienza» (Lin., paragrafo 142).
- La famiglia è il primo momento dell'eticità, quello in cui il rapporto
immediato e naturale fra i sessi assume la forma di un'«unità spirituale»
fondata sull'amore e sulla fiducia. La famiglia si articola nel matrimonio,
nel patrimonio e nell'educazione dei figli.
- La società civile (bügerliche Gesellschaft) è il secondo momento
dialettico dell'eticità e si identifica con quello spazio intermedio fra
l'individuo e lo Stato che coincide, di fatto, con la sfera
economico-sociale e giuridico-amministrativa del vivere insieme, ovvero
con il luogo di scontro, ma anche di incontro, di interessi «particolarri»
e « indipendenti», i quali si trovano a dover coesistere fra
di loro. Infatti Hegel, pur parlando della società civile come di un
«sistema dell'atomistica», la definisce come una «connessione universale
e mediatrice di estremi indipendenti e dei loro interessi particolari» e
come uno «Stato esterno» (Enc., paragrafo 523), ovvero come un sistema di
interessi privati regolati da organi pubblici che si impongono
dall'esterno e nell'ambito di una universalità ancora «formale» (Enc.,
paragrafo 517). Stato «esterno» che il filosofo, per sottolineare il
carattere di frazionamento e di scissione che è tipico della società civile,
chiama anche della «necessità» o dell'«intelletto» (come si è visto,
quest'ultimo è l'organo della « separazione»). La società civile, come si
è visto, si divide nel sistema dei bisogni, nell'amministrazione della
giustizia, nella polizia e nelle corporazioni (cfr. il testo). N.B.
1) Per evitare una serie di equivoci interpretativi che gravano tuttora su
tale concetto, è bene tenere presenti le seguenti puntualizzazioni di N.
Bobbio: « Sulla società civile è stato versato in questi ultimi anni
dopo quasi un secolo di abbandono un profluvio di scritti. Ma sulla scia
di un celeberrimo passo di Marx che identifica la società civile di
Hegel con l'insieme dei rapporti materiali dell'esistenza e propone di
cercare nella economia politica l'anatomia della società civile, si è
finito per vedere nella nuova categoria della società civile soprattutto
l'espediente di cui Hegel si servì per introdurre nel sistema i problemi
dell'economia. Ma l'analisi dei bisogni, del lavoro e delle classi occupa,
com'è noto, solo la prima parte della sezione. La seconda, che è
oltretutto la più lunga, e anche la terza, trattano temi in gran parte
giuridici. La società civile hegeliana non è tanto la descrizione del
sistema dell'economia borghese e dei rapporti di classe, quanto piuttosto
la descrizione del modo con cui nello stato borghese i rapporti
economici sono giuridicamente regolatti». Detto altrimenti:
«l'identificazione tra società civile e luogo dei rapporti economici, o,
che è lo stesso, la distinzione tra società civile e stato come
distinzione tra società economica e società politica è opera di Marx e
non di Hegel: riferita, come accade spesso, a Hegel, è puramente e
semplicemente una deformazione del suo pensiero» (opera citata, pagine 58
e 163). N.B. 2) Nel pensiero anteriore ad Hegel, in particolare nel
giusnaturalismo, la società civile si contrapponeva a «società naturale»
ed era sinonimo di «società politica» e quindi di «Stato». Nel
Sei-Settecento per società civile si comincia anche ad intendere la
società «civilizzata» in antitesi alla società «selvaggia». Uso che
diviene predominante in Rousseau. Come si vede, si tratta di significati
distanti da quello hegeliano, il quale possiede dunque una sua spiccata
originalità. Ciò non toglie che prima di Hegel una nozione di società
civile prossima alla sua sia stata sostenuta ad esempio da August Ludwig
Schlözer (1793) e poi da Anselm Feuerbach (Antihobbes, 1798, capitolo 3).
- Lo Stato (Staat) è il momento culminante dell'eticità, ossia la
ri-affermazione dell'unità della famiglia (tesi) al di là della
dispersione della società civile (antitesi). Esso rappresenta quindi una
sorta di famiglia in grande, nella quale l'ethos di un popolo esprime
consapevolmente se stesso, superando i particolarismi della società
civile in vista del bene comune: «Lo Stato è la sostanza etica
consapevole di sé, la riunione del principio della famiglia e della
società civile» (Enc., paragrafo 537).
- Per Stato etico si intende abitualmente la concezione hegeliana dello
Stato come incarnazione suprema della moralità sociale e promotore del
bene comune. Concezione che si differenzia storicamente da quella
liberale e da quella democratica (vedi il testo) e che si configura come
una forma di organicismo (vedi).
- Per concezione organica dello Stato si intende la prospettiva
anti-atomistica ed anti-individualistica che è propria della filosofia
politica di Hegel, secondo cui «lo stato è un'unione e non un'associazione,
un organismo vivente e non un prodotto artificiale, una totalità e non
un aggregato, un tutto superiore e anteriore alle sue parti, e non
una somma di parti indipendenti tra loro» (N. Bobbio). In virtù di questa
prospettiva, il filosofo tedesco - il quale si compiace in più luoghi di
riprendere l'affermazione aristotelica che « secondo natura il popolo
(nel testo greco è polis) è precedente al singolo» (Fol., 1253a) - ritiene
che non sia l'individuo a fondare lo Stato, ma lo Stato a fondare
l'individuo.
- Per Costituzione Hegel intende «l'organizzazione dello Stato»
(Lin., paragrafo 271, Enc., paragrafo 539). Organizzazione che, a suo
giudizio, non è il frutto di una elucubrazione a tavolino, ma un'entità
che sgorga dalla vita storica di un popolo. Hegel identifica
la costituzione «razionale» con la monarchia costituzionale moderna,
ossia con un organismo che prevede una serie di poteri distinti, ma non
divisi, tra di loro. Tali poteri sono: il legislativo, il governativo
e quello principesco (v. il testo).
- La storia del mondo (Weltgeschichte) è «lo svolgimento dell'idea
universale dello spirito» (Enc., paragrafo 536) attraverso una serie di
gradi razionali e necessari che obbediscono ad un piano provvidenziale
immanente. In concreto, la storia, che ha come soggetto lo Spirito del
mondo incarnato nei vari «spiriti dei popoli» ( Volksgeister), è una
successione di forme statali che tendono alla realizzazione della libertà.
I tre momenti fondamentali di essa sono il mondo orientale (dove uno solo
è libero), il mondo greco-romano (dove alcuni sono liberi) e il mondo
cristiano-germanico (dove tutti sono liberi, ossia soggetti di diritto).
- Astuzia della Ragione (List der Vernunft). è forse il concetto più
caratteristico della filosofia della storia di Hegel. Con esso, il filosofo
ha voluto alludere al fatto che l'Idea universale fa agire nella storia le
passioni degli uomini come suoi strumenti e le fa logorare e consumarsi per
i propri fini: «L'Idea paga il tributo dell'esistenza e della caducità non
di sua tasca ma con le passioni degli individui. Cesare doveva compiere
quello che era necessario per rovesciare la decrepita libertà; la sua
persona perì nella lotta ma quello che era necessario restò... »
(Filosofia della storia, pagina 98).
- Lo spirito assoluto è il momento in cui l'idea giunge alla piena coscienza
della propria infinità o assolutezza (cioè del fatto che tutto è Spirito e
non vi è nulla al di fuori dello Spirito). Tale auto-sapersi assoluto
dell'Assoluto avviene attraverso l'arte (vedi), la religione (vedi) e
la filosofia (vedi).
- L'arte è il momento in cui lo Spirito acquista coscienza di se medesimo
nella forma dell'intuizione sensibile (figure, parole, musica eccetera),
vivendo in modo immediato ed intuitivo quella fusione fra soggetto ed
oggetto, spirito e natura che la filosofia idealistica teorizza tramite
la mediazione dei concetti. Ciò accade perché di fronte all'esperienza
del bello artistico (si pensi ad esempio ad una statua greca), spirito
e natura vengono recepiti come un tutt'uno, in quanto nella statua
l'oggetto (il marmo) è già natura spiritualizzata, cioè la manifestazione
sensibile di un messaggio spirituale, ed il soggetto (l'idea artistica) è
già spirito naturalizzato, ovvero concetto incarnato e reso visibile. A
seconda che vi sia squilibrio oppure equilibrio fra contenuto e forma,
ossia fra messaggio spirituale e forma sensibile, Hegel distingue fra
arte simbolica (squilibrio per povertà di contenuto), arte classica
(perfetto equilibrio) e arte romantica (squilibrio per eccesso di contenuto).
- La religione è il momento in cui lo Spirito acquista coscienza di se
medesimo nella forma della rappresentazione, intendendo per quest'ultima
un modo di pensare: 1) che sta a metà strada fra l'intuizione sensibile ed
il concetto: «le rappresentazioni in genere possono essere considerate
come metafore dei pensieri e concetti» (Enc., paragrafo 3);
2) che procede in modo adialettico, ovvero giustapponendo le proprie
determinazioni, quasi fossero indipendenti le une dalle altre.
Ad esempio la rappresentazione cristiana di Dio-Padre che crea il
mondo è la rappresentazione, ossia l'ipostatizzazione metaforica
(frutto di immagini giustapposte) del fatto che la natura costituisce un
momento dialettico della vita dello spirito. Lo sviluppo della coscienza
religiosa inizia con le religioni naturali e culmina nel cristianesimo,
religione assoluta in cui Dio appare finalmente come puro spirito, sia
pure ancora nella forma imperfetta della rappresentazione.
- La filosofia è «l'Idea che pensa se stessa» (Enc., paragrafo 574) e «la
verità assoluta e intera» (ivi, paragrafo 236), cioè il momento in cui
l'Assoluto acquista coscienza di sé in forma concettuale. Per questa sua
natura, la filosofia ha i propri oggetti in comune con la religione
«perché oggetto di entrambe è la verità, e nel senso altissimo della
parola - in quanto cioè Dio, e Dio solo, è la verità», anche se essa,
a differenza della religione (vedi), «manifesta l'esigenza di mostrare
la necessità del suo contenuto» e di «provare l'essere e i caratteri
dei suoi oggetti» (ivi, paragrafo 1). In quanto «considerazione pensante
degli oggetti» (ivi, paragrafo 2), la filosofia ha come fine specifico
e scopo supremo la dimostrazione della razionalità del reale: «Comprendere
ciò che è, è il compito della filosofia, poiché ciò che è, è la ragione»
(Lin., Prefazione). Di conseguenza, essa risulta simile alla nottola
di Minerva, che «inizia il suo volo soltanto sul far del crepuscolo» (ivi).
N.B. Vista in rapporto all'epoca in cui sorge, la filosofia può essere
definita come il proprio tempo «appreso in pensieri» (ivi). Tempo di cui
essa rappresenta «il fiore più elevato» (Lez. sulla fil. di storia,
Introduzione, B, 1, C).
- La storia della filosofia è l'insieme delle tappe necessarie attraverso
cui, dai Greci ad Hegel, la verità dell'Idea è andata progressivamente
manifestando se stessa. Infatti, al di là della molteplicità
apparentemente caotica e accidentale delle filosofie, vi è
l'auto-costituirsi di quell'unica vera Filosofia che procede dallo Spirito
e in cui lo Spirito perviene finalmente alla propria compiuta
consapevolezza: «l'artefice di questo lavoro di millenni è quell'Uno
spirito vivente, la cui natura pensante consiste nel recarsi alla
coscienza ciò ch'esso è», «La storia della filosofia mostra, da una parte,
che le filosofie, che sembrano diverse, sono una medesima filosofia in
diversi gradi di svolgimento; dall'altra, che i princìpi particolari, di
cui ciascuno è a fondamento di un sistema, non sono altro che rami di un
solo e medesimo tutto. La filosofia, che è ultima nel tempo, è insieme
il risultato di tutte le precedenti e deve contenere i princìpi di
tutte: essa è perciò - beninteso, se è davvero una filosofia, - la più
sviluppata, ricca e concreta» (Enc., paragrafo 13).
STORIA DELLA FILOSOFIA
di Nicola Abbagnano
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
VOLUME TERZO
CAPITOLO 7: Schopenhauer ed Herbart
2. Herbart.
2.1. La metafisica.
Un'altra forma di opposizione ad Hegel è rappresentata dal filosofo e
pedagogista Johann Friedrich Herbart. Nato ad Oldenburg nel 1776, morto
a Gottinga nel 1841, era stato scolaro a Jena di Fichte e di Schiller. Dal
primo fu conquistato alla filosofia e dal secondo assorbì l'ideale di una
piena, armonica, onnilaterale formazione umana, e il concetto che un tale
ideale è allo stesso tempo di natura etica ed estetica. Le sue opere
fondamentali sono: l'Introduzione alla filosofia 1813); La Psicologia come
scienza (1824-1825) e la Metasica generale (1828-1829). Le sue opere
pedagogiche (Pedagogia generale, 1806 e Lezioni di pedagogia, 1835) hanno
esercitato un vasto e durevole influsso sulla storia e la pratica
dell'educazione in Germania.
L'idealismo concepiva lo spirito come autocreazione, tendeva a vanificare
l'importanza degli elementi esterni alla coscienza, o a scorgervi solo
termini dialetticamente opposti e ben presto eliminati, giacché ogni
contraddizione è alfine superata nell'unità suprema dell'Autocoscienza.
La Teoria dei Reali.
Per Herbart invece l'alterità, l'estraneità è caratteristica essenziale e
ineliminabile della realtà, che è un complesso di reali, necessariamente
molteplici e nella cui molteplicità, debitamente riconosciuta e
sufficientemente penetrata, può soltanto trovarsi la soluzione delle
contraddizioni che, anche secondo Herbart, caratterizzano la nostra
esperienza. La metafisica di Herbart segna dunque un ritorno all'impostazione
leibniziana, con qualche maggior accentuazione dei limiti che la nostra
conoscenza della realtà effettiva necessariamente incontra, secondo
l'esigenza critica kantiana: «Esistono effettivamente fuori di noi, afferma
Herbart, una quantità di enti, la cui natura semplice e propria ci è
sconosciuta, ma sulle cui condizioni interne ed esterne noi possiamo
acquistare una somma di conoscenze che può aumentare all'infinito».
Una conoscenza metafisica siffatta è possibile, secondo Herbart, in quanto
essa trova una sua verifica nello studio accurato dell'esperienza, sia
interna (psicologia) che esterna (filosofia della natura), e ciò in quanto i
rapporti fra i reali sono adombrati nei rapporti fra i fenomeni, anche se
l'essenza dei reali ci resta nascosta. I reali sono esistenze
autosufficienti ed autonome, fra i quali non possono istituirsi che rapporti
accidentali: essi infatti reagiscono con un atto di autoconservazione ad ogni
rapporto più impegnativo, ad ogni urto con altri reali. Anche le
rappresentazioni sono atti del genere, con cui certi reali semplici o anime
reagiscono all'urto della realtà esterna. I rapporti di attrazione o
repulsione che sussistano fra rappresentazioni sono i medesimi che sussistono
fra i reali corrispondenti (come risultato del loro stato interno e dei
rapporti accidentali).
2.2. La psicologia.
Le rappresentazioni e le loro forme.
Dalle tesi fondamentali della metafisica risulta immediatamente che le
rappresentazioni non possono essere altro che le autoconservazioni di un
ente semplice, detto anima. Posto ciò, l'idea capitale della psicologia è
la seguente: « le rappresentazioni, compenetrandosi a vicenda nell'anima,
che è una, si impediscono in quanto opposte e si unificano in una forza
comune in quanto non sono opposte». Tutta la vita dell'anima si lascia
spiegare, secondo Herbart, da questa idea fondamentale. Due rappresentazioni
opposte tendono a sparire perché si bloccano reciprocamente, ma quando una
di esse ceda o venga resa inefficiente da qualche altra rappresentazione,
la rappresentazione contraria risorge. In altri termini le rappresentazioni
si trasformano, mediante la loro pressione reciproca, in una tendenza a
rappresentare, che prende il nome di appetito, vita, stimolo, attività reale,
volontà eccetera. Non esistono quindi facoltà diverse nell'anima. Né il
sentimento, né la volontà sono nulla fuori delle rappresentazioni e accanto
ad esse. Esse consistono soltanto in stati mutevoli delle rappresentazioni
e sono piuttosto «concetti di classe» secondo i quali si ordinano i fenomeni
osservati.
Questa dottrina implica che le rappresentazioni sono forze e come forze
agiscono nell'animo umano. Herbart parla infatti di una statica e di una
meccanica dello spirito e introduce il calcolo matematico per determinare
il comportamento delle rappresentazioni, giungendo a formule che dovrebbero
esprimere le leggi generali dei fenomeni psichici. L'introduzione del
calcolo nella psicologia doveva poi essere messa a partito dagli sviluppi
ulteriori di questa scienza.
2.3. L'arte, la morale e la pedagogia.
L'estetica.
Sotto il nome di estetica, Herbart comprende la teoria dell'arte bella e la
morale. Bello è tutto ciò che è oggetto di approvazione; la teoria del bello,
l'estetica, comprende perciò ogni disciplina genericamente valutativa.
Còmpito dell'estetica è quello di individuare ed esporre ordinatamente i
concetti-modello o idee, che devono essere depurati da tutti gli elementi
soggettivi e mutevoli e quindi messi al di sopra delle emozioni e degli
appetiti. Lidea del bello non si identifica perciò col concetto di utile
o di gradevole. La caratteristica del bello artistico è che esso piace
spontaneamente e che suscita immediatamente effetti estremamente vari, ma
passeggeri, che vengono fissati o resi permanenti dal giudizio estetico.
L'etica.
Nel dominio morale, i concetti-modello o idee esprimono relazioni fra volontà
diverse, intendendosi per volontà non già facoltà dell'anima, ma atti singoli
e individualizzati del volere. La prima idea morale è quella della libertà
interna che esprime l'armonia tra la volontà e il giudizio che su di essa si
formula. Quest'armonia è il consenso tra l'atto e la valutazione dell'atto,
consenso che «piace assolutamente», e che è la libertà interna del soggetto
agente.
La seconda idea morale è quella della perfezione. La terza idea morale è
quella della benevolenza. Su di essa è fondato il pensiero capitale della
morale cristiana, quello dell'amore. La quarta idea è quella del diritto che
si origina come soluzione del conflitto fra volontà di persone diverse.
La quinta ed ultima idea morale è quella della retribuzione o equità, la quale
nasce dal fatto che un'azione non retribuita implica un perturbamento, che
viene eliminato mediante la retribuzione.
La dottrina della virtù concerne la conformità della condotta umana, nella sua
unità personale, a tutte insieme le idee morali. Ma l'esperienza sola
consente di stabilire i limiti e le modalità della realizzazione delle idee
morali nelle molteplici vicende della vita. La dottrina della virtù dipende
perciò dalla psicologia, che le fornisce la conoscenza di ciò che l'uomo
empiricamente è; e in quanto la psicologia dipende dalla metafisica, dipende
indirettamente anche da questa. I due rami principali della dottrina della
virtù sono la politica e la pedagogia. La politica assume a suo fondamento
l'ideale del diritto, senza la quale non può concepirsi nessuna struttura
sociale che sia conforme a ragione.
La pedagogia.
La pedagogia si fonda su tutte le idee morali, ma dà maggior risalto a quella
della perfezione, in quanto ne fa una continua applicazione. Accanto
all'etica che, con le idee morali, fornisce alla pedagogia i fini, ai quali
dev'essere indirizzata l'educazione, Herbart pone la psicologia come scienza
dei mezzi dell'educazione stessa.
Capitolo settimo: Glossario e riepilogo
- «Il mondo come volontà e rappresentazione». Schopenhauer intitola in questa
maniera il suo capolavoro «perché come il mondo è da un lato, in tutto e per
tutto rappresentazione, così è, dall'altro lato, in tutto e per tutto,
volontà».
- La rappresentazione (Vorstellung) è la realtà in quanto oggetto di conoscenza
da parte di un soggetto «tutto ciò che esiste per la conoscenza - adunque
questo mondo intero - è solamente oggetto in rapporto al soggetto, intuizione
di chi intuisce; in una parola, rappresentazione», «Tutto... deve
inevitabilmente aver per condizione il soggetto, ed esiste solo per il
soggetto. Il mondo è rappresentazione». Schopenhauer fa coincidere l'ambito
della rappresentazione con l'ambito del fenomeno, in senso kantiano. Tuttavia,
tale concetto, oltre che avere una valenza più marcatamente
coscienzialistico-soggettivistica (ossia di entità che esiste dentro la
coscienza) presenta, in Schopenhauer, dei connotati metafisici ed
orientaleggianti estranei al kantismo. Tale è la dottrina del fenomeno come
di un'illusione che si frappone tra noi e la cosa in sé, a guisa di un velo
(il «velo di Maya» di cui parla la sapienza indiana) che copre il volto vero
delle cose.
- La cosa in sé di cui parla Schopenhauer non è un concetto limite che serva
soprattutto a rammentarci i confini della conoscenza, ma una realtà assoluta
che nasconde dietro l'ingannevole trama del fenomeno. Realtà che Schopenhauer,
a differenza di Kant, ritiene conoscibile. Infatti, argomenta il filosofo, se
noi fossimo soltanto conoscenza e rappresentazione, ovvero un'«alata testa
dangelo» (par. 18) non potremmo mai uscire dal mondo fenomenico, ossia da una
rappresentazione puramente esteriore di noi e delle cose. Ma poiché siamo
dati a noi medesimi non solo come rappresentazione, ma anche come corpo, non
ci limitiamo a vederci dal di fuori, bensì ci viviamo anche dal di dentro,
godendo e soffrendo. Ed è proprio questa esperienza di base che permette
all'uomo di squarciare il velo del fenomeno e di rendersi conto che la cosa
in sé è nient'altro che la volontà di vivere (vedi).
- La Volontà di vivere (Wille zum Leben) è il noumeno del mondo, ovvero
l'essenza nascosta dell'universo: «Non soltanto in quei fenomeni che sono
affatto simili al suo proprio - negli uomini e negli animali - egli dovrà
riconoscere, come più intima essenza, quella medesima volontà; ma la
riflessione prolungata lo condurrà a conoscere anche la forza che ferve e
vegeta nella pianta, e quella per cui si forma il cristallo, e quella che
volge la bussola al polo, e quella che scocca nel contatto di due metalli
eterogenei, e quella che si rivela nelle affinità elettive della materia,
come repulsione ed attrazione, separazione e combinazione... (par. 21).
Poiché ciò che la volontà sempre vuole è la vita, puntualizza Schopenhauer,
«è tutt'uno, e semplice pleonasmo, quando invece di "volontà" senzaltro
diciamo "volontà di vivere"» (par. 54). Essendo al di là del fenomeno e delle
sue forme costitutive (lo spazio, il tempo e la causa), la Volontà è unica,
aspaziale, atemporale ed incausata (per l'illustrazione di questi attributi
vedi il testo) e si configura, in sostanza, come un eterno e cieco impulso,
di cui tutto ciò che esiste è manifestazione od oggettivazione.
N.B. Il concetto di volontà in Schopenhauer non coincide con il concetto di
volontà cosciente, ma con quello, più generale, di energia o impulso. Di
conseguenza, la Volontà cosmica può essere sia inconsapevole (come accade
nella materia) sia consapevole (come accade nell'uomo).
- Schopenhauer considera le idee (nel senso platonico del termine) come la
prima ed immediata oggettivazione della Volontà, ovvero come l'insieme degli
archetipi delle cose: «Per idea intendo adunque ogni determinato ed immobile
grado di obiettivazione della Volontà, in quanto esso è cosa in sé, e sta
quindi fuor della pluralità. Cotesti gradi stanno ai singoli oggetti, come
le loro forme eterne, o i loro modelli» (par. 25).
- Dolore, piacere e noia. Dire che l'essere è Volontà equivale a dire,
secondo Schopenhauer, che l'essere è costitutivamente dolore. Infatti, volere
significa desiderare, e desiderare significa trovarsi in uno stato di
tensione e di mancanza, che nessun appagamento può colmare. Tant'è che «per
un desiderio che venga appagato, ne rimangono almeno dieci insoddisfatti».
Del resto, una soddisfazione che plachi temporaneamente i desideri, precipita
l'uomo in una situazione altrettanto negativa, che è quella della noia.
O il dolore o la noia: ecco il destino dell'uomo. L'esistenza del piacere
non contraddice affatto questa verità. Infatti, ciò che gli uomini
chiamano piacere è nient'altro che una cessazione momentanea dal dolore,
ossia lo scarico da uno stato preesistente di tensione. Momento cui
succedono inevitabilmente nuovi desideri (e quindi nuovi dolori) oppure la
noia. Da ciò il pessimismo (vedi).
- Il pessimismo metafisico di Schopenhauer deriva dalla constatazione che
essere = dolore, in quanto l'universo è solo Volontà inappagata, ossia il
teatro di una vicenda di cui la sofferenza costituisce la legge immanente.
- L'amore, inteso come eros per Schopenhauer è nient'altro che uno
stratagemma di cui si serve il genio della specie per sedurre l'individuo
e indurlo alla perpetuazione della vita. Di conseguenza, l'amore
procreativo va condannato.
- L'ottimismo, in tutte le sue forme (metafisiche, sociali e storiche),
viene definito da Schopenhauer come un pensare «iniquo» e come «un amaro
scherno dei mali senza nome patiti dall'umanità» (par. 59).
- Le vie di liberazione dal dolore sono le varie tappe attraverso cui l'uomo
cerca di liberarsi dalla volontà di vivere e si identificano con
l'arte (vedi), la morale (vedi) e l'ascesi (vedi).
- Schopenhauer respinge il suicidio poiché vede in esso una malcelata forma
di attaccamento alla vita («il suicida vuole la vita, ed è solo malcontento
delle condizioni che gli sono toccate») che, per di più, sopprime
soltanto una manifestazione fenomenica della Volontà e non la Volontà in se
stessa.
- L'arte, per Schopenhauer, è la contemplazione delle idee (vedi),
ossia la conoscenza pura e disinteressata degli aspetti universali ed
immutabili della realtà. Di conseguenza, a differenza della storia, la quale
si dirige a ciò che è spazio-temporalmente delimitato, l'arte, che è
opera del genio, riproduce «l'essenziale e il permanente in tutti i fenomeni
del mondo» (par. 36). Proprio per questo suo carattere contemplativo, e
per questa sua capacità di dirigersi verso un mondo di forme non toccate
dalla « ruota del tempo», l'arte libera l'individuo dalla catena dei
desideri e dei bisogni, elevandolo al di sopra del dolore e del tempo.
Tuttavia, la liberazione prodotta dalle varie arti, al culmine delle
quali Schopenhauer colloca la musica (vedi il testo), ha pur sempre un
carattere parziale e temporaneo, che coincide con i momenti fugaci e
preziosi in cui ha luogo: « Non diviene ella adunque per lui... un
quietivo della volontà; non lo redime per sempre dalla vita, ma solo per
brevi istanti, e non è ancor una via a uscir dalla vita, ma solo a volte
un conforto nella vita stessa... (par. 52).
- La morale, per Schopenhauer, non sgorga da un imperativo categorico
dettato dalla ragione, ma da un sentimento di pietà o di compassione nei
confronti del prossimo, ossia da una « partecipazione, immediata e
incondizionata, ai dolori altrui ».
La pietà etica si concretizza in due virtù cardinali: la giustizia e la
carità: «Questa pietà è l'unica base effettiva di una giustizia spontanea
e di ogni carità genuina» (I due problemi fondamentali della morale).
La giustizia, rappresentata dal principio neminem laede, consiste nel non
fare del male agli altri e perciò costituisce soltanto l'aspetto «negativo»
della pietà. La carità, che Schopenhauer riassume nel principio omnes,
quantum potes, juva, coincide con la volontà attiva di fare del bene al
prossimo, ossia con l'aspetto « positivo» della pietà.
- L'ascesi, che nasce dall'«orrore delluomo per l'essere», è l'esperienza
per la quale l'individuo, cessando di volere la vita ed il volere stesso,
si propone di estirpare il proprio desiderio di esistere, di godere e di
volere mediante una serie di accorgimenti (castità, umiltà eccetera) al
culmine dei quali sta il nirvana (paragrafi 68 e 71).
STORIA DELLA FILOSOFIA
di NICOLA ABBAGNANO
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
VOLUME TERZO.
CAPITOLO 8: Sören Kierkegaard.
1. Vita e scritti.
L'impianto anti-idealistico del filosofare kierkegaardiano.
L'opera di Kierkegaard non può essere certo ridotta a un momento della
polemica contro l'idealismo romantico. Sta di fatto però che molti temi
di essa costituiscono una precisa antitesi polemica ai temi di
quell'idealismo. La difesa della singolarità dell'uomo contro
l'universalità dello spirito; quella dell'esistenza contro la ragione;
delle alternative inconciliabili contro la sintesi conciliatrice della
dialettica; della libertà come possibilità contro la libertà come
necessità; e infine della categoria stessa della possibilità, sono punti
fondamentali della filosofia kierkegaardiana che nel loro insieme
costituiscono un'alternativa radicalmente diversa da quella sulla quale
l'idealismo romantico aveva indirizzato la filosofia europea. Si tratta
però di un'alternativa che rimase pressoché inoperante nella filosofia
dell'800 e che solo alla fine di questo secolo cominciò ad acquistare
risonanza dapprima nel pensiero teologico poi in quello filosofico.
Le vicende biografiche e intellettuali.
Sören Kierkegaard nacque in Danimarca a Copenhagen il 5 maggio 1813.
Educato da un padre anziano nel clima di una religiosità severa, si
iscrisse alla facoltà di teologia di Copenhagen, dove fra i giovani
teologi dominava l'ispirazione hegeliana. Nel 1840, dopo circa 10 anni
dal suo ingresso all'Università, si laureava con una dissertazione
Sul concetto dell'ironia con particolare riguardo a Socrate che
pubblicava l'anno seguente. Ma non intraprese la carriera di pastore alla
quale la sua laurea lo abilitava. Nel 1841-1842 fu a Berlino e ascoltò le
lezioni di Schelling, che v'insegnava la sua filosofia positiva, fondata
sulla distinzione radicale tra realtà e ragione. Dapprima entusiasta di
Schelling, Kierkegaard ne fu presto deluso. Dopo di allora, egli visse a
Copenhagen con un capitale lasciatogli dal padre, assorto nella
composizione dei suoi libri. Gli incidenti esteriori della sua vita sono
scarsi e apparentemente insignificanti: il fidanzamento, che egli stesso
mandò a monte, con Regina Olsen; l'attacco di un giornale umoristico, «Il
corsaro», di cui si dolse e si crucciò come di una persecuzione; la
polemica, che occupò gli ultimi anni della sua vita, contro l'ambiente
teologico di Copenhagen e specialmente contro il teologo hegeliano
Martensen. Kierkegaard moriva l'11 ottobre 1855.
Gli episodi spiacevoli cui si è fatto cenno hanno avuto, nella sua vita
interiore (come ne fa testimonianza il Diario) e nelle sue opere, una
risonanza profonda e apparentemente sproporzionata alla loro reale
entità. Kierkegaard parla nel Diario di un «grande terremoto» che si è
prodotto ad un certo punto nella sua vita e che lo ha costretto a mutare
il suo atteggiamento di fronte al mondo. Egli accenna soltanto vagamente
alla causa di questo rivolgimento («Una colpa doveva gravare su tutta
la famiglia, un castigo di Dio discendere su di essa; essa doveva
scomparire, cancellata come un tentativo mal riuscito dalla potente mano
di Dio»); e per quuanto i biografi si siano affaticati, indiscretamente
quanto inutilmente, a determinarla, è chiaro che essa rimane, dinnanzi
agli occhi dello stesso Kierkegaard, come una minaccia vaga e terribile
insieme.
La «scheggia» nelle carni.
Kierkegaard parla poi nel Diario, e ne parlò anche sul letto di morte, di
una «scheggia nelle carni» che egli è stato destinato a portare; e anche
qui, di fronte ala mancanza di ogni dato preciso, sta il carattere grave e
ossessionante della cosa. Fu appunto probabilmente questa scheggia nelle
carni che gli impedì di condurre in porto il suo fidanzamento con
Regina Olsen, che egli ruppe, dopo qualche anno, di sua spontanea
iniziativa. Anche qui nessun motivo preciso, nessuna causa determinata;
solamente il senso di una minaccia oscura e inafferrabile, ma paralizzante.
Perciò pure non intraprese la carriera di pastore né nessun'altra; e di
fronte alla sua stessa attività di scrittore dichiarò di porsi in «un
rapporto poetico», cioè in un rapporto di distacco e di lontananza:
distacco ancora accentuato dal fatto che egli pubblicò i suoi libri sotto
pseudonimi diversi, quasi a impedire ogni riferimento del loro contenuto
alla sua stessa persona. Questi elementi biografici vanno tenuti
continuamente presenti per la comprensione dell'atteggiamento filosofico
di Kierkegaard.
Le opere.
Ecco intanto le sue opere principali: Il concetto dell'ironia (1841);
Aut-Aut, di cui fa parte il Diario di un seduttore (1843); Timore e
tremore (1843); La ripetizione (1843); Briciole filosofiche (1844);
Il concetto dell'angoscia (1844); Prefazione (1844); Stadi nel cammino
della vita (1845); Postilla conclusiva non scientica (1846); Il punto di
vista sulla mia attività di scrittore (postumo ma composto nel 1846-1847);
La malattia mortale (1849). Kierkegaard è anche autore di numerosi
Discorsi religiosi; e pubblicò nel 1855 (maggio-settembre) il periodico
«Il momento», nel quale trovarono posto i suoi attacchi contro la
chiesa danese.
2. L'esistenza come possibilità e fede.
Il sentimento paralizzante del possibile.
Una prima caratteristica dell'opera e della personalità di Kierkegaard è
l'aver cercato di ricondurre la comprensione dell'intera esistenza umana
alla categoria della possibilità e di aver messo in luce il carattere
negativo e paralizzante della possibilità come tale. Già Kant aveva
riconosciuto, a fondamento di ogni potere umano, una possibilità reale
o trascendentale; ma di tale possibilità egli aveva messo in luce l'aspetto
positivo, che ne fa un'effettiva capacità umana, limitata bensì, ma che
ritrova, nei limiti stessi, la sua validità e il suo impegno di
realizzazione. Kierkegaard scopre e mette in luce, con un'energia mai
prima raggiunta, l'aspetto negativo d'ogni possibilità che entri a
costituire l'esistenza umana. Ogni possibilità è infatti, oltre che
possibilità-che-sì sempre anchepossibilità-che-non: implica la nullità
possibile di ciò che è possibile, quindi la minaccia del nulla. Kierkegaard
vive, e scrive, sotto il segno di questa minaccia. Si e visto come tutti i
tratti salienti della sua vita si siano rivestiti, ai suoi stessi occhi, di
un'oscurità problematica. I rapporti con la famiglia, l'impegno di
fidanzamento, la sua stessa attività di scrittore, gli appaiono carichi di
alternative terribili, che finiscono per paralizzarlo. Egli stesso ha
vissuto in pieno la figura così potentemente descritta nelle pagine finali
del Concetto dell'angoscia: quella del discepolo dell'angoscia, di chi
sente in sé le possibilità annientatrici e terribili che ogni alternativa
dell'esistenza prospetta. Perciò di fronte a ogni alternativa, Kierkegaard
si è sentito paralizzato.
Egli stesso dice di essere «una cavia d'esperimento per l'esistenza» e
di riunire in sé i punti estremi di ogni opposizione. «Ciò che io sono è
un nulla; questo procura a me e al mio genio la soddisfazione di
conservare la mia esistenza al punto zero, tra il freddo e il caldo, tra
la saggezza e la stupidaggine, tra il qualche cosa e il nulla come un
semplice forse». Il punto zero è l'indecisione permanente, l'equilibrio
instabile tra le alternative opposte che si aprono di fronte a qualsiasi
possibilità. E forse potrebbe essere proprio questa la scheggia nelle
carni di cui Kierkegaard parlava: l'impossibilità di ridurre la propria
vita a un còmpito preciso, di scegliere tra le alternative opposte, di
riconoscersi e attuarsi in una possibilità unica. Questa impossibilità
si traduce per lui nel riconoscimento che il proprio còmpito, l'unità
della propria personalità, è appunto in questa condizione eccezionale di
indecisione e di instabilità e che il centro del suo io è nel non avere
un centro.
Le alternative dell'esistenza.
Una seconda caratteristica del pensiero di Kierkegaard è il suo sforzo
costante di chiarire le possibilità fondamentali che si offrono all'uomo,
gli stadi o i momenti della vita che costituiscono le alternative
dell'esistenza e tra le quali l'uomo generalmente è condotto a scegliere,
mentre egli, Kierkegaard, non poteva scegliere. La sua attività fu quella
di un contemplativo: ed egli si disse e si credette poeta. E moltiplicò la
sua personalità con pseudonimi, in modo da accentuare il distacco tra se
stesso e le forme di vita che veniva descrivendo, in modo da far intendere
chiaramente che egli stesso non s'impegnava a scegliere tra esse. Una
terza caratteristica basilare del suo pensiero è il tema della fede.
La fede.
Soltanto nel Cristianesimo egli vede un'àncora di salvezza: in quanto il
Cristianesimo gli sembrava insegnare quella stessa dottrina
dell'esistenza che a lui pareva l'unica vera e nello stesso tempo offrire,
con l'aiuto soprannaturale della fede, un modo per sottrarre l'uomo
all'angoscia e alla disperazione, che costituiscono strutturalmente
l'esistenza.
3. La verità del «singolo»: il rifiuto dell'hegelismo e «l'infinita
differenza qualitativa» fra l'uomo e Dio.
Per tutti questi motivi, la filosofia hegeliana appare a Kierkegaard
l'antitesi del punto di vista sull'esistenza da lui vissuto, e un'antitesi
illusoria. Le alternative possibili dell'esistenza non si lasciano
riunire e conciliare nella continuità di un unico processo dialettico.
In questo, l'opposizione delle alternative stesse è solo apparente,
perché la vera ed unica realtà è l'unità della Ragione con se stessa. Ma
nella Ragione l'uomo singolo, l'uomo concretamente esistente, è assorbito
e dissolto.
L'istanza del «singolo» e la polemica anti-hegeliana (cfr. il Glossario).
Di fronte ad essa, Kierkegaard presenta l'istanza del singolo,
dell'esistente come tale. «La verità, egli dice, è una verità
solo quando è una verità per me». La verità non è l'oggetto del pensiero
ma il processo con cui l'uomo se l'appropria, la fa sua e la vive:
l'appropriazione della verità è la verità. Alla riflessione oggettiva
propria della filosofia di Hegel, Kierkegaard contrappone la riflessione
soggettiva, connessa con l'esistenza: la riflessione nella quale il
singolo uomo è direttamente coinvolto quanto al suo stesso destino e che
non è oggettiva e disinteressata, ma appassionata e paradossale. Hegel
ha fatto dell'uomo un genere animale giacché solo negli animali il genere
è superiore al singolo. Il genere umano ha invece la caratteristica che
il singolo è superiore al genere. Questo è, secondo Kierkegaard,
l'insegnamento fondamentale del cristianesimo; ed è il punto su cui
bisogna combattere la battaglia contro la filosofia hegeliana e in
generale contro ogni filosofia che si avvalga della riflessione
oggettiva. Kierkegaard considera come un aspetto essenziale del còmpito
che si è proposto l'inserzione della persona singola, con tutte le sue
esigenze, nella ricerca filosofica. Non per nulla egli avrebbe voluto
far scrivere sulla sua tomba questa sola espressione: «Quel singolo».
L'abisso fra l'uomo e Dio.
E non per nulla ha combattuto tutta la vita contro il panteismo
idealistico, cioè contro la pretesa di identificare uomo e Dio, affermando
invece «l'infinita differenza qualitativa» tra il finito e l'infinito,
ossia l'abisso incolmabile che divide il modo d'essere del singolo da
quello dell'Assoluto.
4. Gli stadi dell'esistenza.
4.1. Vita estetica e vita etica (da integrare con il Glossario).
La vita estetica...
Il primo libro di Kierkegaard s'intitola significativamente Aut-Aut. è una
raccolta di scritti pseudonimi che presentano l'alternativa di due stadi
fondamentali della vita: la vita estetica e la vita morale. Il titolo
stesso indica già come questi stadi non siano due gradi di uno sviluppo
unico che passi dall'uno all'altro e li concili. Tra uno stadio e l'altro
vi è abisso e salto. Ognuno di essi forma una Vita a sé, che con le sue
opposizioni interne si presenta all'uomo come un'alternativa che esclude
l'altra.
Lo stadio estetico è la forma di vita di chi esiste nell'attimo,
fuggevolissimo irripetibile. L'esteta è colui che vive poeticamente, cioè
vive insieme di immaginazione e di riflessione. Egli è dotato di un
senso finissimo per trovare nella vita ciò che vi è di interessante, e sa
trattare i casi vissuti come se fossero l'opera dell'immaginazione poetica.
Così l'esteta si foggia un mondo luminoso, dal qual è assente tutto ciò
che la vita presenta di banale, insignificante e meschino; e vive in uno
stato di ebbrezza intellettuale continua. La vita estetica esclude la
ripetizione, che implica sempre monotonia e toglie l'interessante alle
vicende più promettenti. La vita estetica è concretamente rappresentata da
Kierkegaard in Giovanni, il protagonista del Diario del seduttore, che sa
porre il suo godimento non nella ricerca sfrenata e indiscriminata del
piacere, ma nella limitazione e nell'intensità dell'appagamento.
...e il suo fallimento.
Ma la vita estetica rivela la sua insufficienza e la sua miseria nella noia.
Chiunque viva esteticamente è disperato, lo sappia o non lo sappia; la
disperazione è l'ultimo sbocco della concezione estetica della vita. Essa
è l'ansia di una vita diversa che si prospetta come un'altra alternativa
possibile. Ma per raggiungere quest'altra alternativa, bisogna attaccarsi
alla disperazione, scegliere e darsi ad essa con tutto l'impegno, per
rompere l'involucro della pura esteticità e riagganciarsi con un salto
all'altra alternativa possibile, la vita etica.
«Scegli dunque la disperazione, dice Kierkegaard; la disperazione stessa
è una scelta giacché si può dubitare senza scegliere di dubitare ma non si
può disperarsi senza sceglierlo. Disperandosi, si sceglie di nuovo e sceglie
se stesso, non nella propria immediatezza, come individuo accidentale, ma
si sceglie se stesso nella propria validità eterna».
La vita etica.
La vita etica nasce appunto con questa scelta. Essa implica una
stabilità e una continuità che la vita estetica, come incessante ricerca
della varietà, esclude da sé. Essa è il dominio della riaffermazione di
sé, del dovere e della fedeltà a se stessa: il dominio della libertà per
la quale l'uomo si forma o si afferma da sé. « L'elemento estetico è
quello per il quale l'uomo è immediatamente ciò che è; l'elemento etico è
quello per cui l'uomo diviene ciò che diviene». Nella vita etica l'uomo
singolo si sottopone a una forma, si adegua all'universale e rinuncia ad
essere l'eccezione. Come la vita estetica è incarnata dal seduttore, la
vita etica è incarnata dal marito. Il matrimonio è l'espressione tipica
dell'eticità, secondo Kierkegaard: esso è un còmpito che può essere
proprio di tutti. Mentre nella concezione estetica dell'amore, una coppia
di persone eccezionali può essere felice in forza della sua
eccezionalità, nella concezione etica del matrimonio può diventar felice
ogni coppia di sposi. Inoltre la persona etica vive del suo lavoro. Il
suo lavoro è anche la sua vocazione, perciò essa lavora con piacere: il
lavoro la mette in relazione con altre persone, e adempiendo il suo
còmpito essa adempie a tutto ciò che può desiderare al mondo.
La scelta della scelta.
La caratteristica della vita etica in questo senso è la scelta che l'uomo
fa di se stesso. La scelta di se stesso è una scelta assoluta perché non
è la scelta di una qualsiasi determinazione finita (che non è mai il «se
stesso») ma la scelta della libertà: cioè in fondo della scelta stessa.
Una volta effettuata questa scelta, l'individuo scopre in sé una
ricchezza infinita, scopre che ha in sé una storia nella quale riconosce
la sua identità con se stesso. Questa storia include i suoi rapporti con
gli altri sicché nel momento in cui l'individuo sembra isolarsi di più,
penetra più profondamente nella radice con la quale si riattacca
all'intera umanità. Per la sua scelta, egli non può rinunziare a nulla
della sua storia, neanche agli aspetti di essa più dolorosi e crudeli; e
nel riconoscersi in questi aspetti, egli si pente. Il pentimento è
l'ultima parola della scelta etica, quella per cui questa scelta appare
insufficiente e trapassa nel dominio religioso.
Il «pentimento» e l'apertura a Dio.
«Il pentimento dell'individuo, dice Kierkegaard, coinvolge se stesso, la
famiglia, il genere umano, finché egli si ritrova in Dio. Solo a questa
condizione egli può scegliere se stesso e questa è la sola condizione che
egli vuole perché solo così può scegliere se stesso in senso assoluto>. La
scelta assoluta è dunque pentimento, riconoscimento della propria
colpevolezza, della colpevolezza perfino di ciò che si è ereditato. « Il
suo se stesso si trova in qualche modo fuori di lui e dev'essere
conquistato; e il pentimento è il suo amore perché egli lo sceglie
assolutamente, per la mano di Dio». Questo è lo scacco finale della vita
etica, lo scacco per cui essa, in virtù della stessa struttura che la
costituisce, tende a raggiungere la vita religiosa.
4.2. La vita religiosa.
Non c'è tuttavia continuità tra la vita etica e quella religiosa.
La vicenda di Abramo.
Tra esse c'è anzi un abisso ancora più profondo, un'opposizione ancora più
radicale che tra l'estetica e l'etica. Kierkegaard chiarisce questa
opposizione in Timore e tremore, raffigurando la vita religiosa nella
persona di Abramo. Vissuto fino a 70 anni nel rispetto della legge
morale, Abramo riceve da Dio l'ordine di uccidere il figlio Isacco
e di infrangere così la legge per la quale è vissuto. Il significato
della figura di Abramo sta nel fatto che il sacrificio del figlio non
gli è suggerito da una qualsiasi esigenza morale (come fu, ad esempio,
per il console Bruto) ma da un puro comando divino
che è in contrasto con la legge morale e con l'affetto naturale e non
trova alcuna giustificazione innanzi ai familiari stessi di Abramo. In
altri termini, l'affermazione del principio religioso sospende interamente
l'azione del principio morale. Tra i due princìpi non c'è possibilità di
conciliazione o di sintesi. La loro opposizione è radicale. Ma se è così,
la scelta tra i due princìpi non può essere facilitata da nessuna
considerazione generale, né decisa in base a nessuna regola. L'uomo, che
ha fede come Abramo, opterà per il principio religioso, seguirà l'ordine
divino anche a costo di una rottura totale con la generalità degli uomini e
con la norma morale. Ma la fede non è un principio generale: è un rapporto
privato tra luomo e Dio, un rapporto assoluto con l'Assoluto. è il dominio
della solitudine: non si entra in essa «in compagnia», non si odono voci
umane e non si scorgono regole. Di qui deriva il carattere incerto e
rischioso della vita religiosa.
Ad esempio, come può l'uomo esser certo di essere l'eccezione giustificata?
Come può sapere che egli è l'eletto, colui al quale Dio ha affidato un
còmpito eccezionale, che esige e giustifica la sospensione dell'etica? C'è
un solo segno indiretto: la forza angosciosa con cui proprio questa
domanda si pone all'uomo che è stato veramente eletto da Dio. L'angoscia
dell'incertezza è la sola assicurazione possibile. La fede è appunto la
certezza angosciosa, l'angoscia che si rende certa di sé e di un nascosto
rapporto con Dio. L'uomo può pregare Dio che gli conceda la fede; ma la
possibilità di pregare non è essa stessa un dono divino?
La fede come paradosso e scandalo.
Così c'è nella fede una contraddizione ineliminabile. La fede è paradosso
e scandalo. Cristo è il segno di questo paradosso è colui che soffre e
muore come uomo, mentre parla e agisce come Dio; è colui che è e si deve
riconoscere come Dio, mentre soffre e muore come un misero uomo. L'uomo è
posto di fronte al bivio: credere o non credere. Da un lato è lui che deve
scegliere dall'altro ogni sua iniziativa è esclusa perché Dio è tutto e
da lui deriva anche la fede. La vita religiosa è nelle maglie di questa
contraddizione ineplicabile. Ma questa contraddizione è quella stessa
dell'esistenza umana. Kierkegaard vede perciò rivelata dal cristianesimo
la sostanza stessa dell'esistenza. Paradosso, scandalo, contraddizione,
necessità e nello stesso tempo impossibilità di decidere, dubbio,
angoscia, sono le caratteristiche dell'esistenza e sono nello stesso
tempo i fattori essenziali del cristianesimo.
Di un cristianesimo, però, che Kierkegaard si accorse (negli ultimi anni
della vita) esser assai lontano da quello delle religioni ufficiali.
« Sono in possesso di un libro, egli scrisse una volta, che in questo
paese può dirsi sconoscluto e di cui voglio quindi dare il titolo:
"Il Nuovo Testamento di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo"». La
polemica contro il pacifico e accomodante cristianesimo della chiesa
danese, polemica nella quale dichiarò di scendere in campo, più che per
il cristianesimo, per la sincerità e l'onestà, dimostra come in realtà
egli difendesse nel cristianesimo il significato dell'esistenza che aveva
riconosciuto e fatto proprio. Ma questo significato, se si trova espresso
e, per così dire, incarnato storicamente nel cristianesimo, non è limitato
al dominio religioso ma è connesso con ogni forma o stadio dell'esistenza.
La religione ne è consapevole, ma non lo monopolizza: la vita estetica e
la vita etica lo includono, come si è visto, ugualmente. E le opere più
significative di Kierkegaard sono quelle che lo affrontano direttamente
e lo fissano nel suo significato umano.
5. Il sentimento del possibile: l'angoscia.
Kierkegaard si è dapprima fermato a delineare gli stadi fondamentali
della vita, presentandoli come alternative escludentisi e come situazioni
dominate da irrimediabili contrasti interni. L'approfondimento della sua
ricerca lo porta al punto centrale nel quale si radicano le stesse
alternative della vita ed i loro contrasti: l'esistenza come possibilità.
Kierkegaard affronta direttamente, nelle sue due opere fondamentali,
il Concetto dell'angoscia e La malattia mortale, la situazione di radicale
incertezza, di instabilità e di dubbio, in cui l'uomo si trova
costituzionalmente per la natura problematica del modo d'essere che gli
è proprio. Nel Concetto dell'angoscia questa situazione è chiarita nei
confronti del rapporto dell'uomo col mondo, nella Malattia mortale nei
confronti del rapporto dell'uomo con se stesso, cioè nel rapporto
costitutivo dell'io.
L'angoscia come esperienza vissuta e tormentosa della possibilità.
L'angoscia è la condizione generata nell'uomo dal possibile che lo
costituisce. Essa è strettamente connessa col peccato ed è a fondamento
dello stesso peccato originale. L'innocenza di Adamo è ignoranza; ma è
un'ignoranza che contiene un elemento che determinerà la caduta. Questo
elemento non è né calma né riposo; non è neppure turbamento o lotta,
perché non c'è ancora niente contro cui lottare. Non è che un niente; ma
proprio questo niente genera l'angoscia. A diferenza del timore e di
altri stati analoghi che si riferiscono sempre a qualcosa di determinato,
l'angoscia non si riferisce a nulla di preciso. Essa è il puro sentimento
della possibilità.
«Il divieto divino, dice Kierkegaard, rende inquieto Adamo perché
sveglia in lui la possibilità della libertà. Ciò che si offriva
all'innocenza come il niente dell'angoscia è ora entrato in lui, e qui
ancora resta un niente: l'angosciante possibilità di potere. Quanto a ciò
che può, egli non ne ha nessuna idea, altrimenti sarebbe presupposto ciò
che ne segue, cioè la differenza tra il bene e il male. Non vi è in
Adamo che la possibilità di potere, come una forma superiore d'ignoranza,
come un'espressione superiore di angoscia, giacché in questo grado più
alto essa è e non è, egli l'ama e la fugge».
Nell'ignoranza di ciò che può, Adamo possiede il suo potere nella forma
della pura possibilità; e l'esperienza vissuta di questa possibilità è
l'angoscia. L'angoscia non è né necessità né libertà astratta, cioè libero
arbitrio; è libertà finita, cioè limitata e impastoiata, e così si
identifica col sentimento della possibilità.
La connessione fra l'angoscia, il possibile e il futuro.
La connessione dell'angoscia col possibile si rivela nella connessione
del possibile con l'avvenire. Il possibile corrisponde completamente
all'avvenire. «Per la libertà, il possibile è l'avvenire, per il tempo
l'avvenire è il possibile. Così all'uno come all'altro, nella vita
individuale corrisponde l'angoscia». Il passato può angosciare solo in
quanto si ripresenta come futuro, cioè come una possibilità di
ripetizione. Così una colpa passata genera angoscia, solo se non è
veramente passata, giacché se fosse tale potrebbe generare pentimento,
non angoscia. L'angoscia è legata a ciò che non è ma può essere, al nulla
che è possibile o alla possibilità nullificante. Essa è legata
strettamente alla condizione umana. Se l'uomo fosse angelo o bestia, non
conoscerebbe l'angoscia; e difatti essa manca o diminuisce negli stadi
che degradano o inclinano verso la bestialità, nell'aspiritualità per la
quale l'uomo è troppo felice e troppo privo di spirito. Ma anche in
questi stadi l'angoscia è sempre pronta ad insorgere: è mascherata e
nascosta, ma è lì, pronta a riprendere il suo imperio sull'uomo.
Le pagine conclusive del Concetto dell'angoscia esprimono in modo
potentemente autobiografico la natura dell'angoscia come sentimento del
possibile. La parola più terribile pronunciata da Cristo non è quella
che impressionava Lutero: Mio Dio, perché mi hai abbandonato? ma l'altra
che egli rivolse a Giuda: Ciò che tu fai, affrettalo! La prima parola
esprime la sofferenza per ciò che accadeva, la seconda l'angoscia per ciò
che poteva accadere; e solo in questa si rivela veramente l'umanità del
Cristo; perché umanità significa angoscia. La povertà spirituale sottrae
l'uomo all'angoscia; ma l'uomo sottratto all'angoscia è lo schiavo di tutte
le circostanze che lo sballottano di qua e di là senza mèta. L'angoscia è
la più gravosa di tutte le categorie.
L'infinità o l'onnipotenza del possibile.
Kierkegaard collega l'angoscia strettamente con il principio dell'infinità
o dell'onnipotenza del possibile: principio che egli esprime più spesso
dicendo: «Nel possibile, tutto è possibile». Per questo principio, ogni
possibilità favorevole all'uomo è annientata dall'infinito numero delle
possibilità sfavorevoli.
«Di solito, dice Kierkegaard, si dice che la possibilità è leggera
perché s'intende come possibilità di felicità, di fortuna eccetera. Ma
questa non è affatto la possibiiità; questa è un'invenzione fallace che gli
uomini nella loro corruzione imbellettano per avere un pretesto di
lamentarsi della vita e della provvidenza e per avere un'occasione di
farsi importanti ai propri occhi. No, nella possibilità tutto è
ugualmente possibile e chi fu realmente educato mediante la possibilità
ha compreso tanto il lato terribile quanto quello piacevole di essa.
Quando si esce dalla sua scuola si sa meglio di come un bambino sa le sue
lettere che dalla vita non si può pretendere nulla e che il lato
terribile, la perdizione l'annientamento abitano a porta a porta con
ciascuno di noi; e quando si è appreso a fondo che ciascuna delle
angosce che noi temiamo può piombare su di noi da un istante all'altro,
siamo costretti a dare alla realtà un'altra spiegazione: siamo costretti
a lodare la realtà quando anche essa gravi su di noi con mano pesante e a
ricordarci che essa è di gran lunga più facile che non la possibilità».
è l'infinità o indeterminatezza delle possibilità che rende insuperabile
l'angoscia e ne fa la situazione fondamentale dell'uomo nel mondo. «Quando
l'accortezza ha fatto tutti i suoi calcoli innumerevoli, quando il gioco è
fatto, ecco l'angoscia, ancor prima che il gioco sia vinto o perduto nella
realtà; e l'angoscia mette una croce davanti al diavolo, sicché non può
più andare avanti e la più astuta combinazione dell'accortezza scompare
come uno scherzo di fronte a quel caso che l'angoscia forma mediante
l'onnipotenza della possibilità». In tal modo l'onnipotenza della
possibilità divezza dall'accortezza che si muove tra le cose finite ed
educa l'individuo «a riposare nella provvidenza». Allo stesso modo, essa
dà il senso infinito della colpa che non può essere visto attraverso la
finitezza: «Se un uomo è colpevole, è colpevole infinitamente».
6. Disperazione e fede.
L'angoscia è la condizione in cui l'uomo è posto dal possibile che si
riferisce al mondo; la disperazione è la condizione in cui l'uomo è posto
dal possibile che si riferisce alla sua stessa interiorità, al suo io.
La possibilità che provoca l'angoscia è inerente alla situazione dell'uomo
nel mondo: è la possibilità di fatti, di circostanze, di legami, che
rapportano l'uomo al mondo. La disperazione è inerente alla personalità
stessa dell'uomo, al rapporto in cui l'io è con se stesso e alla
possibilità di questo rapporto. Disperazione e angoscia sono quindi
strettamente legate, ma non identiche: entrambe tuttavia sono fondate
sulla struttura problematica dell'esistenza.
Genesi e struttura della disperazione.
«L'io, dice Kierkegaard, è un rapporto che si rapporta a se stesso; è,
nel rapporto, l'orientamento interno di questo stesso rapporto. L'io non è
rapporto, ma è il ritorno su se stesso del rapporto». Posto ciò, la
disperazione è strettamente legata alla natura dell'io. Difatti l'io può
volere, come può non volere, esser se stesso. Se vuole esser se stesso,
poiché è finito, quindi insufficiente a se stesso, non giungerà mai
all'equilibrio e al riposo. Se non vuole esser se stesso e cerca di
rompere il proprio rapporto con sé, che gli è costitutivo, urta
anche qui contro un'impossibilità fondamentale. La disperazione è la
caratteristica sia dell'una che dell'altra alternativa. Essa è perciò
la malattia mortale, non perché conduca alla morte dell'io ma perché è
il vivere la morte dell'io: è il tentativo impossibile di negare la
possibilità dell'io o rendendolo autosufficiente o distruggendolo nella
sua natura concreta. Le due forme della disperazione si richiamano l'un
l'altra e si identificano: disperare di sé nel senso di volersi disfare
di sé significa voler essere l'io che non si è veramente; voler essere se
stesso ad ogni costo significa ancora voler essere l'io che non si è
veramente, un io autosufficiente e compiuto. Nell'uno e nell'altro caso la
disperazione è l'impossibilità del tentativo.
Necessità, libertà e disperazione.
Dall'altro lato, l'io è, secondo Kierkegaard, «la sintesi di necessità e
di libertà» e la disperazione nasce in lui o dalla deficienza di
necessità o dalla deficienza di libertà. La deficienza della necessità è
la fuga dell'io verso possibilità che si moltiplicano indefinitamente e
non si solidificano mai. L'individuo diventa « un miraggio ». « Alla
fine, dice Kierkegaard, è come se tutto fosse possibile ed è proprio
questo il momento in cui l'abisso ha ingoiato l'io ». La disperazione è
qui quella che oggi chiamiamo « evasione », cioè il rifugio in
possibilità fantastiche, illimitate, che non prendono piede e non si
radicano in nulla. «Nella possibilità tutto è possibile. Perciò nella
possibilità ci si può smarrire in tutti i modi possibili ma
essenzialmente in due. L'una di queste forme è quella del desiderio,
dell'aspirazione, l'altra è quella malinconico-fantastica (la speranza, il
timore o l'angoscia)». C'è poi la disperazione dovuta alla deficienza del
possibile. In questo caso, «la possibilità è l'unica cosa che salva.
Quando uno sviene si manda per acqua, acqua di colonia gocce di
Hoffmann; ma quando qualcuno vuol disperarsi bisogna dire: "Trovate una
possibilità, trovategli una possibilità". La possibilità è l'unico
rimedio; dategli una possibilità e il disperato riprende lena, si
rianima, perché se l'uomo rimane senza possibilità è come se gli mancasse
l'aria. Talvolta l'inventiva della fantasia umana può bastare per trovare
una possibilità; ma alla fine, cioè quando si tratta di credere, giova
soltanto questo, che a Dio tutto è possibile».
Proprio perché a Dio tutto è possibile, il credente possiede il
contravveleno sicuro contro la disperazione: «il fatto che la volontà di
Dio è possibile fa sì che io possa pregare; se essa fosse soltanto
necessaria, l'uomo sarebbe essenzialmente muto come l'animale».
La fede come antidoto contro la disperazione.
Come opposto della fede, la disperazione è il peccato: e perciò l'opposto
del peccato è per l'appunto la fede, non la virtù. La fede è l'eliminazione
della disperazione, è la condizione in cui l'uomo, pur orientandosi
verso se stesso e volendo esser se stesso, non si illude
sulla sua autosufficienza ma riconosce la sua dipendenza da Dio. In
questo caso, la volontà di esser se stesso non urta contro
l'impossibilità dell'autosufficienza che determina la disperazione, perché
è una volontà che si affida alla potenza da cui l'uomo stesso è posto,
cioè a Dio. La fede sostituisce alla disperazione la speranza e la fiducia
in Dio. Ma porta pure l'uomo al di là della ragione e di ogni possibilità
di comprensione: essa è assurdità, paradosso e scandalo. Che la realtà
dell'uomo sia quella di un individuo isolato di fronte a Dio, che ogni
individuo come tale, sia esso un potente della terra o uno schiavo,
esista dinanzi a Dio, questo è lo scandalo fondamentale del cristianesimo,
scandalo che nessuna speculazione può togliere o diminuire.
I paradossi del pensiero religioso.
Tutte le categorie del pensiero religioso sono impensabili.
Impensabile è la trascendenza di Dio, che implica una distanza infinita
tra Dio e l'uomo e così esclude qualsiasi familiarità tra Dio e l'uomo
anche nell'atto del loro più intimo rapporto. Impensabile è il peccato
nella sua natura concreta, come esistenza dell'individuo che pecca.
Impensabile è l'idea di un Dio che si fa carne e muore per noi. La fede
crede nonostante tutto, e assume tutti i rischi. La fede è, per
Kierkegaard, il capovolgimento paradossale dell'esistenza; di fronte
all'instabilità radicale dell'esistenza costituita dal possibile la fede
si appella alla stabilità del principio di ogni possibilità, a Dio, cui
tutto è possibile.
7. L'istante e la storia: l'eterno nel tempo.
L'«istante».
Secondo Kierkegaard la storia non è affatto una teofania, cioè, come
pensava Hegel, una rivelazione o autorealizzazione dell'Assoluto.
Infatti, il rapporto tra l'uomo e Dio non si verifica nella storia,
ovvero nella continuità del divenire umano, ma piuttosto nell'istante,
inteso come subitanea inserzione della verità divina nell'uomo. In questo
senso, il cristianesimo è paradosso e scandalo. Se il rapporto tra l'uomo
e Dio si verifica nell'istante, ciò vuol dire che l'uomo per suo conto
vive nella non-verità; e la conoscenza di questa condizione è il peccato.
Socratismo e cristianesimo.
Kierkegaard contrappone il cristianesimo così inteso al socratismo,
secondo il quale l'uomo invece vive nella verità e si tratta soltanto per
lui di renderla esplicita, di trarla fuori maieuticamente. Il maestro
per il socratismo è una semplice occasione per il processo maieutico,
giacché la verità abita sin dal principio nel discepolo. Socrate perciò
rifiutava di chiamarsi maestro e dichiarava di non insegnare nulla. Ma
dal punto di vista cristiano, poiché l'uomo è la non-verità, si tratta di
ricreare l'uomo, di farlo rinascere, per renderlo adatto alla verità che
gli viene da fuori. Il maestro è perciò un salvatore, un redentore, che
determina la nascita di un uomo nuovo, capace di accogliere nell'istante
la verità di Dio.
Dio rimane quindi al di là di ogni possibile punto d'arrivo della ricerca
umana. L'unica sua possibile definizione, secondo Kierkegaard, è quella
che lo contrassegna come differenza assoluta; ma è una definizione
apparente, perché una differenza assoluta non può essere pensata, e
allora questa differenza assoluta non significa altro che l'uomo non è
Dio, che l'uomo è la non-verità, il peccato. La ricerca di Dio non ha
fatto un passo innanzi.
L'istante è dunque l'inserzione paradossale e incomprensibile dell'eternità
nel tempo, e realizza il paradosso del cristianesimo, che è la venuta di
Dio nel mondo. In questo senso soltanto, il cristianesimo è un fatto
storico; e se ogni fatto storico fa appello alla fede, questo
particolare fatto storico implica una fede alla seconda potenza perché
esige una decisione che superi la contraddizione implicita nell'eternità
che si fa tempo, nella divinità che si fa uomo.
Il discepolo di «prima mano» e quello di «seconda mano».
Ma questo fatto storico non ha testimoni privilegiati, giacché la sua
storicità si ripresenta, nell'istante, ogni volta che il singolo uomo
riceve il dono della fede. Kierkegaard afferma a questo proposito che
non c'è nessuna differenza tra il «discepolo di prima mano» e il
«discepolo di seconda mano» di Cristo.
L'uomo, che vive dopo molti secoli dalla venuta di Cristo, crede
all'informazione del contemporaneo di Cristo solo in virtù di una
condizione che a lui stesso deriva direttamente da Dio. Per lui quindi
si verifica originalmente la venuta di Dio nel mondo, e ciò accade in
virtù della fede. La divinità di Cristo non era più evidente per il
testimone immediato, per il contemporaneo di Gesù, di quanto non lo sia
per qualsiasi cristiano che abbia ricevuto la fede.
8. Eredità kierkegaardiane.
La filosofia di Kierkegaard è, nel suo complesso, un'apologetica
religiosa e precisamente il tentativo di fondare la validità della
religione sulla struttura dell'esistenza umana come tale. Si tratta
tuttavia di un'apologetica assai lontana dalla razionalizzazione della
vita religiosa che era stata effettuata da Hegel e che, dopo
di Hegel, era diventato il còmpito della destra hegeliana. La religione
non è per Kierkegaard una visione razionale del mondo né la trascrizione
fantastica o emotiva di tale visione; è soltanto la via della salvezza,
cioè l'unico modo di sottrarsi all'angoscia, alla disperazione e allo
scacco delle possibilità che costituiscono l'uomo, mediante
l'instaurazione di un rapporto immediato con Dio. Il ritorno a Kierkegaard
nella filosofia contemporanea è stato iniziato dalla cosiddetta
«rinascita kierkegaardiana», proprio in vista di questo aspetto della
filosofia di Kierkegaard .
La fortuna di alcuni concetti tipici di Kierkegaard.
Dall'altro lato, Kierkegaard ha offerto all'indagine filosofica strumenti
che si sono rivelati efficaci: come i concetti di possibilità, di scelta,
di alternativa e di esistenza come modo d'essere proprio dell'uomo; e ha
insistito su quell'aspetto della fìlosofia per la quale essa è non tanto
un sapere oggettivo quanto un atteggiarsi o un progettarsi totale
dell'esistenza umana e quindi impegno in tale progettazione. Questa
dimensione è stata poi fatta propria da tutte le correnti
dell'esistenzialismo contemporaneo.
Indicazioni bibliografiche
R. Cantoni La coscienza inquieta: S. Kierkegaard, Mondadori, Milano 1949.
C. Fabro, Tra Kierkegaard e Marx, Vallecchi, Firenze 1952.
Auroti Vari, Studi kierkegaardiani, a cura di C. Fabro, Morcelliana,
Brescia 1957 (Si veda, in questo volume, l'articolo di N. Abbagnano,
Kierkegaard e il sentiero della possibilità).
G Lukács, La distruzione della ragione, Einaudi, Torino 1959.
T.W. Adorno, Kierkegaard. La costruzione dell'estetico, Longanesi,
Milano 1962.
L. Pareyson, L'etica di Kierkegaard nella prima fase del suo pensiero,
Giappichelli Torino 1965 (si veda pure di L. Pareyson, Studi
sull'esistenzialismo, Sansoni, Firenze 1971).
F. Lombardi, Kierkegaard, Sansoni, Firenze 1968
T. Perlini, Che cosa ha veramente detto Kierkegaard, Ubaldini, Roma 1968.
F. Castagnino, Gli studi italiani su Kierkegaard (1906-1922), Edizioni
dell'Ateneo 1972.
M. Gigante, Religiosità di Kierkegaard, Morano, Napoli 1972.
A. Cortese, Kierkegaard, in Questioni di storiografia filosofica,
La Scuola, Brescia 1975-1978 volume 3 pagine 417-717 (per la fortuna e le
interpretazioni).
G. Velocci, Filosofia e fede in Kierkegaard, Città Nuova, Roma 1976.
S. Spera, Il giovane Kierkegaard, Cedam, Padoa 1977.
L. Lunardi, La dialettica in Kierkegaard. Liviana, Padova 1982.
S. Spera, Introduzione a Kierkegaard, Laterza, Roma-Bari 1983.
V . Melchiorre, Saggi su Kierkegaard, Marietti, Genova 1987.
L. Amoroso (a cura di), Maschere kierkegaardiane, Rosenberg e Sellier,
Torino 1990.
P. Nepi (a cura di), L'«Esercizio del Cristianesimo» di Kierkegaard e
il Cristo dei filosofi, Paravia, Torino 1992.
Glossario e riepilogo
- Esistenza. è lo specifico modo d'essere dell'uomo nel mondo. Modo che
risulta definito dai concetti interdipendenti di singolarità (vedi),
possibilità (vedi), scelta (vedi), angoscia (vedi), disperazione (vedi)
e fede (vedi).
- Il Singolo è, per Kierkegaard, la categoria propria dell'esistenza umana,
filosoficamente concepita come realtà irriducibile al concetto e
cristianamente intesa come valore assoluto. Ecco taluni passi del Diario
che insistono eloquentemente su tale nozione: «L'esistenza corrisponde
alla realtà singolare, al singolo (ciò che già insegnò Aristotele); essa
resta fuori del concetto che comunque non coincide con essa. Per un
singolo... l'esistenza (essere o non essere) è qualcosa di molto decisivo;
un uomo singolo non ha certo un'esistenza concettuale»; «"Il Singolo" è
la categoria attraverso la quale debbono passare, dal punto di vista
religioso, il tempo, la storia, l'umanità»; «In ogni genere animale la
specie è la cosa più alta... Solo nel genere umano - a causa del
cristianesimo - ... l'individuo è più alto del genere»; «Se io dovessi
domandare un epitaffio per la mia tomba, non chiederei che "quel Singolo",
anche se ora questa categoria non è capita. Lo sarà in seguito»;
«Con questa categoria "il Singolo", quando qui tutto era sistema su
sistema, io presi polemicamente di mira il sistema, ed ora di sistema non
si parla più »; «A questa categoria è legata assolutamente la mia possibile
importanza storica. I miei scritti saranno presto dimenticati, come quelli
di molti altri. Ma se questa categoria era giusta, se questa categoria era
al suo posto, se io qui ho colpito nel segno, se ho capito bene che questo
era il mio compito, tutt'altro che allegro, comodo e incoraggiante: se mi
sarà concesso questo, anche a prezzo di inenarrabili sofferenze interiori,
anche a prezzo di indicibili sacrifici esteriori: allora io rimango e i
miei scritti con me...».
- L'antihegelismo di Kierkegaard è parte integrante della sua difesa
dell'«esistenza ». Ad Hegel Kierkegaard rimprovera soprattutto:
1) la mentalità «pagana», ossia la tendenza a ritenere la specie (l'Umanità,
lo Spirito eccetera) più importante dell'individuo;
2) la concezione della filosofia come scienza oggettiva (cioè distaccata
e disinteressata) e non come riflessione soggettiva nella quale il singolo
è direttamente coinvolto;
3) la conseguente scissione fra speculazione filosofica e vita vissuta,
ossia l'edificazione di un «sistema» nel quale non trova posto e fondamento
la condizione effettiva in cui il filosofo, al pari di tutti gli altri
uomini, è costretto a vivere:
«Succede della maggioranza dei filosofi sistematici, riguardo ai loro
sistemi, come di chi si costruisse un castello e poi se ne andasse a vivere
in un fienile: per conto loro essi non vivono in quell'enorme costruzione
sistematica. Ma nel campo dello spirito ciò costituisce un'obiezione
capitale. Qui i pensieri, i pensieri di un uomo, debbono essere
l'abitazione in cui egli vive... altrimenti sono guai» (Diario, 1,
pagina 243);
4) la tendenza a «mediare» e a «conciliare» ciò che nella vita concreta non
risulta affatto mediabile e conciliabile;
5) l'identificazione panteistica fra uomo e Dio, e quindi l'incapacità di
cogliere «l'infinita differenza qualitativa» che separa il finito
dall'infinito.
- Possibilità. Secondo Kierkegaard l'esistenza non è un'entità necessaria
e garantita, ma un insieme di possibilità che obbligano l'uomo ad una
scelta (vedi) e che implicano una componente ineliminabile di rischio.
Ogni possibilità è infatti, oltre che possibilità-che-sì, anche
possibilità-che-non: «Di solito la possibilità di cui si dice ch'è
così lieve, s'intende come possibilità di felicità, di fortuna eccetera.
Ma questa non è affatto la possibilità; questa è un'invenzione fallace...
No, nella possibilità tutto è ugualmente possibile...», «la possibilità è
la più pesante di tutte le categorie» (Il concetto dell'angoscia, vedi).
- Scelta. Secondo Kierkegaard esistere significa scegliere. Infatti, la
scelta non è una semplice manifestazione della personalità, ma
costituisce o forma la personalità stessa, che sceglie vivendo o vive
scegliendo. In altri termini, l'individuo non è quel che è, ma ciò che
sceglie di essere. Tant'è vero che persino la rinuncia alla scelta è una
scelta, sia pure un tipo di scelta per causa della quale l'uomo rinunzia
a farsi valere come io: La scelta è decisiva per il contenuto della
personalità; con la scelta essa sprofonda nella cosa scelta e se essa
non sceglie, appassisce in consunzione (Aut-Aut, 2).
- Gli stadi dell'esistenza sono i modi fondamentali di vivere e di
concepire l'esistenza. Modi che per Kierkegaard sono essenzialmente tre:
la vita estetica (vedi), etica (vedi) e religiosa (vedi). I primi due sono
descritti in Aut-Aut e il terzo in Timore e Tremore. Secondo Kierkegaard
questi stadi non possono hegelianamente addizionarsi (et-et e fondersi
in una finale sintesi conciliatrice di tipo dialettico, ma si presentano
come reciprocamente escludentisi fra di loro (aut-aut). Tant'è che il
passaggio dall'uno all'altro postula sempre una rottura o un « salto»,
accompagnato da un cambiamento radicale di mentalità.
- Lo stadio estetico è la forma di vita in cui l'uomo «è immediatamente ciò
che è», ossia il comportamento di colui che, rifiutando ogni vincolo o
impegno continuato, cerca l'attimo fuggente della propria realizzazione,
all'insegna della novità e dell'avventura. Infatti, l'esteta, che trova il
suo simbolo più significativo nel Don Giovanni di Mozart (ma anche nelle
coscienze «inquiete» dell'ebreo errante e del Faust di Goethe), si propone
di fare della propria vita un'opera darte da cui sia bandita la monotonia
e nella quale, viceversa, trionfino le emozioni inedite («Godi la vita e
vivi il tuo desiderio», insegna l'esteta, per il quale ogni donna non è
che uno «spunto poetico» messo al servizio della propria raffinata ricerca
del piacere). Tuttavia, al di là della sua apparenza gioiosa e
brillante, la vita estetica è destinata alla noia (che segue alla vanità
del piacere) e al fallimento esistenziale. Infatti, vivendo attimo per
attimo ed evitando il peso di scelte impegnative (ossia scegliendo di
non scegliere), l'esteta, secondo Kierkegaard, finisce per rinunciare ad
una propria identità e per avvertire, con disperazione, il vuoto della
propria esistenza senza centro e senza senso.
- Lo stadio etico è il momento in cui l'uomo, scegliendo di scegliere,
ossia assumendo in pieno la responsabilità della propria libertà, si
impegna in un compito, al quale rimane fedele. Infatti, a differenza
della vita estetica, la quale tenta di evitare la «ripetizione» e cerca ad
ogni istante il nuovo, la vita etica si fonda sulla continuità e sulla
scelta «ripetuta» che l'individuo fa di se stesso e del proprio compito.
In altri termini, nella vita etica (che è simboleggiata dallo stato
matrimoniale) l'individuo si sottopone ad una «forma o ad un modello
universale» di comportamento, che implica, al posto del desiderio
dell'«eccezionalità», la scelta della «normalità» («La morale - scrive
Kierkegaard - è propriamente il generale e, in quanto generale, è ciò che
vale per tutti»). Tuttavia, pur collocandosi su di un piano più alto
rispetto alla vita estetica, la vita etica è destinata anch'essa al
fallimento. Infatti, l'uomo etico non può fare a meno di riconoscere la
propria finitudine peccaminosa e quindi di «pentirsi». Inoltre,
nell'ambito della generalità della vita etica e della connessa ritualità
dei suoi comportamenti, l'individuo non riesce a trovare veramente se
stesso e la propria singolarità genuina. Tanto più che esiste, in
ognuno, un'ansia di infinito che non si lascia racchiudere nei limiti di
una tranquilla esistenza di marito e di impiegato. Da ciò il bisogno di
un'esperienza più profonda e coinvolgente grazie a cui l'individuo
vincendo l'angoscia (vedi) e la disperazione (vedi) che lo costituiscono
come uomo e che giacciono al fondo di ogni vita, anche della più fortunata
e felice - possa davvero realizzarsi come singolo e nelle sue aspettative
migliori. Tale è la vita religiosa (vedi).
- L'angoscia di cui parla Kierkegaard è il sentimento del possibile, cioè
quello stato d'animo esistenziale che sorge dinanzi alla vertigine della
libertà e alle infinite possibilità negative che incombono sulla vita e
sulla personalità dell'uomo. Per questi suoi caratteri, l'angoscia è
diversa dalla paura che si prova al cospetto di una situazione determinata
e ad un pericolo preciso. Inoltre, essa è un sentimento tipicamente umano.
Tant'è che viene provata solo da chi ha spirito: «più profonda è l'angoscia
più grande è l'uomo». L'unico modo efficace per contrastare l'angoscia e i
suoi tormenti («nessun grande inquisitore tien pronte torture così
terribili come l'angoscia; nessuna spia sa attaccare con tanta astuzia la
persona sospetta, proprio nel momento in cui è più debole, né sa
preparare così bene i lacci per accalappiarla come sa l'angoscia; nessun
giudice, per sottile che sia, sa esaminare così a fondo l'accusato come
l'angoscia che non se lo lascia mai sfuggire, né nel divertimento, né nel
chiasso, né sotto il lavoro, né di giorno, né di notte...») non è
l'accortezza umana, ma la fede religiosa in Colui al quale «tutto è
possibile».
- La disperazione. Mentre l'angoscia si riferisce al rapporto dell'uomo
con il mondo, la disperazione si riferisce al rapporto dell'uomo con se
stesso, in cui consiste propriamente l'io. In questo rapporto, se l'io
vuol essere se stesso, poiché è finito e quindi insufficiente a se
stesso, non giungerà mai all'equilibrio e al riposo. Viceversa, se non
vuol essere se stesso, urta anche qui contro un'impossibilità di fondo.
Nell'uno e nell'altro caso, ci si imbatte nella disperazione, che è
un'autentica malattia mortale, non perché conduca alla morte dell'io, ma
perché è il vivere la morte dell'io, cioè la negazione del tentativo
umano di rendersi autosufficienti o di evadere da sé. Ma se ogni
uomo, lo sappia o meno, è malato di disperazione, l'unica terapia
efficace contro di essa è la fede, ossia quella condizione in cui l'io,
pur orientandosi verso se stesso e pur volendo essere se stesso, non si
illude sulla sua autosufficienza, ma riconosce la sua dipendenza da
Colui che lo ha posto e che, solo, può garantire la sua realizzazione.
L'uomo deve quindi «volere» la disperazione, poiché riconoscendosi in preda
ad essa egli può volgersi alla ricerca di una salvezza.
N.B. La disperazione di cui parla Kierkegaard non è la disperazione finita
che discende dalla perdita di beni mondani (ad esempio di una persona cara
o di un patrimonio); ma la disperazione infinita che discende dalla propria
insufficienza esistenziale. Infatti, se la prima costringe l'uomo a
«rinchiudersi» in sé e nel finito, la seconda lo spinge ad uscire «fuori di
sé» e ad aprirsi all'Assoluto: «Eppure è mia intima convinzione che la vera
salvezza dell'uomo è nel disperarsi. Qui appare di nuovo l'importanza di
volere la propria disperazione, di volerla in senso infinito, in senso
assoluto, poiché un simile volere è identico all'assoluta dedizione. Se
invece voglio la mia disperazione in senso finito, la mia anima ne
soffre, poiché così il mio essere più profondo non giunge a prorompere
nella disperazione, ma al contrario si richiude in essa, si indurisce.
Così la disperazione finita è un rinchiudersi nel finito, la disperazione
assoluta un dischiudersi all'infinito» (Aut-Aut).
- Lo stadio religioso è lo stadio della fede, intesa come «rapporto
assoluto con l'Assoluto» (Timore e tremore), ossia lo stadio in cui
l'individuo, andando al di là della limitatezza della vita etica, si apre
totalmente a Dio, riuscendo a vincere (anche se non ad eliminare
completamente) l'angoscia e la disperazione che lo costituiscono come
uomo. Fra lo stadio etico e quello religioso esiste un abisso, incarnato
dalla figura di Abramo (vedi testo). Infatti, lo stadio religioso, lungi
dal ridursi alle tranquillizzanti verità della ragione e dell'etica,
costituisce la dimensione dello scandalo e del paradosso (come
testimoniano le principali credenze del cristianesimo: si pensi all'idea
di un Dio che si fa «carne» e che «muore» sulla croce per i nostri
peccati).
- L'istante o l'attimo. Secondo Kierkegaard la fede ha un carattere
«istantaneo» in quanto implica una subitanea inserzione dell'eternità nel
tempo, ossia un'improvvisa «discesa» della verità divina nell'uomo.
La natura istantanea della fede, comportando un incontro paradossale fra
la linea verticale della trascendenza e quella orizzontale dell'immanenza,
esclude che essa possa venir suscitata o prodotta da procedimenti umani o
dimostrativi e fa sì che la divinità di Cristo non sia più evidente, per i
contemporanei di Gesù, di quanto non lo sia per un qualsiasi cristiano che
abbia ricevuto il dono della fede.
Approfondimento
- Ironia e umorismo. Da un lato Kierkegaard tende a valorizzare l'ironia,
poiché essa, consistendo nel «non prendere sul serio» il finito tramite un
atteggiamento di distaccata superiorità spirituale, porta ad una
relativizzazione delle realtà mondane (come quando Socrate svela le
presunzioni conoscitive degli uomini, o come quando l'esteta prende
coscienza della insufficienza e vacuità dei propri piaceri). Dall'altro
lato, Kierkegaard critica l'ironia, poiché essa, risolvendosi
romanticamente in una indebita infinitizzazione dell'interiorità (Diario,
6, A, 8) rischia di capovolgersi in un atteggiamento nichilista ed
estetizzante cristianamente inaccettabile. All'ironia Kierkegaard
contrappone l'umorismo: «il criterio discriminante fra ironia e "humor"...
sembra sia il diverso atteggiamento della coscienza verso il finito:
mentre l'ironia accetta il vuoto e la dispersione del finito come la
realtà in sé che tocca subire e l'uomo resta ancora nell'immanenza e nel
dubbio, così che si distacca sempre di più dal reale che lo circonda, lo
"humor" si appoggia e deriva da una certezza, quella religiosa, che
vince il dubbio e spinge ad agire nel mondo che ci circonda... Lo
"humor", rispetto all'ironia, è più dialettico e più costruttivo ad un
tempo: in quanto l'umorista è l'uomo della religiosità, della passione
infinita, il quale si tiene bensì distaccato con lo spirito del finito,
e tuttavia gli resta fedele nell'azione...» (C. Fabro).
STORIA DELLA FILOSOFIA
di NICOLA ABBAGNANO
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
VOLUME TERZO
PARTE QUARTA: LA SINISTRA HEGELIANA E IL MARXISMO
«La coscienza che luomo ha di Dio è la coscienza che luomo ha di sé».
(Feuerbach)
«Il divenire filosofia del mondo è in pari tempo un divenire-mondo della
filosofia». (Marx)
CAPITOLO 9: LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH
1. Destra e Sinistra hegeliana.
La spaccatura della scuola hegeliana.
Alla morte di Hegel (1831) i suoi numerosi discepoli continuarono ad
ispirare la cultura filosofica tedesca, nonostante le sempre più marcate
divisioni esistenti fra i «Vecchi hegeliani» (la generazione più
anziana, composta per la maggior parte dagli editori delle opere del
filosofo) ed i « Giovani hegeliani » (la generazione più giovane,
composta da coloro che erano nati dopo il 1800). Nel 1837 David Strauss
designava queste due correnti, con termini desunti dalle consuetudini
del Parlamento francese, come destra e sinistra hegeliana (egli
individuava anche un centro costituito da K. F. Rosenkranz). La
spaccatura della scuola, «resa possibile dalla fondamentale equivocità
dei "superamenti" dialettici di Hegel, che potevano essere interpretati
tanto in un senso conservatore quanto in un senso rivoluzionario»
(K. Löwith), fu dovuta al diverso atteggiamento assunto dai discepoli di
fronte alla religione e alla politica.
a) Conservazione o distruzione della religione?
L'ambiguità della teoria hegeliana della religione.
Riguardo alla religione, la dottrina di Hegel risultava manifestamente
ambigua. Infatti, egli aveva affermato che religione e filosofia
esprimono un medesimo contenuto (cioè una medesima verità) in due forme
distinte, in quanto la prima esprime quel contenuto nella forma della
«rappresentazione» e la seconda nella forma del «concetto». Ovviamente,
una dottrina di questo tipo poteva dar luogo a due antitetiche
impostazioni. La prima era propria di coloro che insistevano sulla
identità di contenuto fra rappresentazione e concetto (in quanto
espressioni di una stessa verità) e che concepivano la filosofia come
conservazione della religione. La seconda era propria di coloro che
insistevano sulla diversità di forma fra rappresentazione e concetto
(ovvero sulla loro inadeguatezza o adeguatezza rispetto alla verità) e
che concepivano la filosofia come distruzione della religione.
La Destra e la religione.
La prima posizione prese corpo nella Destra, rappresentata soprattutto
da Karl-Friedrich Göschel (1781-1861), Kasimir Conradi (1784-1849) e
Georg Andreas Gabler (1786-1853), la quale finì per configurarsi come una
sorta di scolastica dell'hegelismo, volta ad utilizzare la ragione
hegeliana allo stesso modo in cui la scolastica medievale aveva
utilizzato la ragione aristotelica o la scolastica occasionalistica la
ragione cartesiana: cioè al fine di una giustificazione razionale delle
credenze religiose. Ovviamente, la Destra poté adempiere il suo compito
solo a patto di «amputare» gli aspetti panteistico-immanentistici
dell'hegelismo e solo patto di « adattare » l'idealismo alle tesi-madri del
cristianesimo: esistenza di un Dio trascendente, immortalità personale
eccetera.
La Sinistra e la religione.
La seconda posizione prese corpo nella Sinisra, la quale, sostenendo
l'inconciliabilità fra dogma e verità speculativa, finì per fare della
filosofia uno strumento di contestazione razionale della religione.
b) Legittimazione o critica dell'esistente?
L'atteggiamento conservatore della Destra.
Considerata la stretta connessione esistente fra trono ed altare, la
spaccatura ebbe anche motivazioni e significati politici. Infatti la
Destra, rifacendosi alla polemica hegeliana contro il dover-essere,
sostenne l'identità ontologica fra realtà e ragione ed assunse quindi un
atteggiamento globalmente giustificazionistico e conservatore nei
confronti dell'esistente.
L'atteggiamento «rivoluzionario» della Sinistra.
Viceversa, la Sinistra, meno attaccata alla lettera dei testi hegeliani,
interpretò il pensiero del Maestro in modo dinamico e rivoluzionario,
affermando che il mondo costituisce un processo in cui ciò che sussiste,
auto-superandosi incessantemente, è chiamato a farsi razionale. In tal
modo, la Sinistra, ammettendo che non tutto ciò che esiste di fatto è
razionale (e quindi genuinamente «reale»), finiva per concepire la
filosofia come critica dell'esistente, ovvero come un progetto di
trasformazione rivoluzionaria delle istituzioni politiche contemporanee.
2. Strauss, Bauer e Ruge.
La Destra hegeliana ebbe limitata incidenza storica. Ben più influente
ed originale fu invece la Sinistra. Muovendo da una critica serrata
dell'hegelismo, la Sinistra si propose di far valere quei tratti e quei
caratteri dell'uomo concreto che nell'idealismo non avevano trovato un
riconoscimento soddisfacente. Sul piano religioso, questa impostazione
dette luogo ad un'analisi critico-razionale dei testi biblici e al
tentativo di ridurre il significato della religione ad esigenze e
motivazioni umane (Strauss, Feuerbach). Sul piano politico dette luogo
al tentativo di interpretare la storia in modo «materialistico» e in
chiave rivoluzionaria (Marx).
Strauss la religione come mito.
David Friedrich Strauss (1808-1874) fu scolaro di Ferdinando Baur a
Tubinga e fu in stretti rapporti con la scuola hegeliana. Nel 1835
pubblicò la Vita di Gesù, opera che divenne presto famosa e suscitò le
violente polemiche che cristallizzarono la divisione della scuola
hegeliana. Quest'opera è il primo tentativo radicale, sistematico e
compiuto, di applicare il concetto hegeliano della religione alla
critica dei testi biblici. Il risultato di questo tentativo è la
riduzione del contenuto della fede religiosa, in quanto non si lascia
ridurre a filosofia o a storia, a semplice mito. Il mito è un'idea
metafisica espressa nella forma di un racconto immaginato o fantastico.
Esso ha quindi due aspetti: uno negativo, in quanto non è storia, l'altro
positivo, in quanto è una finzione prodotta dall'orientamento
intellettuale di una società data. Esso è diverso dalla leggenda, che è
la trasfigurazione o l'invenzione, operata dalla tradizione, di un fatto
storico, senza significato metafisico. I miti si trovano in tutte le
religioni giacché costituiscono la parte propria ed essenziale della
religione stessa; e in realtà ciò che nelle religioni non è mito, o è
storia o è filosofia.
Un mito evangelico è un racconto che si riferisce immediatamente o
mediatamente a Gesù e che si deve considerare non come l'espressione di
un fatto, ma come quella di un'idea dei suoi partigiani primitivi.
Le due fonti dei miti evangelici sono:
1) l'attesa del Messia in tutte le sue forme, attesa che esisteva nel
popolo ebreo prima di Gesù e indipendentemente da lui;
2) l'impressione particolare prodotta da Gesù in virtù della sua
personalità, della sua azione, del suo destino, impressione che modificò
l'idea che i suoi compatrioti si facevano del Messia.
Partendo da queste idee direttive, Strauss conduce avanti
l'analisi filologica e storica dei testi evangelici, rigettando nel mito
e nella leggenda ogni elemento soprannaturale o comunque non fondato
sulla testimonianza controllata e concorde delle fonti. Il corpo
dell'opera è così diretto a dimostrare la differmza tra la religione
cristiana, caratterizzata dai suoi miti, e la filosofia. Nella
conclusione, Strauss si sofferma a dimostrare invece l'identità di
contenuto tra cristianesimo e filosofia. Questo contenuto identico è
costituito dall'unità dell'infinito e del finito, di Dio e dell'uomo.
L'esigenza che questa unità esca dal campo delle semplici possibilità e
si realizzi come una certezza sensibile, è quella che porta al principio
cristiano dell'incarnazione, al Dio-uomo. Ma l'incarnazione, intesa come un
fatto particolare, nella persona di un individuo storico determinato, è
essa stessa un mito.
Bauer.
Bruno Bauer (1809-1882), filosofo e biblista tedesco, aderì inizialmente
alle tesi della Destra hegeliana, criticando Strauss ed affermando la
verità del Cristianesimo.
Negli anni Quaranta si avvicinò invece alle tesi della Sinistra,
pervenendo a negare la realtà storica di Cristo.
Dopo essere entrato in urto con l'ortodossia religiosa, ed aver
scandalizzato il pubblico dei credenti con La tromba del giudizio
universale su Hegel ateo ed anticristo. Un ultimatum (1841), fu
allontanato dall'insegnamento universitario (1842) e fondò a Berlino il
circolo dei «Liberi», gruppo di giovani radicali assestati sulle
posizioni di un immanentismo ateo. In seguito, mentre gli altri
pensatori della Sinistra andavano sempre più accentuando il momento
della politica e della prassi, Bauer sviluppò una filosofia, da lui
stesso definita della «critica pura», che opponeva gli «intellettuali»
e lo «spirito» alla «massa», racchiudendosi in una sorta di
aristocratismo idealistico. Per questo motivo, Marx ed Engels ruppero
con lui nel 1844, considerandolo ormai un «superato» avulso dalla
concretezza della storia.
Ruge.
Arnold Ruge (1802-1880) fu inizialmente un hegeliano ortodosso. In
seguito alla spaccatura della scuola aderì alla Sinistra, dirigendo, dal
1838, gli Hallische Jahrbücher («Annali di Halle»), dove scrissero, fra
gli altri, Bauer, Feuerbach e Marx.
L'importanza storica di Ruge, all'interno della Sinistra, fu quella di
favorire il passaggio dalla critica religiosa a quella politica.
Nell'opera La filosofia del diritto hegeliana e la critica del nostro tempo
(1842) egli attacca Hegel, accusandolo di aver assolutizzato
filosoficamente la realtà politica contemporanea (soprattutto la
monarchia ereditaria ed il maggiorascato), anticipando così taluni
motivi della critica marxista alla filosofia politica di Hegel.
Collaboratore, con Marx, degli Annali franco-tedeschi (1844), fu
costretto all'esilio in seguito alla soppressione della rivista. Mentre
Marx passava dalla democrazia liberale a quella comunista, Ruge rimase
su posizioni moderate, divenendo, nel 1848, deputato al parlamento
nazionale. Più tardi finì per avvicinarsi sempre di più alla Realpolitik
bismarckiana.
3. Feuerbach.
3.1. Vita e opere.
La maggior figura della Sinistra hegeliana è quella di Feuerbach, il
fondatore dell'ateismo filosofico ottocentesco.
Ludwig Feuerbach nacque il 28 luglio 1804 a Landshut nella Baviera e
morì a Rechenberg il 13 settembre 1872. Scolaro di Hegel a Berlino,
libero docente ad Erlangen, si vide troncare la carriera universitaria
dall'ostilità incontrata dalle idee sulla religione esposte in uno dei
suoi primi scritti, Pensieri sulla morte e l'immortalità (1830). Si
ritirò allora nella solitudine e nello studio e visse quasi sempre a
Bruckberg. Nell'inverno 1848-1849, per invito di una parte degli studenti
di Heidelberg, tenne in quella città le Lezioni sull'essenza della
religione. L'invito era stato reso possibile da avvenimenti del 1848 e fu
soltanto una parentesi nella vita di Feuerbach, che passò i suoi ultimi
anni in miseria, a Rechenberg. Dapprima hegeliano fervente, Feuerbach si
staccò in seguito dall'hegelismo e il distacco è segnato dallo scritto
Critica della filosofia hegeliana (1839), al quale seguirono nello
stesso senso le Tesi provvisorie per la riforma della filosofia (1843)
e Princìpi della filosofia dell'avvenire (1844). Ma intanto aveva
pubblicato, nel 1841, la sua opera fondamentale, L'essenza del
cristianesimo; alla quale seguì nel 1845 l'altra altrettanto importante
L'essenza della religione. Le opere successive non fanno che riprendere
e riesporre le tesi contenute in queste due opere: Lezioni sull'essenza
della religione (tenute come si è detto nel 1848-1849, ma pubblicate
nel 1851); Teogonia secondo le fonti dell'antichità classica
ebraico-cristiana (1857); Divinità, libertà e immortalità dal punto di
vista dell'antropologia (1866); Spiritualismo e materialismo (1866);
L'eudemonismo (postumo).
3.2. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.
La filosofia di Feuerbach, che muove dall'esigenza di cogliere l'uomo e la
realtà nella loro concretezza, ha come presupposto teorico e metodologico
una critica radicale della maniera ideelistico-religiosa di rapportarsi
al mondo.
Il concreto non è un predicato o un attributo dell'astratto, ma viceversa.
Maniera che, secondo Feuerbach, consiste sostanzialmente in
uno stravolgimento dei rapporti reali fra soggetto e predicato,
concreto ed astratto. Ad esempio, mentre nella realtà effettiva delle
cose l'essere si configura come il soggetto originario di cui il pensiero
è il predicato, cioè l'attributo o l'effetto, nell'idealismo il pensiero si
configura come il soggetto originario, di cui l'essere è il predicato,
cioè l'attributo o l'effetto. In altri termini, l'equivoco di fondo
dell'idealismo è quello di fare del concreto (dell'essere, della natura,
dell'uomo, del finito eccetera) un predicato o un attributo dell'astratto
(del pensiero, dello spirito, di Dio, dell'infinito eccetera), anziché
dell'astratto un predicato o un attributo del concreto (« Il vero
rapporto tra pensiero ed essere non può essere che questo: l'essere è il
soggetto, il pensiero è il predicato. Il pensiero dunque deriva
dall'essere, ma non l'essere dal pensiero») (Tesi provvisorie per una
riforma della filosofia (1943), traduzione italiana in Princìpi
della filosofia dell'avvenire, Einaudi, Torino 1948, pagina 63).
Detto con altre parole ancora, l'idealismo offre una visione rovesciata
delle cose, in cui ciò che viene realmente prima (il concreto, la causa)
figura come ciò che viene dopo, e ciò che viene realmente dopo (l'astratto,
l'effetto) figura come ciò che viene prima: «Il cammino che sinora ha
percorso la filosofia speculativa dall'astratto al concreto, dall'ideale
al reale, è un cammino alla rovescia. è una via per la quale non si giunge
mai alla realtà vera... ».
Da ciò il programma feuerbachiano di un'inversione radicale dei rapporti
fra soggetto e predicato instaurati dalla religione e dall'idealismo: «La
nuova filosofia, conformemente alla verità, ha trasformato l'attributo in
sostantivo, il predicato in soggetto... », «L'inizio della filosofia
non è Dio, non è l'Assoluto, non è l'essere come predicato dell'assoluto o
dell'idea: l'inizio della filosofia è il finito, il determinato, il reale»
(Tesi, pagine 55 e 67).
3.3. La critica alla religione.
a) Dio come proiezione delluomo.
Applicando la sua metodologia materialistica alla religione, Feuerbach
afferma che non è Dio (l'astratto) ad aver creato l'uomo (il concreto), ma
luomo ad aver creato Dio.
Dio come proiezione dell'uomo.
Infatti Dio, secondo Feuerbach, è nient'altro che la proiezione illusoria
o l'oggettivazione fantastica di qualità umane, in particolare di quelle
«perfezioni» caratteristiche della nostra specie che sono la ragione,
la volontà e il cuore. In altri termini, il divino è nient'altro che
l'umano in generale, proiettato in un mitico aldilà e adorato come
tale: « La religione - scrive Feuerbach in L'essenza del cristianesimo
(Traduzione italiana, Feltrinelli, MIlano 1960) - è l'insieme dei rapporti
dell'uomo con se stesso, o meglio con il proprio essere, riguardato però
come un altro essere... Tutte le qualificazioni dell'essere divino sono
perciò qualificazioni dell'essere umano», «Tu credi che l'amore sia un
attributo di Dio perché tu stesso ami, credi che Dio sia un essere
sapiente e buono perché consideri bontà e intelligenza le migliori tue
qualità...» (pagine 39 e 44). Il mistero della teologia è quindi
l'antropologia. Proprio in quanto antropologia capovolta, la religione
costituisce «la prima, ma indiretta autocoscienza delluomo». Tant'è vero
che essa « precede sempre la filosofia, nella storia dell'umanità così
come nella storia dei singoli individui. L'uomo sposta il suo essere
fuori da sé, prima di trovarlo in sé... La religione è l'infanzia
dell'umanità; il bambino vede il proprio essere, l'uomo, fuori da sé,
ossia oggettiva il proprio essere in un altro uomo. Perciò il progresso
storico delle religioni consiste appunto nel considerare in un secondo
tempo come soggettivo e umano ciò che le prime religioni consideravano
come oggettivo e adoravano come dio. Le prime religioni sono idolatrie
per le religioni posteriori; queste riconoscono che l'uomo ha adorato il
proprio essere senza saperlo... Ma ogni religione particolare che
definisce idolatrie le sue più antiche sorelle, esclude se stessa - ed
invero necessariamente, altrimenti non sarebbe più religione - da questo
destino, da questa natura universale della religione; soltanto alle altre
religioni attribuisce ciò che rimane pur sempre... il vizio della
religione in generale» (pagina 38).
L'origine dell'idea di Dio.
Appurato che Dio è l'essenza dell'uomo personificata e che l'antropologia
costituisce la chiave di volta della teologia (e quindi di tutti i
misteri del cristianesimo, dalla Trinità alla verginità di Maria: cfr.
il Glossario), rimane da vedere, in concreto, come nasca, nell'uomo,
l'idea di Dio. A questo proposito Feuerbach si è variamente espresso.
La distinzione fra individuo e specie.
Talora (in particolare ne L'essenza del cristianesimo) egli tende a porre
l'origine dell'idea di Dio nel fatto che l'uomo, a differenza dell'animale,
ha coscienza di se stesso non solo come individuo, ma anche come specie.
Ora, mentre come individuo si sente debole e limitato, come specie si
sente invece infinito ed onnipotente. Da ciò la figura di Dio, il quale,
come si è appena visto, è nient'altro che una personificazione
immaginaria delle qualità della specie: «la religione è la coscienza
dell'infinito; essa dunque è, e non può essere altro, che la coscienza
che l'uomo ha, non della limitazione, ma dell'infinità del proprio essere»
(pagina 26).
L'opposizione fra volere e potere.
Altre volte (in particolare nella Teogonia, ma il tema è presente anche
negli altri scritti) Feuerbach tende a scorgere l'origine
dell'idea di Dio nell'opposizione umana tra volere e potere. Opposizione
che porta l'individuo a costruirsi una divinità in cui tutti i suoi
desideri appaiono realizzati: «A proprio presupposto la religione ha il
contrasto o la contraddizione tra volere e potere, desiderare e
ottenere... Nel volere, nel desiderare, nel rappresentare l'uomo è
illimitato, libero, onnipotente - è Dio; ma nel potere, nell'ottenere,
nella realtà egli è condizionato, dipendente, limitato... Il pensare, il
volere sono cosa mia; ma ciò che io voglio e penso non è cosa mia, è
fuori di me, non dipende da me. La tendenza, il fine della religione è
rivolto a togliere questa contraddizione o contrasto; e l'ente in cui
queste vengono tolte, in, cui ciò che è possibile secondo i miei
desideri e le mie rappresentazioni, ma impossibile per le mie forze
diventa possibile, o piuttosto reale, - questo ente è l'ente divino »
(Essenza della religione, paragrafo 30), «"Il tuo Dio è tale qual è il tuo
cuore". Quali i desideri degli uomini tali i loro dèi» (paragrafo 55). I
greci avevano divinità limitate, esemplifica Feuerbach, perché i loro
desideri erano limitati. I desideri dei cristiani sono senza limiti,
perciò la loro divinità è infinita e onnipotente. In sintesi: «Dio è
l'ottativo del cuore umano divenuto tempo presente» (Essenza del
cristianesimo, pagina 151).
La dipendenza dell'uomo di fronte alla natura.
Altre volte (in particolare nella Essenza della religione), Feuerbach ha
visto la genesi primordiale dell'idea di Dio nel sentimento di dipendenza
che l'uomo prova di fronte alla natura. Sentimento che ha spinto l'uomo ad
adorare quelle cose senza le quali egli non potrebbe esistere: la luce,
l'aria, l'acqua e la terra (tant'è, ricorda Feuerbach, che alcuni popoli,
ad esempio gli antichi messicani, avevano come divinità anche il sale).
b) L'alienazione e l'ateismo.
La struttura dell'alienazione.
Qualunque sia l'origine della religione, è comunque certo, secondo
Feuerbach, che essa costituisce una forma di alienazione (cfr. il
Glossario), intendendo con questo termine (presente in Hegel e ripreso
da Marx) quello stato patologico per cui l'uomo, «scindendosi», proietta
fuori di sé una Potenza superiore (Dio) alla quale si sottomette (anche
nei modi più umilianti e crudeli: si pensi ai sacrifici di vite umane
compiuti per scopi religiosi). Ma se la religione è il frutto di
un'«oggettivazione» alienata ed alienante, in virtù della quale l'uomo
tanto più pone in Dio quanto più toglie a se stesso («La gloria di Dio
si fonda esclusivamente sull'abbassamento dell'uomo, la beatitudine divina
solo sulla miseria umana, la divina sapienza solo sull'umana follia, la
potenza divina solo sulla debolezza umana»), l'ateismo si configura non
solo come un atto di onestà filosofica, ma anche come un vero e proprio
dovere morale.
L'ateismo come imperativo filosofico e morale.
Infatti, secondo Feuerbach, è ormai venuto il tempo che l'uomo recuperi in
sé i predicati positivi che egli ha proiettato fuori di sé in quello
specchio illusorio ed astratto della propria essenza che è Dio.
Detto altrimenti, ciò che nella religione è soggetto deve ridiventare
predicato. Quindi non più: Dio (soggetto) è sapienza, volontà e amore
(predicato), ma, al contrario, la sapienza, la volontà e l'amore umano
(soggetto) sono divini (predicato). Di conseguenza, il compito della
vera filosofia non è più quello di porre il finito nell'infinito (ossia
di risolvere l'uomo in Dio) ma quello di porre l'infinito nel finito
(ossia di risolvere Dio nell'uomo). Ciò fa sì che l'ateismo di Feuerbach
non abbia un carattere puramente negativo, ma si presenti anche, in
positivo, come proposta di una nuova divinità: l'uomo (per le conseguenze
etiche e pratiche di questo atteggiamento vedi il paragrafo 3.5).
3.4. La critica ad Hegel.
L'hegelismo come teologia mascherata.
Se la religione è un'antropologia capovolta, l'hegelismo (del
quale Feuerbach, come si è accennato, era stato inizialmente seguace) si
configura come una teologia mascherata, o meglio, come una teologia
razionalizzata che costituisce la traduzione, in chiave «speculativa»,
di tutto il filone teologico dell'Occidente. Particolarmente
significative, a questo proposito, alcune affermazioni contenute nelle
Tesi: «Chi non rinunzia alla filosofia di Hegel, non rinunzia neppure
alla teologia. La dottrina hegeliana, secondo cui la natura, o la
realtà, è posta dall'idea, non è altro che l'espressione in termini
razionali della dottrina teologica, secondo cui la natura è creata da
Dio, o l'essere materiale è creato da un essere immateriale, cioè
astratto», «La filosofia di Hegel è l'ultimo rifugio, l'ultimo sostegno
razionale della teologia. Come una volta i teologi cattolici diventarono
de facto aristotelici per poter combattere il protestantesimo; così ora
i teologi protestanti devono diventare de iure hegeliani per poter
combattere l'ateismo», «La filosofia speculativa si è resa colpevole
dello stesso errore che ha commesso la teologia: l'errore di aver ridotto
a determinazioni, a predicati dell'infinito, le determinazioni della
realtà o del finito...» (pagine. 56 e 63).
Carattere alienante dell'idealismo.
In ogni caso, argomenta Feuerbach, l'Idea o lo Spirito di Hegel,
analogamente al Dio della Bibbia, non è altro che un fantasma di noi
stessi, ovvero il frutto di un'astrazione alienante: «L'essere della
teologia è l'essere trascendente, l'essere dell'uomo posto al di fuori
dell'uomo; l'essere della logica di Hegel è il pensiero trascendente, il
pensiero dell'uomo posto al di fuori dell'uomo» (pagine 51-52),
«Astrarre vuol dire porre l'essenza della natura al di fuori della natura,
l'essenza dell'uomo al di fuori dell'uomo, l'essenza del pensiero al di
fuori dell'atto del pensiero. La filosofia di Hegel ha estraniato l'uomo
da se stesso, avendo fatto appoggiare tutto il sistema su questi atti di
astrazione» (pagina 53). E poiché Hegel, secondo Feuerbach, rappresenta «il
compimento» della filosofia moderna, ovvero «il termine ultimo di
un'evoluzione di pensiero, la cui caratteristica comune è lo smarrimento
dell'uomo» (U. Perone), la critica ad Hegel equivale, di fatto, alla
fondazione di una nuova filosofia incentrata sull'uomo e capace di
cogliere nel «testo» ciò che Hegel ha relegato nelle «note», ovvero la
vita nella sua immediatezza.
3.5. Umanismo e filantropismo.
L'umanismo naturalistico.
La nuova filosofia, o «filosofia dell'avvenire», delineata da Feuerbach
nell'ultima fase del suo pensiero, ha la forma di un umanismo
naturalistico. Umanismo: poiché fa dell'uomo l'oggetto e lo scopo del
discorso filosofico. Naturalistico: perché fa della Natura la realtà
primaria da cui tutto dipende, compreso l'uomo: «La nuova filosofia fa
dell'uomo l'oggetto unico, universale e supremo della filosofia,
includendovi la natura considerata come fondamento dell'uomo. La nuova
filosofia fa dell'antropologia, con inclusione della fisiologia, la
scienza universale» (Princìpi della filosofia dell'avvenire, paragrafo 54).
L'uomo come essere «di carne e di sangue».
Nucleo di questo umanismo naturalistico è il rifiuto di considerare
l'individuo come astratta spiritualità o razionalità e la concezione
dell'uomo come essere che vive, che soffre, che gioisce e che avverte una
serie di «bisogni» dai quali si sente dipendente. Un essere, insomma,
«di carne e di sangue», che risulta condizionato dal corpo e dalla
sensibilità: « Il reale nella sua realtà, o, il reale in quanto reale, è
il reale in quanto è oggetto dei sensi, è ciò che è sensibile. Verità,
realtà, senso, sono tutt'uno. Soltanto un essere sensibile è un essere
vero, un essere reale... » (paragrafo 32).
L'amore.
Sensibilità che per Feuerbach non si riduce affatto ad un atteggiamento
puramente conoscitivo, ma che presenta una valenza pratica, come dimostra
il suo legame con l'amore, ossia con quella passione fondamentale che fa
tutt'uno con la vita («Non essere alcuna cosa e non amare alcuna cosa sono
tutt'uno. Tanto più uno partecipa all'essere, quanto più ama, e viceversa»).
Passione che ha il potere di aprirci verso il mondo: «l'amore è la vera
prova ontologica dell'esistenza di un oggetto al di fuori della nostra
testa... Esiste soltanto ciò che - essendo - ti procura gioia, e - non
essendo - dolore» (paragrafo 33). Ammettere che l'uomo è bisogno,
sensibilità e amore equivale nello stesso tempo ad ammettere la necessità
degli altri, ossia il fatto che l'io, per usare la caratteristica
terminologia di Feuerbach, non può stare senza il tu (come testimonia
già il fatto biologico della necessità della donna per l'uomo e viceversa).
L'essenza sociale dell'uomo.
Da ciò il «comunismo» filosofico di Feuerbach (che non va confuso con
quello di Marx), ossia la dottrina dell'essenza sociale delluomo: «Le
idee scaturiscono soltanto dalla comunicazione, solo dalla conversazione
dell'uomo con l'uomo. L'uomo si eleva al concetto, alla ragione in
generale, non da solo, ma insieme con l'altro. Due uomini occorrono per
creare l'uomo, sia l'uomo spirituale sia quello fisico: la comunione
dell'uomo con l'uomo è il primo principio e il primo criterio
della verità e della validità universale. La certezza che esistano altre
cose al di fuori di me è ottenuta attraverso la certezza che esiste al
di fuori di me un altro uomo. Di quello che vedo da solo, non posso far
a meno di dubitare: è certo soltanto quello che anche l'altro vede»
(paragrafo 41).
L'importanza di una teoria degli alimenti.
La messa in luce dei condizionamenti naturali fa sì che in Feuerbach
assuma dignità etica e politica la teoria degli alimenti. Da ciò la tesi
paradossale, contenuta anche nel titolo di un suo scritto del 1862,
secondo cui «L'uomo è ciò che mangia». Tesi che non implica, come
ritengono frettolosamente taluni studiosi, una forma di materialismo
volgare (Feuerbach non è mai giunto a «ridurre» lo spirito alla materia
o la psiche al corpo) ma che esprime piuttosto una lucida
consapevolezza: 1) dell'unità psicofisica dell'individuo; 2) del fatto
che se si vogliono migliorare le condizioni spirituali di un popolo
bisogna innanzitutto migliorare le sue condizioni materiali: «La fame e
la sete abbattono non solo il vigore fisico ma anche quello spirituale e
morale delluomo, lo privano della sua umanità, della sua intelligenza e
della coscienza », « La teoria degli alimenti è di grande importanza
etica e politica. I cibi si trasformano in sangue, il sangue in cuore e
cervello; in materia di pensieri e di sentimenti. L'alimento umano è il
fondamento della cultura e del sentimento. Se volete far migliore il popolo,
in luogo di declamazioni contro il peccato, dategli un'alimentazione
migliore. L'uomo è ciò che mangia».
Dall'ateismo al filantropismo.
Anche da queste parole traspare il grande amore per l'umanità che fu
proprio di Feuerbach, la cui filosofia finisce per risolversi in una
forma di filantropia. Dall'amore per Dio all'amore per luomo, dalla fede in
Dio alla fede nell'uomo, dalla trascendenza all'immanenza: ecco l'esito più
caratteristico dell'ateismo «positivo» di Feuerbach. Esito che nelle
Lezioni sull'essenza della religione tenute ad Heidelberg nel 1848-1849
trova un'eloquente manifestazione: «Lo scopo dei miei scritti, come pure
delle mie lezioni, è questo: trasformare gli uomini da teologi in
antropologi, da teofili in filantropi, da candidati dell'al di là in
studenti dell'aldiqua, da camerieri religiosi e politici della monarchia e
aristocrazia celeste e terrestre in autocoscienti cittadini della terra... ».
3.6. L'importanza storica di Feuerbach.
La filosofia di Feuerbach ha esercitato una notevole influenza sul
pensiero successivo. In primo luogo, il suo anti-hegelismo e la sua
rivendicazione dell'uomo «in carne ed ossa» hanno rappresentato una delle
matrici filosofiche del marxismo.
Parlando del suo capolavoro, Engels scriverà: « Bisogna aver provato
direttamente l'azione liberatrice di questo libro per farsene un'idea.
L'entusiasmo fu generale: per un momento fummo tutti feuerbachiani».
Tant'è vero che l'azione del suo pensiero fu paragonata, nell'ambito della
Sinistra hegeliana, a quella di un autentico Feuer-bach, ossia, in
tedesco, a quella di un «torrente di fuoco». In secondo luogo, la sua
religione dell'Umanità ha influito su tanta parte del filantropismo
ottocentesco. In terzo luogo, Feuerbach è divenuto uno dei «luoghi
obbligati» del dibattito moderno intorno all'ateismo ed è stato uno
degli interlocutori di spicco della teologia protestante del Novecento
(che, per certi aspetti, si configura come un tentativo di «rispondere»
al filosofo di L'essenza del cristianesimo). Infine, il suo
riconoscimento dei «bisogni» e del condizionamento che la natura
esercita sull'uomo ha finito per divenire (al di là delle specifiche
implicazioni che esso riveste nel suo pensiero) uno dei punti fermi, e
ormai universalmente acquisiti, della filosofia e della cultura
contemporanea.
4. STIRNER.
Un'opposizione estrema all'universalismo di Hegel, che si configura nello
stesso tempo come una critica a Feuerbach, proviene dall'individualismo
anarchico di Max Stirner (1806-1856), autore di L'unico e la sua
proprietà.
L'individualismo anarchico.
La tesi fondamentale di Stirner è che l'individuo è l'unica realtà e
l'unico valore; la conseguenza che Stirner trae da questa tesi è l'egoismo
assoluto. L'individuo, proprio nella sua singolarità, per la quale è
unico e irripetibile, è la misura di tutto. Subordinarlo a Dio,
all'umanità, allo spirito, a un qualsiasi ideale, sia pure a quello
stesso dell'uomo, è impossibile, giacché tutto ciò che è diverso dall'io
singolo, ogni realtà che si distingua da esso e gli si contrapponga, è
uno spettro, di cui egli finisce per essere schiavo. Stirner condivide
la tesi di Feuerbach che Dio non è nulla fuori dell'uomo e che è la
stessa essenza dell'uomo. Ma questa tesi è insufficiente, e semplicemente
preparatoria, rispetto alla tesi radicale che ne deriva. L'essenza
dell'uomo è già qualcosa di diverso dall'uomo singolo, è già un ideale che
pretende di subordinarlo a sé. In tal modo l'uomo diventa a se stesso un
fantasma, perché non vale più nella sua singolarità ma come idea, come
spirito, come specie, cioè come qualcosa di superiore a cui deve
subordinarsi. Stirner si rifiuta di riconoscere alcunché di superiore
all'uomo stesso .
Indicazioni bibliografiche
Sulla scuola hegeliana in generale:
K. Löwith, Da Hegel a Nieksche, Einaudi, Torino 1959.
E. Rambaldi, Le origini della Sinistra hegeliana, La Nuova Italia,
Firenze 1966.
C. Cesa, Studi sulla Sinistra hegeliana, Argalia, Urbino 1972.
M. Rossi, Da Hegel a Marx, Feltrinelli, Milano 1974.
Su Feuerbach:
F. Lombardi, Feuerbach, Sansoni, Firenze 1935.
C. Cesa, Il giovane Feuerbach, Laterza, Bari 1963.
E. Rambaldi, La Critica antispeculativa di L. A. Feuerbach, La Nuova
Italia, Firenze 1966.
H. Arvon, Che cosa ha veramente detto Feuerbach, traduzione italiana
Ubaldini Roma 1972.
U. Perone, Teologia ed esperienza religiosa in Feuerbach, Mursia,
Milano 1972.
G. Severino, Origine e figure del processo teogonico di Feuerbach,
Mursia, Milano 1972.
L. Casini, Storia e umanesimo in Feuerbach, Il Mulino. Bologna 1974.
A. Schmidt, Il materialismo antropologico di L. Feuerbach, De Donato,
Bari 1975.
G. Passadore, Il Criso ateo in Feuerbach, Istituto Padano Arti Grafiche
Rovigo 1976.
C. Cesa, Introduzione a Feuerbach. Laterza, Roma-Bari 1978.
F. Tommasini, Feuerbach e la dialettica dell'essere. Con la pubblicazione
di due scritti inediti. La nuova Italia, Firenze 1982.
Idem, Feuerbach e la natura non umana, La Nuova Italia, Firenze 1986.
Su Stirner:
G. Penzo, Max Stirner. La rivolta esistenziale, Pàtron, Bolona 1981.
F. Bazzani, Il tempo dell'esistenza. Stirner, Hess, Feuerbach, Marx,
Angeli, Milano 1987.
Glossario e riepilogo
Feuerbach
- Per rovesciamento dei rapporti di predicazione si intende il metodo
caratteristico usato da Feuerbach nella sua battaglia contro la
mentalità idealistico-religiosa. Metodo che consiste nel ricapovolgere
ciò che l'idealismo ha capovolto, ossia nel riconoscere di nuovo ciò che
è realmente soggetto (= il concreto) e ciò che è realmente predicato
(= l'astratto). Ad esempio non è la natura a fungere da predicato o
attributo dello spirito (idealismo), ma lo spirito a fungere da predicato o
attributo della natura (naturalismo).
- Dio, secondo Feuerbach, è nient'altro che l'essenza oggettivata del
soggetto, cioè l'immagine riflessa o la proiezione illusoria di qualità
umane: «Tutte le qualificazioni dell'essere divino sono... qualificazioni
dell'essere umano (Essenza del Cristianesimo (E.C.), pagina 39). Circa
l'origine dell'idea di Dio Feuerbach si è variamente espresso. Talora
ne ha individuato la genesi nella distinzione fra individuo e specie;
talora nell'opposizione fra volere e potere; talora nel sentimento di
dipendenza che l'uomo prova nei confronti della Natura. In ogni caso,
la religione ha una chiara matrice antropologica (vedi).
- Antropologia capovolta. è il modo con cui Feuerbach concepisce la
religione, intesa come «la prima, ma indiretta autocoscienza dell'uomo».
Infatti, puntualizza il filosofo «come l'uomo pensa, quali sono i suoi
princìpi, tale è il suo dio... Tu conosci l'uomo dal suo Dio, e,
reciprocamente, Dio dall'uomo... Dio è l'intimo rivelato, l'essenza
dell'uomo espressa; la religione è la solenne rivelazione dei tesori
celati dell'uomo, la pubblica professione dei suoi segreti d'amore...»
(E.C., pagine 37-38). Da ciò la possibilità di una riduzione, in chiave
antropologica, di tutti i dogmi della teologia. Ad esempio, per quanto
concerne il cristianesimo, che cos'è il mistero dell'incarnazione, cioè del
farsi-uomo di Dio, se non la metafora dell'uomo riconosciuto come Dio? Che
cos'è il mistero della Trinità, se non la metafora della vita sociale e
della comunione fra l'io e il tu? Che cos'è il mistero della resurrezione
di Cristo se non il soddisfacimento dell'antico desiderio dell'uomo di
vincere la morte? Che cos'è il mistero della Vergine-madre se non il
risultato del fatto che «l'individuo non si conforma alle noiose leggi
della logica e della fisica, ma all'arbitrio della fantasia?» per cui
«in una medesima cosa esclude ciò che gli è sgradevole e conserva ciò che
gli è gradito. Così gli piace la vergine pura, senza macchia, ma gli piace
anche la madre, però solo madre incontaminata...?» (E.C., pagina 168). E
così via.
- Alienazione. è un termine, presente in Hegel e ripreso da Marx, che
indica l'elemento patologico insito nell'«oggettivazione» religiosa
descritta da Feuerbach, ovvero quello stato per cui l'uomo, «scindendosi»,
proietta fuori di sé una Potenza superiore (Dio) alla quale si
sottomette a guisa di oggetto: «L'uomo - questo è il mistero della
religione - proietta il proprio essere fuori di sé e poi si fa oggetto di
questo essere metamorfosato in soggetto, in persona; egli pensa, ma come
oggetto del pensiero di un altro essere, e questo essere è Dio (E.C.,
pagine 55-56). L'alienazione è collegata al fatto che quanto più l'uomo
pone in Dio, tanto più toglie a se stesso: «Nella religione l'uomo opera una
frattura nel proprio essere, scinde sé da se stesso, ponendo di fronte a
sé Dio come un essere antitetico. Nulla è Dio di ciò che è l'uomo, nulla
è l'uomo di ciò che è Dio. Dio è l'essere infinito, l'uomo l'essere finito;
Dio perfetto, l'uomo imperfetto; Dio eterno, l'uomo perituro; Dio
onnipotente, l'uomo impotente; Dio santo, l'uomo peccatore. Dio e l'uomo
sono due estremi: Dio il polo positivo, assomma in sé tutto ciò che è
reale, l'uomo il polo negativo, tutto ciò che è nullo» (pagina 61). La presa
di coscienza del fenomeno dell'alienazione, in quanto stato di «scissione»
interiore e di «dipendenza» esteriore, genera, per Feuerbach, la necessità
dell'ateismo (vedi).
- Per Feuerbach l'ateismo si identifica con la riappropriazione, da parte
dell'uomo, della propria essenza alienata (vedi). Come tale, esso non
esprime soltanto un atto di intelligenza filosofica, ma anche un dovere
umano e morale. L'ateismo di Feuerbach non ha un carattere puramente
negativo, poiché si presenta anche, in positivo, come proposta di una
nuova divinità: l'Uomo. All'ateismo Feuerbach finisce quindi per
sostituire una forma di antropoteismo.
- Teologia mascherata o razionalizzata è la formula usata da Feuerbach per
sottolineare come l'idealismo hegeliano sia nient'altro che la traduzione,
in termini speculativi, della religione cristiana: «Chi non rinunzia alla
filosofia di Hegel, non rinunzia neppure alla teologia».
- Filosofia dell'avvenire. è la nuova filosofia proposta da Feuerbach in
antitesi alla vecchia filosofia teologizzante. Filosofia che si
identifica sostanzialmente con una forma di umanismo naturalistico (vedi).
- Umanismo naturalistico è la formula con cui può venir riassunta la parte
positiva del pensiero di Feuerbach. Umanismo, perché fa dell'uomo
l'oggetto e lo scopo del discorso filosofico; naturalistico perché fa
della Natura la realtà ontologica primaria da cui tutto dipende,
compreso l'uomo e i suoi bisogni: « La nuova filosofia fa dell'antropologia,
con inclusione della filosofia, la scienza universale» (Princìpi,
paragrafo 54).
- L'essenza sociale dell'uomo di cui parla Feuerbach deriva dal fatto che
l'io, come egli scrive, non può stare senza il tu, in quanto l'uomo ha
costitutivamente bisogno dei propri simili. E ciò non solo a livello
biologico (necessità del maschio per la femmina e viceversa) ma in tutti
gli aspetti della sua vita.
- L'amore per l'umanità (filantropia) costituisce uno degli aspetti più
caratteristici dell'ateismo positivo (vedi) di Feuerbach, che si propone di
sostituire l'amore per Dio con l'amore per l'uomo.
STORIA DELLA FILOSOFIA
di Nicola Abbagnano
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
VOLUME TERZO
Capitolo 10: Marx
1. Vita e opere.
Il marxismo rappresenta una delle componenti intellettuali e politiche
più importanti dell'età moderna. E Marx, oltre che essere stato
«il filosofo del comunismo», è anche un «classico» della cultura, il
cui pensiero riveste quindi una portata universale.
Marx nasce a Treviri nel 1818 da una famiglia ebrea, la quale, benché
convertitasi al protestantesimo per ragioni di opportunità politica, era
di fatto su posizioni agnostiche. Per mezzo del padre, avvocato
brillante e colto, Marx riceve un'educazione di stampo razionalistico e
liberale. Nel 1835-1836 si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza a Bonn
e, successivamente, a Berlino. Entrato in contatto con il club dei
«giovani hegeliani », studia a fondo la filosofia di Hegel.
La tesi e l'attività giornalistica.
Passato da Giurisprudenza a Filosofia, si laurea all'Università di Jena
con una tesi sulla Differenza tra la filosofia della natura di Democrito
e quella di Epicuro. Abbandonati i progetti di carriera universitaria,
in seguito alla politica sempre più reazionaria del governo prussiano,
si dedica al giornalismo politico. Divenuto caporedattore della
«Gazzetta renana», è costretto a trasferirsi a Parigi in seguito
all'interdizione del giornale da parte del governo (1843). Nel frattempo
si è sposato con Jenny von Westphalen, una giovane appartenente all'antica
aristocrazia renana, che sarà la compagna preziosa della sua vita
travagliata. Sempre nel 1843 termina la stesura della Critica della
filosofia del diritto di Hegel, in cui comincia a misurarsi polemicamente
con i problemi della filosofia politica moderna.
Dal liberalismo al comunismo.
Nel 1844 esce a Parigi, sotto la direzione di Ruge e di Marx, il primo
ed unico numero degli Annali franco-tedeschi, sui quali appaiono due
importanti saggi, che testimoniano l'esplicito passaggio di Marx al
comunismo: La questione ebraica e Per la critica della filosofia del
diritto di Hegel. Introduzione. A Parigi stringe con Engels un'amicizia
che durerà tutta la vita e che gli sarà di conforto intellettuale, morale
e materiale. Nel corso dell'anno, Marx, che ha cominciato ad approfondire
gli studi economici, stende i manoscritti economico-filosofici. Espulso
dalla Francia, su insistenza del governo prussiano, si trasferisce a
Bruxelles, dove in collaborazione con Engels scrive la Sacra famiglia,
contro Bauer e seguaci. Intanto matura il distacco polemico dall'intera
filosofia tedesca, che si concretizza nelle Tesi su Feuerbach, e,
soprattutto, in L'ideologia tedesca (1845-1846), scritta in collaborazione
con Engels (vedi paragrafo 12) e rimasta inedita, in cui vengono poste
le basi della concezione materialistica della storia. Nel 1847 si tiene a
Londra il primo Congresso della «Lega dei Comunisti» e Marx, che non può
parteciparvi, viene rappresentato da Engels. In questo periodo pubblica
la Miseria della filosofia, che rappresenta il polemico e totale distacco
da Proudhon.
Il «Manifesto».
Sempre nel 1847, Marx viene incaricato dalla Lega di elaborare un documento
teorico-programmatico, che viene pubblicato a Londra in collaborazione
con Engels, con il titolo di Manifesto del partito comunista (1848).
Nel 1849 la vittoria della controrivoluzione tedesca provoca l'espulsione
di Marx dalla Germania, che intanto, a Colonia, aveva fondato la
«Nuova gazzetta renana».
Rifugiatosi a Parigi, in seguito a difficoltà sorte con il governo
francese, che vorrebbe concedergli asilo solo a patto del suo trasferimento
a Morbihan, una zona paludosa della Bretagna, emigra a Londra.
Il soggiorno a Londra.
Nel 1850 scrive degli articoli sulla rivoluzione quarantottesca,
che in seguito saranno ripubblicati da Engels con il titolo Le lotte di
classe in Francia dal 1848 al 1850. Dopo un tentativo di riorganizzazione
della Lega, che si conclude però con il suo scioglimento, nel 1851 Marx
si ritira dalla politica attiva ed inizia a lavorare al British Museum.
Per lui e la sua ormai numerosa famiglia sono anni difficili, tormentati
da problemi economici, cui Marx sopperisce in parte con i compensi tratti
dalla collaborazione al «New York Tribune» e con i benevoli aiuti di
Engels. La sua produzione scientifica è però feconda. Nel 1852 pubblica
a New York una serie di articoli dal titolo Il diciotto brumaio di
Luigi Buonaparte, dedicati al colpo di Stato francese dell'anno precedente.
Sempre più «sprofondato» in studi economici, nel 1857-1859 stende i
Lineamenti fondamentali della Critica dell'economia politica.
Nel 1859 pubblica Per la Critica dell'economia politica.
Il «Capitale».
Nel 1864 viene fondata l'Associazione Internazionale dei Lavoratori,
nella quale Marx è figura dominante. Nel 1866 inizia il primo
libro del Capitale, che viene pubblicato ad Amburgo nel 1867 (il secondo
ed il terzo volume, grazie al lavoro di Engels, che ne «decifrerà» i
manoscritti, appariranno postumi nel 1885 e nel 1894). Nel 1870, a nome
del Consiglio generale dell'Internazionale, scrive due Indirizzi sulla
guerra franco-prussiana. Il terzo indirizzo, del 1871 e dal titolo La
guerra civile in Francia, contiene le importanti osservazioni di Marx
sulla Comune parigina. Nel 1875 scrive gli Appunti sul libro di Bakunin
«Stato e anarchia» e la Critica del programma di Gotha (in occasione
dell'unificazione dei socialisti tedeschi a Gotha, all'insegna di una
strategia politica che a Marx sembrava poco rivoluzionaria). Nel 1881
muore Jenny, e a distanza di due anni, nel 1883, anche Marx la segue
nella tomba, compianto da Engels e dal movimento operaio internazionale.
Una delle tante corone di fiori, inviata da studenti moscoviti, reca
l'emblematica scritta: «A colui che ha difeso i diritti dei lavoratori
nella teoria e li ha fatti valere nella pratica».
2. Caratteristiche del marxismo.
Carattere globale dell'analisi marxista.
Il primo contrassegno del pensiero di Marx è la sua irriducibilità alla
dimensione puramente filosofica, sociologica o economica ed il suo porsi
come analisi globale della società e della storia, in grado di
investire l'intero assetto strutturale dell'analisi e sovrastrutturale
del capitalismo, ossia il mondo borghese nella molteplicità delle sue
espressioni.
Infatti, come scrive Karl Korsch «il marxismo non si lascia collocare in
nessuno dei comparti tradizionali del sistema delle scienze borghesi, e
anche se si intendesse approntare appositamente per esso... un nuovo
comparto chiamato sociologia, esso non vi rimarrebbe tranquillamente,
ma continuerebbe a uscirne per infilarsi in tutti gli altri.
"Economia", "filosofia", "storia", "teoria del diritto e dello Stato",
nessuno di questi comparti è in grado di contenerlo, ma nessuno di essi
sarebbe al sicuro dalle sue incursioni se si intendesse collocarlo in
un altro» (K. Korsch, Marxismo e filosofia, Sugar, Milano, 1968, pagina 87).
Di conseguenza, il pensiero di Marx appare pervaso da una «energia
totalistica» per usare una espressione di Kostas Axelos che investe i
diversi settori dello scibile, facendo sì che per esso appaia decisiva
quella che Lukács ha chiamato appunto «la considerazione dialettica della
totalità» (G. Lukács, Storia e coscienza di classe, Sugar, Milano, 1967,
pagina 17), ossia la tendenza ad indagare il fatto sociale non a
compartimenti stagni, ma nell'unità organica delle sue manifestazioni.
Il motivo della prassi.
Un secondo contrassegno del marxismo è il suo legame con la prassi,
ovvero la tendenza a fornire un'interpretazione dell'uomo e del suo mondo
che sia anche impegno di trasformazione rivoluzionaria. Nel discorso
pronunciato sulla tomba dell'amico, Engels afferma che «lo scienziato non
era neppure la mèta di Marx... Perché Marx era prima di tutto un
rivoluzionario». E infatti, nonostante la sua spiccata predisposizione
per il pensiero e la scienza, Marx ha perseguito per tutta la sua vita
l'ideale dell'unione fra teoria e prassi.
Questa predisposizione appare evidente sin dalla tesi di Laurea sulla
Differenza tra la filosofia della natura di Democrito e quella di Epicuro
(1841). In essa Marx esalta Epicuro come «il più grande illuminista
greco», sottolineando il suo tentativo di liberare l'uomo dalla servitù
degli dèi e preferendolo a Democrito, per aver giustificato, al di là
della necessità meccanica, l'azione dell'uomo. Nello stesso tempo egli
paragona le filosofie post-aristoteliche a quelle post-hegeliane,
impegnate entrambe, dopo il trionfo dei grandi sistemi, a portare la
filosofia nella realtà. Da ciò il giovanile «programma prometeico» di
Marx: come l'eroe greco ha trasportato il fuoco sulla terra, così il
filosofo post-hegeliano deve condurre il sapere acquisito nella città
degli uomini, favorendo in tal maniera il «divenire mondo» della
filosofia e il «divenire filosofia» del mondo.
Siamo qui ad un punto-chiave del marxismo, che sta alla base della scelta
rivoluzionaria che lo contraddistingue: l'ideale di tradurre in atto
quell'incontro tra realtà e razionalità che Hegel aveva solo pensato e
che Marx si propone invece di attuare con la prassi, mediante l'edificazione
di una nuova società.
Le influenze culturali che stanno alla base del marxismo.
Come scrive Engels, le influenze culturali che stanno alla base del
marxismo sono essenzialmente tre: la filosofia classica tedesca da Hegel
a Feuerbach; l'economia politica borghese da Smith a Ricardo; il pensiero
socialista da Saint-Simon ad Owen. Come vedremo, queste tre esperienze
intellettuali, che fungono da coordinate teoriche della genesi del
marxismo, vengono ripensate da Marx alla luce di una sintesi creativa
che, pur muovendo da esse, procede criticamente oltre i loro risultati,
mettendo capo ad una nuova visione del mondo.
3. La critica al «misticismo logico» di Hegel.
Il problema dei rapporti Hegel-Marx.
Il rapporto Hegel-Marx risulta assai complesso e oggetto di divergenti
interpretazioni critiche, poiché mentre alcuni studiosi (ad esempio Lukács)
hanno sottolineato soprattutto le relazioni di continuità fra i due
pensatori, altri (ad esempio Althusser), hanno insistito soprattutto sui
nessi di rottura. Al di là della diatriba critica, è innegabile che
l'hegelismo abbia esercitato su Marx, per affinità o per opposizione,
un notevole influsso, che gli studiosi attuali tendono a precisare sempre
meglio. In un epigramma giovanile dedicato a Hegel, Marx scrive: «sono
tronfio come un dio, mi ammanto nelle tenebre come lui. A lungo ricercai
e mi affaticai sul mare agitato del pensiero ed ecco trovai il Verbo, cui
mi tengo solidamente aggrappato » (Scritti politici giovanili, pagina 489).
L'enfasi romantico-adolescenziale di queste parole non costituisce una
ragione per sottovalutarle. Infatti, come vedremo, anche quando Marx si
allontanerà maggiormente da Hegel, qualcosa del «verbo» dell'antico
maestro resterà sempre. Anzi, nel marxismo, un certo «sfondo hegeliano»
generale, per usare le parole di Dal Pra (M. Dal Pra, La dialettica in Marx,
Laterza, Bari, 1972. Libro che segnaliamo sin d'ora come uno dei più rigorosi
ed approfonditi sui rapporti Hegel-Marx), non verrà mai meno. Per
cui, come scrive Kostas Axelos, «Il pensiero di Marx deve essere
compreso a partire da quello di Hegel. Senza comprensione filosofica - e
non soltanto storica o sistematica - della filosofia di Hegel non vi è
profonda comprensione di Marx e del marxismo» (K. Axelos, Marx pensatore
della tecnica, Sugar, Milano 1963, pagina 433).
La critica alla filosofia del diritto di Hegel.
Il primo testo in cui Marx si misura con il maestro è la Critica
della filosofia hegeliana del diritto pubblico (1843). Poco conosciuta per
lungo tempo, oggi è stata completamente rivalutata dagli studiosi,
finalmente d'accordo con Marx stesso nel ritenerla un documento-chiave
della formazione del suo pensiero. Lo scritto è filosofico-politico al
tempo stesso, anche se, per ragioni di funzionalità espositiva, possiamo
distinguere, in esso, un momento più propriamente filosofico-metodologico,
che trattiamo ora, ed un momento più specificamente storico-politico, che
analizzeremo nel prossimo paragrafo. Il primo momento colpisce al cuore
il metodo di Hegel, cioè il suo modo stesso di filosofare. Secondo Marx
lo « stratagemma » di Hegel consiste nel fare delle realtà empiriche
delle manifestazioni necessarie dello Spirito. Questo significa che
invece di limitarsi a constatare, ad esempio, che in certi ordinamenti
storici esiste la monarchia, Hegel afferma che lo Stato presuppone per
forza una sovranità, la quale si incarna necessariamente nel monarca,
che è la sovranità statale personicata. Inoltre, poiché ciò che è
necessario, per Hegel, è anche razionale, egli deduce la piena «logicità»
della monarchia, identificandola con la razionalità politica in atto.
Il «misticismo logico» e il capovolgimento idealistico fra soggetto e
predicato.
Marx definisce questo procedimento « misticismo logico », poiché in
virtù di esso le istituzioni, anziché comparire per ciò che di fatto
sono, finiscono per essere «allegorie» o personificazioni di una realtà
spirituale che se ne sta occultamente dietro di essi. Esaminando il
«mistero» di questa «costruzione speculativa», Marx, sulla scia di
Feuerbach, arriva alla conclusione che essa è il risultato del
capovolgimento idealistico fra soggetto e predicato, concreto ed astratto.
Un esempio che illustra in modo semplice e scherzoso questo aspetto
chiave della critica marxista lo troviamo nella Sacra famiglia. Mentre
l'uomo comune ed il filosofo realista pensano che prima esistano le mele,
le pere, le fragole e le mandorle reali e poi il concetto «di frutto»,
il pensatore idealista ritiene che prima esista « il frutto » e poi, in
seguito, a titolo di sue manifestazioni necessarie e derivate, la mela,
la pera eccetera. Ovviamente, in tal modo, l'idealista «stravolge» l'ordine
delle cose, poiché egli, anziché considerare come soggetto ciò che nella
realtà è soggetto (la mela, la pera...) e anziché considerare come
predicato, o manifestazione derivata, ciò che nella realtà è predicato
(la nozione astratta «il frutto»), trasforma il predicato in soggetto e
viceversa, affermando appunto che prima esiste «il frutto», che poi si
specifica nelle frutta (mele, pere, eccetera).
L'idealismo fa dunque del concreto la manifestazione dell'astratto, e di
ciò che vien prima la manifestazione di ciò che viene dopo. Ecco in che
senso Hegel, dopo essersi costruito il concetto astratto di Spirito
partendo dalla realtà, finisce per fare della realtà la manifestazione
dello Spirito. Al metodo «mistico» di Hegel, Marx, ispirandosi alle
feuerbachiane Tesi provvisorie per una riforma della filosofia (1842),
oppone polemicamente il metodo trasformativo, che consiste nel ri-capovolgere
ciò che l'idealismo ha capovolto, ossia nel riconoscere di nuovo ciò che è
veramente soggetto e veramente predicato.
Il giustificazionismo speculativo e politico di Hegel.
Oltre che essere fallace sul piano filosofico, il metodo « mistico » di
Hegel è anche conservatore sul piano politico, poiché porta a
«canonizzare» o a «santificare» la realtà esistente, ossia a
«razionalizzare» i dati di fatto, trasformandoli in manifestazioni
razionali e necessarie dello Spirito. Per cui l'esito del
giustificazionismo speculativo di Hegel (secondo il quale ciò che è
reale è razionale) è un giustificazionismo politico, che facendo la
corte ai fatti (Marx parla di «crasso positivismo»), conduce
all'accettazione delle istituzioni statali vigenti, puntellando
ideologicamente la reazione.
Primo confronto con la dialettica.
La «demistificazione» dell'hegelismo non toglie che Marx riconosca ad
esso dei meriti notevoli, che si assommano nella sua visuale « dialettica»,
ossia nella concezione generale della realtà come totalità
storico-processuale, costituita di elementi concatenati fra di loro e
mossa dalle opposizioni. Marx, per ora, sottolinea soprattutto questo
ultimo aspetto, riconoscendo ad Hegel il merito di « cominciare ovunque
con l'opposizione delle determinazioni», anche se gli muove l'appunto di
aver giocato troppo sulle opposizioni «concettuali», anziché su quelle
«reali» e di aver cercato una troppo facile mediazione e sintesi fra gli
opposti, dimenticando che nella realtà gli opposti stanno invece come
«due armate nemiche», fra cui non c'è sintesi, ma solo lotta od esclusione
(schema che in seguito Marx applicherà al rapporto proletariato-borghesia).
Nei prossimi paragrafi vedremo gli sviluppi di questo confronto con
la «dialettica» (per un prospetto globale cfr. il Glossario).
4. La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione
«politica» e «umana».
Alla base della teoria di Marx e della sua adesione al comunismo,
esplicitata nel 1844, vi è una critica globale della civiltà moderna
e dello Stato liberale, che rappresenta uno dei nuclei teorici più
importanti del marxismo.
(Nel Novecento, dopo la rivoluzione sovietica, i termini di
«comunismo» e di «socialismo» tendono ad essere distinti, indicandosi
con l'uno le forze che in qualche modo si ispirano più direttamente a
Marx e alla rivoluzione d'Ottobre, e con l'altro le forze che respingono
la via leninista ed il modello sovietico, mantenendosi per lo più, su
posizioni «revisioniste» rispetto al marxismo ortodosso. In Marx i due
termini tendono invece ad essere usati in modo equivalente, anche se dal
1848 in poi Marx usa preferibilmente le espressioni « comunisti » e «
comunismo ».)
La «scissione» moderna fra Stato e società civile.
Il punto di partenza del discorso di Marx - iniziato nella Critica e
sviluppato in modo rigoroso negli Annali franco-tedeschi del '44 - è la
convinzione, mutuata da Hegel, che la categoria del moderno si
identifichi con quella della «scissione», che prende corpo,
innanzitutto, nella frattura fra società civile e Stato. Mentre
nella polis greca l'individuo si trovava in un'«unità sostanziale» con
la comunità di cui era faceva parte, e non conosceva antitesi fra ego
pubblico ed ego privato, fra sfera individuale e sfera sociale, fra
società e Stato, nel mondo moderno l'uomo è costretto a vivere come
due vite: una «in terra» come «borghese», cioè nell'ambito
dell'egoismo e degli interessi particolari della società civile, e l'altra
«in cielo» come «cittadino», ovvero nella sfera superiore dello Stato e
dell'interesse comune.
La falsa universalità dello Stato moderno.
Tuttavia il «cielo» dello Stato, secondo Marx, è puramente
illusorio, poiché la sua pretesa di porsi come organo che persegue
l'interesse comune, ossia come universale che media gli interessi
particolari della società, è verificabilmente falsa. Infatti, anziché
essere lo Stato che imbriglia la società civile, «innalzandola» al bene
comune, è piuttosto la società civile che imbriglia lo Stato,
«abbassandolo» a semplice strumento degli interessi particolari delle
classi più forti. In altre parole, lo Stato, ben lontano dal perseguire
mete generali, non fa che riqettere e sanzionare gli interessi
particolari dei gruppi e delle classi. Tant'è vero che la stessa
proclamazione dell'uguaglianza «formale» dei cittadini di fronte alla
legge, che è la grande conquista della Rivoluzione francese, non fa che
presupporre e ratificare la loro disuguaglianza «sostanziale». In
sintesi, la civiltà moderna rappresenta, al tempo stesso, la società
dell'egoismo e delle particolarità «reali» e della fratellanza e
delle universalità «illusorie».
(Circa la sottile dialettica marxista dell'universalità illusoria e
della particolarità reale, cfr. N. Bobbio - M. Bovero Modello
giusnaturalistico e modello hegelomarxiano, Il Saggiatore, Milano 1980.)
Di conseguenza, commenta ironicamente Marx, come i cristiani, pur essendo
tutti diseguali in terra, si consolano di essere tutti eguali in cielo,
così gli individui dell'epoca borghese, pur essendo tutti diseguali nella
società civile, si consolano di essere tutti eguali di fronte allo Stato,
il quale, nel capitalismo, non può che assumere le sembianze di una
evanescente democrazia «cristiana».
L'individualismo e l'atomismo della civiltà borghese.
Secondo Marx la falsa universalità dello Stato deriva dunque dal tipo di
società che si è formata nel mondo moderno. Rifacendosi ancora una volta
ad Hegel, che aveva descritto il sistema borghese come la società del
bellum omnium contra omnes, Marx scorge i tratti essenziali della
civiltà moderna nell'«individualismo» e nell'«atomismo», ossia nella
«separazione» del singolo dal tessuto comunitario. E siccome lo Stato
post-rivoluzionario legalizza questa situazione, riconoscendo, quali
«diritti dell'uomo», la libertà individuale (che nella Costituzione del
'93 viene intesa come l'esercizio di tutto ciò che non nuoce ad altri) e
la proprietà privata (che nella Costituzione del '93 si identifica con il
diritto di godere arbitrariamente dei propri beni), esso non è altro che
la proiezione politica di una società strutturalmente a-sociale o
contro-sociale. Questa critica filosofico-politica allo Stato è così
radicale, in Marx, da far sì che egli rifiuti in blocco la civiltà
liberale, comprese quelle che vengono comunemente ritenute le due
conquiste più preziose della rivoluzione anti-feudale ed anti-assolutistica:
il principio della «rappresentanza» (che presuppone già, per definizione,
la «scissione» fra individuo e Stato) e quello della libertà individuale
(espressione, come si è visto, dell'«atomismo» borghese).
L'ideale di una democrazia sostanziale o totale (= il comunismo).
Queste critiche allo Stato moderno, che scavano un abisso fra marxismo
ortodosso e liberalismo, si comprendono adeguatamente solo in rapporto
all'ideale di società che Marx ha in mente, che si identifica con un
modello di democrazia sostanziale o totale, in cui esiste una sorta di
compenetrazione perfetta fra singolo e genere, individuo e comunità, e
nella quale « ciascuno è realmente solo un momento dell'intero demos»,
che rappresenta, insieme agli altri, se stesso e la società. Mentre
Hegel pensava che tale società organica, simile alla polis greca, si
potesse ottenere con una serie di strumenti politici quali la
corporazione, la burocrazia e lo Stato, Marx, denunciando tutto ciò come
«mistificazione» (come si può pensare, ad esempio, che la burocrazia,
essendo espressione dei particolarismi della società civile, persegua
veramente fini universali?), ritiene che l'unico modo per realizzare tale
modello di comunità solidale sia l'eliminazione delle diseguaglianze
reali fra gli uomini, ed in particolare del principio stesso di ogni
diseguaglianza: la proprietà privata. Ma come tradurre concretamente in
atto questa «vera» democrazia, che coincide con il comunismo stesso?
Mentre nella Critica del 1843 lo strumento cui ricorre Marx è il
«suffragio universale», negli Annali franco-tedeschi e nei Manoscritti
economico-filosofici del 1844, l'arma cui egli fa appello è la rivoluzione
sociale, di cui Marx ha ormai individuato anche il soggetto esecutore:
il proletariato.
Infatti per il giovane Marx è proprio la classe priva di proprietà,
ovvero la classe che soffre maggiormente dell'«alienazione» prodotta
dalla società borghese (vedi paragrafo 5), quella destinata ad eseguire la
condanna storica della civiltà proprietaria ed egoistica, e a realizzare
la democrazia comunista.
Emancipazione politica ed emancipazione umana.
Di conseguenza, all'ideale dell'emancipazione politica, che mira alla
democrazia e all'uguaglianza formale, Marx contrappone l'ideale di una
emancipazione umana che mira alla democrazia e all'uguaglianza
sostanziale, ovvero al recupero autentico dell'«essenza sociale delluomo»
(das Kommunistische Wesen des Menschen).
5. La critica dell'economia borghese e la problematica dell'«alienazione».
I Manoscritti economico-filosofici, composti a Parigi nel 1844, segnano il
primo decisivo approccio di Marx all'economia politica e rappresentano
l'applicazione, in sede economica, degli schemi critico-dialettici
applicati precedentemente al campo politico.
I limiti dell'economia «borghese».
Nei confronti dell'economia « borghese » l'atteggiamento di Marx è duplice,
poiché da un lato egli la considera come un'espressione teorica della
società capitalistica, e quindi come una valida « anatomia » di essa,
e dall'altro le muove l'accusa di fornire un'immagine globalmente
mistificata, cioè falsa, del mondo borghese. Ciò è dovuto principalmente,
secondo Marx, alla sua incapacità di pensare in modo «dialettico».
Infatti, anziché collocarsi in una prospettiva storico-processuale,
essa «eternizza» il sistema capitalistico, considerandolo non come un
sistema economico fra i tanti della storia, ma come il modo naturale,
immutabile e razionale di produrre e di distribuire la ricchezza. Tant'è
vero che la stessa proprietà privata appare come un «fatto» da cui muovere,
cioè come un dato metastorico che funge da postulato di ogni ricerca di
economia «scientifica». Inoltre l'economia politica non scorge la struttura
contraddittoria del proprio oggetto, ossia la conflittualità che
caratterizza il sistema capitalistico e che si incarna soprattutto
nell'opposizione reale fra capitale e lavoro salariato, fra borghesia e
proletariato. Nei Manoscritti tale contraddizione viene espressa
mediante il concetto di «alienazione».
Il concetto di «alienazione».
Questo concetto affonda le sue radici nella filosofia tedesca
precedente. Per Hegel l'alienazione è il movimento stesso
dello Spirito, che si fa altro da sé, nella natura e nell'oggetto,
per potersi riappropriare di sé in modo arricchito. Come
tale l'alienazione riveste, in Hegel, un significato negativo e positivo
al tempo stesso. In Feuerbach l'alienazione è qualcosa di puramente
negativo, poiché si identifica con la situazione dell'uomo religioso,
che, «scindendosi», si sottomette ad una potenza estranea (Dio) che lui
stesso ha posto, «estraniandosi» in tal modo dalla propria realtà. Marx
si rifà soprattutto a Feuerbach, da cui accetta la struttura formale del
meccanismo dell'alienazione, intesa appunto come una condizione patologica
di «scissione», di «dipendenza» e di «autoestraniazione». Tuttavia, a
differenza di Feuerbach, per il quale l'alienazione è ancora
un fatto prevalentemente coscienziale, derivante da un'errata
interpretazione di sé, in Marx essa diviene un fatto reale, di natura
socio-economica, in quanto si identifica con la condizione storica del
salariato nell'ambito della società capitalistica.
Gli aspetti fondamentali dell'alienazione.
L'alienazione dell'operaio viene descritta da Marx sotto quattro aspetti
fondamentali, strettamente connessi fra di loro:
a) Il lavoratore è alienato rispetto al prodotto della sua attività,
in quanto egli, in virtù della sua forza-lavoro, produce un oggetto
(il capitale), che non gli appartiene e che si costituisce come una
potenza dominatrice nei suoi confronti.
b) Il lavoratore è alienato rispetto alla sua stessa attività, la quale
prende la forma di un «lavoro forzato» o «costrittivo>, in cui egli è
strumento di fini estranei (il profitto del capitalista), con la grave
conseguenza che l'uomo si sente «bestia» quando dovrebbe sentirsi
veramente «uomo», cioè nel lavoro sociale, e si sente uomo quando fa la
bestia, cioè si «stordisce» nel mangiare, nel bere e nel procreare.
Infatti sebbene queste ultime, puntualizza Marx, siano «anche funzioni
schiettamente umane», esse, in quell'astrazione che le separa dalla
restante cerchia dell'attività umana e le fa diventare scopi ultimi e
unici, sono funzioni animali.
c) Il lavoratore è alienato rispetto al suo stesso Wesen, ossia alla
sua «essenza» o «genere». Infatti la prerogativa dell'uomo nei confronti
dell'animale è il lavoro libero, creativo e universale (in quanto egli
« sa produrre secondo la misura di ogni specie»), mentre nella società
capitalistica è costretto ad un lavoro forzato, ripetitivo e unilaterale.
d) Il lavoratore è alienato rispetto al prossimo, perché «l'altro», per
lui, è soprattutto il capitalista, ossia un individuo che lo tratta come
un mezzo e lo espropria del frutto della sua fatica, facendo sì che il suo
rapporto con lui, e con l'umanità in genere, sia per forza conflittuale.
L'alienazione è causata dalla proprietà privata.
La causa del meccanismo globale dell'alienazione, la quale fa sì che
l'operaio sia ridotto a strumento per produrre una ricchezza che non gli
appartiene e che si erge di fronte a lui come potenza estranea, risiede
dunque nella proprietà privata dei mezzi di produzione, in virtù della
quale il possessore della fabbrica (= il capitalista) può utilizzare il
lavoro di una certa categoria di individui (= i salariati) per
accrescere la propria ricchezza, secondo una dinamica che Marx, nel
Capitale, descriverà in termini di «sfruttamento» e «logica del profitto».
La dis-alienazione dell'uomo si identifica dunque, secondo
Marx, con il superamento del regime della proprietà privata e con
l'avvento del comunismo.
La storia come luogo della perdita e della riconquista da parte dell'uomo
della propria essenza.
Di conseguenza, per il Marx dei Manoscritti, la storia si configura come
il luogo della perdita e della riconquista, da parte dell'uomo, della
propria essenza e il comunismo diviene «la soluzione dell'enigma della
storia». Questa dialettizzazione del corso storico rivela un evidente
influsso della hegeliana Fenomenologia dello Spirito. Infatti, come per
Hegel la coscienza, dopo essersi «perduta» in tante figure, «ritrova»
finalmente se stessa nell'eticità e nello spirito assoluto, così, per Marx,
l'uomo, dopo aver smarrito se stesso nella civiltà di classe, ritrova
finalmente se medesimo nella società assoluta del comunismo.
Meriti e demeriti di Hegel.
Ancora una volta, il rapporto Marx-Hegel, nelle analogie e nelle
diversità, si rivela decisivo. Infatti nel capitolo finale dei
Manoscritti Marx fa ancora una volta i conti col vecchio maestro. Egli
riconosce ad Hegel una serie di meriti: 1) per aver concepito l'uomo in
un'ottica storica e come risultato della propria attività, ossia come
«processo di autogenerazione»; 2) per aver sottolineato in tale processo
auto-formativo l'importanza del lavoro; 3) per aver inteso tale processo
in termini di alienazione e soppressione dell'alienazione; 4) per aver
evidenziato «la dialettica della negatività come principio motore e
generatore», ossia per aver intuito che la liberazione scaturisce
dialetticamente dall'oppressione, in quanto l'unico modo di realizzarsi,
per l'uomo, consiste nel negare le condizioni che negano il proprio essere.
Tuttavia, sebbene Hegel, in tal modo, abbia colto «l'espressione astratta,
logica, speculativa per il movimento della storia», i suoi limiti consistono
sostanzialmente: 1) nell'aver ridotto l'individuo ad «autocoscienza» o
«spirito», mettendo quindi, al posto dell'uomo reale, l'essenza astratta
di esso; 2) nell'aver considerato soprattutto il lavoro spirituale e
«speculativo», quale si incarna nella figura del filosofo; 3) nell'aver
inteso l'alienazione e la disalienazione come delle operazioni ideali,
che si consumano a livello coscienziale e filosofico e non sul
piano pratico; 4) nell'aver identificato l'alienazione con l'oggettivazione
del soggetto, non rendendosi conto che ciò che aliena l'individuo non è
l'oggettivazione in quanto tale, attuata tramite il lavoro, ma
quell'ogettivazione negativa e disumanizzante che è propria del lavoro
oeraio nella società capitalistica.
In sintesi, Hegel non ha fotografato la storia vera ed il suo processo
concreto di alienazione e disalienazione, poiché si è limitato a
descrivere una storia ideale ed astratta, che si svolge tutta nel
cerchio del puro pensiero e che non presuppone degli interventi pratici
sul mondo. Di conseguenza, la teoria di Hegel non ha niente a che fare
coll'alienazione e la disalienazione effettiva, essendo piuttosto lo
specchio mistificato di essa.
L'alienazione economica come causa di tutte le altre alienazioni.
Ma se l'alienazione economica è un fatto reale, che sta alla base
di tutte le altre alienazioni, soprattutto di quella politica
(vedi paragrafo 4) e di quella religiosa (vedi paragrafo 6), l'unico modo
per abbatterla, secondo Marx, è l'atto reale, e non puramente pensato,
della rivoluzione e dell'instaurazione del socialismo, inteso come
«umanismo giunto al proprio compimento».
6. Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave
«sociale».
Il rapporto con Feuerbach.
Analogamente ad Hegel, anche Feuerbach ha giocato, nel pensiero del
giovane Marx, un ruolo di primo piano. Infatti nei Manoscritti del
1844 Marx afferma che con Feuerbach «è il solo che si trovi in un
rapporto serio, in un rapporto critico, con la dialettica hegeliana, ed
abbia fatto in questo campo delle autentiche scoperte». Tant'è vero che
egli appare a Marx «il vero superatore della vecchia filosofia».
Tuttavia, nelle Tesi su Feuerbach (1845) e nella successiva Ideologia
tedesca (1846), il rapporto con il maestro di un tempo appare
definitivamente consumato. Vediamo schematicamente i vari momenti
concettuali di tale processo.
La principale «rivoluzione teoretica» di Feuerbach consiste, agli occhi
di Marx, nella rivendicazione della naturalità e concretezza degli
«individui umani viventi» e nel rifiuto dell'idealismo teologizzante di
Hegel, che ha ridotto l'uomo ad autocoscienza e a manifestazione di un
soggetto spirituale infinito. In particolare, Feuerbach ha avuto il
merito di teorizzare il «rovesciamento materialistico» di
soggetto-predicato, concreto-astratto (vedi paragrafo 3), che ha permesso
la «demistificazione» della dialettica hegeliana. Pur avendo sottolineato
la naturalità dell'uomo (e questo è il passo in avanti rispetto ad
Hegel), Feuerbach (e questo è il passo indietro rispetto a lui) ha perso
di vista la sua storicità, non rendendosi debitamente conto che l'uomo,
più che natura è società, e quindi storia, in quanto « l'essere umano non
è un'astrazione immanente all'individuo singolo» bensì «l'insieme dei
rapporti sociali» (sesta tesi). Rompendo con Feuerbach e con l'antropologia
filosofica tradizionale, che parlava dell'uomo come di un'essenza
atemporale fornita di certe proprietà immutabili, Marx sostiene che
l'individuo è reso tale dalla società storica in cui egli vive, per cui
non esiste l'«Uomo» in astratto, ma l'uomo figlio e prodotto di una
determinata società e di uno specifico mondo storico.
La « correzione di Hegel con Feuerbach e viceversa.
In tal modo, Marx corregge Hegel con Feuerbach e Feuerbach con Hegel,
poiche, contro l'uno può difendere la naturalità vivente dell'uomo, e,
contro l'altro, la sua costitutiva socialità e storicità. Nello stesso
tempo, egli può sostenere che ogni discorso sull'uomo si risolve
inevitabilmente in un discorso sulla società e sulla storia, preparando
così il passaggio dalla problematica antropologica all'indagine storica e
socio-economica, secondo un processo che Althusser ha descritto come
transizione dalla filosofia alla scienza.
Un secondo punto che unisce e divide Marx da Feuerbach è
l'interpretazione della religione. Pur avendo «scoperto» il meccanismo
generale dell'alienazione religiosa - per cui non è Dio a creare l'uomo,
ma l'uomo a « proiettare» Dio sulla base dei propri bisogni - Feuerbach, in
virtù della sua concezione prevalentemente «naturalistica» dell'uomo, non
è stato in grado, secondo Marx, di cogliere le cause reali del fenomeno
religioso, né di offrire dei validi mezzi per il suo superamento. Infatti
all'autore dell'Essenza del Cristianesimo è sfuggito che chi produce la
religione non è un soggetto astratto, avulso dalla storia ed
immutabilmente uguale a se stesso, ma un individuo che è «un prodotto
sociale» (settima tesi). Ma se «l'uomo non è altro che il mondo dell'uomo,
lo Stato la società», risulta ovvio, per Marx, che le radici del fenomeno
religioso non vanno cercate nell'uomo in quanto tale, ma in un tipo
storico di società.
La religione come «oppio dei popoli».
Infatti, sin dagli Annali franco-tedeschi, Marx è
andato elaborando la sua nota teoria della religione come Opium des
Volks (= oppio dei popoli). Secondo questa dottrina, la religione, in
sostanza, è un «sospiro della creatura oppressa», ossia il prodotto di
un'umanità alienata e sofferente per causa delle ingiustizie sociali, che
cerca illusoriamente nell'aldilà ciò che le è negato di fatto nell'aldiqua.
La disalienazione religiosa ha come presupposto la disalienazione economica.
Ma se la religione, in quanto narcotico delle masse, è il sintomo di una
condizione umana e sociale alienata, l'unico modo per eliminarla non è la
critica filosofica (come pensava ancora Feuerbach, nella sua astrattezza di
intellettuale), ma la trasformazione rivoluzionaria della società. In
altri termini, se la religione è il frutto malato di una società malata,
l'unico modo per sradicarla è quello di distruggere le strutture sociali
che la producono. La disalienazione religiosa ha dunque, come suo
presupposto, la disalienazione economica, ossia l'abbattimento della
società di classe.
Secondo Marx, un altro limite di fondo del pensiero di Feuerbach, che
lo accomuna alla tradizione, risiede nel tendenziale contemplativismo e
teoreticismo. Infatti egli, a giudizio di Marx, ha ignorato l'aspetto
attivo e pratico della natura umana e ha cercato la soluzione dei
problemi reali nella dimensione della teoria, trascurando completamente
l'aspetto della praxis rivoluzionaria. Di conseguenza, al vecchio
materialismo speculativo e contemplante, di cui Feuerbach è l'ultima
incarnazione, Marx oppone un nuovo materialismo, che considera l'uomo
soprattutto come prassi, ritenendo che la soluzione dei problemi non
sia da ricercarsi nella speculazione, ma nell'azione «I filosofi hanno
solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di mutarlo»
(11esima tesi).
7. La concezione materialistica della storia.
7.1. Dall'«ideologia» alla scienza».
L'ideologia tedesca.
La critica a Feuerbach segna il passaggio di Marx dall'umanismo al
materialismo storico, poiché coincide con la transizione dall'antropologia
speculativa al «sapere reale» della storia. Il testo in cui si concretizza
tale processo è L'ideologia tedesca, scritta da Marx ed Engels, con la
collaborazione di M. Hess, durante l'esilio di Bruxelles (1845-1846) e
rimasta inedita sino al 1932. Più di dieci anni dopo, nella Prefazione a
Per la critica dell'economia politica (1857), Marx dirà di essa:
«Decidemmo di mettere in chiaro, con un lavoro comune, il contrasto tra
il nostro modo di vedere e la concezione ideologica della filosofia
tedesca, di fare i conti, in realtà, con la nostra anteriore coscienza
filosofica».
Prima ancora che nei contenuti, l'originalità di quest'opera risiede nel
tentativo di cogliere il «movimento reale» della storia, al di là delle
rappresentazioni ideologiche che ne hanno velato da sempre la struttura
effettiva e le concrete forze motrici. Infatti, il discorso
storico-materialistico di Marx ed Engels presuppone una basilare
contrapposizione fra «scienza reale e positiva» ed «ideologia».
Questultimo termine, alla fine del Settecento, aveva assunto, con
Destutt de Tracy, il significato di un'analisi gnoseologica delle idee
nel loro derivare dalle sensazioni, ossia di uno studio della base
empirica dello scibile. Con Napoleone il termine riveste una
connotazione spregiativa e polemica, poiché «ideologo» diviene sinonimo
di intellettuale «testa calda» e avulso dalla realtà. Marx ed Engels
riprendono tale nozione, usandola, per lo più, in modo negativo, ma
dando ad essa nuovi e profondi significati.
Il concetto marxista di ideologia.
In una delle sue accezioni principali l'ideologia appare come una «falsa
rappresentazione » della realtà, ed allude al processo per cui alla
comprensione oggettiva dei rapporti reali fra gli uomini si sostituisce
un'immagine deformata di essi. In altre parole, discorrere di
rappresentazione ideologica del mondo equivale a parlare, secondo i
classici del marxismo, di rappresentazione costituzionalmente
mistificante di esso. Di altri significati, nonché delle «cause» e della
«funzione» sociale delle ideologie diremo in seguito, quando conosceremo
meglio il discorso marxista sulla storia (vedi paragrafo 7.4). Per ora
ci basti sapere che l'intento di Marx è quello di svelare, al di là delle
ideologie, la verità sulla storia, mediante il raggiungimento di un
punto di vista obbiettivo sulla società, che permetta di descrivere non
ciò che gli uomini «possono apparire nella rappresentazione propria o
altrui, bensì quali sono realmente» (L'ideologia tedesca, Roma 1969,
pagina 12).
La «scienza» della storia.
Questo programma comporta, ovviamente, la distruzione della vecchia
filosofia idealistica e l'inaugurazione di una nuova «scienza», in
relazione a cui la filosofia viene ad assumere l'ufficio strumentale di
«sintesi dei risultati più generali che è possibile astrarre dall'esame
dello sviluppo storico degli uomini» (ivi, pagina 14).
La storia come processo «materiale» alla cui base sta il lavoro.
Ma che cos'è l'umanità, intesa finalmente in modo scientifico e non
ideologico? Marx risponde in prima definizione che essa è una specie
evoluta, composta di individui associati, che lottano per la propria
sopravvivenza. Di conseguenza, la storia non è, primariamente, un evento
spirituale, ma un processo materiale fondato sulla dialettica
bisogno-soddisfacimento:
«Il vivere implica prima di tutto il mangiare e bere, l'abitazione, il
vestire e altro ancora. La prima azione storica è dunque la creazione
dei mezzi per soddisfare questi bisogni; la produzione della vita
materiale stessa... che ancora oggi, come millenni addietro, deve essere
compiuta ogni giorno e ogni ora semplicemente per mantenere in vita gli
uomini» (ivi, pagina 18).
Ed è proprio quest'azione « materiale » che umanizza l'uomo. Infatti,
commenta ironicamente Marx, si possono distinguere gli uomini dagli
animali per la coscienza, per la religione, per tutto ciò che si vuole,
ma essi cominciarono di fatto a distinguersi dagli animali allorché, in
virtù della necessità, cominciarono a produrre i loro mezzi di
sussistenza. Alla base della storia vi è dunque il lavoro, che Marx
intende come creatore di civiltà e di cultura e come ciò attraverso cui
l'uomo si rende tale, emergendo dall'animalità primitiva e distinguendosi
dagli altri esseri viventi.
7.2. Struttura e sovrastruttura.
Le forze produttive
Nell'ambito di quella «produzione sociale dell'esistenza» che costituisce
la storia, bisogna distinguere, secondo Marx, due elementi di fondo:
le forze produttive e i rapporti di produzione. Poiché questi concetti
stanno alla base della scienza storica marxista, è importante afferrarne
bene, sin dall'inizio, il preciso significato. Per forze produttive Marx
intende tutti gli elementi necessari al processo di produzione, ossia,
fondamentalmente:
1) gli uomini che producono (= la forza lavoro);
2) i mezzi (terra, macchine eccetera) che utilizzano per
produrre (= i mezzi di produzione);
3) le conoscenze tecniche e scientifiche di cui si servono per
organizzare e migliorare la loro produzione.
I rapporti di produzione.
Per rapporti di produzione Marx intende i rapporti che si instaurano fra
gli uomini nel corso della produzione e che regolano il possesso e
l'impiego dei mezzi di lavoro, nonché la ripartizione di ciò che tramite
essi si produce. I rapporti di produzione trovano la loro espressione
giuridica nei rapporti di proprietà.
Forze produttive e rapporti di produzione costituiscono, nella loro
globalità, il «modo di produzione» di un certo periodo.
Struttura e sovrastruttura.
L'insieme dei rapporti di produzione, o, più in generale, la base economica,
quale si esprime nel «modo di produzione» e nella relativa dialettica tra
forze produttive e rapporti di produzione (cfr. paragrafo 7.3), costituisce
la struttura, ovvero lo scheletro economico, della società, intesa come
organismo complessivo. Infatti, rispetto alla totalità sociale la
struttura rapprsenta il piedistallo concreto su cui si eleva una
sovrastruttura giuridico-politico-culturale. In altre parole, il termine
sovrastruttura (dal tedesco überbau: über = sopra, Bau = costruzione)
sta ad indicare che secondo il materialismo storico i rapporti giuridici,
le forze politiche, le dottrine etiche, artistiche, religiose e filosofiche
non debbono essere intese, idealisticamente, come delle realtà a sé
stanti, ma come delle espressioni più o meno dirette dei rapporti che
definiscono la struttura di una certa società storica. Ecco, a questo
proposito, il limpido testo di Max:
«La mia ricerca arrivò alla conclusione che tanto i rapporti giuridici
quanto le forme dello Stato non possono essere compresi né per se stessi,
né per la cosiddetta evoluzione generale dello spirito umano, ma hanno le
loro radici, piuttosto, nei rapporti materiali dell'esistenza il cui
complesso viene abbracciato da Hegel... sotto il termine di "società
civile"; e che l'anatomia della società è da cercare nell'economia politica.
Il risultato generale al quale arrivai e che, una volta acquisito, mi
servì da filo conduttore nei miei studi, può essere brevemente formulato
così: nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in
rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in
rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di
sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi
rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società,
ossia la base reale sulla quale si eleva la sovrastruttura giuridica e
politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza
sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in
generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è
la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al
contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza...»
(Prefazione a Per la critica dell'economia politica).
Il materialismo storico.
Di conseguenza, non sono le leggi, lo Stato, le forze politiche, le
religioni, le filosofie eccetera, che determinano la struttura economica
della società (= idealismo storico), ma è la struttura economica che
determina le leggi, lo Stato, le religioni, le filosofie eccetera
(= materialismo storico. Da quanto si è detto emerge chiaramente
come il termine «materialismo», usato da Marx per denominare la propria
dottrina, non alluda, come nel linguaggio filosofico tradizionale, alla
tesi metafisica secondo cui la materia è la sostanza e la causa delle
cose, ma al convincimento secondo cui le vere forze motrici della storia
non sono di natura spirituale, come pensavano per lo più i filosofi
precedenti, bensì di natura socio-economica. In altri termini, quello
di Marx è un materialismo storico che si contrappone polemicamente
all'idealismo storico. Soltanto con Engels troviamo il materialismo inteso
come dottrina complessiva dell'universo (vedi paragrafo 12).
I rapporti struttura-sovrastruttura.
Nell'ambito della critica marxista il rapporto struttura-sovrastruttura è
stato oggetto di molteplici e talora discordanti interpretazioni. Senza
entrare in merito a tali discussioni è bene osservare che:
1) Quando Marx impiega il termine sovrastruttura intende sottolineare, per
mezzo di un'immagine visiva, la dipendenza dei fenomeni politici e culturali
dalla base economica, ma non intende ridurre questi ultimi a qualcosa di
superfluo o di poco importante. Infatti, come chiarisce incisivamente
Antonio Labriola: «i meditati disegni, i propositi politici, le scienze,
i sistemi di diritto e così via, anzi che essere il mezzo e l'istrumento
della spiegazione della storia, sono appunto la cosa che occorre
spiegare; perché derivano da determinate condizioni e situazioni. Ma ciò
non vuol dire che siano mere apparenze e bolle di sapone. L'esser quelle
delle cose divenute e derivate da altre non implica che non sian cose
effettuali: tanto è che son parse per secoli alla coscienza non
scientifica, e alla coscienza scientifica ancora in via di formazione,
le sole che veramente fossero» (Del Materialismo storico).
2) Per indicare il rapporto fra struttura a sovrastruttura Marx fa uso
di due termini: «determinare» e «condizionare». Sebbene egli li utilizzi
indifferentemente, la loro portata concettuale è diversa, poiché
«determinare» denota un rapporto più stretto ed immediato, mentre
«condizionare» allude ad un rapporto più lato e indiretto. Questo uso
ambiguo è probabilmente dovuto al fatto che Marx, com'è stato osservato
ad esempio da Luciano Gruppi, vuole sottolineare la dipendenza della
sovrastruttura dalla struttura, evitando nel contempo di concepirla in
modo meccanico ed immediato. Ciò vale soprattutto quando si tratta delle
idee artistiche, filosofiche e religiose, poiché secondo quanto
chiarisce Engels: «Quanto più il terreno che stiamo indagando si
allontana dal terreno economico e si avvicina al terreno ideologico
puramente astratto, tanto più troveremo che esso rappresenta nella sua
evoluzione degli elementi fortuiti, tanto più la sua curva si svolge a
zigzag. Ma se vi provate a tracciare l'asse medio della curva troverete
che, quanto più lungo è il periodo preso in esame e quanto più esteso è
il terreno studiato, tanto più quest'asse si avvicina all'asse
dell'evoluzione economica e corre parallelamente a questultimo» (Lettera
a H. Starkenburg, 25, 1, 1894).
3) Marx non nega che le idee possano influire sugli avvenimenti storici,
anche se ciò, dal suo punto di vista, può accadere soltanto perché le
idee esprimono già, a loro volta, determinati mutamenti di struttura
(ad esempio è vero che le idee dei philosophes hanno agito sugli
avvenimenti successivi, ma ciò è potuto accadere solo perché le
idee «rivoluzionarie», in Francia, rispecchiavano a loro volta una
situazione già oggettivamente «rivoluzionaria»). Per cui, stando ai
testi di Marx, l'unico elemento veramente determinante della storia,
e l'unico fattore che si autodetermina, è la struttura economica, mentre
la sovrastruttura, con tutto ciò che ne fa parte, è unicamente un riflesso
della struttura, che partecipa solo indirettamente della sua storicità.
Infatti, di per sé, le istituzioni giuridico-politiche e le idee « non
hanno storia, non hanno sviluppo, ma gli uomini che sviluppano la loro
produzione materiale e le loro relazioni materiali trasformano, insieme con
questa loro realtà, anche il loro pensiero e i prodotti del loro
pensiero » (Ideologia tedesca, pagina 13).
7.3. La legge della storia e le grandi formazioni economico-sociali.
La teoria della corrispondenza e della contraddizione tra forze
produttive e rapporti di produzione
Forze produttive e rapporti di produzione, oltreché rappresentare la
chiave di lettura della statica della società, si configurano anche come
lo strumento interpretativo della sua dinamica, poiché si identificano
con la molla propulsiva del suo divenire, ovvero con la legge stessa della
storia. Marx ritiene infatti che ad un determinato grado di sviluppo
delle forze produttive tendano a corrispondere determinati rapporti di
produzione e di proprietà (ad esempio, rapporti di produzione di tipo
feudale corrispondono a forze produttive di tipo agricolo). Tuttavia i
rapporti di produzione si mantengono soltanto sino a quando favoriscono le
forze produttive e vengono distrutti quando si convertono in ostacoli o
catene per le medesime. Ora, poiché le forze produttive, in connessione
con il progresso tecnico, si sviluppano più rapidamente dei rapporti di
produzione, che esprimendo delle relazioni di proprietà tendono a rimanere
statici, ne segue periodicamente una situazione di frizione o di
contraddizione dialettica fra i due elementi, che genera «un'epoca di
rivoluzione sociale».
Infatti le nuove forze produttive sono sempre incarnate da una classe in
ascesa, mentre i vecchi rapporti di proprietà sono sempre incarnati da una
classe dominante al tramonto. Di conseguenza, risulta inevitabile lo
scontro fra di esse, che si gioca non solo a livello sociale, ma anche
politico e culturale (sotto forma, in quest'ultimo caso, di « battaglia
delle idee»). Alla fine finisce quasi sempre per trionfare la classe che
risulta espressione delle nuove forze produttive, che in tal modo riesce
ad imporre la propria maniera di produrre e di distribuire la ricchezza,
nonché la sua specifica visione del mondo, poiché «le idee della classe
dominante sono in ogni epoca le idee dominanti; cioè la classe che è la
potenza materiale dominante è in pari tempo la sua potenza spirituale
dominante».
Esemplificazioni storiche.
Questo modello teorico, secondo Marx, trova la sua tipica
esemplificazione, per quanto riguarda il passato, nella Francia del
Settecento, dove, ad un certo punto, vi fu uno scontro aperto fra la
borghesia (espressione delle nuove forze produttive di tipo
capitalistico) e l'aristocrazia (espressione dei vecchi rapporti di
proprietà agrario-feudali e quindi interessata al loro mantenimento).
Vinse alla fine la borghesia, che riuscì ad imporre i suoi rapporti di
proprietà e la sua visione del mondo. Analogamente, nel capitalismo moderno
si sta delineando una contraddizione sempre più «esplosiva» fra forze
produttive sociali e rapporti di produzione privatistici. Infatti la
fabbrica moderna, pur essendo proprietà di un capitalista (o di un gruppo
di azionisti), produce soltanto grazie al lavoro collettivo di operai,
tecnici, impiegati, dirigenti eccetera. Ma se sociale è la produzione della
ricchezza, sociale deve essere, secondo Marx, la distribuzione di essa. Ma
questo significa che il capitalismo porta in sé, come esigenza dialettica,
il socialismo. Infatti Marx afferma che il capitalismo pone le basi del
socialismo, in quanto genera, per la prima volta nella storia, le
«condizioni oggettive » favorevoli ad una rivoluzione comunista
mondiale (vedi paragrafo 9).
La legge della «corrispondenza» e della «contraddizione» tra forze
produttive e rapporti di produzione permette dunque a Marx di delineare un
quadro generale della storia passata e presente, e di scandire il cammino
dell'umanità nel tempo secondo alcune grandi formazioni economico-sociali
qualificate da determinati modi di produrre, da specifici rapporti di
proprità, da peculiari istituzioni giuridico-politiche e da corrispondenti
forme di coscienza.
Le grandi formazioni economico-sociali.
Nella Prefazione a Per la critica dell'economia politica, dove compare
l'espressione ökonomische Gesellschaftsformation (mentre in L'ideologia
tedesca si parla semplicemente di «forme di proprietà»), Marx distingue
quattro « epoche» della formazione economica della società: quella asiatica
(fondata su forme comunitarie di proprietà), quella antica di tipo
schiavistico, quella feudale e quella borghese. Tuttavia, poiché sia Marx
che Engels accennano talora ad una « comunità primitiva » (Urgemeinschaft)
di stampo comunista (sia intesa alla stregua di un tipo generale di cui la
società asiatica sarebbe un sottotipo, sia intesa come tipo distinto e a
sé stante) si può dire che le grandi formazioni economico-sociali
individuate dai «classici del marxismo» siano la comunità primitiva,
la società asiatica, la società antica, la società feudale, la società
borghese e la futura società socialista.
Carattere «progressivo» della storia.
Sebbene queste epoche non costituiscano, a rigore, delle tappe
necessarie, in quanto molte società hanno saltato l'una o l'altra fase, è
indubbio che esse costituiscano, dal punto di vista di Marx, altrettanti
gradini di una sequenza che procede dall'inferiore al superiore.
Altrettanto indubbio è che la storia, secondo i classici del marxismo,
proceda dal comunismo primitivo (comunque inteso o prospettato) al
comunismo futuro, attraverso il momento intermedio della società di
classe, la quale si basa sulla divisione del lavoro e sulla proprietà
privata (due concetti che per Marx sono identici, in quanto «con la
prima si esprime in riferimento all'attività esattamente ciò che con
l'altra si esprime in riferimento al prodotto dell'attività»).
Il comunismo come sbocco inevitabile della società.
Parimenti indubbio è che questo diagramma storico dello sviluppo della
civiltà (che tanto fascino ha esercitato sugli intelletti) poggi sulla
tesi-convinzione del socialismo come sbocco inevitabile della dialettica
storica: «Il comunismo per noi non è uno stato di cose che debba essere
instaurato, un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo
comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti».
Differenze fra la «dialettica» storica di Marx e quella di Hegel.
Il carattere «dialettico» del materialismo storico di Marx ed il suo
persistente legame con Hegel risulta dunque evidente. Infatti anche per
Marx, come per Hegel, la storia si configura - formalmente - come una
totalità processuale dominata dalla forza della contraddizione e mettente
capo ad un «risultato finale». Però con questa notevole differenza di
contenuto: che Marx ritiene di aver fatto camminare la dialettica di
Hegel «sui piedi», anziché sulla «testa»:
1) in quanto il soggetto della dialettica storica non è più lo Spirito,
ma la struttura economica e le classi;
2) in quanto la «dialetticità» del processo storico è concepita come
«empiricamente» e scientificamente «osservabile» nei fatti stessi;
3) in quanto le opposizioni che muovono la storia non sono astratte e
generiche, bensì concrete e determinate, pur riconducendosi tutte a
quella dialettica tra forze produttive e rapporti di produzione che
rappresenta il cuore ed il centro strategico di tutta la scienza
marxista della società.
7.4. La critica agli «ideologi» della Sinistra hegeliana.
In che senso i rappresentanti della Sinistra hegeliana sono ancora degli
« ideologi»...
La conoscenza delle linee generali del materialismo storico permette di
intendere in modo adeguato anche la critica marxista ai rappresentanti
della Sinistra hegeliana (cui è dedicata gran parte dell'Ideologia
tedesca). Il concetto complessivo mediante il quale Marx ed Engels
schematizzano tali filosofi, come segnala il titolo che è stato dato
all'opera, è quello di «ideologi». Con questo termine, essi intendono
dire, in sostanza, che tali filosofi vivono nella « falsa coscienza »,
poiché non si rendono conto che le idee, in quanto rispecchiano le
relazioni materiali degli uomini, non hanno un'esistenza autonoma.
smarrendo i contatti con la realtà e ritirandosi nei loro castelli
speculativi, gli ideologi finiscono invece:
1) per sopravvalutare la funzione delle idee e degli intellettuali, viste,
le une, come le forze trainanti degli avvenimenti, e concepiti, gli altri,
come i «fabbricanti della storia»;
2) per presentare le proprie idee come universalmente e sovratemporalmente
valide;
3) per credere che tutto il negativo del mondo risieda nelle «idee
sbagliate» che gli individui si fanno circa se medesimi e che
l'emancipazione umana consista nel sostituire a idee false idee «vere»,
tramite una battaglia puramente «filosofica»;
4) per fornire, come conseguenza di tutto ciò, un quadro inevitabilmente
deformante o «mistificante» del reale.
...e le contro-tesi di Marx.
A questi traviamenti dell'ideologia, Marx, sulla base della propria
concezione materialistica della storia, oppone, invece, punto per punto,
che le vere forze motrici della storia non sono le idee, bensì le strutture
economico-sociali; che le idee non hanno mai un valore universale e
sovratemporale, in quanto rispecchiano sempre determinati interessi e
rapporti storici fra gli uomini; che la vera alienazione non risiede nelle
idee, ma nelle situazioni sociali concrete in cui gli uomini si trovano a
vivere, per cui la vera disalienazione o liberazione dell'uomo non è un
problema filosofico risolvibile sul piano sovrastrutturale della critica
teorica, ma un problema pratico-sociale, risolvibile sul piano strutturale
della rivoluzione; che i giovani hegeliani, con le loro «frasi», anziché
«scuotere il mondo», non fanno che emetter dei «belati filosofici», non
rendendosi conto che essi «non combattono il mondo realmente esistente
quando combattono soltanto le frasi di questo mondo»; che il sapere
effettivo può essere soltanto un sapere aderente al reale, e quindi una
conoscenza non-ideologica, anzi anti-ideologica per programma.
Le «cause» e le «funzioni» delle ideologie.
L'originalità del marxismo non risiede soltanto nella denuncia del sapere
«ideologico» della Sinistra hegeliana - come di gran parte della tradizione
filosofica e culturale - ma anche nella messa in luce delle «cause» e delle
«funzioni» sociali dell'ideologia. Innanzitutto, come mai, ad un certo
punto, si produce quella separazione fra teoria e prassi da cui si origina
l'ideologia? La risposta di Marx è in linea con la metodologia
storico-materialistica del suo pensiero: «se nell'intera ideologia gli
uomini e i loro rapporti appaiono capovolti come in una camera oscura,
questo fenomeno deriva dal processo storico della loro vita », ossia
dalla «divisione sociale del lavoro ». Infatti, in virtù di quest'ultima,
che implica innanzitutto una separazione fra lavoro manuale e lavoro
intellettuale, la coscienza si pone come qualcosa di autonomo e fa delle
proprie idee la realtà «vera », sino a fare dello Spirito, la sostanza
stessa del mondo.
Il concetto marxista di ideologia non è assimilabile a quello
(illuministico) di «bugia».
Pur affondando le loro radici nella divisione del lavoro, le ideologie,
per Marx, assolvono un'importante funzione, in quanto servono ad occultare
i reali processi della società e a mascherare l'asservimento dell'uomo.
In altre parole, «la mistificazione ideologica» fa parte integrante di
ogni società di classe, che non si regge solo sulla forza, ma anche
sulla «menzogna» intellettuale. Tuttavia, le ideologie di cui parla Marx,
a differenza delle «bugie dei preti» o delle «escogitazioni dei potenti»
di cui discorrevano gli illuministi, non sono per lo più qualcosa di
«consapevole», in quanto affondano nella sfera del
non-esplicitamente-cosciente, sottraendosi, come tali, ad un calcolo
deliberato. In altre parole, le ideologie sono delle «necessità sociali»
che si formano, per lo più, indipendentemente dalla volontà e dalla
coscienza degli individui, che infatti non si «accorgono», in genere,
di essere degli ideologi, né di fungere da difensori occulti di determinati
interessi sociali.
8. La sintesi del «Manifesto».
8.1. Borghesia, proletariato e lotta di classe.
Articolazionedel Manifesto.
Il Manifesto del partito comunista (1848), nel quale Marx si propone di
esporre «in faccia al mondo» gli scopi e i metodi dell'azione
rivoluzionaria, rappresenta una stringata summa della concezione marxista
del mondo. I punti salienti di esso sono:
1) l'analisi della funzione storica della borghesia;
2) il concetto della storia come «lotta di classe» ed il rapporto fra
proletari e comunisti;
3) la critica dei socialismi non-scientifici.
La funzione storica della borghesia...
Nella prima parte del Manifesto Marx descrive, con un'eloquenza
brillante, la vicenda storica della borghesia, sintetizzandone, dal suo
punto di vista, meriti e limiti. A differenza delle classi che hanno
dominato nel passato, che tendevano alla conservazione statica dei modi
di produzione, la borghesia, secondo Marx, non può esistere senza
rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione e tutto l'insieme
dei rapporti sociali. Di conseguenza, la borghesia appare una classe
costituzionalmente dinamica, che ha dissolto non solo le vecchie
condizioni di vita, ma anche idee e credenze tradizionali.
La borghesia ha modificato la faccia della terra in una misura che non
ha precedenti nella storia, mostrando ai popoli che cosa possa l'attività
umana. Ha compiuto ben altre meraviglie che le piramidi d'Egitto, gli
acquedotti di Roma e le cattedrali gotiche; ha portato a termine ben
altre spedizioni che gli spostamenti dei popoli e le Crociate in
Terrasanta. La borghesia ha realizzato per la prima volta l'unificazione
del genere umano, poiché il bisogno di uno smercio sempre più esteso per
i suoi prodotti l'ha spinta a percorrere tutto il globo terracqueo.
Agevolando le comunicazioni e trascinando nella civiltà tutti i paesi,
assoggettando l'Oriente all'Occidente, è riuscita a costruire un mercato
mondiale e a porre le basi per un reale cosmopolitismo. Nello stesso
tempo ha assoggettato la campagna alla città, distruggendo le antiche
civiltà contadine e creando centri urbani immensi. In una parola, scrive
Marx, essa si è creata un mondo a propria immagine e somiglianza.
...e le sue contraddizioni.
Senonché questa borghesia, che ha evocato come per incanto forze così
gigantesche, assomiglia allo stregone che non riesce più a dominare le
potenze infernali da lui evocate. Infatti le moderne forze produttive,
sempre più sociali, si rivoltano contro i vecchi rapporti di proprietà,
ancora privatistici e sottomessi alla logica del profitto personale,
generando delle crisi terribili, che mettono in forse l'esistenza stessa
del capitalismo. Tanto che il proletariato, classe oppressa della
società borghese, non può fare a meno di mettere in opera una dura lotta
di classe, volta al superamento del capitalismo e delle sue forme
istituzionali e ideologiche.
La storia come «storia di lotte di classi».
Il concetto della storia come «lotta di classe» è uno dei più
significativi del Manifesto. Infatti, se in L'ideologia tedesca Marx pone
come motore dello sviluppo sociale la dialettica tra forze produttive e
rapporti di produzione, in questa opera individua, come soggetto
autentico di storia, la lotta fra le classi:
«La storia di ogni società, esistita fino a questo momento, è storia di
lotte di classi. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi
della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in breve, oppressori e
oppressi, furono continuamente in reciproco contrasto, e condussero una
lotta ininterrotta, ora latente ora aperta; lotta che ogni volta è
finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con
la comune rovina delle classi in lotta».
Come abbiamo già accennato, parlare di dialettica tra forze produttive e
rapporti di produzione da un lato e di lotta di classe dall'altro, dal
punto di vista di Marx, nonostante qualche equivoco da parte dei suoi
interpreti, significa dire la stessa cosa, poiché le forze produttive e
i rapporti di produzione non sono «strutture senza soggetto», ma
risultano incarnate concretamente da quei gruppi di «individui umani
viventi» che sono le classi.
Il contributo di Marx alla teoria delle classi.
Marx non si è mai attribuito il merito di avere «scoperto» l'esistenza
delle classi nella società moderna, né la lotta esistente fra di loro.
Infatti nella lettera a Weydemeyer del 5-3-1852 egli ammette francamente
che molto prima di lui «storici borghesi hanno descritto lo sviluppo
storico di questa lotta delle classi ed economisti borghesi ne hanno
descritto l'anatomia economica». In realtà, come risulta dal seguito della
lettera, e dall'intera opera di Marx, il suo contributo originale, a
questo proposito, risiede piuttosto nell'aver puntualizzato che:
1) l'esistenza delle classi è legata a determinate fasi storiche di
sviluppo della produzione;
2) le classi si definiscono essenzialmente in relazione alla proprietà o
meno dei mezzi di produzione, la quale fa sì che in ogni epoca vi siano
sempre due classi fondamentali;
3) la lotta di classe conduce «necessariamente», attraverso la «dittatura
del proletariato (vedi paragrafo 10), alla soppressione di tutte le classi
e ad una società senza classi.
Tralasciando per ora l'argomento della presa del potere da parte del
proletariato e concentrandoci sulle nozioni di classe e di partito, si
noti come una delle caratteristiche del marxismo sia la distinzione fra
classe «in sé» e «per sé». Con questa terminologia, ch compare in
seguito ma che sottintende un concetto già presente nel Manifesto, Marx
intende dire che un conto è la classe intesa come aggregato di individui
che in una data società si trovano in una situazione economico-sociale
pressappoco identica, ed un conto è la classe intesa come unità
autocosciente che lotta in modo solidale per i medesimi obiettivi.
Evidentemente una classe si trasforma in soggetto rivoluzionario solamente
quando perviene alla coscienza di classe e aderisce al Partito comunista.
L'internazionalismo proletario.
Conformemente alle sue analisi del capitalismo come fatto mondiale, Marx
insiste inoltre sull'internazionalismo della lotta proletaria e termina
il Manifesto con il noto slogan rivoluzionario: «Proletari di tutti i
Paesi, unitevi!».
8.2. La critica dei falsi socialismi.
Una delle sezioni più importanti del Manifesto è costituita dalla critica di
Marx ai socialismi precedenti. Marx raggruppa e divide la letteratura
socialista e comunista in tre tendenze di fondo: il socialismo reazionario,
il socialismo conservatore o «borghese» e il socialismo e comunismo
critico-utopistici. Schieramenti che vengono divisi, a loro volta, in altre
sotto-correnti.
1) Il socialismo reazionario...
Il socialismo reazionario attacca la borghesia più secondo parametri
conservatori, rivolti al passato, che secondo schemi rivoluzionari rivolti
al futuro, proponendosi di «far girare all'indietro la ruota della storia».
Esso presenta tre forme: « feudale », «piccolo-borghese » e « tedesca ».
...e le sue forme.
Il socialismo feudale, medioevalistico e romanticheggiante (Marx allude
ad esempio a certo «legittimismo francese» e alla «Giovane Inghilterra»
capeggiata da Disraeli) auspica l'abolizione della società capitalistica
moderna e dei suoi inconvenienti, acutizzati dalla Rivoluzione francese
e dall'industrialismo, ed il recupero di un passato pre-rivoluzionario,
pre-borghese e pre-industriale. Sebbene i «feudali» cerchino l'alleanza
del proletariato, in funzione anticapitalistica, l'alleanza è basata su
di un equivoco: infatti mentre i primi vogliono sostituire l'alienazione
«attuale» con una alienazione «passata» (di stampo medioevale), i secondi
mirano al superamento di ogni alienazione. All'ombra del socialismo feudale
prolifica anche un « socialismo pretesco », il quale, secondo Marx, utilizza
il messaggio evangelico per darsi una «tinta socialistica».
Il socialismo piccolo-borghese, rappresentato soprattutto dall'economista
svizzero Sismondi (1773-1842), esprime il punto di vista della piccola
borghesia rovinata dal capitalismo industriale, che vorrebbe
anch'essa il ritorno ad una situazione pre-borghese, facendo rivivere il
sistema corporativo per l'industria manifatturiera ed il sistema
patriarcale per l'agricoltura.
Il socialismo «tedesco» o sedicente «vero socialismo» (Marx allude ad
esempio a K. Grün, H. Krieger, B. Bauer, M. Hess eccetera), anch'esso di
estrazione piccolo-borghese, rappresenta la traduzione germanica e
«filosofica» del socialismo francese. Esso usa infatti una terminologia
astratta ed interclassista, parlando più dell'«Uomo » che dei proletari.
Inoltre, nella sua rabbia anti-borghese, finisce per sostenere i governi
tedeschi della reazione, opponendosi in tal modo a quelle conquiste della
borghesia liberale (Stato rappresentativo, libertà di stampa eccetera) che
gli stessi operai avrebbero interesse ad ottenere.
2) Il socialismo conservatore o borghese.
Il socialismo conservatore «borghese» è incarnato da quegli economisti,
filantropi e umanitari che vorrebbero rimediare agli «inconvenienti»
sociali del capitalismo, senza distruggere il capitalismo stesso. Infatti,
nella loro mentalità a-dialettica, essi vorrebbero la borghesia senza il
proletariato, «la proprietà senza il furto», il lato positivo del sistema
borghese senza quello negativo, non accorgendosi che producendo se
medesimo il capitalismo produce inevitabilmente i suoi inconvenienti,
per cui esso non va «curato», bensì distrutto.
Principale esponente di questa corrente è Proudhon, che Marx aveva già
bersagliato nella Miseria della filosofia (1847), accusandolo di non
comprendere il meccanismo della dialettica e l'importanza dell'antagonismo
e delle contraddizioni, e di volere la proprietà senza i difetti che ne
conseguono, proponendosi non già di eliminare la proprietà stessa, ma di
distribuirla fra i lavoratori (del resto, la sua nota affermazione secondo
cui la proprietà è un «furto», rileva Marx, non fa che presupporre il
concetto stesso di proprietà).
3) Il socialismo e il comunismo critico-utopistico
Il socialismo e il comunismo critico-utopistico è costituito da quella
feconda corrente di idee pre-marxiane che conta soprattutto i nomi
di Saint-Simon, Fourier e Owen.
Pur avendo avuto il merito di scorgere l'antagonismo fra le classi e gli
elementi di contraddizione esistenti nel mondo moderno, questi autori,
che scrivono in un primo e poco sviluppato periodo della lotta del
proletariato, hanno il limite, secondo Marx, di non riconoscere al
proletariato una funzione storica e rivoluzionaria autonoma, e di fare
appello a tutti i membri della società, compresi i ceti dominanti, per
una pacica azione di riforme, muovendosi in tal modo in una dimensione
moralistica ed utopistica. Infatti, sganciati dalla realtà sociale
concreta, questi socialisti hanno dedicato gran parte della propria
opera alla delineazione di società « ideali». A questo tipo di
socialismo « utopistico» Marx contrappone invece il proprio socialismo
«scientifico», basato su di un'analisi critico-scientifica dei meccanismi
sociali del capitalismo e sull'individuazione del proletariato come forza
rivoluzionaria destinata ad abbattere il sistema borghese.
Debiti di Marx ed Engels nei confronti dei socialisti utopisti.
La critica di Marx ed Engels al socialismo «utopistico» non impedisce che
essi abbiano tratto da questa corrente importanti indicazioni circa la
società del futuro. Ad esempio, idee ed espressioni come quelle circa
l'abolizione dello «sfruttamento dell'uomo sull'uomo», della «soppressione
dello Stato politico» (vedi paragrafo 10), del «superamento del contrasto
fra città e campagna», della necessità di dare «a ciascuno secondo il
suo lavoro» (vedi paragrafo 11), sono apertamente derivate dal
socialismo francese. Tant'è vero che E. J. Hobsbawn, dati alla mano, ha
scritto recentemente che « tutto, o quasi, nei confronti ciò che Marx ed
Engels hanno detto intorno alla forma concreta della società comunista
si basa sui primi scritti utopistici». (E.J. Hobsbawn, Marx, Engels e il
socialismo premarxiano, in Storia del marxismo, Einaudi, Torino 1978,
Volume 1, pagina 15)
9. Il Capitale.
9.1 . Economia e dialettica.
Il Capitale si propone di mettere in luce i meccanismi strutturali della
società borghese, al fine di « svelare la legge economica del movimento
della società moderna» (Prefazione al libro 1). Esso rappresenta quindi
il capolavoro di Marx ed il testo-chiave della sua dottrina. Il fatto che
il Capitale rechi, come sottotitolo, Critica dell'economia politica,
rivela l'esplicita contrapposizione di Marx all'economia classica.
La critica dell'economia borghese e i princìpi metodologici dell'economia
marxista.
Come si è già accennato, Marx si differenzia dai grandi teorici
dell'economia borghese - da Smith a Ricardo - soprattutto per il suo
metodo storicistico-dialettico. Infatti, a differenza di tali autori,
Marx è convinto che non esistano leggi universali dell'economia, e che
ogni formazione sociale abbia caratteri e leggi storiche specifiche
(le leggi che valgono per il feudalesimo, ad esempio, non valgono per
il capitalismo). In secondo luogo, Marx è convinto che la società borghese
porti in se stessa delle contraddizioni strutturali che ne minano la
solidità, ponendo le basi oggettive della sua fine. In terzo luogo,
Marx è persuaso che l'economia debba far uso dello schema dialettico
(mutuato da Hegel) della totalità organica, studiando il capitalismo
come una struttura i cui elementi risultano strettamente connessi: «Il
risultato al quale perveniamo non è che produzione, distribuzione,
scambio, consumo, siano identici, ma che essi rappresentano tutti dei
membri di una totalità, differenze nell'ambito di un'unità... Una
produzione determinata determina quindi un consumo, una distribuzione,
uno scambio determinati, nonché i determinati rapporti tra questi diversi
momenti».
Particolarmente preziose, per quanto riguarda l'applicazione della
dialettica all'economia, risultano le indicazioni metodologiche contenute
in alcuni quaderni di scritti preparatori al Capitale, pubblicate solo
negli anni 1939-1941 con il titolo di Lineamenti (Grundrisse) fondamentali
della critica dell'economia politica, comunemente denominati con
l'abbreviazione Grundrisse. Decisiva è pure l'Introduzione del 1857 alla
Critica dell'economia politica (1859), anch'essa inedita e pubblicata
solo nel 1903.
Il procedimento astrattivo di Marx e il carattere tendenziale delle leggi.
Un'altra caratteristica del metodo di Marx è di studiare il capitalismo
distinguendone gli elementi di fondo ed astraendo da quelli secondari, al
fine di metterne in luce le caratteristiche strutturali e le tendenze di
sviluppo, per poi formulare, su di esso, alcune «previsioni».
Tuttavia, dato il carattere tendenziale delle leggi rilevate (si sa che
ad ogni tendenza può contrapporsi una contro-tendenza che frena la prima),
esse non vanno confuse con delle « profezie ». Ciò non toglie che la
scarsa rigorosità linguistico-concettuale di Marx a questo proposito, che
parla talora di «tendenze operanti ed effettuantisi con bronzea necessità»
(Prefazione al primo libro del Capitale), o del fatto che «la produzione
capitalistica genera essa stessa la propria negazione con la fatalità
che presiede ai fenomeni della natura» , faccia sì che Il Capitale sembri
presentarsi come « un libro di predizioni circa i destini futuri del
capitalismo moderno» - e come tale sia stato letto da parte del movimento
operaio seguente o dai critici di Marx, che lo hanno facilmente assimilato
ad « un testo di profezie sbagliate».
Il Capitale non è solo un libro di economia.
Si noti infine che Il Capitale non è soltanto un libro di economia.
Infatti poiché Marx vede nella sfera economica la chiave di spiegazione
della società nel suo insieme, Il Capitale non intende porsi come studio
di un segmento della vita reale, isolato dagli altri, ma come una
fotografia critica della civiltà capitalistica, intesa come struttura
complessiva.
9.2. Merce, lavoro e plusvalore.
Secondo Marx, la caratteristica specifica del modo capitalistico di
produzione, rispetto alle società precedenti, è di essere produzione
generalizzata di merci. Di conseguenza, la prima parte del Capitale è
dedicata all'analisi del fenomeno «merce».
Valore d'uso e valore di scambio di una merce.
Innanzitutto, una merce deve possedere un valore d'uso, in quanto deve
poter servire a qualcosa, ossia essere utile, poiché nessuno acquista
qualcosa che non venga incontro a determinati bisogni, sia che questi
«provengano dallo stomaco o dalla fantasia» (Il Capitale, volume 1).
In secondo luogo, una merce, per essere veramente tale, deve possedere
un valore di scambio, che ne garantisca la possibilità di essere scambiata
con altre merci. Ma in che cosa risiede il valore di scambio di una merce?
Valore = Lavoro
Marx, sulla scia degli economisti classici e dell'equazione valore = lavoro,
risponde che esso discende dalla quantità di lavoro socialmente necessaria
per produrla. Più lavoro è necessario per produrre una determinata merce
e più essa vale. Il termine «socialmente necessaria», usato da Marx,
significa che egli intende riferirsi alla produttività sociale media
esistente in un determinato periodo storico (infatti una merce che oggi
vale x, in virtù di un mutamento della produttività sociale media, domani
potrebbe valere y). Secondo Marx il valore non si identifica tuttavia con
il prezzo. Infatti su quest'ultimo influiscono altri fattori contingenti,
per esempio l'abbondanza o la scarsezza di una merce. Per cui il prezzo
di una singola merce può superare il suo valore reale o stare al di sotto
di esso, anche se Marx è convinto che, in condizioni normali, la somma
complessiva dei prezzi delle merci esistenti in una determinata società
equivalga alla somma complessiva del lavoro contenuto in esse, ossia al
loro valore. Di conseguenza, sebbene nelle relazioni di mercato il valore
non si presenti mai allo stato puro, ma sempre come prezzo, quest'ultimo
non è il valore, ma ha il valore alla propria base.
Il feticismo delle merci.
La consapevolezza che alla radice di tutto sta il lavoro porta Marx a
contestare il cosiddetto feticismo delle merci, che consiste nel
considerare le merci come delle entità aventi valore di per sé,
dimenticando che esse sono invece il frutto dell'attività umana e di
determinati rapporti sociali (per lo svolgimento di questa problematica
vedi Lukács).
Secondo Marx la caratteristica peculiare del capitalismo è il fatto che
in esso la produzione non risulta finalizzata al consumo, bensì
all'accumulazione di denaro. Di conseguenza, il ciclo capitalistico non è
quello «semplice», prevalente nelle società pre-borghesi e descrivibile
con la formula schematica M.D.M. (merce-denaro-merce), formula che allude
al doppio processo per cui una certa quantità di merce viene trasformata
in denaro ed una certa quantità di denaro viene ritrasformata in merce
(ad esempio il contadino che vende del grano per comperarsi un vestito)
Il ciclo economico capitalistico.
Il ciclo economico peculiare del capitalismo è piuttosto quello
descrivibile con la formula schematica D.M.D. (denaro-merce-più denaro).
Infatti nella società borghese abbiamo un soggetto (= il capitalista)
che investe del denaro in una merce, per ottenere, alla fine, più
denaro. Ma com'è possibile che qualcuno acquisti una merce che gli
procura più denaro, e quindi - essendo il denaro l'equivalente del
valore - più valore? Da dove deriva questo «più» monetario, ovvero tale
plus-valore? A prima vista il processo di generazione del plusvalore
appare una sorta di « mistero ». Infatti il plusvalore (= D') non può
provenire né dal denaro in se stesso, che è un semplice mezzo di
scambio, né dallo scambio medesimo, poiché gli scambi, in termini di
statistica sociale, hanno sempre luogo fra valori equivalenti, per cui
ciò che il capitalista acquista come venditore di merce deve già averlo
perso prima come compratore.
L'origine del plus-valore.
Di conseguenza, Marx ritiene che l'origine del plus-valore non debba
essere cercata a livello di scambio delle merci, bensì a livello
della produzione capitalistica delle medesime. Infatti nella società
borghese il capitalista ha la possibilità di «comperare» ed «usare» una
merce particolare, che ha come caratteristica quella di produrre valore.
Tale è la «merce umana», ossia, fuor di metafora, l'operaio. Infatti il
capitalista compera la sua forza-lavoro, pagandola come una qualsiasi
merce, ovvero secondo il valore corrispondente alla quantità di lavoro
socialmente necessario a produrla, che, nel caso dell'operaio,
corrisponde a quello dei mezzi che gli sono necessari per vivere,
lavorare e generare, ossia al salario. Tuttavia l'operaio - ed è questa la
fonte del plus-valore - ha la capacità di produrre un valore maggiore di
quello che gli è corrisposto col salario.
Chiarendo il tutto con un esempio: poniamo che un operaio lavori 10 ore
al giorno e che in questo tempo produca un valore pari a 10. Evidentemente,
se l'imprenditore gli corrispondesse tutto il valore prodotto, non avrebbe,
per sé, alcun guadagno. Di conseguenza, il valore equivalente al salario
deve per forza essere inferiore al valore globale prodotto dall'operaio.
Poniamo che esso sia pari a 6. In tal caso, l'operaio, in 6 ore di lavoro,
si sarebbe già guadagnato il proprio salario, «regalando» al capitalista
4 ore di plus-lavoro, che equivalgono ad una quantità corrispondente di
plus-valore.
Il plus-valore discende quindi dal plus-lavoro dell'operaio, e si identifica
con l'insieme del valore da lui gratuitamente offerto al capitalista.
Con questa teoria Marx ha voluto fornire una spiegazione «scientifica»
dello «sfruttamento» capitalista, che si identifica quindi con la
possibilità, da parte dell'imprenditore, di utilizzare la forza lavoro
altrui a proprio vantaggio. Ciò avviene in quanto il capitalista dispone
dei mezzi di produzione, mentre il lavoratore dispone unicamente della
propria energia lavorativa ed è costretto, per vivere, a «vendersi» sul
mercato, in vista del salario.
Plus-valore e profitto non sono la stessa cosa.
Dal plus-valore deriva il profitto. Plus-valore e profitto, per Marx, non
sono tuttavia la medesima cosa, come talora impropriamente si afferma, in
quanto il profitto, pur presupponendo il plus-valore, non coincide
totalmente con esso. Per comprendere la ragione di questa tesi risulta
indispensabile tener presente la distinzione marxista fra capitale
variabile (cosiddetto perché coincide col capitale mobile investito in
salari) e capitale costante (che coincide con il capitale investito
nelle macchine e in tutto ciò di cui abbisogna la fabbrica per funzionare
efficaciemente).
Il saggio del plus-valore.
Poiché il plus-valore nasce solo in relazione ai salari, ossia al capitale
variabile (in quanto più aumenta il plus-lavoro più cresce il plus-valore),
il saggio del plus-valore risiede nel rapporto, espresso in percentuale,
tra il plus-valore medesimo e il capitale variabile.
(saggio del plus-valore = plus-valore diviso capitale variabile)
Cerchiamo di chiarire quanto sopra con un esempio. Se il capitale
variabile è 6 e il plusvalore è 4, il saggio del plusvalore sarà
4/6 ovvero 2/3. Moltiplicando questo rapporto per 100 otterremo
66,6 percento (2/3 per 100 = 200/3 = 66,6 percento). Cifra che esprime
appunto, in percentuale, il saggio (o il tasso) del plusvalore conseguito
rispetto al capitale variabile anticipato.
Il saggio del profitto.
Ma il capitalista, per poter dirigere la fabbrica, è costretto ad investire
non solo in salari (capitale variabile), ma anche in impianti (capitale
costante). Per cui il saggio saggio del profitto non coincide con il
saggio del plus-valore, ma scaturisce dal rapporto, espresso in
percentuale, tra il plus-valore da un lato e la somma del capitale
variabile e del capitale costante dall'altro.
(Saggio di profitto = plus-valore diviso capltale costante + variabile
Ad esempio se il plusvalore è 4, il capitale costante 1 e il capitale
variabile 6, il saggio del profitto sarà
4/1 + 6 = 4/7 = 57,1 percento.
Di conseguenza, il saggio del profitto è sempre minore (come appare
chiaro dalla maggior grandezza del denominatore) rispetto al saggio del
plus-valore ed esprime in modo più preciso il guadagno del capitalista.
9.3. Tendenze e contraddizioni del capitalismo.
Il bisogno capitalistico del profitto e il suo esito tragico.
Poiché il capitalismo si regge sul ciclo D.M.D', il suo fine strutturale
immanente è la maggior quantità possibile di plus-valore. Ciò fa sì che
il capitalismo insegua tutte le vie possibili per raggiungere tale
scopo, caratterizzandosi come un tipo di società retto dalla logica del
profitto privato, anziché dalla logica dell'interesse collettivo.
Delineando un'analisi del capitalismo a sfondo tragico, Marx descrive le
varie strade imboccate da esso in vista del proprio auto-accrescimento,
mostrando come tale sistema generi una serie di contraddizioni e
difficoltà, che ne minano la sopravvivenza, preparandone la morte
futura. Analizziamo alcune tappe significative di questo processo.
In un primo momento il capitale cerca di accrescere il plus-valore
aumentando la giornata lavorativa (poniamo sino a quindici ore). Ma
questa dilatazione d'orario, pur generando maggior plus-lavoro, e quindi
maggior plus-valore, presenta dei limiti invalicabili, poiché oltre un
certo numero di ore la forza-lavoro dell'operaio cessa di essere
produttiva. Di conseguenza, più che attraverso il prolungamento della
giornata lavorativa (che Marx chiama plus-valore assoluto), il
capitalismo punta alla riduzione della parte di giornata lavorativa
necessaria ad integrare il salario (che Marx chiama plus-valore relativo).
Il plus-valore relativo.
Infatti se l'operaio, anziché impiegare sei ore per guadagnare il
proprio salario ne impiega quattro, risulta evidente che il plus-valore
intascato dal capitalista è più grande. Ovviamente, tutto ciò si può
ottenere solo mediante una maggior produttività del lavoro. Da ciò
discende la necessità strutturale, per il capitalismo, di introdurre in
continuazione nuovi e più efficienti metodi e strumenti di lavoro.
Storicamente questo processo di produzione del plus-valore relativo passa
attraverso tre fasi successive:
a) la cooperazione semplice;
b) la manifattura;
c) la grande industria.
L'industria meccanizzata.
La grande svolta del modo capitalistico di produzione è la nascita
dell'industria meccanizzata, che introduce, nel ciclo lavorativo, la
macchina, ossia «il mezzo più potente per l'accorciamento del lavoro»,
capace di aumentare enormemente la quantità di merce prodotta nello
stesso tempo con lo stesso numero di operai, e quindi di erogare maggior
plus-valore relativo. Le macchine, che non hanno bisogno di riposo,
permettono anche una maggior estrazione di plus-valore assoluto,
allungando la giornata lavorativa. Inoltre, rendendo meno faticose le
operazioni lavorative, i capitalisti possono ricorrere alla forza-lavoro
delle donne e dei bambini, meno costosa e più docile.
I «costi umani» del capitalismo industriale.
Mettendosi dal punto di vista dei salariati, Marx denuncia i «costi
umani» dell'utilizzazione capitalistica delle macchine. Mentre nella
manifattura era l'operaio ad usare gli strumenti di lavoro, ora è
piuttosto «l'automa semovente» del macchinario di fabbrica ad usare il
salariato, che diviene solo un'appendice o un «servo» della macchina.
Mentre prima donne e bambini non erano forze concorrenti decisive, ora
lo sono diventate, favorendo il contenimento o l'abbassamento dei salari.
Inoltre, la velocità dei macchinari produce un'intensificazione del
lavoro, distruggendo non solo ogni creatività individuale, ma generando
stress psico-fisico. Per tutti questi motivi, fra lavoratore e macchina si
instaura un'inevitabile relazione di ostilità, che nei primi movimenti
operai, incapaci di distinguere fra macchine ed uso capitalistico delle
medesime, prende la forma (vedi il luddismo) di una distruzione del
macchinario.
Ma proprio l'aumento di produttività conseguito con l'uso delle macchine
genera, accanto alla conflittualità operaia, il fenomeno delle crisi
cicliche di sovrapproduzione proprie del capitalismo. Mentre nei secoli
precedenti le crisi erano generate dalla scarsità di beni (a causa di
carestie, epidemie, guerre eccetera) nel capitalismo sono provocate da una
sovrabbondanza di merci.
Le crisi cicliche.
Paradossalmente, nel capitalismo c'è crisi non perché vi sia poca merce
in circolazione, ma perché ne esiste troppa. Questo è dovuto al fatto che
il capitalismo (almeno quello «classico» dei tempi di Marx) risulta
caratterizzato dal fenomeno dell'anarchia della produzione, la quale fa sì
che i capitalisti si precipitino «alla cieca» nei settori dove il profitto
è più alto, facendo sì che, ad un certo punto, si verifichi un eccesso di
produzione rispetto alle esigenze di mercato. Tutto ciò genera la
crisi, che ha come effetti concomitanti sia la distruzione capitalistica
dei beni (spesso proprio quelli di cui avrebbero più bisogno le classi
povere: caffè, frutta eccetera) sia la disoccupazione, che va ad accrescere
il cosiddetto «esercito industriale di riserva».
La caduta tendenziale del saggio di profitto.
La necessità, per il capitalismo, di un continuo rinnovamento tecnologico,
genera anche un altro inconveniente strutturale: la caduta tendenziale
del saggio di profitto. Con questa espressione Marx intende quella legge per
cui, accrescendosi smisuratamente il capitale costante (costituito dalle
macchine e dalle materie prrime) rispetto al capitale variabile, ossia
aumentando ciò che egli denomina la «composizione organica del capitale»,
diminuisce per forza il saggio di profitto. Per comprendere adeguatamente
questa legge, cui Marx attribuisce una grande importanza, bisogna tener
presente che:
1) il plus-valore non è generato dalle macchine di per sé, ma dal lavoro
vivo, che viene pagato con il capitale variabile;
2) il saggio di plus-valore è dato dal rapporto fra il plus-valore stesso
e il capitale variabile;
3) il saggio di profitto è dato dal rapporto fra il plus-valore da un lato
e il capitale costante ed il capitale variabile dall'altro. Ora, se
v (= capitale variabile) resta stabile, resta stabile anche
p (= il plus-valore); ma se nel frattempo c (= capitale costante) è
accresciuto, risulta ovvio che il saggio di profitto è diminuito, come
mostra il seguente prospetto matematico:
(p/c + v oppure p/c (ove c = c + v)
In altri termini, succede grosso modo che il profitto, per quanto
elevato, risulti progressivamente sempre più scarso rispetto a tutto il
capitale impiegato, in virtù appunto, della crescita smisurata del capitale
costante. La legge della caduta tendenziale del saggio di profitto
equivale quindi ad una legge dei rendimenti decrescenti, «demotivante»
rispetto agli investimenti capitalistici. Sebbene Marx abbia elencato
talune «cause antagonistiche» che possono attenuare o rallentare l'efficacia
della legge in questione, come ad esempio l'acquisto di materie prime
all'estero, ad un prezzo minore di quello richiesto in patria, con la
conseguente diminuzione del capitale costante, egli ha considerato la
legge della caduta tendenziale del saggio di profitto come il vero
«tallone dAchille» del sistema capitalistico, legge che, dal suo punto
di vista, può essere eventualmente ritardata nei suoi effetti, ma non
distrutta nei suoi esiti catastrofici per la società borghese.
Le discussioni critiche sulla validità o meno di tale legge.
Sulla validità di questa legge-chiave i pareri sono divisi. Secondo
alcuni l'aumento del macchinario, coincidendo con una maggior
produttività, si tradurrebbe piuttosto in un aumento, e non
in una diminuzione di profitto. Questo spiega perché la legge sia stata
vivacemente contestata, ad esempio, non solo da Joan Violet Robinson
(nota economista di Cambridge, della scuola post-keynesiana), ma anche
da un valente economista marxista come Paul Marlor Sweezy. Altri studiosi
di tale legge marxisti sono invece propensi a ritenerla valida, almeno in
linea di principio e come tendenza di fondo del capitalismo.
La scissione della società in due sole classi antagonistiche.
Comunque si pensi a tal proposito, è un fatto che tale legge, secondo
Marx, tende a mettere in difficoltà la borghesia, e, sommandosi con i
fenomeni dell'anarchia produttiva, della concorrenza e delle crisi,
finisce per produrre quell'ultima e decisiva tendenza del capitalismo
che è la scissione delle società in due sole classi antagonistiche.
Come si è già accennato (vedi paragrafo 8.1), Marx ha una visione
sostanzialmente dualistica della società di classe, in quanto ritiene
che in ogni momento della storia le classi fondamentali siano
due. Questa dottrina, portata ad attribuire minore importanza alle
classi medie, riflette compiutamente, a giudizio di Marx, la situazione
stessa del capitalismo industriale avanzato, nel quale, in seguito al
fenomeno della concorrenza e delle crisi, da un lato abbiamo una
progressiva «espropriazione di molti capitalisti da parte di pochi»,
avente come effetto «la diminuzione costante dei magnati del capitale»,
e dall'altro abbiamo una massa sempre più grande di salariati, occupati e
disoccupati.
La situazione finale del capitalismo.
In altre parole, Marx tende a prospettare la situazione finale del
capitalismo in termini dualistico-dialettici: da un lato una minoranza
industriale, dalla gigantesca ricchezza e dall'immenso potere, dall'altro
una maggioranza proletaria sfruttata. Situazione che, dato il carattere
internazionale del capitalismo, tende a prodursi su scala mondiale,
denunciando il limite massimo cui è pervenuta la contraddizione che sta
alla base di tutte le altre contraddizioni del capitalismo: il contrasto
tra forze produttive sempre più sociali ed il carattere privatistico dei
rapporti di produzione e di proprietà. Da ciò il celebre epilogo del primo
libro del Capitale: «La centralizzazione dei mezzi di produzione e la
socializzazione del lavoro raggiungono un punto in cui diventano
incompatibili col loro involucro capitalistico. Ed esso viene spezzato.
Suona l'ultima ora della proprietà privata capitalistica. Gli
espropriatori vengono espropriati».
10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato.
Le contraddizioni della società borghese rappresentano la base oggettiva
della rivoluzione del proletariato, il quale, impadronendosi del potere
politico, dà avvio alla trasformazione globale della vecchia società,
attuando il passaggio dal capitalismo al comunismo. Di conseguenza, il
proletariato, nella prospettiva di Marx, appare investito di una
specifica missione storico-universale.
Caratteri della rivoluzione comunista.
Infatti, mentre le fratture rivoluzionarie del passato si traducevano nel
trionfo di un nuovo modo di produrre e di distribuire la proprietà e in una
nuova egemonia di classe, la rivoluzione comunista non abolisce soltanto
un tipo particolare di proprietà, di divisione del lavoro e di dominio di
classe, ma cancella ogni forma di proprietà privata, di divisione del
lavoro e di dominio di classe, dando origine ad un'epoca nuova nella
storia del mondo. Lo strumento tecnico della trasformazione
rivoluzionaria è la socializzazione dei mezzi di produzione e di
scambio, che passando dalle mani dei privati a quelli della comunità,
pongono fine al fenomeno del plus-valore e dello sfruttamento di classe.
I metodi per accedere al potere e il problema dell'esistenza o meno di
una via «pacifica».
Sui metodi per accedere al potere Marx ammette una gamma di possibilità,
legate alle specificità storico-nazionali. Sebbene sia propenso a
ritenere che la rivoluzione, come insegna la storia, implichi sempre
forme violente, negli ultimi anni appare indirizzato ad ammettere anche
la possibilità di una via «pacifica» al socialismo. Ad esempio, nel
gennaio 1867, in un discorso commemorativo sull'insurrezione polacca,
afferma: «è possibile che la lotta fra lavoratori e capitalisti sia
meno terribile e meno sanguinosa della lotta fra signori feudali e
borghesia in Inghilterra e in Francia. Speriamolo». E nel discorso
di Amsterdam, che chiudeva il congresso dell'Internazionale, Marx dice:
«L'operaio un giorno dovrà prendere il potere politico... Noi non abbiamo
affatto preteso che per arrivare a questo scopo i mezzi fossero
dappertutto identici. Sappiamo quale importanza abbiano le istituzioni,
i costumi e le tradizioni dei vari paesi, e non neghiamo che esistano dei
paesi come l'America, l'Inghilterra e... l'Olanda, in cui i lavoratori
possono raggiungere il loro scopo con mezzi pacifici».
Alcuni studiosi ritengono tuttavia che Marx, in privato, rimanesse
abbastanza scettico sulle possibilità di una via pacifica, che urtava
contro il suo realismo storicistico. Significativa, a questo proposito,
la testimonianza di H. M. Hyndman, il fondatore della federazione
socialdemocratica inglese, il quale, in un libro di memorie racconta di
un colloquio con Marx negli anni Settanta: «L'Inghllterra è l'unico paese
in cui una rivoluzione pacifica è possibile; ma - soggiunse dopo una
pausa - la storia non ci incoraggia a crederlo. Voi inglesi assomigliate
ai romani in molte cose, ma soprattutto nell'ignorare la vostra storia».
La necessità di abbattere lo Stato borghese e le sue forme istituzionali.
Violenta o pacifica che sia, la rivoluzione proletaria - e su questo punto
le idee di Marx sono rimaste ferme - deve tuttavia mirare, come primo
traguardo, all'abbattimento dello Stato borghese e delle sue forme
istituzionali. In una lettera a Ludwig Kugelmann del 12-4-1871, egli
scrive: «il prossimo tentativo della rivoluzione francese non consisterà
nel trasferire da una mano all'altra la macchina militare e burocratica
com'è avvenuto fino ad ora, ma nello spezzarla... tale è la condizione
preliminare di ogni rivoluzione popolare sul continente ». Di conseguenza,
sebbene certo marxismo successivo di stampo «revisionistico»,
dall'Ottocento ad oggi, abbia diffuso l'idea secondo cui il nucleo della
rivoluzione comunista, per Marx, consisterebbe nel «riempire» di contenuti
sostanziali o sociali la democrazia ancora «formale» dello Stato borghese,
i testi del filosofo, a questo proposito, parlano in modo «duro» e
«chiaro»: il compito del proletariato non è quello di impadronirsi della
macchina statale borghese, manovrandola per i propri scopi, ma quello
di «spezzarne» o distruggerne i meccanismi istituzionali di fondo.
Lo Stato come «macchina» al servizio della borghesia.
Questa dottrina di Marx si lega coerentemente con le sue convinzioni
teoriche circa lo Stato moderno, visto come sovrastruttura di una società
civile prestatale dominata dagli interessi di classe della borghesia.
Da ciò le «classiche» affermazioni de L'ideologia tedesca: «lo Stato è
la forma in cui gli individui di una classe dominante fanno valere i
loro interessi comuni» o del Manifesto: « il potere politico è il potere
di una classe organizzata per opprimerne un'altra» o dell'Antidühring di
Engels: «lo Stato moderno, qualunque ne sia la forma, è una macchina
essenzialmente capitalistica, uno Stato dei capitalisti, il capitalista
collettivo ideale». Ma se lo Stato borghese, compresa la democrazia
rappresentativa, è un insieme di apparati istituzionali (e «ideologici»)
che «servono» specificamente alla borghesia per esercitare il proprio
dominio di classe, esso, per Marx, non costituisce un insieme di tecniche
neutrali che possano essere usate anche a vantaggio del proletariato
(secondo una concezione oggi prevalente, ed accettata in parte anche dalle
sinistre europee). Infatti, come ha notato Norberto Bobbio, lo Stato, per
Marx, è, sì una macchina, ma non è una macchina che ognuno possa
utilizzare ad arbitrio e piacimento, in quanto ogni classe dominante,
secondo il materialismo storico, è costretta a foggiare una macchina
statale secondo le proprie esigenze.
La dittatura del proletariato come misura politica fondamentale per la
transizione al comunismo.
Questo rifiuto netto ed inequivocabile delle forme istituzionali dello
Stato borghese prende corpo nella dottrina della dittatura del proletariato.
Sebbene già nel Manifesto si parli di «interventi dispotici nel diritto
di proprietà e nei rapporti borghesi di produzione», il concetto preciso
di dittatura del proletariato appare solo nella già citata lettera
a Weydemeyer, in cui si afferma che «la lotta delle classi necessariamente
conduce alla dittatura del proletariato». L'espressione «classica»
di questa teoria la si trova poi nella Critica del programma di
Gotha (1875), in cui Marx scrive che «tra la società capitalistica e la
società comunista vi è il perindio della trasformazione rivoluzionaria
dell'una nell'altra. Ad esso corrisponde anche un periodo politico di
transizione il cui Stato non può essere altro che la dittatura
rivoluzionaria del proletariato». Anche la nozione di dittatura del
proletariato discende coerentemente da tutto l'impianto concettuale del
marxismo e dalla sua filosofia dello Stato. Infatti se quest'ultimo, nel
capitalismo, esprime il «dispotismo» o la «dittatura di classe» della
borghesia, risulta ovvio che il proletariato se vuole davvero costruire
il comunismo, parando nel contempo le inevitabili mosse
contro-rivoluzionarie della borghesia, non può fare a meno di instaurare
una sua dittatura che, a differenza delle altre dittature storicamente
esistite, che sono sempre state dittature di una minoranza di oppressori
su di una maggioranza di oppressi, appare invece come una dittatura della
maggioranza degli oppressi su di una minoranza di (ex-) oppressori,
destinata a scomparire.
La dittatura del proletariato si configura dunque, per Marx, come la misura
politica fondamentale per la transizione dal capitalismo al comunismo.
Tant'è vero che Lenin, riferendosi a Marx, scriverà che « marxista è
soltanto colui che estende il riconoscimento della lotta delle classi fino
al riconoscimento della dittatura del proletariato». Ma quali forme
concrete dovrà prendere, secondo Marx, questa dittatura del (e non sul)
proletariato. Su questo punto Marx ha taciuto per parecchio tempo,
sinché le vicende della Comune parigina, di cui parla in La guerra civile
in Francia, si sono configurate, ai suoi occhi, come «la forma politica
finalmente scoperta, nella quale si poteva compiere l'emancipazione
economica del lavoro». Come sintetizza e puntualizza Cesare Pianciola:
«Le caratteristiche fondamentali che Marx enuclea dalla breve esperienza
della Comune sono:
1) sostituzione dell'esercito permanente con l'organizzazione degli operai
armati, garanzia reale del carattere di classe della nuova organizzazione
politica;
2) soppressione det parlamentarismo, cioè della delega dell'esercizio del
potere a un apparato politico specializzato, nominalmente responsabile
davanti al popoìo ma di fatto autonomo e sovrapposto ad esso; sostituzione
del parlamento con delegati eletti a suffragio universale, direttamente
responsabili del loro operato, revocabili in ogni momento e retribuiti
con salari corrispondenti a un normale salario operaio;
3) soppressione del privilegio burocratico attraverso l'estensione di quei
criteri a tutte le cariche pubbliche, giudici e magistrati compresi. In,
definitiva, Marx sottolinea l'eliminazione di tutte le funzioni repressive
e parassitarie dello Stato borghese e la riduzione delle funzioni utili
a semplici funzioni "di lavoro", spogliate di autonomia politica rispetto
al popolo organizzato in comuni» (C. Pianciola, Il pensiero di Karl Marx,
Loescher, Torino, 1971, pagina 312).
Inoltre il modello comunardo, embrione della futura dittatura proletaria,
prevede anche, secondo Marx, l'abolizione della celebrata, ma per lui
fittizia separazione dei poteri («la Comune doveva essere non un
organismo parlamentare, ma di lavoro, esecutivo e legislativo allo
stesso tempo»).
Il «superamento» dello Stato.
Secondo Marx la dittatura del proletariato è solo una misura storica di
transizione (sia pure a lungo termine), che mira tuttavia al superamento
di se medesima e di ogni forma di Stato. Anche questa tematica
dell'«estinzione dello Stato, attinta dai socialisti francesi e presente
in qualche modo sin dai saggi del 1843, che parlano di Aufhebung des
Staates (superamento dello Stato), discende dai princìpi del
materialismo storico. Infatti, se tutti gli Stati storicamente esistiti
si sono sempre configurati come strumento di oppressione e come
dittature di classe, il proletariato, abolendo le classi, pone le basi
per quello che Engels chiamerà il «deperimento» dello Stato.
Differenze del modello marxista da quello socialdemocratico ed anarchico.
Al fondo del comunismo marxista vi è dunque un ideale di tipo anarchico.
A differenza di Bakunin, Marx ritiene tuttavia che l'auspicata società
senza Stato non si possa raggiungere subito, ma solo in una prospettiva
futura. In altri termini, il modello marxista si diversifica non solo
dal modello «socialdemocratico», ma anche da quello «anarchico».
Infatti, se contro i socialdemocratici, i quali vogliono conquistare lo
Stato dall'interno ed utilizzarlo per i propri scopi, Marx afferma che il
proletariato deve «spezzare» la democrazia ed il parlamentarismo
borghese, sostituendolo con una sua democrazia di tipo diretto, contro
gli anarchici sostiene che non si può pensare di distruggere
immediatamente lo Stato senza passare attraverso un lungo periodo di
dittatura proletaria, che coincide con il farsi della rivoluzione.
Solo quando l'edificazione del socialismo sarà compiuta, lo Stato,
secondo Marx, potrà davvero estinguersi, e far posto all'ideale di un
autogoverno dei produttori associati, in cui, secondo la nota
espressione di Engels (attinta da Saint-Simon), il dominio sugli uomini
sarà completamente sostituito dalla semplice amministrazione delle cose.
11. Le fasi della futura società comunista.
L'assenza in Marx, di un modello dettagliato della futura società...
Comè stato notato più volte dagli specialisti, la dottrina di Marx, ben
lontano dal mettere capo ad un prototipo ideale dettagliato della futura
società comunista, si limita ad accennare ad essa in modo piuttosto
frammentario e in scritti non destinati alla pubblicazione. Oltre al già
citato opuscolo La guerra civile in Francia, che riguarda, più
specificamente, le forme politico-istituzionali della transizione
rivoluzionaria, per avere un quadro illustrativo della visione di Marx
circa il futuro assetto della società comunista, dobbiamo rivolgerci
soprattutto ad una sezione dei Manoscritti del 1844, dal titolo
Proprietà privata e comunismo, e alla Critica del programma di Gotha (1875).
...e le diverse interpretazioni di questo dato di fatto.
Che questo «filosofo del comunismo» non abbia specicato il volto
concreto della nuova società, è stato diversamente interpretato. Per
taluni, il fatto che Marx, per usare una sua frase, si sia rifiutato di
« prescrivere ricette per l'osteria dell'avvenire » (« Proscritto » alla
seconda edizione del Capitale), sarebbe una positiva ed encomiabile
manifestazione della sua mentalità « scientifica » ed anti-utopistica,
tesa a parlare con rigore del presente e ad evitare discorsi nebulosi
sul futuro. Per altri tutto ciò costituirebbe invece un grave «vuoto
teorico», destinato a pesare in senso negativo sul futuro movimento
comunista mondiale, che si troverebbe a predicare la distruzione del
capitalismo senza avere in mente un preciso modello di società e di
Stato con cui sostituirlo.
Il rifiuto del comunismo «rozzo».
Nei Manoscritti, nella sezione sopraccitata, Marx distingue fra un
comunismo «rozzo», che è la prima forma in cui si presenta l'istanza
socialista, ed un comunismo superiore ed autenticamente tale.
Nel primo tipo di comunismo - che Marx attribuisce in parte alle
scuole socialiste precedenti - la proprietà viene abolita solo per
essere trasformata in proprietà di tutti. In questo stadio immaturo
di comunismo, la proprietà, anziché venir totalmente soppressa, viene
dunque universalizzata o nazionalizzata, cioè attribuita alla comunità,
mentre gli uomini sono tutti ridotti ad operai, con un medesimo salario.
Di conseguenza, la comunità viene ad assumere il ruolo di un grande
capitalista, che non abolisce, ma universalizza, la situazione
dell'individuo nella società borghese.
La «rozzeria» di questa società post-capitalista, ma ancora pre-comunista,
è chiaramente «svelata», secondo Marx, dalla connessa proposta della
comunione delle donne. Infatti, al matrimonio borghese, visto come forma
esclusiva di proprietà privata, questo comunismo volgare non sa opporre
altro che una situazione in cui la donna appare «la preda e la serva del
piacere della comunità» (Manoscritti, traduzione Bobbio, pagina 109).
La pretesa comunanza delle donne.
La comunanza delle donne rappresenta dunque l'analogo, in campo sessuale,
della generalizzazione della proprietà in campo economico: « allo stesso
modo che la donna passa dal matrimonio alla prostituzione generale, così
l'intero mondo della ricchezza... passa dal rapporto di matrimonio
esclusivo con il proprietario privato al rapporto di prostituzione
generale con la comunità». In conclusione, pur facendo un passo in
avanti rispetto al capitalismo, l'ideale egualitario del comunismo rozzo,
secondo Marx, è ancora dominato dalla mentalità proprietaria e dalla
categoria dell'«avere», e getta le sue radici psicologiche nell'«invidia»
e in una grossolana «brama di livellamento».
L'ideale di un comunismo autentico basato sulla effettiva soppressione
della proprietà privata.
Il comunismo, inteso come «effettiva soppressione della proprietà
privata», appare come quella situazione in cui l'uomo, superato
completamente l'orizzonte sociale ed antropologico della proprietà, cessa
di intrattenere con il mondo rapporti di puro possesso e consumo: «la
proprietà privata ci ha resi così ottusi ed unilaterali che un oggetto è
considerato nostro soltanto quando lo abbiamo, e quindi quando esso
esiste per noi come capitale o è da noi immediatamente posseduto,
mangiato, bevuto, portato sul nostro corpo, abitato eccetera, in breve
quando viene da noi usato».
L'uomo «nuovo».
All'uomo della civiltà proprietaria, all'homo oeconomicus, ossessionato
dall'avere, Marx contrappone invece un uomo nuovo, considerato come un
essere «onnilaterale» e «totale», che esercita in modo creativo l'insieme
delle sue potenzialità, intrattenendo un rapporto poliedrico con la realtà
e con gli altri uomini.
Nella Critica del programma di Gotha, Marx, muovendosi su di un terreno
meno «filosofico» e più socio-politico, distingue invece due fasi
(Queste due fasi in seguito sono state chiamate rispettivamente
«socialismo» e «comunismo»), della società futura, che ricordano, per
taluni spunti, gli schemi dei Manoscritti a proposito del comunismo
rozzo e di quello autentico.
La prima fase, quella ancora imperfetta della società futura.
Nella prima fase abbiamo a che fare con una società comunista, non come
si è sviluppata sulla propria base, ma viceversa come emerge dalla società
capitalistica, che porta ancora, sotto ogni rapporto - economico, morale e
spirituale - le «macchie» della vecchia società, dal cui seno è uscita.
In questa fase, l'avvenuta socializzazione dei mezzi di produzione e di
scambio fa della società l'unico datore di lavoro e trasforma tutti in
salariati. In essa ogni produttore riceve una quantità di beni
equivalente al lavoro prestato. Il principio di uguaglianza che regge
questo stadio comunista consiste dunque nel misurare con una misura
eguale il lavoro erogato. Tuttavia, questo «uguale diritto» si rivela
ancora di tipo «borghese», in quanto non tiene conto delle differenze
individuali, limitandosi ad annullare astrattamente le persone e
dimenticando che «l'uno è fisicamente o moralmente superiore all'altro, e
fornisce quindi nello stesso tempo più lavoro, oppure può lavorare
durante un tempo più lungo... Inoltre un operaio è ammogliato, l'altro
no; uno ha più figli dell'altro... l'uno riceve più dell'altro, l'uno è più
ricco dell'altro e così via». L'uguaglianza ancora imperfetta di questa
prima fase della società comunista «qual è uscita, dopo i lunghi
travagli del parto, dalla società capitalistica» richiede quindi di
essere messa da parte a favore di una «superiore» forma di uguaglianza e
di comunismo, che tenga conto dei «bisogni» e non solo delle «capacità»
degli individui:
La seconda fase («Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i
suoi bisogni»).
«In una fase più elevata della socità comunista, dopo che è scomparsa la
subordinazione asservitrice degli individui alla divisione del lavoro, e
quindi anche il contrasto fra lavoro intellettuale e fisico; dopo che il
lavoro non è divenuto soltanto mezzo di vita, ma anche il primo bisogno
della vita; dopo che con lo sviluppo onnilaterale degli individui sono
cresciute anche le forze produttive e tutte le sorgenti della ricchezza
collettiva scorrono in tutta la loro pienezza, solo allora l'angusto
orizzonte giuridico borghese può essere superato, e la società può
scrivere sulle sue bandiere: Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno
secondo i suoi bisogni».
Questo passo della Critica del programma di Gotha rappresenta il
documento più importante che possediamo circa le idee di Marx sulla
futura società comunista. Pur nella sua sinteticità, esso contiene
alcune delle idee-guida che, sin dagli anni giovanili, hanno ispirato la
sua critica al capitalismo e alla società di classe: l'abolizione della
divisione del lavoro e dell'antitesi fra occupazione «manuale» e mansione
«intellettuale»; l'idea di un lavoro non puramente costrittivo («mezzo di
vita») bensì creativo («bisogno di vita»); l'idea di unumanità
«onnilaterale»; il rilievo attribuito allo sviluppo delle forze
produttive, inteso come presupposto economico-strutturale di una società
in cui ognuno possa davvero avere secondo i suoi bisogni. In sintesi,
dopo i travagli della storia, ecco profilarsi l'attesa società comunista;
senza divisione del lavoro, senza proprietà privata, senza classi, senza
sfruttamento, senza miseria, senza divisioni fra gli uomini e senza Stato.
N.B. Per la «fortuna» di Marx si vedano i capitoli dedicati agli sviluppi
novecenteschi del marxismo.
12. Engels.
Nella precedente esposizione su Marx abbiamo tenuto presente, almeno in
parte, anche Engels. Di conseguenza, in questo paragrafo ci soffermeremo
sulla parte più originale del pensiero di Engels: la dialettica della
natura.
Nato nel 1820 a Barmen, in Germania, e morto a Londra nel 1895, Engels
fu per quarant'anni amico e collaboratore di Marx. L'opera principale di
Engels è l'Anti-Dühring (1878) diretta contro il filosofo positivista
Dühring. Ma egli è anche autore, oltre che di numerosi scritti
storico-politici, di un libro su Feuerbach e la fine della filosofia
classica tedesca (1888) e di una Dialettica della natura pubblicata
postuma (1925).
La dialettica della natura e le sue leggi.
Per Marx la dialettica è un metodo per interpretare la società e la
storia; per Engels è, in primo luogo, un metodo per interpretare la
natura. La preoccupazione dominante di Engels è quella di inquadrare
il marxismo nelle concezioni della scienza positivistica del suo tempo.
« La dialettica è per la scienza naturale odierna la forma di pensiero
più importante perché essa sola offre le analogie e con ciò i metodi per
comprendere i processi di sviluppo che hanno luogo nella natura, i nessi
generali, i passaggi da un campo di ricerca ad un altro». Pertanto le
leggi della dialettica devono essere ricavate «per astrazione» tanto
dalla storia della natura come da quella della società umana. Esse sono
fondamentalmente tre:
1) la legge della conversione della quantità in qualità e viceversa;
2) la legge della compenetrazione degli opposti;
3) la legge della negazione della negazione.
«Tutte e tre queste leggi, dice Engels, sono state sviluppate da Hegel
nella sua maniera idealistica, come pure leggi del pensiero: la prima
nella prima parte della logica, nella teoria dell'essere; la seconda
occupa tutta la seconda, e di gran lunga più importante parte della sua
logica, la teoria dell'essenza; la terza infine figura come legge
fondamentale per la costruzione dell'intero sistema». Queste leggi sono
illustrate da Engels con esempi tolti dalle scienze elementari; esempi
fondati su analogie o immagini appariscenti (per esempio, il seme si nega
trasformandosi in pianta che a sua volta produce il seme, negazione
della negazione). Per ciò che riguarda la compenetrazione degli opposti,
un esempio sarebbe il rapporto tra attrazione e repulsione per le quali
la dialettica scientifica avrebbe dimostrato «che tutte le opposizioni
polari sono condizionate dall'alterno gioco dei due poli opposti l'uno
sull'altro, che la separazione e l'opposizione dei poli sussiste soltanto
nel loro reciproco appartenersi, nella loro unione, e che viceversa la
loro unione può esistere nella loro separazione, il loro rapporto
nell'opposizione». E così via.
Engels condivide le previsioni di alcuni scienziati circa la fine
dell'universo; ma dichiara la sua certezza che la materia in tutti i suoi
mutamenti rimane eternamente la stessa, che nessuno dei suoi attributi
può mai andare perduto e che perciò essa deve di nuovo creare, in altro
tempo e in altro luogo, «il suo più alto frutto, lo spirito pensante,
per quella stessa ferrea necessità che porterà alla scomparsa di esso
sulla terra ».
Indicazioni bibliografiche :
M. Rossi, Marx e la dialettica hegeliana, Editori Riuniti, Roma 1960,1963,
nuova edizione; Da Hegel a Marx 4 volumi, Feltrinelli, Milano 1970,1975.
AA.VV., Marx vivo, 2 volumi, Mondadori, Milano 1962.
U. Cerroni, Marx e il diritto moderno, Editori Riuniti, Roma 1962.
A. Cornu, Marx e Engels dal liberalismo al comunismo, Feltrinelli,
Milano 1962.
K. Axelos, Marx pensatore della tecnica, Sugar, Milano 1963.
J. Hyppolite, Saggi su Marx e Hegel, Bompiani, Milano 1963.
J.Y. Calvez, Il pensiero di K. Marx, Borla, Torino 1964.
F. Fergnani, Marxismo e filosofia contemporanea, Mangiarotti,
Cremona 1965.
G. Girardi, Marxismo e cristianesimo, Cittadella Edizioni,
Assisi 1966.
E. Mandel, Che cos'è la teoria marxista dell'economia?,
Samonà e Savelli, Roma 1967.
A. Plebe, Che cosa ha veramente detto Marx, Ubaldini, Roma 1967.
L. Althusser - E. Balibar, Leggere il Capitale, Feltrinelli, Milano 1968.
G. Bedeschi, Alienazione e feticismo nel pensiero di Marx, Laterza Bari 1968
M. Dobb, Economia politica e capitalismo, Boringhieri, Torino 1968.
E. Fromm, Marx e Freud, Il Saggiatore, Milano 1968.
L. Colletti, Il marxismo e Hegel, Laterza, Bari 1969.
A. Schmidt, Il concetto di natura in Marx, Laterza, Bari 1969.
I. Fetscher 11 marxismo. Storia documentaria Feltrinelli Milano 1969-1970.
U. Cerroni, Teoria della crisi sociale in Marx, De Donato. Bari 1970.
E. Fromm, W. Reich, I. Sapir, Psicanalisi e marxismo, Samollà e Savelli,
Roma 1970.
C. Napoleoni, Smith, Ricardo, Marx. Considerazioni sulla storia del
pensiero economico, Boringhieri, Torino 1970.
A. De Palma, Le macchine e l'industria da Smith a Marx, Einaudi, Torino 1971.
R. Rosdolsky, Genesi e struttura del «Capitale» di Marx, Laterza. Bari 1971.
P. A. Rovatti, Critica e scientificità in Marx, Feltrinelli. Milano 1973.
S. Veca, Marx e la critica dell'economia politica, Il Saggiatore Milano 1973.
R. Guastini, Marx dalla filosofia del diritto alla scienza della società.
Il Mulino, Bologna, 1974.
C. Luporini, Dialettica e materialismo, Editori Riuniti, Roma 1974.
E. V. Ilenkov, La dialettica dell'astratto e del concreto nel «Capitale» di
Marx, Feltrinelli, Milano 1975.
M. Dal Pra, La dialettica in Marx, Latera, Roma-Bari ]977.
P. Dognin, Introduzione a Karl Marx, Città Nuova, Roma 1977.
S. Veca Saggio sul programma scientifico di Marx, Il Saggiatore Milano, 1977.
A. Carandini, L'Anatomia della scimmia. La formazione economica della
società prima del Capitale, Einaudi, Torino, 1979.
G. Bedeschi, Introduzione a Marx, Laterza, Roma-Bari 1981.
H. Lefebvre, Abbandonare Marx?, Editori Riuniti, Roma 1983.
J. Mancini, S. Natoli, Marx e la religione, Cappelli, Bolona 1984.
M. Mugnai, Il mondo rouesciato. Contraddizione e «valore» in Marx,
Il Mulino, Bologna 1984.
N. Tabaroni (a cura di), Il Manifesto del partito comunista di Marx ed
Engels e il dibattito socialista tra utopia e scienza nella prima metà
del 19esimo secolo, Paravia, Torino 1989.
Su Engels:
G. Mayer, F. Engels. La vita e l'opera, Einaudi Torino 1969.
E. Fiorani, F. Engels e il materialismo dialettico, Feltrinelli, Milano, 1971
R. Mondolfo, Il materialismo storico di Federico Engels edizione originale,
1912, La Nuova Italia, Firenze, 1972.
G. Prestipino, Natura e società. Per una nuova lettura di Engels, Editori
Riuniti Roma 1973.
F. De Aloisio. Engels senza Marx, Liguori, Napoli 1973.
Glossario e riepilogo:
- Misticismo logico. è l'accusa che Marx rivolge al metodo di Hegel,
imputato di trasformare le realtà empiriche in allegorie di una realtà
spirituale (= l'Idea) che abita occultamente dietro di esse e che funge
da «significato» e «giustificazione» speculativa di esse. Ad esempio,
invece di limitarsi a constatare l'esistenza della monarchia, Hegel ne
legittima la validità, scorgendo in essa la sovranità statale personificata.
Secondo Marx il «mistero» di questo artificio filosofico va ricercato nel
capovolgimento idealistico del rapporto soggetto e predicato, in virtù
del quale Hegel, dopo essersi costruito il concetto astratto di Spirito
partendo dalla realtà concreta, finisce per fare della realtà la
manifestazione necessaria dello Spirito. Da ciò il giustificazionismo
speculativo e il conservatorismo politico di Hegel, che perviene a
canonizzare o a santificare la realtà esistente e le istituzioni sociali
in cui essa si incarna.
- Dialettica. Il significato e l'uso della dialettica in Marx costituiscono
tuttora argomento di dibattito fra gli studiosi. In generale, si può
dire che per Marx la dialettica rappresenti, hegelianamente, tanto un
modo di essere della realtà quanto un metodo per comprenderla
efficacemente. Tuttavia, poiché Marx crede che in Hegel la dialettica
risulti «capovolta», ossia cammini (idealisticamente) «sulla testa», egli
si propone di rimetterla (materialisticamente)« sui piedi», sforzandosi di
liberarne il «nocciolo razionale» dal «rivestimento mistico» (Poscritto
alla seconda edizione de Il Capitale). In particolare, per Marx la
dialettica è quel metodo di indagine che consiste nel prospettare la realtà
studiata come una totalità in divenire formata:
1) da una serie di momenti intercollegati;
2) da un insieme di contraddizioni che ne rappresentano la molla di
sviluppo ed il negativo da negare. Ad esempio, analizzare dialetticamente,
il capitalismo significa: 1) porre attenzione ai nessi che connettono
organicamente, secondo un rapporto di «reciproco condizionamento», i
vari momenti del ciclo economico (produzione, distribuzione, scambio
eccetera); 2) evidenziare le contraddizioni (tra forze produttive e
rapporti di produzione, fra capitalisti e salariati eccetera) che ne
minano l'assetto interno e che ne fanno prevedere la fine futura,
ossia l'inevitabile tramonto (da questo punto di vista, la dialettica si
configura quindi come uno strumento che ci permette di comprendere,
insieme al capitalismo, anche la negazione necessaria di esso).
In sintesi, dalla dialettica di Hegel, la filosofia materialistica
di Marx ha essenzialmente ereditato:
a) l'idea della processualità del reale;
b) il modello della totalità organica;
c) la tesi del negativo come «principio motore e generatore».
Di essa ha invece rifiutato:
a) la configurazione idealistica;
b) il carattere aprioristico e speculativo;
c) l'uso e l'abuso dello schema triadico di tesi, antitesi e sintesi.
- Per emancipazione politica Marx intende la prassi dello Stato (vedi)
moderno, che si limita ad uguagliare formalmente gli individui di fronte
alla legge.
- Per emancipazione umana Marx intende il superamento delle disuguaglianze
reali, ovvero l'idea di una democrazia sostanziale in cui gli uomini siano
uguali non solo sul piano politico (democrazia formale) ma anche su
quello economico (comunismo).
- Per alienazione si intende, in generale, la perdita o la cessione di un
bene. Ad esempio, nel linguaggio giuridico si parla di alienazione di un
patrimonio e in quello medico di alienazione delle facoltà mentali. In
filosofia, il termine è stato usato sia da Rousseau, per indicare la
cessione dei diritti individuali a favore della comunità, sia da Hegel,
per alludere alla dialettica propria dello Spirito, il quale si perde
nella natura e nell'oggetto per poi potersi riappropriare di sé in modo
arricchito. Tenendo presente la lezione di Feuerbach, che aveva
descritto l'«oggettivazione» religiosa in termini di «scissione» e
di «dipendenza» (= l'uomo che, scindendosi, proietta fuori di sé un Dio al
quale si sottomette), Marx intende per alienazione la situazione storica
dell'operaio nella società capitalistica, in cui il salariato, per causa
della proprietà privata, si trova:
1) scisso o separato sia rispetto al prodotto della sua attività (che
appartiene al capitalista), sia rispetto alla sua attività stessa (che
assume la forma di un lavoro costrittivo nel quale egli è reso strumento
di fini estranei);
2) in uno stato di dipendenza rispetto ad una potenza (il capitale) che egli
stesso produce continuamente con il proprio lavoro: « l'oggetto che il
lavoro produce, il prodotto del lavoro, si contrappone ad esso come un
essere estraneo, come una potenza indipendente da colui che lo
produce... (Manoscritti). Se l'alienazione deriva dal regime di proprità
privata, la disalienazione si identifica, secondo Marx, con la sua
abolizione, cioè con il comunismo.
- Alienazione religiosa. Pur accettando da Feuerbach l'idea della matrice
umana della religione, Marx ritiene che le cause di essa non vadano
cercate nell'uomo in quanto tale, ma in un tipo storico di società che la
produce a titolo di «oppio dei popoli», ovvero a guisa di consolazione
illusoria delle masse, sofferenti per causa delle ingiustizie sociali.
Ora, se la religione è il frutto malato di una società malata, l'unico
modo per sradicarla è, secondo Marx, quello di distruggere le strutture
sociali che la producono: La religione è il gemito della creatura
oppressa, l'anima di un mondo senza cuore, così com'è lo spirito di una
condizione di vita priva di spiritualità. Essa è l'oppio per il popolo.
La soppressione della religione quale felicità illusoria del popolo è il
presupposto della vera felicità. La necessità di rinunziare alle
illusioni riguardanti le proprie condizioni è la necessità di rinunziare
a quelle condizioni che hanno bisogno di illusioni. La critica della
religione è dunque, in germe, la critica della valle di lacrime di cui
la religione è l'aureola sacra...» (Annali franco-tedeschi).
- Ideologia. Nel significato più forte e caratteristicamente marxiano si
intende per ideologia una rappresentazione falsa o deformata della
realtà, derivante da specifici interessi di classe (per altri
significati vedi il testo). La lotta contro l'ideologia costituisce uno
degli scopi primari del marxismo, il quale presenta se stesso, come
«scienza reale e positiva», ossia come un quadro oggettivo delle forze
motrici della società e della storia: « I presupposti da cui muoviamo
non sono arbitrari, non sono dogmi: sono presupposti reali, dai quali si
può astrarre solo nell'immaginazione. Essi sono gli individui reali, la
loro azione e le loro condizioni materiali di vita... Questi presupposti
sono dunque constatabili per via puramente empirica...» (L'ideologia
tedesca, volume 1). N.B. Questa accezione «negativa» di ideologia, tipica
di Marx ed Engels, è andata smarrita presso Lenin e i marxisti russi.
Infatti, da questi ultimi, che non conoscevano gli scritti giovanili di
Marx (rimasti inediti sino agli anni Trenta) il termine ideologia venne
inteso in modo generico e neutrale, ossia come sinonimo di «sistema di
idee». Si parlò così (secondo un uso tuttora prevalente, ma ben distante
da quello originario di Marx) di ideologia marxista, proletaria,
borghese eccetera.
- Per forze produttive Marx intende gli elementi indispensabili al
processo di produzione, ossia, fondamentalmente:
1) gli uomini che producono;
2) i mezzi (terra, macchine eccetera) di cui si servono per
produrre (= i mezzi di produzione);
3) le conoscenze tecniche e scientifiche di cui si servono per organizare
e migliorare la loro produzione.
- I rapporti di produzione sono i rapporti che si instaurano fra gli
uomini nel corso della produzione e che regolano il possesso e l'impiego
dei mezi di lavoro, nonché la ripartizione di ciò che tramite essi si
produce. I rapporti di produzione trovano la loro espressione giuridica
nei rapporti di proprietà.
- Per modo di produzione Marx intende una combinazione storicamente
determinata tra forze produttive (vedi) e rapporti di produzione (vedi).
Combinazione che forma il blocco portante di una formazione sociale
(vedi).
- Struttura. L'insieme dei rapporti di produzione, o, più in generale,
la base economica, quale si esprime nel «modo di produzione» (vedi) e
nella relativa dialettica tra forze produttive e rapporti di produzione,
costituisce la struttura, ovvero lo scheletro economico, di una certa
società.
- La sovrastruttura (dal tedesco überbau: über = sopra, Bau = costruzione)
è l'insieme delle istituzioni giuridico-politiche e delle teorie morali,
religiose, filosofiche eccetera, che corrispondono ad una determinata
struttura (vedi) economica. Il rapporto fra struttura e sovrastruttura,
ossia lo specifico rapporto di dipendenza della seconda dalla prima,
rappresenta uno dei punti più controversi del marxismo (vedi il testo).
- Per materialismo storico si intende la teoria, propria di Marx, secondo
cui le vere forze motrici della storia non sono di natura spirituale o
coscienziale, bensì materiale o socio-economica: «non è la coscienza che
determina la vita, ma la vita che determina la coscienza» (Ideologia
tedesca, volume 1). «Questa concezione della storia si fonda dunque su
questi punti: spiegare il processo reale della produzione, e precisamente
muovendo dalla produzione materiale della vita immediata, assumere come
fondamento di tutta la storia la forma di relazioni che è connessa con
quel modo di produzione e che da essa è generata, dunque la società
civile nei suoi diversi stadi, e sia rappresentarla nella sua azione
come Stato, sia spiegare partendo da essa tutte le varie creazioni
teoriche e le forme della coscienza, religione, filosofia, morale eccetera
e seguire sulla base di queste il processo della sua origine, ciò che
consente naturalmente anche di rappresentare la cosa nella sua totalità
(e quindi anche la reciproca influenza di questi lati diversi l'uno
sullaltro)» (ivi, 1).
- La legge della storia. Forze produttive e rapporti di produzione, oltre
che rappresentare la chiave di lettura della statica della società, si
configurano anche come lo strumento interpretativo della sua dinamica,
ossia come la legge stessa della storia. Marx ritiene infatti che ad un
determinato grado di sviluppo delle forze produttive tendano a
corrispondere determinati rapporti di produzione e di proprietà, che si
mantengono sino a quando favoriscono le forze produttive e vengono
distrutti quando si convertono in ostacoli o catene per le medesime. Ora
poiché le forze produttive, in connessione con lo sviluppo tecnico, si
sviluppano più rapidamente dei rapporti di produzione, che esprimendo
delle relazioni di proprietà tendono a rimanere statici, ne segue
periodicamente uno stato di frizione o di contraddizione fra i due
elementi, che sfocia in una rivoluzione: «A un dato punto del loro
sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in
contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i
rapporti di proprietà (che ne sono soltanto l'espressione giuridica)
dentro i quali tali forze per l'innanzi serano mosse. Questi rapporti, da
forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in catene. E
allora subentra un'epoca di rivoluzione. Con il cambiamento della base
economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca
sovrastruttura...» (Prefazione a Per la critica all'economia politica).
- Per formazione sociale (Gesellschaftsformation) o formazione
economico-sociale (ökonomische Gesellschaftsformation) si intende
l'insieme degli elementi strutturali e sovrastrutturali che
contraddistinguono una società storicamente determinata. Le formazioni
economico-sociali sono dunque delle totalità organiche la cui spina
dorsale è costituita da uno specifico «modo di produzione» (vedi).
« A grandi linee - scrive Marx nella prefazione a Per la critica
dell'economia politica - i modi di produzione asiatico, antico, feudale
e borghese moderno possono essere designati come epoche che marcano il
progresso della formazione economica della società». Tuttavia poiché Marx
ed Engels accennano talora all'esistenza di un «comunismo primitivo» e
prospettano il socialismo come l'ultimo tipo di società della storia,
si può dire che secondo i classici del marxismo le grandi formazioni
economico-sociali della storia siano il comunismo primitivo, la società
asiatica, la società antica, la società feudale, la società borghese e
la società socialista (vedi il testo). N.B. Con questa sequenza evolutiva,
Marx (a differenza del marxismo volgare) non intende alludere ad una serie
di tappe necessarie in rigida successione logica e cronologica (in quanto
molte società hanno saltato l'una o l'altra fase e in una stessa epoca
o area culturale si è avuta la compresenza di più modi di produzione).
Ciò non toglie che le varie formazioni sociali costituiscano, dal punto di
vista di Marx ed Engels, altrettanti gradini di uno sviluppo che, a
cominciare dalle forze produttive, procede necessariamente dall'inferiore
al superiore.
- Classi sociali. Secondo Marx le classi (dal latino classis, nome di
etimologia incerta che denotava il livello tributario o il censo dei
cittadini) si definiscono essenzialmente in rapporto alla proprietà o
meno dei mezzi di produzione, la quale fa sì che in ogni periodo vi
siano sempre due classi fondamentali (liberi e schiavi, baroni e servi
della gleba, capitalisti e salariati eccetera).
- Marx vede nella lotta di classe, in cui si concretizza la contraddizione
tra forze produttive e rapporti di produzione, la forza motrice della
storia sinora trascorsa e concepisce il comunismo (vedi) come una società
senza classi.
- Per falsi socialismi Marx intende tutte quelle dottrine («il socialismo
reazionario», «il socialismo conservatore o borghese», «il socialismo e
il comunismo critico-utopistico» (vedi il testo) che non sono ancora
giunte al socialismo scientifico (vedi).
- Socialismo scientifico. La «scientificità » del socialismo di Marx ed
Engels consiste, secondo i suoi autori:
a) nel fatto che il socialismo da programma razionalistico di
ricostruzione della società che si rivolge indistintamente alla sua parte
intellettualmente illuminata si trasforma in programma di autoemancipazione
del proletariato, in quanto portatore storico della tendenza oggettiva
alla risoluzione comunistica delle contraddizioni economico-sociali
del capitalismo... in questo senso il socialismo intende essere "scienza"
della rivoluzione proletaria;
b) nel fatto che il socialismo non si presenta più come un "ideale" ma
come una necessità storica derivante dall'inevitabile tramonto nel modo
capitalistico di produzione, che si annuncia oggettivamente nelle sempre
più acute e frequenti crisi cui esso va incontro;
c) nel fatto che il socialismo usa ora un "metodo scientifico" di analisi
della società e della storia, che ha i suoi punti di forza nel
"materialismo storico", con la teoria della successione storica dei modi
di produzione, e nella "critica dell'economia politica", con la teoria
del plusvalore...» (C. Pianciola).
- Il partito comunista è l'avanguardia organizzata del movimento operaio,
che deve guidare la classe lavoratrice alla rivoluzione: «Nella sua lotta
contro il potere unificato delle classi possidenti, il proletariato può
agire come classe solo organizzandosi in partito politico autonomo, che
si oppone a tutti gli altri partiti costituiti dalle classi possidenti.
Questa organizzazione del proletariato in partito politico è necessaria
allo scopo di assicurare la vittoria della rivoluzione sociale e il
raggiungimento del suo fine ultimo, la soppressione delle classi» (Marx,
Statuti dell'Associazione Internazionale degli Operai).
- Capitalismo. Marx interpreta la formazione sociale (vedi) capitalistica
dall'angolo visuale di un'analisi scientifica nel modo di produzione
capitalistico. All'interno di questa ottica, egli distingue il
capitalismo dagli altri tipi di società soprattutto in relazione a due
caratteristiche specifiche: la produzione di merci (vedi) e il plusvalore
(vedi). Il capitalismo, scrive Marx in Il Capitale, «produce i suoi
prodotti come merci. Il produrre merci non lo distingue dagli altri modi
di produzione, lo distingue invece il fatto che il carattere prevalente
e determinante del suo prodotto è quello di essere merce...», «il secondo
tratto caratteristico, che contraddistingue specificamente il modo di
produzione capitalistico è la produzione di plusvalore come scopo diretto
e motivo determinante della produzione. Il capitale produce capitale e fa
ciò solamente nella misura in cui produce plusvalore» (libro 3).
- Merce e valore. La merce costituisce, per Marx, la più evidente
caratteristica del capitalismo (vedi) inteso come una «immane raccolta di
merci». La merce deve possedere innanzitutto un valore d'uso («L'utilità di
una cosa ne fa un valore d'uso»). Tuttavia, per essere veramente tale, la
merce deve possedere anche un valore di scambio («esse sono merci
soltanto perché son qualcosa di duplice: oggetti d'uso e
contemporaneamente depositari di valore»). Ma in che cosa consiste tale
valore di scambio? Marx, sulla scia degli economisti classici e
dell'equazione valore = lavoro, risponde che esso discende dalla quantità
di lavoro socialmente necessaria per produrla.
- Marx chiama feticismo delle merci il processo che porta a ritenere:
1) che le merci abbiano valore di per se stesse (dimenticando che esse
sono il frutto del lavoro umano);
2) che i rapporti economici siano rapporti fra «cose» e non fra uomini:
« Quel che qui assume per gli uomini la forma fantasmagorica di un
rapporto fra cose è soltanto il rapporto sociale determinato che esiste
fra gli uomini stessi. Quindi, per trovare un'analogia, dobbiamo involarci
nella regione nebulosa del mondo religioso. Quivi, i prodotti del cervello
umano paiono figure indipendenti, dotate di vita propria... Così, nel
mondo delle merci, fanno i prodotti della mano umana. Questo io chiamo il
feticismo che s'appiccica ai prodotti del lavoro appena vengono prodotti
come merci...» (Il Capitale, libro 3).
- Plusvalore. Il ciclo tipico della società capitalistica D. M. D'.
(merce-denaro-più denaro) ha come presupposto l'incremento di D., ossia
la produzione di plusvalore: «Chiamo plusvalore (surplus value) questo
incremento, ossia questo eccedente sul valore originario» (Il Capitale,
libro 1). Da dove deriva tale incremento? Marx risponde che esso
discende dal fatto che il capitalista ha la possibilità di «comperare ed
usare» una merce particolare, che risulta in grado di produrre valore.
Tale è la «merce umana», ossia fuor di metafora, l'operaio, il quale
producendo ad esempio 10, mentre a lui viene corrisposto un salario
equivalente a 6, è costretto a regalare al capitalista l'eccedenza di
4. Il plusvalore discende quindi dal plus-lavoro dell'operaio e si
identifica con la porzione di valore da lui gratuitamente offerta al
capitalista.
- Il capitale costante coincide con il capitale investito nei mezzi di
produzione.
- Il capitale variabile coincide con il capitale investito nei salari.
- Il saggio del plusvalore è il rapporto, espresso in percentuale, fra il
plusvalore conseguito ed il capitale variabile anticipato sotto forma di
salari. Tale saggio (per la cui esemplificazione matematica vedi il testo)
manifesta il grado di sfruttamento della forza-lavoro operaia («il grado
di sfruttamento determina l'ammontare del saggio del plusvalore»).
- Il saggio del profitto scaturisce da un rapporto, espresso in
percentuale, fra il plusvalore da un lato e la somma del capitale
costante e del capitale variabile dall'altro. Il saggio o tasso del
profitto risulta inferiore, per definizione, al saggio del plusvalore.
- Caduta tendenziale del saggio di profitto. Legge per cui, accrescendosi
smisuratamente il capitale costante (vedi) rispetto al capitale variabile
(vedi), ossia aumentando la cosiddetta «composizione organica del capitale»
diminuisce per forza il saggio di profitto (vedi). In altri termini, in
virtù di tale legge, succede che il profitto, per quanto elevato, risulti
progressivamente sempre più scarso rispetto al capitale impiegato, in
virtù, appunto, della crescita eccessiva del capitale costante.
- Sfruttamento. In senso economico-sociale e tecnicamente marxiano,
coincide con il prelievo di plusvalore (vedi) agli operai salariati da
parte dei capitalisti. Dal punto di vista filosofico coincide con
l'alienazione (vedi), ossia con la riduzione dell'uomo a mezzo.
- Contraddizioni del capitalismo. Secondo Marx il capitalismo risulta
internamente minato da una serie di contraddizioni che ne spiegano
l'instabilità di fondo e la fine inevitabile. Tali sono, ad esempio,
l'anarchia della produzione, le crisi cicliche, la disoccupazione, la
caduta tendenziale del saggio di profitto (vedi), la concorrenza e la
scissione della società in due classi antagonistiche (con la relativa
proletarizzazione della maggior parte della società). Contraddizioni che
dipendono tutte dalla contraddizione di fondo del capitalismo, cioè dal
contrasto tra forze produttive sempre più sociali e il carattere
privatistico dei rapporti di produzione e di proprietà.
- Per rivoluzione Marx intende il processo con il quale il proletariato,
impadronendosi del potere politico, dà avvio alla trasformazione globale
della vecchia società, attuando il passaggio dal capitalismo al
comunismo. Passaggio che prevede una progressiva abolizione della
proprietà privata dei mezzi di produzione, la scomparsa delle classi e la
realizzazione di una società di liberi produttori nella quale non vi
siano più né sfruttatori né sfruttati. Dal punto di vista
storico-filosofico, la rivoluzione coincide con il processo che porta
alla fine della «preistoria dell'umanità».
- Lo Stato borghese, secondo Marx, non è un'entità neutrale o al di sopra
delle parti, ma un insieme di apparati istituzionali e ideologici che
servono, alla borghesia per esercitare il proprio dominio di classe:
«Lo Stato è la forma in cui gli individui di una classe fanno valere i
loro interessi comuni» (Ideologia tedesca, libro 1).
Di conseguenza, secondo il marxismo rivoluzionario, il compito del
proletariato non è quello di « impadronirsi» della macchina statale
borghese (secondo il modello del marxista revisionista) ma quello di
smantellarne i meccanismi strutturali, compresa la democrazia
rappresentativa.
- La dittatura del proletariato si configura, secondo Marx, come la misura
politica fondamentale del processo rivoluzionario, ossia come la fase
che «media» il passaggio dalla società borghese a quella comunista. In
altri termini, tale dittatura è il momento in cui il proletariato,
organizzandosi «a classe dominante», impone la propria egemonia sulla
classe borghese, al fine di distruggere lo Stato borghese (vedi) e di
attuare il progetto comunista. Le misure concrete della dittatura
proletaria sono state elencate da Marx in relazione alla Comune di
Parigi (vedi il testo).
- Fasi del comunismo. Nella Critica al programma di Gotha, Marx distingue
due fasi della società futura. Nella prima fase, in cui abbiamo a che
fare con una società comunista che porta ancora le «macchie» della
vecchia società, vige il principio (ancora imperfetto) «a ciascuno
secondo il suo lavoro». Nella seconda fase, ossia in una condizione di
comunismo pienamente dispiegato e di grande ricchezza, vige il principio
«a ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni».
Nicola Abbagnano.
STORIA DELLA FILOSOFIA.
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO.
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI.
VOLUME TERZO
CAPITOLO UNDICESIMO: Tradizionalismo, Romanticismo e spiritualismo nella
filosofia francese ed italiana della prima metà dell'Ottocento.
1. La seconda fase del Romanticismo: rivelazione e tradizione.
Il finito come realizzazione dell'infinito.
La parola d'ordine del Romanticismo è l'identità del finito e
dell'infinito. Questa identità viene espressa dalle filosofie romantiche
in vari modi: come identità dell'Io e del non io, dello Spirito e della
natura, del razionale e del reale, dell'ideale e del reale, di Dio e del
mondo: tutte queste coppie di termini hanno pressapoco lo stesso
significato. Per questa identità, il finito (il non-io, la natura, il
reale, il mondo) appare come la realtà o l'esistenza dell'Infinito
(dell'Io, dello Spirito, del Razionale, dell'Ideale, di Dio): sicché, se
da un lato il finito non ha realtà fuori dell'infinito ed è nulla senza
di esso, dall'altro l'Infinito stesso (a meno che non sia concepito come
«falso » o « cattivo » infinito) non ha realtà fuori del finito. Dal
punto di vista filosofico questa concezione è un immanentismo rigoroso;
dal punto di vista religioso è un panteismo. Essa si trova nel primo
Fichte, nei Frammenti di Schlegel, nel primo Schelling e in Hegel, oltre
che in Novalis, Schleiermacher eccetera.
Il finito come rivelazione dell'infinito.
Ma le filosofie romantiche presentano pure un'altra concezione del
rapporto tra l'infinito e il finito: una concezione per la quale
l'Infinito viene in qualche modo a distinguersi dal finito pur
manifestandosi o rivelandosi in esso. In questo caso, il finito (il
mondo, la natura, la storia) non è la realtà dell'infinito ma la sua
rivelazione più o meno adeguata. Hegel si rifiutò costantemente di
distinguere l'Idea dalla sua manifestazione, perciò rimase estraneo a
questa concezione del rapporto tra l'infinito e il finito. Ma essa fu
propria del secondo Fichte, del secondo Schelling e del secondo
Schlegel; e ispirò le correnti romantiche della filosofia europea
dell'800. Se il primo Romanticismo era immanentismo e panteismo, il
secondo Romanticismo, nel quale prevale la distinzione tra l'infinito e
la sua manifestazione, è trascendentismo e teismo: ammette cioè la
trascendenza dell'Infinito rispetto al finito e considera l'Infinito
stesso come un Assoluto o Dio che è al di là delle sue
manifestazioni mondane. In alcuni autori, come in Friedrich Schlegel,
questa seconda fase del Romanticismo si accompagna all'accettazione del
cattolicesimo; ed in questa forma, infatti, il Romanticismo è in accordo
fondamentale con il pensiero religioso e si presta ad essere adoperato
ai fini dell'apologetica religiosa.
La tradizione.
Come già si è detto, uno degli aspetti fondamentali del Romanticismo è
la difesa della tradizione. Mentre l'Illuminismo opponeva
tradizione e storicità e vedeva nella storicità la critica della
tradizione, cioè il riconoscimento e l'eliminazione degli errori e dei
pregiudizi che la tradizione tramanda e fa accettare senza discussione,
il Romanticismo tende a considerare la storicità stessa come tradizione,
cioè come un processo nel quale non ci sono errori, né pregiudizi né
mali e in virtù del quale ogni valore o conquista umana si conserva e
trasmette nel corso del tempo. Quest'aspetto del Romanticismo si accentua
in quella che abbiamo chiamato seconda concezione o fase di esso. In
questa infatti la storia è concepita come la manifestazione progressiva
dell'Infinito, cioè di Dio: sicché, non ci può essere in essa decadenza,
imperfezione od errore che non trovi riscatto o correzione nella
totalità del processo.
2.Il tradizionalismo francese.
Il tradizionalismo in Francia.
Con l'irrompere del Romanticismo nella cultura francese, dominata nel
secolo 18esimo dall'antitradizionalismo illuministico, si delinea un
ritorno alla tradizione che, nella sua manifestazione più ovvia e
battagliera, è una difesa esplicita di essa (tradizionalismo). Araldi
della tradizione sono i primi romantici: Madame de Staël (1766-1817) che
nella sua opera sulla Germania (1813) vede nella storia umana una
progressiva rivelazione religiosa al modo di Schiller e di Fichte, e
René de Chateaubriand (1769-1848) che nel Genio del cristianesimo volge
la difesa della tradizione al servizio del cattolicesimo, assunto come
l'unico depositario della tradizione autentica dell'umanità.
Nel campo filosofico-politico la difesa della tradizione è opera degli
scrittori cosiddetti teocratici o ultramontanisti:
Louis de Bonald (1745-1840), Joseph de Maistre (1753-1821) e
Robert Lamennais (1782-1854). A questi scrittori la tradizione appare
come l'unica depositaria della verità, del bene e di tutti i valori che
presiedono alla vita umana. Per essi, la tradizione si incarna nelle
istituzioni storiche fondamentali, la Chiesa e lo Stato, sicché ogni
ribellione a tali istituzioni e ogni allontanamento dalla tradizione che
esse incarnano è colpa, errore e peccato, che esige e provoca punizione e
dolore. Pertanto questi scrittori vedono nella rivoluzione francese e
nel movimento di pensiero che l'ha preparata una aberrazione colpevole
che non ha prodotto, e non poteva produrre, che guerre, rovine e lutti.
Lamennais.
Robert Lamennais fu dapprima accanito difensore dell'ultramontanismo,
poi sviluppò una forma di cattolicesimo liberale;
ma condannato dalla Chiesa per eresia, si separò dalla Chiesa stessa e
divenne con le Parole di un credente (1834) difensore della democrazia.
Nel Saggio sull'indifferenza in materia religiosa Lamennais aveva visto
nell'indifferenza religiosa la malattia del secolo e ne aveva additata
l'origine nella fiducia riposta nella ragione individuale. Alla ragione
individuale egli aveva contrapposto la ragione comune, una specie di
intuizione delle verità fondamentali comune a tutti gli uomini, che
sarebbe il fondamento della fede cattolica.
La ragione comune è poi la tradizione universale, la cui origine è una
rivelazione primitiva e di cui la Chiesa stessa non è che la depositaria.
Più tardi egli cercò di giustificare questo stesso principio ricorrendo
all'idea dell'essere di Rosmini, che obbedisce a un'esigenza analoga. Quando
la Chiesa condannò la sua dottrina, egli si appellò, contro la Chiesa,
alla tradizione autentica e profetizzò l'avvento di una società religiosa
liberata dalle tirannie politiche e dai privilegi sociali.
L'ideologia.
Nei primi decenni dell'800, la filosofia dell'illuminismo continuò in
Francia a manifestare una certa vitalità e prese il nome di ideologia col
quale si indicò «l'analisi delle sensazioni e delle idee», secondo il
modello di Condillac. Nel seno stesso dell'ideologia doveva però
manifestarsi il ritorno alla tradizione spiritualistica.
De Tracy.
Antonie Destutt De Tracy (1754-1836), nei suoi Elementi di ideologia, ha
cercato di ricondurre alla sensibilità, come a un'unica fonte,
le attività fondamentali dell'uomo, che egli riduce a quattro: sentire,
ricordare, giudicare, volere. Queste attività sono originariamente
distinte e non derivano l'una dall'altra. Inoltre una grande importanza è
attribuita alla «motilità», e ricorrono felici osservazioni su aspetti
dell'attività psichica che noi oggi diremmo pre-consci e sub-consci.
Cabanis.
La stretta connessione delle attività psichiche con l'organismo corporeo
fu illustrata dal medico Pierre Cabanis (1757-1808), in un'opera
intitolata Rapporti fra il fisico e il morale dell'uomo. Cabanis
raccoglie una serie di osservazioni sull'influsso che le condizioni
fisiche (età, sesso, temperamento, malattie, clima) esercitano sulla
vita intellettuale e morale dell'uomo. Queste osservazioni gli fanno
ammettere la dipendenza della vita psichica da quella fisica, senza che
tuttavia egli giunga a ridurre quella a questa. Anzi, in uno scritto
postumo, egli concepisce l'anima come una sostanza dotata di una realtà
indipendente dal corpo e afferma l'esistenza di Dio e il finalismo del
mondo. Attraverso questi ed altri pensatori, l'ideologia francese
accentua sempre più l'importanza dell'esperienza interna, della
riflessione dell'uomo su se stesso, a scapito dell'esperienza esterna che
si rivolge alle cose. Nell'esperienza interna si finisce per vedere la
rivelazione stessa della verità assoluta. L'ideologismo a un certo punto
si salda al tradizionalismo.
Maine De Biran.
Questo punto è costituito dalla filosofia di Maine De Biran (1766-1824).
L'atteggiamento di Maine De Biran consiste da un lato nel ripiegamento
incessante sulla propria interiorità (del quale fa testimonianza il Diario
intimo); dall'altro nel far servire tale osservazione interiore
(o coscienza) alla giustificazione della tradizione religiosa e politica,
e infine nell'identificare coscienza e tradizione. La coscienza svela
all'uomo immediatamente l'attività che costituisce il suo io: questa
attività è uno sforzo che si esercita sull'organismo fisico, sugli stati
sensibili con esso legati, quindi sulla materia. La vita interiore è
attività, volontà, quindi libertà. Al «penso, dunque sono» di Cartesio,
Biran oppone il suo «voglio, agisco, dunque sono». L'osservazione interiore
prova che l'io è una causa libera, una forza che si distingue dai suoi
effetti transitori e dai suoi soggetti passivi. Il fatto primitivo del
senso intimo si identifica perciò col principio di causalità e ne è la
giustificazione assoluta. Ma il principio di causalità conduce
immediatamente a Dio, che è causa prima, sicché Dio è la forza che
agisce nell'anima dell'uomo così come l'anima dell'uomo è la forza che
agisce nel corpo. Come testimonianza della verità assoluta, il senso
intimo è la rivelazione stessa della verità: la coscienza è la
rivelazione di Dio. La rivelazione non è solo quella esterna della
tradizione orale o scritta, ma è soprattutto rivelazione interna o della
coscienza, che, anch'essa, viene direttamente da Dio e sulla quale, assai
più che su quella esterna, sono fondate le istituzioni morali e
religiose. Tali istituzioni avranno veramente raggiunto la loro saldezza
solo quando avranno trovato una base sempre più diffusa nella rivelazione
interiore della coscienza. Maine De Biran ha inteso il senso interno
come strumento di giustificazione della tradizione. Ciò lo connette al
Romanticismo contemporaneo. Dall'altro lato, per l'importanza accordata alla
coscienza, come riflessione dell'uomo su se stesso, Maine De Biran è il
maestro dello spiritualismo contemporaneo.
3. Ritorno alla tradizione in Italia. Galluppi.
Spiritualismo e tradizionalismo in Italia.
Lo spiritualismo italiano della prima metà dell'800 è un movimento di
pensiero analogo e parallelo alla filosofia francese del periodo
contemporaneo. Delle quattro figure di questo movimento - Galluppi,
Rosmini, Gioberti, Mazzini -, Galluppi riprende il tentativo (già condotto
innanzi da Cousin) di far servire l'ideologia alla difesa dello
spiritualismo tradizionale; Rosmini e Gioberti sono più vicini al
tradizionalismo di De Bonald e Lamennais; Mazzini si ispira
all'umanitarismo del Lamennais della seconda maniera e al socialismo
utopistico di Saint-Simon.
Galluppi.
Pasquale Galluppi (1770-1846), che fu professore all'Università di Napoli,
fu benemerito della cultura filosofica italiana per aver fatto
conoscere, con esposizioni precise e lucide, la filosofia europea del
'700, sia negli scritti dedicati a questo scopo (Lettere filosofiche, 1827),
sia in quelli di carattere speculativo (Saggio filosofico sulla critica
della conoscenza, 1819-1832; Filosofia della volontà, 1832-1840). Da
Condillac e dagli ideologi Galluppi desume il principio che l'analisi è
l'attività fondamentale dello spirito, quindi l'unico metodo possibile
della filosofia. Il punto di partenza di quest'analisi è per lui quella
coscienza (o riflessione interiore) che già alcuni ideologi francesi
avevano rivalutata contro il sensismo illuministico.
Il fatto primitivo della coscienza è l'esistenza dell'io conoscente che è
presente immediatamente alla coscienza in ogni suo atto ed è perciò «una
verità primitiva sperimentale». Ma oltre che l'io, la coscienza fa anche
percepire ciò che è fuori dell'io mediante la percezione di un io
conoscente cioè di un io che percepisce qualcosa che non è in lui ma
fuori di lui: l'oggetto esterno. Pertanto, l'esistenza dell'io e l'esistenza
dell'oggetto esterno hanno, secondo Galluppi, la stessa certezza immediata
e costituiscono le due verità primitive e fondamentali della filosofia.
4. Rosmini.
4.1. Gnoseologia e metafisica.
Alla difesa della tradizione cattolica e quindi alla costruzione di un
sistema di filosofia che «possa essere dalla scienza teologica ricevuto
per suo ausiliare» è diretta l'opera di Antonio Rosmini Serbati.
Vita e opere.
Nato a Rovereto il 24 marzo 1797, sacerdote cattolico e fondatore d'una
congregazione religiosa che egli chiamò Istituto della carità, Rosmini
visse quasi sempre assorto nei suoi studi (tranne una breve
partecipazione alla vita politica per una missione del governo
piemontese presso papa Pio nono nel 1848) e morì a Stresa
il 1° luglio 1855. Tra i suoi numerosi scritti, i principali sono i seguenti:
Opuscoli filosofici (1827-1828); Nuovo saggio sull'origine delle idee (1830)
che rimane la sua opera fondamentale; Princìpi della scienza
morale (1831); Il rinnovamento della filosofia in Italia (1836), una
risposta alle critiche di Terenzio Mamiani; Storia comparativa e critica
dei sistemi intorno alla morale (1837); Antropologia (1838);
Trattato della scienza morale (1839); Filosofia della politica (1839);
Filosofia del diritto (1841-1845); Teodicea (1845); Psicologia (1850);
Introduzione alla filosofia (1850); Logica (1854). Alla quale massa
di opere va aggiunta quella non meno imponente delle opere postume: Del
principio supremo della metodica (1857); Aristotele esposto ed
esaminato (1857); Teosofia (1859-1874); Saggio storico-critico sulle
categorie e la dialettica (1882); Antropologia soprannaturale (1884);
oltre a un gran numero di scritti minori e di lettere.
La preoccupazione fondamentale di Rosmini è quella di difendere
l'oggettività della conoscenza e in generale della vita spirituale
dell'uomo, contro il soggettivismo assoluto di Kant e degli idealisti
post-kantiani. Questa preoccupazione coincide con l'altra, propriamente
scolastica, di ristabilire l'accordo intrinseco e sostanziale tra la
speculazione filosofica e la tradizione religiosa cristiana, portando la
prima a fondarsi sullo stesso principio che regge la seconda: Dio e la
rivelazione divina. In rispondenza a queste preoccupazioni fondamentali,
l'atteggiamento filosofico di Rosmini è quello proprio di ogni
spiritualismo, la riflessione sulla coscienza, cioè sui dati del senso
intimo. Rosmini esplicitamente riduce ogni certezza estrinseca, fondata
su un segno della verità (per esempio, sull'autorità) alla certezza
intrinseca che è la conoscenza intuitiva della verità stessa. «Il
principio ultimo della certezza riducesi ad un solo, cioè alla verità
creduta dalla mente con un'intuizione immediata, per sé evidente, senza
segni, senza argomenti di mezzo».
L'idea dell'essere...
Tuttavia l'intuizione immediata non è pura soggettività. è l'intuizione
dell'idea dell'essere, cioè di un principio oggettivo che costituisce la
forma stessa della soggettività razionale; e consente a Rosmini di
riconoscere il fondamento di ogni oggettività in quella stessa ragione che
da Cartesio in poi era considerata come il principio della soggettività.
Rosmini si riannoda in tal modo esplicitamente alla tradizione
dell'agostinismo medievale.
...e i suoi caratteri
Come forma originaria della mente umana, l'idea dell'essere è innata e
inderivabile. Essa non deriva dalle sensazioni, che sono modificazioni
soggettive dell'uomo; ed è presupposta da ogni giudizio che l'uomo formula
sulle cose reali che sono cause di queste sensazioni. Di nulla si può
dire che è (o esiste), se non si possiede preventivamente l'idea
dell'essere o dell'esistenza in generale. Daltra parte quest'idea
universalissima è implicita in ogni altra idea; giacché, per esempio,
l'idea di un uomo o di un libro è l'idea di un essere che è così
determinato, cioè che possiede, oltre l'essere, un certo numero di altre
determinazioni. L'idea dell'essere precede quindi non solo le sensazioni,
ma anche tutte le altre idee. E non può essere frutto di un'operazione
dello spirito umano, per esempio, dell'astrazione, giacché l'astrazione
non fa che togliere ad un'idea alcune determinazioni particolari, ma non
l'idea dell'essere, che rimane perciò presupposta. Bisogna dunque che
l'idea dell'essere sia innata e posta nell'uomo direttamente da Dio. Essa
non è l'idea di Dio, ma solo dell'essere possibile e indeterminato; è la
forma della ragione, il principio che la guida, la luce stessa
dell'intelligenza umana.
La percezione intellettiva e i suoi elementi.
Dall'idea dell'essere così intesa Rosmini intende derivare l'intero sistema
della conoscenza, nonché le facoltà umane che ne sono a fondamento.
Sull'idea dell'essere è infatti fondata l'intera conoscenza umana, il cui
atto è chiarito da Rosmini come percezione intellettiva. Conoscere
significa in ogni caso determinare l'essere possibile mediante la
sintesi di esso con un'idea particolare; o, il che è lo stesso,
universalizzare un'idea particolare mediante la sintesi di essa con l'idea
dell'essere possibile. Questo atto di determinazione o universalizzazione
è la percezione intellettiva. La quale suppone perciò tre elementi:
1° l'idea dellessere; 2° un'idea empirica derivante dalla sensazione (delle
cose esterne) o dal sentimento (che l'io ha di sé); 3° la sintesi o il
rapporto, espresso in un giudizio, tra l'idea dell'essere da un lato, la
sensazione o il sentimento dall'altro.
Conseguenze della dottrina rosminiana.
Da questa dottrina fondamentale scaturiscono varie conseguenze
importanti. La prima è che la conoscenza che l'io ha di sé non è più
originaria e più certa della conoscenza che egli ha di una realtà
qualsiasi. Difatti per affermarsi esistente, l'io
ha bisogno non solo del sentimento della propria esistenza, ma anche
dell'idea dell'essere, esattamente come accade per l'affermazione delle altre
cose. La seconda conseguenza è che la realtà dei corpi esterni perde il
carattere problematico, che aveva assunto da Cartesio in poi, e viene
dichiarata indubitabile e certa. Difatti dall'idea dell'essere scaturiscono
necessariamente non soltanto i princìpi logici d'identità e di
contraddizione, ma anche il principio di causalità, giacché in base ad
essa non si può ammettere che ci sia un mutamento senza che ci sia un
ente che lo produca; sicché quando si producono nell'uomo quelle
modificazioni che sono le sensazioni, bisogna ammettere le cause di
queste sensazioni, cioè i corpi. Tali corpi dovranno essere concepiti
come sostanze perché solo la sostanza è un'energia operante. Per lo
stesso motivo il sentimento fondamentale, cioè la sensazione della
propria vita organica, implica l'esistenza di un corpo col quale siamo
uniti e dal quale nell'atto stesso ci distinguiamo. La terza conseguenza è
che l'essere ideale toglie alla soggettività umana l'autonomia e la
capacità d'iniziativa che la filosofia moderna, da Cartesio in poi, le
veniva riconoscendo, e consente a Rosmini la ripresa di quella tradizione
ontologistica che era circolata nella scolastica medievale.
4.2. Morale, Diritto e politica.
Morale.
L'idea dell'essere è anche il fondamento della morale, del diritto e della
politica. La formula più generale della morale è: «Segui nel tuo operare
il lume della ragione.» Il lume della ragione non è la ragione, la quale è
soltanto la facoltà dello spirito umano di applicare l'idea dell'essere; ma
è la stessa idea dell'essere, che non è soggetta alla limitazione
dell'intelligenza umana perché è la verità stessa nella propria eternità e
necessità. Rendono impossibile la legge morale, da un lato quei sistemi
(come quello di Kant) che identificano la ragione umana col suo lume e
così rendono autonomo l'uomo e lo divinizzano, dall'altro quei sistemi
(empiristici) che identificano il lume della ragione con l'uomo e così
rendono variabile e contingente la stessa legge morale. L'uomo, afferma
Rosmini, «è meramente passivo verso la legge morale; egli riceve in sé
questa legge, ma non la forma; è un suddito a cui la legge s'impone, non è
un legislatore che la impone.» L'idea dell'essere rivela all'uomo il bene
perché il bene (come voleva la vecchia metafisica) è l'essere stesso.
«Volere o amare l'essere ovunque lo si conosca».
Come oggetto della volontà, l'essere rivela un ordine intrinseco che è
la guida oggettiva dell'azione morale. La massima di quest'azione si può
dunque formulare così: «Volere o amare l'essere ovunque lo si conosca,
secondo l'ordine che esso presenta all'intelligenza». Ora nell'ordine
dell'essere alcuni enti hanno ragione di fine e sono persone, altri hanno
ragione di mezzo e sono cose. Le cose stesse dunque sono beni che come tali
rientrano in un ordine oggettivo, disposto al fine dell'appagamento umano,
cioè della felicità. Ma beni superiori sono le persone che hanno sempre
valore di fine; ad esse dunque deve dirigersi l'atto morale, che dev'essere
atto di amore, in quanto l'intelletto non può riconoscere nessun essere
superiore a quello dotato d'intelligenza. Ma poiché la dignità delle nature
intelligenti deriva per il tramite dell'idea dell'essere, da Dio, è a Dio
infine che si appunta l'atto morale dell'uomo come al suo fine ultimo ed
assoluto.
La filosofia del diritto.
Sul concetto della persona s'impernia interamente la filosofia del diritto,
che è una delle parti più vive del pensiero del Rosmini. Definito il
diritto come una «potestà morale» e precisamente come «una facoltà di
operare ciò che piace, protetta dalla legge morale che ne ingiunge ad
altri il rispetto», Rosmini lo considera legato
indissolubilmente alla persona morale. La libertà della persona è il
principio formale di tutti i diritti che poi si specificano e
determinano mediante il concetto di proprietà. La proprietà, come
«dominio che una persona ha di una cosa, costituisce la sfera dei
diritti di cui la persona è il centro e come tale è il fondamento di
tutti i diritti che Rosmini chiama connaturali, cioè che sono connessi
con la proprietà dell'uomo su se stesso.
La società civile e lo Stato.
Di fronte all'origine puramente morale del diritto, la società civile e
lo stato (che è la società civile esistente di fatto)
non hanno altro còmpito che quello di regolare la modalità dei diritti
stessi, al fine di proteggere il loro esercizio armonico, evitando le
collisioni e garantendo a ogni individuo la massima libertà possibile.
Rosmini ritiene che solo la società teocratica (cioè la chiesa) esista
di suo pieno diritto indipendentemente dalla volontà umana. La società
domestica (la famiglia) e la società civile non esistono di diritto se
non per un atto della volontà umana che liberamente le promuove. In
particolare, la società civile, risultando da un'azione di famiglie o di
padri di famiglie, trae il suo principio non dalla conoscenza spontanea
e naturale, ma dalla libera riflessione; e il suo fine essenziale è
quello di regolare la modalità dei diritti di cui godono naturalmente le
persone che la costituiscono. Per questo fine, la società civile deve
indubbiamente avere una forza prevalente senza la quale il regolamento
della modalità dei diritti sarebbe inefficace. Essa deve tendere
all'uguaglianza; ma non all'uguaglianza assoluta. Questa supporrebbe che
ogni individuo avesse posto nella società lo stesso capitale il che è
contro natura; l'ineguaglianza cade dunque entro la sfera del diritto. La
società deve invece pareggiare la quota-parte di utilità che dalla sua
istituzione e gestione può derivare agli individui. Questa forma
d'eguaglianza è il bene comune, al quale deve tendere ogni società
giuridicamente ordinata.
Nella stessa Filosofia del diritto, come nell'opera precedente Filosofia
della politica, Rosmini subordina la struttura politica della società
alla sua struttura sociale, che deve tendere al bene comune. Pur non
potendo proporsi, come s'è visto, l'abolizione della disuguaglianza delle
fortune, la società deve provvedere ai mali ch'essa procura, primo fra
tutti l'estrema miseria dell'altra parte della scala sociale. Questa è una
delle condizioni fondamentali del perfezionamento della società.
Perfezionamento che non può essere inteso come un progresso necessario
ma piuttosto come perfettibilità dell'uomo e della società verso l'ideale
cristiano di una comunità libera e giusta.
5. Gioberti: le dottrine metafisiche.
Alla difesa della tradizione spirituale italiana, riconosciuta nel
cattolicesimo e nel papato, è diretta l'opera di Vincenzo
Gioberti (1801-1852). Gioberti ha esercitato col Primato morale e civile
degli Italiani (1842) un influsso potente sul clima spirituale e politico
del Risorgimento italiano.
Ministro di Carlo Alberto nel 1848, ritornò in esilio dopo il fallimento
della politica neo-guelfa e nel Rinnovamento civile degli italiani (1851)
modificò radicalmente, in senso unitario e liberale, le idee
federalistiche e «neo-guelfe» del Primato. La sua opera filosofica
fondamentale è l'Introduzione allo studio della filosofia (1839-1840);
nelle opere postume Protologia, Filosofia della rivelazione, Riforma
cattolica, Gioberti accentua l'aspetto immanentistico e dialettico del
suo pensiero, i cui fondamenti sono tuttavia mantenuti immutati.
Gioberti è, come Rosmini, un difensore della tradizione e in particolare
della tradizione oggettivistica che anch'egli ritiene propria del
cattolicesimo. Ma egli non ritiene l'oggettivismo sufficientemente
fondato dall'idea dell'essere che Rosmini riconosce come forma o principio
di tutto il sapere. L'idea dell'essere è pur sempre unidea, cioè un dato
soggettivo: la conoscenza deve fondarsi, non già su un'idea, ma sulla stessa
realtà assoluta, cioè su Dio. Principio del sapere e garanzia della sua
oggettività deve essere l'intùito, cioè la visione diretta e immediata
di Dio. L'intùito tuttavia non è perfetto. Esso rivela bensì alluomo l'Ente
assoluto ma non ne rivela l'intima essenza, che rimane sovrintelligibile.
Alla limitazione dell'intùito supplisce in qualche modo la rivelazione,
che ci dà una rappresentazione analogica del sovrintelligibile. Alla scienza
che rivela l'intelligibile (e che è la filosofia) va dunque congiunta la
scienza del sovrintelligibile, la teologia alla quale la filosofia stessa
deve subordinarsi.
La formula ideale: «L'Ente crea l'esistente».
L'intùito è la condizione di ogni conoscenza, ma non è la conoscenza stessa.
Questa ha inizio solo con la riflessione che circoscrive e determina
l'oggetto dell'intùito, mediante l'espressione sensibile, cioè mediante il
linguaggio. Nasce così la possibilità di racchiudere in una formula
(la formula ideale) la rivelazione che nell'intùito l'Ente assoluto fa di
se stesso. L'intùito non ci fa cogliere l'Ente nella sua immobilità e
astrattezza, ma nella sua vita e nella sua completezza, cioè in quanto
è causa produttrice delle cose finite. La formula che esprime l'intùito
è perciò l'Ente crea l'esistente. In questa formula compaiono tre
realtà indipendenti dalla nostra mente: una Sostanza o Causa prima,
una molteplicità di sostanze e di cause seconde, e un atto reale
e libero della Sostanza o Causa prima in virtù del quale essa produce
e conserva le sostanze e le cause seconde con una creazione continua.
Da questa formula appare evidente, secondo Gioberti, che l'uomo
«è in ogni istante della sua vita intellettiva spettatore diretto e
immediato della creazione ».
L'esistente ritorna all'Ente.
Ma luomo non è soltanto spettatore, è anche attore del ciclo creativo.
Questo infatti non termina con la creazione dell'esistente, ma tende a
riportare a sé l'esistente e farlo partecipe della propria perfezione.
Ciò accade in virtù della vita morale per la quale liberamente l'uomo
si rende meritevole di quella beatitudine che è il suo ritorno a Dio.
L'esistente ritorna all'Ente, ecco la seconda parte della formula ideale,
che esprime il compimento del ciclo creativo. Mentre nella prima parte
il ciclo è solamente divino, nella seconda parte è divino e umano insieme,
perché le forze create concorrono, come cause seconde o concause, a
effettuarlo, sotto l'azione promovente e governatrice della Causa prima.
5.1. Le dottrine politiche.
Già le prime opere filosofiche di Gioberti, La teoria del soprannaturale
e l'Introduzione, contengono i princìpi politici che Gioberti doveva
lungamente illustrare nel Primato. Il primato degli Italiani è da Gioberti
dedotto dalla sua formula ideale, « l'Ente crea l'esistente». Applicata
alla società umana, questa formula significa: «la religione crea la moralità
e la civiltà del genere umano». Ora poiché il cristianesimo è la sola
religione che mantiene e conserva integra la rivelazione divina e poiché la
chiesa cattolica è l'unica depositaria ed interprete della rivelazione
cristiana, Gioberti vede nel cattolicesimo l'intera civiltà del genere
umano e nella storia del cattolicesimo la storia dell'umanità come tale.
Ma il cattolicesimo ha il suo centro in Italia dove risiede il suo capo;
la storia d'Italia si lega così più strettamente di quella d'ogni altro
paese alla storia del cattolicesimo e quindi della civiltà universale.
Gioberti vede i primordi duna storia cattolica già nella civiltà della
Magna Grecia cioè di quella «stirpe pelasgica» ch'egli, come Vico, ritiene
la prima depositaria della sapienza italica. Negli altri paesi d'Europa,
il principio della libertà della ricerca, affermato da Cartesio e da
Lutero, ha rotto l'unità della tradizione universale e costituisce una
minaccia di anarchia e di guerra. E perciò interesse dell'intera civiltà
ritornare alla sua tradizione cattolica; e questo ritorno non può essere
che un ritorno all'Italia, che è il centro di quella tradizione. L'Italia
deve dunque riprendere la sua missione ieratica e civilizzatrice,
conciliare tradizione e progresso, unificare l'elemento laico e l'elemento
sacerdotale che appaiono divisi e in contrasto. Tale è il còmpito che
Gioberti attribuisce al Risorgimento italiano, da lui quindi prospettato
come un'esigenza della civiltà universale, che deve ritrovare nella
tradizione autentica dell'umanità gli elementi della sua vita e del suo
progresso. Da questi concetti, Gioberti ricavava anche il suo programma
politico concreto: quello di una federazione di stati italiani che
avesse come suo capo il papa e come suo strumento secolare la forza
militare del Regno di Sardegna.
Fallita nel 1848-1849 la politica del neo-guelfismo, Gioberti pubblicava
nel 1851 il Rinnovamento politico dltalia che, lasciando in piedi
l'impalcatura filosofica dell'opera precedente, ne modifica
sostanzialmente la direttiva politica. Mentre nel Primato egli rivolgeva
il suo appello agli stati e alle classi dirigenti, nel Rinnovamento egli
si rivolge al popolo e si fa banditore di un rinnovamento democratico
della vita italiana e dell'Europa in genere. La sovranità deve spandersi
fino a immedesimarsi col popolo tutto e questo esige l'istruzione delle
classi popolari e la loro elevazione economica. Contrario al principio
comunista dell'abolizione della proprietà, Gioberti afferma il carattere
e la finalità sociale e morale di essa: e riconosce l'esigenza che lo
stato intervenga nella trasmissione e nella distribuzione della
ricchezza in modo da favorire il benessere del genere umano. Gioberti
vedeva il rinnovamento italiano nel quadro del rinnovamento europeo e
riaffermava la spiritualità del movimento storico attraverso il quale
una Nazione può riconoscersi e affermarsi come realtà. Riconosciuta
l'impossibilità di piegare il papato all'esigenza dell'unificazione
nazionale, Gioberti additava nel Piemonte lo stato italiano che doveva
assumersi il còmpito di condurla a termine.
6. Mazzini.
Le dottrine di Rosmini e Gioberti sono dominate dall'idea di tradizione;
il pensiero di Mazzini è dominato dall'idea di progresso. Ma l'apparente
antitesi delle due concezioni e l'aspra polemica in cui spesso si sono
urtate non devono nasconderci il motivo che esse hanno tuttavia in
comune: il progresso stesso non è che la tradizione ininterrotta del
genere umano, ed è di natura essenzialmente spirituale.
Progresso e tradizione.
Tuttavia accentuare, come fa Mazzini, il concetto di progresso implica una
differenza importante dal punto di vista pratico-politico: giacché
significa far servire l'idea della tradizione al fine della
trasformazione della società e delle istituzioni umane, anziché al fine
della loro conservazione.
Giuseppe Mazzini (1805-1872) fu il profeta e l'apostolo dell'unità del
popolo italiano, unità che egli intese nel quadro della cooperazione e
dell'armonia di tutti i popoli del mondo.
Coscienza e tradizione sono, secondo Mazzini, i soli criteri che noi
possediamo per raggiungere il vero. La tradizione (il cui valore è stato
a giusto titolo rivendicato da Lamennais, secondo Mazzini) è corretta in
ciò che ha di angusto e di immobile dalla coscienza individuale.
Coscienza e tradizione sono la rivelazione stessa della verità;
rivelazione che, con la famosa frase di Lessing, Mazzini chiama anche
«l'educazione progressiva dell'umanità». La parola rivelazione è intesa da
Mazzini nel senso più letterale. Dio s'incarna successivamente
nell'umanità; e l'umanità è la sola interprete di Dio sulla terra. «Dio è
Dio e l'umanità è il suo profeta», egli dice. Come manifestazione di Dio
sulla terra, la storia dell'umanità è un incessante progresso e, nel seno
di questo progresso, ad ogni individuo come ad ogni popolo è assegnato
un compito, una missione, che, per quell'individuo o per quel popolo, e
il suo dovere supremo.
STORIA DELLA FILOSOFIA
di Nicola Abbagnano
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
PARTE SESTA: Lo sviluppo delle scienze e l'affermazlone del Positivismo
"Noi dobbiamo considerare lo stato presente dell'universo come l'effetto
del suo stato anteriore e la causa di quello che seguirà". (Laplace)
"Chi di noi non ricorda, contemplando la sua propria storia, che è stato
successivamente, rispetto alle nozioni più importanti, teologo nella sua
infanzia, metafisico nella sua giovinezza e fisico nella sua maturità?".
(Comte)
CAPITOLO 12: Sviluppi e tendenze della scienza ottocentesca.
Il trionfo del meccanicismo e i segni premonitori della sua crisi
1. I nuovi rapporti tra scienza e filosofia.
Divorzio tra scienza e filosofia.
Nell'800 la scienza nata dalla rivoluzione scientifica esplica pienamente
le sue potenzialità. Con la fondazione della termodinamica e
dell'elettromagnetismo, con il rapido sviluppo della chimica e di
talune branche della biologia si allargano enormemente gli orizzonti
delle scienze della natura, che ancora per Kant non si spingevano oltre
i confini della meccanica. Ma il contesto culturale entro il quale si
realizzano questi progressi risulta profondamente diverso rispetto all'età
precedente. L'armonica collaborazione tra scienza e filosofia, realizzata
dall'Illuminismo, viene meno nell'età romantica. La filosofia, anche
prendendo spunto dall'emergere di nuove scoperte che stentano ad inserirsi
nel tradizionale modello newtoniano, va elaborando nuovi sistemi
onnicomprensivi fisico-filosofici privi di fondamento sperimentale e non
riesce più a fornire alla scienza un proprio orientamento. La scienza
d'altro canto tende a frantumarsi in una molteplicità di ricerche
sperimentali e teoriche che portano al costituirsi di innumerevoli
branche, tra le quali risulta problematico ogni tentativo di organica
unificazione. Nel laborioso processo di scandaglio dei nuovi territori
aperti all'indagine scientifica è pur vero che emergono a tratti
significative connessioni tra le diverse branche del sapere, ma si
tratta di rapporti per ora troppo frammentari, che solo nella seconda
metà del secolo cominceranno ad avviare il processo di integrazione.
Verso la metà del secolo, attraverso l'esperienza positivistica, che
riprende e rinnova molti temi dell'Illuminismo, la filosofia torna ad
accostarsi alla scienza e torna a cimentarsi nella sua tradizionale
vocazione unificatrice; si tratta, nondimeno, di un'esperienza
cronologicamente assai più circoscritta di quella realizzata
dall'Illuminismo, ma soprattutto connotata da un intento programmatico,
che irrigidisce filosofia e scienza nei loro specifici ruoli più che
favorire la loro collaborazione, e in questo nuovo difficile connubio
con la scienza la filosofia risulta coartata entro confini angusti
inconciliabili con il suo spirito e con la sua tradizione.
Al tramonto del secolo, attraverso la crisi del meccanicismo e del
positivismo, pensiero filosofico e pensiero scientifico tornano ad assumere
piena libertà, pagando talora la riacquistata autonomia con profonde
lacerazioni, ma trovando nello stesso tempo in essa il fondamento di una
nuova e di una più proficua collaborazione.
Il meccanicismo.
Frattanto la pratica scientifica, pur nel suo divorzio dalla filosofia,
non può ovviamente rinunciare a taluni princìpi regolativi, di carattere,
in ultima analisi, filosofici, che fungono da guida nell'indagine. In
questo senso il quadro di riferimento che fa da sfondo alla ricerca
continua in prevalenza ad essere il meccanicismo, di cui incontriamo,
già al dischiudersi del secolo, una lapidaria formulazione in un celebre
passo di Laplace (Teoria analitica delle probabilità, 1812). "Noi
dobbiamo considerare, scriveva, lo stato presente dell'universo come
l'effetto del suo stato anteriore e la causa di quello che seguirà.
Un'intelligenza che, per un istante dato, conoscesse tutte le
forze da cui la natura è animata e la situazione rispettiva degli esseri
che la compongono, se fosse abbastanza vasta per sottomettere questi dati
al calcolo, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi
corpi dell'universo e quelli del più leggero atomo: niente sarebbe incerto
per essa e l'avvenire, come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi".
Questo meccanicismo, che in Laplace è soltanto una formulazione aprioristica
di principio, con una forte valenza ideologica, nel corso del 19esimo
secolo, in virtù dei molteplici progressi delle scienze, sembra avviarsi
a divenire una visione scientifica del mondo, sui cui princìpi giova
soffermarsi.
La concezione meccanicistica, nella sua versione ottocentesca, riconduce il
mondo a quattro distinte entità: lo spazio, la materia, il tempo e il
movimento (o le forze, mentre il concetto di energia è, all'inizio del
secolo, tutt'altro che chiaro). Spazio e tempo costituiscono contenitori
formali, indifferenti ai propri contenuti, strutturati secondo
determinazioni oggettive a priori. Le leggi matematiche universali della
meccanica che governano il moto sono sufficienti a fornire spiegazione di
ogni fenomeno che entro quei contenitori possa aver luogo.
Capisaldi del meccanicismo.
Da questo modello si ricavano agevolmente i princìpi che caratterizzano la
concezione meccanicistica ottocentesca: determinismo, predicibilità,
riduzionismo, reversibilità. Ai quali princìpi possiamo aggiungere, in
un'ottica più specificamente filosofica, il ripudio del finalismo e della
metafisica.
Il determinismo sembrerebbe scaturire dal carattere matematico delle
leggi fisiche, sebbene in realtà non sia così, mentre la predicibilità
deriva dalla fede, non meno infondata, che qualunque equazione matematica,
almeno in via di principio, risulti risolvibile. Il riduzionismo a sua
volta è giustificato dalla convinzione che tutti i fenomeni di cui abbiamo
esperienza siano il prodotto di sistemi quanto si voglia complessi, ma pur
sempre scomponibili nelle loro parti costitutive di natura, in ultima
analisi, meccanica. La reversibilità si deduce infine dalla natura dei
fenomeni meccanici, che risultano simmetrici rispetto all'inversione del
tempo (si pensi, ad esempio, agli urti elastici. Ovviamente tra questi
princìpi rivestono un ruolo particolare il riduzionismo e la
reversibilità, che contrastano radicalmente con la nostra visione
intuitiva del mondo.
Il riduzionismo, infatti, induce a negare ogni carattere specifico alla
vita e alle stesse attività spirituali dell'uomo. Un essere vivente finisce
con il risultare solo una macchina molto complessa, un automa. Macchine
sono inoltre tutti i sistemi fisici funzionanti con regolarità, e
macchina, infine, può essere considerato l'universo stesso nella sua
totalità. La difficoltà è, ovviamente, spiegare come possa accadere che
sistemi così complessi, come quelli degli organismi, o regolari e
ordinati, come il sistema solare, possano essersi costituiti senza un
progetto o senza una particolare potenzialità o predisposizione della
materia. Le risposte fornite dal meccanicismo a questo problema sono varie,
ma riconducibili sostanzialmente a due tipi differenti. Per un verso il
meccanicismo tende a conciliarsi con la metafisica e, pur considerando
l'organizzazione come effetto di forze totalmente cieche, spiega i
risultati eccezionali cui esse pervengono riconducendoli al primo
impulso dato da Dio al mondo; il quale impulso fu così ben bilanciato da
predeterminare meccanicisticamente tutto ciò che poi si sarebbe prodotto.
Per altro verso, in una prospettiva opposta, che è quella prevalentemente
accolta dagli scienziati dell'800, ritiene invece che i concetti di ordine
e di disordine siano concetti puramente soggettivi. Un ammasso informe di
materia, malgrado la casualità del modo in cui le particelle sono
aggregate insieme, rappresenta, nella sua individualità, una
combinazione estremamente improbabile, non meno improbabile di quella
complessa macchina che è un essere vivente; la maggiore importanza che
noi attribuiamo alla seconda rispetto alla prima ci fa ritenere che la
prima possa essere un risultato fortuito, mentre ci fa ritenere che la
seconda debba essere in qualche modo il risultato di un progetto; ma in
realtà non vi è progetto né in un caso né nell'altro; tutto è dovuto al
gioco cieco e deterministico delle forze.
La reversibilità, infine, implica che il tempo possa essere percorso
indifferentemente in un verso o nell'altro; così, i corpi che
costituiscono il sistema solare potrebbero, senza guasto per la fisica,
percorrere le loro orbite nel verso opposto, e comunque, dopo un certo
lasso di tempo, torneranno a presentarsi nella medesima disposizione.
Ove non si abbia a che fare con sistemi ordinati, non sarà ovviamente
pensabile questa immediata reversibilità, tuttavia anche in questo caso
il tempo non lascia tracce permanenti e pertanto una qualunque
configurazione della materia, qualunque stato del sistema universo può,
almeno teoricamente, tornare a proporsi, dopo che si sia manifestato una
volta. Pertanto il mondo non dovrebbe avere una storia; né una storia
concepita come evoluzione e come progresso, che implicherebbe una certa
qual forma di creatività della materia, né una storia concepita come
degradazione, che implicherebbe, all'opposto, un'insufficienza del mondo a
permanere nella propria condizione.
Il superosservatore.
Ma il fondamento del meccanicismo riposa, oltre che sulla possibilità di
mantenere uno dall'altro distinti gli ingredienti del mondo, sulla
tacita inconfessata convinzione che lo scienziato, assimilabile in
qualche modo alla mente superiore cui fa cenno Laplace,
si collochi nella condizione di superosservatore, che, mentre osserva il
mondo, non lo contamina, né risulta contaminato nell'atto di
osservazione. Non che venissero negate le istanze della prospettiva
trascendentale kantiana, che qualche scienziato era anzi disponibile ad
accogliere; mancava invece ogni consapevole riflessione sulla presenza
empirica dell'osservatore nel mondo stesso che egli osserva. Dovremo
giungere ai primi decenni di questo secolo perché questi presupposti
della scienza vengano meno, attraverso la seconda rivoluzione scientifica.
Incrinature del meccanicismo.
Tuttavia già nell'800, proprio mentre il meccanicismo sembra
poter celebrare il suo trionfo, emergono a poco a poco fatti nuovi, che,
lavorando in profondità, erodono progressivamente le fondamenta
dell'edificio. Non si tratta tanto della novità dei contenuti (il
magnetismo, l'elettricità, la chimica), i quali anzi, almeno in parte,
contribuiscono a fornire nuovi argomenti alla tesi meccanicistica; si
tratta invece di novità nell'attenzione posta su fenomeni ben conosciuti,
ma fino ad allora trascurati, novità nei metodi di indagine, novità,
infine, nei modelli interpretativi. In particolare nell'ambito della
biologia si va affermando progressivamente una prospettiva storica, che,
almeno in linea di principio, si oppone alla reversibilità. Nello studio
dei fenomeni fisici va acquistando rilievo l'analisi della probabilità,
che assumerà un ruolo fondamentale nella meccanica statistica. Infine
nell'elettromagnetismo fa la sua prima comparsa il modello del campo, una
nuova chiave di lettura dei fenomeni fisici, che si porrà in concorrenza
con il modello newtoniano dell'azione a distanza. Sono temi che già
precorrono la seconda rivoluzione scientifica.
2. Ricerca di un nuovo rigore formale nelle matematiche.
Entro il panorama scientifico dell'800 la matematica tende
progressivamente a configurarsi come scienza rigorosamente formale, che
ricerca entro se stessa il proprio fondamento, svincolandosi da ogni
riferimento intuitivo e acquisendo con ciò una libertà di cui fino allora
non aveva mai goduto.
Esigenza di rigore.
Il problema non è più quello di tradurre in termini matematici i contenuti
delle intuizioni sensibili, di utilizzare il numero per contare, la
geometria per descrivere lo spazio della nostra comune esperienza, o
l'analisi per lo studio della variazione delle grandezze fisiche
continue; si tratta di volgere l'attenzione in maniera esclusiva
all'aspetto formale della scienza, costruendo e definendo i suoi
enti, a prescindere da ogni loro riferimento empirico. Così, ad esempio,
i numeri complessi acquistano ormai pieno diritto di cittadinanza anche se
la fisica non ha ancora individuato una loro possibile utilizzazione, e le
radici di un'equazione, reali o immaginarie, meritano attenzione
indipendentemente dall'interpretazine che possiamo fornirne; così ancora
la geometria può scandagliare le possibilità di spazi non euclidei,
svincolandosi da ogni ipotesi intorno alla natura dello spazio reale. La
matematica tende pertanto a divenire, in un'ottica squisitamente
leibniziana, la scienza di ciò che è logicamente possibile, ponendosi con
ciò nella condizione non solo di cogliere le strutture formali delle
nostre esperienze attuali, ma di approntare altresì strumenti idonei ad
analizzare altre possibili esperienze affatto nuove. In effetti, attraverso
questa investigazione sulle pure possibilità logiche, la matematica
dell'800 ha anticipato modelli e strumenti che la fisica ha utilizzato solo
molto più tardi.
La ricerca di un rigore concettuale tende a separare le diverse branche
della disciplina e a conferire a ciascuna una propria indipendenza. Si
assiste, pertanto, in analogia a ciò che avviene contemporaneamente
nell'ambito della fisica, al costituirsi di settori autonomi di indagine.
Tuttavia la ricerca di un maggior rigore favorisce, nello stesso tempo, il
conseguimento di un più alto livello di astrazione, che è la base di un
nuovo processo di unificazione, attuato non più a livello di contenuti
intuitivi, ma di strutture formali sempre più generali. Le geometrie non
euclidee, la geometria proiettiva, le funzioni complesse, la chiarificazione
del concetto di limite, la teoria dei gruppi, l'algebra astratta, l'algebra
della logica sono alcuni dei frutti più significativi del mutato
atteggiamento.
Le geometrie non-euclidee.
Sulla fondazione delle geometrie non-euclidee giova soffermarsi più
diffusamente non solo in considerazione dell'influenza che tale scoperta
ha avuto nell'ambito della matematica e della fisica, ma anche per le sue
ripercussioni sulla filosofia.
La geometria era apparsa per secoli l'unica scienza puramente razionale,
che avesse per oggetto una realtà fisica, lo spazio. L'interpretazione
kantiana dello spazio, come forma trascendentale della sensibilità
esterna, sembrava aver finalmente fornito il fondamento epistemologico
della sua validità. Ma il dubbio che potesse essere pensata una geometria
differente e che pertanto fosse casuale, e comunque da verificarsi, la
concordanza dello spazio reale con la geometria euclidea cominciava a
farsi strada. Ed il dubbio sorse intorno ad un postulato che fin
dall'antichità aveva lasciato perplessi i matematici. Si tratta del quinto
postulato, che oggi viene solitamente espresso nella formulazione
risalente a Proclo: per un punto esterno ad un retta è sempre possibile
tracciare una e una sola parallela alla retta data. Le perplessità
nascevano soprattutto dal fatto che il postulato non appariva così
immediatamente evidente come gli altri. Di qui i tentativi di ridurlo al
rango di semplice teorema, deducibile dagli altri postulati. Ogni
tentativo di fornire una dimostrazione era nondimeno destinato al
fallimento, perché il postulato è effettivamente indipendente dagli
altri quattro. Le incertezze e i dubbi furono risolti solo nei primi
decenni del 19esimo secolo da tre matematici: dal tedesco Karl Friedrich
Gauss (1777-1855), dal russo Nicolaj Ivanovic Lobacevskij (1793-1856) e
dall'ungherese Janos Bolyai (1802-1860). Costoro, procedendo ciascuno per
proprio conto, colta l'autonomia del quinto postulato rispetto agli altri
quattro e sostituitolo pertanto con un altro, secondo cui è possibile per
un punto esterno ad una retta tracciare infinite parallele ad essa,
fondarono una nuova geometria, che verrà detta iperbolica. Nella seconda
metà del secolo Bernard Riemann (capitolo 20, paragrafo 2), assumendo
invece uno spazio in cui non si diano parallele, fonderà le geometria
ellittica.
Geometrie non-euclidee ed intuizione.
Va avvertito che non è possibile comprendere intuitivamente con
chiarezza la geometria non euclidea, nondimeno è possibile
farsene una vaga idea. Se prendiamo un disco di metallo e lo
scaldiamo nella sua zona centrale, quest'ultima si dilata e il disco si
trasforma in una calotta, nella quale il rapporto tra la circonferenza
ed il raggio (incurvato) sarà minore di 2pi greco. Se invece
riscaldiamo la parte periferica, la circonferenza si allungherà
provocando un'ondulazione del contorno ed il rapporto tra la
circonferenza ed il raggio diverrà maggiore di 2pi greco. Ebbene, se
immaginiamo uno spazio, per così dire, più angusto, in cui la calotta
possa essere piana abbiamo uno spazio ellittico; se immaginiamo uno
spazio più capiente, in cui possa in un certo modo spianarsi il disco
dal bordo ondulato, avremo uno spazio iperbolico. Nel primo non esistono
rette parallele, di angoli interni del triangolo misurano più di 180 gradi,
il rapporto tra la circonferenza e il raggio è minore di 2pi greco; nel
secondo per un punto esterno ad una retta passano infinite parallele alla
retta data, gli angoli interni di un triangolo misurano meno di 180 gradi
e il rapporto tra la circonferenza ed il raggio e maggiore di 2pi greco.
3. La chimica e l'ipotesi atomica.
Mentre la matematica, nella sua ricerca di rigore, si sviluppava come
una scienza eminentemente formale, che approntava strumenti idonei
all'analisi dei fenomeni fisici, le scienze sperimentali venivano
indagando il mondo della natura nell'intento di dar concretezza
all'astratto modello meccanicistico. Nei primi decenni dell'800, in virtù
di più accurate indagini sperimentali, la materia perde progressivamente
la sua vaghezza metafisica e si avanzano le prime ipotesi scientifiche
sulla sua struttura, fondate su basi ben più solide delle precedenti
teorie filosofiche.
L'ipotesi atomica.
Nel 1807 l'inglese Humphry Davy (1778-1829) mediante l'elettrolisi operava
la decomposizione dell'acqua determinando con sufficiente approssimazione
i rapporti in volume dell'idrogeno e dell'ossigeno. Poco dopo il chimico
francese Joseph-Louis Proust (1754-1825) formulava la legge delle
proporzioni definite e l'inglese John Dalton (1766-1844) quella delle
proporzioni multiple. L'esistenza di rapporti definiti tra gli elementi
che entrano in composizione chimica conferiva plausibilità all'ipotesi
atomica, che di fatto fu avanzata da Dalton nel 1808 e confermata dalle
ricerche del francese Joseph-Louis Gay-Lussac (1778-1850), non senza
opposizioni da parte della comunità scientifica. è all'italiano Amedeo
Avogadro (1776-1856) che si deve la prima formulazione rigorosa
dell'ipotesi atomico-molecolare. Comunque il modello, nonostante la sua
portata chiarificatrice, sarà a lungo osteggiato, perché non sembrava
suffragato da adeguate prove sperimentali e arriverà ad affermarsi solo
nella seconda metà del secolo, anche in virtù del successo della teoria
cinetica del calore.
Affinità chimica e forze elettriche.
L'ipotesi atomico-molecolare richiedeva un chiarimento intorno alla natura
della forza responsabile dei legami chimici, risultando del tutto
insoddisfacente l'appello al vecchio principio di affinità. Il
funzionamento della pila di Volta e il fenomeno dell'elettrolisi
facevano ovviamente sospettare una certa relazione tra l'elettricità e i
fenomeni chimici. Fu il fisico svedese Jacob Berzelius (1779-1848) ad
avanzare l'ipotesi, esatta nella sua generalità, che i legami chimici
fossero dovuti alla forza di attrazione tra cariche elettriche,
immaginando, erroneamente, che alcuni atomi fossero carichi di
elettricità positiva ed altri di elettricità negativa.
4. La teoria ondulatoria della luce e l'elettromagnetismo.
Le indagini sperimentali sulla struttura della materia costituivano una
valida conferma della teoria corpuscolare e della separazione netta di
spazio e materia; ma gli studi sulla luce e sui fenomeni elettromagnetici
infersero un duri colpi al modello newtoniano.
Teoria ondulatoria della luce.
Agli inizi del 19esimo secolo la teoria ondulatoria della luce, già proposta
da Huygens nel '600, ma soppiantata presto dalla teoria corpuscolare,
venne ripresa dall'inglese Thomas Young (1773-1829), che nel 1803 realizzò
alcuni esperimenti volti ad evidenziare fenomeni di interferenza
luminosa, analoga all'interferenza sonora, spiegabile appunto facendo
ricorso all'ipotesi ondulatoria. Le ricerche di Young trovarono conferma
negli studi di Augstine Fresnel (1788-1827), Hippolyte Fizeau (1819-1896)
e Michel Foucault(1819-1868).Ma il modello ondulatorio implicava, in
analogia a quanto avviene per il suono, un mezzo di propagazione
identificato con un ipotetico etere, una sostanza imponderabile che
dovrebbe pervadere tutto lo spazio, compreso l'interno dei corpi.
Condizione di grave imbarazzo, non solo perché chiamava in causa una
forma di materia sui generis, probabilmente continua, ma anche perché
l'etere appariva quasi un duplicato dello spazio, fornito, tuttavia, a
differenza dello spazio newtoniano, di una capacità di interagire con la
materia; ne scaturivano complessi problemi che saranno chiariti soltanto
dalla teoria della relatività.
Elettricità e magnetismo.
Frattanto si andavano approfondendo gli studi sull'elettricità e il
magnetismo, che, sviluppandosi dapprima parallelamente alla teoria
ondulatoria della luce, si fonderanno con essa nella seconda metà del
secolo ad opera di Maxwell. Ciò che in questa storia si rileva di più
significativo è il progressivo e contrastato emergere del modello
interpretativo del campo, che verrà a sostituire gradualmente il modello
dell'azione a distanza. Di carattere schiettamente newtoniano è la prima
legge dell'elettromagnetismo, già formulata da Charles-Augustin de
Coulomb, secondo la quale due cariche elettriche interagiscono con una
forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle cariche e
inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Ma già nel 1820
il fisico Hans Christian Oersted (1777-1851), nell'interpretare i
risultati di alcuni suoi esperimenti, abbandona il modello newtoniano.
Egli, osservando la deviazione dell'ago magnetizzato collocato in
prossimità di un filo elettrico percorso da corrente, era giunto a
confermare quello che era già stato un sospetto di Franklin e un'ipotesi
filosofica di Schelling: che vi fosse una relazione tra elettricità e
magnetismo. Oersted spiegava il fenomeno ipotizzando la presenza di un
conflitto di forze elettriche che si diffonde nello spazio circostante e
coinvolge le particelle magnetiche. Lo spazio non è per lui l'inerte
contenitore newtoniano, ma è divenuto una realtà fisica animata da forze
che fanno di essa quasi un'entità organica.
Partendo dai risultati di Oersted, il fisico francese André-Marie Ampère
(1775-1836) confermò la stretta connessione tra magnetismo ed
elettricità, interpretando il magnete come un corpo percorso da correnti
elettriche. Ma nell'interpretazione del fenomeno egli torna a proporre
una prospettiva schiettamente newtoniana: "Guidato dai princìpi della
filosofia newtoniana, scriveva nel 1827, io ho invece ricondotto il
fenomeno studiato da Oersted... a forze agenti sempre secondo la retta
che congiunge le due particelle fra le quali queste si esercitano".
L'interpretazione di Ampère continua ad essere dominante tra i fisici
nella prima metà del secolo.
Teoria intuitiva del campo.
L'eccezione più significativa è rappresentata dall'inglese Michael Faraday
(1791-1867). Nella sua opera la molteplicità delle esperienze
elettromagnetiche cerca chiarificazione nel modello del campo, che,
respingendo il principio newtoniano dell'azione a distanza, apre la
strada all'opera di Maxwell. Lo spazio, nella sua visione dinamicistica,
è percorso da una molteplicità di linee di forza "visualizzabili usando
della limatura di ferro sparsa in prossimità di un magnete". Tali linee
di forza sono sede di vibrazioni, origine dei fenomeni di radiazione.
Infine gli atomi sarebbero in realtà secondo Faraday "puri centri di
forza o poteri, non particelle di materia". è una fisica del continuo,
ove si pongono le basi, non solo per la fondazione rigorosa della teoria
del campo, che sarà opera di Maxwell, ma anche per il superamento del
dualismo materia-energia, che troverà conferma nella relatività ristretta.
5. Termodinamica e meccanica statistica. La freccia del tempo.
La freccia discendente del tempo.
Se la teoria ondulatoria e l'elettromagnetismo incrinano la concezione
meccanicistica dello spazio e rendono problematica la distinzione tra
spazio, materia ed energia, la termodinamica, mentre per un verso
rafforza la teoria corpuscolare e la separazione tra spazio e materia,
per altro verso scalfisce l'indifferenza del tempo di fronte agli eventi,
mostrando come questi ultimi si dipanino in una storia irreversibile, al
termine della quale tutto sarà irrimediabilmente compiuto; una storia le
cui vicende possono essere in qualche modo anticipate, non già sulla
base di previsioni deterministiche, ma in virtù di semplici considerazioni
probabilistiche.
Lo studio del calore non aveva fatto apprezzabili progressi nei secoli
precedenti. Due modelli interpretativi si contrapponevano nel tentativo
di fornire spiegazione della sua natura: secondo un primo modello, di
ascendenza galileiana, il calore era interpretato come un moto di
particelle; un secondo modello ne riconduceva l'origine ad un fluido
imponderabile, il calorico, ed era ancora accolto tra gli altri da
Laplace e da Carnot. Ma agli inizi dell'800 la teoria scientifica
ricevette grande impulso dalla riflessione sui problemi tecnologici
connessi con il funzionamento delle macchine termiche, che, dopo i
perfezionamenti apportati da James Watt, andavano rapidamente diffondendosi.
Il secondo principio della termodinamica.
Ed appunto una riflessione sui princìpi di funzionamento
di tali macchine è il breve ma fondamentale lavoro pubblicato nel 1824
dall'ingegnere francese Sadi Carnot (1796-1832), Rif!essioni sulla
forza motrice del fuoco e sulle macchine adatte a sviluppare questa forza,
ove trova una prima formulazione il secondo principio della termodinamica,
in base al quale non è possibile estrarre lavoro dal calore ove non si
disponga di due sorgenti a temperatura differente e il lavoro estratto è
proporzionale al dislivello termico fra le sorgenti stesse.
Il primo principio della termodinamica.
Successivo di una trentina di anni è il primo principio della
termodinamica, che nella sua genesi si ricollega storicamente al
dinamismo settecentesco, di ascendenza leibniziana. Per Cartesio, padre
del moderno meccanicismo filosofico, ciò che si conserva eternamente è
la materia e, subordinatamente, la quantità di moto, che è un
particolare stato della materia. Per Leibniz invece è la forza viva
(l'energia cinetica) a costituire la sostanza del mondo. Il pensiero di
Schelling e la filosofia della natura germanica mutuano dalla tradizione
settecentesca la concezione leibniziana e la rielaborano arricchendola
sulla base delle nuove scoperte scientifiche; la realtà non può
risolversi in materia e moto inerziale, essa è costituita invece da un
flusso continuo di molteplici forze, dominate dal principio della
polarità, che si trasformano l'una nell'altra e attraverso i loro effetti
producono ciò che percepiamo come materia. A questo dinamismo, di cui
abbiamo colto già l'influenza nell'opera, Oersted si ispirò al
tedesco Julius R. von Mayer (1814-1878) nei suoi studi volti ad
evidenziare la conservazione e la trasformazione delle forze e a
puntualizzare quell'equivalenza tra calore e lavoro, che costituisce
appunto il secondo principio della termodinamica.
Frattanto l'interpretazione cinetica dei fenomeni termodinamici
cominciava a farsi strada e conquistava l'adesione di un numero crescente
di fisici. La tesi di Mayer, spogliata delle sue implicazioni
filosofiche e ricondotta al modello molecolare cinetico, fu confermata
dalle numerose ricerche sperimentali del fisico inglese
James Joule (1818-1889), che determinò l'equivalente meccanico del
calore e studiò gli effetti termici del passaggio della corrente
elettrica in un conduttore; esperienze che dimostravano sperimentalmente
la conversione e l'equivalenza tra tipi diversi di energia. La teoria
generale alla quale queste scoperte avviavano fu formulata dal tedesco
Hermann Helmholtz (1821-1894). In una memoria Sulla conservazione della
forza del 1847 egli enunciava il principio della conservazione dell'energia.
Giungeva così a conclusione verso la meta dell'800 il secolare dibattito
sul principio leibniziano dell'indistruttibilità della forza viva, che
trovava finalmente conferma scientifica.
Il principio della conservazione dell'energia avrebbe potuto richiamare
in vita il miraggio del moto perpetuo, ma gli scienziati sapevano,
sebbene la cosa non fosse del tutto chiara, che un'energia
indistruttibile non significa un'energia perennemente disponibile.
L'attenzione si volgeva pertanto all'analisi di quei processi spontanei di
trasformazione in cui l'energia meccanica si converte in energia termica,
la quale, pur conservandosi, si degrada a sua volta verso una condizione
di equilibrio che la sottrae ad ogni tentativo di utilizzazione. Gli
studi e le ricerche di Mayer, Joule e Helmoltz avevano confermato l'antica
ipotesi di Leibniz, secondo la quale negli attriti e negli urti
anelastici l'energia cinetica si trasferisce alle particelle di cui i
corpi sono costituiti; ma la novità era che questo trasferimento, che
avviene spontaneamente dal livello macroscopico a quello microscopico,
non si attua spontaneamente nel verso opposto.
L'irreversibilità.
Sulla base di tali considerazioni Lord Kelvin (William Thomson, 1824-1907)
evidenziava l'esistenza di una tendenza universale della natura verso la
degradazione e la dissipazione dell'energia, e Rudolf Clausius (1822-1888)
individuava nell'entropia (una funzione di stato data dal rapporto tra
quantità di calore e temperatura) una grandezza capace di misurare il
progressivo inarrestabile incremento di disordine, di mescolanza,
di omogeneità in un sistema termodinamico. Si tratta di studi, ricerche
e meditazioni, che portavano a riflettere con più attenzione su ciò che
l'uomo della strada sa già da sempre, cioè che il tempo trascorre e che,
a dispetto della meccanica, non è possibile tornare indietro.
Leggi probabilistiche.
La teoria che fornì piena spiegazione della totalità dei processi
dissipativi e della spontanea tendenza dei sistemi fisici a portarsi
nelle condizioni di equilibrio termodinamico fu la meccanica statistica,
elaborata dallo scozzese James Clerck Maxwell (1831-1879) e dall'austriaco
Ludwig Boltzmann (1844-1906). La nuova disciplina offriva gli strumenti
per trattare statisticamente i moti disordinati delle molecole, per i
quali è impensabile un'analisi individuale, e conferiva un rilievo
particolare alla probabilità nello studio dei fenomeni fisici. In
termini probabilistici, sulla base di un modello puramente meccanico,
riusciva a chiarire la misteriosa tendenza della natura verso la
dissipazione, già additata da Lord Kelvin.
In questa nuova disciplina i moti molecolari sono moti meccanici e
pertanto pienamente reversibili; potremmo dire anzi che rappresentano
l'ambito in cui il modello meccanico funziona meglio. Eppure questa
reversibilità a livello molecolare si trasforma di fatto in
irreversibilità a livello macroscopico, non per una qualche misteriosa
legge fisica che richieda un ulteriore supporto sperimentale, ma per una
legge probabilistica di natura matematica, la stessa legge che ci dice
quanto sia improbabile un terno secco.
Ogni sistema fisico isolato tende spontaneamente ad evolvere da una
condizione di ordine ad una condizione di disordine, da una
configurazione improbabile verso una configurazione più probabile, e il
grado di probabilità o di disordine di un sistema fisico, cioè la sua
entropia, costituisce in un certo senso la misura del tempo trascorso,
la traccia lasciata dietro di sé dal tempo. Sul piano cosmologico se ne
può trarre una conclusione sconcertante: l'universo, se può essere
considerato un sistema chiuso, è volto inesorabilmente verso una
progressiva morte termica, secondo una visione prospettata, tra gli
altri, da Clausius, Kelvin e Helmholtz e fatta propria dalla cultura del
tempo.
L'universo ha una storia.
Così la meccanica statistica, se per un verso riusciva momentaneamente a
respingere le istanze del dinamicismo schellinghiano, per
altro verso era costretta a far posto, sia pure controvoglia,
alla simmetria del tempo: il futuro sarà diverso rispetto al passato.
L'universo viene ad assumere, dunque, una storia, che si dipana tra un
inizio, ancora difficilmente immaginabile, cui si sarebbe dovuto
attribuire un grado minimo di entropia, ed una fine, caatterizzata da un
totale livellamento termico, entro il quale non è più ipotizzabile
alcuna forma di organizzazione. Questa morte termica dell'universo non
piaceva ovviamente ad un'età dominata dall'ideologia del progresso e
furono fatti da più parti tentativi per esorcizzare il fantasma di
questo ultimo destino ineluttabile. Ma nessuna delle alternative
proposte apparve convincente. D'altronde sulla fine del secolo, trascorso
ormai il tempo dell'ottimismo positivistico, la morte dell'universo finì
col trovarsi in sintonia con talune visioni tragiche dell'esistenza o con
la riscoperta della trascendenza.
6. Evoluzionismo e riduzionismo biologico.
La freccia ascendente del tempo.
La simmetria del tempo, evidenziata dalla termodinamica, emerge anche
nelle teorie evoluzionistiche, che, sviluppando un tema già
affiorato nell'Illuminismo, sono guidate dalla convinzione che
la vita sulla Terra abbia una storia. Il tempo lascia invariabilmente
una traccia, sebbene la traccia termodinamica e quella evolutiva siano
di segno opposto, poiché una evidenzia il progressivo incedere del
disordine, l'altra il lento affermarsi di un'organizzazione.
Il primo tentativo di delineare sistematicamente il processo evolutivo
della vita si deve a Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1822). Nella sua
Filosofia zoologica (1809) e nella Storia naturale degli animali
invertebrati (1815-1822) Lamarck enunciava la sua concezione
evoluzionistica fondata sull'ipotesi di una originaria tendenza della
vita ad espandersi e ad organizzarsi in forme via via più complesse,
attraverso un processo ramificato, guidato finalisticamente dall'esigenza
di adattamento ai diversi tipi di ambiente. Ma le tesi del trasformismo
biologico furono osteggiate autorevolmente da Georges Cuvier (1769-1832),
sostenitore del fissismo, sulla base di argomentazioni assai più
circostanziate delle vaghe intuizioni di Lamarck e dei suoi seguaci; e
nello scontro rimasero sconfitte. Solo nella seconda metà del secolo
l'evoluzionismo riprenderà vigore, su basi teoriche profondamente
diverse, per opera di Charles Darwin.
Il riduzionismo biologico.
Frattanto le scienze biologiche assumevano in prevalenza il modello
riduzionistico e meccanicistico, guidate dalla speranza di poter
trovare la spiegazione della vita in semplici processi di natura
chimico-fisica. I primi buoni auspici alla realizzazione del programma
furono forniti dai progressi della chimica organica. Le sostanze
organiche erano apparse in un primo tempo di natura affatto
differente da quelle inorganiche e la loro formazione veniva
attribuita ad un'ipotetica forza vitale. Tuttavia si scoprì ben
presto, attraverso i numerosi esperimenti di Michel Cheuvrel
e Jean-Baptiste Dumas (1800-1884), la possibilità di trasformarle mediante
reazioni chimiche; finalmente il tedesco Friedrich Woehler (1800-1882)
riuscì ad ottenere per via sintetica nel 1828 la prima sostanza
organica, l'urea. Ulteriori e importanti sviluppi della chimica organica
si ebbero ad opera del grande chimico francese Pierre-Marcelin
Berthelot (1827-1907) . Appariva ormai superfuo l'appello ad un'ipotetica
forza vitale per spiegare la formazione delle sostanze organiche.
Anche nell'ambito della fisiologia il determinismo riduzionistico andava
progressivamente conquistando terreno ai danni del vitalismo. I suoi
successi furono conseguiti soprattutto nell'individuazione delle funzioni
dei diversi organi e nella spiegazione delle funzioni stesse in termini
meccanici e chimici, con l'eliminazione di ogni ricorso alla forza
vitale. In questo ambito risultò di fondamentale importanza l'opera del
francese Claude Bernard (1813-1878), fondatore della fisiologia moderna e
della moderna farmacologia, sostenitore, nella sua Introduzione alla
medicina sperimentale, di un rigoroso determinismo biologico.
Malgrado queste significative conquiste nellambito della chimica
organica e della fisiologia, l'origine della vita e, più specificamente,
della cellula rimase per il riduzionismo un problema insolubile, sebbene
in un primo tempo il successo sembrasse arridere alle ricerche dei
tedeschi Matthias Schleiden (1804-1881) e Theodor Schwann (1810-1882),
che, nell'approfondire lo studio delle cellule animali e vegetali,
avanzarono l'ipotesi che esse si venissero formando attraverso un
processo chimico-fisico, analogo a quello della cristallizzazione.
Ricerche successive mostrarono invece l'infondatezza dell'ipotesi e
condussero il fisiologo tedesco Rudolf Virchow (1821-1902) ad affermare il
principio secondo il quale ogni cellula deriva da una cellula.
Frattanto importanti sviluppi si attuavano anche nell'ambito della
micrologia, soprattutto ad opera di Louis Pasteur (1822-1895), cui si
devono ricerche fondamentali sui fenomeni di fermentazione e di
putrefazione, che chiarivano il processo di circolazione della vita
dall'organico all'inorganico e viceversa ed evidenziavano tra i due
regni quella saldatura che non si era potuta cogliere affrontando il
problema dell'origine della vita stessa. Il riduzionismo poteva ripagarsi
in parte con questa vittoria dell'altra ben più grave sconfitta.
7. Il meccanicismo ideologico e l'idea del progresso.
Il meccanicismo ideologico.
Il meccanicismo che, pur con numerose eccezioni e incrinature costituisce
in sostanza lo sfondo della scienza già dalla prima metà del secolo, si
afferma in modo pressoché incontrastato nei decenni successivi, e, sebbene
per gli scienziati esso fosse soprattutto un modello interpretativo valido
in virtù dei numerosi successi conseguiti, al di fuori dei confini della
scienza si va decisamente configurando in una visione del mondo e in
un'ideologia, in cui si esprime lo spirito di una borghesia attiva,
intraprendente, fiduciosa nel progresso, entusiasta della scienza che
tanto ha contribuito al suo successo.
Questo meccanicismo alquanto deformato, in cui risultano accentuati
soprattutto il riduzionismo e il materialismo antimetafisico a danno
dello strumento matematico che dovrebbe garantire la prevedibilità dei
fenomeni, si è fatto ormai più ambizioso e, nella convinzione che nessun
aspetto della realtà possa ormai sfuggire alla scienza, presume di
sottoporre ad indagine scientifica gli stessi prodotti della civiltà
umana, trattati alla stregua di fenomeni chimici. " Il vizio e la virtù
sono prodotti come il vetriolo e lo zucchero" scriveva Hippolyte Taine,
e Karl Vogt: "Il pensiero sta al cervello nella stessa relazione in cui
la bile sta al fegato e l'urina ai reni". è una mentalità che si afferma
senza contrasto in Francia, innestandosi alla tradizione illuministica,
si diffonde anche in Italia, favorita dall'anticlericalismo della nostra
classe politica, dà luogo invece in Germania ad una virulenta polemica,
condotta contro la stanca tradizione culturale delle università tedesche,
pervasa di residui idealistici, di ortodossia religiosa e di un vago
spiritualismo. La cultura inglese frattanto ancora fedele alla propria
tradizione empiristica, si dimostra più cauta ad accogliere la nuova fede.
L'idea del progresso.
Al materialismo meccanicistico si venne saldando, con un'incoerenza
filosoficamente inaccettabile ma culturalmente feconda, l'idea di
progresso, sintesi di più temi differenti, che si erano venuti
sedimentando nella cultura a partire dal basso Medioevo. Già nella
scuola di Chartres il progresso era inteso come frutto dell'accumularsi
attraverso la storia di una quantità crescente di conoscenze, che
pongono l'uomo nella condizione di poter comprendere sempre meglio la
realtà. Quando il sapere venne acquistando, con la rivoluzione
scientifica, un carattere operativo e tecnologico, l'accumularsi delle
conoscenze significò acquisizione di una capacità crescente di dominio
sulla natura a vantaggio dell'uomo. Lo sviluppo delle scienze economiche,
giuridiche, politiche conferì infine all'Illuminismo la fiducia che la
stessa società umana potesse progredire nella razionalità della sua
organizzazione.
Fino a questo punto il progresso è soprattutto un processo di
accumulazione. è dell'800, invece, sebbene sia possibile additare qualche
anticipazione nei secoli precedenti, l'idea di un progresso inteso come
processo evolutivo. Ad essa contribuì certamente, per strade indirette,
la concezione idealistica, che identifica la realtà con il farsi dello
spirito. Più diretto, invece, risultò l'influsso dell'evoluzionismo
biologico, i cui princìpi vennero estesi, non solo, come è ovvio,
all'uomo, ma anche alla società stessa considerata come un organismo e
persino, talora, all'universo intiero.
Indicazioni bibliografiche
Storia delle scienze (a cura di N. Abbagnano), UTET, Torino 1965.
M.B. Hesse, Forze e campi. Il concetto di azione a distanza nella
storia della fisica, Feltrinelli, Milano, 1974.
M. Jammer, Storia del concetto di forza, Feltrinelli, Milano, 1976.
J.I. Soloviev, L'evoluzione del pensiero chimico dal '600 ai nostri
giorni, Momndadori, Milano, 1976.
Storia del pensiero filosofico e scientifico (a cura di L. Gerymonat),
Garzanti, Milano, 1976.
Storia della Scienza (a cura di M. Daumas), Laterza, Roma-Bari, 1976.
E. Bellone, Le leggi della termodinamica da Boyle a Boltzmann,
Loescher, Torino, 1978.
A. La Vergata, L'evoluzione biologica da Linneo a Darwin, Loescher,
Torino, 1979.
P. Parrini, Geometria e Fisica dall'Ottocento a oggi, Loescher, Torino, 1979.
C.B. Boyer, Storia della matematica, Mondadori, Milano, 1980.
P. Campogalliani, Prima di Einstein. Quiete, moto e relatività, La Scuola,
Brescia, 1983.
Autori Vari, Storia della scienza moderna e contemporanea (a cura di
P. Rossi), UTET, Torino, 1988.
STORIA DELLA FILOSOFIA
di Nicola Abbagnano
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
Parte sesta Capitolo 13: IL POSITIVISMO SOCIALE
1. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo.
Il Positivismo è un movimento filosofico e culturale, caratterizzato da
una esaltazione della scienza, che nasce in Francia nella prima metà
dell'Ottocento e che si impone, a livello europeo e mondiale, nella
seconda parte del secolo.
Significati del termine "positivo".
Il termine "positivo", da cui deriva il nome di questa corrente, viene
assunto, dai filosofi positivisti, in due significati fondamentali:
1) "positivo" è innanzitutto ciò che è reale, effettivo, sperimentale,
in opposizione a ciò che è astratto, chimerico, metafisico;
2) "positivo" è anche ciò che appare fecondo, pratico, efficace, in
opposizione a ciò che è inutile ed ozioso.
Comparso per la prima volta nel Catechismo degli industriali (1822) di
Saint-Simon, il termine viene messo a punto da Comte, che lo
applica alla propria dottrina, consacrandone l'uso nella terminologia
filosofica europea (il Positivismo).
Tesi generali del Positivismo.
Pur comprendendo pensatori che si diversificano tra loro sia per
formazione intellettuale, sia per temi e soluzioni specifiche (per le
quali rimandiamo alle singole figure), il Positivismo appare
caratterizzato, sin dall'inizio, da una celebrazione della scienza, che
si concretizza in una serie di convinzioni di fondo:
1) La scienza è l'unica conoscenza possibile ed il metodo della scienza
è l'unico valido: pertanto il ricorso a cause o princìpi che non siano
accessibili al metodo della scienza non dà origine a conoscenza; e la
metafisica, che fa appunto tale ricorso, è priva di valore. Il grido
risuonato in Germania - "Keine Metaphisik mehr!": Niente più
metafisica! - rappresenta, di conseguenza, uno dei principali motti
polemici del Positivismo, che tuttavia, come vedremo, non sarà sempre
fedele ad esso.
2) Non avendo oggetti suoi propri, o campi privilegiati di indagine
sottratti alle scienze, la filosofia tende a coincidere con la totalità
del sapere positivo o, più specificamente, con l'enunciazione dei
princìpi comuni alle varie scienze. La funzione peculiare della
filosofia consiste quindi nel riunire e nel coordinare i risultati delle
singole scienze, in modo da realizzare una conoscenza unificata e
generalissima. In ogni caso, essa si costituisce come studio delle
"generalità scientifiche".
3) Il metodo della scienza, in quanto è l'unico valido, va esteso a tutti
i campi, compresi quelli che riguardano l'uomo e la società. Tant'è vero
che la sociologia diviene la creatura prediletta dei positivisti.
4) Il progresso della scienza rappresenta la base del progresso umano e
lo strumento per una riorganizzazione globale della vita in società,
capace di superare la "crisi" del mondo moderno o di accelerarne lo
sviluppo in modo sempre più rapido.
Quest'ultimo punto risulta basilare per comprendere la genesi stessa del
movimento. Infatti, come scrive Pietro Rossi, "Ciò che caratterizza il
positivismo ottocentesco è, in primo luogo, la consapevolezza di una
profonda crisi storica che ha investito la società europea e che comporta
una rottura irreparabile con il passato e le istituzioni tradizionali"
(P. Rossi, Positivismo e società industriale (antologia), Loescher, Torino
1973, pagina 9.)
Esistenza di una "prima" e di una "seconda" fase del Positivismo.
Parlando del Positivismo in generale, risulta tuttavia indispensabile
distinguere tra una "prima" ed una "seconda" fase di esso. Infatti, mentre
all'inizio, nell'età della Restaurazione e nella prima metà dell'Ottocento,
il Positivismo, con Comte, si pone soprattutto come proposta di superamento
di una "crisi" socio-politica e culturale (quella post-illuministica e
post-rivoluzionaria), nella seconda metà del secolo il Positivismo, più
che come soluzione di una "crisi", si presenta come riflesso e stimolo di
un "progresso" in atto. Inoltre, mentre il pensiero di Comte tenta di uscire
dalla crisi mediante un modello politico "organicistico" ed antiliberale, il
Positivismo posteriore, soprattutto in Inghilterra, identifica il progresso
con il trionfo del liberalismo. Per di più mentre nella prima metà del
secolo il Positivismo appare offuscato dalla preponderante influenza
romantico-idealistica, il Positivismo della seconda metà del secolo diviene
la filosofia "egemone" della cultura europea.
Basi storiche e culturali del "successo" del Positivismo.
Le basi storiche e culturali di questo "successo" del Positivismo sono
parecchie. Sul piano politico (cfr. il Corso di storia) abbiamo un quadro
europeo che, al di là dello scontro in Crimea (1854) e della guerra-lampo
tra Prussia e Francia (1870), appare sostanzialmente caratterizzato dalla
pace e dall'espansione coloniale in Africa ed in Asia. Dal punto di vista
economico abbiamo un ulteriore balzo in avanti del capitalismo industriale,
coincidente con una sua progressiva "iternazionalizzazione". In ambito
sociale troviamo un profondo mutamento delle strutture e dei modi
di vita delle città, che in pochi decenni sono investite da rivolgimenti
più radicali di quelli conosciuti in altrettanti secoli. Nel settore
scientifico abbiamo tutta una serie di importanti scoperte (vedi
capitolo 12), mentre sul piano tecnico le applicazioni del vapore e
dell'elettricità danno inizio ad un'èra nuova, rappresentata soprattutto
dalle ferrovie, divenute ben presto il principale "simbolo" della modernità
e delle sue vittorie sullo spazio e sul tempo. In ambito culturale, accanto
al tramonto dell'idealismo romantico e alla ricerca di un sapere "positivo"
più aderente alla realtà, si assiste ad una maggior diffusione del sapere,
di cui sono testimonianza la nascita delle collane "economiche" e delle
collane "popolari", soprattutto di letteratura e di scienza.
La fiducia entusiastica nell'uomo e nella scienza.
Il decollo del sistema industriale, della scienza, della tecnica, degli
scambi e dell'estensione della cultura su larga scala, determina, in questo
periodo, un "clima" generale di fiducia entusiastica nelle forze dell'uomo
e nelle potenzialità della scienza e della tecnica.
A titolo di "documento" umano o di esemplificazione-tipo dell'euforia di
un'intera età, si possono riportare i versi carducciani di Satana,
artisticamente modesti ma storicamente significativi, che celebrano le
"grandezze" della vaporiera:
Un bello e orribile
mostro si sferra
corre gli Oceani
corre la terra...
come di turbine
alito spande:
ei passa, o popoli,
Satana il grande.
Questo ottimismo, presente soprattutto nelle classi dirigenti e
capitalistiche, ma anche nelle classi popolari, che possono vivere in
condizioni più agiate, o meno grame, rispetto al passato, si traduce
in un vero e proprio culto per il pensiero scientifico e tecnico.
Per cui, se l'Umanesimo aveva celebrato, come ideale o tipo umano,
soprattutto il filologo, l'Illuminismo soprattutto il filosofo,
il Romanticismo soprattutto il poeta, il Positivismo esalta soprattutto
lo scienziato, di cui è incarnazione massima quel Newton della biologia
che è Darwin. E accanto allo scienziato glorifica il capitano d'industria,
l'ingegnere, il medico e anche il maestro, visto come diffusore di cultura
presso la povera gente. Tutte "figure" che dovevano diventare celebri
anche in virtù di note rappresentazioni letterarie, da Verne a De Amicis.
E di tutto ciò il Positivismo rappresenta la forma e la coscienza
filosofica.
Positivismo e società industriale.
Complessivamente riguardato, il Positivismo della seconda metà del
secolo appare quindi come la filosofia della moderna società industriale
e tecnico-scientifica e come l'espressione culturale delle speranze,
degli ideali e delle infatuazioni ottimistiche che hanno caratterizzato
tutto un tratto della storia moderna. Non per nulla esso si sviluppa
principalmente in quelle nazioni (come l'Inghilterra, la Francia e la
Germania) che appaiono all'avanguardia del progresso industriale e
tecnico-scientifico, mentre impiega tempo ad affermarsi nei paesi (come
ad esempio l'Italia) in ritardo rispetto ad esso. Dall'altro lato, il
Positivismo della seconda metà dell'Ottocento appare anche come l'ideologia
tipica della borghesia liberale dell'Occidente.
Positivismo e borghesia.
Infatti, come ha osservato Geymonat (L. Geymonat, Storia del pensiero
filosofico-scoientifico, citazione, pagina 453), sebbene non si possa
sostenere, in modo rigido, l'equazione Positivismo = borghesia, "riducendo"
tale complesso movimento di pensiero a determinate matrici sociali
(tanto più che esso, da parte della borghesia, ha trovato non solo
incoraggiamenti, ma anche opposizioni) è indubbio che il Positivismo, nel
suo complesso, esprima anche, e in modo accentuato, ideali e punti di vista
della borghesia, con la quale condivide la mentalità ottimistica circa la
moderna società industriale e la tendenza politica riformistica, nemica
del conservatorismo, ma anche ostile al rivoluzionarismo marxista, che
proprio in quegli anni andava elaborando una visione fortemente critica
dell'esistente, anzi una vera e propria fotografia in negativo dei
"costi umani" collegati alle strutture socio-economiche del capitalismo
industriale.
2. Positivismo e Illuminismo.
Per comprendere adeguatamente il Positivismo risulta indispensabile
coglierne le connessioni con l'Illuminismo da un lato e con il Romanticismo
dall'altro. Infatti, la rete di rapporti che collegano il Positivismo a
questi due fenomeni culturali è molto più stretta di quanto potrebbe
apparire ad un primo sguardo (e questo vale soprattutto, come vedremo,
per il Romanticismo). Che il Positivismo, tramite Comte, risulti
geneticamente congiunto all'Illuminismo è un fatto. Anzi, per
certi versi, il Positivismo si configura come una ripresa originale del
programma illuministico all'interno della nuova situazione storico-sociale
post-rivoluzionaria, caratterizzata dall'avvento del capitalismo
industriale e dallo sviluppo delle scienze e della tecnica.
Questa tesi presuppone quindi delle affinità e delle differenze nei
confronti dell'Illuminismo. Vediamo analiticamente quali sono, soffermandoci
soprattutto sulle diversità, che servono a delineare meglio la
specificità storica del movimento in esame.
Affinità fra Positivismo e Illuminismo.
Innanzitutto, Positivismo e Illuminismo presentano degli schemi generali
di pensiero verificabilmente simili:
a) la fiducia nella ragione e nel sapere, concepiti come strumenti di
progresso a servizio delluomo e della "pubblica felicità";
b) l'esaltazione della scienza a scapito della metafisica e di ogni sorta
di sapere non-verificabile;
c) la visione tendenzialmente laica ed immanentistica della vita.
Differenze storiche, politiche e teoriche fra Positivismo e Illuminismo.
Nello stesso tempo, positivisti e illuministi differiscono fra di loro
per taluni atteggiamenti di fondo:
1) Sebbene gli idoli polemici del Positivismo siano in parte identici a
quelli contro cui si era battuto l'Illuminismo (ad esempio la tradizione
metafisica e religiosa o il parassitismo di certa aristocrazia agraria,
considerata come "ostacolo" al progresso), il momento storico in cui
vivono i positivisti della seconda metà del secolo è notevolmente diverso.
Infatti, mentre gli illuministi hanno combattuto contro forze culturali e
sociali ancora dominanti, facendosi promotori oggettivi degli interessi
economico-politici di una borghesia in ascesa, i positivisti agiscono in una
mutata situazione intellettuale e sociale, che vede, da un lato, uno
sviluppo sempre più accentuato del pensiero scientifico e della mentalità
laica, e, dall'altro l'ormai consolidato potere della borghesia. Ciò spiega
la minor "carica" polemica - filosofica e politica - dei positivisti,
portati a considerare le vecchie forme culturali e sociali come semplici
realtà "anacronistiche", destinate ad essere spazzate via dal progresso
immancabile della storia. Inoltre, mentre l'Illuminismo si configurava come
un riformismo tendenzialmente gravido di rivoluzionarismo (tradotto in
atto dalla Rivoluzione francese), il Positivismo si presenta come un
riformismo consapevolmente anti-rivoluzionario, ossia come un
atteggiamento politico che, pur lottando contro la vecchia tradizione
politica e culturale, appare contrario alle nuove forze rivoluzionarie
rappresentate dal proletariato e dalle dottrine socialiste.
2) Illuminismo e Positivismo si diversificano anche per una dissimile
maniera di intendere il compito della filosofia nei confronti della scienza.
Infatti, mentre gli illuministi, preoccupati di legittimare il sapere
positivo, appaiono indirizzati, sulla scia degli empiristi, ad una
fondazione gnoseologica e critica della scienza (che culminerà, come
sappiamo, nel kantismo), i positivisti, dando per scontata la "validità"
in atto del pensiero scientifico, ritengono che il compito della filosofia
sia quello di ordinare il quadro complessivo delle scienze, o di proporre
una sintesi unificatrice e generalizzatrice dei loro risultati. Questo
spiega perché nel Positivismo ottocentesco il problema gnoseologico non
metta capo a impostazioni originali e si nutra per lo più di soluzioni
formulate in altri contesti; o perché in esso, di contro a certo
agnosticismo illuministico e kantiano si miri al traguardo di una
"visione scientifica del mondo", nella quale rivive spesso, soprattutto
nelle correnti materialistiche, il vecchio ideale metafisico di una
spiegazione complessiva della realta.
3) Illuminismo e Positivismo si differenziano anche per un diverso modo di
rapportarsi alla scienza stessa. Infatti, mentre negli illuministi
l'appello al sapere sperimentale funge prevalentemente da dissoluzione delle
antiche credenze della metafisica e della religione, nei positivisti il
richiamo alla scienza (v. Comte) si concretizza talora in una
riedificazione di certezze assolute, esplicitamente presentate come la
forma " moderna " e " positiva " delle antiche religioni e metafisiche.
Inoltre, mentre l'Illuminismo, erede della gnoseologia empiristico-lockiana
e della metodologia di Newton, appare lontano da una dogmatizzazione dei
poteri della scienza (che in Hume, tra laltro, vengono scetticamente
confutati e in Kant criticamente delimitati), il Positivismo si nutre
invece, soprattutto all'inizio, ma anche in seguito, di un'esplicita
assolutizzazione della scienza, che rappresenta l'analogo, in riferimento
al sapere positivo, dell'assolutizzazione romantica del sentimento e
dell'arte. Quest'ultimo punto, di basilare incidenza per la comprensione
dell'intero fenomeno positivistico, ci porta ad esaminare il rapporto
fra pensiero positivista e cultura romantica.
3. Positivismo e Romanticísmo.
Le "macroscopiche" differenze fra idealismo e Positivismo.
Idealismo romantico e positivismo sono, per molti aspetti, due filosofie
profondamente diverse, che presuppongono un dissimile retroterra
culturale, un dissimile contesto teorico-linguistico e dissimili
condizionamenti economici e sociali. L'uno nasce in Germania e si
sviluppa in relazione ai problemi suscitati dal pensiero kantiano.
L'altro nasce in Francia e si riconnette all'eredità illuministica.
L'uno parla in termini di filosofia speculativa, di Spirito e di dialettica;
l'altro in termini di scienza, di Umanità e di progresso. L'uno si afferma
in una società, come quella tedesca, dove non vi è stata la rivoluzione
borghese; l'altro muove i primi passi in una società, come quella
francese, che ha conosciuto uno dei più grandi rivolgimenti politici del
mondo moderno. L'uno è collegato al ceto medio di una società
sostanzialmente pre-industriale, l'altro esprime interessi e ideologie
della borghesia industriale e capitalistica. Ma tutte queste diversità,
ed altre che si potrebbero aggiungere, non escludono affatto l'esistenza
di forti analogie categoriali fra Romanticismo e Positivismo, e di
sotterranei o aperti influssi del primo sul secondo.
Le "sottili" analogie categoriali fra Romanticismo e Positivismo.
Infatti il Positivismo, colto nel suo nucleo storico-filosofico più
decisivo, si rivela sostanzialmente come "il romanticismo della
scienza", ossia come l'esaltazione o l'infinitizzazione del sapere
positivo, assunto ad unica verità e ad unica guida della vita umana, in
tutti i campi. Come i romantici e gli idealisti, presi dalla brama
dell'infinito, tendevano a caricare la poesia o la filosofia di
significati assoluti, così i positivisti, partecipi di un'analoga
mentalità, tendono ad attribuire alla scienza una portata assoluta e di
tipo religioso.
Talora si è creduto di mettere in forse questa tesi della
"romanticizzazione" positivistica della scienza appellandosi al caso di
Stuart Mill. Ora, a parte il fatto che non bastano uno o più autori per
smentire la mentalità prevalente all'interno di un certo movimento,
proprio il caso di Mill costituisce, in realtà, un'ulteriore, anche se
indiretta, verifica delle nostre tesi. Infatti se questo filosofo, pur
condividendo la comune infatuazione positivistica della scienza e del
progresso, appare lontano, in sede gnoseologico-epistemologica, da
tendenze assolutistiche, ciò è dovuto agli influssi empiristici ed
illuministici, i quali, mentre lo connettono alla più tipica tradizione
inglese, lo neutralizzano, al tempo stesso, nei confronti degli influssi
comtiani e romantico-idealistici, presenti invece in altri aspetti della
sua opera (ad esempio nella dottrina della storia come tradizione
ininterrotta e cumulativa). Ma se prescindiamo da casi specifici
(cfr. anche Carlo Cattaneo, paragrafo 11), che sono pur sempre l'eccezione
e non la regola, e prendiamo in considerazione la vasta letteratura
positivistica, da Comte ai materialisti tedeschi, possiamo verificare in
quale misura l'"atmosfera" culturale incarnata dal Positivismo sia stata
davvero quella di un "romanticismo della scienza", tanto più evidente
nei "minori" e negli epigoni, anche italiani, del movimento.
In ogni caso, idealismo romantico e positivismo (comtiano ed
evoluzionistico) risultano accomunati da taluni tratti formali di fondo.
Infatti, sebbene l'idealismo parli ad esempio di Spirito o di dialettica,
mentre il Positivismo di Umanità, di Natura o di evoluzione, entrambi
sono portati a concepire ciò che esiste mediante una medesima categoria
di base, che è quella della totalità processuale necessaria.
La comune idea di uno sviluppo necessario e ascendente della realtà.
Infatti, sia che prendano in considerazione la natura, oppure l'uomo e
la storia, gli idealisti e positivisti tendono a far uso delle nozioni
di sviluppo necessario e divenire ascendente, e ad interpretare il loro
oggetto di studio a guisa di un processo ascensionale e cumulativo, nel
quale ogni evento è il risultato di un progresso rispetto al passato e la
condizione di un miglioramento futuro.
Questo schema generale, che caratterizza buona parte delle filosofie
dell'Ottocento, è stato elaborato dapprima dall'idealismo, tramite la
nozione di "svolgimento necessario dello Spirito" (vedi soprattutto
Hegel). Contemporaneamente, o poco dopo, è stato usato da Comte come
chiave di lettura della storia, considerata come una serie di "epoche" o
di "stadi" attraverso cui passa necessariamente l'Umanità nel suo sviluppo
progressivo. In seguito, l'evoluzionismo lo ha esteso alla realtà intera,
facendone la piattaforma di una teoria complessiva delluniverso, valida
per la formazione dei cieli come per la dinamica delle civiltà.
Evidentemente, il fatto che l'idealismo abbia tentato di giustificare
quest'idea-madre della cultura ottocentesca mediante la nozione
"speculativa" di dialettica, il Positivismo per mezzo della nozione
"scientifica", ripensata filosoficamente, di evoluzione, non elimina la
verificabile somiglianza dei risultati. Al di là del loro linguaggio
tecnico e specifico, idealisti e positivisti tendono infatti a
considerare il finito come manifestazione di una realtà infinita (l'Io
di Fichte, l'Assoluto di Schelling, l'Idea di Hegel, l'Umanità di Comte,
l'Inconoscibile di Spencer, l'Indistinto di Ardigò, la Materia o la Forza
di Haeckel eccetera) e a concepire l'esistente, naturale e storico, sotto
forma di una successione unilineare di avvenimenti, ognuno dei quali
costituisce l'anello di una catena necessaria che appare in marcia verso
qualche risultato finale, che coincide di solito con una situazione
umanamente desiderabile (la libertà, una società scientificamente
organizzata, un'umanità altruistica eccetera).
Il comune atteggiamento giustificazionista ed ottimista nei confronti
del reale.
Tant'è vero che anziché presentarsi come teorico di un piano etico-politico
problematico, semplicemente proposto come ideale ai suoi simili (secondo
lo schema illuminista), il filosofo idealista o positivista tende a farsi
"profeta" di una situazione futura, inscritta nelle cose stesse e
garantita dal corso del mondo. Da ciò la celebrazione idealistica
dell'esistente ("tutto ciò che è reale è razionale") o il culto
positivista del dato ("il fatto è divino"), che porta questi filosofi ad
assumere un atteggiamento essenzialmente giusticazionista nei confronti
del reale, considerato non solo come una struttura necessaria, ma anche
come una totalità positiva, in rapporto alla quale il negativo risulta
semplicemente un " momento" del realizzarsi cosmico e storico del
positivo. Da ciò la comune polemica contro "l'individualismo"
illuministico e la tendenza a "risolvere" o ad "integrare" l'individuo in
totalità statali, sociali, storiche, biologiche e cosmiche in relazione
alle quali perdono di senso, o appaiono sublimate, quelle situazioni
esistenziali (angoscia, disperazione, morte eccetera) che per Kierkegaard
e l'esistenzialismo novecentesco costituiscono la trama irriducibile
dell'esistenza "singola".
Questo modo di rapportarsi alla realtà e alla storia, di cui studieremo
le manifestazioni concrete nei vari autori, si riassume quindi in una
mentalità ottimistica, la quale, come si è già detto (vedi capitolo 1,
paragrafo 14), rappresenta una delle caratteristiche di fondo dell'intera
cultura dell'Ottocento, che, al di là delle sue contrapposizioni di
superficie, rivela delle insospettate analogie di sostanza, rese possibili
e intelligibili da un comune orizzonte categoriale. In sintesi, pur
rappresentando un momento peculiare della cultura ottocentesca, il
Positivismo, se da un lato risulta geneticamente connesso all'Illuminismo,
dall'altro appare concettualmente impregnato di Romanticismo.
(Il concetto del Positivismo come "romanticismo della scienza
costituisce una delle proposte interpretative più originali della
storiografia di Abbagnano. Nel nostro paese questa tesi ha trovato un
certo consenso, ed è stata tenuta presente dalla maggior parte delle
storie della filosofia seguenti, anche se taluno ha manifestato tacite
riserve, mostrandosi preoccupato circa una possibile messa tra parentesi
dell'eredità illuministica o circa un possibile "appiattimento" delle due
correnti. In realtà, come abbiamo cercato di dimostrare, lo schema
interpretativo di Abbagnano non comporta né la negazione delle radici
illuministiche del Positivismo, né l'ovvia e " macroscopica " diversità
fra idealismo e Positivismo, poiché si limita a constatare, sul piano
storiografico, come questi due movimenti, pur nella loro specifica
fisionomia, si muovano in un orizzonte categoriale molto simile
(cfr. G. Fornero, Concetto e critica del Romanticismo ottocentesco nel
pensiero di Nicola Abbagnano, citazione).
4. L'importanza del Positivismo nella cultura moderna.
La rilevanza del Positivismo nell'ambito della cultura ottocentesca è
stata notevole. Infatti, per la sua capacità di porsi come interprete
dei dinamismi della società industriale moderna e dello sviluppo tecnico
scientifico, esso ha finito per divenire un'autentica " moda culturale "
e per rappresentare la forma mentis di tutta un'età. Di conseguenza, come
si è parlato di un'"epoca" o di una "civiltà" rinascimentale o
illuministica, così si può discorrere, a buon diritto, di un'epoca o di
una civiltà positivistica, il cui " spirito " si estende dalla
letteratura alla politica, dall'arte alla storiografia, dalla pedagogia
all'antropologia criminale.
Il Positivismo come "atmosfera".
Senza riferimento all'"atmosfera" positivistica non si comprenderebbero,
ad esempio, decisivi fenomeni letterari come il realismo ed il verismo
(che rappresentano la concretizzazione artistica del richiamo positivista
ai "fatti"), o non si intenderebbe il mutato modo di praticare la critica
storica e letteraria, o i nuovi indirizzi pedagogici e didattici,
incentrati sul programma di una scuola "laica" e di uno studio
"scientifico" dei problemi educativi.
La "reazione" antipositivista.
Nonostante questa profonda incidenza culturale, il Positivismo, con il
tempo, ha finito per sembrare, a molti filosofi, come un nuovo
dogmatismo avente la pretesa di racchiudere l'uomo negli schemi riduttivi
della scienza. Anzi, il Positivismo, nonostante la sua pretesa di
praticare la filosofia come sintesi unificatrice del sapere
sperimentale, è apparso come una nuova metafisica della scienza, non
certo più rigorosa di quella del passato. Tutto ciò spiega la massiccia
"reazione antipositivistica", che ha caratterizzato la filosofia degli
ultimi decenni dell'Ottocento e degli inizi del Novecento. Controffensiva
cui ha contribuito l'espansione stessa delle scienze, che si sono
sviluppate in direzioni contrastanti con il quadro gnoseologico ed
epistemologico presupposto o delineato dal Positivismo.
Eredità del Positivismo.
Ciò non deve tuttavia far dimenticare (come avviene talora) che il
Positivismo:
l) ha influito in profondità sulla cultura moderna, attirando l'attenzione
sull'importanza conoscitiva e pratico-sociale della scienza;
2) ha stimolato la nascita e l'affermazione delle cosiddette "scienze
umane", in particolare della sociologia e della psicologia;
3) ha proposto un nuovo concetto di filosofia, che rimane tuttora come una
delle alternative fondamentali di tale disciplina;
4) ha posto le basi per delle forme di neo-positivismo metodologicamente
più guardinghe;
5) ha obbligato la filosofia a ripensare criticamente a se stessa e ai suoi
compiti e a definire meglio i suoi rapporti con la scienza e le altre
attività umane.
5. Le varie forme di Positivismo.
Positivismo sociale e Positivismo evoluzionistico.
Come tutte le correnti della storia del pensiero, anche il Positivismo
non è qualcosa di monolitico, poiché presenta un insieme pluriforme di
autori e dottrine. Tradizionalmente si sono distinti, nel suo seno, due
movimenti di fondo, aventi Darwin come spartiacque: il Positivismo sociale,
tipico della prima parte del secolo e rappresentato soprattutto da
Saint-Simon, Comte e Stuart Mill, e il Positivismo evoluzionistico,
rappresentato principalmente da Spencer, dai materialisti tedeschi e da
Ardigò. Oggi, invece, si preferisce distinguere i positivisti per contesti
nazionali: positivisti francesi, inglesi, tedeschi e italiani. In realtà le
due tendenze non si escludono a vicenda, anzi possono proficuamente
integrarsi: infatti pur mantenendo la distinzione sopraccitata è possibile
seguire lo sviluppo delle idee positiviste nazione per nazione, con il
vantaggio di distinguere nettamente la diversa " atmosfera " generale entro
cui si collocano le filosofie della prima e della seconda metà
dell'Ottocento.
"Atmosfera" che all'inizio è caratterizzata soprattutto dal riferimento alla
scienza come strumento di superamento della "crisi" moderna e come mezzo di
rigenerazione complessiva dell'umanità; e che in seguito risulta
improntata soprattutto dalle scoperte biologiche di Darwin, che offrono
una base per ardite generalizzazioni filosofiche ruotanti attorno all'idea
di "evoluzione", assunta a categoria interpretativa universale, valida per
la storia delle galassie come per il divenire delle civiltà umane.
6. La filosofia sociale in Francia.
6.1. Saint-Simon.
I temi fondamentali del positivismo sociale sono già evidenti nell'opera del
conte Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825). Industriale e affarista,
Saint-Simon conobbe gli alti e bassi di un fastoso mecenatismo e di una
nera miseria. Nel 1817 egli pubblicava L'Industria, che è una delle sue
opere principali alla quale seguirono: L'Organizzatore, 1819-1820;
Il sistema industriale, 1821-1822; Il catechismo degli industriali,
1823-1824; Il nuovo cristianesimo, 1825.
L'idea fondamentale di Saint-Simon è quella della storia come un progresso
necessario e continuo.
Epoche organiche ed epoche critiche
La storia è retta da una legge generale che determina la successione di
epoche organiche e di epoche critiche. L'epoca organica è quella che riposa
su credenze ben stabilite, si sviluppa in conformità di esso e progredisce
nei limiti da esso stabiliti. A un certo punto, questo progresso fa mutare
l'idea centrale su cui l'epoca era imperniata e determina così l'inizio
di un'epoca critica.
Il progresso scientifico, distruggendo le dottrine teologiche e metafisiche,
ha tolto il suo fondamento all'organizzazione sociale del Medioevo. Ci
sarà dunque un'epoca in cui la filosofia sarà positiva e la filosofia
positiva sarà il fondamento di un nuovo sistema di religione, di politica,
di morale e d'istruzione pubblica. Solo in virtù di questo sistema il
mondo sociale potrà riacquistare la sua unità e la sua organizzazione,
che non possono ormai più fondarsi su credenze teologiche o su teorie
metafisiche. Saint-Simon si fa annunciatore e profeta di questa
organizzazione sociale fondata sulla filosofia positiva.
Il nuovo potere: scienziati e industriali.
In essa domineranno un nuovo potere spirituale e un nuovo potere
temporale. Il nuovo potere spirituale sarà quello degli scienziati, cioè
degli uomini " che possono predire il più gran numero di cose".
Dall'altro lato, l'amministrazione degli affari temporali sarà affidata
agli industriali. Del resto, scrive Saint-Simon con una parabola famosa,
se la Francia perdesse improvvisamente i tremila individui che coprono
e cariche politiche, amministrative e religiose più importanti, lo stato
non ne avrebbe nessun danno; sarebbe facile infatti sostituire questi
individui con altrettanti aspiranti, che non mancano mai. Ma se la Francia
perdesse improvvisamente i tremila più esperti e abili scienziati, artisti
e artigiani che essa possiede, il danno per la nazione sarebbe irreparabile.
L'ultimo scritto di Saint-Simon, il Nuovo cristianesimo (1825), definisce
l'avvento della società futura come un ritorno al cristianesimo primitivo.
Importanza del sainsimonismo.
Il sansimonismo ebbe in Francia una diffusione notevole: esso contribuì
potentemente a formare la coscienza sociale e spirituale (quindi religiosa)
delle conquiste che la scienza e la tecnica raggiungono. Questa coscienza
determinò da un lato un'attività proficua allo sviluppo industriale
(ferrovie, banche, industrie, anche l'idea dei canali di Suez e di Panama
furono dovuti a sansimonisti); dall'altro determinò correnti socialistiche
miranti ad un'organizzazione più armonica e giusta della vita sociale.
6.2. Fourier e Proudhon.
Fourier.
Fra queste correnti una delle più significative è quella che fa capo a
Charles Fourier (1772-1835), autore di numerosi scritti, ricchi di spunti
utopistici quanto di acute osservazioni morali e storiche. L'idea
dominante di Fourier è che esista nell'universo un piano provvidenziale
nel quale rientrano l'uomo, il suo lavoro e la sua organizzazione sociale.
A meno che non si voglia ammettere che la provvidenza divina sia
insufficiente, limitata e indifferente alla felicità umana, bisogna
ritenere che Dio abbia composto per noi " un codice passionale o sistema
d'organizzazione domestica e sociale, applicabile e tutta l'umanità che ha
dappertutto le stesse passioni"; e che ha dovuto anche fornire all'uomo
un metodo fisso e infallibile per l'interpretazione di questo codice.
"Questo metodo, aggiunge Fourier, non può essere che il calcolo
analitico e sintetico dell'attrazione passionale, giacché l'attrazione è
la sola interprete conosciuta tra Dio e l'universo". In altri termini,
l'organizzazione sociale deve rendere attraente il lavoro cui l'uomo è
chiamato e quindi il posto che egli occupa in esso. Deve quindi non
reprimere le passioni e l'ineliminabile tendenza al piacere, ma
utilizzarle nel loro massimo rendimento. L'organizzazione che si presta a
questo scopo è, secondo Fourier, quella della falange, cioè di una
società di circa 1.600 persone, che vivono in un falansterio, a regime
comunistico, con libertà di rapporti sessuali e regolamentazione della
produzione e del consumo dei beni.
Proudhon.
Contrasta con le tendenze comunistiche di Fourier, l'indirizzo sociale
di Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). Il primo scritto di Proudhon
Che cosa è la proprietà? (1840) contiene la definizione famosa:
"la proprietà è un furto".
Ma questa definizione si riferisce non all'origine della proprietà, ma al
fatto che essa rende possibile l'appropriazione dell'altrui lavoro.
Proudhon vuole perciò, non l'abolizione della proprietà capitalistica, ma
solo l'abolizione dell'interesse capitalistico cioè del reddito
illegittimo che la proprietà consente di godere al capitalista a spese
dell'altrui lavoro. L'opera più importante di Proudhon è quella in tre
volumi intitolata La giustizia nella rivoluzione e nella chiesa (1858).
Il principio da cui muove Proudhon è quello stesso da cui partono tutte
le filosofie sociali dell'età romantica: la storia dell'uomo ha una legge
intrinseca di progresso, per la quale si dirige inevitabilmente alla
perfezione. Questa legge è la giustizia, secondo Proudhon. E la
giustizia deve essere non solo un'idea, ma una realtà, cioè una forza
dell'anima individuale e della vita associata, in modo da valere " come
la prima e l'ultima parola del destino umano individuale e collettivo, la
sanzione iniziale e finale della nostra beatitudine".
7. Comte.
7.1. Vita e scritti.
Dalla filosofia di Saint-Simon prende le mosse il fondatore del
positivismo, Auguste Comte.
Nato a Montpellier nel 1798, Comte studiò alla Scuola Politecnica di
Parigi e fu dapprima insegnante privato di matematica. Amico e collaboratore
di Saint-Simon, assumeva nel 1822 una posizione indipendente nello scritto
Piano dei lavori scientifici necessari per organizzare la società.
Qualche anno dopo interrompeva l'amicizia con Saint-Simon e procedeva
ad un'elaborazione indipendente della sua filosofia. Questa elaborazione
fu interrotta tra il 1826 e il 1827 da una violenta crisi cerebrale che
lo portò al manicomio e di cui trionfò (come egli stesso dice) grazie
alla " potenza intrinseca della sua organizzazione".
Viata e opere.
Nel 1830 usciva il primo volume del Corso di filosofia positiva e
successivamente sino al 1842 uscirono gli altri cinque. La carriera
accademica di Comte fu infelice. Aspirò inutilmente ad una cattedra
di Matematica alla Scuola Politecnica di Parigi. Nel 1833 ottenne un
posto di ripetitore di matematica e di esaminatore dei candidati presso
quella scuola: un posto precario, che, perdette dopo la pubblicazione
dell'ultimo volume del Corso per l'ostilità che avevano incontrato
negli ambienti accademici le idee che vi erano esposte. Comte visse da
allora in poi e sino alla morte con aiuti e sussidi di amici e discepoli,
avendo anche rinunziato ad ogni provento delle sue opere. Separato dalla
moglie, conobbe nel 1845 Clotilde de Vaux, con la quale visse per qualche
mese in perfetta comunione spirituale e che dopo la morte (1846) fu per
lui quella che Beatrice era stata per Dante. L'orientamento religioso del
suo pensiero, già evidente nella prima opera, si accentuò ancora fino a
diventare dominante nella seconda opera capitale, il Sistema di politica
positiva o Trattato di sociologia che istituisce la religione dell'umanità
(4 volumi, 1851-1854). Questa seconda parte della sua carriera ha il
còmpito, come egli stesso dice, di trasformare la filosofia in religione,
come la prima parte aveva trasformato la scienza in filosofia. In questa
fase, Comte si presenta come il profeta di una nuova religione, di cui
formula un catechismo (Catechismo positivista, 1852) e di cui si preoccupa
di fissare il calendario (Calendatio positivista, 1849-1860). Egli si
considerava il pontefice massimo di questa nuova religione che avrebbe
dovuto completare e portare a termine la "rivoluzione occidentale",
cioè lo sviluppo positivista della civiltà occidentale.
Comte moriva a Parigi nel 1857.
Il progetto filosofico di Comte.
La parte dell'opera di Comte che ha avuto maggiore risonanza, diretta o
polemica, è la dottrina della scienza. Ma l'intento di Comte è veramente
la costruzione di una filosofia della storia, che si trasforma, nella
seconda fase della sua vita, in una religione dell'umanità, cioè in una
divinizzazione della storia. Comte stesso afferma che fin dall'età di
quattordici anni aveva provato "il bisogno fondamentale d'una rigenerazione
universale, ad un tempo politica e filosofica"; e questo bisogno è stato in
realtà la molla di tutta la sua attività di scrittore, portandolo a
considerare la scienza positiva come la soluzione definitiva ed ultima di
tutti i problemi del genere umano.
7.2. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.
Quella che agli occhi di Comte è la sua scoperta fondamentale, e che in
realtà è il punto di partenza di tutta la sua filosofia, è la legge dei tre
stadi. Secondo questa legge, che Comte dichiara di aver ricavato da
considerazioni storiche oltre che dall'osservazione dello sviluppo organico
dell'uomo, ciascuna branca della conoscenza umana passa successivamente
per tre stadi teorici differenti: lo stadio teologico e fittizio, lo stadio
metafisico od astratto, lo stadio scientifico o positivo. Vi sono dunque tre
metodi diversi per condurre la ricerca umana e tre sistemi di concezioni
generali. Il primo è il punto di partenza necessario dell'intelligenza
umana; il terzo il suo stadio fisso e definitivo; il secondo è unicamente
destinato a servire di transizione.
Lo stadio teologico.
Nello stadio teologico, lo spirito umano, dirigendo essenzialmente le
sue ricerche verso la natura intima degli esseri e le cause prime e finali,
cioè verso le conoscenze assolute, si rappresenta i fenomeni come prodotti
dall'azione diretta e continua di agenti soprannaturali, più o meno
numerosi, il cui intervento arbitrario spiega tutte le anomalie
appartenenti dell'universo.
Lo stadio metafisico.
Nello stadio metafisico, che è solo una modificazione del primo, gli agenti
soprannaturali sono sostituiti da forze astratte (si pensi ad esempio alle
"essenze") inerenti ai diversi enti del mondo e concepite capaci di
generare da sé tutti i fenomeni osservati, la cui spiegazione
consisterebbe quindi nell'assegnare a ciascuno l'entità corrispondente.
Lo stadio positivo.
Infine, nello stadio positivo, lo spirito umano, riconoscendo
l'impossibilità di raggiungere nozioni assolute, rinuncia a cercare
l'origine e il destino dell'universo e a conoscere le cause intime dei
fenomeni e si applica unicamente a scoprire mediante l'uso ben combinato
del ragionamento e dell'osservazione, le loro leggi effettive: cioè le
loro relazioni invariabili di successione e di somiglianza.
Questa legge dei tre stadi sembra a Comte immediatamente evidente di per
se stessa. Essa inoltre è appoggiata dall'esperienza personale. "Chi di
noi non ricorda, contemplando la sua propria storia, che è stato
successivamente, rispetto alle nozioni più importanti, teologo nella sua
infanzia, metafisico nella sua giovinezza e fisico nella sua virilità?".
Ora, sebbene varie branche della conoscenza umana siano entrate nella
fase positiva, la totalità della cultura intellettuale umana, e quindi
dell'organizzazione sociale che su di essa si fonda, non sono state
ancora permeate dallo spirito positivo. In primo luogo, Comte nota che
accanto alla fisica celeste, alla fisica terrestre, meccanica e chimica,
e alla fisica organica, vegetale e animale, manca una fisica sociale cioè
lo studio positivo dei fenomeni sociali. In secondo luogo, la mancata
penetrazione dello spirito positivo nella totalità della cultura
intellettuale produce uno stadio di anarchia intellettuale e quindi la
crisi politica e morale della società contemporanea.
L'anarchia intellettuale e politica della società contemporanea.
è evidente che se una delle tre filosofie possibili, la teologia, la
metafisica e la positiva, ottenesse in realtà una preponderanza universale
completa, ci sarebbe un ordine sociale determinato. Ma poiché invece le
tre filosofie opposte continuano a coesistere, ne risulta una situazione
incompatibile con un'effettiva organizzazione sociale. Comte si propone
perciò il còmpito di portare a termine l'opera iniziata da Bacone, Cartesio
e Galilei e di costruire il sistema delle idee generali che deve
definitivamente prevalere nella specie umana, ponendo termine così alla
crisi rivoluzionaria che tormenta i popoli civilizzati.
La filosofia "positiva" e l'enciclopedia delle scienze.
Tale sistema di idee generali o filosofia positiva presuppone però che
sia determinato il compito particolare di ciascuna scienza e l'ordine
complessivo di tutte le scienze: presuppone un'enciclopedia delle scienze
che muovendo da una classificazione sistematica fornisca il prospetto
generale di tutte le conoscenze scientifiche. Comte comincia per
escludere dalla sua considerazione le conoscenze applicate della tecnica
e delle arti, limitandosi alle conoscenze speculative; e anche di queste
considera solo quelle generali ed astratte, escludendo quelle
particolari e concrete. Posto ciò egli cerca di determinare una scala
enciclopedica delle scienze che corrisponda alla storia delle scienze
stesse. Le scienze si possono classificare considerando in primo luogo
il loro grado di semplicità o, ciò che è lo stesso, il grado di
generalità dei fenomeni che costituiscono il loro oggetto.
Il principio della complessità crescente e della semplicità decrescente.
I fenomeni più semplici sono infatti anche i più generali; ed i fenomeni
semplici e generali sono anche quelli più facilmente osservabili. Perciò,
graduando le scienze secondo l'ordine della complessità crescente e della
semplicità decrescente, si viene a riprodurre, nella gerarchia così
formata, l'ordine di successione con cui le scienze sono entrate nella
fase positiva.
Seguendo questo criterio si possono in primo luogo distinguere i
fenomeni dei corpi bruti e i fenomeni dei corpi organizzati come oggetti
di due gruppi principali di scienze. I fenomeni dei corpi organizzati
sono evidentemente più complicati e più particolari degli altri;
dipendono dai precedenti che a loro volta non ne dipendono. Di qui la
necessità di studiare i fenomeni fisiologici dopo quelli dei corpi
inorganici. La fisica si trova dunque divisa in fisica organica e fisica
inorganica. A sua volta la fisica inorganica, secondo lo stesso criterio
della semplicità e della generalità, sarà dapprima fisica celeste
(o astronomia sia geometrica, sia meccanica) e poi fisica terrestre che
a sua volta sarà fisica propriamente detta e chimica. Una divisione analoga
sarà fatta per la fisica organica. Tutti gli esseri viventi presentano due
ordini di fenomeni distinti, quelli relativi all'individuo e quelli relativi
alla specie: ci sarà dunque una fisica organica o fisiologica e una fisica
sociale che è fondata su di essa.
Le scienze fondamentali.
L'enciclopedia delle scienze sarà dunque costituita da cinque scienze
fondamentali: astronomia, fisica, chimica, biologia e sociologia.
Di questa gerarchia non fanno parte, come si vede, né la matematica, né la
logica, né la psicologia.
La matematica.
I motivi dell'esclusione sono diversi. La matematica è stata esclusa non
perché non sia una scienza, ma perché costituisce la base di tutte le altre
scienze. Anzi, tenendo presente che essa è stata la prima scienza ad entrare
nello stadio positivo, l'enciclopedia comtiana può venir globalmente
articolata secondo l'ordine seguente: 1) matematica; 2) astronomia;
3)fisica; 4) chimica; 5) biologia; 6) sociologia.
La logica.
La logica è stata esclusa poiché Comte ritiene che essa non sussista in
generale e in astratto, ma si identifichi con il metodo
concreto
impiegato da ogni specifica branca del sapere.
La psicologia.
Infine, la psicologia deve la sua esclusione dall'enciclopedia al fatto
che non è una scienza e non è suscettibile di diventarlo.
La cosiddetta "osservazione interiore" che si è destinata allo studio dei
fenomeni intellettuali è impossibile. I fenomeni intellettuali non possono
essere osservati nell'atto stesso in cui si verificano. "L'individuo
pensante non può dividersi in due, di cui l'uno ragioni, mentre l'altro lo
guardi ragionare. L'organo osservato e l'organo osservatore essendo in
questo caso identici, come potrebbe l'osservazione aver luogo?".
Piuttosto, ciò che vi è di scientifico nella psicologia, da un lato è
riconducibile all'esame fisiologico del cervello (cioè alla biologia) e
dall'altro all'esame del suo comportamento sociale (cioè alla sociologia).
7.3 La sociologia.
La sociologia come scienza positiva.
La scienza alla quale tutte le scienze sono subordinate, come al loro ultimo
fine, è la sociologia. Còmpito di questa scienza è quello di "percepire
nettamente il sistema generale delle operazioni successive, filosofiche
e politiche, che devono liberare la società dalla sua fatale tendenza alla
dissoluzione imminente e condurla direttamente ad una nuova organizzazione,
più progressiva e più salda di quella che riposava sulla filosofia
teologica ". A questo scopo la sociologia deve costituirsi nella stessa
forma delle altre discipline positive e concepire i fenomeni sociali come
soggetti a leggi naturali che ne rendano possibile la previsione sia pure
nei limiti compatibili con la loro complessità superiore.
La statica sociale.
La sociologia, o fisica sociale, è divisa da Comte in statica sociale e
dinamica sociale, corrispondenti ai due concetti fondamentali su cui essa
si fonda, quelli dell'ordine e del progresso. La statica sociale mette in
luce la relazione necessaria, il "consenso universale", che hanno tra loro
le varie parti del sistema sociale. Così tra il regime politico e lo stadio
corrispondente della civiltà umana c'è un rapporto necessario, per il quale
un determinato regime, pur essendo in accordo con la fase corrispondente
della civiltà, diventa inadeguato ad una fase diversa e successiva.
La dinamica sociale.
L'idea fondamentale della dinamica sociale è invece quella del progresso,
cioè dello sviluppo continuo e graduale dell'umanità. Per la nozione
del progresso, clascuno degli stadi sociali consecutivi è "il risultato
necessario del precedente e il motore indispensabile del seguente, secondo
il luminoso assioma del grande Leibniz: il presente è gravido dell'avvenire".
L'idea del progresso ha per la sociologia un'importanza ancora maggiore di
quella che l'idea della serie individuale delle età ha per la biologia.
Essa spiega anche il sorgere degli uomini di genio, di quelli che Hegel
chiamava "individui della storia cosmica"; e la spiegazione di Comte è
analoga a quella di Hegel. Gli uomini di genio non sono che gli organi
propri del movimento predeterminato, il quale, nel caso di una loro
mancanza, si sarebbe aperte altre vie. Il progresso realizza un
perfezionamento incessante, per quanto non illimitato, del genere umano;
e questo perfezionamento segna "la preponderanza crescente delle
tendenze più nobili della nostra natura". Ma questo perfezionamento non
implica che una qualsiasi fase della storia umana sia imperfetta o
inferiore alle altre.
La necessità della storia.
Per Comte come per Hegel, la storia è sempre, in tutti i suoi momenti,
tutto ciò che dev'essere. " Poiché il perfezionamento effettivo risulta
soprattutto dallo sviluppo spontaneo dell'umanità, come potrebbe esso non
essere essenzialmente, a ciascun'epoca, ciò che poteva essere secondo
l'insieme della situazione?". Comte afferma che senza questa compiutezza
di ciascun'epoca della storia in se stessa la storia sarebbe
incomprensibile. E non esita neppure a ripristinare nella storia il
concetto di causa finale. Gli eventi della storia sono necessari nel
duplice significato del termine: nel senso che in essa è inevitabile ciò
che si manifesta dapprima come indispensabile, e reciprocamente. è
questo un modo altrettanto efficace di esprimere l'identità hegeliana tra
il razionale e il reale. E Comte cita a questo proposito "il bell'aforisma
politico dell'illustre De Maistre: tutto ciò che è necessario esiste".
7.4. La dottrina della scienza e la sociocrazia.
La dottrina della scienza è la parte dell'opera di Comte che ha avuto più
vasta e duratura risonanza nella filosofia e maggiore efficacia sullo
sviluppo stesso della scienza. Come già Bacone e Cartesio (ai quali
dichiara di collegarsi), Comte concepisce la scienza come essenzialmente
diretta a stabilire il dominio dell'uomo sulla natura. Non che la scienza
sia essa stessa di natura pratica o abbia esplicitamente di mira
l'azione. Comte, al contrario, afferma energicamente il carattere
speculativo delle conoscenze scientifiche e le distingue nettamente da
quelle tecnico-pratiche, limitando ad esse soltanto il compito di
un'enciclopedia delle scienze. Tuttavia, considerato nel suo insieme, lo
studio della natura è destinato a fornire "la vera base razionale
dell'azione dell'uomo sulla natura"; giacché "solo la conoscenza delle
leggi dei fenomeni, il cui risultato costante è di farceli prevedere,
può evidentemente condurci nella vita attiva a modificarli a nostro
vantaggio ".
Scienza, previsione e azione.
Lo scopo dell'indagine scientifica è la formulazione delle
leggi perché la legge permette la previsione; e la previsione dirige e
guida l'azione dell'uomo sulla natura. "Insomma, dice Comte, scienza,
donde previsione; previsione, donde azione: tale è la formula
semplicissima che esprime in modo esatto la relazione generale tra la
scienza e l'arte, prendendo questi due termini nella loro accezione
totale".
L'osservazione dei fatti e la formulazione di leggi esauriscono il
compito della scienza. Ma la dottrina di Comte insiste più sulla legge
che sull'osservazione dei fatti. Questa ha per scopo di rendere possibile
la formulazione delle leggi. La legge permette la previsione perché, una
volta accertata la condizione che provoca il verificarsi di un certo
fatto, si può prevedere il verificarsi del fatto stesso. E la previsione
consente all'uomo di servirsi dei fatti, di volgerli a proprio vantaggio
e così di estendere il suo potere su di essi.
La "sociocrazia".
L'opera di Comte risulta esplicitamente diretta a favorire l'avvento di
una società nuova che egli chiamò sociocrazia, cioè un regime fondato
sulla sociologia, analogo e corrispondente alla teocrazia fondata sulla
teologia. Egli stesso avrebbe voluto essere il capo spirituale di un
regime positivo, altrettanto assolutista del regime teologico che esso
avrebbe dovuto soppiantare, in quanto avverso alle idee moderne di libertà
individuale e di pluralismo, assimilate, da Comte, ad una forma di
"disordine". Tant'è vero che il mondo moderno, dal punto di vista di Comte,
non è altro che un "interregno anarchico " tra lo stadio organico
dell'ordine teologico-feudale e lo stadio parimenti organico
dell'ordine positivo.
7.5. La divinizzazione della storia e la religione della scienza.
Il Sistema di politica positiva è diretto esplicitamente a trasformare
la filosofia positiva in una religione positiva. Esso tende cioè a
fondare l'unità dogmatica, culturale e pratica dell'umanità, unità che,
infranta dalla decadenza del regime teocratico e dal primo sorgere dello
spirito positivo, non è stata ancora ristabilita. Quest'unità non è
soltanto perciò l'unità di una dottrina, ma anche quella di un culto, di
una morale e di un costume. Comte nell'opera citata ne lumeggia tutti gli
aspetti.
Il culto dell'Umanità.
Il concetto fondamentale è quello dell'Umanità, che deve prendere il
posto di quello di Dio. L'Umanità è il Grande Essere come "l'insieme degli
esseri passati, futuri e presenti che concorrono liberamente a
perfezionare l'ordine universale". Questa celebrazione dell'umanità
dimostra chiaramente l'ultima ispirazione del suo pensiero. Il concetto
dell'umanità non è un concetto biologico (per quanto sia anche
biologico), ma un concetto storico, fondato sull'identificazione
romantica di tradizione e storicità. L'Umanità è la tradizione
ininterrotta e continua del genere umano, tradizione condizionata dalla
continuità biologica del suo sviluppo, ma includente tutti gli elementi
della cultura e della civiltà del genere umano. Comte mette in luce
continuamente la saggezza e la provvidenza del Grande Essere, che ha
saputo mirabilmente e gradualmente svilupparsi nelle sue età primitive
(teologica e metafisica) per giungere all'età positiva, che preannuncia
la sua piena maturità. L'Umanità non è quindi che la tradizione
divinizzata; una tradizione che comprende tutti gli elementi oggettivi e
soggettivi, naturali e spirituali, che costituiscono l'uomo.
Comte delinea, con minuziosi particolari, anche il culto positivistico
dell'umanità. Stabilisce un "calendario positivista" in cui i mesi e i
giorni sono dedicati alle maggiori figure della religione, dell'arte,
della politica e della scienza. Propone perfino un nuovo "segno", che
dovrebbe sostituire il segno di croce dei cristiani e che consiste nel
toccare successivamente "i principali organi che la teoria cerebrale
assegna ai suoi tre elementi", cioè all'amore, all'ordine, al progresso.
Infine nell'ultimo scritto, dedicato alla Filosofia della matematica
(1856) che si propone di associare la scienza della natura col sentimento,
pretende di stabilire una trinità positivistica. Accanto al Grande Essere
che è l'Umanità, egli pone come soggetto di adorazione il Grande Feticcio
cioè la terra e il Grande Mezzo cioè lo spazio.
La morale del positivismo.
La morale del positivismo è l'altruismo. Vivere per gli altri è la sua
massima fondamentale. Tale massima non è contraria a tutti gli istinti
dell'uomo, perché essi non sono esclusivamente egoistici. Accanto agli
istinti egoistici, l'uomo possiede istinti simpatici che l'educazione
positivista può sviluppare gradualmente sino a renderli predominanti
sugli altri.
8. Il Positivismo utilitaristico inglese.
8.1. Malthus e Ricardo.
L'utilitarismo della prima metà dell'Ottocento può essere considerato come
la prima manifestazione del positivismo in Inghilterra. Si trattò di un
positivismo sociale (analogo e corrispondente a quello francese
contemporaneo) dal quale le tesi teoretiche di filosofia o di morale
furono considerate come strumenti di rinnovamento o di riforma sociale.
L'utilitarismo si connette infatti strettamente ad un'attività politica,
di stampo radicale o socialista, che ebbe i suoi massimi esponenti
proprio nei tre teorici principali dell'utilitarismo, Bentham, James Mill
e Stuart Mill.
Gli utilitaristi annoverarono, tra i loro massimi rappresentanti e
profeti, le due grandi figure dell'economia politica dell'Ottocento,
Malthus e Ricardo. Al suo primo sorgere, con i fisiocrati francesi e con
Adam Smith, l'economia politica aveva condiviso la fede ottimistica del
Settecento illuminista. Essa aveva elaborato il concetto di un ordine
dei fatti economici per il quale vengano provvidenzialmente a coincidere
l'interesse privato e l'interesse pubblico, onde basta all'individuo
seguire il suo proprio interesse per agire nello stesso tempo come una
forza diretta al vantaggio di tutti. Con Malthus e Ricardo vengono messe
in luce talune anomalie fondamentali dell'ordine economico.
Malthus.
Thomas Robert Malthus (1766-1834) pubblicava anonimo nel 1798 il suo
Saggio sulla popolazione, che ristampava nel 1803 in una seconda
edizione accresciuta e modificata. Il suo punto di partenza è la
considerazione del rapporto tra l'accrescimento della popolazione e
l'accrescimento dei mezzi di sussistenza. Malthus osservò che la
popolazione tende a crescere secondo una progressione geometrica
(2-4-8 eccetera) cioè raddoppiandosi ogni venticinque anni, mentre
i mezzi di sussistenza tendono a crescere secondo una progressione
aritmetica (1-2-3 eccetera). Lo squilibrio che così si determina tra
popolazione e mezzi di sussistenza può essere, secondo Malthus, eliminato
in due modi: in primo luogo attraverso la miseria ed il vizio che
diminuiscono e falcidiano la popolazione; in secondo luogo attraverso
il "controllo preventivo " delle nascite. Evidentemente il progresso
della società umana consiste nel sostituire, quanto più è possibile,
il controllo repressivo col controllo preventivo: nell'impedire
l'accrescersi eccessivo della popolazione mediante quello che egli
chiama il "ritegno morale", cioè "con l'astenersi dal matrimonio per
motivi prudenziali e con una condotta strettamente morale durante
il periodo di questa astinenza".
Ricardo.
L'altro economista David Ricardo (1772-1823) è autore dei Principi di
economia politica e di tassazione (1817), che divenne la Bibbia
economica degli utilitaristi. Le analisi di Ricardo si muovono sulla
stessa linea di quelle di Malthus, ma vertono soprattutto sul rapporto
tra il salario del lavoratore e il profitto del capitalista. Egli in
primo luogo mette in luce il fenomeno della cosiddetta "rendita
fondiaria". Poiché sul mercato lo stesso prodotto deve essere venduto
allo stesso prezzo, i proprietari dei terreni più fertili, che producono
a un costo inferiore, hanno un sovrappiù di profitto che costituisce
appunto la rendita fondiaria. è evidente che questo fenomeno mette
l'interesse dei proprietari di terra in antagonismo con l'interesse della
collettività: giacché a misura che si verifica un aumento della
popolazione o comunque uno stato di maggiore miseria, il reddito dei
proprietari di terra si accresce. L'ordine economico qui non agisce come
ordine provvidenziale o benefico. Quanto al salario, Ricardo riconobbe
che il suo prezzo naturale "è quello necessario a mettere in grado i
lavoratori di vivere e perpetuare la loro razza senza aumentare né
diminuire". Egli vide così chiaramente l'antagonismo tra profitto e
salario. E pur considerando il capitale nient'altro che "lavoro accumulato,
non ritenne che il reddito di esso fosse sempre proporzionato al lavoro
personale.
8.2. Bentham e James Mill.
Bentham
Jeremiah Bentham (1748-1832) assume come suo principio fondamentale la
massima di Cesare Beccaria, che il fine di ogni attività morale e di
ogni organizzazione sociale debba consistere nella "maggiore felicità
possibile del maggior numero possibile di persone". In virtù di questa
massima, un'azione è buona quando è utile, cioè contribuisce in qualche
grado alla felicità comune, procurando un piacere o evitando un dolore.
Ma piacere e dolore sono spesso commisti, inoltre vi sono piaceri che si
escludono a vicenda. Occorrono perciò precisi criteri per effettuare un
" bilancio morale" capace di trarci d'imbarazzo, cioè un " calcolo" del
piacere complessivo che i vari corsi d'azione possibili promettono di
offrire. Del piacere che possiamo aspettarci nei vari casi si dovrà dunque
considerare l'intensità, la durata, la certezza, la prossimità, la
fecondità (possibilità di produrre altri piaceri), la purezza (incapacità
di produrre dolore) e l'estensione (capacità di estendersi al maggior
numero di persone). Un piacere che presenti tutti questi caratteri è
senz'altro il bene, e deve essere assunto come il fine, non solo
dell'attività morale, ma anche di quella sociale e politica; e Bentham
indica le riforme che nel campo sociale e politico questo principio esige.
James Mill.
L'utilitarismo viene giustificato dal punto di vista psicologico
da James Mill (1773-1836) nella sua opera Analisi dei fenomeni dello
spirito umano. Già David Hartley (1705-1757) aveva condotto all'estremo
l'atomizzazione della vita spirituale iniziata da Hume, risolvendo nelle
idee (considerate come elementi o atomi spirituali) tutta la vita della
coscienza e spiegando i fatti di coscienza con le associazioni delle idee.
Secondo Mill, le associazioni possono diventare così salde da dar luogo a
complessi che non hanno più il carattere delle idee che contengono.
Per esempio i sentimenti disinteressati si generano in realtà dalla
tendenza egoistica: l'associazione costante tra il nostro piacere e
quello degli altri finisce per far desiderare il piacere altrui anche
quando, poi, esso è indipendente da quello nostro o magari contrario ad
esso. Associazioni di questo genere spiegano, secondo Mill, tutti i
sentimenti morali; il che d'altronde non toglie nulla al loro merito,
perché la questione dell'origine non ha nulla a che fare con la
questione del valore.
In queste dottrine dell'utilitarismo, i caratteri che occorre sottolineare
sono due: questi scrittori vogliono (esattamente come Comte) che la morale,
la politica, il diritto eccetera, cioè le discipline che concernono l'uomo,
divengano una scienza positiva, simile a quella che concerne il mondo
naturale. Ma le finalità civili e politiche che si crede con ciò di favorire
sono nettamente liberali e democratiche (ben diversamente da quelle
di Comte) intese a rinsanguare con opportune riforme la tradizione
parlamentare inglese.
9. Stuart Mill.
9.1. Vita e scritti.
L'utilitarismo inglese, di cui abbiamo delineato i tratti fondamentali, è
nel suo complesso un positivismo della morale. John Stuart Mill ha messo
in chiara luce i princìpi filosofici impliciti in questo positivismo
etico e lo ha collegato col positivismo sociale francese.
John Stuart Mill nacque nel 1806 a Londra. I suoi scritti fondamentali
sono: Sistema di logica deduttiva e induttiva, 1843; Saggi su alcune
incerte questioni di economia politica, 1844; Princìpi di economia
politica, 1848; Sulla libertà, 1859. Fra gli scritti minori sono
particolarmente significativi quello sulla Libertà e sulla Servitù delle
donne (1869). Il primo è una difesa della libertà contro il possibile
pericolo che può derivarle dallo sviluppo dell'eguaglianza sociale; il
secondo è una difesa dei pieni diritti morali, civili e politici del
sesso femminile.
Mill e Comte.
L'Autobiografia di Stuart Mill rende esplicita testimonianza dell'influenza
che gli scritti di Saint-Simon e dei suoi seguaci ebbero sul pensiero di
lui. Con molta simpatia Stuart Mill considerò pure i primi volumi della
Filosofia positiva (Autobiografia, capitolo 5), ma la sua corrispondenza
con Comte dimostra il graduale affievolirsi della sua simpatia per il
filosofo francese. Pur accettando il principio che l'umanità è il
fondamento e il fine di ogni attività umana e ammettendo che i filosofi
debbano col tempo assumere l'ascendente morale e intellettuale una volta
esercitato dai preti, Stuart Mill rifiutava nettamente la sociologia
mitologica che Comte aveva costruito nella Politica positiva e nelle
opere collaterali. Ripugnava a Stuart Mill, difensore ed apostolo della
libertà individuale, il dispotismo spirituale e temporale di cui Comte
si era fatto banditore, e che gli appariva non meno oppressivo di quello
di Ignazio di Loyola. Lo studio Augusto Comte e il positivismo, pubblicato
da Stuart Mill nel 1865, mentre rende giustizia ai meriti filosofici del
positivista francese, mette in luce senza pietà gli aspetti ridicoli o
ripugnanti della sua dottrina.
9.2. La logica.
In realtà, la differenza fondamentale tra il positivismo di Comte e
il positivismo di Stuart Mill è che l'uno è un razionalismo radicale
mentre l'altro, nato sul tronco tradizionale della filosofia inglese,
è un non meno radicale empirismo. Il positivismo di Comte intende, sì,
partire dai fatti, ma solo per giungere alla legge la quale, una volta
formulata, entra a far parte del sistema totale delle credenze
dell'umanità e viene dogmatizzata.
Tendenza empiristica del positivismo di Mill.
Per il positivismo di Stuart Mill invece il richiamo ai fatti è continuo
e incessante, e non è possibile alcuna dogmatizzazione dei risultati della
scienza. La logica di Stuart Mill ha come suo scopo principale
quello di battere in breccia ogni assolutismo della credenza e di
riportare ogni verità, principio o dimostrazione, alla validità delle
sue basi empiriche. Per questa via, la ricerca filosofica non perde
quel carattere sociale che aveva acquistato negli scritti dei
saint-simonisti e di Comte stesso; soltanto il fine sociale non è quello
di stabilire un unico sistema dottrinariamente e politicamente
oppressivo, bensì quello di combattere alle sue basi ogni possibile
forma di dogmatismo assolutistico. Nell'introduzione alla Logica Mill si
sbarazza subito di tutte le questioni metafisiche che, egli afferma,
cadono fuori del dominio di questa scienza in quanto è la scienza della
prova e dell'evidenza. "è quasi generalmente ammesso, egli dice che
l'esistenza della materia o dello spirito, dello spazio o del tempo non è
per sua natura suscettibile di essere dimostrata, e che se c'è qualche
conoscenza di essa dev'essere l'intuizione immediata". Ma una " intuizione
immediata " che cada fuori di ogni possibilità di ricerca e di
ragionamento è perciò priva di significato filosofico; e la separazione
che Stuart Mill stabilisce tra logica e metafisica è in realtà la
condanna e l'eliminazione di quest'ultima. Accanto all'eliminazione di ogni
realtà metafisica, c'è l'eliminazione di ogni fondamento metafisico o
trascendente o comunque non empirico delle verità e dei princìpi universali.
Genesi empirica di tutte le verità.
Tutte le verità sono Genesi empirica empiriche: la sola giustificazione
del "questo sarà" è il "questo è stato". Le cosiddette proposizioni
essenziali (del tipo "l'uomo è razionale") sono puramente verbali:
asseriscono di una cosa indicata con un nome solo ciò che è asserito col
fatto di chiamarla con questo nome.
Sono cioè il frutto di una pura convenzione linguistica e non dicono
assolutamente nulla di reale sulla cosa stessa. I cosiddetti assiomi
sono originariamente suggeriti dall'osservazione. Non avremmo mai saputo
che due linee rette non possono chiudere uno spazio, se non avessimo mai
veduto una linea retta. Tali assiomi non hanno pertanto un'origine
differente da tutto il resto della nostra conoscenza: la loro origine è
l'esperienza.
Perfino il principio di contraddizione non è che "una delle nostre prime
è più familiari generalizzazioni dall'esperienza". Il suo fondamento
originario è che il credere e il non credere sono due stadi mentali
diversi che si escludono a vicenda. Questo ci è reso noto dalla più
semplice osservazione del nostro spirito. E se a tale osservazione si
aggiungono quelle che ci rivelano l'opposizione e l'esclusione reciproca
di luce e tenebre, suono e silenzio, movimento e quiete eccetera, si vede
subito come il principio di contraddizione non è che la generalizzazione
di questi fatti.
Stuart Mill non intende però portare queste premesse alla conclusione
scettica cui da premesse analoghe era giunto Hume. Egli intende
garantire alla conoscenza umana il grado di validità che le compete in
conformità coi suoi fondamenti empirici. Ogni proposizione universale è
una generalizzazione dei fatti osservati.
Il problema dell'induzione.
Ma che cosa giustifica questa generalizzazione, dato che non è mai
possibile osservare tutti i fatti e che talvolta basta un fatto solo a
giustificare una generalizzazione? è questo il problema fondamentale
dell'induzione, alla quale si riduce in ultima analisi ogni conoscenza vera.
Stuart Mill vede la soluzione di questo problema nel principio
dell'uniformità della natura.
Uniformità della natura e principio di cusalità.
Le uniformità della natura sono le leggi naturali: sono rivelate
dall'esperienza e si confermano e si correggono reciprocamente. Ma le
uniformità naturali rivelate dall'esperienza rivelano tra loro un'uniformità
fondamentale, che è a sua volta una legge: la legge di causalità. Questa
legge, asserendo che ogni fatto che ha un inizio ha una causa, asserisce
che "è una legge che ogni cosa abbia una legge". Come tale è la base di
ogni induzione e permette di riconoscere nella natura un ordine costante
e necessario di fenomeni.
Ma se le leggi di natura non sono che uniformità attestate dall'osservazione,
da che cosa è garantita la legge di causalità, la quale afferma che tali
uniformità ci debbono essere? Stuart Mill ritiene che non è difficile
concepire che in qualcuno dei molti firmamenti dell'universo siderale gli
eventi possano succedersi senza alcuna legge determinata. La legge di
causalità non è quindi un istinto infallibile del genere umano o
un'intuizione immediata o comunque una verità necessariamente connessa
con la natura umana come tale.
La legge che regola l'induzione è, essa stessa, un'induzione.
Non rimane quindi che ammettere che la legge stessa che regola
l'induzione è un'induzione. "Noi arriviamo a questa legge generale mediante
generalizzazione da molte leggi di generalità inferiore. Non avremmo mai
avuto la nozione della causazione (nel significato filosofico del termine)
come condizione di tutti i fenomeni, se molti casi di causazione o, in
altre parole, molte parziali uniformità di successione non ci fossero
diventate precedentemente familiari. La più ovvia delle uniformità
particolari suggerisce e rende evidente l'uniformità generale,
e l'uniformità generale, una volta stabilita, ci permette di dimostrare
le altre uniformità particolari, dalle quali risulta".
Circolo vizioso?
Far dipendere la validità dell'induzione dalla stessa induzione può
sembrare un caso ovvio di circolo vizioso. Ma Stuart Mill osserva che
tale sarebbe solo se si ammettesse la vecchia dottrina del sillogismo
secondo la quale la verità universale (o premessa maggiore) di un
ragionamento è la dimostrazione reale delle verità particolari che
sarebbero dedotte da essa. Stuart Mill invece illustra la dottrina opposta,
cioè che la premessa maggiore non è la prova della conclusione ma è essa
stessa provata, insieme con la conclusione, da una medesima evidenza.
" "Tutti gli uomini sono mortali" non è la prova che Lord Palmerston è
mortale; ma la nostra passata esperienza della mortalità ci autorizza a
inferire insieme la verità generale e il fatto particolare, con lo stesso
grado di sicurezza per l'una e per l'altro".
9.3. Economia e politica.
Il Sistema di economia politica di Mill riassume ed unifica i risultati
che questa scienza aveva raggiunto attraverso l'opera di Smith, Malthus e
Ricardo. Mill non ritiene tuttavia che l'ordine economico sia automatico
e fatale. Le leggi della produzione sono, egli dice, "leggi reali di
natura"; quelle della distribuzione dipendono invece dalla volontà
umana, e quindi dal diritto e dal costume.
Individualismo, socialismo e libertà.
è possibile modificare queste leggi per ottenere una migliore distribuzione
della ricchezza. Mill afferma a questo proposito che la scelta tra
individualismo e socialismo "dipenderà principalmente da un'unica
considerazione, cioè da quale dei due sistemi si concili con la massima
somma possibile di libertà e spontaneità umana". Ed in realtà ciò che
trattiene Mill dall'aderire al socialismo, del quale condivide il
riconoscimento e la condanna delle ingiustizie sociali, è l'esigenza di
salvaguardare in ogni caso la libertà individuale. L'ultima parte del
suo trattato è infatti dedicata a determinare i limiti dell'intervento
del governo negli affari economici. Questi limiti sono in ultima analisi
richiesti dall'esigenza che vi sia "nell'esistenza umana una roccaforte
sacra, sottratta all'intrusione di qualsiasi autorità". Questo non gli
impedisce tuttavia di difendere tutta una serie di misure che dovrebbero
avere lo scopo di distribuire più equamente la ricchezza o di migliorare
le condizioni del popolo.
Al sistema di economia politica si connette un gruppo di opere che
sviluppano problemi già in esso trattati: il saggio sulla Libertà (1859);
quelli sul Governo rappresentativo (1861) e sulla Servitù delle donne (1869)
e quello sull'Utilitarismo (1868). Tutti questi scritti tendono a delineare
nei suoi aspetti (morale, sociale, politico ed economico) un individualismo
radicale, che non può avere altro limite che quello dell'autoprotezione
dell'individuo. Stuart Mill ritiene cioè che l'intervento di un'autorità
qualsiasi nella condotta di un individuo non può essere giustificato se
non nella misura in cui tale intervento è giusticato dalla difesa
degli stessi diritti individuali.
10. Il positivismo sociale in Italia: Cattaneo.
Carlo Cattaneo (1801-1869) partecipò al moto del risorgimento italiano
come repubblicano federalista e dopo la costituzione del regno d'Italia
si esiliò in Svizzera, dove insegnò nel liceo di Lugano e dove morì. A
Milano, egli aveva fondato e diretto una rivista, "Politecnico", che già
nel titolo mostra quella tendenza alla sintesi scientifica che è propria
del positivismo. Gli scritti di Cattaneo sono saggi brevi e occasionali,
fra i quali il più notevole è quello dal titolo Psicologia delle menti
associate, 1859-1866. Fu anche pubblicato postumo il Corso di filosofia
che Cattaneo teneva al liceo di Lugano.
Il progetto di una filosofia "sperimentale".
L'intenzione polemica di Cattaneo è rivolta contro la teologia, la
metafisica, e in generale ogni filosofia che proceda a priori,
prescindendo dai fatti e dalle loro leggi così come sono accertati dalle
singole scienze. In questo senso la filosofia devessere "sperimentale",
deve cioè attenersi al metodo e all'intento propri delle scienze
sperimentali.
Il suo carattere tuttavia, a differenza di quello delle singole scienze,
è generale o sintetico. Cattaneo esprime con varie formule questo
carattere; ma nelle formule di cui più frequentemente si avvale la
filosofia è "lo studio del pensiero o, più precisamente "lo studio
dell'uomo nelle sue relazioni più generali agli altri esseri, come questi
appariscano al testimonio concorde di tutte le scienze morali e fisiche".
Ciò vuol dire che la filosofia non può studiar l'uomo se non nei suoi
rapporti con la natura e con la società; e poiché la natura e la società
sono gli oggetti rispettivi delle scienze naturali e morali, non può
studiar l'uomo prescindendo dai risultati di queste scienze. Cattaneo non
si attende la conoscenza dell'uomo dalla coscienza, cioè dal ripiegamento
dell'uomo su se stesso ma solo dalla considerazione dei rapporti oggettivi
che lo legano a quel mondo della natura e della società che è loggetto
delle scienze.
Scienze e filosofia.
Le scienze offono infatti nella varietà, nel rigore e nell'efficacia dei
loro procedimenti il quadro delle possibilità effettive di cui l'uomo
dispone per conoscere e operare nel mondo e trasformarlo in vista dei
propri bisogni e dei propri ideali.
Indicazioni bibliografiche.
Sul Positivismo in generale:
L. Kolakowski, La filosofia del positivismo, Laterza, Roma-Bari 1974.
W. M. Simon, Il positivismo europeo nel 19esimo secolo, Il Mulino,
Bologna 1980.
Autori Vari, Scienza e filosofia nella cultura positivistica, a cura
di A. Santucci, Feltrinelli, Milano 1982.
Autori vari, Arbor scientiarum. Enciclopedia e sistemi in Francia da
Diderot a Comte (a cura di W. Tega), Il Mulino, Bologna 1984.
Autori Vari, L'età del positivismo (a cura di P. Rossi), Il Mulino,
Bologna 1986.
S. Poggi, Introduzione al positivismo, Laterza, Roma-Bari 1987.
Su Comte:
D. Fisichella, Il potere nella società industriale. Saint-Simon e Comte,
Morano, Napoli 1965.
A. Negri, A. Comte e l'umanesimo positivistico, Armando, Roma 1971.
M. Quaranta, Che cosa ha veramente detto Comte, Ubaldini, Roma 1974.
O. Negt, Hegel e Comte, Il Mulino, Bologna 1975.
F. Manuel, I profeti di Parigi, Il Mulino, Bologna 1979.
A. Negri, Introduzione a Comte, Laterza, Roma-Bari 1983.
Su Stuart Mill:
G. Giulietti, La dottrina dell'induzione nel sistema di J. Stuart Mill,
Ghidini, Verona 1958.
F. Arata, La logica di Stuart Mill e la problematica etico-sociale,
Marzorati, Milano 1964.
F. Restaino, J. Stuart Mill e la cultura filosofica britannica, La Nuova
Italia, Firenze 1968.
G. Frongia, John Stuart Mill e il metodo scientifico, E.S.I., Napoli 1984.
C. Cressati, La libertà e le sue garanzie, Il pensiero politico di J.S. Mill,
Il Mulino, Bologna 1988.
Su Cattaneo:
N. Bobbio, Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo, Einaudi,
Torino 1971.
Autori Vari, L'opera e l'eredità di C. Cattaneo, Il Mulino, Bologna 1975.
U. Puccio, Introduzione a Cattaneo, Einaudi, Torino 1977.
GLOSSARIO E RIEPILOGO.
Comte
- Filosofia positiva. Nel Corso, Comte scrive: "uso il termine filosofia
nell'accezione degli antichi, e in particolare di Aristotele, come quello
che designa il sistema generale delle concezioni umane; aggiungendo il
termine positiva, dichiaro di ritenere questa particolare maniera di
filosofare, consistente nell'indagine... avente per oggetto la
coordinazione dei fatti osservati" (Avvertenza al lettore).
In tal modo, egli cerca di combinare insieme quelle che ritiene le due
maggiori caratteristiche della filosofia e della scienza: l'ideale di una
spiegazione complessiva ed unitaria delle cose ed il richiamo ai fatti
osservati. N.B. Nel Discorso sullo spirito positivo, Comte, delineando
una sorta di mappa dei vari significati del termine positivo, afferma
che esso designa:
1) "il reale in opposizione al chimerico";
2) "il contrasto dell'utile con l'inutile";
3) "l'opposizione tra la certezza e l'indecisione";
4) l'antitesi fra "il preciso" e "il vago";
5) il contrario del negativo: "Sotto questo aspetto, indica una delle più
eminenti proprietà della vera filosofia moderna, mostrandola destinata,
soprattutto, per sua natura, non a distruggere, ma a organizzare".
- La legge dei tre stadi, che Comte considera come la sua "scoperta"
maggiore, consiste nel fatto che "ogni nostra fondamentale concezione...
ogni settore delle nostre conoscenze, passano attraverso tre diversi
stadi teorici: lo stadio teologico o fittizio (vedi); lo stadio metafisico
o astratto (vedi); lo stadio scientifico o positivo (vedi)" -(Corso).
Questi stadi teorici corrispondono a "tre diversi metodi di filosofare"
ovvero a "tre differenti tipi di filosofia, o di sistemi generali di
concezioni sull'insieme dei fenomeni, che si escludono reciprocamente".
- Nello stadio teologico "lo spirito umano mira essenzialmente, mediante la
ricerca, allo scoprimento della natura intima degli esseri, delle cause
prime e finali dei fenomeni che lo colpiscono; in una parola, tende alle
conoscenze assolute. Si rappresenta i fenomeni come prodotti dell'azione
diretta e costante di agenti sovrannaturali, più o meno numerosi, il cui
intervento arbitrario spiega le apparenti anomalie delluniverso" -(Corso).
Il sistema teologico, prosegue Comte, "ha toccato la sua più alta
perfezione quando ha sostituito l'azione provvidenziale d'un essere
unico al gioco delle numerose divinità indipendenti, che erano state
immaginate in principio", ovvero quando dal feticismo e dal politeismo
si è passati al monoteismo.
- Nello stadio metafisico "gli agenti sovrannaturali sono sostituiti da
forze astratte, vere entità (astrazioni personificate) inerenti ai
diversi esseri nel mondo, e concepite (si pensi alle "essenze") come
capaci di produrre tutti i fenomeni che cadono sotto la nostra
osservazione, e la cui spiegazione consiste allora soltanto
nell'assegnare a ciascun fenomeno l'entità corrispondente". Il culmine
dello stadio metafisico risiede nel "concepire, in luogo di diverse
entità particolari, una sola grande entità generale, la natura,
considerata come unico fondamento di tutti i fenomeni".
- Nello stadio positivo "lo spirito umano, riconosciuta l'impossibilità di
toccare nozioni assolute, rinuncia ad indagare sull'origine e sul destino
dell'universo, e tenta unicamente di scoprire, mediante l'uso ben
combinato della ragione e dell'esperienza, le loro leggi effettive, ossia
le loro relazioni invariabili di successione e di somiglianza. La
spiegazione dei fatti, ridotta allora in termini reali, non è altro che
il legame stabilito fra i diversi fenomeni particolari e qualche fatto
generale, il cui numero tende via via a diminuire in seguito al
progresso costante delle scienze".
- La classificazione o l'enciclopedia comtiana delle scienze obbedisce ad
un criterio storico e logico al tempo stesso. Infatti, essa ordina le
scienze: a) secondo la sequenza storica in cui hanno raggiunto lo stadio
positivo (criterio storico) e b) secondo il loro passaggio dalla
semplicità alla complessità, ovvero secondo la regola della complessità
crescente e della semplicità decrescente (criterio logico). Tale
enciclopedia risulta costituita da cinque scienze fondamentali: astronomia,
fisica, chimica, biologia e sociologia. N.B. Di questa gerarchia non fanno
parte, come si vede, né la matematica, né la logica, né la psicologia.
I motivi dell'esclusione sono diversi. La matematica è stata esclusa non
perché non sia una scienza (anzi, essa è stata la prima ad entrare nello
stadio positivo) ma perché sta alla base di tutte le altre scienze.
Tant'è vero che l'enciclopedia comtiana può venir globalmente articolata
secondo l'ordine seguente: 1) matematica; 2) astronomia; 3) fisica;
4) chimica; 5) biologia; 6) sociologia.
La logica è stata esclusa poiché Comte ritiene che essa non sussista in
generale e in astratto, ma si identifichi con il metodo concreto impiegato
da ogni specifica branca del sapere.
La psicologia è stata esclusa poiché Comte, mettendo in discussione la
sua scientificità, sostiene che l'individuo non può raggiungere, sopra
se stesso, un punto di vista oggettivo (in quanto dovrebbe "dividersi"
in due). Ciò che vi è di scientifico nella psicologia, da un lato è
riconducibile all'esame fisiologico del cervello (cioè alla biologia)
e dall'altro all'esame del suo comportamento sociale (cioè alla sociologia).
- La sociologia costituisce, per Comte, la scienza suprema, che ha come
scopo la determinazione delle leggi della società. Per questa sua
caratteristica, essa si configura come una "fisica sociale" e si divide in
una statica, che studia l'ordine della società (e il rapporto di
interdipendenza delle sue parti) e in una dinamica, che ne studia il
progresso. Comte attribuiva alla sociologia la stessa funzione
riconosciuta da Bacone in poi alle altre scienze: quella di dominare, a
vantaggio degli uomini, le leggi scoperte. In particolare, egli credeva
che la sociologia dovesse portare alla sociocrazia (vedi).
- Sociocrazia. è uno dei termini creati da Comte per designare la fase
della società in cui il positivismo sarà divenuto regime. In altri
termini, Comte intende, per sociocrazia, quella struttura politica
fondata sulla sociologia e sulla filosofia positivista, che rappresenta
il corrispondente moderno della teocrazia medioevale, fondata sulla
teologia. In Comte tale struttura manifesta una fisionomia assolutistica
ed autoritaria avversa alle idee di libertà individuale e di pluralismo,
assimilate, dal filosofo francese, ad una forma di "anarchia".
- La dottrina della scienza di Comte trova la sua formulazione sintetica
nella formula: "scienza, donde previsione; previsione, donde azione", con
la quale il filosofo intende dire che la scienza ha come scopo lo studio
di leggi, le quali servono a prevedere i fenomeni e quindi ad agire su
di essi.
- L'ultima fase della filosofia comtiana mette capo ad una vera e propria
"religione della scienza" fondata sul culto dell'Umanità e del progresso.
N.B. Tale fase, che mette a nudo quel "romanticismo della scienza" che è
tanta parte del positivismo, non deve tuttavia essere giudicata in modo
esclusivamente negativo, in quanto essa, pur con tutte le sue ingenuità
e i suoi estremismi, fa pur sempre parte di una storica battaglia a
favore della scienza e della filantropia.
STORIA DELLA FILOSOFIA
di NICOLA ABBAGNANO
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
VOLUME TERZO
PARTE SESTA: LO SVILUPPO DELLE SCIENZE E L'AFFERMAZIONE DEL
POSITIVISMO.
CAPITOLO 14: IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO
1. Il concetto di evoluzione e il principio romantico dell'infinito.
La generalizzazione filosofica del concetto biologico di evoluzione e
l'estensione al mondo della natura del concetto della storia elaborato
dall'idealismo romantico.
L'altro indirizzo del positivismo è quello evoluzionistico. Questo
indirizzo consiste nell'assumere il concetto d'evoluzione come il
fondamento di una teoria generale della realtà naturale e nello scorgere
nell'evoluzione stessa la manifestazione di una realtà - soprannaturale o
metafisica - infinita ed ignota. Il punto di partenza di questo indirizzo
cioè il concetto di evoluzione è desunto dalla dottrina del trasformismo
biologico, quale è stata elaborata da Lamarck e Darwin: esso infatti si
presenta come la generalizzazione di tale dottrina. Ma questa
generalizzazione è condizionata dal presupposto romantico che il finito
sia la manifestazione o rivelazione dell'infinito; giacché solo in virtù
di questo presupposto, i singoli processi evolutivi, frammentariamente
accertabili dalla scienza in alcuni aspetti della natura, possono
ritenersi saldati in un processo unico, universale, continuo e
necessariamente progressivo. Sotto questo rispetto, l'evoluzionismo
positivistico è l'estensione al mondo della natura del concetto della
storia elaborato dall'idealismo romantico. Come la storia nella dottrina
di Fichte o di Schelling, così la natura nella dottrina di Spencer è un
processo di sviluppo necessario, la cui legge è il progresso.
2. La teoria dell'evoluzione: Darwin.
Se il principio romantico dell'infinito che si rivela o realizza nel
finito è la categoria tacitamente presupposta dalla filosofia
positivistica dell'evoluzione, la teoria biologica della trasformazione
della specie è il suo punto di partenza di fatto. L'evoluzionismo è
infatti una generalizzazione di questa dottrina biologica,
generalizzazione tacitamente fondata su quella categoria.
L'evoluzionismo biiologico.
Si è già visto (vedi capitolo 12) come l'evoluzionismo biologico, cioè la
dottrina che le specie animali e vegetali si trasformano l'una nell'altra,
fu concepito come semplice ipotesi da Buffon e fu poi difeso, ma senza
successo, da Lamarck e Geoffroy Saint-Hilaire. Essa non poté trionfare
nella scienza finché non fu eliminata la teoria delle catastrofi, proposta
da Cuvier, secondo la quale la terra è stata il teatro di successivi
cataclismi che ne hanno cambiato la faccia e periodicamente distrutte le
specie viventi. Quando questa teoria fu eliminata da Lyell non si
prospettava altra alternativa, per spiegare la sparizione delle specie
fossili, se non quella di ammettere che tali specie si fossero trasformate
gradualmente in quelle ora viventi. Tuttavia questa dottrina mancava di
qualsiasi dimostrazione; Darwin per primo ne dette la dimostrazione.
Nipote del naturalista Erasmo, Charles Darwin (12 febbraio 1809-19
aprile 1882) fu il tipo dello scienziato interamente dedito alle ricerche.
Dopo un viaggio per mare durato cinque anni, si dedicò a raccogliere e a
riordinare il materiale per la sua grande opera L'origine della specie
che apparve nel 1859. Il libro ebbe un successo fulmineo e la prima
edizione (più di 1.000 esemplari) si esaurì il primo giorno di vendita.
Ad esso Darwin faceva seguire quello su La variazione degli animali
e delle piante allo stato domestico (1868); e nel 1871 la Discendenza
dell'uomo. L'ultimo lavoro notevole di Darwin fu il libro sull'Espressione
delle emozioni nell'uomo e negli animali (1872) al quale seguirono
alcuni minori lavori scientifici. Nel 1887 il figlio di Darwin, Francis,
pubblicava due volumi intitolati La vita e la corrispondenza di Carlo
Darwin, che contengono anche una breve autobiografia dello scienziato e
sono indispensabili per intendere la sua personalità.
Il merito di Darwin consiste nell'aver dato una compiuta e sistematica
teoria scientifica del trasformismo biologico fondandola su un numero
enorme di osservazioni e di esperimenti, e di averla presentata proprio
nel momento in cui l'idea romantica del progresso, nata sul terreno
dell'indagine storica, si affermava nella sua massima universalità e
pareva incrollabile.
Il nucleo della teoria darwiniana.
La teoria di Darwin si fonda su due ordini di fatti:
1) l'esistenza di piccole variazioni organiche che si verificano
negli esseri viventi lungo il corso del tempo e sotto l'influenza delle
condizioni ambientali, variazioni che, in parte, per la legge della
probabilità, sono vantaggiose agli individui che le presentano;
2) la lotta per la vita che si verifica necessariamente tra gli individui
viventi per la tendenza di ogni specie a moltiplicarsi secondo una
progressione geometrica. Quest'ultimo presupposto è evidentemente desunto
dalla dottrina di Malthus. Da questi due ordini difatti segue che gli
individui presso i quali si manifestino mutamenti organici vantaggiosi
hanno maggiori probabilità di sopravvivere nella lotta per la vita; e in
virtù del principio di eredità vi sarà in essi una tendenza pronunciata a
lasciare in eredità ai loro discendenti i caratteri accidentali acquisiti.
Tale è la «legge della selezione naturale».
La legge della selezione naturale.
L'accumularsi delle piccole variazioni e la loro conservazione per mezzo
dell'eredità producono la variazione degli organismi animali che, nei suoi
termini estremi, è il passaggio da una specie ad un'altra. Ciò che l'uomo
fa per le piante e gli animali domestici producendo gradualmente le
varietà di essi che sono più utili ai suoi bisogni, la natura può ben
farlo su scala immensamente più vasta.
Dalla teoria segue che, tra le varie specie, han dovuto esistere
innumerevoli varietà intermedie che collegano strettamente tutte le
specie di uno stesso gruppo; ma evidentemente la selezione naturale ha
sterminato queste forme intermedie di cui tuttavia si possono trovare le
tracce nei residui fossili. Accanto allo studio dei fossili, quello
degli organi rudimentali, delle specie cosiddette aberranti e
dell'embriologia può condurre a determinare l'ordine progressivo degli
esseri viventi. « Se, dice Darwin, noi non possediamo né albero
genealogico, né libro d'oro, né stemmi ereditari, abbiamo, per scoprire e
seguire le tracce delle numerose linee divergenti delle nostre
genealogie naturali, l'eredità da lungo tempo conservata dei caratteri di
ogni specie». La conclusione di Darwin è nettamente ottimista: egli
crede di aver stabilito l'inevitabile progresso biologico allo stesso
modo che il romanticismo idealistico e socialistico credeva
all'inevitabile progresso spirituale. «Noi possiamo concludere con
qualche fiducia che ci è permesso di contare su un avvenire di lunghezza
incalcolabile. E come la selezione naturale agisce solamente per il bene
di ciascun individuo, ogni dono fisico o intellettuale tenderà a
progredire verso la perfezione».
L'uomo e gli animali.
L'altra opera fondamentale di Darwin, La discendenza dell'uomo, tende in
primo luogo a stabilire che «non esiste alcuna differenza fondamentale
fra l'uomo e i mammiferi più elevati per ciò che riguarda le loro facoltà
mentali ». La sola differenza tra l'intelligenza e il linguaggio
dell'uomo e quelli degli altri animali è una differenza di grado che si
spiega con la legge della selezione naturale ed anche, in parte, con la
scelta sessuale alla quale Darwin attribuisce, per l'evoluzione dell'uomo,
importanza assai maggiore che per l'evoluzione degli animali. Darwin non
crede che il riconoscimento della discendenza dell'uomo da organismi
inferiori diminuisca in qualche modo la dignità umana.
«Chi, egli dice, abbia veduto un selvaggio nella sua terra nativa non
sentirà molta vergogna se sarà obbligato a riconoscere che il sangue di
qualche creatura più umile gli scorre nelle vene. In quanto a me, vorrei
tanto essere disceso da quell'eroica scimmietta che affrontò il suo
terribile nemico per salvare la vita al suo custode o da quel vecchio
babbuino che sceso dal monte strappò trionfante il suo giovane compagno
a una muta attonita di cani, quanto da un selvaggio che si compiace di
torturare i suoi nemici, offre sacrifici di sangue, pratica
l'infanticidio senza rimorsi, tratta le sue mogli come schiave, non
conosce che cosa sia la decenza ed è dominato da grossolane superstizioni».
Darwin fu e volle essere esclusivamente uno scienziato. Solo raramente,
e, si direbbe, mal volentieri, egli si decise a esprimere le sue
convinzioni filosofiche e religiose; e sempre in linea privata, in lettere
personali non destinate alla stampa.
L'agnosticismo.
In una lettera del 1879 egli scrive: «la descrizione più esatta del mio
stato di spirito è quella dell'agnostico». Il termine agnosticismo era
stato creato nel 1869 dal naturalista Thomas Huxley (1825-1895) che era
giunto, prima della pubblicazione dell'Origine della specie, a giungere
già per suo conto alla trasformazione delle specie biologiche e che
divenne in seguito uno dei più entusiasti seguaci di Darwin.
«Il termine, dice Huxley, mi venne in mente come antitesi dello
"gnostico" della storia della chiesa che pretendeva di saperla lunga
sulle cose che io ignoravo». Esso implica, già nella mente dello Huxley,
un riferimento a quella inconcepibilità dell'Assoluto e dell'Infinito
sul quale avevano insistito Hamilton e Mansel. Un riferimento meno
esplicito esso ha nella mente di Darwin, per il quale signica
semplicemente l'impossibilità di trovare nel dominio della scienza
conferme o smentite decisive delle credenze religiose tradizionali.
La negazione della finalità della natura.
Darwin credeva tuttavia possibile negare decisamente ogni « intenzione »
della natura, cioè ogni causa finale, e metteva in luce a questo
proposito l'esistenza del male e del dolore. Ma era convinto che «l'uomo
sarà nel futuro una creatura assai più perfetta di quel che è attualmente»;
e in realtà le sue convinzioni scientiche e l'intera struttura
sistematica della sua teoria dell'evoluzione si fondano sul presupposto
dell'idea del progresso che dominava il clima romantico dell'epoca.
Attraverso l'opera di Darwin, la scienza ha inserito l'intero
mondo degli organismi viventi nella storia progressiva dell'universo.
Il darwinismo sociale.
Carattere prevalentemente ideologico ebbe invece il cosiddetto
darwinismo sociale, che estendendo dalla natura alla società il concetto
di « selezione» e di «lotta per l'esistenza » pervenne alla
giustificazione delle discriminazioni razziste e classiste esistenti nel
mondo umano. Infatti, secondo questa teoria, la società si dividerebbe
in «adatti» e «non-adatti», in «forti» e «deboli», e i primi avrebbero la
prerogativa naturale di dominare i secondi.
3. Spencer.
3.1. Vita e scritti.
L'epoca era dunque propizia per una teoria del progresso che non lo
restringesse al destino dell'uomo nel mondo, ma lo estendesse al mondo
intero, nella totalità dei suoi aspetti. Elaborare la dottrina del
progresso universale e mettere in luce il valore infinito quindi
religioso (per quanto solo misteriosamente religioso) del progresso,
fu il compito che si assunse Spencer, diffondendo nel marzo del 1860
il prospetto di un vastissimo Sistema di filosofia sintetica.
Herbert Spencer (1820-1903) era nato nel 1820 a Derby in Inghilterra e
divenne ingegnere delle ferrovie a Londra. Pubblicò dapprima solo alcuni
articoli politici ed economici; nel 1845, avuta una piccola eredità,
obbedì alla sua vocazione filosofica e abbandonò la carriera
dell'ingegnere per dedicarsi alla sua attività di scrittore. Appartenne
dal 1848 al 1853 alla Redazione dell'«Economist». Il primo risultato
della sua attività furono i Princìpi di psicologia pubblicati nel 1855.
Nel 1857 pubblicava un saggio sul progresso (Il progresso, sua legge e
sua causa) che è molto significativo per il suo orientamento
fondamentale. E nel 1862 usciva il primo volume del Sistema di filosofia
sintetica progettato nel 1860, Primi princìpi, che è il suo scritto
filosofico fondamentale. Seguivano i due volumi dei Princìpi di biologia
(1864-1867); e in seguito: Princìpi di psicologia e Princìpi di
sociologia. A queste opere vanno aggiunti numerosi altri scritti
collaterali.
Il progresso come fatto universale cosmico.
Nell'articolo sul progresso del 1857 (poi raccolto nei Saggi), che è il
primo abbozzo del suo sistema, si può cogliere chiaramente l'ispirazione
fondamentale dell'evoluzionismo di Spencer: questo doveva servire a
giustificare, nella sua legge e nella sua causa fondamentale, il
progresso, inteso come fatto universale e cosmico. «Sia che si tratti,
diceva Spencer, dello sviluppo della terra, dello sviluppo della vita
alla sua superficie, dello sviluppo della società, del governo,
dell'industria, del commercio, del linguaggio, della letteratura, della
scienza, dell'arte, sempre il fondo di ogni progresso è la stessa
evoluzione che va dal semplice al complesso attraverso differenziazioni
successive. Dai più antichi mutamenti cosmici di cui vi sia traccia,
fino agli ultimi risultati della civiltà, noi vedremo che la
trasformazione dell'omogeneo in eterogeneo è l'esistenza stessa del
progresso». Nello stesso articolo veniva prospettato il carattere divino
e perciò religioso della realtà velata, più che rivelata, dal progresso
cosmico. Questo carattere è il punto di partenza dei Primi princìpi.
3.2. La dottrina dell'Inconoscibile e i rapporti fra scienza e religione.
La religione e il mistero.
La prima parte del capolavoro di Spencer s'intitola «L'Inconoscibile». Essa
tende a dimostrare l'inaccessibilità della realtà ultima ed assoluta, ma
nello stesso tempo vien fatta servire da Spencer a dimostrare la
possibilità di un incontro e di una conciliazione tra la religione e la
scienza. Religione e scienza infatti hanno entrambe la loro
base nella realtà del mistero e non possono essere inconciliabili. Ora
la verità ultima inclusa in ogni religione è che «l'esistenza
del mondo con tutto ciò che contiene e con tutto ciò che lo circonda è
un mistero che sempre esige di essere interpretato» (Primi princìpi,
paragrafo 14). Tutte le religioni falliscono nel dare
quest'interpretazione: le diverse credenze in cui esse si esprimono non
sono logicamente difendibili. Attraverso lo sviluppo della religione perciò
il mistero viene sempre meglio riconosciuto come tale; sicché l'essenza
della religione si può riconoscere nel convincimento che la forza che si
manifesta nell'universo è completamente imperscrutabile.
La scienza e il mistero.
Dall'altro lato, anche la scienza urta contro il mistero che avvolge la
natura ultima della realtà di cui essa studia le manifestazioni. Che cosa
siano il tempo e lo spazio, la materia e la forza, quale sia la durata
della coscienza - se finita o infinita - e che cosa sia il soggetto stesso
del pensiero, sono per la scienza enigmi impenetrabili. Le idee
scientifiche ultime sono tutte rappresentative di realtà che non possono
essere comprese.
La relatività della conoscenza umana e l'Inconoscibile.
Ciò accade perché la nostra conoscenza, come Hamilton e Mansel hanno
chiarito (William Hamilton (1788-1856) ed Henry Mansel (1820-1871) sono due
filosofi inglesi che avevano affermato la relatività della conoscenza
umana e l'inconcepibilità dell'Assoluto.), è chiusa entro i limiti
del relativo. Certamente, per mezzo della scienza, essa progredisce e
si estende incessantemente. Ma questo progresso consiste nell'includere
verità speciali in verità generali e verità generali in verità ancora
più generali; sicché ne segue che la verità più generale, la quale non
ammette inclusioni in una verità ulteriore, non è comprensibile ed è
destinata a rimanere un mistero. Spencer ammette quindi senz'altro la
tesi di Hamilton e Mansel, secondo la quale l'assoluto, l'incondizionato,
l'infinito (o comunque si chiami il principio supremo della realtà) è
inconcepibile per l'uomo, data la relatività costitutiva della sua
conoscenza. Egli tuttavia non si ferma al concetto negativo dell'assoluto,
qual era stato difeso da quei due pensatori, poiché concepisce l'assoluto
come la forza misteriosa che si manifesta in tutti i fenomeni naturali e
la cui azione è sentita dall'uomo positivamente. Non è possibile tuttavia
definire o conoscere ulteriormente questa forza.
La conciliazione fra scienza e religione.
Còmpito della religione sarà quello di richiamare l'uomo al mistero della
causa ultima; e còmpito della scienza sarà quello di estendere
incessantemente la conoscenza dei fenomeni. Religione e scienza sono così
necessariamente correlative. Il riconoscimento della forza imperscrutabile
è il limite comune che le concilia e le rende solidali.
A questo limite, la scienza arriva inevitabilmente in quanto raggiunge i
suoi confini e la religione in quanto vi è irresistibilmente indirizzata
dalla critica. L'uomo ha tentato sempre e tenterà ancora di costruire
simboli che gli rappresentino la forza sconosciuta dell'universo. Ma
continuamente e sempre egli si renderà conto dell'inadeguatezza di questi
simboli. Sicché i suoi continui sforzi e le sue continue disfatte
possono servire a dargli il dovuto senso della differenza
incommensurabile che c'è tra il condizionato e l'incondizionato e ad
avviarlo alla più alta forma della saggezza, al riconoscimento
dell'inconoscibile come tale.
Il fenomeno e l'Inconoscibile.
Che la scienza sia limitata al fenomeno non significa, per Spencer, che
essa sia confinata nell'apparenza. Il fenomeno non è l'apparenza: è
piuttosto la manifestazione dell'Inconoscibile. Spencer ammette il
principio che «le impressioni persistenti, essendo i risultati
persistenti in una causa persistente, sono praticamente identiche per
noi alla causa stessa e possono essere abitualmente trattate come suoi
equivalenti» (ivi, par. 46).
In virtù di questo principio, lo spazio, il tempo, la materia, il
movimento, la forza, nozioni tutte persistenti e immutabili, devono
essere considerate come prodotte in qualche modo dallo stesso
Inconoscibile. Esse non sono certamente identiche con l'Inconoscibile, né
sono modi di esso: sono «effetti condizionati della causa
incondizionata». Tuttavia corrispondono a un modo d'essere o d'agire, per
noi sconosciuto, di questa causa; e in questo senso sono reali.
Il «realismo trasfigurato».
Spencer chiama realismo trasfigurato questa corrispondenza ipotetica tra
l'Inconoscibile e il suo fenomeno. «Il noumeno e il fenomeno sono qui
presentati nella loro relazione primordiale come i due lati dello stesso
mutamento di cui siamo obbligati a considerare il secondo non meno reale
che il primo».
3.3. La teoria dell'evoluzione.
Tra la religione alla quale spetta il riconoscimento dell'Inconoscibile,
e la scienza alla quale spetta l'intero dominio del conoscibile, quale
posto ha la filosofia? Spencer la definisce come la conoscenza nel suo
più alto grado di generalità. La scienza è conoscenza parzialmente
unificata; la filosofia conoscenza completamente unificata.
La filosofia come teoria dell'evoluzione.
Le verità della filosofia stanno alle verità scientifiche più alte come
queste stanno alle verità scientifiche più basse; sicché le generalizzazioni
della filosofia comprendono e consolidano le più vaste generalizzazioni
della scienza. La filosofia è il prodotto finale di quel processo che
comincia con la raccolta di osservazioni isolate e termina con le
proposizioni universali. Essa perciò deve assumere come suo proprio
materiale e punto di partenza i princìpi più vasti e più generali ai
quali la scienza è giunta.
Tali princìpi sono: l'indistruttibilità della materia, la continuità del
movimento, la persistenza della forza - con tutte le loro conseguenze fra
le quali è la legge del ritmo cioè dell'alternarsi dell'elevazione, e della
caduta nello sviluppo di tutti i fenomeni. La formula sintetica che
questi princìpi generali richiedono è una legge che implica la continua
ridistribuzione della materia e della forza. Tale è, secondo Spencer, la
legge dell'evoluzione la quale significa che la materia passa da uno
stato di dispersione a uno stato di integrazione (o concentrazione),
mentre la forza che ha operato la concentrazione si dissipa. La
filosofia è dunque essenzialmente una teoria dell'evoluzione.
I caratteri dell'evoluzione.
I Primi princìpi definiscono la natura e i caratteri generali
dell'evoluzione: le altre opere di Spencer studiano il processo evolutivo
nei diversi domini della realtà naturale. La prima determinazione
dell'evoluzione è che essa è un passaggio da una forma meno coerente a una
forma più coerente. Il sistema solare (che è sorto da una nebulosa), un
organismo animale, una nazione, mostrano nel loro sviluppo questo
passaggio da uno stato di disgregazione a uno stato di coerenza e di
armonia crescenti. Ma la determinazione fondamentale del processo
evolutivo è quello che lo caratterizza come un passaggio dall'omogeneo
all'eterogeneo. Questa caratterizzazione è suggerita a Spencer dai
fenomeni biologici. Ogni organismo, pianta o animale, si sviluppa
attraverso la differenziazione delle sue parti: che da principio sono,
chimicamente o biologicamente, indistinte, poi si differenziano a
formare tessuti e organi diversi. Spencer ritiene questo processo
proprio di ogni sviluppo in qualsiasi campo della realtà: nel
linguaggio, dapprima costituito da semplici esclamazioni e suoni
inarticolati e poi differenziantisi in parole diverse; come nell'arte
che, a partire dai popoli primitivi, si va sempre più dividendo nelle
sue branche (architettura, pittura, scultura, arti pratiche) e nelle sue
direzioni. Infine l'evoluzione implica anche un passaggio dall'indefinito
al definito: indefinita è per esempio la condizione di una tribù selvaggia
in cui non c'è specificazione di còmpiti e di funzioni, definita quella
di un popolo civile, fondata sulla divisione del lavoro e delle classi
sociali.
La definizione globale dell'evoluzione.
Spencer dà quindi dell'evoluzione questa formula definitiva
(ivi, paragrafo 145): «L'evoluzione è un'integrazione di materia e una
concomitante dissipazione di movimento; durante la quale la materia
passa da un'omogeneità indefinita e incoerente ad un'eterogeneità definita
e coerente; e durante la quale il movimento conservato soggiace ad una
trasformazione parallela».
Il necessitarismo e l'ottimismo.
L'evoluzione è un processo necessario. L'omogeneità, che è il suo punto di
partenza, è uno stato instabile che non può durare e deve trapassare
nell'eterogeneità per raggiungere l'equilibrio. Perciò l'evoluzione deve
cominciare; una volta cominciata deve continuare perché le parti rimaste
omogenee tendono, a loro volta, per la loro instabilità, verso
l'eterogeneità. Il senso di questo processo necessario e continuo è
ottimistico. Spencer ammette che, per la legge del ritmo, l'evoluzione e
la dissoluzione devono alternarsi. Ma ritiene che la dissoluzione, là
dove si verifica, è la premessa di un'evoluzione ulteriore. Per ciò che
riguarda l'uomo, l'evoluzione deve determinare una crescente armonia tra
la sua natura spirituale e le condizioni di vita. «E questa è, dice
Spencer (ivi, paragrafo 176), la garanzia per credere che l'evoluzione
può terminare solo con lo stabilirsi della più grande perfezione e
della più completa felicità».
3.4. Biologia, psicologia e teoria della conoscenza.
La vita come adattamento.
Le opere dedicate da Spencer alla biologia, alla psicologia, alla
sociologia ed all'etica costituiscono l'applicazione del principio
evolutivo al campo di queste scienze. La biologia è, per Spencer, lo
studio dell'evoluzione dei fenomeni organici e della sua causa. La vita
consiste nella combinazione di fenomeni diversi, contemporanei e
successivi, la quale si verifica in corrispondenza con
mutamenti contemporanei o successivi dell'ambiente esterno. Essa
perciò consiste essenzialmente nella funzione dell'adattamento; e
appunto attraverso questa funzione si formano e si differenziano gli
organi, per l'esigenza di sempre meglio rispondere alle sollecitazioni
dell'esterno.
Spencer dà così il primo posto, nella trasformazione degli organismi
viventi, al principio di Lamarck della funzione che crea l'organo; ma
riconosce l'azione del principio darwiniano della selezione naturale (che
egli chiama «sopravvivenza del più adatto», che però non può agire se
non attraverso l'adattamento all'ambiente e quindi lo sviluppo funzionale
degli organi. Soprattutto egli insiste sulla conservazione e
sull'accumulazione dei mutamenti organici individuali per opera
dell'ereditarietà; e concepisce il progresso della vita organica come
l'adattamento crescente degli organismi all'ambiente dovuto all'accumularsi
delle variazioni funzionali che sempre meglio rispondono ai requisiti
ambientali.
La coscienza.
La coscienza è uno stadio di questo adattamento, ed anzi la sua fase
decisiva. Spencer non ammette la risoluzione integrale della coscienza
nelle impressioni o nelle idee, secondo l'insegnamento tradizionale
dell'empirismo inglese. La coscienza presuppone un'unità, una forza
originaria, quindi una sostanza spirituale che sia la sede di questa
forza. Ma, come si verifica per la sostanza e per la forza materiale,
anche la sostanza e la forza spirituale sono, nella loro ultima natura,
inconoscibili; e la psicologia deve limitarsi a studiarne le
manifestazioni.
La psicologia.
Tuttavia una psicologia è possibile come scienza autonoma; e Spencer si
allontana dalla tesi di Comte che l'aveva negata. C'è una psicologia
oggettiva la quale studia i fenomeni psichici nel loro substrato
materiale; e c'è una psicologia soggettiva, fondata sull'introspezione che
«costituisce una scienza completamente a parte, unica nel suo genere,
indipendente da tutte le altre scienze e antiteticamente opposta a
ciascuna di esse». Soltanto la psicologia soggettiva può contribuire a
determinare lo sviluppo evolutivo dei processi del pensiero. Tale
sviluppo si spiega tuttavia come ogni altro sviluppo; è un processo di
adattamento graduale che va dall'azione riflessa, che è la prima fase
della psichicità, attraverso l'istinto e la memoria, sino alla ragione.
Ciò che è a priori per l'individuo è a posteriori per la specie.
Per ciò che riguarda la ragione, Spencer ammette che vi siano nozioni o
verità a priori nel senso di essere indipendenti dall'esperienza puntuale
e temporanea dell'individuo; e in tal senso riconosce la parziale
legittimità delle dottrine «aprioristiche», come quelle di Leibniz e
Kant. Ma ciò che in questo senso è a priori per l'individuo, non lo è per
la specie umana, giacché è prodotto dall'esperienza accumulata dalla
specie stessa attraverso un lunghissimo periodo di sviluppo e fissata e
resa ereditaria nella struttura organica del sistema nervoso.
3.5. Sociologia e politica.
Pur utilizzando alcuni risultati della sociologia di Comte ed accettando
il nome della scienza che Comte aveva inventato, Spencer modifica
radicalmente il concetto di essa.
Il compito della sociologia
Per Comte, essa è infatti la disciplina che, accertando le leggi dei fatti
sociali, consente di prevederli e guidarli; il fine della sociologia è la
sociocrazia, la fase della società in cui il positivismo sarà diventato
regime. Per Spencer invece la sociologia deve limitarsi al còmpito
puramente descrittivo dello sviluppo della società umana sino al punto in
cui esso è giunto finora. Essa può bensì determinare le condizioni alle
quali lo sviluppo ulteriore dovrà soddisfare; ma non le mète e gli ideali di
esso. Determinare le mète, cioè stabilire quale debba essere l'uomo
ideale in una ideale società, è il còmpito della morale. Sociologia e
morale, che facevano tutt'uno nell'opera di Comte, vengono così distinte da
Spencer.
La difesa dell'individuo e della libertà.
La sociologia determina le leggi dell'evoluzione super-organica e
considera la stessa società umana come un organismo, i cui elementi sono
prima le famiglie, poi gli individui singoli. La sociologia di Spencer è
nettamente orientata verso l'individualismo e quindi verso la difesa di
tutte le libertà individuali, in contrasto con la sociologia di Comte e
in generale con l'indirizzo sociale del positivismo. Uno dei temi
principali, sia dei Princìpi di sociologia sia di altre opere
collaterali (L'uomo contro lo stato, 1884; Statica sociale, 1892), tema
che domina da un capo all'altro la sociologia di Spencer, è il principio
che lo sviluppo sociale dev'essere abbandonato alla forza spontanea che
lo presiede e lo muove verso il progresso e che l'intervento dello Stato
nei fatti sociali non fa che disturbare od ostacolare questo sviluppo.
La gradualità dello sviluppo sociale.
Il concetto di uno sviluppo sociale lento, graduale e inevitabile, rende
Spencer estremamente alieno da quelle idee di riforma sociale che erano
state accarezzate dal positivismo sociale, compresi in esso gli
utilitaristi e Stuart Mill. «Allo stesso modo che non si può abbreviare
la via tra l'infanzia e la maturità, evitando quel noioso processo di
accrescimento e di sviluppo che si opera insensibilmente con lievi
incrementi, così non è possibile che le forme sociali più basse
divengano più elevate, senza attraversare piccole modificazioni
successive». Perciò ogni tentativo di bruciare le tappe dell'evoluzione
storica, ogni sogno di visionari o di utopisti, ha come unico risultato
quello di ritardare o sconvolgere il processo naturale dell'evoluzione
sociale. Ciò non implica, secondo Spencer, che l'individuo debba
passivamente abbandonarsi al corso naturale degli eventi. Lo stesso
sviluppo sociale ha determinato il passaggio da una fase di cooperazione
umana costrittiva ed imposta ad una fase di cooperazione più libera e
spontanea.
Dal regime militare a quello industriale.
è questo il passaggio dal regime militare contrassegnato
dalla prevalenza del potere statale sugli individui ai quali esso impone
còmpiti e funzioni, al regime industriale che è fondato invece
sull'attività indipendente degli individui, e perciò li determina a
rafforzare le loro esigenze e a rispettare le esigenze degli altri,
rinvigorendo la coscienza dei diritti personali e deliberandoli a
resistere agli eccessi del controllo statale. Spencer tuttavia non
ritiene definitivo il regime industriale (nel quale peraltro la società
attuale è appena entrata).
La possibilità di un terzo tipo sociale.
è possibile prospettarsi la possibilità di un terzo tipo sociale, il quale,
pur essendo fondato come quello industriale sulla libera cooperazione
degli individui, ponga moventi altruistici al posto dei moventi egoistici
che reggono il regime industriale; o, meglio ancora, concili insieme
altruismo ed egoismo. Ma questa possibilità non può essere prospettata
dalla sociologia, sebbene soltanto dall'etica.
3.6. L'etica evoluzionistica.
L'etica di Spencer è sostanzialmente un'etica biologica. che ha per oggetto
la condotta dell'uomo, cioè l'adattamento progressivo dell'uomo stesso
alle sue condizioni di vita. Questo adattamento implica non solo un
prolungamento della vita stessa ma la sua maggiore intensità e ricchezza.
Tra la vita di un selvaggio e quella di un uomo civile non c'è solo
una differenza di lunghezza ma anche di estensione: quella dell'uomo civile
implica il raggiungimento di fini assai più svariati e ricchi, che la
rendono più intensa ed estesa. Questa crescente intensità è ciò che si deve
intendere per felicità. Poiché è buono ogni atto che è adatto al suo
fine, la vita che si presenta nel suo complesso meglio adatta alle sue
condizioni è anche la vita più felice e piacevole.
Sebbene il fine ultimo e indiretto della moralità sia l'utile collettivo,
il movente diretto di essa è il dovere.
Per questo, il bene si identifica col piacere; e la morale edonistica o
utilitaristica è, sotto un certo aspetto, l'unica possibile. Spencer
tuttavia non ammette l'utilitarismo nella forma che esso aveva assunto
ad opera di Bentham edei due Mill. Il movente dichiarato e consapevole
dell'agire morale dell'uomo non è e non può essere l'utilità. L'evoluzione
sociale, accumulando con l'eredità un enorme numero di esperienze morali che
rimangono inscritte nella struttura organica dell'individuo, fornisce
all'individuo stesso un a priori morale, che tale è per lui sebbene tale
non sia per la specie.
Carattere «acquisito» del dovere.
Si deve ammettere che l'uomo singolo agisca per dovere, per un sentimento
di obbligazione morale; ma l'etica evolutiva dà conto del sorgere di
questo sentimento, mostrando come esso nasca dalle esperienze ripetute e
accumulate attraverso il succedersi di innumerevoli generazioni. Queste
esperienze hanno prodotto la coscienza che i sentimenti che si
riferiscono a risultati lontani e generali sono di solito più utili per
raggiungere il benessere di quelli che devono essere immediatamente
soddisfatti; e hanno trasformato la coazione esterna politica, religiosa
e sociale in un sentimento di coazione puramente interiore ed autonomo.
Con il tempo, il dovere cesserà di essere qualcosa di coattivo e
diventerà qualcosa di spontaneo.
Ma questa stessa considerazione evolutiva dimostra pure che il senso del
dovere e dell'educazione morale è transitorio e tende a diminuire col
crescere della moralità. Anche ora accade che il lavoro, che dev'essere
imposto al ragazzo come un obbligo, è una manifestazione spontanea
dell'uomo d'affari immerso nelle sue faccende. Così il mantenimento e la
protezione della moglie da parte del marito, l'allevamento dei figli da
parte dei genitori, non hanno il più delle volte alcun elemento
coattivo, ma sono còmpiti che si eseguono con perfetta spontaneità e
piacere. Spencer prevede perciò che «col completo adattamento allo stato
sociale, quell'elemento della coscienza morale, che è espresso dalla
parola obbligazione, scomparirà del tutto. Le azioni più elevate,
richieste per lo svolgimento armonico della vita, saranno fatti così
comuni come lo sono ora quelle azioni inferiori a cui ci spinge il
semplice desiderio». Questa fase finale dell'evoluzione morale non
implica la prevalenza assoluta dell'altruismo a spese dell'egoismo.
Il finale accordo fra altruismo ed egoismo.
L'antitesi tra egoismo e altruismo è naturale nella condizione presente
che è caratterizzata dal prevalere indebito delle tendenze egoistiche e
nella quale perciò l'altruismo assume la forma di un sacrificio di queste
tendenze. Ma l'evoluzione morale, facendo sempre più coincidere la
soddisfazione del singolo col benessere e la felicità altrui (nel che
propriamente consiste la simpatia), provocherà l'accordo finale
dell'altruismo e dell'egoismo.
3.7. «Fortuna» e «sfortuna» di Spencer.
L'iniziale successo e la posteriore sfortuna.
La vicenda culturale di Spencer è forse la più paradossale della
filosofia moderna. Mentre altri filosofi hanno avuto scarso
successo all'inizio e molta fortuna più tardi (Schopenhauer, Kierkegaard,
Nietzsche eccetera), Spencer ha avuto molto successo all'inizio ed una
pressoché totale sfortuna in seguito.
Il Sistema di fifilosofia sintetica, che è stato definito «la Bibbia del
positivismo» della seconda metà dell'Ottocento, lo ha reso ben
presto il più celebre filosofo dei suoi tempi e l'interprete più
«sistematico » ed « enciclopedico » della Weltanschauung evoluzionista.
Tant'è vero che i Primi princìpi furono tradotti, in poco tempo, in quasi
tutte le lingue europee (anche in russo), e quando lo zar Alessandro secondo
si recò a Londra ed espresse il desiderio di conoscere le personalità
più famose e le menti più illustri dell'Occidente, Spencer fu tra i primi
invitati da Lord Derby. L'importanza storica di Spencer è consistita
nel fare del concetto di «evoluzione» una categoria generale di
interpretazione della realtà. Il suo limite -agli occhi dei posteri - è
stato quello di averne fornito una presentazione più « metafisica » che
scientifica.
Importanza storica di Spencer.
Questo spiega perché, con la crisi del Positivismo, la notorietà di
Spencer si sia completamente eclissata. Anche in Italia, dove, grazie ad
Ardigò, ha conosciuto notevole fama, Spencer ha avuto la stessa sorte.
Tant'è vero che l'ultima edizione dei Primi princìpi risale ai primi del
Novecento (Mentre i Primi princìpi ormai si trovano solo nelle biblioteche,
i Princìpi di sociologia sono stati editi recentemente, a cura di F.
Ferrarotti, presso la Utet, Torino 1968.). La stessa bibliografia su
questo autore (come si può verificare alla fine del capitolo) è molto
scarsa.
Eppure, l'importanza storica di Spencer è fuori di dubbio, e
parte della cultura del secondo Ottocento non sarebbe comprensibile
senza il riferimento alla sua sintesi portentosa, nella quale, come
scrive M. Toscano, egli «ha obbligato termini opposti ad una
convergenza che riteneva dinamica: religione e scienza, filosofia e
scienze, conoscenza e morale, natura e cultura, necessità e libertà,
materia e spirito, inorganico e organico, immanente e trascendente, uomo
e ambiente, individuo e Stato, razionale e irrazionale, inerzia ed
energia, felicità ed infelicità, pace e guerra, barbarie e civiltà... »
(M. Toscano, Malgrado la storia. Per una lettura critica di Herbert
Spencer, Feltrinelli, Milano 1980, pagina 12).
4. Ardigò.
Il positivismo evoluzionistico trovò in Italia un vigoroso difensore
nella persona di Roberto Ardigò, che esercitò notevole influenza sul
clima filosofico italiano degli ultimi decenni dell'Ottocento.
Vita e opere.
Nato a Casteldidone (Cremona) nel 1828, Ardigò fu prete cattolico e
svestì l'abito a 43 anni (nel 1871) quando ritenne incompatibile con esso
le convinzioni positivistiche che si erano andate maturando lentamente
in lui. Nel 1881 veniva chiamato a insegnare storia della filosofia
nell'Università di Padova. Ardigò moriva di sua mano a Padova nel 1920,
quando il clima filosofico italiano si era già orientato verso
quell'idealismo che egli aveva negli ultimi anni tenacemente combattuto.
Il suo primo scritto è un saggio su Pietro Pomponazzi (1869) nel quale
egli vede un precursore del positivismo . Seguirono: La psicologia come
scienza positiva (1870); La formazione naturale nel fatto del sistema
solare (1877); La morale dei positivisti (1879); Sociologia (1879);
Il fatto psicologico della percezione (1882) Il vero (1891); Scienza
dell'educazione (1893); La ragione (1894); L'unità della coscienza (1898);
La dottrina spenceriana dell'inconoscibile (1899); ed altri numerosi
saggi di chiarimento e di polemica che illustrano, senza mutarli, i
capisaldi contenuti negli scritti principali citati.
Analogie con Spencer.
La dottrina di Ardigò è analoga a quella di Spencer: come
Spencer, Ardigò ritiene che la filosofia si riduca
all'organizzazione logica dei dati scientifici; come Spencer, ammette che
questa organizzazione si faccia in virtù del principio dell'evoluzione;
come Spencer, infine, ritiene che i dati fondamentali della filosofia,
il soggetto e loggetto, l'io e il mondo esterno, non sono due realtà
opposte ma due diverse organizzazioni dello stesso contenuto psichico
(secondo la dottrina che Hume aveva fatto prevalere nell'empirismo inglese).
Differenze da Spencer.
Da Spencer, Ardigò si distingue veramente in due punti: nella negazione
dell'inconoscihile e nella diversa determinazione del concetto
dell'evoluzione; ed entrambi questi punti sono fondati sull'impostazione
empirico-psicologica della sua dottrina. Innanzitutto Ardigò rigetta quel
ragionamento che risale dalla relatività della conoscenza umana alla
necessità dell'incondizionato, che Spencer aveva accettato da Hamilton.
Ogni conoscenza particolare è relativa, ma ciò non dice che sia relativa
la conoscenza nella sua totalità. Le conoscenze singole si trovano
infatti concatenate insieme in modo che l'una è relativa all'altra; ma
da questa concatenazione nessuna illazione può scaturire sulla relatività
della conoscenza totale che ne risulta.
L'Inconoscibile è semplicemente il non ancora noto.
Per conseguenza, l'inconoscibile non è l'assoluto o l'incondizionato che è
al di là della conoscenza umana e la sorregge, ma è piuttosto l'ignoto,
vale a dire ciò che non è ancora diventato conoscenza distinta. Già queste
considerazioni fanno sorgere il concetto di un indistinto, cioè di un
alcunché avvertito confusamente o genericamente, che tuttavia sollecita
il pensiero verso l'analisi e quindi verso una conoscenza articolata e
distinta.
L'evoluzione come passaggio dall'indistinto al distinto.
Ora appunto questo passaggio dall'indistinto al distinto è ciò che
costituisce l'evoluzione, o come Ardigò dice, la «formazione naturale» di
ogni tipo o forma della realtà. Mentre Spencer aveva desunto dalla biologia
il suo concetto dell'evoluzione come passaggio dall'omogeneo
all'eterogeneo, Ardigò preferisce definire l'evoluzione in termini
psicologici o di coscienza. L'indistinto è tale relativamente, cioè
rispetto a un distinto che ne deriva; così ogni distinto è a sua volta un
indistinto per il distinto successivo perché è ciò che produce, sollecita
e spiega tale distinto. Ogni formazione naturale, nel sistema solare come
nello spirito umano, è un passaggio dall'indistinto al distinto; questo
passaggio avviene necessariamente e incessantemente, secondo un ordine
immutabile, regolato da un ritmo costante, cioè da un alternarsi armonico di
periodi. Però il distinto non esaurisce mai l'indistinto che permane al
di sotto di esso e risorge al di là di esso; e poiché il distinto è il
finito, bisogna ammettere, al di là del finito, l'infinito come
indistinto. Ogni formazione naturale, compreso il pensiero umano, è una
« meteora» che, nata dall'indistinto, finirà di nuovo per tuffarsi
nell'indistinto e perdervisi dentro.
Il caso.
Un'attenuazione del determinismo rigoroso che il positivismo ammette in
tutti i processi naturali è introdotta da Ardigò con la dottrina del
caso. L'ordine complessivo dell'universo presuppone infiniti ordini
possibili, e il verificarsi dell'uno o dell'altro di essi è dovuto al
caso. Ciò accade perché un avvenimento è in generale il prodotto
dell'intersecazione, in un dato punto del tempo, di serie causali diverse
e divergenti; e sebbene ognuna di queste serie sia necessaria e
determinata, l'incontro di esse non è tale. Il pensiero umano è uno di
questi prodotti casuali dell'evoluzione cosmica. L'azione del caso
determina l'imprevedibilità e l'indeterminazione relative di tutti gli
avvenimenti naturali, ivi comprese le azioni umane.
L'origine della morale.
Gli scritti morali di Ardigò sono essenzialmente una polemica contro
ogni forma di etica religiosa, spiritualistica e razionalistica e
ripetono il tentativo fatto da Spencer di ricondurre la formazione delle
idee morali dell'uomo a fattori naturali e sociali. Secondo Ardigò, le
idealità e le massime della morale nascono dalla reazione della società
agli atti che la danneggiano; reazione che colpendo l'individuo finisce
per fissarsi nella sua coscienza come norma o imperativo morale. I
caratteri interiori del dovere, la sua obbligatorietà, la sua
trascendenza, e la responsabilità che gli è connessa, sono dovuti perciò
all'interiorizzazione progressiva, attraverso l'esperienza ripetuta e
costante, delle sanzioni esterne che l'atto immorale incontra nella
società, in quanto atto antisociale.
5. Sviluppi agnostici, materialistici e spiritualistici del positivismo.
Nel positivismo evoluzionistico culmina la concezione meccanica del
mondo. Esso difatti non è altro che la giustificazione metafisica di
questa concezione. La spiegazione meccanica esige che tutti i fenomeni
siano spiegati in termini di materia, di forza e di leggi necessarie;
l'evoluzionismo dimostra (o crede di dimostrare) che così deve essere,
dal momento che dalla materia, dalla forza e dalle loro leggi necessarie
derivano, per un processo continuo di evoluzione, tutti gli aspetti
della realtà, la vita biologica, la vita psichica, la vita sociale.
Tuttavia la stretta connessione delle forme superiori di vita con le
forme inferiori e la loro dipendenza necessaria da queste ultime non
implica la loro riduzione totale a queste ultime. Che anche le forme
superiori della vita spirituale si trovino sulla stessa linea evolutiva
dei fenomeni bruti e dipendano dalle stesse leggi, non è una tesi che
implica necessariamente il materialismo, cioè la pura e semplice
identità tra fenomeni materiali e fenomeni spirituali. La stessa
dottrina di Spencer, come si è visto, è ugualmente lontana dal
materialismo e dallo spiritualismo.
Agnostici e materialisti.
Questa posizione di equilibrio non fu mantenuta da tutti. Accanto a
quelli che la mantennero e che si chiamarono, col termine adoperato da
Darwin e da Huxley, agnostici, ci furono quelli che interpretarono
l'evoluzionismo o in senso materialistico o in senso spiritualistico. Nel
1880 il fisiologo tedesco Emil Du Bois-Reymond (1818-1896) enumerava Sette
enigmi del mondo: 1) L'origine della materia e della forza. 2) L'origine
del movimento. 3) Il sorgere della vita. 4) L'ordinamento finalistico
della natura. 5) Il sorgere della sensibilità e della coscienza. 6) Il
pensiero razionale e l'origine del linguaggio. 7) La libertà del volere.
Di fronte a questi enigmi, Du Bois-Reymond ribadiva l'agnosticismo
affermando che gli uomini dovrebbero pronunciare non solo un ignoramus,
ma anche un ignorabimus: la scienza non potrà mai risolverli.
Haeckel.
Ebbe invece la pretesa di risolverli col materialismo il biologo tedesco
Ernst Haeckel (1834-1919). Nel 1866 Haeckel aveva pubblicato la
Morfologia generale degli organismi che adduceva un gran numero di
osservazioni e di fatti in sostegno della teoria darwiniana
dell'evoluzione ed era il primo tentativo di estendere questa teoria a
tutte le forme organiche. Nella Storia della creazione naturale (1868)
egli esprimeva la cosiddetta «legge biogenetica fondamentale», secondo
la quale c'è un perfetto parallelismo tra lo sviluppo dell'embrione
individuale e lo sviluppo della specie a cui esso appartiene. Per ciò
che riguarda l'uomo, l'ontogenesi ossia lo sviluppo dell'individuo è una
breve rapida ripetizione (una ricapitolazione) della filogenesi o
evoluzione della stirpe a cui l'uomo appartiene. Questa legge, secondo
Haeckel, bastava a dimostrare la continuità e l'unità dello sviluppo
organico, nel senso che tutti gli organismi viventi trovavano posto per
essa in un solo albero genealogico. Ma questa continuità egli volle
estenderla a tutta la realtà, considerando l'intero universo come un
unico processo di evoluzione retto dalla legge della conservazione della
materia. Nello scritto Gli enigmi del mondo (1899) che ebbe una
diffusione enorme, egli volle dimostrare che tutte le fasi della realtà
sono prodotte dall'evoluzione progressiva della materia, mediante la
diversa organizzazione degli atomi. Egli concepiva però gli atomi come
già dotati di movimento e sensibilità (picnatomi); ed affermava
energicamente l'unità dello spirito e della materia, sino a farsi
banditore di una «religione monistica» fondata sull'identità di Dio con
la natura, religione che pareva dovesse definitivamente soppiantare le
vecchie religioni dualistiche fondate sulla spiritualità di Dio, la
libertà e l'immortalità dell'anima.
Lombroso.
Questo materialismo evoluzionistico, permeato di spirito romantico, ebbe
per qualche decennio un gran successo e trovò in tutti i paesi
rappresentanti e difensori. In Italia il positivismo materialistico
trovava una manifestazione singolare nell'opera di Cesare Lombroso
(1836-1909), fondatore della «Scuola positiva di diritto penale» secondo
la quale i criminali non delinquono per un atto cosciente e libero di
volontà malvagia, ma perché hanno tendenze malvagie, tendenze che
ripetono la loro origine da un'organizzazione fisica e psichica diversa
da quella normale. Da questo presupposto la scuola positiva deduceva la
conseguenza che il diritto della società a punire i delinquenti non si
fonda sulla malvagità del delinquente stesso o sulla sua responsabilità,
ma soltanto sulla sua pericolosità sociale. Lo studio delle
caratteristiche fisiopsichiche che determinano la delinquenza fu
chiamato da Lombroso «antropologia criminale». Era questo un corollario,
nel campo del diritto penale, del principio del determinismo assoluto,
per il quale i caratteri e i comportamenti dell'uomo sono determinati
necessariamente dalla sua struttura organica.
Il positivismo spirituale.
Accanto all'interpretazione materialistica dell'evoluzionismo, si sviluppa
parallelamente la sua interpretazione spiritualistica, che si propone
essenzialmente di adattare il concetto evolutivo della
realtà alle esigenze morali e religiose tradizionali.
Il principale esponente di questa forma di positivismo è Wundt; ma esso
trovava i suoi rappresentanti anche in Inghilterra, in Francia e in Italia.
Wundt.
Wilhelm Wundt (1832-1920) fu dapprima medico e professore di fisiologia,
poi professore di filosofia a Lipsia, dove fondò e diresse il
primo « Istituto di psicologia sperimentale ». Il suo principale merito
è infatti quello di aver dato un grande impulso alle ricerche di
psicologia sperimentale. Già Theodor Fechner (1801-1887) si era posto il
problema di una psicologia sperimentale a base matematica e aveva
formulato la cosiddetta «legge psicofisica fondamentale» che concerne il
rapporto quantitativo fra l'intensità dello stimolo e l'intensità della
sensazione da esso prodotta, affermando che la sensazione stessa è
proporzionale al logaritmo dello stimolo. Wundt estende il metodo
sperimentale a tutto il dominio della psicologia. I suoi Princìpi di
psicologia fisiologica (1874) costituiscono il primo esempio sistematico
di quella che si chiamò «psicologia senz'anima»: cioè di una psicologia
che studia i fenomeni psichici prescindendo da ogni sostanza spirituale,
considerandoli in rapporto strettissimo con i fenomeni fisiologici e
applicando, fin dove è possibile, i procedimenti del calcolo. Il
presupposto di cui Wundt si serve in queste ricerche è il parallelismo
psicofisico, secondo il quale i fenomeni psichici e i fenomeni
fisiologici costituiscono due serie causali indipendenti, che non
interferiscono l'una sull'altra, ma che tuttavia si corrispondono termine
a termine.
Indicazioni bibliografiche
Su Darwin e l'evoluzionismo:
G. Pancaldi, Ch. Darwin, Storia ed economia della natura, La Nuova Italia,
Firenze 1977.
G. Montalenti. Ch. Darwin, Editori Riuniti, Roma 1982.
G. Pancaldi, Darwin in Italia, Il Mulino, Bologna 1983.
Su Spencer:
Per lo «spencerismo» V. M. Harris, L'evoluzione del pensiero antropologico,
Il Mulino, Bologna 1971
M. Toscano, Malgrado la storia. Per una lettura critica di H. Spencer,
Feltrinelli, Milano 1980.
Su Ardigò e il positivismo italiano:
Autori vari, Il positivismo e la cultura italiana (a cura di E. R. Papa),
Franco Angeli, Milano 1985.
G. Landucci, L'occhio e la mente. Scienze e filosofia nell'Italia del
secondo Ottocento, Olschki, Firenze 1987.
A. L. Gentile, La religione civile. Del positivismo di R. Ardigò, Esi,
Napoli 1988.
Glossario e riepilogo
Spencer:
- Per Inconoscibile Spencer intende la Forza misteriosa che si manifesta
in tutti i fenomeni naturali e la cui azione è avvertita dall'uomo
positivamente. Il riconoscimento di tale realtà inaccessibile accomuna
religione e scienza (costrette entrambe ad urtare contro il muro
dell'ignoto) ed elimina ogni possibile conflitto fra di loro. Infatti,
ammesso l'Inconoscibile, il compito della religione sarà quello di
richiamare l'uomo al mistero della causa ultima e il compito della
scienza sarà quello di estendere incessantemente la conoscenza dei
fenomeni: «le cause del conflitto diminuiranno, e si raggiungerà per
sempre la pace, quando la scienza sarà pienamente convinta che le sue
spiegazioni sono prossime e relative, e quando la religione sarà
pienamente convinta che il mistero ch'essa contempla è ultimo e assoluto.»
N.B. La nozione spenceriana di Inconoscibile non deve essere confusa con
quella kantiana di cosa in sé. Infatti, mentre il noumeno di Kant è un
concetto gnoseologico collegato al fatto che noi conosciamo la realtà
attraverso le forme «a priori», l'Inconoscibile di Spencer è il principio
metafisico dell'universo, ovvero l'Assoluto (sia pure ignoto) quale si
manifesta nei fenomeni che costituiscono il mondo.
- La filosofia è, per Spencer, la conoscenza nel suo più alto grado di
generalità e quella che meglio risponde alle esigenze mentali della
sintesi e dell'unificazione: «"Filosofia" può essere propriamente il
titolo per le cognizioni della più alta generalità» (Primi princìpi,
paragrafo 37), «la scienza è conoscenza parzialmente unificata; la
filosofia è conoscenza completamente unificata» (ivi). Di conseguenza,
le verità della filosofia stanno alle verità scientifiche più alte come
queste stanno alle verità scientifiche più basse; sicché le
generalizzazioni della filosofia comprendono e consolidano le più vaste
generalizzazioni della scienza. Essa deve perciò assumere come proprio
materiale e punto di partenza i princìpi più vasti e generali ai quali
la scienza è giunta: l'indistruttibilità della materia, la continuità del
movimento e la persistenza della forza. La ridistribuzione della materia
e della forza trova la sua formula sintetica nella legge
dell'evoluzione (vedi). La filosofia sarà dunque, ai suoi massimi livelli,
una teoria dell'evoluzione.
- Evoluzione e involuzione. Nel paragrafo 145 dei First principles, Spencer
definisce l'evoluzione, intesa come legge universale di tutti i fenomeni,
«un'integrazione di materia accompagnata da dispersione di moto; in cui la
materia passa, da una omogeneità indefinita, incoerente, a una
eterogeneità definita, coerente, mentre il moto trattenuto subisce una
trasformazione parallela». Opposta all'evoluzione è invece la dissoluzione
(o involuzione), nella quale si ha assorbimento di moto e
disintegrazione di materia, insieme ad un concomitante passaggio
dall'eterogeneo all'omogeneo, dal definito all'indefinito, dal coerente
all'incoerente. L'involuzione non è un dato definitivo, poiché là ove si
verifica costituisce semplicemente la premessa di una evoluzione
ulteriore. N.B. Ridotta ai minimi termini, la formula spenceriana
dell'evoluzione e dell'involuzione allude quindi al passaggio dal semplice
al complesso e viceversa.
- Per Spencer la biologia si identifica con lo studio dell'evoluzione dei
fenomeni organici e della sua causa. La vita consiste nella combinazione
di fenomeni diversi, contemporanei e successivi, la quale si verifica in
corrispondenza con mutamenti contemporanei o successivi dell'ambiente
esterno. Essa perciò consiste essenzialmente nella funzione
dell'adattamento; e appunto attraverso questa funzione si formano e si
differenziano gli organi, per l'esigenza di sempre meglio rispondere alle
sollecitazioni dell'esterno. Spencer dà così il primo posto al principio
di Lamarck della funzione che crea l'organo; ma riconosce l'azione del
principio darwiniano della selezione naturale, che però non può agire se
non attraverso l'adattamento all'ambiente e quindi lo sviluppo funzionale
degli organi.
- Psicologia. Secondo Spencer la sostanza spirituale, analogamente alla
sostanza e alla forza materiale, risulta, nella sua natura ultima,
inconoscibile. Per cui, la psicologia deve limitarsi a studiarne le
manifestazioni. Ciò non toglie che la psicologia, contrariamente a
quanto pensava Comte, sia possibile come scienza autonoma. Infatti,
accanto ad una psicolGgia oggettiva, la quale studia i fenomeni psichici
nel loro substrato materiale, Spencer ammette una psicologia soggettiva
fondata sull'introspezione.
- Cercando di conciliare in modo evoluzionistico le opposte verità
dell'empirismo e dell'innatismo, Spencer afferma che «ciò che è a priori
per l'individuo è a posteriori per la specie», in quanto risulta
prodotto dall'esperienza accumulata dalla specie stessa attraverso un
lunghissimo periodo di sviluppo e fissata attraverso l'ereditarietà.
- Per Spencer il compito della sociologia è quello di determinare in modo
descrittivo le leggi dell'evoluzione superorganica, cioè le leggi che
regolano il progresso dell'organismo sociale. In altri termini, la
sociologia è lo studio dell'ordine progressivo della società come un
tutto (Principles of Sociology, 1876,). La sociologia di Spencer è
nettamente orientata verso l'individualismo e quindi verso la difesa di
tutte le libertà individuali, in contrasto con la sociologia di Comte e,
in generale, con l'indirizzo sociale del positivismo.
- Il riformismo di Spencer, che si oppone sia al conservatorismo che al
rivoluzionarismo, discende dalla sua mentalità evoluzionistica, portata
a scorgere, nella storia, non dei salti dialettici, ma degli sviluppi
lenti e graduali: «Allo stesso modo che non si può abbreviare la via tra
l'infanzia e la maturità... così non è possibile che le forme sociali più
basse divengano più elevate, senza attraversare piccole modificazioni
successive».
- Sviluppo sociale. Spencer ritiene che nella storia vi sia stato il
passaggio da una fase di cooperazione umana costrittiva ed imposta ad
una fase di cooperazione più libera e spontanea. Tale è il passaggio dal
regime militare, contrassegnato dalla prevalenza del potere statale
sugli individui ai quali esso impone còmpiti e funzioni, al regime
industriale, che è fondato invece sull'attività indipendente degli
individui, e perciò li determina a rafforzare le loro esigenze e a
rispettare le esigenze degli altri, rinvigorendo la coscienza dei
diritti personali e deliberandoli a resistere agli eccessi del controllo
statale. Spencer tuttavia non ritiene definitivo il regime industriale
(nel quale peraltro la società attuale è appena entrata), ma prospetta
la possibilità di un terzo tipo sociale, il quale, pur essendo fondato
anch'esso sulla libera cooperazione degli individui, ponga moventi
altruistici al posto dei moventi egoistici che reggono il regime
industriale; o meglio ancora, concili insieme altruismo ed egoismo.
Possibilità che per Spencer costituisce la sostanza e l'ideale
dell'etica.(vedi)
- L'etica evoluzionistica di Spencer vagheggia un accordo finale fra
altruismo ed egoismo, ovvero una situazione in cui l'uomo (come accade
sin d'ora nella famiglia) avverte la premura verso il prossimo non come
un obbligo, ma come una manifestazione spontanea della sua persona.
STORIA DELLA FILOSOFIA
di Nicola Abbagnano
VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA EZIO
GALIANO
REVISIONE DI AMEDEO MARCHINI
VOLUME TERZO
Parte settima. Il «caso» Nietzsche.
«Quanta verità può sopportare,
quanta verità può osare un uomo?
Questa è diventata la mia vera
unità di misura, sempre più».
CAPITOLO 15: Nietzsche.
1. Vita e scritti.
Considerato un tempo come «filosofo e profeta del nazismo» e più tardi
come «filosofo della liberazione», in questi ultimi anni, parallelamente
ad una vera e propria Nietzsche-Renaissance, Nietzsche è stato uno dei
filosofi più letti, studiati e tradotti del mondo.
Friedrich Nietzsche nacque a Röcken presso Lutzen il 15 ottobre 1844.
Studiò filologia classica a Bonn e a Lipsia sotto la guida di Friedrich
Ritschl, e in questi studi andò formandosi il suo entusiasmo romantico
per l'antichità greca. A Lipsia lesse per la prima volta Il mondo come
volontà e rappresentazione di Schopenhauer e ne fu conquistato.
L'incontro con Schopenhauer.
Così egli scriveva in un frammento autobiografico del 1867: «Qui ogni riga
gridava la rinuncia, la negazione, la rassegnazione; qui io guardavo
come in uno specchio il mondo, la vita e la mia propria anima, grandiosi
di orrore; qui, simile al sole, il grande occhio dell'arte mi fissava,
staccato da tutto; qui io vedevo malattia e guarigione, esilio e
rifugio, inferno e cielo». I lavori del giovane filologo attirarono su
di lui l'attenzione degli ambienti scientifici; e nel 1869, a 24 anni,
Nietzsche fu chiamato ad una cattedra di filologia classica
dell'Università svizzera di Basilea.
La cattedra a Basilea e l'amicizia con Wagner.
Qui Nietzsche si legò di amicizia con Richard Wagner, che si era ritirato
con Cosima Bulow nella villa di Triebschen sul lago dei Quattro Cantoni,
e divenne un fervente ammiratore del musicista. Nel 1872 Nietzsche
pubblicava il suo primo libro, La nascita della tragedia, che incontrava
l'ostilità dei filologi e rimaneva ignoto al gran pubblico. L'anno
dopo (1873) Nietzsche pubblicava le quattro Considerazioni inattuali.
Frattanto l'amicizia con Wagner si andava affievolendo: Nietzsche era
portato sempre più a vedere in lui l'estremo rappresentante del
romanticismo e a scorgere nell'ultima fase della sua opera, orientata
nostalgicamente verso il cristianesimo, un abbandono di quei valori vitali
che erano propri dell'antichità classica e uno spirito di rinuncia e di
rassegnazione. Umano, troppo umano pubblicato nel 1878 segna il suo
distacco da Wagner e da Schopenhauer.
La malattia.
Frattanto la salute del filosofo si andava indebolendo. Già nel 1875
egli aveva interrotto il suo insegnamento a Basilea e nel 1879 rinunziò
definitivamente alla cattedra. Da allora in poi la sua vita fu quella di
un malato inquieto e nervoso: visse quasi sempre tra la Svizzera e
l'Italia settentrionale, tutto preso dalla composizione dei suoi libri e
dalla speranza impaziente e sempre delusa che essi gli suscitassero
intorno una schiera di discepoli e di seguaci. Nel 1880 usciva la
seconda parte di Umano, troppo umano, che porta il titolo Il viaggiatore
e la sua ombra, ed è un inno d'attesa alla morte. La morte tuttavia non
venne; e nel 1881 Nietzsche pubblicava Aurora, che è il primo libro in
cui si affacciano decisamente le tesi tipiche della dottrina
nietzschiana. Ad esso seguiva La gaia scienza (1882) nel quale si
afferma vittoriosamente la speranza del filosofo di poter condurre
l'umanità verso un nuovo destino. Nietzsche ritiene a questo punto di
poter uscire dalla solitudine e di poter trovare la comprensione e il
successo. Ma un incidente sopravviene a deluderlo. Nel 1882 conosce una
giovane finlandese di 24 anni, Lou Salomé, nella quale crede d aver
trovato un discepolo e una compagna di eccezione. Ma ella rifiutò di
sposarlo e si unì tempo dopo in matrimonio con l'amico e discepolo di
Nietzsche, Paul Rée. Nietzsche si sentì abbandonato e tradito.
La composizione delle opere maggiori.
Tra il 1883 e il 1884 egli componeva il suo poema filosofico Così parlò
Zarathustra; ma questo libro fu pubblicato soltanto nel 1891 quando
Nietzsche era già caduto nella notte della pazzia. Nel 1885 pubblicava
Al di là del bene e del male che è uno dei suoi libri più significativi,
ma che, come tutti gli altri, non ebbe successo immediato. Ad esso
seguivano: La genealogia della morale (1887); e poi, Il caso Wagner, Il
crepuscolo degli idoli, L'anticristo, Ecce homo, Nietzsche contro Wagner,
opuscoli e libelli che Nietzsche compose nel 1888. L'Ecce homo è una
specie di autobiografia. Nel frattempo Nietzsche si era stabilito a
Torino, che egli chiama: «la città che si è rivelata come la mia città».
Qui egli aveva continuato a lavorare alla sua opera filosofica, rimasta
incompiuta. Ma nel febbraio del 1889 un accesso di pazzia lo gettava
incosciente al collo di un cavallo maltrattato dal padrone davanti
all'abitazione torinese del filosofo.
La pazzia.
Nietzsche rimase ancora più di dieci anni immerso in una blanda pazzia,
in cui affioravano di tanto in tanto i ricordi e le delusioni della sua
vita tormentata. In un biglietto a Cosima Wagner egli scrisse: «Arianna,
io ti amo» e in un'altra lettera parlò di Cosima-Arianna. Si è concluso
per un amore infelice di Nietzsche per Cosima Wagner; ma in realtà la
vita e le opere del filosofo non mostrano tracce (salvo l'episodio isolato
di Lou Salomé) di un autentico amore. Gli amici che ebbe e a cui tenne
molto gli furono a poco a poco allontanati dalla sua stessa opera. E la
sua fama si iniziò proprio quando, chiuso nella pazzia, non poté più
rendersene conto. Nietzsche moriva il 25 agosto 1900; i libri che egli
aveva pubblicato a sue spese correvano ormai per il mondo.
L'interpretazione nazista.
L'interpretazione nazista di Nietzsche, che ha trovato la più emblematica
espressione nel libro di Alfred Bäumler Nietzsche, il filosofo e il
politico (1931), è stata facilitata da una singolare vicenda filologica,
consistente nel fatto che la sorella, Elisabeth Förster-Nietzsche, nel
desiderio di fare del fratello il teorico di una palingenesi reazionaria
dell'umanità, non esitò, dopo essersi impadronita degli inediti, a
manipolare i testi del filosofo, pubblicando nel 1906 la Volontà di
potenza nella quale il pensiero di Nietzsche assume quella fisionomia
anti-umanitaria ed anti-democratica sulla quale farà leva la
lettura nazista, che influenzerà profondamente tutta la cultura del
primo Novecento.
L'edizione critica degli scritti.
Soltanto nel secondo dopoguerra si è avviata una profonda revisione
dell'opera di Nietzsche, che, sul piano filologico, ha avuto la sua
tappa decisiva nella benemerita edizione critica degli scritti del
filosofo avviata da Giorgio Colli e Mazzino Montinari.
Contemporaneamente, si è avuta tutta quella fioritura di interpretazioni
nuove del pensiero di Nietzsche, che costituisce tuttora l'orizzonte
generale degli studi sul filosofo.
2. Filosofia e malattia: nuovi punti di vista critici.
L'interpretazione tradizionale.
Per parecchio tempo, la malattia di Nietzsche ha rappresentato un
«argomento» di cui si è servito certa critica per screditare la sua
filosofia. L'alternativa consisteva solamente nell'interpretare il suo
pensiero come «risultato» della sua malattia o, più originalmente, la
sua malattia come «risultato» del suo pensiero (Era questa la tesi
caratteristica di Abbagnano, secondo cui «il centro del filosofare di
Nietzsche deve fornire la chiave non solo delle sue dottrine fondamentali
ma anche dello scacco della sua vita e del dissolvimento della sua
personalità»). In ogni caso la malattia veniva considerata come qualcosa
di esclusivamente negativo e da mettere in correlazione necessaria con
il suo sistema filosofico.
Nuove letture.
Oggigiorno la situazione è radicalmente cambiata. Infatti, non solo ci si
rifiuta di considerare la filosofia di Nietzsche sulla base della sua
malattia o viceversa (come se si trattasse di un deterministico rapporto
di causa-effetto) ma, in taluni settori della critica, si tende piuttosto
a valorizzare la malattia, scorgendo in essa una condizione positiva del
suo filosofare. In altri termini, secondo questo punto di vista, sarebbe
anche in virtù della sofferenza e della solitudine che Nietzsche,
lasciandosi alle spalle le illusioni (o le «magie») dei «sani», avrebbe
potuto attingere un punto «abissale» sul mondo. «La condizione di certi
uomini malati - scrive il filosofo - che a lungo e terribilmente sono
tormentati dai loro dolori, senza che per questo il loro intelletto
resti offuscato, non è senza valore per la conoscenza, anche
prescindendo dai benefici intellettuali che ogni profonda solitudine,
ogni subitanea e consentita libertà da ogni dovere e consuetudine
portano con sé. Colui che soffre fortemente vede dalla sua condizione,
con una terribile freddezza, le cose al di fuori: tutte quelle piccole
ingannevoli magie in cui di consueto nuotano le cose, quando l'occhio
dell'uomo sano vi si affissa, sono invece per lui dileguate; anzi egli si
pone dinanzi a se stesso privo di orpelli e di colore. Ammesso che sia
vissuto fino a quel momento in una qualche pericolosa fantasticheria,
questo supremo disincantarsi attraverso il dolore è il mezzo per
strapparlo da essa: è forse l'unico mezzo...» (Aurora).
IL rifiuto odierno di giudicare la filosofia di Nietzsche sulla base della
malattia.
Si condivida o meno questa persuasione (presente anche in altri maestri
dell'avanguardia artistica e filosofica), è comunque un fatto ormai
universalmente ammesso che la filosofia di Nietzsche, come quella di
qualsiasi altro pensatore, vada giudicata per quello che oggettivamente
dice - ossia per i titoli di verità cui ambisce - e non per le presunte
matrici biografiche o patologiche che ne starebbero all'origine.
3. La denuncia delle «menzogne millenarie» dell'umanità e l'ideale di un
«oltre-uomo».
In quel vasto processo che è stato definito come «demitizzazione» della
cultura e «desacralizzazione» del mondo, la figura di Nietzsche occupa
un posto centrale.
La tendenza critico-demistificatrice.
Infatti, la filosofia di Nietzsche, per un certo aspetto, è tutta
un incessante distruzione di miti e di credenze codificate, in quanto egli
è convinto che gli uomini, per poter sopportare l'impatto con il caos
della vita, abbiano costruito una serie di certezze (metafisiche, morali,
religiose eccetera), che, ad uno sguardo profondo, si rivelano soltanto
come delle necessità di sopravvivenza, che il filosofo, mediante una
serie di «itinerari nel proibito», ha il gravoso ufficio di mettere a nudo.
Facendosi profeta del suo destino d'eccezione, Nietzsche, in Ecce homo,
si presenta come «il primo uomo decente» dopo la «falsità che dura da
millenni», destinato, come tale, a scatenare, nel prossimo, tracolli e
convulsioni: «Conosco la mia sorte. Sarà legato al mio nome il ricordo
di qualcosa di enorme - una crisi, quale mai si era vista sulla terra, la
più profonda collisione della coscienza, una decisione evocata contro
tutto ciò che finora è stato creduto, preteso, consacrato. Io non sono
un uomo, sono una dinamite». E in Umano troppo umano annota: «I miei
scritti sono stati chiamati una scuola di sospetto e ancor più di
disprezzo, per fortuna però anche di coraggio, anzi di temerarietà. E in
realtà io stesso non credo che alcuno abbia mai scrutato il mondo con un
sospetto ugualmente profondo».
La messa in discussione della civiltà occidentale e l'idea del
«super-uomo».
Quest'opera di demolizione polemica del passato non si risolve tuttavia
in una semplice critica delle idee o dei sistemi, poiché si concretizza
anche, secondo la tendenza storica del filosofare di Nietzsche, in
un'esplicita messa in discussione della civiltà occidentale nel suo
complesso e del «tipo antropologico» da essa prodotto: l'individuo
anti-vitale e sottomesso ad autorità costituite. E poiché il rifiuto
dell'uomo del passato avviene alla luce di un'intuizione del possibile
uomo del futuro, il pensiero di Nietzsche non si esaurisce neppure nel
momento critico e polemico del «sospetto» verso le teorie e i
comportamenti tradizionali, in quanto mette capo alla delineazione di un
nuovo modello di umanità: «il super-uomo» o «l'oltre-uomo» (Il termine
« oltr-euomo», traduzione del termine tedesco übermensch, è stato usato
soprattutto da Gianni Vattimo (uno dei maggiori studiosi attuali del
filosofo), per sottolineare la nuova interpretazione del super-uomo visto
come modo d'essere di una possibile umanità futura.).
Le parole di Ecce homo, a questo proposito, sono estremamente eloquenti:
«Io vengo a contraddire, come mai si è contraddetto, e nondimeno sono
l'opposto di uno spirito negatore. Io sono un lieto messaggero, quale
mai si è visto, conosco compiti di un'altezza tale che finora è mancato
il concetto per definirli; solo a partire da me ci sono nuove speranze».
La tendenza anti-sistematica.
Il filosofare di Nietzsche, aforistico ed antisistematico, è ben lontano
dal formare una costruzione architettonica conclusa. Anzi, il suo
discorso multidimensionale presenta una pluralità di significati e di
direzioni di marcia non totalizzabili univocamente. Per cui, in
relazione a questo « pensiero selvaggio» (com'è stato chiamato), che si
nutre di battute, allusioni, aforismi e profezie, e che ha generato una
vera e propria selva di studi, non esistono monopoli interpretativi, ma
solo schemi o tracce di lettura, sempre aperte, in modo ancor più
accentuato che per gli altri filosofi, a nuovi approfondimenti e
riformulazioni.
4. Nietzsche e Schopenhauer.
L'incontro di Nietzsche con Schopenhauer non si esaurisce nella prima
fase della vita di Nietzsche. In realtà la diagnosi di Schopenhauer
sulla natura della vita rimane il presupposto costante dell'opera del
filosofo, anche quando Nietzsche respinge e condanna l'atteggiamento di
rinunzia e di abbandono che da quella diagnosi Schopenhauer aveva
dedotto. La vita è dolore, lotta, distruzione, crudeltà, incertezza,
errore. Essa non ha ordine nel suo sviluppo, né ha scopo, il caso la
domina, i valori umani non trovano in essa garanzie ontologiche
pre-costituite. Due atteggiamenti sono allora possibili di fronte alla vita.
Il rifiuto dell'ascetismo.
Il primo è quello della rinunzia e della fuga, che mette capo all'ascetismo;
questo è l'atteggiamento che Schopenhauer derivò dalla sua diagnosi ed è
l'atteggiamento, secondo Nietzsche, proprio della morale cristiana e
della spiritualità comune. Il secondo è quello dell'accettazione della
vita come essa è, nei suoi caratteri originari, ed è l'atteggiamento che
mette capo all'esaltazione della vita e al superamento dell'uomo. Questo è
l'atteggiamento di Nietzsche. Tutta l'opera di Nietzsche è intesa a
difendere e a chiarire l'accettazione totale ed entusiastica della vita.
Dioniso è il simbolo divinizzato di questa accettazione e Zarathustra è
il suo profeta.
5. Il «dionisiaco» e l'«apollineo » come categorie interpretative del
mondo greco.
Il «dionisiaco» e l'«apollineo» come coordinate di fondo dello spirito
greco e del suo mondo artistico.
Il motivo centrale de La nascita della tragedia è la distinzione fra il
«dionisiaco» e l'«apollineo», che si concretizza nel contrasto fra una
serie di opposti: caos-forma; divenire-stasi; infinito-finito;
istinto-ragione; oscurità-luce; inquietudine-serenità; ebbrezza-sogno
eccetera. Queste coppie di opposti, che sono presenti anche in Natura
(nella quale vige il contrasto fra la Vita e la forma, tra ápeiron e péras,
ovvero tra il Principio infinito e gli esseri finiti che da esso sgorgano
e a cui ritornano) rappresentano, secondo Nietzsche, le coordinate di fondo
dello spirito greco e del suo mondo artistico. Infatti, mentre il
dionisiaco, che scaturisce dalla forza vitale e dal senso caotico del
divenire, si esprime nell'esaltazione creatrice della musica, l'apollineo,
che scaturisce da un atteggiamento di fuga di fronte al flusso
imprevedibile degli eventi, si esprime nelle forme limpide ed armoniche
dell'arte plastica e dell'epopea. In antitesi all'immagine tradizionale e
cristiana dell'Ellade come mondo della serenità e dell'equilibrio (ossia
come regno dell'apollineo), Nietzsche insiste invece sul carattere
originariamente dionisiaco (o «asiatico») della sensibilità greca,
portata a scorgere ovunque il dramma della vita e della morte e gli
aspetti orribili e assurdi della vicenda crudele dell'essere. Tant'è vero,
continua Nietzsche, che l'apollineo nacque solo sul terreno di una
visione dionisiaca dell'esistenza e dal tentativo di sublimare il caos
nella forma, ossia dallo sforzo di trasfigurare l'orribile e l'assurdo in
un mondo definito e armonico, capace di rendere accettabile la vita. Gli
stessi dèi olimpici furono nient'altro che un modo per «sopportare»,
mediante una trasposizione mitico-ideale, la caducità dolorosa
dell'essere-uomini: « il Greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità
dell'esistenza: per poter comunque vivere, egli dovette porre davanti a
tutto ciò la splendida nascita sognata dagli dèi olimpici...».
Le varie fasi del rapporto fra dionisiaco e apollineo.
In un primo tempo, nella Grecia presocratica, impulso apollineo e
impulso dionisiaco convissero separati ed opposti. In un secondo tempo,
nell'età della tragedia attica (di Sofocle ed Eschilo), apollineo e
dionisiaco si armonizzarono fra di loro, dando origine a capolavori
sublimi. Infatti, sebbene vivificata dallo spirito dionisiaco, la grande
tragedia greca manifesta un perfetto «accoppiamento» fra il dionisiaco
(rappresentato dalla musica) e l'apollineo (rappresentato dalla vicenda
compiuta dell'eroe).
L'origine della tragedia.
Per quanto concerne, più specificamente, l'origine della tragedia,
Nietzsche riprende l'idea secondo cui essa (conformemente all'etimologia
"trágos", «capro» e "óde", «canto») sarebbe nata dal coro tragico, ovvero
dal coro dei seguaci di Dioniso, mascherati da capri. Egli ne propone
tuttavia una nuova interpretazione, che si lega alle nozioni di dionisiaco
e di apollineo. Ecco come si esprime, a questo proposito, Gianni Vattimo:
«è nota la tesi generale di Nietzsche sul modo in cui si sviluppa la
tragedia greca: essa ha origine dal coro tragico, come già la tradizione
diceva; il coro è in origine una sorta di processione religiosa dei
seguaci di Dioniso, che nell'esaltazione mistica si trasforma, ai propri
stessi occhi, in coro di Satiri, cioè di esseri naturali che sono
insieme l'uomo allo stato originario e qualcosa di sublime e di divino
(...). Nel partecipare alla processione dionisiaca l'uomo della vita
quotidiana subisce un primo processo di trasformazione: si vede e si
sente vivere come Satiro, come essere umano-divino primigenio. Ma a
questa visione ne segue una seconda: il coro dei Satiri, nella sua
trasformazione, "vede fuori di sé una nuova visione come compimento
apollineo del proprio stato" (Genesi della Tragedia 8); vede cioè il dio,
Dioniso, che raffigura in vicende articolate la "storia" stessa del
Satiro come essere naturale; è questa nuova visione quella che
costituisce la vicenda vera e propria del dramma, e che compie lo
sviluppo della tragedia fino alla forma nella quale ci è stata tramandata».
In altri termini, quando Nietzsche afferma che la genesi della tragedia
greca risiede in un «coro dionisiaco che sempre di nuovo si scarica in
un mondo apollineo di immagini», egli intende dire che il dramma tragico
diviene veramente tale allorquando Dioniso è "rappresentato" tramite una
serie di "immagini" che trasformano in un mondo di ideale compiutezza e
bellezza il vissuto di sofferenza dell'eroe (ovvero l'essenza caotica
dell'esistere).
Il prevalere dell'apollineo e l'inizio del processo di «decadenza».
Nell'arte successiva, questa sorta di sintesi fra dionisiaco ed
apollineo, che per Nietzsche rappresenta un autentico «miracolo
metafisico» della civiltà ellenica viene messa in forse dal prevalere
dell'apollineo, che trionfa sul dionisiaco fin quasi a soffocarlo. Questo
processo di «decadenza» inizia con la tragedia di Euripide (cioè con
colui che porta sulla scena non più l'eroe, ma l'omuncolo nelle sue
quotidiane peripezie) e trova la sua espressione paradigmatica
nell'insegnamento razionalistico ed ottimistico di Socrate, ossia del
filosofo con cui si compie l'«uccisione» delle profondità istintuali e
tragico-dionisiache della vita, a favore di quel pallido ideale che è la
ragione e la sua visione «serena» e «misurata» del mondo.
6. Laccettazione totale della vita.
Dioniso come metafora del «sì» totale alla vita e al mondo.
Nietzsche vuol essere un discepolo di Dioniso, poiché nell'antica figura
greca egli vede il simbolo del suo «sì» totale al mondo. In altri
termini, Dioniso è, per Nietzsche, «l'affermazione religiosa della vita
totale, non rinnegata né frantumata». è l'esaltazione entusiastica del
mondo com'è, senza diminuzione, senza eccezione e senza scelta:
esaltazione infinita dell'infinita vita. Lo spirito dionisiaco non ha nulla
a che fare con l'accettazione rassegnata della vita, con l'atteggiamento
di chi vede in essa la condizione negativa di quei valori di bontà, di
perfezione, di umiltà, che sono la sua negazione. è la volontà
orgiastica della vita nella totalità della sua potenza. Dioniso è il dio
dell'ebbrezza e della gioia, il dio che canta, ride e danza: egli
bandisce ogni rinunzia, ogni tentativo di fuga di fronte alla vita. Ciò
vuol dire, secondo Nietzsche, che l'accettazione integrale della vita
trasforma il dolore in gioia, la lotta in armonia, la crudeltà in
giustizia, la distruzione in creazione. Essa rinnova profondamente la
tavola dei valori morali. Tutti i valori fondati sulla rinunzia e
sulla diminuzione della vita, tutte le cosiddette virtù che tendono
a mortificare l'energia vitale, a spezzare e a impoverire la
vita, appaiono a Nietzsche come un abbassamento dell'uomo al di sotto
di sé e quindi come indegne di lui.
L'esaltazione dei valori vitali.
Per lui sono virtù tutte le passioni che dicono sì alla vita e al mondo:
«La fierezza, la gioia, la salute, l'amore sessuale, l'inimicizia e la
guerra, le belle attitudini, le buone maniere, la volontà forte, la
disciplina dell'intellettualità superiore, la volontà di potenza, la
riconoscenza verso la terra e verso la vita - tutto ciò che è ricco e
vuol dare, e vuol gratificare la vita, dorarla, eternizzarla e
divinizzarla... tutto ciò che approva, afferma ed agisce per affermazione».
Nietzsche pone crudamente il dilemma tra la morale tradizionale e quella
che egli difende; ma in realtà questo dilemma è già incluso nell'altro,
che è il solo fondamentale, tra l'accettazione della vita e la rinunzia
alla vita, tra il sì e il no di fronte al mondo. Solamente l'atto
dell'accettazione, la scelta libera e gioiosa di ciò che la vita è nella
sua potenza primitiva, determina la trasfigurazione dei valori e indirizza
l'uomo verso l'esaltazione di sé anziché verso l'abbandono e la rinunzia.
Ciò non significa che il pensiero di Nietzsche possa venir considerato alla
stregua di un ottimismo estetizzante che veda nell'esistenza un baccanale
di gioia o un'orgia di piacere. Infatti, come si è visto, Nietzsche, in
quanto discepolo di Schopenhauer, è ben consapevole del momento tragico
e crudele dell'essere.
Al di là del pessimismo e dell'ottimismo.
Criticando il pessimismo come segno di decadenza e l'ottimismo come segno
di superficialità, egli mira piuttosto a proporre un accoglimento della
vita nell'insieme dei contrari che la caratterizzano.
7. La critica della morale e la trasvalutazione dei valori.
Il tema dell'accettazione della vita - che costituisce il filo conduttore di
tutto il pensiero di Nietzsche - porta il filosofo a polemizzare aspramente
contro la morale e il cristianesimo, considerati come le tipiche forme
di coscienza e di azione attraverso cui l'uomo è giunto a porsi contro la
vita stessa.
La morale come problema.
Secondo Nietzsche la morale, attraverso i tempi, è sempre stata
considerata come un fatto evidente che si auto-impone all'individuo.
Tant'è vero che, in ogni scienza della morale esistita sino
ad oggi, si puntualizza in Al di là del bene e del male, è sempre
mancato, per quanto possa riuscire strano, il problema stesso della
morale: è mancato il sospetto che ci potesse essere, su questo punto,
qualcosa di problematico. Di conseguenza, il primo passo da compiere nei
confronti della morale, come afferma la prefazione alla Genealogia della
morale, è di mettere in discussione la morale stessa: « abbiamo bisogno
di una critica dei valori morali, di cominciare a porre una buona volta
in questione il valore stesso di questi valori».
La genealogia della morale (cfr. il Glossario).
Proprio in vista di ciò, Nietzsche intraprende un'analisi genealogica
della morale, al fine di scoprirne la genesi psicologica effettiva.
Nell'ambito di questo «viaggio» alle sorgenti dei comportamenti etici,
Nietzsche è guidato da una convinzione che in Ecce homo esprime con
un aforisma famoso:
«dove voi vedete le cose ideali,
io vedo cose umane, ahi troppo umane».
Egli ritiene infatti che i pretesi valori trascendenti della morale e la
morale stessa, intesa come specifico modo di essere, siano nient'altro
che una proiezione di determinate tendenze umane, che il filosofo, in
virtù della psicologia, «signora delle scienze», ha il compito di
svelare nei loro meccanismi segreti.
La genesi sociale dei comportamenti etici.
Innanzitutto la cosiddetta «voce della coscienza», da cui procederebbe la
morale, secondo Nietzsche, è nient'altro che la presenza, in noi, delle
autorità sociali da cui siamo stati educati Per cui, anziché essere
«la voce di Dio nel petto dell'uomo», la coscienza risulta piuttosto,
scrive testualmente Nietzsche, «la voce di alcuni uomini nell'uomo». In
altre parole, la moralità è «l'istinto del gregge nel singolo», ovvero
il suo assoggettamento a determinate direttive fissate dagli esponenti
delle élites dominanti. Anziché rappresentare delle entità ontologiche
autonome, i valori etici, considerati dal punto di vista
storico-psicologico, sono quindi «il risultato di determinate prospettive
di utilità per il mantenimento e il rafforzamento delle forme di dominio
umano; e solo falsamente sono proiettati nell'essenza delle cose»
(Frammenti postumi).
La morale dei signori e la morale degli schiavi.
Tuttavia, mentre in un primo momento, soprattutto nel mondo classico, la
morale essendo espressione di un'aristocrazia cavalleresca, risulta
improntata ai valori vitali della forza, della salute, della fierezza,
della gioia (= la morale dei signori), in un secondo momento, che giunge
al suo apice con il cristianesimo, la morale appare improntata ai valori
anti-vitali del disinteresse, dell'abnegazione, del sacrificio di sé ù
eccetera (= la morale degli schiavi). Ma come si spiega la vittoria della
morale degli schiavi, ossia l'avvento di una maniera anti-vitale di
rapportarsi alla vita? Com'è possibile che, ad un certo punto, l'umanità
occidentale abbia imboccato la strada della malattia e della decadenza?
Ciò è avvenuto, risponde Nietz