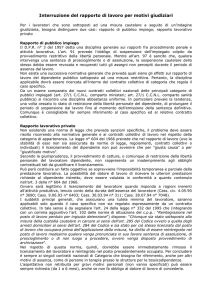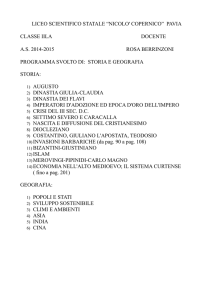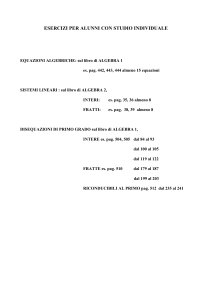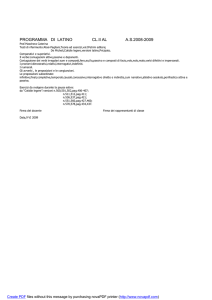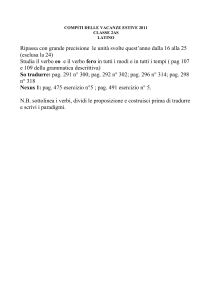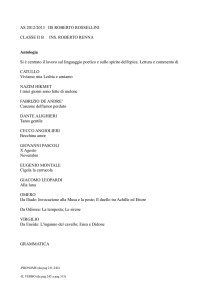Pubblicazione bimestrale - Anno XVI, n. 1 gennaio-febbraio 2011 - Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. I, comma I, DCB Milano
ISSN 1126-5760
ADL
ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO
FONDATI DA MATTIA PERSIANI
DIRETTI DA
Mattia Persiani e Franco Carinci
1/2011
Osservazioni sulla revisione della dottrina sindacale
La cronaca si fa storia: da Pomigliano a Mirafiori
I nuovi profili dell’impugnazione del licenziamento
La nuova certificazione dei contratti di lavoro
Tutela dei diritti del lavoratore e termini di decadenza
Il collegato lavoro e le novità introdotte nel contratto a termine
La legislazione del lavoro degli anni ’80
Inidoneità permanente, impossibilità sopravvenuta della prestazione
e giustificato motivo oggettivo di licenziamento – Malattia e inidoneità sopravvenuta
del lavoratore e limiti del “repêchage” – Rischio elettivo ed infortunio in itinere –
Diritto alla privacy, diritto alla difesa e criteri di bilanciamento – Trattamento
pensionistico degli iscritti all’ex Fondo Esattoriali e principio comunitario
di parità retributiva tra uomini e donne – Stabilizzazione dei lavoratori a termine
e nozione di procedura concorsuale ai fini dell’attribuzione della giurisdizione –
Lavoro straordinario nella lettura degli attuali orientamenti giurisprudenziali
Argomenti di diritto del lavoro intende contribuire
al dibattito sull’evoluzione del diritto del lavoro
come sistema giuridico quale risulta dagli apporti della
giurisprudenza e dagli sviluppi della legislazione.
Fondatore Mattia Persiani
Direttori: Mattia Persiani e Franco Carinci
Condirettori: Enrico Gragnoli e Roberto Pessi
Collaborano alla direzione:
Alessandro Bellavista, Marina Brollo, Laura Castelvetri, Maria Teresa Carinci,
Carlo Cester, Raffaele De Luca Tamajo, Germano Dondi, Rosario Flammia,
Alessandro Garilli, Mario Grandi, Stefano Liebman, Fiorella Lunardon,
Mariella Magnani, Arturo Maresca, Luigi Montuschi, Mario Napoli, Luca Nogler,
Giancarlo Perone, Giampiero Proia, Maurizio Ricci,
Mario Rusciano, Giuseppe Santoro Passarelli, Renato Scognamiglio,
Giuseppe Suppiej, Paolo Tosi, Patrizia Tullini, Armando Tursi,
Tiziano Treu, Antonio Vallebona, Carlo Zoli.
Redazione: Michele Miscione e Michel Martone (capi redattori);
Marco Marazza, Sandro Mainardi, Alberto Pizzoferrato, Valerio Maio.
Segreteria di Redazione Roma – Sezione Dottrina: Cristina Di Silvestre
E-mail: [email protected]
Segreteria di Redazione Bologna – Sezione Giurisprudenza: Susanna Palladini
E-mail: [email protected]
Direzione e Redazione di Roma
Via A. Bertoloni, 44 – 00197 Roma
Tel. 06/80691974 – Fax 06/80691685
Direzione e Redazione di Bologna
Via S. Margherita, 2 – 40123 Bologna
Tel. 051/234883 – Fax 051/234834
Sede operativa CEDAM,
Viale dell’Industria, 60 – 35129 Padova
Tel. 049/8239111 – Fax 049/8752900
ADL
ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO
FONDATI DA MATTIA PERSIANI
DIRETTI DA
Mattia Persiani e Franco Carinci
1/2011
Osservazioni sulla revisione della dottrina sindacale
La cronaca si fa storia: da Pomigliano a Mirafiori
I nuovi profili dell’impugnazione del licenziamento
La nuova certificazione dei contratti di lavoro
Tutela dei diritti del lavoratore e termini di decadenza
Il collegato lavoro e le novità introdotte nel contratto a termine
La legislazione del lavoro degli anni ’80
Inidoneità permanente, impossibilità sopravvenuta della prestazione
e giustificato motivo oggettivo di licenziamento – Malattia e inidoneità sopravvenuta
del lavoratore e limiti del “repêchage” – Rischio elettivo ed infortunio in itinere –
Diritto alla privacy, diritto alla difesa e criteri di bilanciamento – Trattamento
pensionistico degli iscritti all’ex Fondo Esattoriali e principio comunitario
di parità retributiva tra uomini e donne – Stabilizzazione dei lavoratori a termine
e nozione di procedura concorsuale ai fini dell’attribuzione della giurisdizione –
Lavoro straordinario nella lettura degli attuali orientamenti giurisprudenziali
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl
ISBN 978-88-13-30640-3
A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.
Editore: Wolters Kluwer Italia Srl - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Pal. F6 - 20090 Assago (MI)
Autorizzazione del Tribunale di Padova del 20 febbraio 1998 n. 1594
Direttore responsabile: Mattia Persiani
Composizione: Bertoncello Artigrafiche - Cittadella (PD)
Stampa: GECA S.p.a. - Via Magellano, 11 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Stampato in Italia - Printed in Italy
INDICE-SOMMARIO N. 1/2011
PARTE PRIMA
SAGGI
Mattia Persiani, Osservazioni sulla revisione della dottrina del diritto sindacale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.
1
Franco Carinci, La cronaca si fa storia: da Pomigliano a Mirafiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
11
Enrico Gragnoli, Nuovi profili dell’impugnazione del licenziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
39
Marco Marazza, Oggetto ed effetti della nuova certificazione dei
contratti di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
61
Elena Boghetich, Tutele dei diritti del lavoratore e nuovi termini
di decadenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
68
Giovanni Mimmo, Decadenza e regime sanzionatorio: come il “collegato lavoro” ha modificato la disciplina del contratto a termine
»
87
Andrea Allamprese, La legislazione del lavoro degli anni ’80.
Una intensa stagione riformatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
106
Marco Ferraresi, Inidoneità permanente al volo, impossibilità sopravvenuta della prestazione e giustificato motivo oggettivo di licenziamento (nota a Cass., Sez. Lav., 29 marzo 2010, n. 7531)
»
133
Stefano Maria Corso, Malattia e inidoneità sopravvenuta del lavoratore e limiti del “repêchage” secondo una recente sentenza
della Cassazione (nota a Cass., Sez. Lav., 23 aprile 2010, n.
9700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
146
PARTE SECONDA
GIURISPRUDENZA
Note di commento
ADL 1/2011
VI
INDICE-SOMMARIO
Sentenze annotate
Cass., Sez. Lav., 26 marzo 2010, n. 7373, con nota di Francesco
Paolo Rubbio, Rischio elettivo ed infortunio in itinere . . . . . .
pag. 161
Cass., Sez. Lav., 5 agosto 2010, n. 18279, con nota di Gianvito
Riccio, Antagonismo fra diritto alla privacy e diritto alla difesa
e criteri di bilanciamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
168
Trib. Pisa 6 maggio 2010, con nota di Gaetana Pendolino, Il
trattamento pensionistico degli iscritti all’ex Fondo Esattoriali e
il principio comunitario di parità retributiva tra uomini e donne
»
177
App. Firenze 16 luglio 2010, con nota di Alessandro Lima, La
stabilizzazione dei lavoratori a termine e la nozione di procedura concorsuale ai fini dell’attribuzione della giurisdizione . . . . .
»
186
»
197
Rassegna
Irene Corso, Il lavoro straordinario: una lettura degli attuali
orientamenti giurisprudenziali alla luce del d.lgs. n. 66/2003 . .
ADL 1/2011
FABIO MAZZIOTTI DI CELSO
Se ne è andato un altro protagonista della nostra materia, questa volta
uno che ne ha conosciuto e condiviso la fase della sua ricostruzione postbellica.
Sensibile e intelligente interprete dei mutamenti della realtà sociale, alla luce di valori costituzionali assunti e referenti fermi e immodificabili.
Lascia di sé, come persona, l’immagine di un colto gentiluomo napoletano; come studioso un ricco ed articolato patrimonio di contributi che
spaziano per tutti i settori della nostra materia.
ADL 1/2011
SAG G I
Mattia Persiani
Prof. emerito de La Sapienza romana
OSSERVAZIONI SULLA REVISIONE DELLA DOTTRINA
DEL DIRITTO SINDACALE (*)
Sommario: 1. Le vicende e le tradizionali nozioni del diritto sindacale. – 2. Contrattazione collettiva “zoppa” e contrattazione collettiva “separata”. – 3. Assenza di criteri legali di soluzione della rappresentatività sindacale. – 4. Principio di libertà sindacale e negazione di discriminazioni tra sindacati. – 5. Il reciproco riconoscimento come condizione di fatto per l’esercizio della autonomia collettiva. – 6. La libertà sindacale dei datori di lavoro come condizione dell’effettività del contratto collettivo. – 7. Il diritto alla retribuzione proporzionata
e sufficiente. – 8. Il ricorso al concetto di rappresentanza, volontaria e legale, per spiegare la
legittimazione a stipulare il contratto collettivo. – 9. L’applicazione del contratto collettivo
da parte del datore di lavoro sindacalizzato. – 10. L’autonomia collettiva come species del genus autonomia privata destinata a produrre effetti normativi per soddisfare interessi collettivi. – 11. L’autonomia privata individuale non è abilitata a produrre effetti normativi onde
l’adesione dei singoli lavoratori non può spiegare la legittimazione a stipulare il contratto
collettivo. – 12. Il conferimento dei poteri dell’autonomia collettiva ad opera dell’ordinamento giuridico. – 13. Rifiuto di stipulare il contratto collettivo ed esercizio della libertà sindacale. – 14. Inesistenza e inutilità di criteri idonei a verificare l’attitudine a stipulare il contratto collettivo. – 15. Valutazione del risultato della trattativa sindacale e libertà sindacale. –
16. I nuovi scenari. – 17. Assenza di un criterio idoneo a valutare l’idoneità del contratto collettivo a realizzare l’interesse collettivo. – 18. Impossibilità di far ricorso al criterio quantitativo e di far ricorso al giudice. Inutilità del referendum. – 19. Opportunità di una revisione
critica del concetto di contratto collettivo nazionale. – 20. Superamento del concetto di
contratto collettivo nazionale. – 21. I vari livelli ai quali l’autonomia è esercitata e la loro
equivalenza. – 22. L’influenza della concezione corporativa sul concetto di contratto collettivo nazionale.
1. – È probabile che le recenti vicende napoletane e torinesi forniscano,
almeno agli studiosi più attenti, l’occasione per tentare una revisione critica delle tradizionali nozioni che, da tempo, guidano i nostri ragionamenti
quando si tratti di dare applicazione ad un “diritto senza norme ” qual’è il diritto sindacale.
Del resto, quelle vicende, prima ancora di porre problemi fino ad ora
non avvertiti, si inserisce in un contesto caratterizzato da una nuova politi-
(*) Dedicato alla memoria di Giuliana Ciocca.
ADL 1/2011
PARTE PRIMA . SAGGI
2
ca di relazioni sindacali che, come tale, richiede venga messa in dubbio la
possibilità di continuare ad utilizzare le nozioni elaborate quando quel
contesto era molto diverso.
Dispersa, infatti, anche l’idea residua di una politica di unità di azione
sindacale, sembra stia consolidandosi la prassi di contratti collettivi che i
datori di lavoro stipulano soltanto con alcuni, e non con tutti, i sindacati
che pure sarebbero comparativamente più rappresentativi.
2. – Fenomeno questo che è stato definito come quello della contrattazione collettiva “zoppa ” perché non sottoscritta da tutte le tre organizzazioni sindacali che, a lungo, erano state ritenute titolari della “rappresentanza egemonica della classe lavoratrice ”.
Peraltro, contrattazione “zoppa ” e non “separata ” come, invece, veniva
definita quella sottoscritta da tutti e tre i grandi sindacati dopo aver condotto, da soli, le trattative. Lo stesso testo del contratto era, poi, soltanto
sottoscritto in sedi, appunto, “separate ” anche dai sindacati minori.
Va, però, osservato come fosse, via via, accaduto che molti sindacati minori avevano finito per ottenere, peraltro senza molto scandalo, che i giudici ne riconoscessero, ai sensi di legge, quella maggiore rappresentatività
che veniva loro negata nelle relazioni sindacali.
A quel punto, però, non si pose, come forse avrebbe dovuto porsi, il
problema di sapere se anche la contrattazione che, allora, veniva definita
“separata ” non fosse, in realtà, anch’essa una contrattazione “zoppa ”. Ciò
perché soltanto una scelta di politica sindacale escludeva dalla trattativa, e
quindi dalla sostanziale ed effettiva stipulazione del contratto collettivo,
sindacati, almeno per legge, da ritenere maggiormente rappresentativi.
3. – Ciò avveniva perdurando la mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 Cost. e vigente il regime del pluralismo sindacale.
Quel regime è tuttora vigente e, a ben vedere, esclude, ora come allora,
una qualsiasi gerarchia tra i sindacati che, comunque, siano rappresentativi.
Per contro, il legislatore ha tentato di introdurre un ulteriore, e più rigoroso, criterio (quello della “comparativamente maggior rappresentatività ”).
Senonché, risulta che a quel criterio sia stato, ancora una volta, attribuito, nei fatti, soltanto un contenuto politico, così come politiche sono state le ragioni che ne hanno suggerito l’introduzione. Resta che quel criterio
è stato previsto per selezionare i sindacati soltanto quando si tratti di dar vita, come si usa dire, a un regolamento delegato e non già quando si tratti di
stipulare un contratto collettivo di diritto comune.
4. – Le considerazioni fin qui accennate potrebbero indurre a porre
ADL 1/2011
MATTIA PERSIANI
3
sullo stesso piano due problemi: quello della legittimità di un contratto collettivo “zoppo ” perché, come accadeva tempo fa, non era stato stipulato da
uno dei sindacati dei lavoratori che, ai sensi di legge e secondo i giudici, era
soltanto, e secondo i giudici, maggiormente rappresentativo e il problema
della legittimità del contratto collettivo “zoppo ” perché non è stato stipulato da un sindacato che non solo è maggiormente rappresentativo, ma, come
sembra avvenga sempre più spesso, raccoglierebbe anche il consenso della
maggior parte dei lavoratori interessati.
E la soluzione dei due problemi potrebbe essere identica ove, ancora
una volta, si ritenga che il principio della libertà sindacale, e il conseguente
regime del pluralismo sindacale, non consente, mancando una legge sindacale, di assegnare rilevanza giuridica alla consistenza numerica delle iscrizioni ai sindacati. Il principio della libertà sindacale, quindi, non consente
qualsiasi discriminazione tra sindacati rappresentativi.
Tutti i sindacati, infatti, indipendentemente dalla loro storia, dalle
ideologie alle quali si ispirano e dalla consistenza numerica dei loro iscritti
hanno le stesse prerogative e gli stessi diritti. Ne consegue che, così come
nessuno contesta che qualsiasi sindacato sia abilitato, anche da solo, a proclamare lo sciopero, non può essere negato ad ogni sindacato il potere di
stipulare, anche da solo, un contratto collettivo.
5. – Conclusione quest’ultima che non suscita, a mio avviso, perplessità
sol che si rammenti come, nella prospettiva segnata dal pluralismo sindacale, è stato autorevolmente insegnato che, in assenza di regole legislative e
quindi nell’ordinamento intersindacale, la legittimazione a stipulare il contratto collettivo è condizionata soltanto dal reciproco riconoscimento delle parti stipulanti. È condizionata, cioè, soltanto dalle scelte politiche di
queste ultime.
Ma, se in tal modo viene data soluzione al problema della legittimazione di alcuni, e non di tutti, i sindacati a stipulare un contratto collettivo, resta, pur sempre, un problema al quale dare soluzione.
Trattasi del problema di sapere quale sia la ragione per cui un datore di
lavoro potrebbe pretendere di applicare un contratto collettivo che, non
solo fosse stato stipulato con uno o più sindacati ai quali, però, non tutti i
suoi dipendenti siano iscritti, ma addirittura quando la maggioranza dei
suoi dipendenti fosse iscritta a un sindacato che, valutata negativamente la
conclusione della trattativa, abbia, per questa ragione, rifiutato di sottoscrivere quel contratto collettivo.
6. – Orbene, quest’ultimo problema dovrebbe essere risolto, a mio avviso, senza ricorrere alle foglie di fico.
ADL 1/2011
4
PARTE PRIMA . SAGGI
Occorre, cioè, constatare che, alla stregua del nostro diritto vigente e
nella realtà delle cose, i contratti collettivi di diritto comune trovano effettiva applicazione soltanto se il datore di lavoro lo vuole e, cioè, se è sindacalizzato ovvero se ha tenuto quei comportamenti che, secondo i giudici,
equivalgono alla iscrizione al sindacato stipulante.
La conseguenza è che, in mancanza di una legge sindacale, la libertà
sindacale dei datori di lavoro esclude l’esistenza non solo di un diritto dei
lavoratori a vedersi applicato un qualsiasi contratto collettivo, ma, a maggior ragione, esclude l’esistenza del diritto dei lavoratori a vedersi applicato esclusivamente il contratto collettivo che è stato stipulato dal sindacato
al quale fossero iscritti.
7. – L’unico diritto riconosciuto ai lavoratori, infatti, è il diritto ad una
retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.).
Orbene i nostri giudici, da un lato, non sempre accolgono una nozione
ampia di retribuzione e, d’altro lato, accertano se la retribuzione sia, o no,
proporzionata facendo, sia pure soltanto, riferimento alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.
Ma, se il sindacato al quale il lavoratore è iscritto non ha stipulato un
contratto collettivo, e non già perché non è un sindacato rappresentativo
ma perché non ha valutato le condizioni di quel contratto idonee a dare effettiva tutela agli interessi dei suoi iscritti, non resta al giudice che far riferimento al contratto collettivo che, comunque, risulta essere stato stipulato.
8. – Se queste conclusioni lasciano, come suol dirsi, la bocca amara è
soltanto perché si continua a ragionare come se il sindacato stipulasse il
contratto collettivo nell’esercizio della delega che i singoli lavoratori avrebbero conferito mediante l’iscrizione sindacale.
A ben vedere, però, questa costruzione era stata adottata dalla dottrina
dell’inizio del secolo scorso che, per prima, studiò il fenomeno della contrattazione collettiva e che, quando rimase fedele al metodo giuridico, dovette fare i conti con un diritto civile ancora di impronta romanistica e,
quindi, tutto rinchiuso nella prospettiva individuale.
Se mai, si noti che quella costruzione influenzò anche la legislazione fascista che, per dare efficacia generale ai contratti collettivi corporativi, non
trovò nulla di più semplice che attribuire ai sindacati pubblici la rappresentanza legale della categoria professionale, in contrapposizione, appunto, a
quella che era la rappresentanza volontaria nell’esercizio della quale era stato ritenuto, fino ad allora, operassero le libere associazioni sindacali.
E, così, è rimasta l’idea che il sindacato stipulerebbe il contratto collettivo esercitando quella rappresentanza che gli iscritti hanno liberamente
ADL 1/2011
MATTIA PERSIANI
5
conferito con l’iscrizione sindacale così come, nel periodo corporativo,
avrebbe esercitato una rappresentanza conferita dalla legge.
Peraltro, soltanto continuando ad accettare questo modo di ragionare,
sarebbe forse possibile tentare di sostenere, in qualche modo, che il lavoratore avrebbe diritto a vedersi applicato il contatto collettivo stipulato dal
sindacato al quale è iscritto e spingersi fino a ritenere che potrebbe rifiutare di vedersi applicato il contratto collettivo stipulato da un sindacato al
quale non è iscritto.
9. – Senonché, sarebbe da dire che quell’impostazione, almeno dal
punto di vista dei lavoratori, ha fatto il suo tempo.
È stato dianzi ricordato come l’effettività del contratto collettivo, oramai, di diritto comune è condizionata da ciò che il datore di lavoro accetti
di applicarlo (cfr. n. 6). Qui va aggiunto che, quando un datore di lavoro applica un contratto collettivo, lo applica, per ragioni pratiche, a tutti i suoi dipendenti: iscritti o non iscritti ai sindacati che l’hanno stipulato e indipendentemente da ciò che siano, o no, dissenzienti.
Così l’eventuale rinunzia dei lavoratori dissenzienti ai diritti derivanti
dal contratto collettivo oggetto di dissenso altro non è che una mera protesta politica. Trattasi, infatti, di rinunzia, sia pure temporaneamente, invalida stante il disposto dell’art. 2113 Cod. Civ. , in quanto rinunzia avente ad
oggetto diritti derivanti da un contratto collettivo.
10. – Ma v’è di più. La dottrina del diritto sindacale ha sviluppato, oramai da tempo, l’originaria intuizione di F. Santoro Passarelli che, immediatamente dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, aveva
individuato l’autonomia privata collettiva come una species, insieme a quella individuale, del genus autonomia privata.
La dottrina, infatti, ha avuto modo di approfondire il significato del
concetto di autonomia privata collettiva. E ciò ha fatto distinguendo l’autonomia privata collettiva da quella individuale in quanto la prima è idonea
ad avere effetti suoi propri: effetti normativi, cioè, in quanto destinata a dare soddisfazione a un interesse collettivo e, quindi, a dettare direttamente
la disciplina dei rapporti di lavoro senza incorporarsi in quella prevista dai
contratti individuali di lavoro.
Per contro, l’autonomia privata individuale continua ad essere idonea a
produrre soltanto effetti reali e obbligatori, idonei, come tali, a soddisfare
interessi individuali.
11. – Ma, se è così, il potere di esercitare l’autonomia privata collettiva
mediante la stipulazione del contratto collettivo non può essere conferito
ADL 1/2011
6
PARTE PRIMA . SAGGI
dai singoli lavoratori con l’iscrizione sindacale. Ciò perché, i singoli lavoratori hanno soltanto i poteri dell’autonomia privata individuale e non quelli
dell’autonoma collettiva. Onde è inevitabile che nemo plus juris ad alium
transferre potest quam ipse habet.
Il potere di esercitare l’autonomia collettiva e, cioè, di stipulare un contratto collettivo, quindi, non deriva al sindacato dal mandato che con l’iscrizione gli sarebbe stato conferito dai singoli lavoratori, ma è un potere
originario. Un potere, cioè, conferito al sindacato direttamente dall’ordinamento giuridico tutte le volte i singoli lavoratori, coalizzandosi, ne pongono in essere la fattispecie.
Quello che conta, dunque, è che un sindacato esista perché l’ordinamento lo abiliti a stipulare contratti collettivi.
12. – Ed è anche questa la ragione per cui, da un lato, il giudice accerta
la proporzionalità della retribuzione facendo riferimento anche al contratto collettivo stipulato con il dissenso del sindacato al quale il lavoratore
aderisce. D’altro lato, è questa la ragione per cui il lavoratore, a meno che
non scioperi, non potrebbe legittimamente rifiutare di adempiere alla sua
obbligazione di lavorare nel rispetto delle modalità e delle regole previste
dal contratto collettivo anche se non è stato stipulato dal sindacato al quale
aderisce.
Quel contratto, infatti, una volta applicato (cfr. n. 6), è la fonte della disciplina di tutte le posizioni, attive e passive, riconducibili ai rapporti individuali di lavoro.
13. – Il problema che dovrà essere affrontato e risolto dalla nuova dottrina del diritto sindacale non è, quindi, quello di individuare in quale considerazione deve essere tenuto il contratto collettivo che non sia stato stipulato da uno dei sindacati comparativamente più rappresentativi ed al
quale sia anche iscritto il maggior numero di lavoratori.
Ed infatti, si deve ritenere che il sindacato dissidente abbia, comunque,
esercitato la sua libertà sindacale proprio scegliendo di rifiutare la sottoscrizione di un contratto collettivo non ritenuto idoneo a realizzare un’adeguata tutela dei suoi iscritti.
14. – Trattasi di una scelta di politica sindacale che rientra nell’ambito
di quella libertà sindacale costituzionalmente garantita (primo comma, art.
39 Cost.).
Del resto, nella prospettiva segnata dal riconoscimento costituzionale
di quella libertà, non ha senso, a mio avviso, porre il problema dei modi e
dei criteri con i quali sarebbe possibile individuare quale sindacato abbia la
ADL 1/2011
MATTIA PERSIANI
7
maggiore attitudine a valutare qual’è la disciplina idonea a realizzare la migliore, o l’effettiva, tutela degli interessi dei lavoratori.
Quel problema è, a ben vedere, un problema inutile perché, se risultasse che il più idoneo fosse sempre il sindacato che, aspirando costantemente a condizioni migliori, valuta negativamente il risultato delle trattative,
non sarebbe mai stipulato un contratto collettivo con conseguenze, alla
lunga, negative.
Ciò perché, il contratto collettivo, a differenza di altri contratti e sia pure entro ragionevoli limiti, deve, comunque, essere stipulato con una frequenza predeterminata. Quel contratto, infatti, deve tener conto delle ineludibili, ricorrenti e sempre mutevoli, esigenze sociali che, soltanto con la
sua stipulazione, possono trovare una qualche possibile soddisfazione.
Al tempo stesso, l’esperienza insegna che le conquiste dei lavoratori sono state, nel lungo periodo e nel loro complesso, il risultato algebrico di
una dinamica incostante e, a volte, alternata.
15. – Del resto, tutti i sindacati, una volta che non siano “di comodo” e
che sia stato consentito loro di partecipare alle trattative, sono abilitati, allo
stesso modo, a valutare l’opportunità, o no, di stipulare il contratto collettivo di lavoro.
Contratto collettivo che, come tutti i contratti, non può essere condizionato al rispetto della logica tra mezzi e fini, perché la sua stipulazione rispetta esclusivamente la logica della possibile reciproca convenienza, dovendo tener conto, di volta in volta, di tutti i condizionamenti derivanti dalle contingenti situazioni storiche e dalle mutevoli situazioni economiche e
sociali.
Ond’è che la valutazione del risultato della trattativa è inevitabilmente
una valutazione rimessa alle parti sindacali e, nell’attuale regime di pluralismo sindacale, a ciascuna di esse, proprio perché ciascuna di esse è abilitata dall’ordinamento giuridico a perseguire quella che è ritenuta la migliore
e più efficace tutela dei lavoratori.
16. – Il venir meno anche dell’unità di azione sindacale prospetta, dunque, scenari completamente diversi da quelli nei quali si sono finora messi
gli studiosi del diritto sindacale.
Scenari che mostrano problemi nuovi e che, perdurando l’assenza di
una legge sindacale, non sembra consentano soluzioni ragionevoli e sicure.
Le considerazioni fin qui svolte danno, infatti, la netta impressione che
il conflitto tra il sindacato che rifiuta la stipulazione del contratto collettivo
e sindacato che la accetta è inevitabilmente, e indipendentemente da altro,
risolto a favore di quest’ultimo.
ADL 1/2011
8
PARTE PRIMA . SAGGI
17. – Ed infatti, già è stato accennato come manca un criterio per accertare a quale sindacato spetti di stabilire se un’ipotesi di contratto collettivo
sia idonea, o no, a realizzare l’effettiva tutela degli interessi dei lavoratori
(cfr. n. 14).
Quel criterio, infatti, non può nemmeno essere individuato avendo riguardo a ciò che l’art. 39 Cost. prevede una rappresentanza dei sindacati
“proporzionata al numero degli iscritti ”.
Ed infatti, quel criterio, così come quelli previsti per la stipulazione dei
contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, hanno un senso in
quanto attengono alla stipulazione di contratti collettivi ad efficacia generale. Ed è questa la ragione per cui la consistenza numerica dei sindacati stipulanti costituisce esclusivamente una garanzia per i lavoratori non iscritti
ai sindacati stipulanti e non già per quelli iscritti a questi ultimi.
18. – Il criterio quantitativo non solo non è previsto per la stipulazione
dei contratti collettivi di diritto comune, ma nemmeno potrebbe essere utilizzato mancando una qualsiasi disciplina delle modalità che dovrebbero
presiedere all’accertamento della effettiva consistenza numerica degli
iscritti a ciascun sindacato.
Mancanza alla quale non può ragionevolmente supplire il referendum
sindacale indetto sul contratto concluso posto che quel referendum, anche
se non fosse fortemente condizionato, avrebbe, al più, un significato di
politica sindacale. Esso potrebbe, cioè, fornire alle organizzazioni sindacali un punto di riferimento per le loro successive scelte di politica sindacale.
Né, infine, nella situazione attuale, sarebbe consentito chiedere al giudice addirittura di accertare, tenendo necessariamente conto anche delle
ideologie e delle strategie dei sindacati che hanno preso parte alla trattativa, quale delle contrastanti valutazioni in ordine alla stipulazione, o no, del
contratto collettivo debba prevalere.
19. – Le vicende napoletane e torinesi, però, nella misura in cui attirano
l’attenzione anche sui problemi nella contrattazione collettiva periferica,
potrebbero costituire la buona occasione per tentare la revisione critica di
concezioni che, a ragione delle stratificazioni storiche del nostro diritto
sindacale, sono state anch’esse ereditate dal passato e che, con molta probabilità, continuiamo, soltanto per questo, ad utilizzare acriticamente.
Una concezione sulla quale sarebbe da riflettere è, a mio avviso, quella
che assegna una posizione dominante al contratto collettivo nazionale.
Sembra, infatti, che questo contratto collettivo non si caratterizzerebbe
soltanto per la tendenziale estensione della sua efficacia ad un intero setto-
ADL 1/2011
MATTIA PERSIANI
9
re della produzione, ancorchè da ciò possa, a volte, derivarne anche una rilevanza politica. Sembra, invece, si tratti di un contratto collettivo diverso
dagli altri quasi che fosse idoneo a condizionare l’efficacia dei contratti collettivi ad ambito territoriale minore.
Efficacia, però, che ha questo di caratteristico: sembrerebbe costituire
una qualità esclusiva del contratto collettivo nazionale in quanto non risulta ne sia stata postulata l’esistenza con riguardo ai contratti collettivi stipulati ai diversi minori ambiti territoriali, ancorchè anche tra questi potrebbe
essere individuata un qualche gerarchia.
20. – A ben vedere, però, mai è stato approfondito il problema di sapere quale sarebbe il titolo del potere dal quale deriverebbe quell’efficacia e
come quest’ultima si realizzi.
La supremazia del contratto collettivo nazionale è sempre stata data per
scontata tutte le volte che il discorso sia stato condotto in termini generali,
ma è stata anche, e per più versi, contrastata.
Dal punto di vista dell’esperienza sindacale, è stata superata con l’affermazione del metodo della contrattazione articolata anche se, poi, questa è
stata limitata alle materie oggetto di rinvio.
Dal punto di vista giurisprudenziale, è stata superata perché, quando si
è trattato di risolvere un contrasto fra contratti collettivi ad ambito territoriale diverso, il criterio prevalentemente utilizzato è quello della specificità.
21. – Ma v’è di più. L’idea di una centralità del contratto collettivo nazionale non è propria dell’ordinamento sindacale repubblicano.
Questo, infatti, è caratterizzato dal principio della libertà sindacale e,
quindi, dall’esclusione, quando non si tratti del contratto collettivo con efficacia generale previsto dalle disposizioni costituzionali non ancora attuate, di una qualsiasi gerarchia tra gli atti di autonomia sindacale.
Certo, le organizzazioni sindacali ben avrebbero potuto darsi una
struttura gerarchica che imponesse ai componenti gli organismi sindacali
territoriali di non stipulare contratti collettivi territoriali in deroga al contratto nazionale.
Ma, in caso di violazione, le eventuali deroghe sarebbero rimaste illese,
sussistendo, se mai una responsabilità sociale degli associati che le avessero poste in essere.
Esemplare, del resto, è il caso dell’accordo interconfederale che, nell’istituire le commissioni interne, vietava loro di stipulare accordi sindacali.
Diffusa è stata la violazione di questo divieto, ma, per quanto mi è dato di ricordare, mai venne messa in discussione la validità dei numerosissimi accordi aziendali conclusi dalle commissioni interne anche se i più timidi li
ADL 1/2011
10
PARTE PRIMA . SAGGI
qualificarono come contratti a favore di terzo. Stesso modo in cui, a quanto risulta, non venne mai prospettata la responsabilità di chi aveva sottoscritto quei contratti anche quando fossero stati iscritti ai sindacati o, addirittura, ne fossero stati dirigenti.
22. – Fatto è che l’ idea di una supremazia del contratto collettivo nazionale è stata anch’essa ereditata dall’ordinamento sindacale corporativo.
Questo, infatti, aveva esaltato il contratto collettivo nazionale sia perché era l’unico di competenza dei sindacati corporativi, sia perché, avendo
quel contratto efficacia generale per legge, non poteva che essere nazionale. In quella concezione era, poi, forte l’influenza della componente autoritaria di quel regime che non tollerò manifestazioni dell’azione sindacale
che non provenissero dai sindacati corporativi o che a questi facessero, comunque, concorrenza.
Per contro, la persistenza di quella concezione potrebbe anche essere
spiegata avendo riguardo alla nota circostanza che, nell’immediato secondo dopoguerra, il libero sistema sindacale venne necessariamente ricostituito a cominciare dall’alto e non, come era avvenuto, più o meno, un secolo prima, a partire dalla base e, cioè, dal basso.
L’impressione è che, da un lato, anche questa circostanza abbia finito
per conservare una sua qualche influenza e, d’altro lato, dispersa l’unità sindacale, sia stato inevitabile accentuare la dimensione politica dell’azione
sindacale e, con essa, l’esigenza di una centralità nazionale.
Dimensione politica nella quale, almeno nel versante dei sindacati dei
lavoratori, si registra la contrapposizione ideologica, prima ancora che strategica, delle due massime centrali sindacali: una costantemente aperta alla
ricerca del particolare e l’altra ferma nell’affermare l’esigenza di una centralità qual è quella espressa, appunto, dal contratto collettivo nazionale.
ADL 1/2011
Franco Carinci
Prof. ord. dell’Università di Bologna
LA CRONACA SI FA STORIA:
DA POMIGLIANO A MIRAFIORI
Sommario: 1. La vera posta in gioco: il sistema contrattuale e rappresentativo. – 2. Varietà della categoria metalmeccanica ed uniformità di disciplina. – 3. Il doppio compromesso dello Statuto dei lavoratori: associazionismo/movimentismo/pluralismo/unità. – 4. Esaurimento della “spinta propulsiva” del Protocollo del ’93. – 5. La riforma “separata”: gli accordi interconfederali del gennaio e dell’aprile 2009. – 6. L’Ipotesi di accordo categoriale
“separato” del 15 ottobre 2009: dalla rottura interconfederale a quella federale. – 7. L’accordo separato di Pomigliano del 15 giugno 2010: prevalenza della linea soft della Confindustria. – 8. L’accordo separato di Mirafiori del 23 dicembre 2010: prevalenza della linea
hard della Fiat. – 9. Dall’accordo di Mirafiori al contratto collettivo separato del 29 dicembre 2010: la chiusura del cerchio. – 10. Chi fa la “storia”, un uomo e/o una situazione?
1. – Se avessi scritto questo mio pezzo all’indomani dell’accordo di Pomigliano, cercando di sincronizzarlo e sintonizzarlo al dibattito svoltosi
nell’ambito del Seminario dedicatovi in quel di Bologna, lo avrei intitolato
con un’interrogazione, “Pomigliano, cronaca o storia”? Un titolo non particolarmente originale, ma destinato a enfatizzare quel dubbio ricorrente
che ogni avvenimento del nostro contesto istituzionale, politico, sindacale,
così ricco di coup de théâtre e così povero di fatti significativi, fa emergere:
ancora una volta molto rumore per nulla, un’occasione per rinfocolare una
guerriglia cronica, grave ma non seria, con la sua momentanea ora di gloria
negli indigesti pastoni giornalistici e nei logorroici talk-show televisivi; oppure questa volta, sì, un momento di svolta, una rottura di continuità, destinata a durare, anzi a caratterizzare una nuova stagione, se pur ancora in fase di incubazione. Scrivendolo ora, all’indomani del referendum di Mirafiori, l’interrogazione può ben lasciar posto all’affermazione qui prescelta,
perché a prender la parola “storia” nell’accezione minore, propria di chi la
vive, ristretta ad anni, non certo di chi la scrive, dilatata a decenni se non a
secoli, la linea di frattura risulta ormai non solo evidente, ma passibile di allargamento, sì da rompere la preesistente contiguità territoriale.
Quella fisica è solo una metafora, perché qui non c’è proprio nulla di empirico da vedere, verificare, misurare. E usarla può servire a materializzare
una valutazione, che, però, domanda d’essere precisata, a cominciare proprio da cosa ne costituisca l’oggetto. Dato il mestiere che mi è proprio, l’oggetto è certo il diritto del lavoro; ma attenzione: il riferimento è a quel che
chiamiamo diritto sindacale, assai più ed assai prima di quel che battezziamo come diritto del rapporto individuale di lavoro.
ADL 1/2011
12
PARTE PRIMA . SAGGI
È comprensibile che nello scontro al calor bianco, il fuoco reciproco colpisca meno il cambio radicale relativo al sistema di relazioni collettive, ed
assai più il patrimonio di diritti individuali, ex lege o ex contractu, presuntivamente messi in discussione. Sono proprio questi ultimi ad essere sentiti
dai lavoratori, che si raffigurano modi e tempi di lavoro diversi, con sforzi e
stress ricostruibili come fossero dei vissuti già sperimentati; e sono sempre
questi ultimi ad essere meglio percepiti dalla c.d. opinione pubblica, che si
identifica con individui concreti, in carne ed ossa, toccati nei loro stili e ritmi quotidiani.
Tutto ben comprensibile. Ma, avvalendomi del privilegio dello studioso
di selezionare quanto ritiene essere più rilevante e significativo rispetto ad
un processo che rimette in movimento un determinato status quo, è proprio
il nuovo incipit relativo al nostro sistema di relazioni collettive a meritare il
massimo dell’attenzione. Esso coniuga un duplice, interconnesso fenomeno: da un lato, un vero e proprio salto verso un radicale decentramento della bargaining unit (dall’industrial al company agreement), col correttivo “positivo” di un forte centralismo dei bargaining agents (le oo.ss. nazionali);
dall’altro, un ritorno ad un pluralismo rappresentativo di base (dalla rsu alle rsa), col correttivo “negativo” di un regime promozionale condizionato
dalla sottoscrizione del contratto collettivo da parte delle oo.ss. di riferimento, ciò a seguito del vulnus apportato all’art. 19 St. lav. dal referendum
abrogativo del 1995.
2. – Non sorprende che il processo abbia avuto come terreno elettivo la
categoria dei metalmeccanici, a tutt’oggi quella industriale per antonomasia, con – al 2007 – i suoi 1.600.000 addetti, pari al 10% dell’intera economia
ed al 47% dell’industria manifatturiera; e con i suoi 400 miliardi di euro di
fatturato, di cui 117 di VA, sì da contribuire per il 7,6 % al Pil e per il 48,8%
al VA dell’intera economia, nonché per il 53% alle esportazioni italiane. Numeri di per sé estremamente significativi, ma che lo diventano ancora di più
se si tiene presente che è l’industria metalmeccanica a produrre la totalità
dei beni di investimento in macchine ed attrezzature, sì da trasmettere l’innovazione tecnologica a tutti i rami e settori della vita economica.
Per quanto scontato, occorre ricordare che quella metalmeccanica, come
“categoria”, ha sì una sua base oggettiva, ma quale definita dal campo di applicazione del contratto collettivo nazionale, con a suo criterio base quello
costituito dall’oggetto dell’attività svolta: lavorazione del metallo e siderurgia. E tale definizione, così come poi dettagliatamente articolata, è figlia di
una scelta storica che non ha dalla sua alcuna ontologica giustificazione,
tanto che avrebbe potuto e potrebbe essere diversa, per es. elevando ad altrettante categorie autonome quelle considerate solo come settori interni
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
13
dallo stesso contratto collettivo, fra l’altro appiattiti sotto lo stesso regime
unitario: siderurgico autoavio, elettromeccanico ed elettronico, meccanica
generale, fonderie di seconda fusione, cantieristico.
Ne è risultata una categoria amplissima, omnicomprensiva fino ad una
estrema eterogeneità dei datori, dei processi e dei prodotti, dei moduli organizzativi, dei tipi e livelli di patrimoni professionali richiesti, dei mercati
ecc. , con l’aggravante tipica della struttura produttiva italiana, di una estrema frammentazione fortemente piramidale: oggi circa 60.000 imprese, di
cui quelle con meno di 200 dipendenti rappresentative del 98% del totale,
per il 59% degli addetti.
Al di là della ricostruzione storica di tale scelta, resta che essa risultava
pienamente sintonica rispetto alla opzione di fondo per un’organizzazione
sindacale ed una contrattazione industriali, cioè verticali, con una ricomposizione “classista”, che non solo superasse la tradizionale distinzione impiegati/operai, ma realizzasse una disciplina tendenzialmente uniforme a
scapito delle spinte centrifughe: anzitutto settoriali, a vantaggio dei settori
più deboli; poi, dimensionali, a favore delle imprese minori; infine territoriali, a pro delle realtà produttive meridionali. All’interno di tale contenitore era possibile combinare l’effetto traino esercitato dai trattamenti degli
impiegati, ieri, ed oggi dei quadri, dai settori più avanzati, dalle imprese
maggiori, dalle concentrazioni settentrionali, con una mobilitazione di
massa almeno tendenzialmente uniformatrice verso l’alto. Lo era, in forza
di una duplice caratteristica interdipendente, cioè la più forte stabilità e la
più forte propensione sindacale della forza lavoro, riconducibile, almeno
per la nostra categoria metalmeccanica, anche alla prevalenza degli operai
e dei maschi, diminuita nel corso del tempo, ma ancora attestata, rispettivamente, sul 60% e sull’82%. Ma, a riprova di quanto detto, questa duplice caratteristica risente sempre del fatto dimensionale, tanto che, stando ad
un’Indagine della Federmeccanica del 2009, la percentuale dei full time va
dall’88,4% delle imprese fino a 50 dipendenti al 96,6% di quelle oltre i
5000, con un valore medio del 94%; e, a sua volta, il tasso di sindacalizzazione dal 17% delle prime al 45,4% delle seconde, con un valore medio del
34,4%.
3. – Come ben noto, l’opzione a pro di una organizzazione categoriale
non solo venne risuscitata senza soluzione di continuità nel secondo dopoguerra, ma recepita ed ingessata nella nostra stessa Carta costituzionale,
senza peraltro trovare mai la via di una sua traduzione legislativa: certo per
una incoerenza intrinseca fra affermazione della libertà sindacale e predeterminazione eteronoma della struttura contrattuale; ma anche e soprattutto per il venire meno della sua precondizione, cioè l’unità sindacale. Il che
ADL 1/2011
14
PARTE PRIMA . SAGGI
non impedì il perpetuarsi dell’opzione in parola, peraltro non solo collaudata e consolidata, ma rispondente alla stessa situazione post-bellica. La lasciò, però, affidata all’evoluzione del sistema, tanto da permettere, prima –
al temine degli anni del boom, quelli ’50 – la faticosa nascita, e poi, al culmine degli anni del risveglio operaio, quelli a cavallo fra i ’60 e i ’70 – la turbolenta egemonia della contrattazione aziendale.
Lo Statuto dei lavoratori, che privilegia proprio l’azienda, cercando di
assicurarvi diritti di “cittadinanza” sia ai lavoratori uti singuli sia ai sindacati, lo fa riportando la promozione sul luogo di lavoro sostanzialmente nell’ambito di un sistema fortemente centralizzato e gerarchizzato, anzitutto
degli agenti, ma, poi, anche, indirettamente e direttamente, dei livelli contrattuali. Sotto la “copertura” delle tre Confederazioni, viste come le controparti e le garanti del “patto politico” sotteso allo Statuto, erano le associazioni ed i contratti nazionali di categoria ad uscirne da protagonisti, come reso del tutto evidente dal testo originario dell’art. 19, ma anche dell’art.
26, nonché confermato dall’art. 36 e dall’art. 28.
Il che rendeva del tutto verbale il compromesso fra “organizzazione” e
“movimento” realizzato in apertura dell’art. 19, con riguardo alle rappresentanze sindacali aziendali, costituibili “ad iniziativa dei lavoratori”, ma
“nell’ambito” delle associazioni sindacali di cui alle lett. a) e b), come ben
presto dovette essere riconosciuto. Tanto più che vi si parlava di rappresentanze sindacali aziendali, che nella pur asfittica esperienza pre-statutaria,
erano viste e vissute come istanze di base delle federazioni nazionali, formate dai rispettivi associati nelle unità produttive di riferimento.
Quest’ultima osservazione ci introduce ad un altro compromesso, assai
più rilevante e significativo, perché vero e proprio pilastro portante del titolo III dello Statuto, quello fra “unità” e “pluralismo”. Non v’è dubbio che
lo Statuto fu partorito in una stagione non solo di unità di azione, ma addirittura precludente all’unità organica, nell’idea illusoria di una “supplenza sindacale” da parte della Trimurti confederale, che avrebbe superato l’artificiosa e sterile contrapposizione partitica, con una assunzione in
prima persona della rappresentanza di una classe. Una classe, peraltro,
ben lontana dalla interpretazione offertane dalla letteratura marxiana: sia
come “classe in sé” (perché dilatata, nella sua composizione oggettiva, alla generica platea degli “sfruttati”), sia come “classe per sé” (perché resa,
nella sua presa di coscienza soggettiva, con una confusa mescolanza di
contrapposizione anti-capitalista, di ribellione anti-autoritaria, di solidarietà evangelica).
E non v’è dubbio, altresì, che lo Statuto depurasse e canalizzasse in senso riformista questa spinta unitaria; ma lo faceva con una sorta di dissociazione fra intentio e ratio legislativa: l’intentio la dava per scontata, fino al
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
15
punto da elevarla a precondizione implicita della stessa piena operatività
della sua politica promozionale, tesa ad una conversione negoziale e ad una
deflazione della conflittualità; la ratio la ridimensionava a possibilità implicita, perché, come detto, formalmente consacrava il pluralismo rappresentativo nelle unità produttive, fino al limite di anticipare un suo possibile superamento solo nei termini di una “fusione delle rappresentanze sindacali
aziendali” contemplata dall’art. 29.
Un duplice compromesso, uno esplicito ma apparente, perché tutto sbilanciato a pro dell’ “organizzazione” rispetto al “movimento”; e l’altro implicito ma reale, perché fondato sul presupposto dell’ “unità” e reso secondo la declinazione del “pluralismo”. Il tutto – deve essere aggiunto – assumendo a referente quella realtà manifatturiera e quella grande e media impresa, allora quantitativamente e qualitativamente assai più rilevanti di oggi, caratterizzate da elevati tassi, attuali o potenziali, di sindacalizzazione.
4. – La partita giocata dallo Statuto doveva risultare vincente, favorita nel
decennio ’70 da una crisi strutturale che restituirà una assoluta primazia
proprio alle Confederazioni, con l’anticipazione della concertazione: concertazione destinata a divenire una caratteristica del sistema, ma ad avere
un’evoluzione carsica. Essa era condannata a scontare la stretta delle rigidità produttive ed economiche imposte dalla competizione internazionale
e delle limitazioni finanziarie dettate dall’Unione europea, ancor prima che
la pur rilevante diversa coloritura politica del Governo di volta in volta in
carica.
La risposta al sovraccarico garantista costituito dallo Statuto e da un collective bargaining continuamente al rilancio e aggravato da quel lascito dell’autunno caldo costituito da un clima aziendale di conflitto strisciante, avverrà non per nulla proprio nel settore leader del manifatturiero, il metalmeccanico, e nella grande impresa per antonomasia, la Fiat. Vista a posteriori la vicenda dell’ ’80 sembra anticipare quella che si sta svolgendo sotto
i nostri occhi, con una Fiat alle prese con un mercato fortemente concorrenziale e competitivo, impegnata in uno scontro frontale con la Fiom per il
governo delle fabbriche. Che, allora, non solo una stagione si fosse chiusa,
ma che la c.d. gente se ne fosse resa consapevole, emerge con chiarezza dall’efficacia risolutiva della “marcia dei quarantamila”, testimonianza di una
perdita di egemonia della componente operaia su quella impiegatizia, con
una presenza degli emergenti quadri; e viene confermata in quella altrettanto storica vittoria referendaria del 1985 sulla decelerazione della scala
mobile, che vide ancora una volta la spaccatura interconfederale, fra una
Cgil trainata dalla Fiom e la Cisl e l’Uil, trasformata in una spaccatura politica, fra il Pci e il governo di centro-sinistra guidato da Craxi.
ADL 1/2011
16
PARTE PRIMA . SAGGI
Lo Statuto non veniva toccato, anzi avrebbe conosciuto un “prolungamento” nell’intervento legislativo a cavallo fra il decennio ’80 ed il decennio ’90, con riguardo al regime del licenziamento, individuale e collettivo,
ed al regime anti-discriminatorio. Ma era già in corso un processo di obsolescenza, dovuto al ridimensionamento dell’universo manifatturiero e all’esaurimento del classico modulo fordista, col passaggio ad uno stadio postindustriale ed informatico. Se pur non se ne poteva considerare l’unico responsabile, certo poteva dirsi che lo stesso Statuto avesse contribuito al
crescente dualismo del mercato del lavoro, fra insiders ed outsiders, cioè semi-protetti, non protetti, esclusi; e, rispetto agli stessi insiders, ad un irrigidimento nell’uso della forza lavoro costruito a misura di quel modulo fordista ormai chiaramente datato agli occhi di chi quel mondo imprenditoriale era costretto ad innovare per sopravvivere al confronto con l’estero.
Questo era il punctum dolens ben percepibile, tanto da dar vita a una sequenza di formulazioni correttive degli artt. 18 e 13, per ammorbidire sia il
primo, al fine di favorire il turn-over fra “interni” ed “esterni”, sia il secondo, allo scopo di flessibilizzare la mobilità professionale intra-aziendale;
nonché alimentare una parallela successione di proposte più o meno estensive dello stesso Statuto, destinato, secondo un indirizzo prolungatosi dal
ministro Treu al ministro Sacconi, tramite il comune consulente, Marco
Biagi, ad avere come suo legittimo successore uno Statuto non più dei lavoratori, ma dei lavori. Un grande travaglio di pensiero, dibattito, scontro,
specie con riguardo ad un qualsiasi ritocco dell’art. 18, assurto a invalicabile linea del Piave, come già a suo tempo l’indennità di contingenza. Ma, a
far da contrappeso alla salda tenuta di un contratto a tempo indeterminato
presidiato per tutto un universo “privilegiato” dalla c.d. tutela reale, ecco
fiorire una legislazione favorevole all’utilizzazione del contratto a tempo
determinato, alla valorizzazione del part-time, alla legittimazione del lavoro interinale, all’acquisizione di attività para-subordinata, sub specie prima
della collaborazione coordinata e continuativa, e poi, del lavoro a progetto.
C’era, però, un altro punctum dolens, meno visibile, ma più rilevante, cioè
quello attinente allo stesso indirizzo promozionale consacrato nel Titolo
III dello Statuto. Come visto, il compromesso raggiunto fra “unità” e “pluralismo” era di dar per scontata la prima e di declinare esplicitamente il secondo: naturalmente la convinzione era che quell’ “unità” sarebbe stata
realizzata in chiave consensuale, imputando la dote statutaria non alle rappresentanze sindacali aziendali, ma ad una rappresentanza unica, con una
più o meno forte composizione elettiva. Dato che la legittimazione di partenza era data in primis dall’essere associazioni sindacali aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative, era evidente che la scommessa
sull’ “unità” riguardasse anzitutto il vertice, con una sequenza gerarchica
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
17
dal nazionale all’aziendale, estesa dagli agenti ai corrispondenti livelli contrattuali: insomma, da una parte, unità di azione dei sindacati nazionali,
preliminare ad una unità organica della rappresentanza di base, vista come
cellula terminale comune; dall’altra, unitarietà del contratto di categoria,
altrettanto preliminare all’unitarietà del contratto aziendale, vissuti in un
rapporto correlato e coordinato fra I° e II° livello.
Solo che col decennio ’80 l’unità di azione al vertice ed organica alla base era entrata in sofferenza anche laddove era stata compiutamente realizzata, per una crescente divergenza di strategie fra Cgil e Cisl ed Uil, che
dalla diversa valutazione sulla crisi strutturale del Paese e dalla diversa risposta privilegiata (ideologico-politica e rispettivamente pragmatica-tradeunionista) riportava in primo piano una risalente differenziazione circa
il rapporto fra contrattazione di categoria e contrattazione aziendale; ma la
riportava, spostandola, per così dire in avanti, cioè con riguardo allo stesso
punto di equilibrio raggiunto.
A far da scena di fondo c’era la contrapposizione emersa nel corso del
decennio ’50 fra Cgil e Cisl, risolta, all’inizio del decennio ’60 a pro di quella “contrattazione articolata”, destinata ad essere rinnegata nel turmoil
dell’ “autunno caldo”, per riemergere nella stagione dei Protocolli dell’ultimo ventennio del secolo. Quel che ormai tentava la Cisl era di rimettere in
discussione la stessa formula consolidata, con una contrattazione aziendale non più di mera integrazione, ma di relativa autonomia: un II° livello rimpolpato rispetto ad un I° o dimagrito ad accordo quadro o flessibilizzato ad
accordo derogabile.
Peraltro, all’inizio del decennio ’90, la congiuntura era sfavorevole: la
crisi finanziaria, resa drammatica dalla sua dimensione quantitativa, tale da
poter escludere la stessa partecipazione alla costruzione europea in itinere,
veniva accompagnata dalla crisi istituzionale. In questa situazione, un Governo tecnico e le parti sociali erano chiamati a riempire il vuoto lasciato
dall’uscita di scena della scala mobile, che restituiva alla contrattazione
un’area di manovra più ampia, ma al tempo stesso una responsabilità più
grande. E, nel contesto di una condivisa politica dei redditi ancorata all’inflazione programmata, il Protocollo del ’93 sembrava costituire il tanto invocato completamento consensuale dell’impianto dello Statuto dei lavoratori: consacrava l’unità d’azione al vertice e l’unità organica alla base, in ragione e funzione di un sistema contrattuale confederalizzato e funzionalizzato alla politica dei redditi, con un I° livello delegato al mantenimento del
potere d’acquisto ed un II° destinato al recupero dell’incremento di produttività; e lo faceva, con a contropartita la scommessa su una concertazione destinata ad essere sempre più formalizzata ed istituzionalizzata.
Così letto ed interpretato nel suo nocciolo duro, il Protocollo avrebbe
ADL 1/2011
18
PARTE PRIMA . SAGGI
avuto un indubbio successo in termini di contenimento salariale. Peraltro,
una volta esaurito il suo compito di contenimento della spirale inflazionistica, avrebbe fatto esplodere lo squilibrio del do ut des: da un lato, un ritardo cronico nel recupero del salario reale; dall’altro, uno svuotamento della
concertazione che, proprio al climax della sua formalizzazione sul finire del
decennio ’90, sarebbe risultata sempre più inflazionata nella partecipazione e sempre meno dotata di contropartite pubbliche, nonché largamente
condizionata in una democrazia dell’alternanza dal Governo in carica.
Col procedere del primo decennio del nuovo secolo avrebbe ripreso vigore quell’aspetto già visto di una diversità di strategie rispetto ad un sistema contrattuale che privilegiava l’aspetto retributivo rispetto a quello organizzativo. Non era più sufficiente restare ancorati ad una tendenziale uniformità del trattamento normativo stabilito al I° livello, per ridurre il rapporto fra I° e II° a quello fra adeguamento del salario nominale e recupero
dell’incremento della produttività; il fatto era che la produttività risultava
in cronico calo, con un crescente divario negativo rispetto all’estero; e rilanciarla richiedeva una forte iniezione di innovazione e quindi di riorganizzazione, al di fuori ed al di là della rigida camicia di forza costituita da un
contratto nazionale, fra l’altro costruito a misura di una categoria tanto ampia quanto eterogenea.
Certo tutto questo non sembrava all’ordine del giorno in quel lontano
1993, che, anzi vedeva traslato il modello del Protocollo nel pubblico impiego privatizzato, ma qui con un intervento legislativo che lo toglieva alla
disponibilità delle parti, tagliando a priori il nodo della rappresentanza dei
lavoratori al vertice ed alla base, secondo una soluzione che l’esperienza
avrebbe dimostrato non esportabile sic et simpliciter nel settore privato; e,
comunque, perpetuando il vecchio pregiudizio che tutto questo avrebbe
potuto automaticamente tradursi in un incremento in termini di efficienza
ed efficacia delle pubbliche amministrazioni, come la stessa Corte costituzionale aveva ritenuto per licenziarne la legittimità. Il risveglio avvenuto
nel corso del primo decennio del secolo nuovo sarebbe stato amaro, fino a
portare alla tanto contrastata riforma Brunetta.
In quello stesso torno di tempo, però, sarebbe stato proprio il referente
legislativo costituito dal Titolo III dello Statuto ad essere completamente
svuotato ad opera dei referendum del 1995. Col senno di poi, si può ben dire che tutta una componente radicale, politica e sindacale, che li promosse
e li appoggiò, fece la parte dell’apprendista stregone, ma è il risultato, destinato a divenire esplosivo proprio ai nostri giorni, ad interessare. Il criterio principale del primato confederale, già indebolito da un indirizzo giurisprudenziale lassista, venne eliminato, con la soppressione della lettera a),
ed il criterio sussidiario del primato del contratto di categoria venne sop-
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
19
presso con l’amputazione della lettera b): d’allora in poi l’ingresso al trattamento promozionale di cui al Titolo III avrebbe richiesto la sottoscrizione
di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. Non solo, perché il supporto legislativo alla raccolta dei contributi tramite delega ai datori di lavoro venne meno, con l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 26, creando un
vuoto che solo la contrattazione collettiva avrebbe potuto riempire.
La ricaduta immediata si ebbe in sede della sempre più frequente delega
legislativa ad una contrattazione collettiva derogatoria, integrativa, suppletiva, con una sostituzione alla consolidata nozione di “maggiormente rappresentativa”, se pur progressivamente dilatata, di quella assai più generica
e manipolabile di “comparativamente più rappresentativa”, fra l’altra predicata, con una incoerente assenza di sistematicità, a confederazioni e/o federazioni e/o rappresentanze aziendali, se non, con un’omnicomprensività
di difficile giustificazione, ad organizzazioni, associazioni sindacali non ulteriormente qualificati; o, addirittura, sostituita con una diretta chiamata in
causa della contrattazione, senza precisarne gli agenti, ma al massimo il livello. Che cosa questo abbia significato per fondarne un’efficacia della
stessa contrattazione tale da investire l’intera generalità interessata, come la
delega legislativa avrebbe dovuto far supporre, è ben noto a lippis et tonsoribus.
5. – Non per nulla il sistema era destinato ad esplodere proprio nella categoria leader costituita da quella metalmeccanica; e non per nulla ad avere il suo epicentro in quel settore strategico rappresentato dal settore auto,
egemonizzato dalla Fiat: settore che conta oggi 1.750 imprese, per complessivi 174.000 dipendenti, ma con una prevalenza assoluta in termini di
occupazione e di produzione della grande impresa torinese. Qui era destinata a svolgersi una sorta di riedizione dell’epica battaglia dell’80, con a
co-protagonisti Fiat e Fiom, ma con più di una differenza, tale da renderla
meno emblematicamente radicale, ma più significativa con rispetto non
solo ai rapporti di forza, ma anche ai cambiamenti di sistema. Da un lato
una Fiat, confrontata da un mercato dell’auto ancor più concorrenziale, tenibile solo a prezzo di un aumento del volume produttivo, effettuato con
un maggior valore aggiunto ed un minor costo; dall’altro una Fiom, assestata sulla difesa di un patrimonio acquisito da gestire in prima persona, avvalendosi di una sua indubbia forza in termini di base e di capacità di mobilitazione.
A dire il vero lo scenario era già mutato allo stesso livello interconfederale, con una frattura che si era venuta approfondendo dal c.d. Patto per l’Italia del 5 luglio 2002 all’accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali 22 gennaio 2009, entrambi “separati”, per la chiamata fuori della Cgil.
ADL 1/2011
20
PARTE PRIMA . SAGGI
Certo non senza un decisivo influsso del quadro politico, perché fra il Patto per l’Italia e l’accordo quadro, conclusi sotto il secondo e rispettivamente il terzo Governo Berlusconi, c’era stato, a rompere il continuum, un Protocollo unitario, il c.d. Protocollo welfare del 23 luglio 2007, stipulato sotto
il secondo Governo Prodi.
Pur dando per scontato questo influsso, accentuato dal clima fortemente polarizzato e radicalizzato, rimane pur sempre che il focus del confrontoscontro era sindacale. Il che risulta chiarissimo con riguardo all’accordo
quadro 22 gennaio 2009, poi seguito da quell’Accordo interconfederale 15
aprile 2009 per la sua attuazione qui assunto come referente. Non intendo
ritornare su un argomento già trattato, se non per sottolineare come il dissenso si fosse aperto non sull’an ma su il quomodo di rivedere il glorioso Protocollo del ’93, che, come detto, aveva ormai assolto al suo compito principale, quello anti-inflattivo. Se, da una parte, se ne criticava il dinamismo del
salario categoriale, sempre in ritardo rispetto ad un tasso di inflazione non
più tale da preoccupare; dall’altra, se ne sottolineava il riscontro poco o
nulla significativo del collegamento fra salario aziendale e produttività.
A tener conto di quanto enfatizzato nello scontro e nello stesso intervento correttivo, l’aggiornamento del Protocollo del ’93, quale anticipato dall’accordo del gennaio e definito dall’accordo dell’aprile qui assunto a referente, – sempre col dissenso della Cgil – finiva per essere centrato sull’indicatore della crescita dei prezzi al consumo, offerto non più da un tasso di
inflazione programmata ormai svalutato dal suo essere fissato d’autorità, in
funzione esclusiva della politica economico-finanziaria del Governo; ma
dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia (IPCA), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici, secondo
il giudizio di un “soggetto terzo”. Il che, peraltro, non sembrava rimettere
affatto in discussione il preesistente sistema contrattuale fortemente centralizzato e gerarchico: riaffermata la primazia del contratto nazionale, come regolatore dell’intero sistema articolato su un doppio livello e garante
di un trattamento base uniforme sull’intero territorio nazionale, peraltro riunificando su una scadenza triennale la parte normativa ed economica, in
coerenza all’abbandono del referente costituito dall’inflazione programmata; riconfermata la consolidata apertura, almeno sulla carta, al contratto
decentrato, quale strumento di rilancio della produttività e della retribuzione reale.
Il continuismo era comprensibile, dato che un sistema coordinato e controllato, così come consolidatosi nell’arco di un cinquantennio, era e restava nel comune interesse; né appariva sostituibile con un nuovo e pieno regime senza l’adesione della Cgil. Restava l’idea di un’adesione successiva,
tant’è che la riforma veniva considerata sperimentale, destinata ad essere
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
21
verificata in prossimità della sua scadenza, il 15 aprile 2013. Ma c’era del
nuovo, che, riletto oggi, risulta assai più significativo di quanto apparisse allora, a cominciare dalla enfatizzata connessione fra rappresentanza e responsabilità: connessione che affiora assai più che nelle formalizzate procedure di rinnovo, peraltro già note, nella affermata sinallagmaticità fra
nuovo regime delle rsa/rsu e dovere di pace sindacale. Se, da un lato, il
punto 7.1 dell’accordo interconfederale attuativo rinviava “ad uno specifico
accordo interconfederale per rivedere ed aggiornare le regole pattizie che
disciplinano la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo ivi compresa
la certificazione all’Inps dei dati di iscrizione sindacale”, con un’indubbia
apertura alla Cgil; dall’altro, il punto 7.2 aggiungeva subito che per “un regolare sistema di relazioni industriali le parti si impegnano a rispettare e a
far rispettare – nell’esercizio del cosiddetto potere d’influsso proprio delle
organizzazioni delle imprese e dei lavoratori – tutte le regole che sono liberamente definite in materia di contrattazione collettiva”. Il che lasciava
aperto il vecchio problema dell’enforcement, ma al tempo stesso lo poneva in
primo piano, elevandolo implicitamente a nodo da sciogliere contestualmente.
Non solo, perché c’era dell’altro, che riguardava proprio il rapporto fra
contratto categoriale ed aziendale. Quel che si auspicava era un diverso
rapporto nel salario, sicché quello fisso stabilito dal primo lasciasse più spazio a quello variabile distribuito dal secondo, con a supporto l’intervento
defiscalizzante del Governo; ma non si ignorava che questo avrebbe lasciato scoperto l’ampio universo privo di un contratto collettivo aziendale. Ecco allora la previsione di un “elemento di garanzia retributiva” che il punto
4.1 presentava come un incentivo indiretto ad una estensione del contratto,
ma che in realtà puntava ad attenuare il differenziale retributivo che altrimenti si sarebbe creato: “i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria stabiliscono che sia riconosciuto un importo . . . a titolo di elemento di
garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di
contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti
economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria”.
Non è tutto, perché col punto 5.1, rubricato in modo anodino “Intese per
il governo delle situazioni di crisi e per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio”, si toccava un nervo scoperto, quello delle “deroghe
al contratto nazionale di categoria”. Certo la formulazione era prudente,
perché si accoppiavano due situazioni e finalità diverse, “governare direttamente nel territorio situazioni di crisi aziendali” o “favorire lo sviluppo
economico ed occupazionale dell’area”, con la prima, sufficientemente
ADL 1/2011
22
PARTE PRIMA . SAGGI
specifica e scontata, a far da copertura alla seconda, largamente generica ed
innovativa; e perché si delineavano condizioni procedurali rigide per le intese, quali la loro previsione nei contratti di categoria, la loro trattazione e
conclusione “fra le Associazioni industriali territoriali e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti”, nonché la loro
successiva approvazione “dalle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria interessata”. Ma l’ambito delle possibili “deroghe” restava assai largo, tanto da essere individuato al primo paragrafo, come ricomprensivo di tutte quelle dirette a “modificare in tutto o in parte,
anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”. E
non è che nel secondo paragrafo esso venisse più di tanto precisato: “La capacità di modificare è esercitabile sulla base di parametri oggettivi individuali nel contratto nazionale quali, ad esempio, l’andamento del mercato
del lavoro, il livello di competenze e professionalità disponibili, il tasso di
produttività, il tasso di avvio e di cessazione delle iniziative produttive, la
necessità di determinare condizioni di attrattività per nuovi investimenti”.
Non lo veniva, perché qui si davano criteri relativi ai fini giustificativi, non
ai loro impatti su istituti economici e normativi; anche se pare evidente che,
dando per scontati i limiti inderogabili legislativi, i compromessi fra costi e
vantaggi per i lavoratori non potevano essere effettuati se non attraverso
giudizi sintetici a misura dei singoli casi. Ma se così è, il contratto di II° livello avrebbe potuto spingersi fino ad “espropriare” in modo significativo
quello di I°, fino al limite logico se non pratico, di configurarsi esso stesso
come un quasi-contratto di I° livello.
6. – All’indomani dell’accordo interconfederale attuativo, la palla passava alle Federazioni di categoria della Cisl e della Uil, che avrebbero dovuto
vedersela con il suo carattere di accordo separato, una volta impegnate nel
rinnovo della parte economica biennale dei contratti collettivi, a suo tempo
siglati unitariamente. Senza scendere nei dettagli, si può dire che il processo si svolse in modo niente affatto traumatico, con un comportamento
pragmatico e compromissorio da parte delle stesse Federazioni della Cgil,
con l’unica eccezione, ma estremamente pesante, quella della Fiom. Veniva
così riecheggiato e moltiplicato a livello categoriale lo strappo avvenuto a
livello interconfederale: il 15 ottobre 2009, Federmeccanica, Fim ed Uilm
firmano un’Ipotesi di accordo separato che non si limita ad aggiornare la
parte economica biennale, ma si prolunga a revisionare anche la parte normativa quadriennale del contratto collettivo nazionale del 20 gennaio 2008
per l’industria metalmeccanica privata, quest’ultimo, a suo tempo, sottoscritto anche dalla Fiom.
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
23
A dire il vero, il tema più caldo, quale costituito dal recepimento del nuovo rapporto fra contratto di I° e di II° livello di cui all’accordo interconfederale 15 aprile 2009, veniva rinviato alla stesura del testo definitivo, con la
contestuale istituzione di una Commissione paritetica incaricata di predisporre “linee guida per la definizione dei premi di risultato” entro il giugno
2010 e regole in tema di “disciplina integrativa aziendale” entro il dicembre
2010. Ma, a tale ultimo riguardo, il tono era piuttosto prudente, dato che vi
si sottolineava l’intento “di consolidare il modello contrattuale fondato su
due livelli di contrattazione, introdotto con il Protocollo del 23 luglio 1993
così come integrato dall’Accordo interconfederale 15 aprile 2009”, dando
in questo modo per scontato un sostanziale continuum; e vi si fissava un preciso percorso per la Commissione. Il mandato conferito alla Commissione
non calcava la mano, perché richiedeva di conformare il regime del contratto di II° livello a quanto innovato dall’accordo interconfederale dell’aprile 2009, ma con riguardo al suo punto 3 (“Il secondo livello di contrattazione”), senza alcun richiamo esplicito del punto 4 (“Elemento di garanzia retributiva”) e soprattutto del punto 5 (“Intese per il governo delle situazioni di crisi e per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio”). Non solo: qui, ricalcando quello stesso accordo interconfederale, si
continuava a parlare di rappresentanze sindacali unitarie, sì da dar per
scontato che la crisi dell’unità di azione verificatasi a livello confederale e
federale non rimettesse in discussione l’unità organica della presenza sindacale in azienda.
Il punctum dolens restava quello costituito dall’efficacia dell’Ipotesi dell’ottobre 2009, destinata a confrontarsi con una problematica complicata,
data dalla sovrapposizione temporale fra l’Ipotesi stessa ed il precedente
contratto nazionale del gennaio 2008. Secondo la tempistica in vigore ai
sensi del Protocollo del luglio ’93, il contratto nazionale aveva una durata
distinta, quadriennale per la parte normativa “fino a tutto il 31 dicembre
2011”, e biennale per la parte economica, “fino a tutto 31 dicembre 2009”;
mentre, stando alla tempistica stabilita dall’accordo interconfederale dell’aprile 2009, unica e triennale, l’Ipotesi prevedeva una decorrenza dal 1°
gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.
Ora la complicazione non riguardava tanto una rivisitazione della parte
economica del contratto nazionale del 2008, di cui era prevista la scadenza
biennale proprio al 31 dicembre 2009; e, comunque, una rivisitazione migliorativa. Riguardava, invece, la riscrittura della parte normativa, di cui era
contemplata una scadenza quadriennale al 31 dicembre 2011, ora destinata
a fare i conti con la tempistica dell’Ipotesi, per la sua sostituzione con la
nuova disciplina 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012. Ritornava, così, di
estrema attualità la problematica dell’efficacia di un accordo separato, con
ADL 1/2011
24
PARTE PRIMA . SAGGI
l’ulteriore complicazione di un suo sovrapporsi ad un contratto unitario
non ancora scaduto. Tanto più che qui il primo non sostituiva completamente il secondo: qua e là lo richiamava per modificarlo; e, comunque, lasciava un vuoto non riempibile altrimenti se non per rinvio implicito al contratto unitario precedente.
Questo per il presente, mentre per il futuro era destinata ad incombere la
classica clausola della proroga tacita e dell’ultra-attività, inclusa more solito
nel contratto nazionale del gennaio 2008: “Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il presente
Contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo
Contratto nazionale”.
7. – Se pur l’Ipotesi di accordo dell’ottobre 2009 non desse corso al rinvio
di cui al punto 5 dell’accordo interconfederale dell’aprile 2009, circa il previo
varo di un regime a livello categoriale delle intese derogatorie del contratto
nazionale stipulabili in sede territoriale, tale punto troverà il suo test in un accordo aziendale firmato a Roma il 15 giugno 2010, dalla Fiat Group Automobiles S.p.A., assistita dall’Unione industriale di Torino e dall’Unione degli industriali di Napoli, e dalla Fim, Uilm e Fismic nazionali e di Napoli. È su questo testo che è stato condotto l’approfondito confronto dell’ultimo Seminario
di Bertinoro, cercando di districare un vero e proprio groviglio giuridico:
groviglio prodotto da un contratto aziendale separato (accordo di Pomigliano del giugno 2010), che attuava il punto più conflittuale di un accordo interconfederale pure separato, il 5 (accordo interconfederale dell’aprile
2009), senza il previsto passaggio intermediatorio per via di un contratto nazionale (Ipotesi di accordo dell’ottobre 2009), intervenuto sì, ma silente al riguardo, nonché, soprattutto, se pur separato, inteso a modificare la parte non
ancora scaduta del contratto nazionale unitario del gennaio 2008.
Non intendo qui né riprendere quanto già svolto altrove, né ricostruire
se pur sinteticamente quel dibattito svoltosi nel Seminario, perché è tutto
scritto e pubblicato, meritevole di essere appreso dalla viva “voce” dei partecipanti, senza aggiungere e togliere niente, a rischio altrimenti di mortificarne od alterarne la ricchezza. Desidero, invece, approfittare del privilegio
auto-accordatomi di essere l’ultimo, quello che chiude la porta, per rivedere come l’accordo di Pomigliano costituisse non una istantanea a sé, ma la
prima immagine di una pellicola di cui è stata sviluppata ormai una gran
parte: una prima immagine, cui ne seguono altre, in quello stesso 2010, cioè
l’accordo categoriale 29 settembre 2010, sulle “intese modificative”, l’accordo Mirafiori del 23 dicembre 2010, il contratto collettivo di Pomigliano
del 29 dicembre 2010.
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
25
Secondo l’angolo di visuale prescelto, mi limiterò a considerare l’impatto sul sistema contrattuale, senza questa volta lasciarmi coinvolgere nel pur
interessante e significativo confronto circa il se ed il come possa essere stato compromesso il patrimonio garantista o appesantito il carico fisio-psichico dei singoli lavoratori. D’altronde, continuo a ritenere che, pur dando
per ovvio il peso esercitato dall’ “indurimento” dell’impegno richiesto agli
occhi dei diretti interessati, così come percepito e rappresentato, il vero
cuore dello scontro sia stato costituito dal ruolo dei protagonisti collettivi,
per quel che si aspettavano dovesse derivarne per il presente e per il futuro.
In una sintesi, che certo non rende la complessità della vicenda nella sua
frenetica evoluzione, ma serve a dipingere con qualche rapida pennellata la
scena di fondo, si deve prendere atto dell’ “assenza della politica”, da intendersi, però, nella sua vera portata: di mancanza non di un’attenzione, di
una presa di posizione, di una schermaglia fra una coalizione di centro-destra compatta a favore dell’operazione, ed una di centro-sinistra combattuta e divisa fra il pro ed il contro; ma di una mediazione governativa accompagnata e rafforzata dalla messa a disposizione di risorse pubbliche. Personalmente ritengo che non fosse più possibile battere quest’ultima via una
volta usata ed abusata, per la concomitante presenza di impedimenti giuridici e finanziari e di vincoli dettati da oltre oceano; ma che non fosse nemmeno opportuno.
Qualunque sia il giudizio, però, il fatto è che la partita si è svolta tutta fra
le parti sociali, secondo una contrapposizione tutt’altro che lineare. Sulla
sponda datoriale c’è stata una indubbia diversità di vedute fra una Confindustria, costretta a navigare fra Scilla e Cariddi, “perdere” la Fiat o “destabilizzare” un’intera categoria dominata dalla medio-piccola impresa; e, rispettivamente, una Fiat condannata a mettere sul tavolo l’ultima carta,
quella di una joint venture italo americana, tutta giocata sulla messa a disposizione di dollari, pubblici e privati, a pro di una significativa crescita nel
mercato automobilistico e – perché no – borsistico. Una diversità di vedute, questa, che condizionerà la vicenda, con una concessione iniziale alla linea soft di Confindustria, come testimoniato dall’accordo di Pomigliano del
giugno; ma con una ricezione finale della linea hard della Fiat, come evidenziato dall’accordo di Mirafiori del dicembre 2010.
Sull’altra sponda, quella sindacale, la contrapposizione destinata ad incattivirsi strada facendo era fra la Fiom e gli altri sindacati; ma, al tempo
stesso, c’era, se pur non una contrapposizione, una dialettica continua ed
intensa anche fra la Fiom e la Cgil. Per quanto meno appariscente, quest’ultima ha giocato indubbiamente una parte importante, riecheggiando ed
amplificando una divisione presente all’interno della Confederazione, tutt’altro che priva di sponda all’esterno, in una sinistra incapace di converge-
ADL 1/2011
26
PARTE PRIMA . SAGGI
re su una sintesi condivisa fra l’anima riformista e l’anima tardo-classista o
movimentista. È ipotizzabile che la Fiom abbia vissuto la sua battaglia come una minoranza nella Confederazione (con un 6% degli iscritti ed un
17% dei voti per la sua mozione, contro l’83% per la mozione Epifani-Camusso, nell’ultimo Congresso della Cgil), tesa a radicalizzarne la strategia e
come un’avanguardia nel Paese, capace di esprimerne la diffusa precarietà
economica e sociale; e che l’abbia fatto in forza di una ideologia ed una cultura sopravvissute alla stagione sessantottesca, perché radicate nella residua realtà dell’ “operaio massa”, ormai largamente minoritaria rispetto a
quella dell’ “operaio diffuso”.
Questo non toglie che la battaglia abbia avuto come suo epicentro un
duplice nodo sindacale: costituito, il primo, dal rapporto fra I° e II° livello;
rappresentato, il secondo, dall’esercizio del diritto di sciopero. E nel condurre tale battaglia la Fiom ha certo rivelato una notevole spregiudicatezza.
Se riusciva scontata la contrarietà di principio ad un contratto aziendale
che derogasse a quello nazionale, con piena sintonia fra la Fiom e la Cgil,
che anche per questo si era rifiutata di sottoscrivere l’accordo interconfederale dell’aprile 2009; risultava, altresì, provata una prassi di contrattazione aziendale derogatoria con la stessa Fiom come protagonista. E se riusciva indubbia l’opposizione a qualsiasi limite all’esercizio individuale del diritto di sciopero; risultava, anche, possibile una lettura delle due clausole
più discusse dell’accordo di Pomigliano, la 14 (clausola di responsabilità) e
la 15 (clausole integrative del contratto individuale di lavoro) che evidenziasse come ad essere messa in questione era la fase collettiva, preliminare
(proclamazione) o contestuale (influenza), se pur fino al limite di una sorta di responsabilità oggettiva, e non quella individuale (astensione). Possibile, anzi obbligata, perché a prescindere dalla lettera ambigua di tali clausole, tanto da non andare affatto esenti da critica, una diversa interpretazione, una volta messa in pratica, non sarebbe riuscita a trovare alcuna conferma giudiziale da parte di una giurisprudenza, a tutt’oggi unanimemente
favorevole alla titolarità individuale del diritto di sciopero, nonostante
qualche riserva a pro della titolarità sindacale o perlomeno collettiva dello
stesso diritto coltivata da una certa dottrina di “sinistra” (!).
Solo che alla Fiat la Fiom non intendeva fare alcuna concessione derogatoria, perché era la Fiat, cioè l’impresa metalmeccanica per antonomasia,
quella per cui un’eccezione non avrebbe confermato, ma avrebbe sostituito la regola; né intendeva accettare alcuna corresponsabilizzazione rispetto all’osservanza della disciplina contrattuale, perché significava farsi garante e guardiana della pace sociale rispetto all’intera platea dei lavoratori.
Il che – perfettamente rispettabile se pur non condivisibile - sarebbe rimasto occultato in una campagna di opposizione tutta condotta all’insegna di
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
27
un sovraccarico fisio-psichico, tale da portare ad uno sfruttamento, fuori da
ogni misura e da ogni comparazione; e, rispettivamente, di un esproprio
del patrimonio garantista non solo legislativo, ma anche costituzionale. Un
rullar di tamburi continuo ed ossessivo, accompagnato da un disinteresse
per il risultato immediato, tale da apparire al limite del cinismo, dato che
era in gioco uno stabilimento estremamente significativo per il livello occupazionale assicurato, dentro e fuori, nell’indotto, nonché per il territorio
debole presidiato.
Un disinteresse, peraltro, più apparente che reale, visto l’impegno profuso nello svolgimento del referendum; ma anche reale, perché ad essere considerato prioritario non era l’esito della battaglia, ma il posizionamento in
vista della guerra così apertasi: era opportuno vincere la battaglia referendaria in corso; ma era necessario, anzi essenziale, condurla, anche a fronte
di un’elevata probabilità di perderla, perché una sconfitta ora avrebbe permesso una rivincita domani.
Il punto di maggior difficoltà per la Fiom era quello relativo al referendum
sull’accordo separato: da un lato, era lo strumento consacrato da sempre
come quello democratico par excellence; dall’altro, proprio per questo risultava pericoloso legittimarlo in un caso in cui avrebbe molto probabilmente
dato semaforo verde ad un accordo separato. Come venirne fuori? Il modo,
che sarà poi elevato a modello applicato anche nel successivo caso di Mirafiori, è stato quello di considerarlo illegittimo: nell’oggetto, perché l’accordo sottopostovi sarebbe risultato contrario all’ordinamento giuridico ed all’ordinamento sindacale; e nello svolgimento, perché il risultato sarebbe riuscito alterato dal sotteso ricatto occupazionale: il sì, pollice a favore, il no,
pollice contrario al lavoro.
Il che, però, non era destinato ad essere seguito da un comportamento
coerente, perché la Fiom avrebbe condotto senza risparmio di colpi il combattimento referendario; ed una volta risoltosi con un successo del sì del
63%, notevole, ma al di sotto del previsto, avrebbe rivendicato per sé il
37% dei no, enfatizzando il fatto che fosse superiore al suo tasso di sindacalizzazione.
8. – A Pomigliano aveva prevalso la linea soft della Confindustria: l’accordo era sottoscritto da una Fiat ancora aderente alla Confindustria, tanto da
farlo con l’assistenza dell’Unione industriali di Torino e dell’Unione degli
industriali di Napoli; era formalmente un accordo aziendale relativo allo
stabilimento Gian Battista Vico, che spendeva il punto 5 dell’accordo interconfederale dell’aprile 2009, se pur l’Ipotesi di accordo dell’ottobre 2009
non gli aveva dato attuazione; era siglato da Fim, Uilm e Fismic Nazionali e
di Napoli, senza l’adesione della rsu, ma non rimetteva in discussione que-
ADL 1/2011
28
PARTE PRIMA . SAGGI
st’ultima; era aperto ad un successivo ingresso della Fiom, senza prevedere
un previo semaforo verde da parte di ciascun sottoscrittore originario.
Solo che la linea hard della Fiat avrebbe tardato ben poco a manifestarsi
con la sua prima mossa, la registrazione avvenuta il 19 luglio 2010, di una
newco “Fabbrica Italia”, controllata al 100% da Fiat Partecipazioni, che faceva sospettare quale fosse la sua direzione di marcia, verso un’uscita da
Federmeccanica e la chiamata fuori dallo stesso contratto nazionale di lavoro. Dura protesta della Fiom, ma anche viva preoccupazione della Fim e
della Uilm; mentre Federmeccanica abbozzava, tanto da inviare il 7 settembre 2010 la disdetta dal contratto collettivo “unitario” del gennaio
2008, con grande anticipo rispetto alla previsione contrattuale, per la quale sarebbe stato sufficiente trasmetterla tre mesi prima della scadenza, cioè
del 31 dicembre 2011. Per esplicita ammissione la disdetta era giustificata
dall’opportunità di rimuovere in anticipo ogni eccezione di ultrattività di
quel contratto del gennaio 2008 oltre la data prevista, lasciando così il campo completamente sgombro all’Ipotesi di accordo categoriale dell’ottobre
2009, che era intervenuto dopo, peraltro con una sorta di malformazione
congenita, perché, come noto, era separata.
Solo che un’anticipazione temporale così lunga doveva risentire della
paura del momento, che, cioè, la Fiat scappasse di mano. Paura condivisa,
tant’è che un accordo categoriale raggiunto il 29 settembre dello stesso
2010, tra Federmeccanica, Fim ed Uilm, interveniva a “sanare” l’assenza di
una traduzione a livello categoriale del famoso punto 5 dell’accordo interconfederale separato dell’aprile 2009: a “sanare”, perché tale assenza
avrebbe dovuto essere riempita prima, non dopo l’accordo di Pomigliano
del giugno 2010.
Proprio qui riesce confermato quanto già anticipato a proposito dell’Ipotesi di accordo categoriale dell’ottobre 2009, che, cioè, desse per scontato
il rinvio implicito al contratto nazionale del gennaio 2008, incorporando
quanto non modificato. Tant’è che l’accordo categoriale pur sempre separato del settembre 2010 aggiungeva proprio alla sezione terza, sul sistema
di regole contrattuali, del contratto nazionale unitario del gennaio 2008,
un art. 4 bis, sulle intese modificative del CCNL. Rispetto al suo referente,
cioè il punto 5 dell’accordo interconfederale separato dell’aprile 2009, l’art.
4 bis presentava qualche variante, fra cui la più significativa riguardava una
precisazione del contenuto. Ai sensi del 4° comma dell’art. 4 bis, le “intese
modificative dovranno indicare: gli obbiettivi che si intendono conseguire
(qualora di natura sperimentale o temporanea), i riferimenti puntuali agli
articoli del CCNL oggetto di modifica, le pattuizioni a garanzia dell’esigibilità dell’accordo con provvedimenti a carico degli inadempienti di entrambe le parti”; mentre a termini del 5° comma le “intese modificative non
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
29
possono riguardare i minimi tabellari, gli aumenti periodici d’anzianità e
l’elemento perequativo oltreché i diritti individuali derivanti da norme inderogabili di legge”. Trasparenza, più che per gli obbiettivi, per gli articoli
modificati, sanzionabilità dell’eventuale inosservanza, esclusione della
parte retributiva destinata a costituire la base uniforme per l’intera categoria; ma al tempo stesso larga facoltà di manovra sulla ricaduta di una eventuale ristrutturazione sull’organizzazione del lavoro, con l’ovvia salvezza
dei diritti individuali inderogabili ex lege.
Ormai, però, si è fuori tempo massimo. La Fiat accelerava: il 16 dicembre
2010, dando vita ad una scissione parziale, con la società holding Fiat Spa,
che controlla, con riguardo alla produzione di auto, la Fiat Group Automobiles (al 100%), cui fa capo la partecipazione in Chrysler Group LLC (per
il 25%), la Maserati (al 100%), la Ferrari (all’85%); e, rispettivamente, con
riguardo alla produzione di macchine agricole ed industriali la Fiat Industrial S.p.A. (al 100%). La strategia è chiara, separare due attività: da un lato, quella dell’auto, che dovrebbe riprendersi da una indubbia difficoltà di
mercato attraverso l’acquisto della Chrysler, con conseguente immissione
di denaro fresco, accelerazione del tasso di innovazione, crescita assai significativa del fatturato; dall’altro, quella delle macchine agricole ed industriali, che dovrebbe continuare a godere della sua buona salute produttiva e finanziaria. Ma una siffatta strategia domanda una grossa scommessa
finanziaria, con a sua premessa una piena, continua, regolare utilizzazione
degli impianti, che solo una più intensa, ma soprattutto cooperativa disponibilità della forza lavoro potrebbe assicurare. Su questa necessità batte e
ribatte l’uomo della Provvidenza insediato al vertice della Fiat, che spende
l’indubbio successo conseguito in passato quale credenziale per il futuro; e
che, nel giro del breve tempo trascorso dall’accordo di Pomigliano, si è venuto convincendo ancora di più della debolezza della linea soft sostenuta
dalla Confindustria e della bontà della linea hard da lui previsata fin dall’inizio.
È possibile che abbia pesato il suo essere un italiano abituato a giocare
oltre Oceano, dove il confronto è duro e crudo, ma una volta chiuso, tale rimane; ma certo ha pesato di più quanto ci si riprometteva da parte di quel
mondo politico e sindacale americano, disposto sì a rischiare, ma senza
sconto alcuno rispetto all’impegno italiano. Certo è che Marchionne non
era più disposto ad accontentarsi del risultato conseguito a Pomigliano,
non per il nuovo regime organizzativo varato, ma per il sistema contrattuale in cui risultava inquadrato. Quest’ultimo era reso pesante ed incerto dal
coesistere di un doppio regime, unitario e separato, a livello sia interconfederale (Protocollo del luglio 1993 e, rispettivamente, accordi interconfederali del gennaio e dell’aprile 2009) che categoriale (contratto collettivo na-
ADL 1/2011
30
PARTE PRIMA . SAGGI
zionale del gennaio 2008 e, rispettivamente Ipotesi di accordo dell’ottobre
2009). Il che creava un intreccio problematico al limite del paralizzante per
quanto riguardava il rapporto di contenuto normativo, di ambito di efficacia, di interlocutori, di decorrenza, di situazione post-scadenza; intreccio
destinato a scaricarsi in termini di conflittualità e vertenzialità giudiziaria
sullo stesso accordo aziendale separato di Pomigliano.
Il cambio di marcia avviene con l’accordo di Mirafiori del 23 dicembre
2010, siglato fra la Fiat Group Automobiles S.p.A. , assistita dall’Unione industriale di Torino e i rappresentanti delle Segreterie nazionali e della provincia di Torino di Fim, Uilm, Fismic e Ugl Metalmeccanici e della Associazione Capi e Quadri Fiat. A venir per prima è la precisazione che “la Joint
Venture . . . non aderirà al sistema confindustriale” e che, coerentemente,
“applicherà un contratto collettivo specifico di primo livello che includerà
quanto convenuto con la presente intesa”, rinviando, per il trattamento non
disciplinato, alla “stesura del contratto collettivo specifico” e, “per il sistema di partecipazione e i diritti sindacali all’allegato n. 1”. A seguire per seconda, è la puntualizzazione che l’ “adesione al presente accordo è condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie”. A chiudere per terza ed ultima, è l’esplicita previsione che il “presente documento conclusivo diventerà operativo a fronte dell’approvazione da parte della maggioranza dei lavoratori”.
La svolta dall’industrial collective agreement, a doppio livello, al company
agreement, monolivello, è compiuta, con recupero del modello organizzativo di Pomigliano, sub specie di contratto non più di II°, ma di I° livello, come tale autonomo ed auto-sufficiente. Ma un siffatto sganciamento richiede un cambio nel sistema, perché se, da un lato, impegna in prima persona
le associazioni sindacali nazionali, dall’altro, deve scontare l’opposizione
della Fiom Cgil, quindi fare a meno della legittimazione di base derivante
dalla sottoscrizione della rsu: la via d’uscita è costituita dal referendum, dove la partita viene giocata una volta per tutte, senza possibilità di essere riaperta, sì da mettere a rischio l’investimento effettuato. Proprio per questa
definitività dell’eventuale risposta positiva – che toccherà alle parti sindacali firmatarie garantire fino al limite della responsabilità oggettiva, con
una sorta di solidarietà creditizia – un’eventuale successiva adesione della
Fiom deve essere accettata da tutte le organizzazioni stipulanti.
Ne segue un ritorno allo Statuto, cioè all’art. 19, così come amputato dai
referendum del 1995: la rsu lascia il posto alle rsa, cioè l’unità organica a base elettiva al pluralismo a base associativa. Se ce n’è un’avvisaglia nella mutuazione della clausola di responsabilità dell’accordo di Pomigliano da parte del successivo accordo di Mirafiori, che prende luogo con la sostituzione di “ dalle Organizzazioni sindacali e/o dalla RSU” con “dalle Organiz-
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
31
zazioni sindacali e/o dalla Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori”; ce
n’è, invece, una precisa e dettagliata conferma nell’allegato 1 allo stesso accordo di Mirafiori, a cominciare dal suo art. 1 sulla “Costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali”.
Peraltro questo ritorno allo Statuto non concede più niente all’ “iniziativa dei lavoratori”, facendo fruttare a suo vantaggio il prevalente indirizzo
dottrinale e giurisprudenziale a pro di una sufficienza di un mero battesimo da parte di una organizzazione a ciò legittimata. Non solo, perché sono
le organizzazioni sindacali territoriali, anzitutto nazionali e poi locali, a
contare, sì da relegare le loro rappresentanze aziendali a sedi di trasmissione più che di assunzione di decisioni.
Basti ripercorrere la composizione delle varie Commissioni, previste e
disciplinate in quell’allegato n.1 all’accordo di Mirafiori, che, peraltro, parla sempre di Rappresentanza sindacale al singolare, se pur, poi, dando per
scontata la presenza rappresentativa di tutte le organizzazioni firmatarie. Si
può cominciare dalla più importante, la Commissione Paritetica di Conciliazione, vera e propria suprema camera preposta ad un una gestione cooperativa dell’applicazione del contratto: essa risulta composta, “per parte
sindacale da un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria
. . . individuato nelle rispettive Segreterie nazionali . . .”. Né troppo diversa
risulta la composizione della Commissione Pari Opportunità, che contempla “ un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria . . . , designati dalle rispettive Segreterie Nazionali nell’ambito delle strutture sindacali di categoria . . .”.
E se è vero che nelle altre Commissioni sono coinvolti componenti delle
Rappresentanze aziendali, questi non sono scelti dalle stesse, ma designati
dalle organizzazioni territoriali: per la Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro i “ componenti . . . , per la parte dei lavoratori, appartengono esclusivamente alla Rappresentanza sindacale dei lavoratori, e il loro
numero è pari a 8”, ma tali componenti, “individuati tra gli RLS dello stabilimento/unità produttiva”, “saranno comunicati all’Azienda congiuntamente dalle Organizzazioni firmatarie . . .”; per la Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione, i membri sono “ per parte sindacale: 2 componenti della Rappresentanza Sindacale dei lavoratori per ogni Organizzazione sindacale firmataria . . . designati dalle rispettive Segreterie territoriali”; per la Commissione Servizi sociali, con formula identica, i membri sono
“ per parte sindacale . . . 2 componenti della Rappresentanza sindacale dei
lavoratori per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria . . . nominati
dalle rispettive Segreterie Territoriali”.
Un sistema destinato a chiudersi su se stesso a riccio: una volta legittimato dal referendum, nessuno può entrarvi senza il consenso di tutte le or-
ADL 1/2011
32
PARTE PRIMA . SAGGI
ganizzazioni firmatarie; ma nessuno può neppure mantenere diritto di piena cittadinanza nella fabbrica, senza esservi entrato. Qui sta un divario sostanziale fra l’accordo di Pomigliano, il quale, se pur separato, era condannato a vivere all’ombra del contratto nazionale unitario del gennaio 2008,
che permetteva alla Fiom di invocare a suo favore l’art. 19, lett. b Stat. lav. ,
in quanto firmataria di quel contratto; e, rispettivamente, l’accordo di Mirafiori, che è si separato, ma, al tempo stesso, si separa dal sistema, sì da sottrarsi all’ipoteca del contratto nazionale unitario del gennaio 2008 e lasciare la Fiom scoperta proprio ai sensi di quell’art. 19, lett. b), perché non firmataria dell’unico contratto applicabile, questo di Mirafiori di I° livello del
dicembre 2010.
Il che è puntualmente accaduto una volta che il referendum si è concluso
con una vittoria dei sì, se pur di stretta misura, col 54%. Non condivido tutto il clamore sollevato circa una siffatta percentuale, considerata inferiore
all’aspettativa dei promotori e sproporzionata una volta suddivisa fra componente operaia ed impiegatizia, sì da rivelare come proprio quest’ultima
sia stata decisiva. Casomai la misura della vittoria, raggiunta solo alla fine,
con solo qualche lunghezza di vantaggio, dovrebbe far dubitare dell’essersi svolto il referendum in un clima tale da pregiudicarne a priori il risultato.
Può essere che i lavoratori pronunciatisi per il no credessero di poterlo fare senza troppo rischio, ritenendo scontato il prevalere del sì e/o giudicando l’ultimatum di Marchionne un puro tatticismo, per cui il prevalere del no
avrebbe portato ad un ritorno al tavolo negoziale. Può essere, anche, che lo
facessero, reagendo ad uno stato di frustrazione che dalla condizione di lavoro si proiettava sulla condizione sociale.
Comunque suona come una forzatura quella di offrire una rappresentazione manichea del risultato del referendum: di qua l’orgoglio ed il coraggio
dei no, di là il rimessivismo e il fidelismo dei sì. Per correggerla potrebbe
essere qui applicata una celebre distinzione weberiana: i no hanno seguito
l’etica della convinzione, che avrebbe salvato solo le anime loro; ed i sì l’etica della responsabilità, che ha salvato i corpi di tutti.
Certo suscita una comprensibile reazione critica la possibilità che la
Fiom, l’organizzazione sindacale di maggioranza relativa (peraltro in uno
stabilimento in cui circa la metà dei lavoratori non è sindacalizzata) possa
restare senza la copertura del Titolo III. Ma intanto, come ben si sa, è pur
sempre legittimata a farsi pagare dall’azienda i contributi sindacali in forza
delle deleghe trasmesse dai lavoratori, sulla base di quella giurisprudenza
che è intervenuta a “correggere” l’abrogazione referendaria dell’art. 26, secondo comma, ricostruendo le deleghe non più come mandati di pagamento, ma come cessioni di credito non richiedenti il consenso della parte
creditrice.
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
33
Resta precluso l’accesso all’art. 19, lett. b) e al conseguente patrimonio
di diritti sindacali. Verrebbe da dire che hoc iure utimur; e se questo diritto
vigente non rende lo spirito originario dello Statuto, falsando il suo meccanismo selettivo e, conseguentemente, il suo disegno promozionale, lo
diventa per effetto di un referendum promosso da un fronte genericamente progressista. Ma se pur valido, questo è e rimane un discorso formale; al
contrario, è e rimane un discorso sostanziale quello per cui cuius commoda,
eius incommoda, sicché una volta approvato legittimamente un contratto, chi
non era d’accordo, può continuare ad avere piena cittadinanza sul luogo
di lavoro, ma non può usarla per rimettere in discussione quello stesso testo.
Ora si obbietta che nessuno e niente ci dice che cosa si debba intendere
per legittimamente, sì da rinviare ad una futura disciplina contrattuale o legislativa. Ma l’obiezione non è fondata, perché se si privilegia il discorso
formale, la risposta è già data dall’art. 19, lett. b, Stat. lav.; se, invece, si privilegia la risposta sostanziale, l’unica possibile e praticabile è proprio quella referendaria: oggi come oggi, giuridicamente non ha rilevanza; ma politicamente fa la differenza.
Ridotta all’osso, l’alternativa “democratica” ad un sistema bloccato di
pluralismo sindacale conflittuale è duplice: far votare i lavoratori a monte,
per la scelta dell’agente contrattuale; far votare i lavoratori a valle per la ratifica di un contratto sottoscritto da alcune organizzazioni sufficientemente rappresentative, ma non da tutte. Non è difficile decidere quale sia la
scelta più consona alla nostra tradizione, cultura, Costituzione, tanto da
renderla addirittura obbligata; sicché non dovrebbe destare particolare
opposizione per l’essere stata anticipata, senza violazione alcuna di legge o
di contratto.
9. – Dato l’angolo di visuale prescelto, non mi sono soffermato, prima, sul
nuovo regime del rapporto di lavoro introdotto dall’accordo di Pomigliano, né mi soffermerò, ora, su quello varato con l’accordo di Mirafiori, che lo
ricalca, peraltro non senza qualche significativo aliquid novi. C’è un punto,
però, dell’accordo di Mirafiori che non posso trascurare, perché tende a
chiudere il cerchio, il punto 10:
“Il fabbisogno degli organici della Joint Venture sarà soddisfatto in via
prioritaria con l’assunzione del personale proveniente dagli stabilimenti di
Fiat Group Automobiles S.p.A. di Mirafiori e, successivamente, dalle altre
aziende del Gruppo Fiat dell’area torinese compatibilmente con le caratteristiche professionali, al fine di assorbirne eventuali eccedenze. Per tale
personale l’assunzione avverrà con cessione individuale del contratto di lavoro, con il riconoscimento dell’anzianità aziendale pregressa e senza l’ap-
ADL 1/2011
34
PARTE PRIMA . SAGGI
plicazione di quanto previsto dall’art. 2112 Cod. Civ. , in quanto nell’operazione societaria non si configura il trasferimento di ramo d’azienda”.
“Con l’avvio della produzione della Joint Venture e in relazione al programma formativo saranno assegnate ai lavoratori le mansioni necessarie
per assicurare un corretto equilibrio tra operai diretti e indiretti, garantendo ai lavoratori la retribuzione e l’inquadramento precedentemente acquisiti nelle aziende del Gruppo Fiat, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 11, L. 223/91”.
Nel primo paragrafo di questo punto è descritto il meccanismo giuridico apprestato per baypassare l’art. 2112 Cod. Civ. , perché di per sé quanto
affermato – che, cioè, l’articolo non sarebbe qui applicabile per difetto in
casu di un trasferimento aziendale – lascia il tempo che trova: non c’è un licenziamento da parte della vecchia ed una nuova assunzione da parte della nuova società, ma una cessione di contratto dall’una all’altra, con la conservazione dell’anzianità pregressa. Ora quel che risulta chiara è l’intenzione sottesa al ricorso all’istituto della cessione del contratto: questo richiede
sì il consenso del ceduto, cioè di ogni singolo lavoratore, ma pare mettere
al riparo dal regime protettivo dell’art. 2112 Cod. Civ. , cioè dal divieto di un
licenziamento motivato in forza e ragione dello stesso trasferimento, nonché dall’obbligo di conservare il trattamento normativo ed economico assicurato dalla contrattazione collettiva in vigore, nazionale, categoriale,
aziendale fino alle previste scadenze.
Mi limito qui ad avanzare qualche riserva su una ricostruzione in chiave
di cessione di credito di qualcosa che comportava un mero e semplice “mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata”, cioè il comun
denominatore del trasferimento ex art. 2112 Cod. Civ. Tanto più che se l’intenzione principale era quella di evitare il vincolo posto al trasferimento di
portarsi in dote tutta la pregressa disciplina collettiva non scaduta del cedente, restava pur sempre la possibilità di far valere l’eccezione rappresentata dall’esistenza di altra disciplina presso il cessionario, quale costituita
proprio dall’accordo di Mirafiori. Certo l’art. 2112 Cod. Civ. richiede, perché la prima venga sostituita dalla seconda, che siano di pari livello; ma se,
ieri, lo stabilimento di Mirafiori era coperto da una contrattazione di I° e di
II° livello, di categoria e di azienda; oggi, la S.p.A. Mirafiori è soggetta ad un
accordo di I° ed esclusivo livello, sicché, almeno formalmente, l’eccezione
avrebbe potuto considerarsi verificata, con conseguente efficacia sostitutiva della vecchia con la nuova regolamentazione collettiva.
D’altronde, nel sopra riportato paragrafo immediatamente successivo
del punto 10, pare si garantisca “ ai lavoratori la retribuzione e l’inquadramento precedentemente acquisiti nelle aziende del Gruppo Fiat”, ma non
le mansioni svolte”, visto che “in relazione al programma formativo saran-
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
35
no assegnate ai lavoratori le mansioni necessarie per assicurare un corretto
equilibrio tra operai e indiretti”. E, dando per scontato che tali assegnazioni possano avvenire in deroga all’art. 2103 Cod. Civ. , vien aggiunto “anche
sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 11, L. 223/91, che, come
ben noto, prevede una deroga all’art. 2103 Cod. Civ. da parte “degli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo,
che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti”; ma le procedure ivi previste sono quelle di mobilità, qui affatto
fuori questione. Una pezza, posta per via di una giurisprudenza per la quale quell’art. 4, undicesimo comma, sarebbe non un’eccezione, ma una
espressione di una regola generale applicabile anche ad altre ipotesi dove si
ponga una questione occupazionale.
Di bello e di brutto, la linea hard della Fiat esce vittoriosa, all’insegna di
un nuovo sinallagma. Da un lato c’è una disciplina del lavoro riadattata a
misura di una nuova organizzazione dell’attività produttiva plus una gestione con chi ci sta di un sistema di relazioni collettive chiuso ed autosufficiente: stabilimenti scorporati e resi autonomi col ricondurli ad altrettante
società per azioni, non iscritte a Federmeccanica e firmatarie di contratti di
I° livello, secondo il modello di company agreement ben conosciuto anche
all’interno dell’Ue; controparti costituite da sindacati nazionali disposti a
farsi co-garanti dell’osservanza dei contratti, fino al limite di una responsabilità oggettiva, sanzionata con la perdita di diritti sindacali ex contractu, aggiuntivi rispetto ai diritti ex lege; organismi rappresentativi di base associativi, totalmente disegnati e controllati dai vertici. Dall’altro, c’è una disponibilità ad un investimento massivo ed ad un programma industriale, tali da
assicurare non solo il mantenimento del livello d’occupazione attuale, ivi
compreso anche l’indotto, ma un ampliamento, senza mettere in discussione quel che alla fine dei conti è e rimane lo snodo strategico, cioè che Torino continui ad essere non solo il cuore, ma anche il cervello della Fiat.
Dopo neppure una settimana dalla firma dell’accordo di Mirafiori, il 29
dicembre 2010, a Roma è stato firmato un contratto collettivo lavoro, che costituisce un ulteriore passo avanti, fin dalla presentazione delle parti stipulanti: se nell’accordo di Pomigliano e nell’accordo di Mirafiori agiva la Fiat
Group Automobiles S.p.A. , con l’assistenza delle Unioni industriali di Torino e Napoli, e, rispettivamente, della sola Unione Industriali di Torino, qui,
nel contratto collettivo lavoro del 29 dicembre 2010 agisce la Fiat S.p.A. ,
senza alcuna assistenza confindustriale. Non manca d’interesse neppure la
rappresentanza seduta dall’altra parte del tavolo: limitata a Fim, Uilm e Fismic nazionali e di Napoli, nell’accordo di Pomigliano; allargata ai rappresentanti delle Segreterie nazionali e della provincia di Torino di Fim, Uilm,
Fismic e Ugl metalmeccanici e dell’Associazione Capi e Quadri Fiat, nell’ac-
ADL 1/2011
36
PARTE PRIMA . SAGGI
cordo di Mirafiori, con una formula poi riprodotta nel contratto collettivo
lavoro del 29 dicembre con un’unica variante, la sostituzione dei rappresentanti della provincia di Torino con quelli della provincia di Napoli.
Il fatto che il contratto collettivo di lavoro del 29 dicembre 2010 si presenta sì come il completamento dell’accordo di Pomigliano, il quale non solo incorpora quanto maturato nel cammino svoltosi fino all’accordo di Mirafiori ma integra gli estremi di un contratto di I° grado, cui far riferimento
da parte di tutte le costituite e costituende società-stabilimenti della Fiat.
Così, riecheggiando l’accordo di Mirafiori, si dice che “ è stato sottoscritto
il presente contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello, che sarà
applicato ai lavoratori di Fabbrica Italia Pomigliano che, non aderendo al
sistema confindustriale non applica la contrattualistica definita nell’ambito
dello stesso”, per, poi aggiungere che l’ “adesione al presente contratto di
terze parti è condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie”.
Il suo titolo primo si articola su tre parti: le prime due, costituite da “ Sistema di relazioni sindacali” e da “ Diritti sindacali”, riprendono l’allegato
n. 1 all’accordo di Mirafiori, di cui s’è parlato sopra; mentre la terza, rappresentata da “Sistema di regole contrattuali”, incorpora i due punti caldi
trasmessi dall’accordo di Pomigliano all’accordo di Mirafiori, negli artt. 8
(Inscindibilità delle disposizioni contrattuali) e 11 (Clausola di responsabilità), se pur con una dizione più controllata, che in questa sede non può
essere verificata nella sua effettiva portata.
Segue un titolo secondo che affronta la peculiarità del sistema Ergo-Uas,
nella sua ricaduta sulla condizione di lavoro in termini di bilanciamenti
produttivi, ambiente ed orario di lavoro; e, a sua volta, un titolo terzo, quello classico, che tratta della disciplina del rapporto di lavoro, dall’assunzione alla risoluzione. Uno si aspetterebbe di leggere la parola fine; e invece
no, perché c’è un ulteriore titolo quarto, che appronta una “normativa specifica per la Fabbrica Italia Pomigliano: “Le parti in applicazione del Contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello sopra definito e in attuazione dell’accordo del 15 giugno 2010 hanno definito la seguente normativa specifica per Fabbrica Italia Pomigliano s.p.a.”
Qui c’è il riscontro di quanto anticipato, che, cioè, il contratto collettivo
lavoro del 29 dicembre 2010 è siglato con riguardo alla Fabbrica Italia Pomigliano, ma in verità viene considerato un contratto di I° livello, a tutt’oggi non “esteso” per forza originaria, ma “estendibile” per adozione successiva alle società-stabilimento Fiat; come tale per la stessa Fabbrica Italia
rappresenta nei suoi titoli I, II, III, la disciplina a regime. Mentre tratta, nel
suo titolo IV, della disciplina transitoria, quella relativa all’assunzione e alla dote economica e normativa assicurata al personale proveniente da Fiat
Group Automobiles e Pc & Ma, secondo la formula di partenza già collau-
ADL 1/2011
FRANCO CARINCI
37
data nell’accordo di Mirafiori: “Per il personale proveniente da Fiat Group
Automobiles s.p.a. stabilimento Giambattista Vico e Plastic Components &
Modules Automative s.p.a. di Napoli, Pomigliano d’Arco, Caivano e Marcianise l’assunzione avverrà con cessione individuale del contratto di lavoro,
senza periodo di prova, con il riconoscimento dell’anzianità aziendale pregressa e con salvaguardia del trattamento economico complessivo e senza
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 2112 Cod. Civ. , in quanto nell’operazione economica non si configurano trasferimenti di rami d’azienda”.
10. – Se si volessero applicare alla nostra vicenda le grandi categorie della storiografia, si potrebbe scegliere fra quella dell’ “egemonismo” e quella
del “determinismo”: fra il grande uomo che curva a sua misura la realtà e la
realtà che trova il grande uomo che la libera. E, a dir la verità, c’è stato chi ha
fatto di Marchionne colui che ha creato qualcosa quasi dal nulla, a seconda
del punto di vista mitizzandolo come uomo della Provvidenza o demonizzandolo come parente stretto di Belzebù; e chi lo ha ridimensionato ad assistente di un parto giunto ormai al termine del suo processo di gestazione.
La cosa non mi appassionerebbe, se l’enfasi posta su Marchionne, meritata o meno, non finisse per far sottovalutare l’obsolescenza ormai irreversibile del nostro glorioso sistema di relazioni industriali, così come cresciuto sullo zoccolo duro dello Statuto pre-referendario; obsolescenza destinata a manifestarsi proprio nell’area di maggior sofferenza, quella della grande impresa, ormai internazionalizzata per necessità e non per virtù, costretta ad innovare nel processo e nel prodotto ed a scommettere su un crescente tasso di produttività, con un’ovvia ricaduta sull’organizzazione del
lavoro, più flessibile e più programmabile al tempo stesso.
Se così è ogni ritorno allo status quo ante è e rimane un sogno, piacevole,
forse redditizio per qualcuno, ma estremamente pericoloso. Col senno di
poi, è facile dire che per la stessa Cgil la previsione di una contrattazione
aziendale in deroga controllata dalla nazionale era una soluzione praticabile; e che per la stessa Fiom la prospettazione di un contratto nazionale auto
era un’opzione consigliabile. Ma, come spesso succede, quel che si percepisce e si persegue come ottimo, è nemico di quel che si potrebbe ottenere
come buono; e, diversamente da quanto previsto dall’orario ferroviario,
perso un treno, può ben non essercene un altro che ci porti dove avremmo
voluto andare.
Ora si parla della riscrittura delle regole della rappresentanza, considerandola come la questione delle questioni, da risolvere a tamburo battente,
dall’oggi al domani, per accordo fra le parti sociali o per legge. Ma affermare che una questione considerata da sempre urgente, sia ancora più urgente non significa accelerarne la soluzione, specie in una congiuntura che tro-
ADL 1/2011
38
PARTE PRIMA . SAGGI
va il movimento confederale spaccato come non mai ed il Governo del tutto restio ad intervenire.
Intanto non è vero che non ci sia stata una soluzione, perché questa era
scritta e consacrata nel Protocollo del ’93; è, vero, invece, che è stata realizzata solo parzialmente e che, comunque, è entrata in crisi proprio laddove
sembrava più radicata. La sua precondizione era la stessa di tutta la ricostruzione post-sessantottesca del nostro sistema di relazioni sindacali, se
non l’unità organica, almeno l’unità di azione; ma oggi come oggi non è
possibile pensare di intervenire, continuando a dar per scontata una precondizione venuta da tempo meno.
Credo non si possa ripartire senza dar per scontata la permanenza di un
pluralismo sindacale destinato ad alternare periodi cooperativi e conflittuali, non per una mera competizione tattica ma per una sostanziale diversità strategica, particolarmente sensibile alla stessa alternanza alla guida del
Paese. Ora, essendo persona di fantasia limitata, non riesco a vedere come
questo pluralismo possa essere salvaguardato se non con il varo di un meccanismo più o meno simile a quello di cui all’art. 39, secondo comma e
segg. Cost. , idoneo ad individuare come agente contrattuale non un unico
sindacato ma un organo rappresentativo, percorso, peraltro, reso difficile
tecnicamente e politicamente; oppure, come già detto sopra, privilegiando
lo strumento referendario. Quello che, però, la vicenda Fiat si lascia alle
spalle come lezione da non ignorare è che, una volta legittimamente varato
un contratto, non è permesso ad un sindacato non firmatario usufruire del
patrimonio promozionale, legislativo e contrattuale; per condurre una
guerriglia contro dall’interno. Il che riguarda solo ed esclusivamente il suo
comportamento, senza che di per sé ne debba seguire alcuna limitazione di
un diritto di sciopero ricostruito come a titolarità individuale e ad esercizio
collettivo.
Dovendo dare un consiglio non richiesto e del tutto ininfluente, mi sentirei di suggerire di prendersi, tutti e nessuno escluso, un certo tempus deliberandi, tanto più che Pomigliano e Mirafiori conosceranno lunghi periodi
di Cig; e che è estremamente importante vedere se gli impegni assunti da
Marchionne saranno mantenuti nei tempi previsti. Ma la sconfitta è cattiva
consigliera e già si preannuncia, ben al di là del rito scontato dello sciopero del 28 gennaio prossimo venturo, una controffensiva giudiziaria a tutto
campo da parte della Fiom.
La cronaca si fa storia. La cronaca di ieri, perché quella di domani continuerà ad alimentare i massmedia e, perche no, a far correre la nostra penna
infaticabile, a maggior gloria di una scienza giuridica ormai condannata ad
oscillare fra la ricostruzione fattuale, la esegesi legislativa, la analisi casistica della giurisprudenza.
ADL 1/2011
Enrico Gragnoli
Prof. ord. dell’Università di Parma
NUOVI PROFILI DELL’IMPUGNAZIONE
DEL LICENZIAMENTO
Sommario: 1. La natura e le finalità dell’impugnazione del licenziamento nell’impostazione
originale dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966. – 2. La contrapposizione fra l’impugnazione giudiziale e quella stragiudiziale nel superato contesto regolativo. – 3. Il nuovo regime dell’impugnazione, dopo la legge n. 183 del 2010. – 4. I licenziamenti oggetto di necessaria impugnazione. – 5. Il rispetto del termine iniziale di sessanta giorni. – 6. Il termine di decadenza per il deposito del ricorso e per l’avvio del tentativo facoltativo di conciliazione o della procedura arbitrale. – 7. Le conseguenze della mancata impugnazione. – 8.
I problemi di diritto transitorio.
1. – Nel contesto regolativo tradizionale e ora superato (1), il termine di
decadenza previsto per l’impugnazione del licenziamento dall’art. 6 della
legge n. 604 del 1966 non sollevava solo rilevanti dubbi su vari aspetti applicativi, ma più generali quesiti sul suo senso complessivo. Vi era da chiedersi perché fosse posto a carico del prestatore di opere un simile onere (2),
il cui adempimento presupponeva adeguata competenza tecnica e, pertanto, quali risultati si prefiggesse l’art. 6, imponendo la rapida contestazione
della legittimità del recesso. Una volta osservato l’art. 6, le azioni del prestatore di opere erano da proporre secondo le indicazioni del diritto comune (3).
Pertanto, se si considera la normale durata delle controversie giudiziali, l’art. 6 non accelerava la definizione della lite, se non altro perché non vi
era onere alcuno di agire in fretta, ma bastava solo impugnare, per lo più in
via stragiudiziale (4). Non era chiaro quale specifico interesse avesse il da-
(1) Problemi altrettanto complessi solleva l’applicazione dell’art. 6 della legge n. 604 del
1966 a istituti diversi dal licenziamento, con una modificazione dei lineamenti dell’istituto, nel
rivolgersi a tali differenti fattispecie. Non è possibile esaminare simili questioni in questa sede.
(2) Per l’identificazione dell’onere quale conseguenza dell’introduzione di un termine di
decadenza, v. . . . Magazzù, Decadenza, in Noviss. Dig. It. , vol. V, pag. 232 e segg.
(3) Sull’operare del termine quinquennale di prescrizione dell’art. 1442 Cod. Civ. , v.
Cass. 13 dicembre 2005, n. 27428, in Lav. Giur. , 2006, pag. 602; Cass. 24 febbraio 2003, n.
2787, in Mass. Giur. Lav. , 2003, pag. 259; Cass. 13 settembre 1993, n. 9502, in Giur. It. , 1994, I,
col. 1.
(4) V. P. Ichino, Il contratto di lavoro, in Tratt. Dir. Civ. e Comm. , diretto da A. Cicu - F. Messineo, poi da L. Mengoni, ora da P. Schlesinger, Milano, 2003, vol. III, pag. 488 e segg. , che,
peraltro, sembra propendere per un intervento normativo volto ad abbreviare i termini di prescrizione, se bene si interpreta.
ADL 1/2011
40
PARTE PRIMA . SAGGI
tore di lavoro a sapere entro sessanta giorni della contestazione del dipendente (5), se, poi, questi poteva esercitare l’azione nei termini di prescrizione (6) e poteva trascorrere un lungo lasso di tempo non solo prima della
conclusione della controversia, ma, addirittura, dell’inizio dell’eventuale
processo.
L’art. 6 non era coerente con la prima, storica sanzione comminata per
il licenziamento illegittimo nel testo originario della legge n. 604 del 1966,
quella cosiddetta della tutela obbligatoria, con l’alternativa fra la riassunzione e la corresponsione di una indennità risarcitoria (7). In tali ipotesi, il
datore di lavoro non aveva un rilevante interesse a conoscere le scelte del
dipendente, poiché, comunque, avrebbe optato per versare l’indennità sostitutiva, come è sempre accaduto.
La situazione era solo in apparenza diversa nel caso di applicabilità dell’art. 18 St. lav. , per i forti limiti apposti al potere di revoca del recesso illegittimo (8). Se non si consentiva al datore di lavoro di rimediare a un errore precedente (9), non è chiaro a che cosa servisse l’impugnazione, la quale
era un ostacolo posto al prestatore di opere senza che ne derivassero corrispondenti benefici per l’impresa. Quanto meno l’ordinamento accettava la
revoca del recesso illegittimo, come accade secondo la prevalente interpretazione dell’art. 18 St. lav. , tanto più era singolare un termine di impugnazione. Esso rendeva più difficile al soggetto debole l’esercizio dei suoi diritti, nonostante la direttiva costituzionale di protezione desumibile dagli
artt. 4 e 35 Cost.
Il termine avrebbe dovuto avere come giustificazione, anche sul piano
costituzionale, un proporzionato vantaggio per il datore di lavoro, affinché
l’art. 6 non comportasse un privilegium odiosum, senza una persuasiva ragione. Era discutibile un simile onere, addossato alla parte debole, la qua(5) V. G. Pera, La cessazione del rapporto di lavoro, Padova, 1980, pag. 200 e segg.
(6) V. F. Mazziotti, L’estinzione del rapporto di lavoro, in Tratt. Dir. Priv. , a cura di P. Rescigno, ed. II, vol. XV, pag. 489 e segg.
(7) Nel senso del mancato operare dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 con riguardo al
licenziamento orale, v. O. Mazzotta, Licenziamento orale immotivato del lavoratore, in Foro It. ,
1976, I, col. 1619 e segg.; P. Magno, Ambito di applicazione del termine di impugnazione del licenziamento, in Dir. Lav. , 1976, II, pag. 76 e segg.; in senso diverso, cfr. A. Cessari, Nullità ed inefficacia dei licenziamenti individuali, in Aa.Vv. , I licenziamenti individuali e la reintegrazione nel
posto di lavoro, in Riv. Dir. Lav. , 1971, I, pag. 516 e segg.
(8) Cfr. C. Zoli, Revoca del licenziamento e libertà del lavoratore di optare immediatamente per
l’indennità sostitutiva della reintegrazione, in Riv. It. Dir. Lav. , 1998, II, pag. 362 e segg.; R. Foglia, L’« opzione » economica del lavoratore reintegrato, in Dir. Lav. , 1991, I, pag. 20 e segg.; F.
Bianchi D’Urso, Prime considerazioni sulla nuova disciplina dei licenziamenti individuali, in
Mass. Giur. Lav. , 1991, pag. 349 e segg.
(9) Cfr. A. Pizzoferrato, Indennità sostitutiva della reintegrazione: funzione giuridica e momento generico, in Riv. It. Dir. Lav. , 1995, II, pag. 406 e segg.
ADL 1/2011
ENRICO GRAGNOLI
41
le, per oggettivi limiti culturali e di esperienza, spesso incorreva in disastrosi errori. Anche in relazione all’art. 24 Cost. , vi era da domandarsi fino
a quale punto effettive esigenze di certezza potessero sorreggere la scelta
dell’art. 6 e non farla apparire come un inutile elemento di complessità, a
vantaggio di chi avesse commesso comportamenti illegittimi e si richiamasse alla forma (10) per impedire al giudice di decidere sulla sostanza.
Se “nella decadenza la non – attività ha rilievo come circostanza del tutto obbiettiva” (11), il termine dell’art. 6 apparteneva a quelli “entro i quali si
richiede il compimento di un atto cosiddetto « singolare », cioè non corrispondente al contenuto del diritto, sia pur ampiamente inteso, consistendo
ad esempio in una denuncia ( . . . ), diffida, riserva” (12), in alternativa rispetto all’esercizio dell’azione. Pertanto, la decadenza poteva dipendere da una
omissione estranea all’esercizio del diritto (13), poiché a tale nozione non
può essere ricondotta l’impugnazione stragiudiziale (14), nemmeno ora,
dopo la legge n. 183 del 2010. L’art. 6 considerava (e riguarda anche oggi)
una inattività verificatasi in un predeterminato spazio di tempo (15) e “ai fini impeditivi della decadenza occorre una valida manifestazione di esercizio del diritto generalmente rappresentata dalla domanda giudiziale, rispetto alla quale assumono il ruolo di mezzi sostitutivi gli atti previsti dalla
legge” (16). In questa logica si iscrive la contrapposizione fra impugnazione
giudiziale e stragiudiziale e i termini della questione non sono modificati.
2. – L’atto di impugnazione stragiudiziale è stato reputato recettizio (17),
per una chiara indicazione dell’art. 6, che lo identifica come l’atto “singolare” idoneo a impedire la decadenza (18). Sul punto, l’art. 6 non presenta no-
(10) Cfr. M. Napoli, Licenziamenti, in Digesto, Disc. Priv. , Sez. Comm. , vol. IX, pag. 86 e segg.
(11) V. G. Panza, Decadenza nel diritto civile, in Digesto, Disc. Priv. , Sez. Civ. , vol. V, pag. 137
e segg. , sulla scia di F. Santoro Passarelli, Prescrizione e decadenza, in Riv. Dir. Civ. , 1926, pag.
562 e segg. .
(12) V. G. Panza, Decadenza nel diritto civile, loc. cit. , pag. 134 e segg..
(13) V. P. Trimarchi, Prescrizione e decadenza, in Jus, 1956, pag. 218 e segg.; G. Azzariti - G.
Scarpello, Della prescrizione e della decadenza, in Comm. Cod. Civ. , a cura di A. Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1964, pag. 346 e segg. .
(14) V. G. Scalfi, Osservazioni sulla prescrizione e sulla decadenza, in Temi, 1952, pag. 234 e
segg. .
(15) Cfr. V. Tedeschi, Decadenza (diritto e processo civile), in Enc. Dir. , vol. XI, pag. 770 e
segg. , e, dello stesso A. , Lineamenti della distinzione fra prescrizione estintiva e decadenza, Milano, 1948, pag. 113 e segg.; A. Candian, Decadenza e prescrizione, in Temi, 1950, pag. 1 e segg.
(16) V. G. Panza, Decadenza nel diritto civile, loc. cit. , pag. 135 e segg.
(17) Cfr. Trib. Milano 20 aprile 1991, in Dir. Prat. Lav. , 1991, pag. 2466.
(18) Sul nesso fra la nozione della decadenza e quella dell’atto “singolare”, v. G.L. Pellizzi, In margine al problema della decadenza, in Giur. It. , 1957, IV, col. 38 e segg.
ADL 1/2011
42
PARTE PRIMA . SAGGI
vità. L’atto deve essere scritto (19) e firmato, senza la necessità di “espressioni particolari” (20); basta rendere nota la volontà di reagire (21). Quindi,
è sufficiente la semplice contestazione della validità del licenziamento. È
stato tradizionale il rigore della giurisprudenza sulla forma scritta, al punto
che si è discusso dell’idoneità del telegramma (22); desta perplessità la diversa impostazione seguita, per esempio, in tema di atti interruttivi della
prescrizione, con affermazioni molto più benevole. Ai fini dell’art. 6, è sufficiente il telegramma dettato per telefono (23), se mai con l’onere del prestatore di opere di dimostrare di avere dato incarico per l’inoltro del messaggio (24), anche se con la collaborazione di un terzo (25). Ai sensi dell’art.
2705 Cod. Civ. , il telegramma è atto scritto se il testo “è stato consegnato o
fatto consegnare dal mittente” (26), seppure con una dettatura per telefono
e, quindi, senza la materiale apposizione della firma. Non vi dovrebbero essere dubbi per il messaggio spedito per telefax (27), se l’immagine comprende la sottoscrizione, poiché è comunicazione di un atto scritto anche la
trasmissione della sua immagine.
(19) V. Corte cost. 13 maggio 1987, n. 161, in Mass. Giur. Lav. , 1987, pag. 319.
(20) V. Cass. 17 gennaio 1983, n. 375, in Giust. Civ. , 1983, I, pag. 724; Cass. 30 maggio 1991,
n. 6102, in Not. Giur. Lav. , 1991, pag. 845.
(21) V. Cass. 27 febbraio 1998, n. 2200, in Dir. Lav. , 1999, II, pag. 307; Cass. 12 agosto
1994, n. 7405, in Not. Giur. Lav. , 1994, pag. 789.
(22) Sull’onere del mittente di dimostrare l’esistenza delle condizioni richieste dall’art.
2705 Cod. Civ. e sulla sufficienza a tale fine del possesso della copia conforme del telegramma, v. Cass. 23 dicembre 2003, n. 19689, in Mass. Giur. Lav. , 2004, pag. 312. Tale sentenza ha
ritenuto sufficiente il telegramma dettato per telefono.
(23) Cfr. Cass. 18 giugno 2003, n. 9790, in Guida Dir. , 2003, n. 31, pag. 57.
(24) V. Cass. 30 ottobre 2000, n. 14297, in Riv. It. Dir. Lav. , 2001, II, pag. 371, con nota di
M. Palla, Revirement della Suprema Corte sulla legittimità dell’impugnazione del licenziamento
mediante telegramma telefonico; Cass. 10 luglio 1991, n. 7610, in Riv. It. Dir. Lav. , 1992, II, pag.
687, con nota di R. Bellè, L’impugnazione del licenziamento con telegramma dettato per telefono.
(25) V. Cass. 5 giugno 2001, n. 7620, in Riv. It. Dir. Lav. , 2002, II, pag. 141, con nota di M.
Vincieri, Sull’impugnazione del licenziamento mediante telegramma telefonico inoltrato dal legale
del lavoratore. Cfr. anche M. Papaleoni, Licenziamento, comunicazione, impugnazione, decadenza,
in Mass. Giur. Lav. , 2001, pag. 877 e segg. Invece, per la giurisprudenza più risalente, il lavoratore dovrebbe “fornire la prova di avere sottoscritto di persona l’originale consegnato all’ufficio di partenza ovvero, in mancanza di sottoscrizione, di avere consegnato o fatto consegnare
l’originale all’ufficio di partenza”; cfr. Cass. 26 luglio 1996, n. 6749, in Dir. Lav. , 1997, II, pag.
347.
(26) Cfr. Cass. 30 ottobre 2000, n. 14297, cit. V. anche Pret. Roma 18 dicembre 1991, in Dir.
Prat. Lav. , 1992, pag. 1457; Trib. Messina 15 luglio 1999, in Riv. It. Dir. Lav. , 2000, II, pag. 533,
con nota di M. Cattani, Sull’impugnazione del licenziamento mediante telegramma telefonico.
(27) In senso contrario, v. Pret. Lucca 27 maggio 1994, in Mass. Giur. Lav. , 1994, pag. 605,
sulla base dell’idea per cui il mittente non potrebbe dimostrare l’avvenuta trasmissione. Ciò
non è conforme a quanto si deduce dalla tecnica attuale. Sul telex, v. Trib. Roma 7 febbraio
1994, in Dir. Lav. , 1994, I, pag. 44.
ADL 1/2011
ENRICO GRAGNOLI
43
Non è stato considerato sufficiente l’atto carente della firma, sebbene,
qualora ammettesse di avere ricevuto l’impugnazione, sul punto l’onere
della prova incombeva sul datore di lavoro, detentore dell’originale. Si è
detto che il prestatore di opere può conferire procura al suo legale (28),
purché scritta (29) e “portata a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza” (30), salva la possibilità di provare l’anteriorità all’impugnazione della procura non comunicata, ma nel rispetto dell’art. 2704
Cod. Civ. (31). La ratifica (32) sarebbe efficace solo se eseguita e resa nota
entro il medesimo termine dell’art. 6. Quindi, è stato invocato l’art. 1392
Cod. Civ. (33), secondo un principio consolidato (34).
A dire il vero, tali ultime sentenze hanno attribuito all’impugnazione
natura negoziale, in contrasto con altre, più convincenti (35). Infatti, l’impugnazione non comporta una regolazione di interessi (36), ma partecipa solo
la contestazione dell’illegittimità del recesso (37). Pertanto, se l’art. 1392
Cod. Civ. è applicabile ai soli negozi, basta una procura orale (38). Se l’art.
1324 Cod. Civ. si riferisce agli atti unilaterali negoziali, come appare ragio-
(28) V. A. Vallebona, Licenziamento. Impugnazione. Forma scritta ad substantiam. Procura
rilasciata ad un terzo, in Nuova Giur. Civ. Comm. , 1987, I, pag. 719 e segg.
(29) V. Cass. 1 settembre 1997, n. 8262, in Riv. Giur. Sarda, 2001, pag. 145.
(30) Cfr. Cass. 24 giugno 1997, n. 5611, in Not. Giur. Lav. , 1997, pag. 527; Cass. 4 luglio
1991, n. 7387, in Dir. Prat. Lav. , 1991, pag. 2543; Pret. Milano 4 luglio 1995, in Gius, 1995, pag.
4127; invece, in senso diverso, sull’inesistenza di un onere di comunicazione della procura, v.
Cass. 7 ottobre 1999, n. 11178, in Riv. Giur. Lav. , 2000, II, pag. 339, con nota di T. Santulli, Impugnazione del licenziamento da parte del difensore: la Cassazione aiuta il lavoratore “impreciso”,
con la precisazione per cui la procura stessa deve avere data certa; Trib. Milano 12 luglio 1997,
in Lav. Giur. , 1998, pag. 61.
(31) V. Cass. 20 agosto 1996, n. 7651, Giur. It. , 1997, col. 1070.
(32) Cfr. R. Triola, In tema di ratifica del licenziamento intimato da falsus procurator, in
Giust. Civ. , 1987, I, pag. 1967 e segg.
(33) V. Cass. 17 gennaio 1983, n. 375, cit.; Trib. Napoli 6 aprile 1984, in Lav. ’80, 1984, 1171.
(34) V. Cass. , Sez. un. , 2 marzo 1987, n. 2179, in Not. Giur. Lav. , 1987, pag. 467; Cass. , sez.
un. , 2 marzo 1987, n. 2180, in Giust. Civ. , 1983, I, pag. 724.
(35) V. Cass. 1 settembre 1982, n. 4750, in Foro It. , 1983, I, col. 2186; Cass. 16 giugno 1987,
n. 5346, in Giust. Civ. , 1987, I, pag. 2497; Pret. Milano 13 marzo 1984, in Lav. ’80, 1984, pag.
592; Pret. Napoli 14 dicembre 1982, in Dir. Giur. , 1983, pag. 657; Pret. Milano 6 gennaio 1982,
in Lav. ’80, 1982, pag. 476.
(36) Sulla sufficienza della lettera del difensore, v. S. Mattone, Note minime sulla impugnazione del licenziamento da parte del difensore, in Lav. ’80, 1984, pag. 1171 e segg.
(37) Cfr. V. Nobile, Forma della procura e atti giuridici non negoziali: a proposito della procura ad impugnare il licenziamento, in Dir. Giur. , 1983, I, pag. 659 e segg.; G. Mannacio, Licenziamento, impugnazione e procura, in Dir. Prat. Lav. , 1987, pag. 1397 e segg.; S. Pulidori, La procura ad impugnare il licenziamento, in Foro It. , 1989, I, col. 843 e segg.; C. Consolo, Oggetto del giudizio ed impugnazione del licenziamento, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ. , 1991, pag. 569 e segg.
(38) Cfr. Trib. Milano 3 novembre 1987, in Lav. ’80, 1988, pag. 247; Pret. Milano 28 ottobre 1987, ibid. , 1988, pag. 250; Pret. Livorno 14 marzo 1988, in Giust. Civ. , 1988, I, pag. 1872.
ADL 1/2011
44
PARTE PRIMA . SAGGI
nevole (39) e come è confermato dalle stesse sentenze di legittimità (40), è
singolare vedere un negozio nell’atto dell’art. 6 e, dunque, all’impugnazione non si applicano né l’art. 1324 Cod. Civ. , né, di conseguenza, l’art. 1392
Cod. Civ.
Per rispettare il termine, non si doveva agire, ma bastava preannunciare, in modo per nulla impegnativo, una possibile, futura iniziativa giudiziale, e così è anche oggi. Al più, si può vedere nell’atto dell’art. 6 una sorta di
riserva di azione, a prescindere dalla reale intenzione di agire, in ordine alla quale nessuna verifica è possibile, né necessaria. Quello dell’art. 6 è un
atto in senso stretto (41), senza implicazioni negoziali, così che è esternata
una mera convinzione. Nella struttura della decadenza, l’atto “singolare”
idoneo a impedirla è una sorta di denuncia (42). Pertanto, la giurisprudenza
dominante non è persuasiva e il legale può impugnare il recesso anche in
forza di una procura orale, poiché non operano l’art. 1324 Cod. Civ. e, pertanto, l’art. 1392 Cod. Civ.
Una recente ricostruzione si è avveduta del problema e si è resa conto
del fatto che non ha senso immaginare diversi regimi in ordine alla sottoscrizione del difensore per l’impugnazione del licenziamento e per l’atto di
interruzione del decorso del termine di prescrizione. Peraltro, si è affermato che, in entrambe tali ipotesi, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art.
1392 Cod. Civ. , poiché “non v’è ragione di restringere la rappresentanza alla sola sostituzione nell’attività negoziale, e non estenderla, invece, a tutti i
casi in cui si instaurino relazioni con terzi e in cui l’ordinamento richieda la
presenza di una volontà consapevole sia per ricollegarvi alcune specifiche
e predeterminate conseguenze sia per determinare effetti che, voluti dall’autore dell’atto, ricevano poi espresso riconoscimento e tutela dall’ordinamento stesso” (43).
L’esame critico di tale posizione travalica i limiti di questa ricerca, poiché presuppone una indagine sull’art. 1392 Cod. Civ. , né questa verifica è
indispensabile. Secondo la tesi citata, la stragrande maggioranza degli atti
di interruzione del decorso del termine di prescrizione redatti ogni giorno
dai difensori sarebbero inoltrati in violazione dell’art. 1392 Cod. Civ. e,
(39) V. F. Carresi, Il contratto, in Tratt. Dir. Civ. e Comm. , diretto da Cicu - Messineo, poi da
Mengoni, ora da Schlesinger, Milano, 1987, vol. I, pag. 102 e segg.
(40) Cfr. Cass. 3 dicembre 2002, n. 17157, in Gius. , 2003, pag. 7620, per cui “la forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non può
ritenersi prescritta anche per il conferimento della relativa procura”.
(41) Cfr. F. Santoro Passarelli, Atto giuridico, in Enc. Dir. , vol. IV, pag. 213 e segg.; P. Rescigno, Atto giuridico, I, Diritto privato, in Enc. Giur. , vol. IV, pag. 2 e segg. (dell’estratto).
(42) V. G. Panza, Decadenza nel diritto civile, loc. cit. , pag. 134 e segg.
(43) V. M. D’Onghia, La forma vincolata nel diritto del lavoro, Milano, 2005, pag. 327 e segg.
ADL 1/2011
ENRICO GRAGNOLI
45
quindi, una modificazione dell’opposto, consolidato orientamento avrebbe conseguenze enormi. Però, se il legale può interrompere il decorso del
termine di prescrizione, può anche impugnare il licenziamento.
Gli opposti, rigorosi principi sull’attività del difensore non sono riferibili all’organizzazione sindacale (44), il cui intervento è richiamato dall’art.
6. Pertanto, era ed è sufficiente “la semplice lettera di provenienza sindacale” (45). In ogni caso, a fronte di un provvedimento espulsivo, il prestatore
di opere non ha l’onere di offrire la prestazione (46), poiché la cessazione
della collaborazione dipende dalla volontà del datore di lavoro.
3. – L’art. 32 della legge n. 183 del 2010 lascia in larga parte inalterati i
principi sul termine iniziale di decadenza, nell’ambito del quale, a decorrere dalla comunicazione del licenziamento, il dipendente deve fare conoscere la sua intenzione di contestare la legittimità del recesso, o con l’avvio
diretto dell’azione giudiziale o, come accade con molta maggiore frequenza, con un atto stragiudiziale. Tuttavia, dopo la legge n. 183 del 2010, questo primo adempimento è collegato all’esercizio dell’azione, poiché vi sono
uno o più successivi termini di decadenza; entro l’ulteriore termine di duecentosettanta giorni, il prestatore di opere deve avviare l’azione in giudizio,
promuovere il tentativo di conciliazione o di arbitrato e, in tale seconda
ipotesi, deve depositare il ricorso entro sessanta giorni dall’esito negativo
della procedura.
Questo nesso fra l’impugnazione originaria e la successiva cognizione
giudiziale è una novità in parte intelligente della legge n. 183 del 2010, che
rimedia al principale difetto dell’originaria impostazione dell’art. 6 e, cioè,
la previsione di una decadenza con forti rischi di errore per il dipendente,
ma senza nessun vantaggio per il datore di lavoro, né in ordine alla revoca
del recesso, né a proposito dell’accelerazione del processo. Questa ultima
affermazione non è più vera ed è ragionevole pretendere che il lavoratore
debba esercitare l’azione entro un tempo prestabilito, anche perché il termine non costituisce un ostacolo irrazionale alla tutela dei diritti, nonostante non operi la sospensione feriale. Se il lasso di tempo programmato è
adeguato, anche a paragone dell’art. 24 Cost. , qualora operi l’art. 18 St. lav.
(44) Sulla sufficienza dell’impugnazione sindacale, v. Pret. Bergamo 24 dicembre 1981, in
Lav. Prev. Oggi, 1982, pag. 952; Trib. Torino 5 aprile 1978, in Not. Giur. Lav. , 1978, pag. 685;
Pret. Milano 13 dicembre 1984, in Lav. Prev. Oggi, 1985, pag. 168; Pret. Prato 20 luglio 1995, in
Riv. Crit. Dir. Lav. , 1995, pag. 1026; in senso contrario, v. Pret. Torino 8 gennaio 1977, in Not.
Giur. Lav. , 1977, pag. 614.
(45) V. Pret. Roma 22 settembre 1990, in Dir. Prat. Lav. , 1991, pag. 308.
(46) V. Cass. 6 novembre 2002, n. 15593, in Lav. Giur. , 2003, pag. 277.
ADL 1/2011
46
PARTE PRIMA . SAGGI
è opportuno fare derivare dall’iniziale impugnazione un vincolo di sollecitazione all’avvio del giudizio. Quanto meno, l’art. 6 della legge n. 604 del
1966 non è più una sorta di ostacolo alle iniziative del prestatore di opere
senza alcun beneficio, nemmeno indiretto, per l’impresa, che, invece, dovrebbe essere lieta di vedere cominciare in modo rapido il processo.
Diverso è il ragionamento per i recessi rientranti nell’area di applicabilità dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966. In tali casi, per il datore di lavoro
è molto meno importante l’avvio immediato del giudizio, poiché la sua durata non incide sulle conseguenze sanzionatorie. Oltre tutto, in tali ipotesi,
considerazioni evidenti di economia processuale avrebbero suggerito di
favorire in ogni modo la conciliazione, perché il nostro sistema giudiziario
non debba affrontare un elevato numero di controversie per importi modesti, con una sproporzione preoccupante fra le aspettative delle parti e i
costi oggettivi del processo, a carico della collettività e, quindi, dello Stato.
Invece, il tentativo di conciliazione preventivo non è più obbligatorio e non
è neppure incoraggiato. In caso di immediato esercizio dell’azione, anche
qualora operi l’art. 8 della legge n. 604 del 1966, il dipendente e il suo difensore hanno duecentosettanta giorni per predisporre l’atto introduttivo
del giudizio, mentre, nell’ipotesi di esito negativo del tentativo di conciliazione, ne residuano solo sessanta.
È umano che i legali optino per l’immediato esercizio dell’azione giudiziale, per ovvie ragioni di organizzazione della loro attività professionale e
per il desiderio comprensibile di evitare termini di decadenza più brevi. Peraltro, se questa sarà la scelta più praticata, come si può immaginare, il nostro sistema processuale non avrà motivo di rallegrarsi, perché saranno depositati ricorsi in gran numero per fattispecie che, in virtù dell’applicabilità
dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, avrebbero potuto e dovuto trovare
una diversa soluzione, con transazioni su importi contenuti, con forti risparmi sia delle parti, sia dello Stato in ordine ai costi del processo. L’art. 32
della legge n. 183 del 2010 non si è accorto che esigenze di accelerazione
dell’inizio del giudizio operano solo per i licenziamenti per i quali il sistema sanzionatorio abbia componenti proporzionali alla durata del processo,
in particolare nell’area di efficacia dell’art. 18 St. lav. , ma anche di altri principi, per esempio quello sulla cosiddetta nullità di diritto comune.
Qualora si debba discutere dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, non
solo l’art. 32 non ha molto senso, ma è controproducente, perché scoraggia
il tentativo di conciliazione, che, in questo ambito, sarebbe dovuto rimanere obbligatorio. Se non si cerca di indurre le parti quanto meno a discutere
della conciliazione nell’ambito di applicabilità dell’art. 8 della legge n. 604
del 1966, si corre il rischio di assistere a una dispendiosa e defatigante moltiplicazione dei giudizi (almeno di quelli cominciati, in attesa di una possi-
ADL 1/2011
ENRICO GRAGNOLI
47
bile composizione nella prima udienza), ai danni del sistema processuale e
della sua efficienza. La riforma dell’art. 6 è opportuna, ma essa avrebbe dovuto contrapporre e non omologare i licenziamenti per cui operano la tutela reale o quella obbligatoria.
4. – In passato, oggetto di impugnazione è stato considerato il solo licenziamento, prima delle novità introdotte dall’art. 32 della legge n. 183
del 2010, sull’ applicabilità della disposizione fuori dal suo originario contesto. Per il suo preteso carattere eccezionale, prima del 2010, l’art. 6 non è
stato considerato riferibile al recesso orale (47) o carente della sottoscrizione del datore di lavoro (48). Per una rilevante pronuncia (49), l’inefficacia
propria del licenziamento orale non avrebbe prodotto l’estinzione del rapporto. Sebbene l’onere di impugnazione riguardasse sia il licenziamento
nullo (50), sia quello annullabile, l’onere stesso non sarebbe stato riferibile
al recesso orale, con il conforto della dottrina (51).
Per una recente e articolata posizione (52), la legge n. 604 del 1966
avrebbe “espressamente previsto, all’art. 2, l’ipotesi del vizio di forma, senza che una simile qualificazione si sia poi rispecchiata con diversità di effetti nella previsione di cui al successivo art. 6”, così che, “a rigore, il termine breve dovrebbe applicarsi in forma indifferenziata a tutti i licenziamenti, a prescindere dalla patologia” (53). Ai fini dell’operare dell’art. 6,
(47) Cfr. Cass. 27 febbraio 2003, n. 3022, in Mass. Giur. Lav. , 2003, pag. 260; Cass. 4 giugno 1999, n. 5519, in Mass. Giur. Lav. , 2003, pag. 260; Cass. 29 novembre 1996, n. 10697, in
Mass. Giur. Lav. , 1997, pag. 9.
(48) V. Cass. 18 luglio 1991, n. 8010, in Riv. It. Dir. Lav. , 1992, II, pag. 1025, con nota di
Massart, La convocazione del datore da parte dell’ufficio del lavoro per il tentativo di conciliazione
vale come impugnazione del licenziamento?.
(49) V. Cass. , sez. un. , 18 ottobre 1982, n. 5394, in Giust. Civ. , 1983, I, pag. 869.
(50)In particolare, sull’operare dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 per il recesso intimato in violazione dell’art. 7 St. lav. , v. anche Cass. 2 ottobre 1989, n. 3949, in Giust. Civ. , 1990, I,
pag. 1014.
(51) Cfr. O. Mazzotta, Licenziamento orale immotivato di lavoratore, loc. cit. , pag. 1619 e
segg.; P. Magno, Ambito di applicazione del termine di impugnazione del licenziamento, loc. cit. ,
pag. 76 e segg. in senso diverso, v. A. Cessari, Nullità ed inefficacia dei licenziamenti individuali, loc. cit. , pag. 152 e segg.; A. Aranguren, La reintegrazione nel posto di lavoro, in Riv. It. Dir.
Lav. , 1971, I, pag. 516; V. Speziale, Licenziamento inefficace per intempestiva comunicazione scritta dei motivi, ibid. , 1984, II, pag. 685 e segg.
(52) Cfr. V. Ferrante, Forma e procedura del licenziamento. Il licenziamento disciplinare, in
Aa. Vv. , Il lavoro subordinato, a cura di F. Carinci, tm. III, Il rapporto individuale di lavoro: estinzione e garanzie dei diritti, coordinato da S. Mainardi, Torino, 2007, pag. 223 e segg.
(53) V. V. Ferrante, Forma e procedura del licenziamento. Il licenziamento disciplinare, loc.
cit. , pag. 223 e segg.; cfr. già R. De Luca Tamajo, Commento all’art. 2, secondo comma, in Aa. Vv. ,
Disciplina dei licenziamenti individuali, a cura di R. De Luca Tamajo - M. D’Antona, in Nuove
Leggi Civ. Comm. , 1991, pag. 185 e segg.
ADL 1/2011
48
PARTE PRIMA . SAGGI
“non potrebbe darsi differenza alcuna in relazione alla natura della patologia” (54). Tale tesi scontava un problema di origine, già sul piano letterale, poiché il rinvio dell’art. 6 alla “comunicazione” quale momento iniziale
del termine di decadenza sottintendeva il necessario rispetto della forma
scritta da parte del datore di lavoro per l’operare dell’art. 6. Infatti, tale
espressione non era coerente con un recesso intimato a voce. A prescindere dalla natura del licenziamento orale, l’art. 6 non poteva essere invocato,
e lo stesso valeva per il recesso privo della sottoscrizione o per la mancata
comunicazione dei motivi.
Proprio per la necessaria unitaria considerazione ai fini dell’art. 6 di
tutte le ipotesi di invalidità, era singolare equiparare al licenziamento orale quello intimato alla lavoratrice madre (55) o quello per causa di matrimonio (56). A torto si riteneva che essi non richiedessero alcuna impugnazione, mentre era persuasivo applicare lo stesso art. 6 al licenziamento discriminatorio (57) e, a ragione, si osservava che il recesso per motivo di matrimonio o di maternità ha natura discriminatoria, seguendo la sorte dell’istituto anche in rapporto all’art. 6 (58).
Inoltre, in virtù dell’art. 10 della legge n. 604 del 1966 (59), l’art. 6 non si
applicava ai dirigenti, poiché a questi non erano riferibili per intero le disposizioni della legge n. 604 del 1966, in specie se essi chiedevano solo l’indennità supplementare prevista dai contratti collettivi. In modo persuasivo,
si era negata la vigenza dell’art. 6 anche per il recesso rivolto all’apprendista, sempre in forza dell’art. 10 e della connessa, generale inapplicabilità
della legge n. 604 del 1966 (60). Anzi, l’onere di impugnazione avrebbe riguardato solo i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo (61),
(54) V. V. Ferrante, Forma e procedura del licenziamento. Il licenziamento disciplinare, loc.
cit. , pag. 223 e segg.
(55)V. Cass. 20 gennaio 2000, n. 610, in Riv. Crit. Dir. Lav. , 2000, pag. 449; Cass. 14 luglio
1984, n. 4144, in Giust. Civ. , 1984, I, pag. 3278, con nota di G. Mammone, Termine di impugnazione e licenziamento di lavoratrice per causa di matrimonio o di maternità; Pret. Roma 23 marzo
1993, in Riv. It. Dir. Lav. , 1993, II, pag. 864.
(56) Cfr. Cass. 30 maggio 1997, n. 4809, in Riv. It. Dir. Lav. , 1998, II, pag. 146.
(57) V. Cass. 29 giugno 1978, n. 3270, in Giur. Agr. It. , 1979, pag. 241.
(58) V. V. Ferrante, Forma e procedura del licenziamento. Il licenziamento disciplinare, loc.
cit. , pag. 223 e segg.
(59) V. Trib. Torino 22 ottobre 1997, in Giur. Piem. , 1998, pag. 55; Pret. Monza 11 marzo
1996, in Riv. Crit. Dir. Lav. , 1996, pag. 792; Trib. Ancona 10 gennaio 1991, in Nuovo Dir. , 1991,
pag. 1078.
(60) V. Cass. 27 febbraio 1997, n. 1781, in Riv. It. Dir. Lav. , 1997, II, pag. 352.
(61) Peraltro, per l’operare dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 ad una azione di annullamento per errore del licenziamento, v. Cass. 28 maggio 1990, n. 4925, in Not. Giur. Lav. , 1990,
pag. 686.
ADL 1/2011
ENRICO GRAGNOLI
49
non quelli intimati nell’esercizio di un potere di libera recedibilità (62), poiché, in tale ultima ipotesi, si sarebbe stati fuori dall’area di vigenza della
legge n. 604 del 1966 (63). L’art. 6 non operava neppure per le azioni rivolte a ottenere la sola indennità sostitutiva del preavviso (64).
Con una disposizione scritta male, l’art. 32, secondo comma, della legge n. 183 del 2010 ha riferito l’applicazione dell’art. 6 “anche a tutti i casi di
invalidità del licenziamento”. A prescindere dalle oggettive difficoltà lessicali (“anche a tutti”), la disposizione non risolve i dubbi, ma li trasforma. È
evidente l’intento di estendere l’operatività dell’art. 6, ma è discutibile fino
a che limite l’obbiettivo sia stato raggiunto. Non vi dovrebbero essere perplessità ulteriori per il recesso intimato alla lavoratrice madre, per quello a
causa di matrimonio, per quello discriminatorio, anche a volere concedere
che, in precedenza, vi potessero essere discussioni. Poiché l’art. 32 fa riferimento in via generale all’invalidità, l’art. 6 deve essere applicato nell’ipotesi di superamento del periodo di comporto (65).
L’art. 32, secondo comma, non è una disposizione della legge n. 604 del
1966 e, quindi, non ha i relativi limiti di operatività, sia perché il precetto
non è collocato in tale contesto prescrittivo, sia perché, a maggiore ragione,
tale interpretazione è in contrasto con le indicazioni implicite dello stesso
art. 32, secondo comma, a prescindere dalla sua stesura poco brillante. Pertanto, la riconducibilità del recesso per superamento del periodo di comporto all’art. 2110 Cod. Civ. e non alla legge n. 604 del 1966 non impedisce
più l’operare dell’art. 6, che riguarda qualunque licenziamento, come sancito dall’art. 32, purché si discuta della sua invalidità. In tale concetto rientra la possibile deviazione dai parametri dell’art. 2110 Cod. Civ. Opposta è
la conclusione qualora il prestatore di opere chieda il pagamento dell’in(62) Sull’inoperare dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 per i lavoratori domestici, v. M.
Mazziotti, I licenziamenti dopo la legge 11 maggio 1990, n. 108, Torino, 1991, pag. 158 e segg.
(63) Cfr. Cass. 22 marzo 1994, n. 2728, in Mass. Giur. Lav. , 1994, pag. 191.
(64) Cfr. Cass. 10 giugno 1992, n. 7111, in Riv. It. Dir. Lav. , 1993, II, pag. 858 e segg. , con
nota di G. Proia, Impugnazione del licenziamento e diritto all’indennità sostitutiva del preavviso;
Trib. Milano 3 marzo 1999, in Riv. Crit. Dir. Lav. , 1999, pag. 673. In senso opposto, v. Pret. Milano 16 giugno 1998, in Lav. Giur. , 1999, pag. 66. Cfr. E. Berti, Tempestiva impugnazione del licenziamento e pretese relative all’indennità di mancato preavviso, in Riv. Giur. Lav. , 1993, II, pag.
351 e segg.; G. Mammone, Tempestiva impugnazione del licenziamento e richiesta dell’indennità di
preavviso, in Giust. Civ. , 1993, I, pag. 2455 e segg.
(65) In precedenza, in modo persuasivo, si era detto che “la fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l’ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di
una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), è soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 Cod. Civ. , che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei
licenziamenti individuali” (v. Cass. 28 gennaio 2010, n. 1861, in Lav. Giur. , 2010, pag. 462).
ADL 1/2011
50
PARTE PRIMA . SAGGI
dennità sostitutiva del preavviso, poiché, in tali circostanze, non si ragiona
dell’illegittimità del recesso, ma solo delle sue conseguenze immediate o
differite.
Residuano due problemi di difficile soluzione, che l’art. 32 avrebbe dovuto affrontare con maggiore consapevolezza. In primo luogo, non è chiaro se il nuovo art. 6 riguardi anche le azioni promosse dai dirigenti desiderosi di vedere liquidata l’indennità supplementare prevista dai contratti
collettivi, per il caso di natura ingiustificata del recesso. In passato, a fronte
di un diverso tenore testuale, era pacifico l’inoperare dell’art. 6, ma, oggi, vi
è da chiedersi se tale fattispecie rientri in quella dell’invalidità, richiamata
dall’art. 32, secondo comma. Vari indizi potrebbero portare all’equiparazione della cosiddetta “ingiustificatezza” all’illegittimità, in specie se si considera come si debba comunque dare attuazione all’art. 7 St. lav. e il diritto
all’indennità supplementare rappresenti la sanzione persino per la violazione del principio del contraddittorio. Tuttavia, è preferibile riportare l’art. 6
alle ipotesi di invalidità comminata per legge, anche perché non avrebbe
troppo senso imporre oneri di impugnazione qualora il sistema sanzionatorio sia solo di carattere economico e non possa portare neppure alla riassunzione dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966.
Ancora più discutibile è la sorte dei licenziamenti adottati in violazione
dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966, o per carenza della forma scritta o per
la mancata comunicazione dei motivi. Si può discutere a lungo sull’effettiva natura dell’inefficacia dell’art. 2 e se tale espressione abbia un significato tecnico preciso o se si debba pensare alla nullità, in una sola o in entrambe le fattispecie regolate dall’art. 2. A maggiore ragione, ci si può domandare se tale “inefficacia” sia da ricondurre all’invalidità, visto che, in carenza di una definizione legale espressa, a tale ultimo riguardo si deve rinviare alla teoria generale. Per parte della giurisprudenza, la violazione dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966 comporta la nullità (66); secondo altre
sentenze, si dovrebbe parlare di inefficacia in senso tecnico (67) o, addirittura, di inesistenza (68).
(66) V. Cass. 27 febbraio 2003, n. 3022, in Mass. Giur. Lav. , 2003, pag. 260; Cass. 5 giugno
2000, n. 7459, in Foro It. Rep. , 2000, v. Lavoro (rapporto), n. 1608; Cass. 10 agosto 1999, n. 8567,
ibid. , 1999, v. cit. , n. 1131; Cass. 20 febbraio 1999, n. 1444, ibid. , 1999, v. cit. , n. 1660; Cass. 13
agosto 1997, n. 7565, in Giur. It. , 1998, col. 2291.
(67) Cfr. Cass. 16 settembre 2002, n. 13543, in Gius, 2003, pag. 153, per cui “la domanda
con la domanda con la quale il lavoratore chieda la dichiarazione di nullità del licenziamento
non si pone in contrasto con la contestazione del licenziamento perché intimato in forma orale”. V. anche Cass. 2 maggio 1996, n. 3966, in Mass. Giur. Lav. , 1996, pag. 370.
(68) Cfr. Cass. 10 novembre 1997, n. 11094, in Giust. Civ. Mass. , 1997, pag. 2126; Cass. 3 novembre 1976, n. 4036, in Foro It. Rep. , 1976, v. Lavoro (rapporto), n. 537.
ADL 1/2011
ENRICO GRAGNOLI
51
La questione della natura della sanzione prevista dall’art. 2 è delicata,
perché, in via espressa, l’art. 2, terzo comma, fa riferimento all’inefficacia
anche per il recesso orale. Del pari, la violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi determina la “inefficacia” (69), con conseguenze in apparenza simili a quelle derivanti dal mancato rispetto della forma scritta (70).
In modo persuasivo, la dottrina si è chiesta se l’art. 2, terzo comma, non
nasconda una aporia, perché è discutibile l’equiparazione fra le due ipotesi (71). Per alcuni, si potrebbe fare riferimento all’inefficacia per l’infrazione all’art. 2, secondo comma, mentre la mancata osservanza del primo comma inciderebbe su un elemento essenziale del negozio, determinando la
nullità (72). È stato obbiettato che “la necessità di una piena conformità al
modello codicistico” sarebbe “pregiudizio dommatico”, perché “la scelta
dell’inefficacia vuole accentuare l’assoluta inidoneità dell’atto a produrre
effetti accertabili con un mero controllo esterno preliminarmente al controllo sui motivi” (73). Rispetto alle interferenze con l’impugnazione, il tema
trova la sua soluzione più convincente nell’esame dell’art. 6 della legge n.
604 del 1966. Poiché la norma fa riferimento alla comunicazione del licenziamento e dei relativi motivi, se richiesti, il termine di decadenza non è applicabile se manca un atto scritto o non è specificata la motivazione, a prescindere dal fatto che la violazione dell’art. 2 comporti nullità o inefficacia
e dal fatto che, se del caso, questa ultima possa essere fatta rientrare nella
più generale figura dell’invalidità.
Con riferimento al periodo antecedente all’entrata in vigore della
legge n. 223 del 1991, si negava che dovessero essere impugnati ai sensi
dell’art. 6 i licenziamenti collettivi (74). Il problema è stato risolto dall’art.
5, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, che prevede un onere analogo a quello dell’art. 6. A dire il vero, l’art. 5 della legge n. 223 del 1991
non è stato modificato, con ovvi problemi di coordinamento. In virtù dell’art. 32, secondo comma, il nuovo sistema dell’art. 6 deve essere applicato ai licenziamenti collettivi, perché i principi relativi hanno carattere ge-
(69) V. Cass. 23 febbraio 1996, n. 1415, in Riv. Crit. Dir. Lav. , 1996, pag. 1015.
(70) V. Pret. Milano 6 luglio 1998, in Lav. Giur. , 1999, pag. 165.
(71) Sull’evoluzione della riflessione sull’art. 2 della legge n. 604 del 1966, v. M.V. Ballestrero, I licenziamenti, Milano, 1975, pag. 95 e segg.
(72) V.: M. Grandi, La risoluzione delle controversie in tema di licenziamenti individuali, in
Riv. Dir. Lav. , 1967, I, pag. 436 e segg.
(73) V. M. Napoli, Licenziamenti, in Dig. , Disc. Priv. , Sez. Comm. , vol. IX, pag. 85 e segg.
(74) Cfr. Cass. , Sez. un. , 18 ottobre 1982, n. 5396, in Foro It. , 1983, I, col. 1337, con nota di
O. Mazzotta, Licenziamento collettivo ed onere di impugnazione; Cass. 23 febbraio 1996, n. 1415,
cit.; Cass. 18 maggio 1995, n. 5485, in Lav. Giur. , 1996, pag. 154. Cfr. R. Del Punta, Illegittimità di licenziamenti collettivi, in Giust. Civ. , 1983, I, pag. 142 e segg.
ADL 1/2011
52
PARTE PRIMA . SAGGI
nerale, senza che l’art. 5, terzo comma, della legge n. 223 del 1991 sia di
ostacolo a tale fine. A maggiore ragione, l’art. 6 opera in tema di lavoro
pubblico.
5. – Qualora l’impresa faccia ricorso al servizio postale o ad altra forma
di trasmissione per comunicare il licenziamento o il successivo atto di
esplicitazione dei motivi, il termine di impugnazione decorre dal momento
nel quale l’atto giunga al domicilio del lavoratore, salvo che egli dimostri di
non avere potuto avere conoscenza della lettera. Pertanto, anche dopo la
legge n. 183 del 2010, trova piana applicazione l’art. 1335 Cod. Civ. . In questa logica sorprende la tesi per cui, in caso di detenzione in carcere del prestatore di opere ignota al datore di lavoro, il termine decorrerebbe dall’arrivo della comunicazione alla residenza (75), nonostante l’evidente impossibilità del destinatario di averne cognizione diretta, per la sua carcerazione (76).
Poiché il termine scatta o dalla ricezione dell’atto del licenziamento o
dall’esternazione dei motivi, il mancato inoltro della motivazione rende superflua l’impugnazione; al contrario, la specificazione della motivazione
nello stesso provvedimento di licenziamento impone l’impugnazione immediata, in quanto il prestatore di opere è a conoscenza delle ragioni dell’estinzione del rapporto e, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966,
non può chiedere chiarimenti. Affinché il termine abbia inizio al momento
della trasmissione dei motivi, questi devono essere stati domandati nel rispetto dell’art. 2 e, pertanto, in modo tempestivo. L’istanza tardiva è irrilevante, non imponendo neppure al datore di lavoro di rispondere. Per altro
verso, se non si chiedono le ragioni del licenziamento, anche per quello immotivato il termine di impugnazione decorre dalla sua comunicazione (77).
Infatti, non vi è mai l’onere (ma solo il potere) di invocare l’illustrazione dei
motivi e l’impugnazione immediata è sempre possibile e sufficiente (78), e
non deve essere rinnovata dopo l’eventuale risposta dell’impresa alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 2.
L’impugnazione (79) deve avere luogo in pendenza del termine di preav-
(75) V. Cass. 23 ottobre 1980, n. 5710, in Giust. Civ. , 1981, I, pag. 37.
(76) Nel senso del testo, v. Cass. 28 giugno 1976, n. 2469, in Foro It. , 1976, I, col. 1804; Pret.
Palermo 22 dicembre 1975, in Dir. Lav. , 1976, II, pag. 424; Pret. Milano 30 aprile 1973, in
Orient. Giur. Lav. , 1973, pag. 555.
(77) V. Pret. Livorno 29 marzo 1991, in Tosc. Lav. Giur. , 1992, pag. 42.
(78) Cfr. Cass. 4 aprile 1990, n. 2785, in Not. Giur. Lav. , 1990, pag. 613.
(79) V. S. Centofanti, Preavviso e impugnazione del licenziamento, in Dir. Lav. , 1985, I, pag.
100 e segg.
ADL 1/2011
ENRICO GRAGNOLI
53
viso (80), né ciò comporta alcuna illegittimità costituzionale (81), poiché non
aggrava la posizione del prestatore di opere. Ormai, non è controverso che,
ai fini dell’impugnazione stragiudiziale, nel termine di sessanta giorni basti
la spedizione, come a ragione rilevato da una recente e nota sentenza (82).
Anche ora, in alternativa all’impugnazione stragiudiziale, il dipendente
può avviare subito il giudizio, nei primi sessanta giorni, senza che debba
compiere alcuna attività ulteriore. L’immediata impugnazione giudiziale
rende superfluo qualunque successivo adempimento e non decorre alcun
altro termine. In linea di massima, per la giurisprudenza sarebbe stato insufficiente il deposito del ricorso in cancelleria (83), ma, nel termine fissato, sarebbe occorsa la notificazione, come confermato dall’ultima dottrina (84). Infatti, solo la notificazione avrebbe realizzato la conoscenza da
parte del convenuto (85) e l’impugnazione giudiziale avrebbe dovuto avere
le stesse connotazioni di quella stragiudiziale (86). Peraltro, è stata considerata sufficiente la “notificazione di un ricorso ai sensi dell’art. 700 Cod.
Proc. Civ. , recante a margine la procura al difensore” (87).
In sostanza, facendo riferimento, talora in via esplicita, a principi riferibili all’interruzione della prescrizione, per la giurisprudenza la struttura
dell’impugnazione giudiziale sarebbe stata da modellare su quella dell’atto
stragiudiziale. Sarebbe stato di per sé insufficiente il deposito del ricorso e
gli effetti sostanziali dell’esercizio dell’azione sarebbero dipesi dalla notificazione (88). La tesi non era persuasiva e si basava su principi che, se mai,
avrebbero potuto riguardare l’interruzione della prescrizione, istituto differente, come ricordato da una remota, ma perspicua decisione, per la quale “il deposito del ricorso, in quanto implica proposizione della domanda
(80) Cfr. Cass. 24 agosto 1991, n. 9116, in Not. Giur. Lav. , 1992, pag. 90; Cass. 30 luglio 1991,
n. 8448, in Mass. Giur. Lav. , 1991, pag. 554; Cass. 15 maggio 1984, n. 2966, ibid. , 1984, pag. 481.
(81) Cfr. Pret. Roma 10 aprile 1970, in Giur. Mer. , 1972, I, pag. 319.
(82) V. Cass. , Sez. un. , 14 aprile 2010, n. 8830, in Lav. Giur. , 2010, pag. 729.
(83) V. Cass. 29 gennaio 1994, n. 899, in Mass. Giur. Lav. , 1994, pag. 237. In senso opposto,
v. Pret. Ancona 19 febbraio 1991, in Giust. Civ. , 1991, I, pag. 1869, per cui sarebbe sufficiente il
deposito, purché il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione siano notificati al datore di lavoro nel termine di dieci giorni introdotto dall’art. 415, quarto comma, Cod.
Proc. Civ.
(84) V. V. Ferrante, Forma e procedura del licenziamento. Il licenziamento disciplinare, loc.
cit. , pag. 220 e segg.
(85) Cfr. Cass. 19 ottobre 1981, n. 5468, in Not. Giur. Lav. , 1982, pag. 156.
(86) V. Cass. , sez. un. , 18 ottobre 1982, n. 5395, in Foro It. , 1982, I, col. 3019; Cass. 7 febbraio 1983, n. 1028, in Riv. It. Dir. Lav. , 1983, II, pag. 979; Cass. 22 dicembre 1983, n. 7501, in
Not. Giur. Lav. , 1984, pag. 405; Cass. 23 dicembre 1983, n. 7609, ibid. , 1984, pag. 405.
(87) Cfr. Cass. 18 aprile 1995, n. 4337, in Orient. Giur. Lav. , 1995, pag. 411.
(88) Cfr. G. Pera, La cessazione del rapporto di lavoro, cit. , pag. 203 e segg. V. anche Trib.
Milano 14 febbraio 2005, ord. , in Guida Dir. , 2005, fasc. 34, pag. 69.
ADL 1/2011
54
PARTE PRIMA . SAGGI
nei modi di legge, è idoneo a impedire una decadenza, perché questo effetto sostanziale è collegato al dato obbiettivo dell’esperimento dell’azione
in un certo termine, a prescindere dalla conoscenza della controparte” (89).
L’art. 6 introduce un termine nell’ambito del quale, in via principale,
deve essere esercitato il diritto sottoposto a decadenza; solo in modo alternativo, l’estinzione è preclusa dal compimento del cosiddetto “atto singolare” e, cioè, dall’impugnazione stragiudiziale (90), più frequente nella prassi, ma fattispecie complementare sul piano logico. In sostanza, “ai fini dell’interruzione della prescrizione basta la volontà manifestata di volersi avvalere del proprio diritto, mentre ai fini impeditivi della decadenza occorre una valida manifestazione di esercizio del diritto generalmente rappresentata dalla domanda giudiziale, rispetto alla quale assumono il ruolo di
mezzi sostitutivi gli atti previsti dalla legge” (91).
In tema di interruzione della prescrizione, “la domanda giudiziale non
ha il valore di atto interruttivo per eccellenza, ma solo in quanto presenti gli
stessi requisiti e realizzi lo stesso risultato partecipativo della costituzione
in mora che, pertanto, assume il rilievo di mezzo interruttivo a carattere generale” (92). Invece, in senso contrario, se la decadenza ha per oggetto l’impugnazione, nel termine previsto basta il deposito del ricorso, che costituisce esercizio dell’azione, e l’art. 6 ha riguardo alla proposizione della domanda in senso processuale. L’impugnazione giudiziale non deve avere caratteristiche analoghe a quella stragiudiziale, ma è l’oggetto principale dell’istituto e, per impedire la decadenza, rileva l’esercizio dell’azione. A maggiore ragione la conclusione deve essere preferita oggi, poiché, seppure
con riguardo al secondo termine di duecentosettanta giorni, l’art. 6 fa riferimento al semplice deposito del ricorso e il principio ha un valore generale. È sufficiente l’esercizio dell’azione e, per esempio, il deposito di un ricorso introduttivo a un procedimento cautelare.
6. – Nel primo termine di sessanta giorni, per lo più, il prestatore di opere procederà a una impugnazione stragiudiziale. Vi è da chiedersi da quando decorra il termine di duecentosettanta giorni o per il deposito del ricorso o per l’avvio del tentativo di conciliazione o della procedura arbitrale.
Poiché, ai fini del rispetto del termine iniziale, basta la spedizione dell’atto
(89) V. Cass. 11 ottobre 1978, n. 4560, in Dir. Lav. , 1979, II, pag. 356.
(90) V. V. Tedeschi, Decadenza, loc. cit. , pag. 776 e segg.; G.L. Pellizzi, In margine al problema della decadenza, loc. cit. , pag. 41 e segg.
(91) Cfr. G. Panza, Decadenza nel diritto civile, loc. cit. , pag. 136 e segg.
(92) Cfr. G. Panza, Decadenza nel diritto civile, loc. cit. , pag. 136 e segg. , e, dello stesso A. ,
Contributo allo studio della prescrizione, Napoli, 1984, pag. 79 e segg.
ADL 1/2011
55
ENRICO GRAGNOLI
di impugnazione, sembra ragionevole collegare a tale spedizione e non al
ricevimento il decorso del secondo termine, fermo il fatto che, se nei sessanta giorni, in luogo di procedere all’impugnazione stragiudiziale, il lavoratore deposita il ricorso giudiziale, non vi è altro da fare.
In ordine all’atto di avvio della procedura di conciliazione o arbitrato,
l’art. 6 non è molto chiaro. Entro i centosettanta giorni dall’impugnazione
stragiudiziale si può dare applicazione all’art. 412 quater Cod. Proc. Civ. ,
con la notificazione del cosiddetto “ricorso” dell’art. 412 quater, terzo comma, Cod. Proc. Civ. , oppure all’art. 410 Cod. Proc. Civ. , con l’istanza del primo comma. In qualunque caso di esito negativo della procedura e, cioè, sia
nell’ipotesi di rifiuto della controparte (art. 410, settimo comma, Cod. Proc.
Civ.; art. 412 quater, quarto comma, Cod. Proc. Civ.), sia di mancato raggiungimento della conciliazione (art. 411, secondo comma, Cod. Proc.
Civ.), al prestatore di opere residuano sessanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale. Peraltro, per l’art. 410, secondo comma, Cod. Proc. Civ. ,
nell’ipotesi di tentativo di conciliazione in sede amministrativa, “la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni
termine di decadenza”, così che, se bene si interpreta, in questa situazione
l’ulteriore termine di decadenza è di fatto di ottanta giorni.
Se, nei primi sessanta giorni, il lavoratore avvia il tentativo di conciliazione in sede amministrativa ai sensi dell’art. 410 Cod. Proc. Civ. comunicando tale attività alla controparte, l’atto vale come impugnazione del licenziamento e non vi è altro da fare, fermo il fatto che, in caso di mancato
accordo, vi sono ottanta giorni per agire in giudizio. Se il lavoratore promuove il tentativo di conciliazione senza alcuna comunicazione al datore
di lavoro, sospende il decorso dei termini dell’art. 6 della legge n. 604 del
1966, ai sensi dell’art. 410, secondo comma, Cod. Proc. Civ. , ma non impugna e lo deve fare dopo la fine del procedimento di conciliazione. Infatti, “il
decorso del termine è sospeso con la presentazione della richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione e non con la successiva convocazione, giacché, in difetto, l’eventuale inerzia o il ritardo della pubblica amministrazione dovrebbero essere posti a carico (e a rischio) del lavoratore,
con la conseguenza di esporre la normativa a censure di incostituzionalità” (93), con principio ispirato a buon senso e da confermare nel nuovo
contesto normativo.
In nessun modo il compiersi della decadenza e, in particolare, il decor-
(93) V. Cass. 19 giugno 2006, n. 14087, in Nuova Giur. Civ. Comm. , 2007, pag. 695.
ADL 1/2011
56
PARTE PRIMA . SAGGI
so del termine di duecentosettanta giorni non può essere impedito da iniziative di conciliazione in sede sindacale, libere, ma irrilevanti ai fini dell’art. 6. Invece, non in tema di licenziamento, ma negli altri casi cui si applica l’art. 6, la decadenza del termine di duecentosettanta giorni non si compie nell’ipotesi dell’avvio della specifica procedura arbitrale ai sensi dell’art. 31, decimo comma, della legge n. 183 del 2010. Anche in tema di licenziamento, la decadenza dei duecentosettanta giorni non si realizza qualora
si avvii il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 31, tredicesimo comma,
della legge n. 183 del 2010 e, quindi, avanti alle Commissioni di certificazione, fermo il residuo termine di ottanta giorni qualora non si raggiunga
l’accordo.
Solo in apparenza il quadro è frammentario. Manca un tentativo razionale di riportare a unità la regolazione delle procedure di conciliazione e di
arbitrato, ma è molto improbabile che ne derivino frequenti problemi applicativi. Lo scarso successo delle procedure arbitrali e, in particolare, di
quella dell’art. 412 quater Cod. Proc. Civ. è destinato a rendere limitate le interferenze con l’art. 6. Per altro verso, vi sarà scarsa propensione a dare impulso ai tentativi di conciliazione e, quindi, a quello dell’art. 410 Cod. Proc.
Civ. , perché il fallimento condurrebbe a una significativa riduzione del termine per l’azione in giudizio, ai danni di una ponderata stesura dell’atto introduttivo. Secondo quanto è verosimile, anche nelle ipotesi di applicabilità dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, il lavoratore procederà all’impugnazione stragiudiziale e dalla successiva azione giudiziale, con un accrescimento del numero delle controversie, soprattutto in quelle aree geografiche nelle quali è prassi la frequente stipulazione di transazioni per i recessi in tutela obbligatoria.
Ci si può chiedere se sia in vigore l’art. 5 della legge n. 108 del 1990, mai
abrogato, neppure dalla legge n. 183 del 2010 e, sul punto, sarebbe stata opportuna una indicazione espressa. Si potrebbe ricavare dal silenzio il perdurante operare della disposizione, ma tale soluzione non convince. A prescindere dall’oscurità dei percorsi del legislatore, questi ha introdotto un
nuovo complessivo regime dell’impugnazione, caratterizzato dall’inesistenza di un tentativo obbligatorio di conciliazione e dall’alternativa fra
l’avvio del giudizio, quello della procedura arbitrale e l’espletamento di un
tentativo di conciliazione facoltativo. Nonostante nulla si dica sull’art. 5
della legge n. 108 del 1990, tali conclusioni sono insite nell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e comportano l’abrogazione implicita di qualunque disposizione in contrasto, come l’art. 5.
7. – Anche dopo la legge n. 183 del 2010 e a prescindere dalle sue
espressioni e, per esempio, dal singolare ricorso al concetto di efficacia del-
ADL 1/2011
ENRICO GRAGNOLI
57
l’impugnazione (che non ha natura negoziale), tutti i termini dell’art. 6 sono di decadenza e insuscettibili di essere interrotti o sospesi (94). Per alcuni, la decadenza dell’art. 6 sarebbe stata solo “in funzione della richiesta di
riassunzione o della reintegrazione e non dell’accertamento dell’illegittimità del recesso” (95). L’art. 6 non rileva se si chiede la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso (96) o se si propone una domanda di accertamento, a prescindere dalla sua ammissibilità e dal sussistere di
un corrispondente interesse.
A maggiore ragione, l’inosservanza dell’art. 6 non preclude di chiedere
il risarcimento del danno dovuto all’eventuale natura ingiuriosa del recesso e, pertanto, alle modalità della sua intimazione. Tali domande sono autonome rispetto a quelle previste dall’art. 18 St. lav. o dall’art. 8 della legge
n. 604 del 1966. Il risarcimento può essere dovuto anche se il licenziamento è legittimo, qualora il comportamento del datore di lavoro non sia stato
rispettoso della dignità del prestatore di opere e abbia determinato un pregiudizio.
Invece, con una impostazione più rilevante dal punto di vista applicativo, ma più discutibile, per alcune pronunce, qualora “non siano applicabili le norme specifiche sul licenziamento, per lo scadere del termine dell’art. 6, il recesso può essere fatto valere come ( . . . ) illecito ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ. o come inadempimento ai sensi dell’art. 1218 Cod.
Civ. e può dare luogo a una condanna al risarcimento del danno, se sussistono tutti i relativi elementi costitutivi” (97). Anzi, la decadenza dell’art. 6
consentirebbe “di esperire la normale azione risarcitoria in base ai principi generali” (98). Il punto è se esista una simile azione, sostitutiva o alternativa rispetto ai meccanismi di tutela previsti in modo specifico, in particolare dall’art. 18 St. lav. o dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, poiché un
“negozio giuridico, quale per certi aspetti il licenziamento, non può esse-
(94) V. Cass. 25 ottobre 1982, n. 5563, in Giust. Civ. , 1983, I, pag. 1553; Cass. 15 giugno
1985, n. 3612, ibid. , 1985, I, pag. 3077, con nota di P. Ghinoy, Sul termine per l’impugnazione del
licenziamento in caso di incapacità naturale del destinatario della comunicazione.
(95) Cfr. Pret. Napoli 13 novembre 1990, in Nuova Giur. Civ. Comm. , 1991, I, pag. 653; v. anche Cass. 24 giugno 1987, in Foro It. Rep. , 1987, v. Lavoro (rapporto), n. 2578; Cass. 5 febbraio
1985, n. 817, ibid. , 1985, v. cit. , n. 1937; Trib. Milano 28 gennaio 2004, in Orient. Giur. Lav. ,
2004, I, pag. 218.
(96) Cfr. Cass. 2 febbraio 1976, n. 39, in Riv. Giur. Lav. , 1976, II, pag. 768.
(97) Cfr. Trib. Torino 22 marzo 2002, in Giur. Piem. , 2003, pag. 179.
(98) V. Cass. 2 marzo 1999, n. 1757, in Riv. It. Dir. Lav. , 2000, II, pag. 177, con nota di A. Pellecchia, Impossibilità di impugnazione di un licenziamento futuro. Per gli errori di formulazione
della massima di Cass. 2 marzo 1999, n. 1757, v. V. Ferrante, Forma e procedura del licenziamento. Il licenziamento disciplinare, loc. cit. , pag. 227 e segg. , che ricostruisce anche alcuni errori di formulazione delle massime delle sentenze (nt. 146).
ADL 1/2011
58
PARTE PRIMA . SAGGI
re considerato in termini di colpa o di non colpa, ma in termini di validità
– invalidità” (99).
A prescindere dalla natura costitutiva o dichiarativa della sentenza relativa alla legittimità del licenziamento, “oggetto del giudizio sono le pretese che il lavoratore può fare valere sulla base della continuità del rapporto” (100). Anzi, con riguardo al sistema dell’art. 18 St. lav. , “la mora debendi ( . . . ) trova il suo fondamento nell’inadempimento dell’obbligazione
retributiva, la quale assume piena rilevanza per l’inefficacia del licenziamento e, quindi, per la sopravvivenza del rapporto” (101). Pertanto, non vi è
una tutela risarcitoria sostitutiva a quella dell’art. 18 St. lav. (condizionata al
rispetto dell’art. 6) e, a maggiore ragione, a quella più tenue e, comunque,
esclusiva dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (102).
Il risarcimento del danno dovuto all’interruzione del rapporto è regolato dall’art. 18 St. lav. e, nella diversa logica dell’art. 8, è sostituito da una indennità predeterminata nel minimo e nel massimo. In nessun caso si fare
può valere la pretesa invalidità come fatto illecito ai sensi dell’art. 2043
Cod. Civ. o come inadempimento ai sensi dell’art. 1218 Cod. Civ. senza che
si dia applicazione all’art. 18 St. lav. od all’art. 8 della legge n. 604 del 1966
e, quindi, senza l’osservanza dell’art. 6, imposta come condizione per l’operare di tali due disposizioni. Diversa è l’azione per il risarcimento di un danno ulteriore, comunque da dimostrare, collegato al complessivo comportamento ingiurioso. In questo caso, nessun ostacolo è frapposto dall’art. 6,
poiché non si dibatte del negozio, ma della condotta dell’impresa e della lesione della dignità.
Però, se si discute della mancata corresponsione delle retribuzioni e,
dunque, dell’interruzione della collaborazione, occorre adempiere all’onere dell’art. 6, poiché non vi è azione differente da quelle indicate dall’art. 18
St. lav. o dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (103). In modo analogo, anche
per eventuali ipotesi di nullità di diritto comune, opera l’art. 6. Se esso è applicabile, nessuna azione risarcitoria può essere esperita in caso di deca-
(99) V. F. Mazziotti, Inefficacia del licenziamento e risarcimento del danno, in Studi in onore
di Giuseppe Suppiej, Padova, 2005, pag. 652 e segg.
(100) V. F. Mazziotti, Inefficacia del licenziamento e risarcimento del danno, loc. cit. , pag. 653
e segg.
(101) Cfr. F. Mazziotti, Inefficacia del licenziamento e risarcimento del danno, loc. cit. , pag.
654 e segg. , con espresso rinvio a Di Majo, I licenziamenti illegittimi tra diritto comune e diritto
speciale, in Riv. Giur. Lav. , 1974, I, pag. 282 e segg.
(102) Nello stesso senso, v. V. Ferrante, Forma e procedura del licenziamento. Il licenziamento disciplinare, loc. cit. , pag. 227 e segg.
(103) V. S. Liebman, Il sistema dei rimedi nella disciplina dei licenziamenti individuali, in
Quad. Dir. Lav. e Rel. Ind. , 2002, n. 26, pag. 52 e segg.
ADL 1/2011
ENRICO GRAGNOLI
59
denza. A conferma, sono intervenute varie e coerenti sentenze di legittimità; per esse, la mancata impugnazione preclude non solo l’esercizio dell’azione dell’art. 18 St. lav. e dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, ma anche
“l’azione risarcitoria di diritto comune” (104). Non fa eccezione, ma si colloca su un diverso piano una azione volta a chiedere il risarcimento di un
danno ulteriore, collegato al complessivo comportamento ingiurioso del
datore di lavoro.
8. – Per quanto sia strano e induca a forti dubbi sulla preveggenza del
legislatore, una così intensa innovazione dell’impugnazione del licenziamento si è accompagnata a un completo silenzio sulla disciplina transitoria,
con il probabile prorompere di futuri e inevitabili scontri giudiziali. Si è già
sentito invocare il principio tempus regit actum, così che, a fronte di licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, le ulteriori attività sarebbero scandite dal nuovo istituto. In particolare, un recesso anteriore al 24 novembre 2010 e impugnato in sede stragiudiziale dovrebbe portare o all’esercizio dell’azione in giudizio entro duecentosettanta giorni dallo stesso 24 novembre o in sessanta giorni, qualora, prima dell’avvento della legge n. 183 del 2010, fosse stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Non a caso, se bene si intuisce, simili, comprensibili preoccupazioni
hanno portato a una immediata accelerazione della preparazione degli atti
introduttivi del giudizio, per motivi di ordine cautelativo. Seppure lodevoli, tali timori sono eccessivi. Il sistema dell’art. 6 può essere invocato solo
per licenziamenti emanati dopo il 24 novembre 2010, poiché a decorrere
da tale momento il nuovo meccanismo deve essere attuato nel suo complesso, oltre tutto con il minimo termine di vacatio legis. Non si vede perché
la disciplina dovrebbe avere una sorta di esecuzione frazionata e, di conseguenza, non si capisce perché essa dovrebbe concernere alcune attività rispetto a sequenze procedurali iniziate prima del 24 novembre 2010. L’impugnazione è un istituto unitario, da concepire in una progressiva scansione, immaginata in modo differente dalle due stesure dell’art. 6. Esse sono
incompatibili e non permettono una sorta di contaminazione fra profili dell’una e dell’altra.
Quindi, non è possibile applicare in modo congiunto allo stesso licenziamento componenti del vecchio o del nuovo art. 6, ma, in ragione del mo(104) V. Cass. 21 agosto 2006, n. 18216, in Arg. Dir. Lav. , 2007, pag. 245, con nota di L. Zaccarelli, Le conseguenze della tardiva impugnazione del licenziamento illegittimo; Cass. 12 ottobre
2006, n. 21833, ibid. , 2007, pag. 517, con nota di L. Zaccarelli, Ancora sulle conseguenze della
tardiva impugnazione del licenziamento illegittimo.
ADL 1/2011
60
PARTE PRIMA . SAGGI
mento di intimazione, si deve dare attuazione a uno dei due modelli. L’ultimo riguarda solo i recessi successivi al 24 novembre 2010 e non può essere
invocato, per esempio, a proposito del deposito del ricorso per provvedimenti adottati in passato e impugnati sulla scorta del regime superato. Oltre tutto, la tesi opposta introdurrebbe elementi di irrazionalità nell’attività
forense e nel relativo rapporto professionale, impostato sulla base di valutazioni organizzative del difensore che, compiute nel vigore di una norma,
non possono essere contraddette dalle scelte del legislatore. Dopo avere
deciso quanti clienti seguire, con determinazioni che tenevano in considerazione i tempi programmabili dell’attività a fronte della stesura originaria
dell’art. 6, il difensore non può essere costretto a fare fronte per rapporti già
instaurati a radicali novità prescrittive, che devono valere solo per il futuro.
ADL 1/2011
Marco Marazza
Prof. ord. dell’Università di Teramo
OGGETTO ED EFFETTI
DELLA NUOVA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
Sommario: 1. Le novità, in sintesi. – 2. La certificazione delle clausole che regolamentano il
rapporto di lavoro. – 3. La certificazione dei contratti nei quali la prestazione di lavoro è
solo indirettamente dedotta. – 4. Poteri del giudice ed effetti della nuova certificazione. –
5. Conclusioni.
1. – La legge n. 183 del 2010 (il cosiddetto “Collegato Lavoro”) interviene anche in materia di certificazione dei contratti di lavoro apportando
tre modifiche dirette alla previgente regolamentazione dell’istituto dettata
dal d.lgs. n. 276 del 2003.
Il quarto comma dell’art. 30 della legge n. 183 del 2010 modifica l’art.
75 del d.lgs. n. 276 del 2003 chiarendo quali sono le nuove finalità dell’istituto. Lo scopo della certificazione non è più quello di “ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro” tramite la “certificazione del contratto” bensì quello, già a prima vista più ambizioso, di “ridurre il contenzioso in materia di lavoro” tramite la certificazione di “contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di
lavoro”.
Il quinto comma del medesimo art. 30 della legge n. 183 del 2010 modifica l’art. 76 del d.lgs. n. 276 del 2003 definendo nuove modalità operative
per la certificazione effettuata dai consigli provinciali dei consulenti del lavoro. In particolare precisando che questi ultimi svolgono attività di certificazione solo nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro ed il
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, cui vengono affidate, tra l’altro, anche le funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi. Parrebbe un atto di diffidenza del legislatore nei confronti delle articolazioni provinciali degli organi associativi dei consulenti del lavoro, ma va
detto che presso le sedi di certificazione – ivi inclusa quella dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro – per effetto della legge n. 183 del 2010 è
oggi non solo possibile esperire il tentativo facoltativo di conciliazione di
cui all’art. 410 Cod. Proc. Civ. (art. 32, tredicesimo comma, della legge n. 183
del 2010) ma anche istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro (art. 32, dodicesimo comma, della legge n. 183 del 2010).
Camere per le quali, è solo il caso di notare, al di fuori delle sedi di certificazione è richiesta ex lege la presidenza di un professore universitario o di un
avvocato cassazionista (art. 412 quater, secondo comma, Cod. Proc. Civ.).
ADL 1/2011
62
PARTE PRIMA . SAGGI
Il diciassettesimo comma dell’art. 31 della legge n. 183 del 2010, infine,
modifica l’art. 79 del d.lgs. n. 276 del 2003 aggiungendo la previsione per
la quale gli effetti della certificazione effettuata nel corso di svolgimento
del rapporto di lavoro si producono dal momento dell’inizio del contratto
ove la commissione abbia appurato “che l’attuazione del medesimo è stata,
anche nel periodo antecedente alla propria attività istruttoria, coerente con
quanto appurato in tale sede”.
Per quanto alcune delle novità introdotte non appaiano in grado di suscitare particolare interesse scientifico, la diversa e più ampia finalità che la
legge assegna all’istituto della certificazione pare densa di rilevanti implicazioni.
Non solo la nuova formulazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 276 del 2003
consente di estendere la certificazione a tipologie di accordi fino ad oggi
estranee a questo istituto (aprendo la porta della certificazione ad ogni tipologia contrattuale nella quale è dedotta, direttamente od indirettamente,
una prestazione di lavoro). Lo stesso art. 30 della legge n. 183 del 2010 stabilisce, inoltre, che nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione di contratto (salvo il
caso di erronea qualificazione del contratto, vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione)
(art. 30, secondo comma) ed affida agli atti di autonomia privata certificati
anche il compito di tipizzare i concetti di giusta causa e giustificato motivo
nonché di modulare le conseguenze risarcitorie del licenziamento illegittimamente intimato nell’ambito di applicazione della tutela obbligatoria
(art. 30, terzo comma).
Dalla lettura coordinata di queste disposizioni, esplicitamente orientate a ridurre il contenzioso in materia di lavoro (e non più a ridurre il solo
contenzioso sulla qualificazione dei contratti di lavoro), se ne deduce che
la certificazione: a) non riguarda più solo la scelta della tipologia contrattuale, essendo oggi estesa anche alla clausole che regolamentano il rapporto di lavoro; b) non è più circoscritta ai contratti che hanno direttamente ad
oggetto una prestazione di lavoro, essendo estesa anche ai contratti che la
prestazione di lavoro la contemplano anche solo indirettamente; c) produce nuovi effetti che sembrano anche condizionare il potere di accertamento del giudice ed, in taluni casi, poter derogare la legge.
2. – L’istituto della certificazione nasce nel 2003, come noto, per dare
un contributo alla stabilità dei rapporti economici proponendosi di assistere la volontà delle parti nella scelta, tra quelli disponibili, di un determinato tipo di contratto di lavoro. Una volta ottenuta la certificazione del con-
ADL 1/2011
MARCO MARAZZA
63
tratto di lavoro dai competenti organi, gli effetti riconducibili a quel tipo
contrattuale non sono più modificabili fin quando non venga accolto uno
dei ricorsi giurisdizionali espressamente previsti dalla legge (l’art. 80 del
d.lgs. n. 276 del 2003 prevede che chi vi abbia interesse possa opporsi agli
effetti della certificazione per erronea qualificazione del contratto; per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua attuazione; per vizi
del consenso). L’ampiezza dei rimedi giurisdizionali esperibili, in buona
sostanza sovrapponibili a quelli azionabili anche in assenza di certificazione, non ha finora consentito di attribuire alla certificazione una reale efficacia di contenimento del contenzioso relativo alla qualificazione dei contratti e ne ha piuttosto confinato gli effetti più rilevanti, certamente non trascurabili, ai rapporti con eventuali terzi interessati ad una diversa qualificazione del contratto di lavoro. Nel momento in cui il contratto è certificato,
infatti, l’eventuale accertamento di un presunto vizio di qualificazione del
contratto o del rapporto non può produrre un effetto nella sfera giuridica
delle parti del contratto di lavoro sino all’emanazione di un provvedimento
giudiziale di merito che accolga uno dei ricorsi giurisdizionali previsti dalla legge. Ond’è che l’esigibilità di eventuali sanzioni amministrative e di
eventuali crediti della pubblica amministrazione o degli enti previdenziali
rimane esclusivamente subordinata all’emanazione di un provvedimento
giudiziale di merito, a differenza di quanto accade nel caso in cui l’accertamento riguardi contratti di lavoro non certificati.
Non v’è dubbio, ad ogni buon conto, che mentre sino ad oggi la certificazione poteva riguardare esclusivamente la scelta di una determinata tipologia contrattuale nell’ambito della quale era direttamente dedotta una
prestazione di lavoro, con la novella del 2010 il legislatore ha, in primo luogo, inteso estendere l’utilizzabilità dello strumento anche a tutte le clausole che regolamentano lo svolgimento del rapporto.
Ciò si deduce non solo dal fatto, già di per se assai significativo, che la
finalità dell’istituto non è più solo quella di contenere il contenzioso sulla
qualificazione dei contratti di lavoro ma anche, e soprattutto, dalla circostanza che nel dettare la regolamentazione dei nuovi effetti della certificazione l’art. 30, secondo comma, della legge n. 183 del 2010 fa esplicito riferimento ai vincoli in cui si imbatte il Giudice nell’applicare clausole certificate ai fini della qualificazione del contratto di lavoro e, per quanto qui più
interessa, della interpretazione delle relative clausole.
Ne deriva, ad esempio, che potranno essere oggetto di certificazione,
tra l’altro, le clausole appositive del termine al contratto di lavoro e le clausole elastiche e flessibili dei contratti di lavoro a tempo parziale.
Ma anche – per esplicita previsione legislativa – le clausole di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che contengano tipiz-
ADL 1/2011
64
PARTE PRIMA . SAGGI
zazioni di giusta causa e giustificato motivo di licenziamento o che fissino
parametri per la quantificazione del risarcimento del danno ai sensi dell’art.
8 della legge n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento intimato nell’area
di applicazione della tutela obbligatoria. Ipotesi, queste ultime, che hanno
richiesto una esplicita previsione legislativa proprio in ragione della valenza anche derogatoria che, in quei casi, può caratterizzare il patto individuale validamente certificato al fine di tipizzare le ipotesi di risoluzione del
rapporto o di personalizzare i criteri di risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo.
3. – A ciò si aggiunga che l’oggetto della certificazione non è più circoscritto ai contratti nei quali è direttamente dedotta una prestazione di lavoro prevalentemente personale, sia essa subordinata o meno, con le sole deroghe – già espressamente contemplate nella previgente disciplina – della
estensione della certificazione anche ai regolamenti interni delle cooperative (art. 83 d.lgs. n. 276 del 2003) ed ai contratti di appalto (art. 84 del
d.lgs. n. 276 del 2003).
Con la modifica dell’art. 75 del d.lgs. n. 276 del 2006 possono infatti oggi essere certificati anche i contratti nei quali la prestazione di lavoro è solo
indirettamente dedotta e la formulazione pare estendere l’applicabilità dell’istituto ai contratti di somministrazione, agli accordi relativi ai distacchi di
personale e, probabilmente, anche ai contratti che hanno ad oggetto la cessione di un’azienda o di un suo ramo (con l’inevitabile indiretto coinvolgimento, ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ. , dei relativi contratti di lavoro).
In altri termini sono oggi certificabili anche tutti contratti sottoscritti
tra due imprenditori, o comunque datori di lavoro, nei quali sia indirettamente dedotta una prestazione di lavoro.
4. – Rimane da verificare quali siano gli effetti di questa nuova e più ampia certificazione, in primo luogo sul potere di accertamento del giudice,
dipendendo da ciò – in fin dei conti – la reale portata innovativa di quest’ultima riforma.
Come detto, l’art. 30, secondo comma, della legge n. 183 del 2010 stabilisce che il giudice nella qualificazione del contratto e nell’interpretazione delle sue clausole non può discostarsi dalle valutazioni delle parti
espresse in sede di certificazione, fatto salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
In sostanza l’art. 30 della legge n. 183 del 2010 richiama i medesimi motivi che legittimano ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 276 del 2003 la proposizione del ricorso avverso l’atto certificato e ciò potrebbe indurre a conclu-
ADL 1/2011
MARCO MARAZZA
65
dere che nulla è sostanzialmente cambiato rispetto al passato. Ma sarebbe
errato non tentare di valorizzare le potenzialità innovative di questa parte
della riforma.
Anzitutto va detto che la portata dell’art. 30 della legge n. 183 del 2010
è generale perché quella disposizione è destinata ad operare in tutti i casi
nei quali all’autorità giudiziaria è richiesto di sussumere una fattispecie
concreta in una fattispecie astratta ai fini della qualificazione del contratto
e della interpretazione delle relative clausole. Dunque in tutte le ipotesi
nelle quali la risoluzione della controversia presuppone che venga accertata l’esistenza o meno di un contrasto tra l’accordo individuale certificato ed
una norma inderogabile di legge al fine di stabilire la validità o l’invalidità
del patto, non importa se relativo alla scelta del tipo contrattuale (ad esempio, lavoro autonomo o subordinato) od alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Dal tenore letterale della legge parrebbe inoltre piuttosto chiara l’intenzione del legislatore di fissare un argine al potere di accertamento del
giudice giacchè questi, così stabilisce l’art. 30, secondo comma, della legge
n. 183 del 2010, non potrà discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse
in sede di certificazione e, cioè, dal contenuto dell’accordo stesso. Le “valutazioni delle parti” cui fa riferimento la legge, infatti, ben possono coincidere con le volontà manifestate all’interno del documento contrattuale il
cui perfezionamento, è il caso di ricordare, avviene proprio nell’ambito della procedura di certificazione e con l’assistenza dell’organo certificatore
(art. 81 del d.lgs. n. 276 del 2003).
Ne deriva che tutte le clausole certificate – nella parte in cui contengano una valutazione condivisa in merito all’esistenza di un’esigenza organizzativa (ad esempio, quale presupposto legittimante dell’apposizione del
termine ad un contratto di lavoro o di somministrazione), alla definizione
del perimetro di un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività
economica organizzata ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ, alla individuazione
di un progetto o programma di lavoro, ecc. . . . – rimangono di fatto sottratte alla verifica giudiziale di congruità rispetto alla legge in quanto già valutate coerenti con la norma imperativa dall’ente certificatore.
Ciò, bene inteso, almeno fin quando non venga accertato, in una sorta
di giudizio preliminare: a) un vizio del consenso, dato per errore, estorto
con violenza o carpito con dolo (art. 1427 Cod. Civ.) ; b) una difformità tra
quanto dichiarato nell’accordo ed il successivo concreto svolgimento dei
fatti; c) un errore nella qualificazione del contratto. Solo nel caso in cui
venga accertata la ricorrenza di una di queste tre ipotesi al Giudice sarà
consentito mettere in discussioni le valutazioni delle parti e sindacare la validità dell’accordo certificato e, dunque, appare assai rilevante, se non de-
ADL 1/2011
66
PARTE PRIMA . SAGGI
terminante, accertare la portata di questi possibili vizi dell’atto certificato
con riferimento alle più ampie tipologie di atti oggi certificabili.
Per il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti, per il vero,
nulla appare realmente modificato rispetto alla previgente disciplina, ben
potendo chi ha interesse rivendicare la diversa qualificazione del contratto
anche solo sostenendo che vi sia stato un errore di qualificazione in sede di
certificazione. In altri termini, se viene qualificato come contratto di appalto un contratto invece sussumibile nella fattispecie del contratto di somministrazione il giudice potrà svolgere il suo accertamento anche solo rilevando l’errore di qualificazione del contratto e, di conseguenza, potrà “discostarsi dalle valutazioni delle parti”.
Ben più incisiva potrebbe invece essere la portata della riforma in tutti
i casi in cui la certificazione non attenga in senso stretto alla qualificazione
del contratto per concentrarsi, invece, su alcuni suoi specifici aspetti. In
questi casi, infatti, il giudice, escluso che possa porsi un problema di errore
nella qualificazione del contratto, potrà discostarsi dalle valutazioni
espresse dalle parti solo ove preliminarmente accerti un vizio del consenso
od un vizio di coerenza tra le dichiarazioni negoziali certificate ed il successivo svolgimento dei fatti.
Con la conseguenza, a ben vedere, che ove venga certificata l’esistenza
di una determinata esigenza organizzativa – ad esempio con la finalità di
certificare ai sensi dell’art. 78, secondo comma, lettera d), del d.lgs. n. 276
del 2010 gli “effetti civili” della apposizione del termine al contratto di lavoro od al contratto di somministrazione – al giudice non sarà in alcun caso consentito mettere in discussione le valutazioni espresse dalle parti, e
quindi l’accordo, se non dopo aver accertato l’esistenza di vizi del consenso o l’inesistenza, in concreto, dell’esigenza organizzativa concordemente
valutata dalle parti come idonea a fare sorgere un vincolo contrattuale temporaneo.
Ove infatti – come credo sia corretto – non si ritenesse di assimilare
questo accertamento ad un accertamento sulla qualificazione del contratto,
risulterebbe precluso al giudice accertare la non sussumibilità della causale in concreto indicata dalle parti in quella astratta prevista dalla legge, giacchè – in assenza di un vizio del consenso o di una difformità tra il programma negoziale e la sua attuazione – quell’indagine postulerebbe comunque
un discostarsi dalle valutazioni delle parti che il legislatore ha inteso
espressamente escludere.
Del tutto coerentemente, del resto, in assenza di vizi del consenso al
giudice, vincolato per legge a “tenere conto” di patti certificati, parrebbe
precluso anche entrare nel merito delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo eventualmente oggetto di certificazione o, comunque, sin-
ADL 1/2011
MARCO MARAZZA
67
dacare i criteri di quantificazione del risarcimento del danno per il caso di
licenziamento illegittimo intimano nell’area della tutela obbligatoria (art.
30, terzo comma, della legge n. 183 del 2010). Potendosi da ciò desumere
che ai sensi della disposizione da ultimo citata l’accordo certificato assumere una valenza in qualche modo anche derogatoria della legge.
5. – Conclusivamente, l’impressione generale che se ne ricava è quella
di un nuovo tentativo, in verità troppo timido e forse eccessivamente confuso, di indirizzare il sistema verso un modello di soft law caratterizzato da
un meccanismo di volontà derogatoria assistita a tutela del contraente debole. Ma che questo fosse fin dall’inizio l’obiettivo dell’istituto della certificazione lo si poteva intuire anche dall’art. 78, quarto comma, del d.lgs. n.
276 del 2003 nella parte in cui il legislatore, già all’epoca, affidava al Ministero del lavoro il compito di emanare con decreto codici di buone pratiche
per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione
dei rapporti di lavoro.
Quella disposizione del 2003 non ha avuto alcun concreto sviluppo, ed
anzi scontò una forte diffidenza. Resterà da vedere come troverà applicazione quest’ultima riforma ma la sensazione è che siamo ancora lontani da
un modello di derogabilità assistita delle tutele.
ADL 1/2011
Elena Boghetich
Giudice del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro
TUTELE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE
E NUOVI TERMINI DI DECADENZA
Sommario: 1. L’esigenza di garantire la certezza del diritto – 2. Diversità di mezzi e diversità di
procedure per l’impugnazione – 3. L’estensione del campo di applicazione oggettiva della
nuova disciplina – 4. L’estensione della disciplina ad ipotesi diverse dai licenziamenti – 5.
Criteri applicabili alla fase transitoria.
1. – L’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (1) introduce nell’ordinamento un articolato regime di impugnazione di tutti quegli atti che, se ritenuti illegittimi, possono condurre il giudice ad accertare la sussistenza o
il ripristino di un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo o parasubordinato) a tempo indeterminato, con conseguente condanna al pagamento dei compensi arretrati.
Nonostante la rubrica della disposizione sia dedicata esclusivamente ai
contratti a tempo determinato (“Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato”), l’articolo introduce un doppio termine
di decadenza per l’impugnazione di licenziamenti intimati in rapporti di lavoro subordinato (anche se simulati), per i recessi intervenuti nel corso o
alla scadenza di rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato, per i trasferimenti dei dipendenti, per le cessioni di aziende, oltre che per i recessi
nell’ambito dei contratti a tempo determinato.
La ratio sottesa all’intervento legislativo è quella di sollecitare certezza
e lealtà dei rapporti giuridici fra le parti, soprattutto in quei casi in cui il decorso del tempo poteva incidere profondamente sulle conseguenze economiche sopportate dalle imprese ed un intervento giudiziale poteva scon-
(1) La legge è pubblicata sul supplemento ordinario n. 243/L alla Gazzetta Ufficiale del
9 novembre 2010, n. 262, ed è entrata in vigore il 24 novembre 2010. Tra i primi commenti si
segnalano: M. Tatarelli, Licenziamenti: inserito un termine di decadenza per avviare l’azione giudiziaria dopo l’impugnazione, in Gli speciali di Guida al diritto, 4 dicembre 2010. Sul disegno di
legge Senato n. 14441-quater, approvato il 3 marzo 2010 e rinviato al Parlamento, ex art. 74
Cost. , dal Presidente della Repubblica il 31 marzo 2010, cfr. A. Vallebona, Una buona svolta del
diritto del lavoro: la legge n. 183 del 2010, in Bollettino ADAPT, 7 aprile 2010, n. 12; G. Pellacani,
Il cosiddetto « collegato lavoro » e la disciplina dei licenziamenti: un quadro in chiaroscuro, in Riv. It.
Dir. Lav. , 2010, I, pag. 215 e segg. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociale ha adottato
una circolare di illustrazione, alle Direzioni provinciali del lavoro, delle nuove modalità da
adottare per i tentativi, ormai facoltativi, di conciliazione (circolare 25 novembre 2010, n.
3428).
ADL 1/2011
ELENA BOGHETICH
69
volgere un assetto organizzativo ormai stabilizzato. Invero, soprattutto in
materia di licenziamenti e di contratti a termine, il ricorso all’autorità giudiziaria a distanza notevole di tempo rispetto all’atto espulsivo impugnato
comportava, in caso di accoglimento della domanda, considerevoli risarcimenti parametrati a tutte le retribuzioni perse, salvo limitazioni degli importi per effetto dei compensi percepiti altrove dal lavoratore (2) ovvero
poteva, più radicalmente, determinare il rigetto della domanda per valutazione del disinteresse alla ricostituzione del rapporto di lavoro collegata al
trascorrere del tempo ed alla presenza di ulteriori significativi indici (3).
(2) La prova dei compensi percepiti, presso altri datori di lavoro, dal lavoratore dopo la risoluzione del rapporto così come le occasioni lavorative che potevano essere reperite con l’ordinaria diligenza (c.d. aliunde perceptum e aliunde percipiendum) spetta al datore di lavoro (secondo Cass. n. 14849 del 2004 è sufficiente provare lo svolgimento di altra attività lavorativa,
stante la presunzione di onerosità del lavoro che consente la determinazione in via equitativa
degli importi; contra, Cass. n. 6668 del 2004 che richiede la prova anche delle somme percepite); la relativa allegazione può essere ammessa anche dopo il deposito della memoria difensiva purché avvenga, comunque, nel primo atto difensivo utile dalla conoscenza dei fatti, dovendo il datore di lavoro fornire la prova del momento di acquisizione della notizia (cfr. Cass.
n. 20500 del 2008, n. 17606 del 2007, n. 14131 del 2006). Peraltro, nel caso in cui la rioccupazione del lavoratore illegittimamente licenziato costituisca allegazione in fatto ritualmente e
tempestivamente acquisita al processo (anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore
di lavoro), il giudice ne deve tener conto – anche d’ufficio – ai fini della quantificazione del
danno provocato dal licenziamento illegittimo (cfr. Cass. n. 10155 del 2005).
(3) In ordine alla risoluzione per mutuo consenso, si è formato un rigoroso orientamento
della giurisprudenza di legittimità che richiede il concorso di vari elementi (apprezzabile lasso di tempo trascorso dopo la conclusione del contratto, comportamento tenuto dalla parti,
eventuali circostanze significative) al fine di desumere una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. In particolare, è
configurabile la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro – ex art. 1372, primo
comma, Cod. Civ. – a fronte di una totale mancanza di operatività, per un lasso di tempo apprezzabile, del rapporto di lavoro, anche in presenza di comportamenti significativi tenuti dalle parti (quali, ad es. , il ritiro del libretto di lavoro, l’iscrizione presso il Centro per l’impiego,
l’assenza di solleciti o messa in mora dell’ex datore di lavoro ai fini della ripresa della prestazione lavorativa) oltre che a fronte di esplicite dichiarazioni. È suscettibile di una qualificazione in tal senso (nel quadro anche della attuale tendenza alla “oggettivizzazione” del contratto, con attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati
in modo tipico) il comportamento delle parti che, in relazione alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, determinino la cessazione della funzionalità di fatto del
rapporto per una durata e con modalità tali da evidenziare il loro completo disinteresse alla
sua attuazione (cfr. Cass. nn. 26935 del 2008, 20390 del 2007, 15264 del 2007, 8903 del 2007,
23554 del 2004, 13891 del 2004). La valutazione del significato e della portata del complesso
di tali elementi di fatto, che compete al giudice di merito, subisce – in concreto – apprezzabili mutamenti a seconda della sensibilità più spiccata verso le esigenze delle imprese ovvero
verso la tutela dei diritti dei lavoratori. Va osservato che, recentemente, la Suprema Corte di
Cassazione ha ritenuto che, a fronte del contenuto lasso di tempo trascorso dalla risoluzione
del rapporto di lavoro (un anno circa, tempo considerato congruo per decidere di intraprendere la via giudiziaria ed impostare la difesa) nonché dell’affidamento riposto dal lavoratore
nel reperimento di occasioni di lavoro a termine (anche con il datore di lavoro precedente), la
ADL 1/2011
70
PARTE PRIMA . SAGGI
La disposizione introduce un doppio termine di decadenza per l’impugnazione di licenziamenti intimati in rapporti di lavoro subordinati (anche
se simulati), per i recessi intervenuti nel corso o alla scadenza di rapporti di
lavoro autonomo o parasubordinati, per i trasferimenti dei dipendenti, per
le cessioni di aziende, oltre che per i recessi nell’ambito dei contratti a tempo determinato.
Come è noto, infatti, chi voleva contestare il licenziamento ricevuto doveva impugnarlo “a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione”, con qualsiasi atto scritto (art. 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604). Generalmente, il lavoratore si limitava ad inviare al datore di lavoro
una breve lettera, talvolta anche sottoscritta da un rappresentante sindacale, con cui contestava il licenziamento. Esaurito questo adempimento (4) ,
l’interessato poteva restare quiescente, ossia completamente inerte dal
punto di vista giudiziale, per quasi cinque anni e decidere, cioè, di promuovere una controversia poco prima che scadesse il termine quinquennale di prescrizione.
Insomma, una volta osservato il termine previsto dall’art. 6 della legge
n. 604 del 1966 mediante l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento,
la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo poteva essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui
all’art. 1442 Cod. Civ. , decorrente dalla comunicazione del recesso.
Secondo la giurisprudenza consolidata, tale termine non era suscettibile
di interruzione ad opera del compimento di una diversa attività, quale, ad
esempio, l’istanza per il tentativo di conciliazione stragiudiziale (5) oppure la
costituzione, sempre nel corso del suddetto termine prescrizionale, del datore di lavoro nel processo penale instaurato nei confronti del lavoratore (6).
mera inerzia del lavoratore non poteva essere interpretata come fatto estintivo del rapporto
(Cass. n. 2279 del 2010).
(4) Secondo giurisprudenza consolidata, la mancata impugnazione del licenziamento nel
termine di 60 giorni non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro, bensì preclude al
lavoratore soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento ai sensi
degli artt. 8 della legge n. 604 del 1966 o 18 della legge n. 300 del 1970. Ne consegue che, nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, qualora si sia verificata la decadenza dall’impugnazione,
il lavoratore è legittimato ad esperire l’ordinaria azione risarcitoria in base ai principi generali
che la disciplinano, sempre che ne ricorrano – e siano dal lavoratore allegati – i relativi presupposti, diversi da quelli previsti dalla normativa sui licenziamenti e tali da configurare l’atto
di recesso come idoneo a determinare un danno risarcibile (cfr. Cass. nn. 5545 del 2007, 245
del 2007, 21833 del 2006, 18216 del 2006).
(5) Cfr. Cass. n. 28514 del 2008, in quanto il datore di lavoro-debitore deve avere conoscenza legale, non meramente effettiva, dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore e tale conoscenza non si produce in ipotesi di domanda proposta esclusivamente avanti alla Direzione provinciale del lavoro.
(6) Cfr. Cass. n. 27428 del 2005, in quanto l’azione risarcitoria fatta valere in sede penale
ADL 1/2011
ELENA BOGHETICH
71
Il termine decadenziale dell’art. 6 della legge n. 604 non era applicabile in
caso di licenziamenti inefficaci per vizi di forma (i licenziamenti intimati oralmente) o per omessa tempestiva comunicazione dei motivi richiesti (7), non
potendosi onerare il lavoratore di adempimenti formali se il datore di lavoro
non aveva preventivamente assolto i propri; il termine decadenziale non era,
inoltre, applicabile al licenziamento nullo intimato nel periodo di interdizione per matrimonio o maternità (8), per motivo illecito o in frode alla legge (9).
In questi casi, pertanto, non vi era nessun limite temporale e l’azione
giudiziale poteva essere iniziata a distanza di notevole tempo dall’evento
espulsivo. In tali casi, inoltre, non era nemmeno applicabile il termine prescrizionale quinquennale stante il principio di imprescrittibilità dell’azione
di nullità (art. 1422 Cod. Civ.), nonostante la giurisprudenza, con una isolata pronuncia, avesse ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione (cfr. Cass. n. 296 del 1990).
Il possibile decorso di un termine apprezzabilmente ampio tra l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (effettuata entro 60 giorni dalla
comunicazione del recesso o dalla comunicazione dei suoi motivi, se non
contestuali) e l’azione giudiziaria era, indubbiamente, contrario ai principi
di certezza del diritto, lasciando, da una parte, il datore di lavoro nella assoluta incertezza sulla stabilità del provvedimento adottato (che era suscettibile di essere travolto a distanza di tempo, compromettendo l’assetto
organizzativo che nel frattempo l’azienda aveva assunto) e consentendo,
dall’altra, condotte speculative di quei lavoratori che volutamente ritardavano l’introduzione del giudizio al fine di lucrare la maggiore entità di risarcimento del danno conseguente all’accertata illegittimità del recesso.
Avverso tale assetto normativo, l’unica difesa era rappresentata dalla proposizione, da parte del datore di lavoro, di un giudizio volto all’accertamento della legittimità del licenziamento ovvero dalla deduzione (sotto
forma di aliunde perceptum) del conseguimento, da parte del lavoratore licenziato, di altri introiti al fine di limitare l’entità del danno (ex art. 1227
Cod. Civ.) ovvero dal rilievo dell’acquiescenza del lavoratore al licenziamento o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. – L’art. 32 sostituisce i primi due commi dell’art. 6 della legge n. 604
con l’intento di introdurre un (secondo) termine, inferiore a quello quin-
non equivale alla predetta azione di annullamento, differenziandosene sia con riguardo al “petitum ” che alla “causa petendi ”.
(7) Cfr. Cass. Sez. Un. n. 5394 del 1982, Cass. nn. 3022 del 2003, 5519 del 1999.
(8) Cfr. Cass. n. 4809 del 1997.
(9) Cfr. Cass. n. 5574 del 1980.
ADL 1/2011
72
PARTE PRIMA . SAGGI
quennale di prescrizione, di decadenza per la proposizione del giudizio avverso i licenziamenti invalidi e determinare a priori i tempi fissati per valutare, in via definitiva (avanti al giudice, alla commissione di conciliazione,
all’arbitro), la legittimità del licenziamento.
Come nel regime precedente, il licenziamento (e, attualmente, gli altri
atti elencati dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010) deve essere impugnato,
anche stragiudizialmente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della
comunicazione del recesso o dei motivi se non contestuali, e il lavoratore
deve, pertanto, rendere nota al datore di lavoro, senza formule sacramentali e senza necessità di specificare i motivi della contestazione, la volontà di
impugnare il provvedimento espulsivo.
L’impugnazione si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di
volontà del lavoratore licenziato giunge a conoscenza del datore di lavoro,
posto che l’impugnazione è – al pari del licenziamento – un negozio giuridico unilaterale recettizio (10). Va, peraltro, considerato che recentemente
la giurisprudenza di legittimità ha mutato orientamento, ritenendo di applicare in materia i principi affermati, dalla stessa Corte di Cassazione e dal
giudice delle leggi, in ambito di notifiche degli atti processuali e, quindi, di
ritenere sufficiente – per evitare la decadenza – l’invio entro il termine di
60 giorni dell’impugnazione. Sul punto, il legislatore – non specificando alcunché – ha senz’altro perso una occasione per stabilire certezza nei rapporti giuridici.
Il lavoratore può anche scegliere di adire immediatamente l’autorità
giudiziaria o di proporre al datore di lavoro la via della conciliazione o dell’arbitrato.
In tali casi (che sicuramente complicano gli adempimenti da svolgere),
la congiunta lettera di impugnazione e di proposizione del ricorso giudiziale o del tentativo di conciliazione o dell’arbitrato dovrà rivestire i requi-
(10) Cfr. Cass. nn. 15678 del 2006, 11116 del 2006, 7625 del 2004; peraltro Cass. Sez. Un.
n. 8830 del 2010 e Cass. n. 22287 del 2008 hanno precisato che l’impugnazione deve ritenersi tempestiva se la spedizione, tramite ufficio postale, avvenga entro il termine di 60 giorni, ancorchè consegnata successivamente. Le Sezioni Unite hanno desunto tale soluzione sulla base dei principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e
affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale,
per cui l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione
demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, al
lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare
la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti
ADL 1/2011
ELENA BOGHETICH
73
siti richiesti, rispettivamente, dall’art. 414 Cod. Proc. Civ. o dal novellato art.
410 Cod. Proc. Civ. o dall’art. 412 quater Cod. Proc. Civ.
Se la scelta cade sulle vie legali, dovrà essere confezionato da un procuratore un atto giudiziario, depositato in Tribunale e, quantomeno, affidato all’ufficiale giudiziario entro il termine di 60 giorni.
In caso di conciliazione, il lavoratore dovrà spedire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (e non semplicemente con qualsiasi mezzo, come ad es. il fax, il telegramma come è consentito dall’art. 6 della legge n. 604) una richiesta ben dettagliata. In caso di arbitrato, il lavoratore
dovrà notificare un ricorso ove sia già indicato il nome dell’arbitro e l’oggetto della domanda. Ciò sempre nel rispetto del termine di 60 giorni. Se la
conciliazione o l’arbitrato producono effetti favorevoli, nulla quaestio; se,
invece, la controparte non accetta la via alternativa di composizione della
lite scelta dal lavoratore, questi dovrà depositare entro 60 giorni il ricorso
giudiziale.
Ove il lavoratore si limiti ad impugnare stragiudizialmente il licenziamento, la novella legislativa prevede che l’impugnazione è inefficace se, nel
successivo termine di 270 giorni, non viene seguita da una delle tre modalità previste dalla legge per far accertare la validità o la giustificatezza del
provvedimento ossia: il deposito del ricorso in cancelleria ovvero la richiesta del tentativo di conciliazione (ora facoltativo) o dell’arbitrato.
Va notato che, con riguardo al ricorso giudiziale (che potrà essere proposto sia in via ordinaria che in via d’urgenza), il legislatore fa riferimento
al “deposito” in Tribunale (e non alla notifica del ricorso alla controparte)
mentre per il tentativo di conciliazione (in sede amministrativa o sindacale) o per l’arbitrato è necessaria la “comunicazione” della scelta di tale via al
datore di lavoro.
Il tenore lessicale della norma, che collega strettamente il secondo termine di decadenza con l’impugnazione, porta a ritenere che il dies a quo del
termine di 270 giorni sia da individuare nella data di effettiva impugnazione del licenziamento e non nel 61° giorno dal licenziamento stesso (11). Anche in tal caso si pone il problema se l’impugnazione sia utile al momento
della mera spedizione della lettera da parte del lavoratore ovvero dalla ricezione da parte del datore di lavoro (12).
Il legislatore fissa, poi, un ulteriore termine di decadenza (di 60 giorni)
in caso di rifiuto o mancato raggiungimento dell’accordo in relazione all’espletamento del tentativo di conciliazione o dell’arbitrato. Anche in tal caso va attentamente individuato il dies a quo della decadenza.
(11) Prediligono questa soluzione sia M. Tatarelli che G. Pellacani.
(12) Vedi la giurisprudenza citata alla nota 10.
ADL 1/2011
74
PARTE PRIMA . SAGGI
Nel caso in cui il lavoratore (dopo aver impugnato stragiudizialmente il
licenziamento entro i 60 giorni) abbia scelto la via del tentativo (facoltativo) di conciliazione ed inviato, quindi, al datore di lavoro (entro 270 giorni) una richiesta con raccomandata (con ricevuta di ritorno), potrà ricevere un diniego espresso, ma potrà anche rimanere nell’assoluta ignoranza
delle determinazioni assunte dalla controparte. Infatti, il novellato art. 410
Cod. Proc. Civ. non pone alcun onere di comunicazione formale all’interessato del rifiuto, della controparte, di accettare la soluzione transattiva. Considerato, pertanto, l’onere di controparte di depositare, entro 20 giorni dal
ricevimento della richiesta del tentativo, una memoria presso la Commissione di conciliazione (art. 410, settimo comma, Cod. Proc. Civ.), il lavoratore dovrà attivarsi spontaneamente (e tempestivamente) per acquisire la
notizia circa l’adempimento di tale deposito; se, infatti, non sarà stata depositata alcuna memoria, il termine di 60 giorni decorrerà dalla scadenza
dei 20 giorni. L’operatività di una decadenza in mancanza di avviso, all’interessato, del rifiuto della conciliazione suscita dubbi di legittimità costituzionale. Questo (terzo) termine di decadenza non sembrerebbe applicabile, stando alla terminologia utilizzata dal legislatore, al caso in cui il tentativo di conciliazione si concluda senza alcun accordo ma solamente all’ipotesi in cui la controparte non accetti questo mezzo alternativo di composizione della lite. Il novellato art. 6 della legge n. 604 del 1966 fa, infatti, riferimento al “rifiuto” della conciliazione richiesta e all’ “accordo necessario al
relativo espletamento”. Èstata, peraltro, proposta una lettura razionale della
norma che includa, pertanto, sia l’ipotesi del rifiuto dello strumento alternativo che quella del mancato accordo a seguito dell’espletamento della
procedura (13). In quest’ultimo caso, il termine di 60 giorni comincerebbe
a decorrere dalla data di chiusura del procedimento in sede conciliativa.
Se il lavoratore sceglie di devolvere la controversia alla decisione di un
arbitro (presso la Direzione provinciale del lavoro, presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva o presso un collegio ad hoc costituito
su istanza delle parti, rispettivamente ai sensi degli artt. 412, 412-ter e 412
quater Cod. Proc. Civ.), la controparte potrà rifiutare l’arbitrato o non accordarsi sulle modalità di espletamento. Va anche in questo caso notato
che, con riguardo alla costituzione del collegio da parte degli interessati, l’istante conoscerà il rifiuto della controparte entro 30 giorni dalla richiesta
dell’arbitrato, essendo tale termine previsto per la nomina congiunta del
Presidente del collegio (art. 412 quater, quarto comma, Cod. Proc. Civ.).
In tal modo il legislatore ha rigorosamente scandito tutto il procedi(13) Cfr. in tal senso A. Vallebona, Una buona svolta ecc. , op. cit. e G. Pellacani, Il cosiddetto collegato lavoro, op. cit. , pag. 254.
ADL 1/2011
ELENA BOGHETICH
75
mento per addivenire ad una valutazione definitiva, giudiziale o stragiudiziale, del licenziamento.
Va rammentato che, secondo consolidata giurisprudenza, la decadenza
prevista dall’art. 6 della legge n. 604 – che impone al lavoratore l’onere dell’impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni – non
può essere rilevata d’ufficio dal giudice, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un’eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro,
deve essere proposta, dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione (14). Deve ritenersi che tale principio sia applicabile anche ai nuovi termini trattandosi, tutti, di termini di decadenza. Quindi, in caso di mancato
rispetto dei termini fissati per l’impugnazione del licenziamento resta affidata esclusivamente al datore di lavoro la scelta della operatività della decadenza.
3. – Ulteriore rilevante novità apportata dall’art. 32 concerne il campo
di applicazione della procedura di impugnazione che viene espressamente
applicata a tutti i casi di invalidità (ossia di nullità e di annullabilità) del licenziamento.
Il secondo comma dell’art. 32 della legge n. 183 prevede che “Le disposizioni di cui all’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”. Va notata, anzitutto, la collocazione della disposizione: il richiamo dell’art. 6, ossia dell’onere di impugnazione, è posto al di fuori della legge n. 604. L’intento del legislatore, pertanto, è quello di estendere l’applicazione del doppio onere di impugnazione (60 giorni e 270 giorni) oltre
i casi disciplinati dalla legge n. 604 del 1966 (e, quindi, in linea di massima,
anche alle ipotesi escluse dal suo campo di applicazione, in forza degli artt.
10 e 11 della medesima legge) (15).
Pertanto, come nel regime precedente (quando l’onere di impugnazione era previsto solamente all’interno della legge n. 604), vanno impugnati,
a pena di decadenza, i licenziamenti ingiustificati e quelli nulli per violazione del procedimento previsto dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, sia
nel settore privato che in quello pubblico privatizzato; ma, in applicazione
della novella legislativa, e proprio per effetto della collocazione esterna al-
(14) Cfr. Cass. n. 1035 del 1991.
(15) Diversamente, G. Pellacani ritiene che la previsione dell’art. 32, secondo comma, attenga al profilo oggettivo dell’atto, non a quello dei suoi destinatari, che rimangono, pertanto,
individuabili con riguardo al campo di applicazione della legge n. 604 del 1966 (Il cosiddetto
“Collegato lavoro”, pag. 260). Peraltro, questa ricostruzione non appare supportata da sufficienti argomentazioni né di natura letterale né di carattere sistematico.
ADL 1/2011
PARTE PRIMA . SAGGI
76
la legge n. 604 e del richiamo a tutte le fattispecie di licenziamenti invalidi,
vanno ora, impugnati, a pena di decadenza (e a differenza del regime precedente), anche i licenziamenti nulli per causa di matrimonio o di maternità, per motivo illecito o in frode alla legge, i licenziamenti per superamento
del periodo di comporto e in genere tutti i licenziamenti anche posti al di
fuori della disciplina contenuta nella legge n. 604 e per i quali il lavoratore
invochi un profilo di illegittimità (quindi o di nullità o di annullabilità).
Ad esempio, il recesso per superamento del periodo di comporto era ritenuto, nel regime precedente, escluso dal termine di decadenza dell’art. 6
della legge n. 604 del 1966, rappresentando una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, che non avrebbe trovato la sua disciplina nella legge, di carattere generale, n. 604 del 1966, bensì nella specifica previsione di cui all’art. 2110, secondo comma, Cod. Civ. (16). La previsione
espressa, da parte dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, dell’applicabilità
dell’onere di impugnazione a tutti i licenziamenti invalidi e la collocazione
di tale previsione al di fuori della legge n. 604 rendono esplicito l’intento
del legislatore di attribuire valenza generale a detto onere e, pertanto, di includere anche tale recesso.
Per la medesima ragione, debbono ritenersi inclusi nella previsione di
impugnazione procedimentalizzata i licenziamenti che si reputano nulli
per causa di matrimonio e per violazione delle norme a tutela della maternità.
Sembra, invece, debba continuare ad essere considerato escluso dal
campo di applicazione dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 il licenziamento del dirigente, che non è soggetto alla regola legale di giustificazione necessaria e per il quale solamente le fonti collettive (nell’ambito della loro efficacia soggettiva) pongono un obbligo di giustificatezza (non di legittimità) del licenziamento, la cui violazione comporta esclusivamente il pagamento (non di un risarcimento del danno bensì) di una indennità c.d. supplementare.
In ordine al lavoratore in prova, come è noto l’art. 10 della legge n. 604
del 1966 sottrae dal campo di applicazione di tale disciplina i lavoratori assunti in prova sino ad un periodo massimo di 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro. L’onere di impugnazione del licenziamento (al lavoratore in
prova) potrebbe, peraltro, derivare dalla previsione, esterna alla legge n.
604 (e, come innanzi evidenziato, contenuta nel secondo comma dell’art.
32 della legge n. 183 del 2010), per tutti i casi in cui il lavoratore abbia intenzione di sollevare profili di illegittimità del recesso. Pertanto, se il lavo-
(16) Cfr. da ultimo Cass. n. 1861 del 2010.
ADL 1/2011
ELENA BOGHETICH
77
ratore deduca che il recesso è stato determinato da motivo illecito estraneo
all’espletamento della prova o da ragioni discriminatorie (17) e che, quindi,
è estraneo alla funzione del patto di prova, dovrà impugnare tempestivamente l’atto. Così, nel caso in cui il lavoratore rilevi la mancata pattuizione
per iscritto (anteriore o contemporanea all’inizio della prestazione lavorativa) del patto di prova ed intenda impugnare il licenziamento intervenuto
in tale periodo, ricorrerà una ipotesi di nullità assoluta dell’assunzione in
prova, la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva e la valutazione del successivo licenziamento (18); per consentire al giudice di valutare quest’ultimo profilo (anche solo per constatare che il licenziamento, intimato per cessazione del periodo di prova e generalmente
sprovvisto di motivazione, era soggetto alla disciplina della legge n. 604 del
1966 e, quindi, doveva essere sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo), il lavoratore dovrà impugnare tempestivamente il licenziamento se non vorrà precludersi, in sede giudiziale, le domande collegate ai
profili di illegittimità del licenziamento subito.
Debbono ritenersi, altresì, inclusi i licenziamenti collettivi, vista la valenza generale attribuita dal legislatore del 2010 all’onere di tempestiva impugnazione. In tal caso, deve ritenersi che la novella abbia una efficacia tacitamente abrogativa della disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991, imponendo ora un sistema procedimentalizzato più articolato e complesso rispetto all’onere di impugnazione (calibrato sulla falsariga del vecchio art. 6 della legge n. 604 del 1966) previsto
dalla legge n. 223.
Infine, debbono ritenersi sottratti all’onere di impugnazione le (resi(17) Tali profili configurano un’ipotesi di nullità del licenziamento in quanto il lavoratore
intende dimostrare che il recesso non è stato determinato da ragioni specifiche inerenti all’esito dell’esperimento in prova (che costituisce la causa del patto) ma che è dovuto a ragioni illecite, o comunque estranee al rapporto, ed in particolare a forme di discriminazione: cfr. Cass.
nn. 21784 del 2009, 23061 del 2007, 22637 del 2004, 7644 del 1998. Si segnala, peraltro, Cass.
n. 402 del 1998 la quale ha ritenuto che l’esistenza di un motivo (di licenziamento del lavoratore in prova) estraneo all’esperimento non integra, di per sé, un motivo illecito ex art. 1345
Cod. Civ. , né è a quest’ultimo equiparabile quanto all’idoneità ad inficiare il recesso come affetto da vizio di nullità. Consegue che, ove il lavoratore dimostri che il recesso è avvenuto per
un motivo che non è qualificabile come motivo illecito, ma che è estraneo all’esperimento lavorativo (quale nella specie la sopravvenienza di un’esigenza aziendale di ridimensionamento di
un reparto e di conseguente soppressione di un posto di lavoro), il giudice non può ritenerne
per ciò solo l’illegittimità, ma deve valutarne la giustificatezza – in termini non dissimili dal giustificato motivo oggettivo di licenziamento in regime di recesso causale – al fine di accertare l’idoneità, o meno, del recesso a per termine alla prova ed a risolvere il rapporto.
(18) Sulla nullità del patto di prova per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 2096 Cod. Civ. , cfr. Cass. n. 5591 del 2001; sulla contestualità o anteriorità del
patto rispetto all’inizio della prestazione lavorativa, cfr. Cass. n. 11597 del 1999.
ADL 1/2011
78
PARTE PRIMA . SAGGI
due) ipotesi di licenziamenti ad nutum non sottoposte alla regola legale di
giustificazione necessaria.
I licenziamenti inefficaci per vizio di forma o per omessa tempestiva comunicazione dei motivi richiesti dal lavoratore sono sottratti all’onere di
impugnazione. L’esclusione dei licenziamenti orali di cui all’art. 2, terzo
comma, della legge n. 604 del 1966 appare coerente con la consolidata ricostruzione giurisprudenziale di tale atto come recesso giuridicamente
inesistente, e come tale sottratto dall’onere di impugnazione e non incidente sulla continuità del rapporto di lavoro (19). Questo licenziamento,
pertanto, rimane soggetto solamente al termine prescrizionale (20).
4. – Il termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento viene, anche, previsto per le ipotesi in cui si debba accertare, preventivamente, il fatto costitutivo della domanda di riassunzione o reintegrazione nel
posto di lavoro (e di risarcimento del danno) e, in generale, la sussistenza
di un contratto di lavoro subordinato prodromico all’instaurazione di un
rapporto a tempo indeterminato.
Quindi, in tutti i casi in cui non sia stato stipulato un contratto di lavoro
e si sia, comunque, svolto, tra le parti, un rapporto secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato, il lavoratore che ritiene di essere stato ingiustamente estromesso dal posto dovrà impugnare tempestivamente il licenziamento se vuole impedire la decadenza e conservare la possibilità di agire, giudizialmente o stragiudizialmente, contro il datore di lavoro.
Come nell’ipotesi del licenziamento, anche in tali casi (ad eccezione
del trasferimento del lavoratore) la ratio perseguita dal legislatore è quella
della certezza dei rapporti giuridici, trattandosi di casi nei quali il lavoratore chiede la ricostituzione ex tunc del rapporto.
Il campo di applicazione del termine decadenziale viene ampliato sino
a ricomprendere l’area dei contratti a tempo determinato, dei rapporti c.d.
parasubordinati (art. 409 Cod. Proc. Civ.: contratti a progetto, contratti di
agenzia, collaborazioni coordinate e continuative), dei trasferimenti dei dipendenti (art. 2103 Cod. Civ.), del passaggio a nuovo datore di lavoro per
effetto di cessione di azienda (art. 2112 Cod. Civ.), della richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro con datore interponente.
In particolare, con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato di fatto, la
lettera a) del terzo comma dell’art. 32 prevede che le disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966 trovino applicazione « ai licenziamenti che
(19) Cfr. Cass. Sez. Un. nn. 5394 del 1982, 1236 del 1984, 2180 del 2007 confermate successivamente da Cass. nn. 3022 del 2003, 5519 del 1999, 2880 del 1990.
(20) Cfr. Cass. nn. 3022 del 2003, 6879 del 2001, 3345 del 2000, 5519 del 1999.
ADL 1/2011
ELENA BOGHETICH
79
presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto ». La norma fa
riferimento a tutte quelle ipotesi in cui tra le parti si instauri di fatto un rapporto di lavoro subordinato senza che sussista alcuna formalizzazione, ovvero venga stipulato un contratto di lavoro formalmente autonomo ma di
fatto subordinato e tale rapporto cessi o con il licenziamento ovvero con
l’eventuale scadenza del termine fissato dalle parti. La previsione concerne
tutte le ipotesi, invero non infrequenti, in cui di fatto tra le parti si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato senza alcuna formalizzazione
del rapporto medesimo (c.d. rapporto di lavoro in nero), ovvero il rapporto di lavoro formalmente venga ricondotto ad una fattispecie autonoma,
per esempio una collaborazione coordinata e continuativa nella forma del
contratto a progetto ovvero una associazione in partecipazione ovvero un
rapporto di agenzia, ma di fatto la prestazione venga resa con le modalità tipiche della subordinazione.
In tutti i casi, pertanto, in cui si controverta sulla qualificazione del rapporto di lavoro (affermando il lavoratore che tra le parti sia intercorso di
fatto un rapporto di lavoro subordinato in luogo di altra fattispecie negoziale comunque qualificata), il prestatore ha l’onere di impugnare la cessazione del rapporto sia che tale evento debba imputarsi a recesso del datore
di lavoro (comunque venga qualificato, purché con atto scritto) ovvero alla scadenza del termine che le parti avevano apposto al rapporto (si pensi
alle ipotesi di rapporto a progetto ovvero ad una associazione in partecipazione aventi una durata prefissata).
Ovviamente la decadenza riguarda esclusivamente la domanda con la
quale, sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato,
il lavoratore chieda la ricostituzione del rapporto di lavoro, non già le ulteriori questioni che possono sorgere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (per esempio differenze retributive, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, ecc.).
Il richiamo dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 come modificato dallo stesso art. 32 rende esplicito che anche nell’ipotesi in esame la decadenza opera solo in presenza o di un recesso scritto o della apposizione per
iscritto di un termine al contratto. Pertanto, rimangono fuori dalla decadenza tutte le ipotesi in cui un rapporto di lavoro, comunque qualificato,
cessi sulla base di una mera dichiarazione orale del datore di lavoro. Inoltre, deve ritenersi che, seppure il terzo comma dell’art. 32 non riproduca né
richiami espressamente la previsione del secondo comma (in base al quale
la decadenza opera in tutti i casi di invalidità del licenziamento), l’onere di
impugnazione abbia valenza generale e si estenda, perciò, ai casi di annullabilità e nullità dei licenziamenti.
ADL 1/2011
80
PARTE PRIMA . SAGGI
In ordine ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la lettera b) del terzo comma dell’art. 32 riguarda il recesso del committente nei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di cui all’art. 409, numero 3, Cod. Proc. Civ. La norma non fa riferimento alle ipotesi in cui si contesti la sussistenza di un valido rapporto di lavoro autonomo e il prestatore invochi, di fatto, l’instaurazione di un rapporto
di lavoro subordinato, in quanto tale eventualità deve ritenersi rientrare
nella ipotesi precedente; si fa, invece, esclusivo riferimento a tutte quelle
ipotesi di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative “genuine” in
cui oggetto del contendere sia esclusivamente la legittimità del recesso del
committente e non anche l’effettiva sussistenza di un rapporto autonomo:
così la norma trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il committente receda ante tempus da un contratto di lavoro autonomo avente le caratteristiche della c.d. “parasubordinazione”, cioè un contratto a progetto, un contratto di agenzia, una associazione in partecipazione, ecc. , purché ovviamente la controversia riguardi unicamente la legittimità del recesso e non
anche la qualificazione del rapporto medesimo.
L’espresso riferimento della norma al « recesso del committente » (e la
considerazione che si tratta di applicare una disciplina, quella decadenziale, che limita la sfera di esercizio dei diritti dell’interessato) impone di circoscrivere l’ipotesi ai soli casi in cui vi sia una comunicazione scritta unilaterale proveniente dal committente; ciò in sintonia con la disciplina vigente per i licenziamenti, considerato il richiamo dell’art. 6 della legge n. 604
del 1966 « come modificato dal comma 1 del presente articolo » (ove, appunto, si richiede la comunicazione scritta della cessazione del rapporto di
lavoro) e nonostante la libertà di forme concernente il recesso dai rapporti
di lavoro autonomo e parasubordinati.
Secondo questi tesi, di ispirazione sistematica, tutti i recessi espressi in
forma orale sarebbero sottratti (parallelamente ai licenziamenti orali) all’onere di tempestiva impugnazione. Peraltro, non appare peregrina nemmeno la tesi che, fondandosi sull’interpretazione letterale della disposizione
(che, da una parte, si riferisce al mero “recesso” nei rapporti di lavoro autonomo, senza riferimento ad obblighi di forma, e, per converso, richiede per
il “licenziamento”, ossia per i rapporti di lavoro subordinato, la forma scritta), ritiene applicabile il regime decadenziale per tutti i recessi, sia espressi
in forma orale che comunicati in forma scritta (21).
La formulazione della norma ne impedisce, comunque, l’estensione a
(21) In tal senso sembrerebbe G. Mimmo, Per i ricorsi contro i contratti a termine la scadenza
viaggia su doppio binario, in Supplemento al Sole24ore, Novembre 2010, 34.
ADL 1/2011
ELENA BOGHETICH
81
tutte le ipotesi in cui sia il committente a contestare la legittimità del recesso del prestatore e invochi, ad esempio, il pagamento delle indennità conseguenti.
La circostanza che la lettera a) faccia riferimento alle controversie
aventi ad oggetto la qualificazione del rapporto di lavoro e che la lettera b)
faccia esclusivo riferimento al recesso del committente, induce a ritenere
che non rientri nel campo di applicazione della nuova disciplina l’ipotesi in
cui il lavoratore a progetto non contesti la legittimità sostanziale del contratto, e dunque la qualificazione del rapporto, ma si limiti a contestazioni
formali in ordine alla assenza di uno specifico progetto e che, per tale ragione, ne invochi la conversione in rapporto di lavoro subordinato ai sensi
dell’art. 69, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003, qualora il rapporto
non sia cessato per recesso del committente ma per la scadenza naturale
del contratto a progetto.
Il terzo comma lett. d) e il quarto comma, lett. a) e b) dell’art. 32 hanno
esteso anche alle azioni di nullità del termine apposto al contratto di lavoro
la disciplina di cui all’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, prevedendo
che il regime decadenziale si applichi anche ai contratti a termine in corso
di esecuzione e ai contratti a termine già conclusi (22).
La lettera c) del quarto comma dell’art. 32 (l’inserimento della disposizione, unitamente alla successiva lettera d), nel quarto comma, che disciplina il regime transitorio per i contratti termine, piuttosto che all’interno
del terzo comma, che appunto prevede la casistica delle ipotesi per le quali
viene esteso il regime di decadenza, può essere ritenuto una mera svista del
legislatore che però non incide sul contenuto della norma) estende la disciplina della decadenza anche alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai
sensi dell’art. 2112 Cod. Civ. con termine di decorrenza dalla data del trasferimento.
Nonostante l’ampia e non corretta formulazione della norma (l’art. 2112
Cod. Civ. disciplina il trasferimento di azienda, di cui la cessione del contratto di lavoro è un effetto) si deve escludere, stante la ratio sopra specificata, che la disposizione trovi applicazione in tutti i casi in cui venga in rilievo un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ. (per esempio, nelle ipotesi in cui il lavoratore, lungi dal contestare la legittimità del
trasferimento di azienda, si limiti ad invocare la responsabilità solidale dei
crediti di lavoro tra datore di lavoro cedente e datore di lavoro cessionario), potendo la decadenza essere limitata soltanto alle ipotesi in cui il lavoratore contesti proprio la legittimità del trasferimento di azienda ed invochi
(22) Vedi sul punto G. Mimmo, Decadenza e regime sanzionatorio: come il “collegato lavoro”
ha modificato la disciplina del contratto a termine, in questo fascicolo, pag. 87 e segg.
ADL 1/2011
82
PARTE PRIMA . SAGGI
la prosecuzione del rapporto con il datore di lavoro cedente. Peraltro, in
questo caso, per espressa indicazione della norma il termine di decadenza
decorre dalla data del trasferimento di azienda.
La lettera d) del quarto comma dell’art. 32 prevede una norma di chiusura e dispone che il regime della decadenza si applichi a tutte le ipotesi in
cui un lavoratore chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di
lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto: il riferimento
è chiaramente rivolto alla somministrazione irregolare, ipotesi espressamente richiamata a titolo esemplificativo dalla norma, ma può essere effettuato anche alle ipotesi di appalto non genuino disciplinate dall’art. 29 comma 3 bis del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ovvero alle ipotesi di passaggio
diretto del lavoratore da una azienda ad un’altra in occasione del mutamento dell’impresa che ha in appalto un servizio cui è addetto il lavoratore.
La disposizione in realtà pone non pochi problemi pratici in quanto
nella fattispecie in esame non vi è alcun provvedimento del datore di lavoro da impugnare e può risultare piuttosto complessa l’individuazione della
decorrenza del termine di sessanta giorni.
Nel caso della somministrazione irregolare o dell’appalto non genuino
in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore si può ipotizzare che l’atto da impugnare sia la cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dell’utilizzatore e che da tale data decorra il
termine per impugnare la stessa e per agire in giudizio nei confronti dell’utilizzatore per ottenere la costituzione del rapporto con lo stesso. Nelle ipotesi di mancato passaggio da una azienda ad un’altra in occasione del mutamento di un appalto di servizi l’atto da impugnare è la mancata assunzione, in violazione di espresse disposizioni contrattuali, presso la azienda
subentrante e il termine decorre dal momento in cui tale passaggio sarebbe dovuto diventare operativo.
Infine, la lettera c) del terzo comma estende il regime della decadenza
ad una ipotesi che non presuppone la cessazione e la ricostituzione del rapporto di lavoro, ma in relazione alla quale è pur sempre sentita l’esigenza di
celere contestazione del provvedimento del datore di lavoro, al fine di evitare che l’incertezza in ordine alla sede di lavoro si protragga nel tempo: il
lavoratore trasferito da una sede ad un’altra ai sensi dell’art. 2103 Cod. Civ. ,
qualora intenda contestare la legittimità del provvedimento datoriale, ha
l’onere di impugnarlo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
dello stesso (dunque, non dal momento in cui al provvedimento venga data esecuzione) e nel termine di duecentosettanta giorni di proporre azione
giudiziaria. Il mancato rispetto di tali termini, anche nell’ipotesi in cui il trasferimento non sia ancora divenuto esecutivo, comporta la decadenza del
lavoratore dal diritto di impugnare il trasferimento.
ADL 1/2011
ELENA BOGHETICH
83
Si pone la questione se debba essere impugnato esclusivamente il trasferimento scritto, in analogia con quanto previsto per il licenziamento, ovvero se anche il trasferimento comunicato verbalmente sia soggetto allo
stesso onere.
Secondo una interpretazione di carattere sistematico (simile a quella
svolta con riguardo al “recesso del committente”), dovrebbe ritenersi che
sia sottoposto all’onere di tempestiva impugnazione esclusivamente il trasferimento comunicato per iscritto, visto il rinvio all’art. 6 delle legge n. 604
del 1966 (da parte dell’art. 32, terzo comma) e l’applicazione necessariamente restrittiva di una disciplina che comprime i diritti dei lavoratori.
Conseguentemente, il dies a quo dei termini decadenziali sarebbe rappresentato dalla ricezione della comunicazione del trasferimento ovvero
dalla comunicazione dei motivi richiesti dal lavoratore e non comunicati
precedentemente (23). Secondo unadiversa ricostruzione esegetica si potrebbe, peraltro, ritenere che, considerato che la comunicazione del trasferimento è assoggettato al principio generale di libertà della forma (24), in
assenza di una esplicita disposizione che ne limiti l’onere di impugnazione
ai soli trasferimenti comunicati per iscritto, induce a ritenere che anche il
trasferimento comunicato verbalmente, dalla data della comunicazione,
debba essere impugnato a pena di decadenza.
Ad identica conclusione si deve pervenire qualora la forma scritta sia
imposta da una disposizione contrattuale, in quanto in tal caso la limitazione inciderebbe sulla legittimità del provvedimento di trasferimento, ma
non sul regime decadenziale.
5. – La novella legislativa non detta disposizioni di carattere transitorio
in materia di termini di decadenza se non con riguardo ai contratti a tempo
determinato (25). Delicato problema che si pone agli interpreti è, quindi,
quello relativo all’entrata in vigore della disciplina con riguardo ai licenzia(23) All’uopo si ricorda che, secondo Cass. nn. 9290 del 2004 e 8668 del 2004, l’onere
dell’indicazione delle ragioni del trasferimento sorge, a carico del datore di lavoro,soltanto
nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento; in caso di mancato adempimento consegue l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento. Peraltro, va segnalato che
Cass. n. 11984 del 2010 (che richiama, quale precedente conforme, Cass. n. 43 del 2007) sottolinea come il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non
deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l’obbligo di
rispondere al lavoratore che li richiede (salvo, ovviamente, l’onere del datore di lavoro di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento, potendo,
altresì, integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento).
(24) Cfr. Cass. nn. 11984 del 2010, 109 del 2004, 914 del 1996, 2095 del 1994.
(25) Vedi G. Mimmo, Decadenza e regime sanzionatorio ecc. , op. cit.
ADL 1/2011
84
PARTE PRIMA . SAGGI
menti (già intimati ed oggetto, o no, di una impugnazione da parte del lavoratore).
Va, innanzitutto, osservato che la norma che si commenta introduce, ex
novo, un articolato onere procedimentalizzato di impugnazione (60 giorni
+ 270 giorni + eventuali altri 60 giorni in caso si sia percorsa infruttuosamente la strada della conciliazione o dell’arbitrato) per determinati atti che
prima non erano oggetto di alcuna fase pregiudiziale: alcuni licenziamenti
sottratti all’applicazione del vecchio art. 6 della legge n. 604 del 1966, gli atti di recesso datoriale nell’ambito di rapporti autonomi o parasubordinati
di cui si contesti la natura, i trasferimenti del lavoratore, le cessioni di aziende e le interposizioni. Invece, per altri tipi di licenziamenti la novella aggiunge all’onere dell’impugnazione stragiudiziale (già applicato prima della novella) quello dell’impugnazione giudiziale (o della conciliazione o arbitrato, ossia 270 giorni + eventuali altri 60 giorni).
Ebbene, deve escludersi l’applicazione dell’art. 252 disp. att. Cod. Proc.
Civ. (che prevede, a favore dell’interessato, l’immediata entrata in vigore di
nuove disposizioni che introducono termini più brevi) in quanto la norma
disciplina casi diversi rispetto a quello in esame (ossia la previsione di un
termine per l’acquisizione di un diritto, mentre nel caso di specie il decorso del termine farebbe perdere il diritto del lavoratore all’esercizio dell’azione di riassunzione/reintegra e di risarcimento del danno).
Non è nemmeno possibile valutare l’applicazione analogica della novella (con riguardo alle previsioni dettate in materia di contratti a tempo
determinato), perché trattasi di norma eccezionale che introduce termini
di decadenza che, quantomeno per l’azione giudiziale, non erano previsti
nel regime precedente (art. 14 preleggi Cod. Civ.).
Deve ritenersi, allora, applicabile il principio generale secondo il quale
la legge non dispone che per l’avvenire, non avendo effetto retroattivo (art.
11 preleggi Cod. Civ.) (26).
(26) In ordine al divieto di irretroattività della norma (salvo che si tratti di norma “autenticamente” interpretativa, in materia è interessante leggere l’Ordinanza interlocutoria di Cass.
n. 5048 del 2007), cfr. Cass. nn. 15872 del 2010, 15871 del 2010, 11200 del 2003, in materia di
applicazione della legge n. 52 del 1996 ai contratti conclusi dai consumatori; cfr. altresì, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive previdenziali e di applicazione retroattiva, in
quanto previsto espressamente, del regime sanzionatorio di cui alla legge n. 388 del 2000,
Cass. nn. 22414 del 2009, 22001 del 2008, 13794 del 2007. La giurisprudenza esclude, peraltro, che il principio di irretroattività possa valere quando la nuova legge sopravvenuta sia diretta a disciplinare effetti (non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente)
che hanno un’autonoma considerazione da parte del legislatore e siano svincolati da relazioni
con l’atto o il fatto giuridico che li abbia generati: cfr. Cass. n. 9972 del 2008. In generale, sulla necessità di applicare il brocardo tempus regit actum non in senso letterale ma in senso razionale e non contraddittorio, cfr. Cass. Sez. Un. nn. 27614 del 2007 e 27172 del 2006 in mate-
ADL 1/2011
ELENA BOGHETICH
85
Alcuni interpreti hanno ritenuto che vadano distinti i licenziamenti per
i quali il primo termine non è ancora decorso (nei confronti dei quali deve
ritenersi applicabile anche il secondo termine) da quelli per i quali sia già
intervenuta l’impugnazione (nei confronti dei quali può ritenersi di escludere l’operatività della seconda decadenza ovvero di applicare la novella
facendo decorrere il secondo termine dalla data di entrata in vigore della
legge) (27).
Un’altra soluzione prospettabile, in applicazione del principio di irretroattività della legge e in considerazione dell’ampliamento del campo di
applicazione dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, potrebbe essere quella
di distinguere tra i tipi di licenziamento: per i licenziamenti già sottoposti al
regime decadenziale del vecchio art. 6 della legge n. 604 del 1966, la novità procedimentale è rappresentata solamente dal secondo termine decadenziale e, pertanto, il principio tempus regit actum deve aver riguardo alla
data di scadenza dei 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale (perché
“l’atto nuovo” è rappresentato dal secondo termine, che si avvia dalla scadenza della prima tranche di 60 giorni); per i licenziamenti e le altre ipotesi
incluse, ex novo, nel campo di applicazione del novellato art. 6 (per cui la
novità, “l’atto nuovo”, è rappresentata dall’impugnazione stragiudiziale,
prima insussistente), va considerato l’atto da impugnare. Quindi, i licenziamenti già sottoposti (nel regime precedente) al termine decadenziale di 60
giorni di cui all’art. 6 della legge n. 604 (impugnazione, anche, stragiudiziale) saranno soggetti alla nuova disciplina (quindi, successiva impugnazione entro i 270 giorni) solamente nel caso in cui il termine (di 60 giorni)
scada successivamente alla data di entrata in vigore della novella legislativa; per i tipi di licenziamenti sottoposti ex novo all’articolata procedura decadenziale dovrà considerarsi solamente i provvedimenti espulsivi intimati
dopo l’entrata in vigore della legge.
In tutti gli altri casi, ossia per i licenziamenti già regolati dall’art. 6 della
legge n. 604 il cui termine di 60 giorni scadeva prima dell’entrata in vigore
della novella legislativa e per i licenziamenti sottratti alla vecchia disciplina,
l’azione giudiziaria (o il ricorso alla conciliazione o all’arbitrato) rimarrà soggetta al termine prescrizionale e sottratta, pertanto, ai termini decadenziali.
Ne consegue, inoltre, che, in caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione (a seguito di rifiuto del datore di lavoro di accedere a
tale soluzione manifestato tramite mancata comparizione alla data della riunione) non si applica il termine di decadenza di 60 giorni, trattandosi di
ria di novelle legislative apportate al regime di impugnativa della sentenza di accoglimento
delle sanzioni disciplinari per i magistrati.
(27) M. Tatarelli, Licenziamenti: inserito ecc. , op. cit. ,V.
ADL 1/2011
86
PARTE PRIMA . SAGGI
licenziamento irrogato ed impugnato in data precedente l’entrata in vigore
della novella legislativa.
Nel particolare caso, infine, in cui un licenziamento sottoposto al regime del vecchio art. 6 della legge n. 604 sia stato immediatamente impugnato, ossia prima del termine di 60 giorni (termine che sarebbe, però, scaduto in momento successivo all’entrata in vigore della novella legislativa),
sembrerebbe più rispettosa del principio di irretroattività delle norme, la
soluzione che ritiene inapplicabile il secondo termine di decadenza (che
decorre da un atto, l’impugnazione del licenziamento, compiuto antecedentemente all’entrata in vigore della modifica legislativa); peraltro, proprio al fine di evitare irragionevoli applicazioni normative (si pensi a due
lavoratori che hanno ricevuto un licenziamento il medesimo giorno e di cui
uno impugni immediatamente l’atto mentre l’altro si riservi di farlo poco
prima della scadenza del 60° giorno e, quindi, dopo l’entrata in vigore della legge) deve ritenersi che vada ricercata una soluzione interpretativa
omogenea per i vari casi e, quindi, dovrebbe privilegiarsi la soluzione di ritenere applicabile il secondo termine di decadenza con decorrenza dall’entrata in vigore della norma.
In tal modo, in caso di licenziamento irrogato prima della novella legislativa (e già sottoposto alla disciplina dettata dal vecchio art. 6 della legge
n. 604 del 1966), il regime delle decadenza non risulterà condizionato da
elementi meramente aleatori, come quelli affidati alla tempestività o meno
dell’impugnazione dell’atto datoriale; il nuovo regime sarà sempre applicabile e il secondo termine decadenziale decorrerà dall’entrata in vigore della legge o dalla (successiva impugnazione effettuata entro i 60 giorni).
La soluzione più ragionevole, che parte da una valutazione sistematica
di tutta la novella legislativa e riconduce ad omogeneità tutti i casi soggetti
all’onere di impugnazione, appare, comunque, quella di ritenere soggetti ai
termini decadenziali solamente i licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della novella legislativa, considerato il principio generale di irretroattività delle disposizioni legislative, la valutazione unitaria del procedimento di impugnazione e, quindi, la rilevanza temporale dell’adozione dell’atto
espulsivo.
Per tutte le altre ipotesi, diversi dai licenziamenti, ai quali si applica l’onere procedimentalizzato dell’impugnazione (accertamento della natura
del rapporto di lavoro finalizzato alla valutazione dell’atto di risoluzione ed
alla instaurazione di un contratto a tempo indeterminato, lavoro a progetto, trasferimento del lavoratore o di azienda), dovrebbe preferirsi la soluzione da ultimo esposta, e, quindi, ritenere sottratto al regime decadenziale ogni atto verificatosi in data precedente l’entrata in vigore della novella
legislativa.
ADL 1/2011
Giovanni Mimmo
Giudice del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro
DECADENZA E REGIME SANZIONATORIO:
COME IL “COLLEGATO LAVORO” HA MODIFICATO
LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE
Sommario: 1. Una normativa che integra il d. lgs. n. 368 del 2001. – 2. Estensione della decadenza alla contestazione dell’illegittimità del termine. – 2.1. Decorrenza del termine di
decadenza; questioni problematiche con particolare riferimento alla successione di contratti a termine . . . – 2.2. . . . e alla retroattività del regime decadenziale. – 3. Conseguenze
dell’illegittimità del contratto a termine; a) conversione del contratto. – 3.1. b) la forfettizazione del risarcimento del danno. – 3.2. Questioni problematiche: ambito di applicazione della norma. – 3.3. Contratti a termine stipulati da una pubblica amministrazione.
1. – L’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183, pur senza intaccare la
struttura del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368, introduce rilevanti modifiche
alla disciplina del contratto a termine destinate ad incidere profondamente
sull’istituto.
In sintesi, le modifiche apportate vanno in due direzioni: da un lato si
introduce, anche per il contratto a termine, una rigorosa disciplina decadenziale e dall’altro si disciplinano in maniera specifica le conseguenze derivanti dall’illegittima apposizione di un termine al contratto di lavoro.
La caratteristica e peculiarità, che non mancherà di suscitare dubbi di
costituzionalità, è che entrambe le modifiche legislative hanno carattere retroattivo.
2. – Il terzo comma lett. d) dell’art. 32 ha esteso anche alle azioni di nullità del termine apposto al contratto di lavoro la disciplina di cui all’art. 6
della legge 15 luglio 1966 n. 604 come modificato dal primo comma dello
stesso art. 32: pertanto, qualora il lavoratore lasci decorrere un termine superiore ai sessanta giorni dalla data di scadenza del rapporto senza avere
impugnato con atto scritto il contratto ritenuto viziato, decade dal diritto di
far valere in giudizio tale illegittimità, con la conseguenza che l’eventuale
azione giudiziaria intrapresa dal lavoratore senza che questi abbia mai impugnato l’apposizione del termine, ovvero lo abbia fatto una volta decorsi
sessanta giorni, verrebbe dichiarata inammissibile. Stessa sorte toccherebbe, pur in presenza di una tempestiva impugnazione, all’azione giudiziaria
volta a far valere l’illegittimità del termine qualora la stessa venga proposta
oltre duecentosettanta giorni dall’impugnazione del contratto a tempo determinato.
ADL 1/2011
88
PARTE PRIMA . SAGGI
Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione, la quale deve essere
fatta nelle forme e con le modalità di cui all’art. 6 della legge 15 luglio 1966
n. 604, decorre dalla data di cessazione del contratto, cioè dalla data di scadenza del termine.
La disciplina sopra descritta si applica espressamente alle azioni di nullità ai sensi degli artt. 1 (il quale fa riferimento ai contratti a termine stipulati per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo),
2 (il quale fa riferimento ai contratti stipulati nell’ambito di situazioni peculiari quali quelle connesse al trasporto aereo o ai servizi aeroportuali o ai
servizi nel settore postale) e 4 (il quale riferimento alla disciplina della proroga) del d. lgs. n. 368 del 2001, con la conseguenza che la norma sembrerebbe non trovare applicazione alle vicende descritte dall’art. 3 (divieti) e
dall’art. 5 (proroga di fatto e termine di durata massima) dello stesso d. lgs.
n. 368 del 2001 e questo in considerazione del fatto che dovendosi ritenere le norme che introducono decadenze di carattere eccezionale ne sarebbe preclusa una interpretazione analogica o estensiva.
Tuttavia, ritenere che, qualora il lavoratore si dolga del fatto che il contratto sia stato stipulato in violazione di un espresso divieto ovvero che il
rapporto sia proseguito oltre la scadenza, senza alcuna proroga, per un
tempo superiore ai venti o trenta giorni, a seconda che il rapporto di lavoro
abbia una durata inferiore o superiore ai sei mesi e invochi per tale ragione
la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, non dovrebbe essere soggetto ai vincoli di impugnazione e di azione giudiziaria
previsti a pena di decadenza per le altre ipotesi, non risponde ad alcuna ragione logico giuridica, non avendo alcun senso la previsione di una differente disciplina.
Ragioni di ordine logico-sistematico inducono a ritenere che il legislatore nella parte in cui fa riferimento alle “azioni di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368 . . .” intendesse riferirsi a tutte le ipotesi di invalidità del
contratto a termine, collegando il richiamo “. . . ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del
d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368 . . .” non già ai motivi di nullità, bensì ai contratti a termine stipulati in base a tali norme. Questa conclusione sembra
preferibile per due ordini di ragioni: a) la circostanza che non vi sarebbe alcun motivo per distinguere, ai fini della decadenza, le ipotesi di nullità del
contratto per violazione degli artt. 1, 2 e 4 da quelle derivanti dalla violazione degli artt. 3 e 5; b) la formulazione del comma 4, lett. a) dello stesso
art. 32, che nel prevedere la applicabilità della decadenza anche ai contratti in corso di esecuzione, fa espresso riferimento “ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 . . .”, inducendo così, coerentemente, a ritenere che anche nella lettera d) del terzo comma il riferimento sia da
ADL 1/2011
GIOVANNI MIMMO
89
operarsi a tutti i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 e non
alle sole ipotesi in cui siano violate tali norme, comprendendo così anche le
violazioni degli artt. 3 e 5, riguardando pur sempre contratti stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4.
In ogni caso, l’espresso riferimento al d. lgs. n. 368 del 2001 porta a ritenere certamente esclusa la decadenza nelle ipotesi previste dall’art. 10
della stessa norma, in cui il citato decreto legislativo non trova applicazione ovvero in tutti i casi di contratti a termine stipulati al di fuori della norma citata.
Rinviando per maggiori approfondimenti alla illustrazione del nuovo
regime decadenziale, occorre rilevare che la ratio dell’intervento normativo consiste nel tentativo di ridurre, in tutte le controversie nelle quali il lavoratore richieda la costituzione ex tunc dalla data della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro ovvero con terzi soggetti, il tempo intercorrente tra la cessazione del rapporto e la sua ricostituzione, onerando
il lavoratore di attivarsi tempestivamente sia impugnando l’atto, sia agendo
in giudizio entro termini perentori. Orbene, identica ratio si pone nel caso
del contratto a termine, considerato che il lavoratore poteva prima contestare la legittimità dell’apposizione del termine anche a notevole distanza
di tempo dalla cessazione del rapporto, senza incorrere in prescrizione o
decadenza, chiedendo così la ricostituzione del rapporto sin dalla data della cessazione medesima, seppure lo stesso rapporto si fosse trovato per lungo tempo in una situazione quiescente.
Questo fenomeno ha assunto in relazione ai contratti a termine una notevole rilevanza negli ultimi anni in occasione del considerevole aumento del
contenzioso, che, evidentemente, ha indotto molti lavoratori ad impugnare
contratti a termine anche a distanza di molti anni dalla loro cessazione. La
giurisprudenza ha ritenuto che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato sul presupposto dell’illegittima
apposizione del termine scaduto potesse configurarsi una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso qualora si accerti – sulla base del lasso di tempo lasciato trascorrere dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine,
nonché alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento
tenuto dalla parti e di eventuali significative circostanze – che sia presente
una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d’accordo
tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr. Cass. 3
gennaio 2011, n. 65; Cass. 7 maggio 2009, n. 10526; 10 novembre 2008, n.
26935; 28 settembre 2007, n. 20390; 6 luglio 2007, n. 15264; 17 dicembre
2004, n. 23554; 11 dicembre 2001, n. 15628; 2 dicembre 2000 n. 15403).
Orbene, l’introduzione del regime della decadenza anche per i contratti a termine consentirà di escludere la configurabilità della risoluzione per
ADL 1/2011
90
PARTE PRIMA . SAGGI
mutuo consenso, posto che risulta incompatibile con l’onere del lavoratore
di tempestiva contestazione nei confronti di un contratto a termine ritenuto illegittimo: infatti, considerato che il lavoratore dovrà contestare la legittimità del termine entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto ed
agire in giudizio entro i successivi duecentosettanta, non vi sarà certamente più spazio per una prolungata inerzia del lavoratore tale da potere configurare una volontà solutoria.
2.1. – Ai sensi dell’art. 32, terzo comma lett. d), il termine di decadenza
decorre dalla scadenza del contratto. La norma non pone problemi nelle
ipotesi ordinarie in cui venga stipulato un contratto a termine che cessi al
momento della naturale scadenza del termine medesimo.
Nella pratica si verificano ipotesi in cui il contratto a termine venga a
cessare prima della scadenza del termine, per esempio per licenziamento.
In tali casi, fermo ovviamente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento per contestare lo stesso, il termine di decadenza al
fine di contestare la legittimità del termine apposto al contratto (la cui verifica ovviamente è subordinata alla illegittimità del licenziamento, non
avendo altrimenti il lavoratore alcun concreto interesse ad agire) dovrebbe
decorrere in ogni caso dalla scadenza del termine originariamente prevista
nel contratto, pur se in concreto il contratto sia cessato ante tempus.
L’art. 5 del d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368 dispone che se il rapporto di
lavoro continui oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, ovvero qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. In tali casi il termine di decadenza relativo all’azione volta a far valere la sussistenza
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sempre, ovviamente che si
ritenga applicabile la decadenza anche alle ipotesi contemplate dall’art. 5)
dovrebbe decorrere rispettivamente dalla scadenza del ventesimo o del
trentesimo giorno e dalla scadenza dell’ultimo contratto che ha comportato il superamento del termine complessivo di trentasei mesi.
La questione che, a parere di chi scrive, comporterà maggiori contrasti
in materia di decadenza riguarda la successione di contratti a termine: in tal
caso il lavoratore sarà tenuto ad impugnare ciascun contratto entro sessanta giorni dalla sua scadenza, ovvero l’impugnazione dell’ultimo contratto
nel suddetto termine consentirà di contestare la validità dei precedenti,
ADL 1/2011
GIOVANNI MIMMO
91
seppure gli stessi non siano stati tempestivamente impugnati? La prima soluzione, che secondo lo scrivente è da preferirsi, fa leva sulla circostanza
che una volta scaduto il contratto e cessato il rapporto senza che vi sia stata
l’impugnazione nel termine di sessanta giorni la decadenza si è compiuta,
senza che tale effetto possa successivamente venir meno in virtù della stipula di un ulteriore contratto (in questo senso, vedi M. Tatarelli, in Licenziamenti: inserito un nuovo termine di decadenza per avviare l’azione giudiziaria dopo l’impugnazione, in Guida al Diritto, n. 48, 4 dicembre 2010, pag. 7).
La circostanza secondo la quale una volta che, in presenza di una successione di contratti a termine illegittimi, il giudice dichiari la sussistenza di un
unitario rapporto di lavoro ha indotto taluno a ritenere che l’impugnazione
possa essere unica, cioè con l’impugnazione dell’ultimo dei contratti si possano contestare anche quelli precedenti. Tale soluzione, seppure in base alla lettera della legge difficilmente sostenibile, ha il pregio di elidere un effetto perverso derivante dall’applicazione del regime della decadenza al
contratto a termine: spesso, infatti, il lavoratore è indotto a non contestare
la legittimità del contratto a termine proprio nella speranza che vengano
stipulati altri contratti, mentre la manifestazione di volontà di portare il datore di lavoro davanti al giudice potrebbe indurre quest’ultimo a non stipulare contratti successivamente.
Una soluzione intermedia, che potrebbe rifarsi ai principi enunciati
dalla Corte costituzionale in materia di decorrenza della prescrizione nel
corso del rapporto (Corte cost. 10 giugno 1966, n. 63) potrebbe essere
quella di non ritenere operante la decadenza nelle ipotesi in cui il successivo contratto a termine venga stipulato entro il termine di decadenza di sessanta giorni, al fine di non costringere il lavoratore a far causa al datore di
lavoro in costanza di (un successivo) rapporto di lavoro.
2.2. – In materia di decadenza ciò che distingue il contratto a termine
dalle altre fattispecie nei confronti delle quali la stessa trova applicazione è
dato dalla specifica previsione della retroattività, cioè della sua applicazione non solo ai contratti che scadono successivamente all’entrata in vigore
della legge, ma anche a tutti quelli scaduti in precedenza, con l’ovvia precisazione che in tal caso il termine per impugnare il contratto decorre dal 24
novembre 2010, data di entrata in vigore della legge.
Il quarto comma, lettera a), dell’art. 32 prevede che il regime della decadenza si applichi anche « ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine ». La disposizione appare piuttosto superflua in quanto una volta che l’art. 32, terzo comma, lett. d), abbia stabi-
ADL 1/2011
92
PARTE PRIMA . SAGGI
lito che il termine di decorrenza della decadenza coincida con la scadenza
del termine, esso trova applicazione, senza che possa in tal caso parlarsi di
retroattività, a tutti i contratti che scadano successivamente all’entrata in vigore della norma, per cui anche senza la previsione dell’art. 32, quarto comma, lett. a) se ne sarebbe potuta affermare l’applicazione.
Maggiormente rilevante, ed in tal caso certamente frutto di una applicazione retroattiva della norma, è la lettera b) del quarto comma dell’art. 32
che prevede l’applicazione della decadenza « ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata
in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge ». In sostanza il legislatore ha chiaramente voluto estendere l’istituto della decadenza a tutti i contratti a termine già scaduti, onerando gli interessati a proporre opposizione entro il 23
gennaio 2011 e nei successivi 270 giorni a promuovere l’azione giudiziaria.
La Corte costituzionale ha ritenuto che il legislatore ordinario, nel rispetto del limite previsto dall’art. 25 Cost. relativamente alla legge penale,
possa emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative
che esse siano, a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (cfr. Corte cost. 7 giugno 1999, n.
229). L’intenzione del legislatore di estendere l’istituto della decadenza a
tutti i contratti a termine non può in sé essere ritenuta irragionevole, in
quanto volta a disciplinare allo stesso modo in maniera indifferenziata tutti i contratti a termine, anche perché in ogni caso è garantito lo stesso termine di sessanta giorni per attivarsi. Né la circostanza che il legislatore abbia previsto la retroattività delle norme sulla decadenza solo per i contratti
a termine e non anche per le restanti fattispecie, pur muovendo tutte le ipotesi dalla medesima ratio, può ritenersi una violazione del principio di
uguaglianza, considerato che le fattispecie sono pur sempre tra loro diverse (in questo senso, vedi P. Tosi, Il contratto di lavoro a tempo determinato nel
“collegato lavoro” alla legge finanziaria, in Riv. It. Dir. Lav. , 2010, 3, pag. 473).
Pertanto, i lavoratori che abbiano in passato stipulato un contratto a
tempo determinato ormai concluso hanno l’onere di impugnare lo stesso
(ovvero gli stessi qualora siano stati stipulati una pluralità di contratti a termine, non potendosi ritenere in tal caso che l’impugnazione dell’ultimo
possa valere anche quale impugnazione dei precedenti) entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In riferimento ai
contratti già conclusi la norma si applica a tutti i contratti a tempo determinato, cioè non solo a quelli stipulati ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2001 n.
368, ma anche a quelli stipulati in virtù di normative precedenti (per esem-
ADL 1/2011
GIOVANNI MIMMO
93
pio, ai sensi della legge n. 260 del 1962 ovvero ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987). Una volta tempestivamente impugnato il contratto il lavoratore deve agire in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro
duecentosettanta giorni dall’impugnazione.
Ovviamente se il lavoratore prima dell’entrata in vigore della norma abbia già contestato la validità del termine non sarà tenuto a reiterare l’impugnazione; tuttavia, al fine di non far perdere efficacia a tale impugnazione
sarà tenuto in ogni caso a proporre giudizio entro il successivo termine di
giorni 270, termine che in tal caso decorre non già dall’impugnazione, ma
pur sempre dall’entrata in vigore della legge (24 novembre 2010).
3. – Sempre in materia di contratti a termine rilevanti novità sono state
introdotte dal quinto comma dell’art. 32, che interviene, senza intaccare
l’impianto del d. lgs. n. 368 del 2001, sul sistema sanzionatorio in ipotesi di
illegittima apposizione del termine.
Invero, la formulazione della norma risulta piuttosto oscura e non mancherà di generare numerosi dubbi interpretativi: « Nei casi di conversione
del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro
al risarcimento del lavoratore . . . ». Si deve verificare in primo luogo a cosa
faccia riferimento il legislatore con la formula “Nei casi di conversione del
contratto a tempo determinato . . .”: infatti, il d. lgs. n. 368 del 2001, come è
noto, non prevede la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con l’unica eccezione dell’art. 5
ove è espressamente indicata, in caso di protrazione di fatto del rapporto,
ovvero di superamento del limite massimo di 36 mesi, la conversione del
contratto (“il rapporto si considera a tempo indeterminato”).
È da escludere che la modifica normativa trovi applicazione nell’unico
caso in cui sia espressamente prevista dalla legge la conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, cioè nell’ipotesi di cui
all’art. 5 del d. lgs. n. 368 del 2001 che disciplina la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del contratto ovvero oltre il limite dei 36 mesi: una
simile interpretazione, infatti, introdurrebbe una disciplina differenziata e
discriminatoria per i lavoratori a termine i quali abbiano continuato a lavorare oltre la scadenza del termine medesimo, ovvero per più di 36 mesi, che
non avrebbe alcuna logica e fondamento e, di fatto, priverebbe di rilevanza la modifica normativa che, in senso opposto, appare volta a disciplinare
tutti i contratti a termine.
Si potrebbe ipotizzare che con una formula volutamente ambigua il legislatore non abbia voluto prendere posizione sulle conseguenze dell’apposizione illegittima di un termine al contratto di lavoro (se il contratto vada convertito, ovvero se debba ritenersi nulla la sola clausola, con conse-
ADL 1/2011
94
PARTE PRIMA . SAGGI
guente nullità dell’intero contratto qualora ritenuta dalle parti essenziale),
ma che abbia voluto lasciare libero l’interprete di adottare la soluzione ritenuta preferibile, intervenendo unicamente nelle ipotesi in cui il giudice
provveda in concreto a convertire il contratto: questa soluzione, tuttavia,
sovvertirebbe i rapporti tra legislatore ed interprete, costituendo una abdicazione del primo nel dettare la disciplina normativa.
A parere di chi scrive, con la norma in questione il legislatore, prendendo atto degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, ha inteso
generalizzare l’istituto della conversione del contratto a termine illegittimo
in contratto a tempo indeterminato.
Al fine di meglio comprendere la portata innovativa della norma appare opportuno ripercorrere le vicende sanzionatorie connesse all’illegittima
apposizione del termine.
La legge 18 aprile 1962 n. 230, pur non facendo esplicito riferimento alla conversione del rapporto a termine illegittimo in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato è sempre stata interpretata in tal senso in quanto l’art.
1 disponeva al primo comma che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate e al terzo comma che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Nel vigore, pertanto, della legge n. 230 del 1962 una volta che il giudice dichiarava l’illegittimità dell’apposizione di un termine al rapporto di lavoro, o perché privo
del necessario requisito formale ovvero perché stipulato al di fuori di una
delle causali in relazione alle quali era ammessa l’apposizione del termine,
il rapporto a tempo determinato veniva convertito in rapporto a tempo indeterminato sul presupposto che essendo priva di effetto la clausola contenente il termine questa si reputava come non apposta, per cui il contratto
doveva intendersi senza la stessa, dunque a tempo indeterminato.
Tuttavia, la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a
tempo indeterminato, con conseguente obbligo di ripristino del rapporto
nell’ipotesi in cui lo stesso fosse nelle more cessato, non esauriva le conseguenze dell’illegittima apposizione del termine. Infatti, per quanto attiene
ai diritti di natura economica discendenti dal riconoscimento della natura
a tempo indeterminato del rapporto di lavoro tra le parti la giurisprudenza,
escludeva l’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro durante gli intervalli non lavorati sul presupposto generale che al dipendente che cessi
l’esecuzione della prestazione lavorativa alla scadenza del termine illegittimamente apposto non spetti la retribuzione finché non provveda ad offrire
la prestazione lavorativa determinando una mora accipiendi (cfr. Cass. 23
novembre 2006, n. 25886; 25 novembre 2003, n. 17987), sulla base della
regola della effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, per la quale, al di fuori delle espresse deroghe legali o contrattuali, la
ADL 1/2011
GIOVANNI MIMMO
95
retribuzione spetta soltanto se la prestazione viene eseguita, ma riconosceva al lavoratore il risarcimento dei danni corrispondente alle retribuzioni
perdute, qualora il datore si trovasse in una situazione di mora accipiendi
nei confronti del dipendente, cioè dal momento in cui quest’ultimo avesse
chiesto al datore di lavoro il ripristino del rapporto sulla base dell’illegittima apposizione del termine provvedendo nel contempo ad offrire le proprie prestazioni lavorative (cfr. Cass. 23 luglio 2008, n. 20316; 21 novembre
2006, n. 24655; 1 dicembre 2003, n. 18354; 26 maggio 2003, n. 8352; 17 ottobre 2001, n. 12697; 26 maggio 2001, n. 7186).
Pertanto, nella vigenza della legge n. 230 del 1962 il sistema sanzionatorio conseguente all’illegittima apposizione del termine faceva leva sia sulla conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato,
con la conseguente dichiarazione della sussistenza di un rapporto a tempo
indeterminato sin dall’inizio della prestazione e del ripristino del rapporto
qualora cessato, sia sul risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non corrisposte dal momento in cui il lavoratore avesse messo in mora, attraverso l’offerta della prestazione lavorativa, il datore di lavoro.
Con l’entrata in vigore del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368 si è posto il
problema se tale sistema sanzionatorio potesse o meno considerarsi inalterato, non riportando la norma alcuna indicazione in proposito. L’art. 1, infatti, non ha riprodotto la disposizione dell’art. 1 della legge n. 230 del 1962
nella parte in cui si prevedeva che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, limitandosi ad affermare, al secondo comma, che la apposizione
del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto
scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
Secondo un primo orientamento, pur in mancanza dell’esplicito riferimento al carattere residuale del contratto a termine, l’eventuale inefficacia
della clausola di apposizione del termine non può che portare, ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, Cod. Civ. , alla nullità della sola clausola, con la
conseguenza che il contratto non potrebbe che ritenersi a tempo indeterminato. Secondo altro orientamento la mancanza di una norma imperativa
avrebbe dovuto portare all’applicazione del primo comma dell’art. 1419
Cod. Civ. , con la conseguenza che si sarebbe dovuta affermare la nullità
dell’intero contratto in presenza della prova che i contraenti non lo avrebbero voluto senza la clausola nulla. In sostanza, applicando la disposizione
di cui al secondo comma dell’art. 1419 Cod. Civ. le conseguenze dell’illegittima apposizione del termine sarebbero state identiche rispetto a quelle
che caratterizzavano il sistema previgente, cioè la sostituzione del rapporto
di lavoro a termine con un contratto a tempo indeterminato, mentre aderendo alla tesi della nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419, primo
comma, Cod. Civ. le conseguenze sanzionatorie derivanti dall’illegittima
ADL 1/2011
96
PARTE PRIMA . SAGGI
apposizione del termine sarebbero state praticamente nulle nelle ipotesi in
cui il datore di lavoro avesse provato che non avrebbe stipulato il contratto
di lavoro senza all’apposizione del termine.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 12985 del 21 maggio 2008 ha
chiaramente optato per la prima delle opzioni interpretative sopra riferite affermando che l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 39 della legge n. 247 del 2007, ha confermato il
principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una
clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di
insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una
norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base
ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto
di lavoro subordinato, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale sistema sanzionatorio è stato confermato dal legislatore con interventi normativi volti ad integrare la disciplina di cui al d. lgs. n. 368 del
2001: l’art. 1, comma 39, della legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha aggiunto
un comma all’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 affermando il principio secondo il quale il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato, riproducendo così la stessa norma che caratterizzava il sistema
previgente; ne consegue che le argomentazioni che permettevano con il vigore della legge n. 230 del 1962 di affermare la conversione del contratto a
tempo determinato illegittimo in contratto a tempo indeterminato, sulla
base della sostituzione della clausola nulla, possono essere integralmente
riproposte con l’attuale assetto normativo.
Un implicito avallo a tale ricostruzione la si può ricavare dall’introduzione dell’art. 21, comma 1 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale introducendo l’art. 4 bis al
d. lgs. prevedeva che con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato,
in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità
di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8
ADL 1/2011
GIOVANNI MIMMO
97
della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Appare evidente
che l’introduzione di tale norma presuppone che secondo lo stesso legislatore, allo stato, la sanzione per la stipula di un contratto a tempo determinato illegittimo non può che essere la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, non avendo altrimenti alcun senso l’introduzione di una tutela transitoria volta ad escludere proprio questo effetto; il legislatore, infatti, ha espressamente voluto introdurre una disposizione
transitoria, applicabile esclusivamente ai giudizi in corso, che escludesse
sia la conversione del rapporto, sia i profili risarcitori come sopra individuati, contenendo entro un limite rigoroso (da 2,5 ad un massimo di 6
mensilità) l’eventuale risarcimento come conseguenza della violazione della normativa sui contratti a termine.
L’irrazionalità della scelta di applicare una norma di chiaro disfavore
per il lavoratore solo a coloro i quali avessero già promosso un giudizio,
con la ovvia esclusione delle sentenze passate in giudicato, ha portato alla
censura di illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis del d. lgs. n. 368 del
2001 introdotto dalla legge n. 133 del 2008. Con sentenza del 14 luglio
2009 n. 214 la Corte costituzionale ha rilevato che in effetti situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo,
per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento
del danno; dall’altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la
mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch’essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell’art. 4 bis del d. lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall’art.
21, comma 1 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).
Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti l’intervento del legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l’apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti
regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del
rapporto di lavoro.
Pur avendo costituito oggetto delle ordinanze di rimessione alla Corte
Costituzionale, il giudice delle leggi non si è pronunciato sulle censure sostanziali al meccanismo introdotto dal legislatore, cioè la possibilità che la
sanzione per l’illegittima apposizione del termine non sia la trasformazione
del rapporto in contratto a tempo indeterminato ma un mero risarcimento
del danno, ritenendole assorbite.
ADL 1/2011
98
PARTE PRIMA . SAGGI
Nella sentenza la Corte costituzionale afferma espressamente che la
conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno costituiscono ormai “diritto vivente”, per cui l’effetto non
può che essere la dichiarazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con conseguente ripristino del rapporto e con il risarcimento del danno dalla messa in mora.
In tale contesto il quinto comma dell’art. 32 in commento nella parte in
cui fa riferimento “ai casi di conversione del contratto a tempo determinato” ha introdotto in via generalizzata la previsione della conversione del
contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato, effetto
che, fino al Collegato lavoro, è sempre stato unicamente di derivazione giurisprudenziale.
Pertanto, la norma, pur non specificandolo espressamente, dà implicitamente per presupposto il “diritto vivente” secondo il quale in presenza di
un contratto a tempo determinato illegittimo la sanzione debba essere
quella della conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in questo senso, Trib. Roma 11 gennaio 2011).
Questo, presumibilmente, spiega il motivo per il quale il riferimento alla conversione del contratto sembri quasi casuale, in quanto il legislatore
più che introdurre una disciplina innovativa non ha fatto altro che fare una
ricognizione di quello che fino a quel momento era ritenuto “diritto vivente”: tuttavia, questo non elimina il carattere innovativo della norma, in
quanto prima la trasformazione del contratto costituiva un effetto di una,
seppure costante, interpretazione giurisprudenziale, mentre adesso è imposto dalla legge.
3.1. – La norma da un lato disciplina le conseguenze dell’illegittima apposizione del termine prevedendo, implicitamente, la conversione del contratto (dando per presupposto che in presenza di una illegittima apposizione del termine il giudice debba convertirlo), dall’altro disciplina il risarcimento del danno che da tale conversione deriva.
Come si è visto prima dell’entrata in vigore del Collegato lavoro la giurisprudenza prevedeva che nell’ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato il datore di lavoro dovesse essere condannato al risarcimento del danno pari alle retribuzioni
non corrisposte dalla data in cui lo stesso lavoratore, mediante l’offerta della prestazione lavorativa, avesse messo in mora il datore di lavoro. Questo
criterio, in concreto, subordinava l’ammontare del risarcimento ad una mera iniziativa del lavoratore, nel senso che il lavoratore che avesse tempestivamente offerto le proprie prestazioni al datore di lavoro e poi agito in giudizio dopo molto tempo si vedeva riconoscere un risarcimento consistente
ADL 1/2011
GIOVANNI MIMMO
99
pari alle retribuzioni non corrisposte dalla messa in mora, mentre il lavoratore che avesse tardato ad offrire le proprie prestazioni ovvero non lo avesse fatto per nulla si vedeva riconoscere un risarcimento inferiore ovvero
non aveva diritto ad alcun risarcimento.
Il comma quinto dell’art. 32, al contrario, introduce, nelle ipotesi di
conversione del contratto, una disciplina che predetermina l’ammontare
del risarcimento, sganciandolo dall’iniziativa del lavoratore e prevedendo
che esso sia compreso tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12
mensilità della retribuzione globale di fatto. Dunque, a prescindere dalla
data di cessazione del contratto a termine, dalla data di messa in mora e
dalla data di ripristino del rapporto, l’ammontare del risarcimento del danno conseguente alla conversione del contratto deve corrispondere ad una
indennità che non può essere inferiore a 2,5 mensilità e superiore a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto. In dottrina A. Vallebona, Una buona
svolta del diritto del lavoro, in Bollettino Adapt 7 aprile 2010 n. 12, pag. 7, evidenzia che l’indennità assorbe qualsiasi risarcimento come risulta dall’aggettivo “onnicomprensiva”, quindi anche il risarcimento da mora accipiendi
per il periodo dalla scadenza del contratto alla sentenza.
Applicando nella fattispecie i principi elaborati dalla giurisprudenza in
tema di risarcimento dei danni per illegittimo licenziamento si può affermare che per retribuzione globale di fatto, quale parametro di computo del
risarcimento del danno patito a seguito di illegittima apposizione del termine, debba intendersi non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni
compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento della cessazione del rapporto, quali mensilità aggiuntive, compensi per lavoro straordinario erogati con continuità, premio di produzione, ecc. , dovendosi invece escludere dal risarcimento i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese (cfr. ,
da ultimo, Cass. 17 febbraio 2009, n. 3787).
Nell’individuare il concreto ammontare dell’indennità il giudice deve
utilizzare i criteri previsti dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Tali
criteri, i quali devono essere riadattati alla diversa tipologia di rapporto,
fanno riferimento a: 1) al numero dei dipendenti occupati e alle dimensioni dell’azienda; 2) all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro; 3) al
comportamento e alle condizioni delle parti. Mentre il riferimento alle dimensioni dell’azienda può costituire utile criterio di determinazione dell’indennità anche nella fattispecie in esame, il riferimento all’anzianità di
servizio può agevolmente essere collegato alla durata complessiva del rapporto (ovvero dei rapporti), nel senso che ad una maggiore durata può essere applicata una maggiore indennità, mentre, il riferimento al comportamento delle parti, che nelle ipotesi del licenziamento è collegato alla gravi-
ADL 1/2011
100
PARTE PRIMA . SAGGI
tà dei profili di illegittimità del recesso, può essere collegato alla gravità dei
profili di illegittimità del contratto a termine, ovvero alla sussistenza di una
pluralità di contratti a termine illegittimi.
Secondo il comma sesto in presenza di contratti ovvero accordi collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità non può superare le sei mensilità. La
norma fa riferimento a quelle aziende in relazione alle quali, per espressa
disposizione contrattuale, i lavoratori utilizzati a tempo determinato vengono inseriti in graduatorie alle quali attingere per la stipula di successivi
contratti a termine ovvero per assunzioni a tempo indeterminato. La norma
può costituire un utile incentivo per le aziende che facciano ricorso a un
numero elevato di contratti a termine a prevedere forme di stabilizzazione
dei lavoratori assunti con contratti a termine.
Nell’ipotesi di una pluralità di contratti a termine, tutti ritenuti illegittimi, si potrebbe porre la questione se l’indennità di cui al comma 5 dell’art.
32 debba essere applicata una sola volta ovvero tante volte quanti sono i
rapporti ritenuti contrari alla legge. L’esplicito riferimento alla conversione
del rapporto e la circostanza che tale conversione sia unitaria anche in ipotesi di pluralità di contratti a termine, porta a ritenere che, a prescindere dal
numero di contratti a termine impugnati, l’indennizzo in questione vada
applicato una sola volta: ovviamente, in tal caso, la sussistenza di una pluralità di contratti a termine inciderà sulla quantificazione dell’indennizzo, sia
sotto il profilo della maggiore durata del rapporto, sia sotto il profilo del
comportamento delle parti in ipotesi di una reiterazione di condotte illegittime.
Occorre dare atto di una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 29
novembre 2010 che, applicando la disposizione di cui all’art. 32, quinto
comma, della legge n. 183 del 2010 ha ritenuto che “una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al diritto comunitario impone di interpretare la disposizione dell’art. 32, quinto comma, nel senso di tutela aggiuntiva e non alternativa a quella ordinaria risarcitoria”. A parere dello
scrivente il tenore letterale e il senso logico della norma rende inaccettabile tale conclusione, la quale, peraltro, si fonda sul rispetto di non meglio
specificati parametri costituzionali e comunitari. Appare del tutto evidente
che il legislatore abbia voluto ridurre gli oneri economici a carico delle
aziende conseguenti alla stipula di contratti a termine viziati, non certo che
abbia voluto aggravarli aggiungendo all’ordinario risarcimento del danno
una ulteriore sanzione (in questo senso, Trib. Roma 11 gennaio 2011).
In senso opposto, deve escludersi una ulteriore possibile interpretazione della norma nel senso di sostituire alla conversione l’indennizzo econo-
ADL 1/2011
GIOVANNI MIMMO
101
mico, riproponendo così il meccanismo previsto dall’art. 21, comma 1 bis,
del decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 che
aveva introdotto l’art. 4 bis al d. lgs. n. 368 del 2001, norma poi dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte cost. 17 luglio
2009, n. 214, non già in virtù dell’esclusione della conversione ma sul presupposto della sua applicabilità ai soli giudizi in corso. Il tenore letterale
dell’art. 32, quinto comma (“nei casi di conversione del contratto a tempo
determinato il giudice condanna. . .”) impedisce di leggere la norma nel
senso che la condanna al risarcimento del danno debba sostituire la conversione del contratto, anche perché non vi sono elementi per ipotizzare
che il legislatore abbia voluto introdurre un sistema di rottura con quello
che la stessa Corte Costituzionale nella sentenza appena citata ha individuato quale “diritto vivente”.
Escluso che la soluzione adottata dal legislatore possa essere censurata
per contrarietà alla Costituzione (vedi P. Tosi, op. cit. , il quale rileva che la
scelta di sostituire la disciplina risarcitoria di diritto comune con una disciplina speciale incardinata sulla forfettizzazione del risarcimento, pur essendo discutibile come ogni scelta in tal senso, non può sollevare perplessità di
ordine costituzionale in quanto il legislatore avrebbe potuto anche escludere la trasformazione del rapporto), la stessa non sembra in alcun modo
porsi in contrasto con la direttiva comunitaria n. 70 del 1999 in quanto la
normativa comunitaria non prevede l’adozione di un determinato regime
sanzionatorio, lasciando così al legislatore nazionale la scelta delle conseguenze dell’illegittima apposizione del termine (come evidenziato dalla
Corte di Giustizia nelle sentenze Mangold del 22 novembre 2005, Adeneler
del 4 luglio 2006 e Angelidaki del 22 aprile 2009 la direttiva neppure nell’ipotesi di successione di contratti a termine impone agli Stati di adottare la
conversione del rapporto). Né apparirebbe pertinente il richiamo alla clausola di non regresso contenuta nella clausola n. 8) par. 3 della direttiva secondo la quale “L’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso” in quanto il divieto di riduzione del livello generale di tutela offerto ai lavoratori è testualmente circoscritto “all’ambito coperto dall’accordo stesso” e, come affermato dalla Corte di Giustizia
nella sentenza Mangold (sentenza 22 novembre 2005 C-144/04) “una reformatio in peius della protezione offerta ai lavoratori nel settore dei contratti a
tempo determinato non è in quanto tale vietata dall’accordo quadro se non è in alcun modo collegata con l’applicazione di questo”, principio ribadito nelle sentenze del 22 aprile 2009 Angelidaki e del 24 giugno 2010 Sorge e nelle ordinanze del 24 aprile 2009 Koukou e del 11 novembre 2010 Vino. Pertanto,
la clausola non preclude al legislatore nazionale di introdurre discipline
ADL 1/2011
102
PARTE PRIMA . SAGGI
che, nel rispetto dei principi dettati dalla direttiva e al di fuori dell’esigenza
di applicare l’accordo quadro, riducano il livello di tutela in favore del lavoratore. In ogni caso, sul punto si deve precisare che l’art. 32, quinto comma,
non incide su una precedente disciplina normativa, in quanto nessuna norma (salva l’ipotesi peculiare di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 368 del 2001) faceva riferimento alle conseguenze dell’illegittima apposizione del termine, essendo, come ampiamente visto, quello della conversione e del risarcimento
del danno dalla messa in mora, mere interpretazioni giurisprudenziali, seppure ormai ampiamente consolidate. Pertanto, non sembra neppure corretto affermare che la norma in questione nel prevedere la conversione del
contratto a termine e la condanna del datore di lavoro al pagamento di un
indennizzo determinato nel massimo e nel minimo abbia introdotto una disciplina deteriore rispetto a quella preesistente, sia perché le interpretazioni giurisprudenziali possono evolversi nel tempo, sia perché l’indennizzo
previsto dal legislatore (da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità), può essere anche un ristoro più favorevole per il lavoratore rispetto al risarcimento danno per mora accipiendi nelle ipotesi in cui non vi sia la messa
in mora ovvero nelle ipotesi di altra occupazione, dovendo in tal caso al risarcimento essere detratto l’aliunde perceptum. Infatti, l’indennità di cui al
quinto comma è dovuta anche in assenza di un danno.
3.2. – Il riferimento contenuto nell’art. 32, quinto comma, della legge n.
183 del 2010 al “contratto a tempo determinato” induce a ritenere che la
norma trovi applicazione non solo ai contratti a termine stipulati ai sensi
della disciplina di cui al d. lgs. n. 368 del 2001 (ovvero anche ai sensi della
normativa previgente), ma anche ad ogni tipologia di contratto a termine
comunque disciplinato, per cui, per esempio, anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. 10
settembre 2003 n. 276 ovvero alle ipotesi sottratte alla applicazione del d.
lgs. n. 368 del 2001. Infatti, mentre i commi terzo e quarto dell’art. 32 fanno
esplicito riferimento ai contratti a termine stipulati ai sensi del d. lgs. n. 368
del 2001, tale rinvio alla norma manca nel quinto comma, facendo la norma
esclusivamente riferimento “ai casi di conversione del contratto a tempo
determinato” con la conseguenza che essa trova applicazione a tutte le ipotesi in cui il giudice sia chiamato a convertire un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
In senso opposto, con sentenza del 21 dicembre 2010 il Tribunale di Napoli ha escluso l’applicazione della norma ad un contratto a termine stipulato da personale marittimo, rilevando che la stessa trova applicazione unicamente ai contratti a termine stipulati ai sensi del d. lgs. n. 368 del 2001.
Il settimo comma dell’art. 32, dispone che la disciplina del quinto com-
ADL 1/2011
GIOVANNI MIMMO
103
ma si applichi non solo ai contratti a termine già stipulati e già conclusi e
non ancora impugnati, ma anche ai contratti a termine la cui legittimità sia
stata contestata davanti al giudice e in relazione ai quali il giudizio sia ancora pendente: la norma, infatti, dispone che le previsioni di cui ai commi 5
e 6 trovino applicazione “a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, la norma trova applicazione a decorrere dal 24 novembre 2010 nei confronti di tutti i contratti a termine, siano essi impugnati o da impugnare, con l’unica ovvia eccezione dei contratti in relazione ai quali sia intervenuta una sentenza definitiva.
Rileva A. Vallebona, op cit. , pag. 8 che l’efficacia retroattiva appare legittima essendo assolutamente ragionevole che il regime speciale introdotto dal legislatore investa anche il passato, proprio per rimediare ai guasti che
deriverebbero da una ulteriore applicazione della disciplina previgente.
In senso opposto, con ordinanza del 20 dicembre 2010 il Tribunale di
Trani ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 32, commi quinto, sesto e settimo, della
legge n. 183 del 2010 con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 11 e 117 della Costituzione sotto i seguenti profili: a) irragionevolezza dell’estensione
dei criteri di liquidazione del danno adottati con riferimento ai licenziamenti illegittimi intimati nell’area di stabilità obbligatoria, pur se in quest’ultimo caso manca il diritto del lavoratore alla ricostituzione del rapporto
di lavoro; b) disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie contrattuali a seguito delle quali alla ricostituzione ex tunc del rapporto segue un risarcimento effettivo; c) disparità di trattamento con i lavoratori assunti a termine la cui controversia pende in grado di appello o di cassazione; d) violazione dei limiti di ragionevolezza e di uguaglianza e violazione dell’art. 6 della
CEDU nello stabilire l’applicabilità della norma ai giudizi già instaurati e ancora pendenti (in senso contrario, Trib. Roma 28 dicembre 2010 che ha ritenuto manifestamente infondate le censure di costituzionalità).
L’espresso riferimento “a tutti i giudizi”, con la precisazione “ivi compresi quelli pendenti” porta a ritenere che la norma trovi applicazione a tutti i giudizi, a prescindere dalla fase processuale in cui si trovino, per cui si
applichi anche ai giudizi pendenti in appello e in cassazione, con la conseguenza che in ipotesi di conferma della sentenza di appello che abbia convertito il rapporto di lavoro con risarcimento del danno, sarà necessario
cassare la sentenza con rinvio affinché il giudice di merito quantifichi l’ammontare dell’indennità, circostanza che attenendo ad una valutazione di
merito è preclusa al giudice di legittimità.
Per i giudizi pendenti la norma espressamente dispone che il giudice
fissi alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda ai so-
ADL 1/2011
104
PARTE PRIMA . SAGGI
li fini della determinazione dell’indennità, svolgendo, qualora necessario,
attività istruttoria ai fini dell’individuazione dei criteri per la sua quantificazione, ai sensi dell’art. 421 Cod. Proc. Civ.
L’esplicito riferimento allo svolgimento di attività istruttoria ai sensi
dell’art. 421 Cod. Proc. Civ. , ha indotto parte della dottrina e la prima giurisprudenza formatasi sul punto a ritenere non applicabile la norma ai giudizi pendenti in appello, anche in riferimento alla previsione di integrabilità
di domande ed eccezioni e non dei motivi di impugnazione (vedi in tal senso, A. Vallebona, op cit. , pag. 8, M. Tatarelli, Entità del risarcimento fissata
dal giudice, in Guida al diritto, n. 48, 4 dicembre 2010, pag. 10, secondo il
quale in ogni caso si deve escludere che la norma possa essere applicata in
cassazione, tenuto conto che in tale sede non paiono possibili né modifiche
di domande o eccezioni, né l’esercizio di poteri istruttori e Corte di Appello di Roma sentenza 30 novembre 2010 che ha ritenuto non applicabile la
norma ai giudizi pendenti davanti alla stessa).
La Suprema Corte, con ordinanza del 28 gennaio 2011, n. 2112, ha ritenuto applicabili i commi 5 e 6 dell’art. 32 anche del giudizio di cassazione,
con rinvio della sentenza al giudice di merito affinché, esercitati i poteri
istruttori di cui al comma 7, determini l’indennità spettante, osservando che
la soluzione negativa equivarrebbe a discriminare tra situazioni diverse in
base alla circostanza, del tutto accidentale, di una pendenza della lite giudiziaria in una od altra fase.
La Corte ha chiarito che non può essere condivisa la tesi secondo cui
l’indennità prevista dal quinto comma si aggiunga al risarcimento del danno, in quanto l’espressione “onnicomprensiva” acquista significato solo
escludendo qualsiasi altro credito risarcitorio. Nella stessa ordinanza la Suprema Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5 e 6, per contrasto con gli artt.
3, 4, 24 e 111 Cost. in quanto vanifica il diritto al lavoro e nuoce all’effettività della tutela giurisdizionale con danno che aumenta con la durata del
processo.
La argomentazione non appare condivisibile, in quanto fa prevalere un
elemento accessorio ed eventuale (quello della necessità di integrazione
istruttoria) sul chiaro ed inequivocabile tenore letterale della norma, la
quale con evidenza, secondo la volontà del legislatore, trova applicazione a
tutti i giudizi, dunque anche a quelli pendenti in appello o cassazione. È ovvio che in tal caso il non preciso rinvio all’attività istruttoria di cui all’art.
421 c.p.c. dovrà essere riferito alle modalità di svolgimento di attività istruttoria proprie del grado di giudizio. Del resto una volta che il legislatore abbia previsto l’applicabilità della norma ai giudizi in corso, la limitazione ai
soli giudizi di primo grado apparirebbe del tutto irragionevole.
ADL 1/2011
GIOVANNI MIMMO
105
3.3. – Ovviamente l’art. 32, quinto comma, della legge n. 183 del 2010
non trova applicazione ai contratti a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni, in relazione ai quali vige il principio della non convertibilità
del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sancito dall’art.
36 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
La Corte di Giustizia Europea dopo avere rilevato che la direttiva
1999/70/CE trova applicazione non solo ai rapporti di lavoro nel settore
privato, ma anche a quelli alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ha ritenuto compatibile con la direttiva il suddetto divieto di trasformazione del contratto di cui all’art. 36, purché l’ordinamento preveda adeguate misure risarcitorie volte a sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di
una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (vedi oltre alle
già citate sentenze 22 novembre 2005 Mangold, 4 luglio 2006 Adeneler e
del 23 aprile 2009 Angelidaki, le sentenze del 22 dicembre 2010 Gavieiro,
13 settembre 2007 Del Cerro, 7 settembre 2006 Marrosu e Sordino).
I giudici italiani, applicando i principi dettati dalla Corte di Giustizia
nonché la disposizione di cui all’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 che
espressamente prevede il diritto del lavoratore al risarcimento del danno,
hanno prevalentemente affermato che lo strumento risarcitorio maggiormente idoneo a riparare il danno sofferto potrebbe essere quello delineato
dai commi 4 e 5 dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, cumulando
così le cinque mensilità previste dal quarto comma con le 15 previste a titolo di indennità sostitutiva della reintegra dal quinto comma (vedi Trib. Genova 5 aprile 2007; Corte di Appello di Genova 9 gennaio 2009; Trib. Caltanissetta 7 ottobre 2009).
In questa ottica, l’introduzione di un risarcimento forfettizato operata
dal quinto comma dell’art. 32, potrebbe costituire, pur nella non applicabilità della norma al settore pubblico, un utile parametro risarcitorio in ipotesi di abuso del contratto a termine da parte di una pubblica amministrazione, certamente più pertinente dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: infatti, una volta che il legislatore abbia predeterminato le conseguenze risarcitorie nell’ipotesi di illegittimo ricorso al contratto a termine, le stesse
conseguenze, pur dovendosi escludere la trasformazione del rapporto,
possono essere ritenute applicabili anche ai rapporti di lavoro a termine
con una pubblica amministrazione.
ADL 1/2011
Andrea Allamprese
Ricercatore nell’Università di Modena e Reggio Emilia
LA LEGISLAZIONE DEL LAVORO DEGLI ANNI ’80.
UNA INTENSA STAGIONE RIFORMATRICE
Sommario: 1. La legge n. 56 del 1987 sull’organizzazione del mercato del lavoro. – 2. Le proposte
di legge del Governo per la riforma degli ammortizzatori sociali e la loro anticipata attuazione nella legge n. 160 del 1988. – 3. Il perché e il come delle soluzioni legislative a cavallo degli
anni ’90. La legge n. 108 del 1990 relativa ai licenziamenti individuali. – 4. Segue. La legge n.
223 del 1991 sui licenziamenti collettivi: una normativa « bifronte ». – 5. Segue. La legge n.
146 del 1990 e il problema dei limiti del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
1. – Nella seconda metà degli anni ’80, soprattutto nell’arco della X legislatura, si assiste a un’intensa stagione riformatrice in campo lavoristico
(qualcuno l’ha definita « illuministica ») (1), nella quale un ruolo non secondario viene svolto dai giuristi del lavoro dislocati nelle commissioni
parlamentari (riunendo così nella loro persona la stessa funzione legislativa), negli uffici legislativi ministeriali, nelle commissioni ministeriali incaricate di predisporre schemi di d.d.l. di riforma, nei centri confederali. È proprio l’apporto del « ceto degli operatori giuridici » che favorisce il riaccostarsi del diritto sindacale e del lavoro « alla fonte regolativa eteronoma a
dispetto di un passato orgogliosamente extra-legislativo » (2). L’attivismo
legislativo è ancora sospinto dalla pressione delle forze sociali (soprattutto
sindacale) e riceve uno stimolo dall’accelerazione del processo di integrazione europea (avviata dall’Atto unico del 1987, significativamente coincidente con l’inizio della X legislatura).
La nostra attenzione si soffermerà su alcune delle vicende più rilevanti
di questa stagione. Vi sono alcuni filoni che tendono a sviluppare le politiche per la flessibilità – inaugurate all’inizio della IX legislatura – con riferimento al mercato del lavoro (emblematiche in tal senso sono le leggi n. 56
del 1987 e n. 223 del 1991) (3). E altri, invece, che recepiscono lo spirito « garantista » di stampo più tradizionale (specialmente le leggi n. 108 del 1990 e
n. 125 del 1991, ma anche in parte la legge n. 223 del 1991). Una collocazio(1) F. Carinci, La centralità della legge nella disciplina dei licenziamenti individuali, in Id. (a
cura di), La disciplina dei licenziamenti dopo le leggi 108/1990 e 223/1991, Napoli, I, 1991, pag.
XXIV.
(2) U. Romagnoli, Lavoro e diritto nella X Legislatura, in Lav. Dir. , 1992, pag. 378.
(3) Così F. Liso, L’unitas multiplex delle regole del mercato del lavoro, in Lav. Dir. , 1992, pag.
439.
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
107
ne a parte spetta alla legge n. 146/90, che può essere considerata una versione inedita della legislazione di sostegno delle organizzazioni sindacali.
Con l’approvazione della legge n. 56 del 1987 sull’organizzazione del
mercato del lavoro arrivava a destinazione un altro vagone sganciato dal
convoglio – del quale si è parlato in altra sede (4) – rappresentato dal d.d.l.
governativo n. 665 recante « Norme in materia di servizi dell’impiego, di
mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale . . . », presentato alla Camera dei deputati il 18 ottobre 1983. Si concludeva così un travagliato iter
legislativo (5) nel corso del quale erano state avanzate proposte per una « liberalizzazione » dell’istituto del collocamento. La legge n. 56 non conteneva però nuove misure in tal senso, anche perché in buona parte la « deregolamentazione » era già stata operata con la legge n. 863 del 1984 (di conversione del d.l. n. 726 del 1984). Infatti, la vecchia struttura burocratica
del collocamento (legge n. 264 del 1949) finiva comunque per essere delegittimata dalla possibilità di utilizzare a larghe mani la nominatività della richiesta di avviamento per il contratto di formazione-lavoro (6).
Nella nuova legge vi sono alcuni rilevanti elementi di novità: da un lato,
quello della valorizzazione del principio dell’avviamento su richiesta numerica per le fasce di inquadramento più basse nell’ambito del pubblico
impiego (art. 16) (7); dall’altro, l’elemento della « negozialità » che, già manifestatosi con riferimento al contratto di formazione-lavoro (art. 3, terzo
comma, legge n. 863 del 1984), si concretizza nell’idea delle convenzioni
tra imprese e commissioni regionali per l’impiego (CRI) per programmi di
assunzione (art. 17). Comincia a farsi strada l’idea della negoziazione sul
mercato del lavoro e un contributo in tal senso è costituito anche dall’art.
23, volto al superamento delle causali rigide del contratto di lavoro a tem(4) A. Allamprese, La legislazione del lavoro negli anni ’80. Dal « diritto della crisi » alle politiche per la flessibilità, in Arg. Dir. Lav. , 2010, par. 4.
(5) Il d.d.l. governativo sopra citato ebbe una conclusione anomala per stralcio. Una sorte diversa toccò invece al d.d.l. n. 665-ter recante « Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro », nato dallo stralcio di alcuni articoli del d.d.l.
n. 665 (deliberato dalla commissione lavoro della camera il 24 luglio 1985). Discusso insieme
ad altri progetti concorrenti, il d.d.l. 665-ter fu approvato in un testo unificato il 12 marzo
1986. Dopodiché il testo passo all’altro ramo del Parlamento (Atto senato n. 1744), dove fu assegnato alla commissione lavoro in sede referente (relatore l’on. G. Giugni) e approvato, con
modificazioni, dall’aula di Palazzo Madama il 26 novembre 1986. Tornato alla camera, il d.d.l.
n. 665-ter-B fu approvato definitivamente dalla commissione lavoro in sede legislativa l’11
febbraio 1987 e divenne legge 28 febbraio 1987, n. 56.
(6) Cfr. M.G. Garofalo, L’abrogazione di fatto del collocamento pubblico, in Id. (a cura di),
Crisi, occupazione, legge, Bari, 1985, pag. 5 e segg.
(7) In ciò riprendendo le indicazioni provenienti dal documento del Ministero del lavoro
La politica occupazionale per il prossimo decennio, settembre 1985 (Cap. su Le politiche per la flessibilità, lett. c).
ADL 1/2011
108
PARTE PRIMA . SAGGI
po determinato, attraverso la contrattazione collettiva espressione dei sindacati maggiormente rappresentativi.
D’altra parte, vengono creati o rafforzati gli organi per una gestione attiva del mercato del lavoro: le commissioni circoscrizionali e regionali e le
Agenzie per l’impiego (titolo II) (8).
Certo non mancano limiti e insufficienze (qualcuno ha parlato di una
riforma esangue) (9). Agli organi così creati o rafforzati si affidano strumenti spuntati e, quindi, inidonei ad affrontare l’immane compito che viene loro affidato (10). Basti qualche esempio: l’unico strumento operativo riconosciuto alle Agenzie per l’impiego è un potere di proposta nei confronti della CRI e degli organi regionali anche in funzione del coordinamento
dei rispettivi interventi (art. 24, lett. d): certamente poco rispetto alle aspettative suscitate da un dibattito sia politico che culturale, ricco e serrato, che
si era svolto alcuni anni addietro (11). Quanto alle convenzioni di cui all’art.
17, pur essendo uno strumento auspicato per introdurre nella gestione del
collocamento elementi di flessibilità governata, l’unico incentivo di cui
l’organo pubblico può disporre per indurre le imprese a negoziare è « l’eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica ».
Tuttavia le convenzioni si riveleranno una scelta felice e manifesteranno la loro importanza sul versante del collocamento obbligatorio, dove era
(8) Si dispone il completamento della struttura paritaria delle commissioni circoscrizionali per l’impiego, in coerenza con la logica di « negozialità » che pervade l’area del mercato
del lavoro; si individua la CRI come « organo di programmazione, di direzione e di controllo
di politica attiva del lavoro » e si attribuiscono ad essa nuovi poteri. In particolare, l’art. 5 le
conferisce la facoltà di: porre in essere « operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi ( . . . ) concorrano lavoratori iscritti nelle liste di altre circoscrizioni » (lett. c); quella di « stabilire ( . . . ) modalità diverse per l’iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione » (lett. e); soprattutto, sulla scorta di
quanto già previsto dalla l. n. 140/81, la facoltà di « determinare ( . . . ) procedure per la convocazione e l’avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore » (lett. g). Poi l’art. 25 dispone che la CRI possa « proporre » deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, riservando così ogni decisione al Ministero del lavoro. Per un esame
della legge v. , fra gli altri, M. Napoli, L’organizzazione del mercato del lavoro nella legge n. 56/87,
in Riv. Giur. Lav. , 1987, I, pag. 177; F. Liso, M. Napoli, T. Treu (a cura di), Commentario alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, in Nuove Leggi Civ. Comm. , 1987, pag. 648.
(9) La definizione è di F. Liso, Servizi all’impiego, in Enc. Giur. , Roma, 2007, che pure evidenzia gli elementi di positività presenti nella legge n. 56.
(10) Cfr. M.G. Garofalo, La legislazione in materia di lavoro nel 1986-87, in Dir. Lav. Rel.
Ind. , 1987, pag. 374 e segg.
(11) In aggiunta a quanto detto in A. Allamprese, op. ult. cit. , par. 2, v. P. Lambertucci,
Una « possibile » configurazione dell’agenzia per l’impiego, in Riv. Giur. Lav. , 1984, I, pag. 187.
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
109
rimasta la politica vincolistica (ossia la numericità della richiesta di avviamento) (12).
Mentre l’Agenzia per l’impiego – come già accennato – nasce sottotono (13), venendo a configurarsi nella legge semplicemente come « organo
tecnico progettuale » (art. 24, secondo comma), e quindi come un tentativo di dare alla CRI (di cui « attua gli indirizzi ») maggiori strumenti per elaborare politiche e programmi. Ben poco rimane delle idee sviluppate nella
seconda metà degli anni ’70 sulle Agenzie del lavoro concepite come strumenti per affrontare le eccedenze di personale in maniera attiva.
All’indomani dell’approvazione della legge n. 56 del 1987, le Regioni
aprirono una trattativa, dapprima con il Ministro del lavoro De Michelis e
poi con il suo successore Formica. Su iniziativa di quest’ultimo e sollecitazione delle Regioni fu costituito, nel dicembre del 1987, un comitato di studio misto Stato-Regioni (14), chiamato a pronunciarsi su una prima bozza
di decreto interministeriale di istituzione e regolamentazione delle Agenzie (15). Una seconda bozza, frutto del lavoro di un gruppo di esperti nomi-
(12) Unendo lo strumento delle convenzioni con la facoltà – riconosciuta in via sperimentale dal legislatore – di chiedere allentamenti della disciplina vincolistica (art. 25 cit. ), le CRI
cominciarono a concordare programmi di assunzione mirata. Per una ricognizione delle delibere regionali nelle quali si iniziavano a sperimentare forme di assunzione mirata nel collocamento obbligatorio v. A. Ramovecchi, Politiche per l’inserimento e l’integrazione delle persone con
handicap. , in Riv. Inf, 1997, I, pag. 39.
(13) Cfr. sul punto L. Mengoni, Il dibattito sulla revisione della legislazione del lavoro, in Riv.
It. Dir. Lav. , 1988, I, pag. 4. Vale la pena ricordare che tutto il gruppo democristiano del senato chiese la soppressione del titolo II del d.d.l. n. 1744 (relativo all’istituzione delle Agenzie
per l’impiego), evidentemente ritenendo che quell’organismo potesse togliere ruolo e potere
al collocamento.
(14) Il comitato di studio comprende alcuni autorevoli giuristi: A. D’Harmant François,
F. Liso, M. D’Antona, T. Treu, F. Carinci, P.A. Varesi. La gran parte di questi peraltro, sul finire degli anni ’80, animerà un gruppo di studio costituito dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro dell’Emilia-Romagna e coordinato da F. Carinci, con l’incarico di approfondire gli aspetti istituzionali, organizzativi, e operativi delle istituende Agenzie. I risultati dell’attività di questo gruppo sono leggibili in F. Carinci (a cura di), L’agenzia regionale per l’impiego, Napoli, 1990.
(15) La posizione dei sindacati, decisamente critica rispetto alla suddetta bozza di decreto la quale incardinava strettamente le Agenzie dentro al sistema ministeriale, è espressa nel
documento Legge n. 56/1987. Costituzione delle Agenzie per il lavoro (artt. 24-30). La proposta di
Cgil, Cisl, Uil, 9 febbraio 1988, dattiloscritto. Infatti le confederazioni auspicavano un’Agenzia
idonea a fornire servizi qualificati sul territorio, dotata di personalità giuridica e di un’autonomia finanziaria, patrimoniale e amministrativa. Al contrario nella bozza di decreto si affermava che: « L’Agenzia è organo periferico del Ministero del lavoro »; « il dirigente dell’UPLMO
della città sede dell’Agenzia provvede alla liquidazione delle spese connesse con le attività
dell’Agenzia stessa, secondo quanto elaborato dalla CRI, nell’ambito dello stanziamento destinato al funzionamento dell’Agenzia e accreditato su apposita voce presso l’UPLMO medesimo ».
ADL 1/2011
110
PARTE PRIMA . SAGGI
nato all’interno del suddetto comitato di studio, venne approvata nel maggio 1988. L’Agenzia vi era scolpita come organismo facente capo direttamente al Ministero del lavoro, destinato a svolgere una funzione tecnicoprogettuale in contesti caratterizzati dalla presenza e dall’attività delle Regioni (16).
2. – È importante, in questo periodo, l’iniziativa portata avanti dal Ministro De Michelis con le parti sociali per mettere a punto un altro dei contenuti del già citato d.d.l. n. 665 del 1983: la riforma degli ammortizzatori
sociali.
Uno schema di d.d.l. in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità
e trattamento di disoccupazione – frutto di una lunga elaborazione in sede
ministeriale iniziata nel 1984 – fu presentato alle organizzazioni sindacali il
6 giugno del 1986, all’interno di un « pacchetto » di proposte comprendente
anche una bozza di d.d.l. in tema di azioni positive. Sui contenuti del suddetto schema cominciò una fase di negoziazione con le parti sociali (17).
Figlio di questa elaborazione ministeriale e di questa negoziazione tra
governo e parti sociali fu il d.d.l. n. 4422 recante « Norme in materia di integrazione salariale, di eccedenze di personale e di trattamento di disoccupazione », presentato alla camera dei deputati il 9 febbraio 1987. L’iter del
d.d.l. fu interrotto dall’anticipata fine della IX legislatura. Il lavoro fatto non
andò perso. Il testo, sul quale era stata laboriosamente raggiunta un’intesa
con le parti sociali (18), fu riproposto dal Ministro Formica nella legislatura
(16) Per un’illustrazione della seconda bozza di decreto e sulla successiva fase della decretazione interministeriale diretta a istituire le Agenzie si rinvia a F. Carinci, Preistoria, storia
e. . . prima cronaca delle agenzie regionali per l’impiego, in Id. (a cura di), L’agenzia regionale per
l’impiego, op. cit. , pag. 21 e segg.
(17) La posizione delle confederazioni sui suddetti temi è espressa nel Documento Cgil,
Cisl, Uil per il confronto con il governo, 7 aprile 1986, dattiloscritto. Il documento individua una
serie di interventi prioritari quali: la riforma dell’indennità ordinaria di disoccupazione; la riconduzione del trattamento straordinario di integrazione salariale alla sua finalità originaria;
l’introduzione di un’indennità di mobilità, per una massimo di tre anni entro i quali garantire
una mobilità effettiva ai lavoratori che, dopo un anno di Cigs e di contrattazione per il loro riassorbimento, risultino eccedenti; l’omogeneizzazione di criteri, tempi e quantità dell’indennità di disoccupazione speciale fruita dai lavoratori in mobilità (cfr. il paragrafo su Mercato del
lavoro e sostegno ai redditi).
(18) È questo il ricordo di uno dei testimoni intervistati nel corso della ricerca, allora a capo dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro: « Nonostante la rottura di S. Valentino,
continuò l’opera di tessitura del governo con tutte le parti sociali. Ho la convinzione che gran
parte della logica dei rinvii legislativi all’autonomia collettiva venga sviluppata in quel periodo
proprio con la finalità di alimentare il dialogo tra le parti sociali. È con De Michelis che si definisce gran parte del contenuto del progetto che sarà poi portato avanti sul piano parlamentare da Formica. Anche se la l. n. 223 va in parto nel 1991, è però l’intero impianto legislativo a
essere preconfezionato al tavolo negoziale. E qui si realizza uno scambio significativo. Dal
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
111
successiva (19) e, quasi nella sua integrità, divenne – dopo un accidentato
iter legislativo – legge (la n. 223 del 1991) (20).
Con la caduta del governo Craxi (il 9 aprile 1987) e il passaggio alla X
legislatura, alcune delle soluzioni che il Ministro De Michelis aveva condiviso con le parti sociali – nella prospettiva di una razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali – troveranno una loro anticipata realizzazione. Una delle partite di scambio con il sindacato, quella dell’indennità di disoccupazione, venne inserita nell’art. 20 del d.d.l. n. 585 e fu poi
stralciata trovando collocazione nella legge n. 160 del 1988 (di conversione del d.l. n. 86 del 1988) (21). Con questa legge, fra l’altro, si cominciava a
percentualizzare il valore della prestazione di disoccupazione (che prima
punto di vista della sostanza politica, il sindacato accettò di abbandonare talune posizioni
che non sembravano più difendibili: il collocamento numerico e la pratica di una Cigs utilizzata in funzione assistenzialistica per il mantenimento in vita di eccedenze di carattere
strutturale, che portavano a configurare quell’istituto come un equivalente funzionale del
trattamento di disoccupazione. In cambio, sul primo versante, ottenne il meccanismo delle
“quote riservate”, che sembrava avere una probabilità maggiore di effettività rispetto al precedente sistema; sul secondo versante, ottenne che la mobilità – il cui significato, nel nuovo
contesto, veniva a subire una profonda modificazione, sostanziandosi in una mobilità in
uscita – fosse accompagnata da corpose tutele per i lavoratori: in primis l’indennità di mobilità, alla quale si cominciò a collegare l’idea della necessaria messa in opera di politiche attive volte a promuovere il reinserimento del lavoratore licenziato. De Michelis, in questo
quadro di carattere generale, accettò anche di accogliere le forti pressioni provenienti dal
sindacato su un altro versante. Le organizzazioni sindacali, nel momento in cui si dichiaravano disponibili nei confronti del governo a una razionalizzazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale ed a porre un freno alla balcanizzazione delle protezioni contro la disoccupazione, chiesero la revisione dei trattamenti di disoccupazione in agricoltura
(al fine di contenere il lavoro sommerso, che quel sistema alimentava) e l’estensione di un
trattamento di disoccupazione analogo ai lavoratori precari del settore extra-agricolo, privi
di copertura. Nella prospettiva del sindacato si trattava, nel momento in cui ci si preoccupava di tutelare i lavoratori stabili, di corrispondere alle esigenze di copertura anche dei lavoratori stagionali e discontinui. Per De Michelis si trattò di una partita di scambio che concesse per favorire il raggiungimento del complessivo quadro di razionalizzazione che si era
proposto di realizzare » (F. Liso, citazione tratta da un protocollo di intervista registrata in
incontri svoltisi fra i mesi di aprile e luglio 2010).
(19) Ci riferiamo al d.d.l. recante « Norme in materia di mercato del lavoro », presentato al
Parlamento il 24 ottobre 1987 (Atto Senato n. 585), e spec. al Titolo III del d.d.l. rubricato
« Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale ».
(20) Cfr. F. Liso, Le nuove regole, in Aa. Vv. , La politica economica italiana negli anni ‘80, Venezia, 2005, pag. 158.
(21) Sul fronte delle politiche attive del lavoro, il Titolo II del d.d.l. n. 585 (contenente
norme riguardanti l’impiego di giovani in « attività di utilità collettiva » nel Mezzogiorno)
– che riproponeva i contenuti di un d.d.l. presentato dal governo nella IX legislatura (Atto Camera n. 2195) – trovò anch’esso una sua anticipata realizzazione nell’art. 23 della legge finanziaria n. 67 del 1988.
ADL 1/2011
112
PARTE PRIMA . SAGGI
era in cifra fissa e non era stata aggiornata) (22); si razionalizzavano alcuni
profili del trattamento di disoccupazione nel settore agricolo e si estendeva questa prestazione con i requisiti ridotti anche al settore extra-agricolo,
elevando però a 78 giorni all’anno l’attività lavorativa minima per avere diritto al trattamento (art. 7, legge n. 160) (23). Solo in seguito – come appena
detto – si arriva a completare il disegno di riforma degli ammortizzatori sociali con l’approvazione della legge n. 223 del 1991.
3. – La stagione riformatrice di cui si parlava all’inizio entra nel vivo con
la legge n. 108 del 1990 in tema di licenziamenti individuali, cui fa seguito
la legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che
rappresenta uno degli esempi più evidenti di « gestazione » sindacale di
una normativa (24); mentre l’attività della X legislatura culmina nella legge
n. 223 del 1991 in tema di cassa integrazione, mobilità, licenziamenti collettivi e regime delle assunzioni. In questo anno – e per la medesima ispirazione « garantista » delle due leggi del 1990 – viene emanata la legge n. 125
sulle azioni positive per la parità uomo-donna (attuativa di Direttive comunitarie), della quale non ci occuperemo in questa sede (25).
Ognuna delle leggi di cui ci occuperemo nel prosieguo, d’altra parte,
(22) Cfr. G.G. Balandi, Tutela del reddito e mercato del lavoro, Milano, 1984, pag. 79 e segg.
Poco prima dell’approvazione della l. n. 160 intervenne la sentenza della Corte Costituzionale
27 aprile 1988, n. 497 (in Riv. Giur. Lav. , 1988, II, pag. 234, con nota di Boer), con la quale fu
dichiarata l’illegittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost. , dell’art. 13
del d.l. n. 30 del 1974 (convertito nella legge n. 114 del 1974), nella parte in cui fissava in lire
800 al giorno la misura dell’indennità di disoccupazione ordinaria, senza prevedere un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.
(23) Sul significato delle modifiche apportate nel 1988 alla disciplina del trattamento di
disoccupazione v. , fra gli altri, F. Liso, L’unitas multiplex ecc. , op. cit. , pag. 453 e segg.; cfr. anche per riferimenti, da ultimo, M. Miscione, Gli ammortizzatori sociali per l’occupabilità, in Dir.
Lav. Rel. Ind. , 2007, pag. 703. Per un tentativo di riflessione sull’esperienza applicativa della l.
n. 160 v. Aa. Vv. , Indennità di disoccupazione, Cnel, Documenti, n. 61, Roma, 1995.
(24) Così T. Treu, relazione tenuta al convegno su «Lavoro e diritto nella X legislatura»
(Ferrara, 11 e 12 aprile 1992), in Lav. Dir. , 1992, pag. 391.
(25) Un d.d.l. sulle azioni positive fu presentato in Parlamento il 30 ottobre 1987 (Atto Camera n. 1818). Il testo – elaborato in sede ministeriale con la consulenza del comitato nazionale per la parità (di cui facevano parte, in qualità di esperti, M.V. Ballestrero e T. Treu) – riprendeva i contenuti di un d.d.l. governativo presentato al senato nella IX legislatura. Il d.d.l.
n. 1818 stazionò alla camera per tre anni prima di essere approvato il 21 dicembre 1990 in testo unificato con altre proposte di legge. Da quel momento, l’iter legislativo subì un’accelerazione. Il testo (che nel frattempo assumeva il n. 2602) venne approvato dalla commissione lavoro del senato, in sede deliberante, il 14 marzo 1991. Nuovamente trasmesso alla camera, il
d.d.l. 1818/B fu approvato definitivamente dalla commissione lavoro, in sede legislativa, il 20
marzo 1991 e divenne l. 10 aprile 1991, n. 125. Per un esame del testo del d.d.l. n. 1818 v. M.V.
Ballestrero, Le azioni positive in Italia e le ragioni di una legge probabile, in Lav. Dir. , 1988, pag.
472 e segg.
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
113
costituiva – per così dire – la punta svettante dell’iceberg: dietro la legge n.
146 si agitava la problematica della rappresentatività sindacale e dei suoi
rapporti con i diritti primari, esemplificata dalla figura del contratto collettivo sulle prestazioni minime indispensabili; dietro la legge n. 108 si agitava la problematica dell’impresa rete, e dunque di una tendenziale universalità e parità di diritti dei lavoratori nonché responsabilità diffusa dell’iniziativa imprenditoriale articolata e decentrata; e dietro la legge n. 223 si agitava la problematica della ristrutturazione del sistema industriale, ma altresì
quella della « terziarizzazione » dell’economia e dunque di una riforma
complessiva degli ammortizzatori sociali (26).
In questa fase convivono, all’interno della maggiore delle tre confederazioni « storiche », opinioni differenti che si evidenziano anche nelle scelte di politica del diritto e che si possono schematizzare in due « anime »: l’una orientata alla nuova idea di « modernizzazione » che viene affermandosi
nella società e nelle scelte di politica economica e sociale; l’altra (rappresentata anche dalla maggior parte dei giuristi che poi confluiranno nella
consulta giuridica della Cgil) critica verso il restringimento dei diritti individuali e verso alcuni aspetti degli accordi di tipo gestionale, che – secondo
questa opinione – avrebbero portato il sindacato a ridimensionare la sua
base sociale. In questa situazione, emersero due esigenze: da un lato, dare
una risposta all’interrogativo che si riproponeva tutti i giorni: « chi rappresenta chi »; dall’altro, ristabilire una rete di diritti individuali dei lavoratori
all’interno della quale avrebbe dovuto collocarsi ogni politica di flessibilizzazione. Questo discorso sui diritti immediatamente diventava il problema
dell’universalità dei diritti. Sicché, in definitiva, il binomio sul quale la consulta giuridica della Cgil iniziò ad operare sin dalla sua nascita (1987) fu
quello della democrazia sindacale e dell’universalità di tutela (27). Nasceva,
in tal modo, la necessità di fare una ricognizione delle situazioni nelle quali si produceva una mortificazione dei diritti dei lavoratori e sindacali, da
cui partire alla ricerca di soluzioni riformatrici che pervenissero a quegli
obiettivi (28). Tant’è vero che, quando la consulta giuridica si riunì per la
(26) Sarà all’interno dell’accordo triangolare del 23 luglio 1993 che verrà assunto l’impegno di estendere gli ammortizzatori sociali al settore terziario: cfr. il paragrafo sulle Politiche
del lavoro, lett. e).
(27) Su quest’ultimo aspetto cfr. M.G. Garofalo, Per una politica dei diritti dei lavoratori
nella piccola impresa (testo della relazione tenuta all’assemblea della consulta giuridica della
Cgil, Roma 7 aprile 1988), in Riv. Giur. Lav. , 1988, I, pag. 393. Peraltro l’esigenza di recuperare un meccanismo di protezione universalistico sarà alla base della già citata legge n. 160 del
1988 di riforma del trattamento ordinario di disoccupazione.
(28) Un contributo al dibattito lavoristico dell’epoca è fornito dal primo volume collettaneo promosso dalla consulta giuridica: Aa. Vv. , Un progetto per il diritto del lavoro. , Roma, 1991
(con contributi di Mariucci, D’Antona, Caruso, D’Alessio, Carinci, M.G. Garofalo, Sciar-
ADL 1/2011
114
PARTE PRIMA . SAGGI
prima volta nell’autunno del 1987, il suo impegno fu la suddivisione dello
scibile con la formazione di una serie di commissioni tematiche.
L’input decisivo per l’emanazione della legge n. 108 del 1990 divenne la
necessità politica di evitare qualche effetto giudicato abnorme della preventiva approvazione di un imminente referendum abrogativo del richiamo
all’art. 18 contenuto nel successivo art. 35 dello Statuto dei lavoratori (29);
ma la legge stessa si inseriva nella tematica allora molto dibattuta del decentramento produttivo, non divenuto ancora fenomeno di delocalizzazione al di fuori dei confini nazionali (30).
Il 2 luglio 1987 fu presentata una proposta di legge (unico firmatario
l’on. Piro) recante « Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e
norme relative all’applicazione della l. n. 300/70 » (Atto camera n. 190);
questa riproponeva quasi alla lettera un disegno di legge presentato il 17 ottobre 1985 dal sen. G. Giugni (Atto Senato n. 1537) al fine esplicito di dare seguito alle proposte formulate dal Cnel nel documento Osservazioni e
Proposte sulla revisione della legislazione sul rapporto di lavoro (31). Il d.d.l.
Giugni restringeva l’area coperta dalla cd. tutela reale contro i licenziamenti ingiustificati ai datori che occupassero più di 80 dipendenti (art. 8);
in contropartita, si estendeva una versione inedita della cd. tutela obbligatoria a categorie di lavoratori allora prive di protezione: in caso di licenziamento annullato, il datore di lavoro che occupasse più di 19 e fino a 80 dipendenti, in alternativa alla reintegrazione del lavoratore disposta dalla
ra, Alleva, Smuraglia, Ventura, Ferraro, Mazzamuto, Garilli, Bellavista, Balandi, Alessi, Galasso, Veneziani).
(29) In tal senso G. Ghezzi, Diritto sindacale e del lavoro, in P. Grossi (a cura di), Giuristi
e legislatori, Milano, 1997, pag. 121. Con la sentenza n. 65 del 1990 la Corte Costituzionale dichiarò la « chiarezza, univocità e omogeneità » di uno soltanto dei tre quesiti referendari promossi da Democrazia proletaria nello stesso anno per realizzare – attraverso l’abrogazione
contestuale dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, dell’art. 11 della legge stessa e del richiamo
all’art. 18 contenuto nel primo comma dell’art. 35 della legge n. 300 del 1970 – la generalizzazione del regime di stabilità reale anche nei confronti delle piccole imprese. La proposta
referendaria, ove fosse stata approvata, avrebbe prodotto l’abrogazione di una porzione di
un sistema normativo complesso, rendendo indispensabile una ricostruzione interpretativa
del sistema alla luce dei nuovi rapporti fra l’art. 18 della legge n. 300 del 1970 e le disposizioni sul campo di applicazione della legge n. 604. La prova referendaria fu scongiurata, appunto, dalla promulgazione di una legge, la n. 108 del 1990, che andava nella direzione del quesito referendario superstite. Su queste vicende v. P. Sandulli, A. Vallebona, C. Pisani, La
nuova disciplina dei licenziamenti individuali, Padova, 1990, pagg. 6-8.
(30) Cfr. M.G. Garofalo, La nuova disciplina dei licenziamenti individuali: prime osservazioni (testo della relazione tenuta all’assemblea della consulta giuridica della Cgil, Roma 14 giugno 1990), in Riv. Giur. Lav. , 1990, I, pag. 170 e segg.
(31) Così espressamente nella Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1537. Il suddetto documento del Cnel – approvato con il solo voto contrario dei rappresentanti delle imprese industriali il 4 giugno 1985 – è leggibile in Riv. It. Dir. Lav. , 1985, I, pag. 416.
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
115
sentenza avrebbe potuto corrispondergli una indennità pari a 36 mensilità
di retribuzione (art. 9).
La proposta n. 190 iniziò il suo iter in commissione lavoro, in sede referente, nel novembre 1987 e venne in seguito abbinata ad altre quattro proposte di legge. Due di queste furono avanzate dall’on. G. Ghezzi: la più ampia per contenuti, la n. 2324 presentata alla camera l’11 febbraio 1988 (32),
riprendeva un testo di legge predisposto da giuristi vicini al sindacato
(« Carta dei diritti dei lavoratori nelle piccole imprese »); la seconda proposta, la n. 4446 del 21 dicembre 1989, si ispirava alle disposizioni di cui ai
primi articoli del progetto 2324 e al progetto sindacale unitario sui diritti
dei lavoratori della piccola impresa reso pubblico il 10 marzo 1988, mutuando altresì alcune previsioni dalla proposta n. 3301 (avanzata dal deputato
del gruppo socialista Cavicchioli).
Della proposta « massimalista » di estensione generalizzata della tutela
reale, il progetto n. 2324 accoglieva il principio dell’universalità della tutela contro i licenziamenti illegittimi, che costituiva una risposta alla tendenza alla fuga verso la piccola dimensione decentrata, priva allora di qualsiasi
garanzia nell’ipotesi in cui l’unità produttiva contasse meno di 16 dipendenti e l’impresa nel suo insieme meno di 35 (33). Il postulato dell’universalità della tutela contro il licenziamento (34) aveva un contraltare nel carattere solo « obbligatorio » della stabilità nelle imprese di dimensioni minori che occupassero da cinque a 15 lavoratori (art. 2 della proposta di legge n. 2324, che riscrive l’art. 8 della legge n. 604 del 1966) (35).
(32) La proposta, recante « Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi », è leggibile
in Riv. It. Dir. Lav. , 1988, III, pag. 187.
(33) Si erano da poco placate le polemiche seguite alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un. , 17 ottobre 1983, n. 6068 (in Foro It. , 1984, I, pag. 143), la quale, contraddicendo
una giurisprudenza che pareva stabile (cfr. , ad es. , Cass. , Sez. Un. , 9 marzo 1983, n. 1756),
aveva affermato, per l’applicabilità della reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo, la necessità del doppio limite: il numero minimo di 16 addetti nell’unità
produttiva e di 35 addetti nell’intera impresa.
(34) Al quale già si ispirava la proposta di legge d’iniziativa popolare promossa nel maggio
1981 dalla Federazione Cgil, Cisl, Uil, intitolata « Norme sui licenziamenti individuali e sull’attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di sedici occupati » (in Gazz. Uff. 19 maggio
1981, n. 135).
(35) Ma, nel progetto n. 2324, ciò era poi controbilanciato da una rete di responsabilità
solidale, che abbracciava tutte le imprese ricomprensibili in un medesimo gruppo (cfr. art. 7),
anticipandosi sin da allora il concetto che altro è l’« impresa » come iniziativa economica, altro
sono le « imprese » e cioè i soggetti giuridici attraverso i quali essa (l’« impresa »), anche se unitaria, può essere – per varie ragioni – condotta in concreto; e che pertanto, se una graduazione delle tutele può essere predicata come opportuna e necessaria in relazione a una dimensione quantitativa, la dimensione da considerare è quella dell’« impresa » e non dei singoli soggetti imprenditoriali giuridicamente distinti che ad essa contribuiscono. Cfr. M.G. Garofalo,
La nuova disciplina dei licenziamenti individuali, op. cit. , pag. 173.
ADL 1/2011
116
PARTE PRIMA . SAGGI
Il testo unificato delle cinque proposte di legge concorrenti (nn.
2324-190-1096-3301-4446) – elaborato da un comitato ristretto in seno
alla commissione lavoro – ricevette il via libera della camera l’11 aprile
1990. A spingere per un rapida approvazione della legge erano anche le
confederazioni Cgil, Cisl e Uil, che tallonarono l’iniziativa parlamentare
in varie forme. Dopodiché il testo passò al senato (Atto senato n. 2239),
dove fu approvato dalla Commissione lavoro in sede legislativa il 10 maggio 1990.
Naturalmente la contingenza politica, e anche la necessità di approvare
rapidamente una legge che impedisse il referendum, portarono nella redazione del testo unificato a talune scelte normative compromissorie (36) ed
al mancato accoglimento della parte, certamente qualificante, della proposta di legge n. 2324 dedicata all’impresa rete (artt. 7-10) (37), con la compensazione di « aggiustamenti » di non poco conto con riguardo: ai licenziamenti discriminatori, ai quali è sempre applicabile l’art. 18 della legge n.
(36) Nella misura in cui, ad es. , il suddetto testo, da un lato, estende l’obbligo della motivazione del licenziamento anche ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze fino a
15 lavoratori (cfr. art. 2, primo comma, d.d.l. n. 2239), dall’altro, indebolisce il regime sanzionatorio nell’area della cd. tutela reale (art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970, comma riformulato da quello che diventerà l’art. 1 della legge n. 108 del 1990): cfr. U. Romagnoli, La
tutela contro i licenziamenti: un passo avanti e due indietro?, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. , 1990, I,
pagg. 1220-1221; in termini, da ultimo, G. Ferraro, Gli anni ’80: la dottrina lavorista dalla marcia dei quarantamila a Maastricht, in P. Ichino (a cura di), Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana . . . , Milano, 2008, pag. 246. La vicenda è così ricostruita, in alcuni particolari, da uno dei
testimoni intervistati nel corso della ricerca: « In quella affrettata redazione non mancarono
gli infortuni anche gravi, ancorché dovuti al classico “naso di Cleopatra”: una banale influenza dell’on. Ghezzi impedì che fosse presidiato, nella riscrittura dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il fondamentale concetto – già accolto dalle Sez. Un. della Cassazione nella sentenza
n. 2925 del 1988 – che gli importi dovuti dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che
ordina la reintegrazione del lavoratore licenziato costituivano retribuzione e non già risarcimento del danno per mancata retribuzione. Dal ché poi è derivato lo “svuotamento” della tutela reale dovuto alle massime giurisprudenziali sulla deduzione dell’aliunde percepito o percepibile in sede di computo del risarcimento dovuto al lavoratore, nonché sulla restituzione
delle somme incassate dal lavoratore stesso in caso di riforma della sentenza in appello, entrambe dedotte – come si sa – dall’asserita natura risarcitoria dell’attribuzione spettante al lavoratore reintegrato » (P. Alleva, citazione tratta da un protocollo di intervista registrata in incontri svoltisi fra i mesi di dicembre 2009 e febbraio 2010).
(37) Cfr. U. Romagnoli, op. ult. cit. , pag. 1219. Peraltro il progetto n. 2324 prevedeva la
possibilità per le imprese artigiane – operanti nel cd. « indotto » dell’impresa committente – di
beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria quante volte le contrazioni
o sospensioni della loro attività fossero determinate da analoghe vicende che giustificassero
l’intervento della Cigs riguardo alla seconda (art. 12, commi 1, 4 e 5). La nozione di « indotto »
veniva precisata a questo scopo, facendosi riferimento a un indicatore di agevole individuazione, consistente nell’esistenza di un « influsso gestionale prevalente » di un’impresa sull’altra. Queste previsioni saranno riprese nell’art. 12 della legge n. 223 del 1991.
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
117
300 del 1970 (art. 3 del d.d.l. n. 2239); ai datori di lavoro non imprenditori
equiparati agli imprenditori, con l’importante eccezione delle organizzazioni non imprenditoriali di tendenza cui non si applica l’art. 18 dello Statuto (artt. 1, 2 e 4, d.d.l.); all’innesto – nell’iter processuale che, in caso di
contestazione, deve condurre ad accertare l’esistenza o no di una giusta
causa o di un giustificato motivo di licenziamento di un lavoratore dipendente da una impresa rientrante nell’area della tutela obbligatoria – di una
fase di conciliazione ed eventualmente di arbitrato (art. 5); e, infine, a un
perfezionamento della tutela di cui all’art. 18 dello Statuto con la previsione della facoltà del prestatore di lavoro, vittorioso in causa ma non più interessato a riprendere una collaborazione ormai compromessa dall’arbitrio
compiuto dalla controparte, di trasformare il diritto alla reintegrazione nel
diritto a un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione (art. 18, quinto
comma, legge n. 300 del 1970, comma riformulato da quello che diventerà
l’art. 1 della legge n. 108 del 1990; la previsione di un’indennità forfettaria
era già nell’art. 8 del d.d.l. n. 1537). Previsione, quest’ultima, nella quale
non era da intravedere una banale « monetizzazione » della tutela contro i
licenziamenti arbitrari (38).
Gli Atti parlamentari testimoniano, pertanto, il parziale recepimento, da
parte della legge n. 108 del 1990, di molte tra le norme più rilevanti formulate nelle proposte di legge presentate dai giuristi-parlamentari Giugni e
Ghezzi. Alcuni spunti non trovarono accoglimento (39). Ad esempio, la razionalità delle proposte (art. 4 del progetto n. 2324; art. 8 del progetto n.
3301; art. 3 del progetto n. 4446) volte a indicare altri requisiti, oltre quello del numero dei dipendenti, come quelli della potenzialità economica e
del capitale investito, da utilizzarsi per misurare l’entità dell’impresa (e/o
dell’unità produttiva) non sfondò. La scelta a favore del parametro occupazionale finì per prevalere (40).
(38) Sulla ratio della attribuzione al lavoratore della facoltà in discorso v. , fra gli altri, M.
D’Antona, Art. 1 – La reintegrazione. III), in R. De Luca Tamajo, M. D’Antona (a cura di), Commentario alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in Nuove Leggi Civ. Comm. , 1991, pag. 171.
(39) Vedasi F. Mazziotti, I licenziamenti dopo la l. 11 maggio 1990, n. 108, Torino, 1991, pag. 4.
(40) D’altra parte, sia il progetto Giugni sia quelli avanzati da Ghezzi proponevano tutti il
superamento della distinzione tra datore nel suo complesso e unità produttiva: i limiti dimensionali ai fini dell’applicazione della sanzione dell’art. 18 erano, infatti, riferiti unicamente al
datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore. Nella legge n. 108 permane, invece, la contemporanea rilevanza dei due parametri del numero dei dipendenti, rispettivamente, dell’impresa e dell’unità produttiva, anche se in un ambito più ristretto, perché se il datore di lavoro
ha più di 60 dipendenti, diviene irrilevante il numero dei lavoratori occupati nella singola unità produttiva; peraltro si stabilisce che nel novero dei lavoratori conteggiabili (ai fini della determinazione del livello occupazionale) rientrano – in conformità a un risalente indirizzo giurisprudenziale – i lavoratori assunti a tempo indeterminato parziale, nonché – in deroga al
ADL 1/2011
118
PARTE PRIMA . SAGGI
Nel complesso, comunque, l’ordinamento italiano si pose alla testa, forse per l’ultima volta, della legislazione comparata in tema di tutela contro il
licenziamento illegittimo, perché restava comunque stabilito il principio
che ogni licenziamento deve essere motivato e giustificato al di là della dimensione occupazionale dell’organizzazione produttiva (salvo alcune aree
nelle quali permane il licenziamento ad nutum).
4. – In parallelo all’iter legislativo della legge n. 108 si stava ponendo mano a quella che sarebbe diventata la legge n. 223 del 1991. Attraverso la presentazione al senato, nell’ottobre del 1987, del d.d.l. n. 585, il Ministro Formica continuava il lavoro impostato da De Michelis (41). Il progetto governativo si collocava al termine di un lungo processo evolutivo iniziato nella prima
metà degli anni ’70 quando, di fronte alle crisi che sempre più frequentemente si manifestavano nel sistema economico, si pose il problema della mobilità
in uscita e di restituire al sistema delle imprese margini di flessibilità.
Al problema delle eccedenze di personale si cercò di porre soluzione
con un provvedimento simbolo del « compromesso storico »: la legge n.
675 del 1977, esempio di proibizione non congiunturale – ma sempre subordinata alla dichiarazione di crisi aziendale – dei licenziamenti collettivi
in favore di « trasferimenti » di manodopera regolati addirittura amministrativamente (42). La legge fu adottata per attivare i circuiti di mobilità cd.
guidata per il personale strutturalmente eccedentario, personale che nell’attesa sarebbe rimasto alle dipendenze dell’impresa ma con i relativi costi
a carico del trattamento di Cigs. Il legislatore, cercando di praticare il principio di stabilità del posto di lavoro – che con l’art. 18 si era sostanziato nello Statuto dei lavoratori – anche sul versante del mercato del lavoro (43),
prospettava che si potesse passare da una occupazione a un’altra direttamente, e che questo passaggio potesse essere governato burocraticamente.
Il problema veniva risolto, ma soltanto sulla carta, cioè ancora in una logica
che risentiva del passato.
preesistente divieto legale (art. 3, decimo comma, legge n. 863 del 1984) – i lavoratori assunti con c.f.l. (cfr. art. 1, secondo comma, proposta di legge n. 2324).
(41) Ciò a conferma del notevole grado di continuità tra la IX e la X legislatura, almeno se
ci si pone nella prospettiva della progettualità: F. Liso, L’unitas multiplex. , op. cit. , pag. 438; T.
Treu, relazione al convegno su «Lavoro e diritto nella X legislatura », op. cit. , pag. 405.
(42) L. Galantino, I licenziamenti collettivi, Milano, 1984, spec. capitolo III. Cfr. , anche, M.
Miscione, Cassa integrazione e tutela della disoccupazione, Napoli, 1978, pag. 178 e segg.; L. Mariucci, I licenziamenti “impossibili”: crisi aziendali e mobilità del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Proc.
Civ. , 1979, I, pag. 1360 e segg.; M. Magnani, La mobilità interaziendale del lavoro. Profili giuridici, Milano, 1985, pag. 106 e segg.
(43) In tal senso F. Liso, Gli ammortizzatori sociali, in Rapporto su La situazione degli ammortizzatori sociali in Italia e in Europa, Cnel, Documenti, n. 48, 2003, pag. 27.
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
119
Il meccanismo della mobilità funzionò poco. Infatti, la vera mobilità venne realizzata attraverso circuiti diversi (44). Il non funzionamento del sistema,
come congegnato dalla legge n. 675, era, dunque, per alcuni una conseguenza riconducibile al « carattere assolutamente utopico del disegno » (45); per
altri era da ricondurre anche all’evoluzione in atto nell’industria: riduzione
dell’occupazione complessiva; ridistribuzione dell’occupazione a favore della piccola impresa; trasformazione dell’organizzazione produttiva (46). La
scarsa efficacia delle misure adottate per la mobilità esterna poteva inoltre
trovare giustificazione nella persistente possibilità di un uso meramente assistenziale della Cig, che sempre più esplicitamente era chiamata a svolgere un
ruolo diverso da quello suo originario (e cioè un ruolo sostitutivo del trattamento straordinario di disoccupazione) (47); uso subito sottolineato e deprecato dalle associazioni imprenditoriali (ma spesso praticato dai singoli datori di lavoro) (48), con la pubblicizzazione scandalistica di casi simbolo (tra i
quali ancora si può ricordare quello della Monti Confezioni di Pescara).
Il problema quindi era quello dell’ormai comprovata scarsa efficacia,
anche per ragioni endogene, del sistema di mobilità da un posto di lavoro
all’altro disciplinato dalla legge n. 675. Si trattava di rompere il guscio del
licenziamento « impossibile » (49) e di pensare al come di un sistema di « ricollocamento » davvero funzionante, ma anche partecipato dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori. E in questo si ebbe alla fine una ricomposizione tra le due « anime » della stessa dottrina giuslavorista « progressista »: quella cd. riformista che aveva denunziato la sclerosi del sistema, e
quella garantista di stampo più tradizionale (v. oltre).
Da un punto di vista generale, vi era la necessità di dare attuazione alla
(44) Ad es. , la mobilità verso le « aziende scatola » della Gepi, appositamente costituite per
assicurare l’apparenza di una continuità occupazionale a lavoratori di aziende poste in liquidazione o che comunque avevano cessato l’attività e per erogare a essi il trattamento di integrazione salariale (art. 5, legge n. 193 del 1984); la mobilità verso il pubblico impiego, a beneficio di piccole quote di lavoratori; la mobilità in uscita dall’azienda e dal mercato del lavoro
attraverso i prepensionamenti (legge n. 155 del 1981). Cfr. F. Liso, op. ult. cit.
(45) F. Liso, L’unitas multiplex ecc. , op. cit. , pag. 449.
(46) F. Carinci, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale, in Dir.
Lav. Rel. Ind. , 1985, pag. 236.
(47) Così M. Magnani, La mobilità interaziendale ecc. , op. cit. , pag. 45. Cfr. anche L. Galantino, I licenziamenti collettivi, op. cit. , pag. 230 e segg.; G.G. Balandi, Tutela del reddito ecc. ,
op. cit. , pag. 143 e segg.; F. Liso, op. ult. cit. , pag. 447; da ultimo M. Miscione, Gli ammortizzatori sociali ecc. , op. cit. , pag. 702 e segg.
(48) In tal senso F. Liso, Intervento al seminario su «Collocamento, cassa integrazione e agenzia nei progetti di riforma. . », in Riv. Giur. Lav. , 1987, I, pag. 132.
(49) Secondo il felice titolo di un saggio di L. Mariucci, I licenziamenti “impossibili” ecc. ,
op. cit.
ADL 1/2011
120
PARTE PRIMA . SAGGI
Direttiva CEE n. 75/129 sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di
licenziamenti collettivi, la cui inosservanza era già costata all’Italia una duplice condanna da parte della Corte di giustizia.
Il titolo III del d.d.l. n. 585/87, nella sua versione originaria, era confezionato in maniera singolare. Esso conteneva una serie di norme in tema di
cassa integrazione e di mobilità; era invece assente la disciplina dei licenziamenti collettivi, che avrebbe dovuto dare attuazione alla suddetta Direttiva (50).
La prospettiva limitata nella quale si muoveva il d.d.l. n. 585 era quella
– già presente nell’« accordo Scotti » del gennaio 1983 (art. 9, lett. d) – di
« fluidificare » la mobilità interaziendale della quale parlava la legge n. 675
del 1977, cioè di agevolare la cessazione della Cigs dando alla mobilità il
senso dell’uscita. E ciò spiega, da un lato, la già accennata assenza di una disciplina a tutto tondo dei licenziamenti collettivi e, dall’altro, il fatto che nel
d.d.l. in discorso ci si limiti a chiarire che quello di procedere al licenziamento collettivo è un potere del datore di lavoro che rimane in vita e non
viene pregiudicato dalla procedura di mobilità.
E che così debba essere emerge dalla formulazione dell’art. 8 del
d.d.l. governativo, che introduce la fattispecie del licenziamento per ritenuta improficuità del rientro dei cassa-integrati. Il datore di lavoro/impresa industriale che sia stato ammesso al trattamento di Cigs, qualora nel
corso di attuazione del programma ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, ha la facoltà di collocare in
mobilità i lavoratori eccedenti, previo espletamento della relativa procedura; tale facoltà dev’essere esercitata entro il termine di undici mesi dal
decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale (trascorso il quale il contributo addizionale in capo alle imprese passa dal 4
all’8% dell’integrazione salariale corrisposta ai dipendenti). Ma il datore
stesso è sempre facoltizzato, prima ed invece della richiesta di intervento
della Cigs o – secondo quanto consentito dalla lett. a) dell’art. 8 – prima
di attivare la procedura di mobilità, a procedere a « normali » licenziamenti collettivi per riduzione di personale, distinti e diversi da quelli
emanati al termine della procedura stessa (51), ai quali ultimi soltanto i be-
(50) Peraltro un invito esplicito a legiferare in materia di licenziamenti collettivi era contenuto nel documento del Ministero del lavoro La politica occupazionale per il prossimo decennio, op. cit. (Cap. su Le politiche per la flessibilità, lett. d).
(51) Rileva il carattere eventuale e residuale della procedura di mobilità scolpita dal d.d.l.
n. 585 G. Arrigo, Cassa integrazione e mobilità del lavoro, in Arrigo, Ichino, Loy, Roccella (a
cura di), Il diritto del lavoro dopo l’« emergenza », Milano, 1988, pag. 234.
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
121
nefici economici e previdenziali previsti dal d.d.l. risultano collegati (cfr.
art. 11).
Si rimane, quindi, nella logica dell’ordinamento esistente. È del tutto assente l’idea – che avrebbe certamente trovato l’accordo del sindacato – di
prevedere un vincolo di utilizzo prioritario della Cigs per risolvere la crisi o la
situazione di eccedenza (52). Il tentativo al quale si lavora è quello di concretizzare in maniera diversa l’idea della mobilità insita nella legge n. 675 del
1977, affinché le cospicue risorse spese per la Cigs siano più produttivamente
utilizzate per ricollocare i lavoratori eccedenti. In quest’ottica, si razionalizza
e si contiene l’uso dello strumento protettivo della cassa integrazione, perché
sia ricondotto alle sue funzioni originarie [art. 5 del d.d.l. n. 585; in tal senso
v. già l’« accordo Scotti » (art. 9, lett. g) e il protocollo di S. Valentino del 14
febbraio 1984 (punto 6)] e si sostituisce il trattamento di disoccupazione speciale degli operai dell’industria (già istituita dalla legge n. 1115 del 1968) con
una ben più corposa prestazione chiamata « indennità di mobilità ».
In ambienti sindacali furono avanzate riserve sulla struttura complessiva del d.d.l. governativo in discussione al senato e perplessità sostanziali su
talune soluzioni tecniche in materia di mobilità (53). Particolarmente criticata era l’impostazione del d.d.l. (o, meglio, la prospettiva limitata in cui esso si muoveva) che faceva dipendere il diritto dei lavoratori licenziati all’indennità di mobilità dall’esito positivo della procedura e che era, quindi,
fonte di una disparità di trattamento ingiustificata tra lavoratori cassa-integrati e lavoratori non cassa-integrati, ma dipendenti sempre da aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs.
Il lavoro parlamentare produceva una maggiore razionalizzazione. In effetti, esso dava un assetto più organico alla materia, poiché si poneva il problema di dare attuazione esplicitamente alle direttive n. 75/129 (cfr. art. 25
del d.d.l. 585-ter, il testo del quale è confluito nell’art. 24 della legge n. 223
del 1991) e n. 77/187 sul trasferimento d’azienda (cfr. art. 24 del d.d.l. 585-ter,
il testo del quale sarà ripreso nell’art. 47 della legge comunitaria n. 428 del
1990) (54). Esso, inoltre, scolpiva l’indennità di mobilità come trattamento
(52) Si fa portatore di questa aspirazione P. Alleva, Intervento al seminario su « Collocamento, cassa integrazione e agenzia nei progetti di riforma . . . », op. cit. , pag. 135.
(53) Un contributo all’elaborazione di proposte di modifica venne anche da M. D’Antona,
nella sua veste di coordinatore della commissione « Mercato del lavoro » della consulta giuridica
della Cgil. Cfr. M. D’Antona, Osservazioni e proposte sulla disciplina della Cig e della mobilità alla luce del d.d.l. governativo n. 585/1987, consulta giuridica della Cgil, 28 aprile 1988, dattiloscritto.
(54) In tal senso, esplicitamente, la relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 2148 recante « Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee (comunitaria per il 1990) », comunicato alla presidenza del senato l’8 marzo 1990.
ADL 1/2011
122
PARTE PRIMA . SAGGI
cui avevano diritto tutti i lavoratori, tanto quelli collocati in mobilità quanto quelli licenziati per riduzione di personale da aziende rientranti nel campo d’applicazione della Cigs (cfr. art. 17 del d.d.l. 585-ter). La trama normativa era certo complessa, ma solida e razionale.
Un importante ruolo svolse l’on. G. Ghezzi (nella sua veste di vicepresidente della commissione lavoro della camera dei deputati, a cui il
progetto di legge fu assegnato nel gennaio del 1989) (55) sia nell’introduzione – secondo le indicazioni già contenute nel protocollo d’intesa tra
Iri e Cgil, Cisl, Uil del 18 dicembre 1984 (par. su Strumenti per una politica attiva dell’occupazione) – della norma sulla « rotazione » come strumento per ripartire i sacrifici fra i singoli lavoratori sospesi (art. 1, settimo
comma e segg. , d.d.l. n. 3497; v. poi art. 1, settimo e ottavo comma, legge
n. 223), sia nella specificazione dei contenuti della comunicazione introduttiva della procedura di mobilità (art. 4, secondo comma e segg. , d.d.l.
n. 3497). Grazie all’iniziativa parlamentare veniva, quindi, recuperata nella formazione della legge in discorso l’ispirazione « garantista » di stampo
più tradizionale (56).
Il punto di mediazione fu quello di prevedere per legge – a fronte dell’accettazione da parte delle organizzazioni sindacali della mobilità in uscita – un’intensa partecipazione sindacale ai processi di ristrutturazione e di
mobilità ed una consistente copertura per i lavoratori licenziati (l’indennità di mobilità, o meglio lo statuto protettivo del lavoratore in mobilità).
Inoltre il legislatore mostrava favore per le soluzioni concordate delle eccedenze di personale a livello sindacale. Il favor verso tali soluzioni si evidenziava sia nell’affidamento alla contrattazione collettiva di alcune flessibilità normative (fra queste, ad es. , la possibilità di stipulare il contratto di
deroga dell’art. 2103 Cod. Civ. ex art. 4, undicesimo comma, d.d.l. n. 3497),
sia nei costi prevedendo cioè minori costi in capo all’impresa nel caso di so-
(55) Il d.d.l. 585-ter d’iniziativa del Ministro Formica (stralcio di alcuni articoli del d.d.l.
n. 585-bis deliberato dalla commissione lavoro del senato, in sede deliberante, il 3 agosto
1988) fu assegnato alla stessa commissione lavoro, in sede deliberante, il 2 dicembre 1988 e
ivi approvato con modificazioni il 21 dicembre 1988. Trasmesso alla camera il 3 gennaio 1989
(Atto Camera n. 3497), il d.d.l. fu assegnato e discusso dalla commissione lavoro, in sede legislativa, insieme ad altre proposte di legge concorrenti (tra le quali la n. 1178 d’iniziativa dell’on. G. Ghezzi). Il lavoro parlamentare fu bruscamente interrotto dalla caduta anticipata del
governo De Mita-1 (il 19 maggio 1989) e riprese soltanto il 4 dicembre 1990. Il d.d.l. n. 3497
fu infine approvato dalla commissione lavoro della camera in un testo unificato il 30 maggio
1991. Trasmesso nuovamente al senato, il d.d.l. 585-ter-B d’iniziativa del Ministro Donat-Cattin fu approvato definitivamente dalla commissione lavoro, in sede deliberante, il 4 luglio
1991 e divenne legge 23 luglio 1991, n. 223.
(56) Così T. Treu, relazione al convegno su «Lavoro e diritto nella X legislatura », op. cit. ,
pag. 399.
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
123
luzione concordata con le organizzazioni sindacali sul provvedimento di
riduzione del personale (art. 5, quarto comma, d.d.l. ). In questo senso, si
può dire che il d.d.l. in discussione alla camera dei deputati continuava nella linea di politica legislativa cd. di promozione dell’autonomia collettiva (57), il cui esempio più esplicito in quest’area era rappresentato dalla l. n.
164/75 (che aveva conferito alle organizzazioni sindacali il diritto ad essere consultate in ordine al ricorso alla Cig).
Il vero punto di equilibrio politico stava nella disposizione (che poi ritroveremo scolpita nell’art. 4 della legge n. 223) per cui, qualora al termine
del periodo di Cigs non risultasse possibile il rientro di tutti i lavoratori, sarebbe iniziata la procedura di collocamento in mobilità. Il disegno sotteso
alla legge era dunque questo: ai primi segni di crisi e di esubero deve iniziare un’intensa interlocuzione sindacale, la quale, in un primo tempo, avrà
ad oggetto tempi e modi della ristrutturazione, l’approvazione di un piano
e l’utilizzo concordato e non discriminatorio della Cigs (predeterminazione e pubblicità dei criteri di scelta dei lavoratori sospesi; principio della rotazione finché possibile); in un secondo tempo, qualora l’esubero non possa essere recuperato nel corso di attuazione del programma, si sostanzierà
in una nuova fase di interlocuzione diretta a esaminare le cause che hanno
contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di reperire rimedi diversi dalla riduzione; in ultima istanza, avrà ad oggetto la
messa in mobilità con cessazione del rapporto di lavoro, ma senza abbandono di responsabilità da parte dell’impresa.
Il dibattito nelle aule parlamentari che sfociò nell’emanazione della
legge n. 223 del 1991 fu particolarmente vivo, perché questa, nei suoi termini, si presentava come una normativa « bifronte ». Poteva essere intesa o
come normativa liberalizzante, che poneva fine agli interventi di integrazione salariale sine die, esplicitando una disoccupazione fino a quel momento « mascherata »; o invece come un provvedimento di garanzia più efficace, perché mirato a un’occupazione reale o da conservare attraverso la
Cigs (il cui intervento veniva non solo mantenuto, ma migliorato nelle sue
procedure) o da recuperare con corposi incentivi economici al ricollocamento guidato presso altre imprese.
Non era facile, insomma, per il sindacato accettare che la « messa in mobilità » significasse licenziamento e che si chiudesse quella che era stata
chiamata la stagione dei licenziamenti « impossibili », e tuttavia questo apparente arretramento rispetto alla legge n. 675 del 1977 era compensato dal
fatto che, a monte, vi era pur sempre – nello schema ideale di funzionamen-
(57) F. Liso, L’ unitas multiplex ecc. , op. cit. , pag. 443.
ADL 1/2011
124
PARTE PRIMA . SAGGI
to della nuova disciplina – l’esperimento, fin quando possibile e razionale,
di misure alternative: la Cigs o i contratti di solidarietà (58). E che poi fosse
prevista non già una deresponsabilizzazione del datore di lavoro, bensì una
sua triplice « corresponsabilizzazione » attraverso: la procedura dell’art. 4
della legge n. 223; l’imposizione di notevoli oneri economici alla messa in
mobilità; e l’estrema severità nella valutazione – in funzione anti-discriminatoria – delle previsioni in tema di criteri di scelta dei licenziandi, la cui
violazione ha come conseguenza sanzionatoria non già il risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento, bensì la reintegrazione nel
posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 (art. 5, legge n. 223 del
1991) (59). Per altro verso, ancora, la dote per un effettivo e veloce ricollocamento, assicurata al lavoratore messo in mobilità, era certo molto appetibile e anche il profilo di sicurezza sociale molto generoso, comprendendo
l’indennità di mobilità articolata per età e zona geografica (art. 7).
In quello stesso contesto, il sindacato accettava di far cadere un altro tabù (60), quello del collocamento numerico. Accettava che i datori potessero scegliere liberamente i lavoratori da assumere; in cambio otteneva la
previsione dell’obbligo di rispetto da parte del datore (con più di dieci dipendenti) della cd. « quota » riservata, prevista a tutela dei soggetti appartenenti alle fasce di manodopera ritenute deboli sul mercato (art. 25, primo
comma, legge n. 223).
5. – Gli anni ’80 sono generalmente connotati come gli anni della promozione della mediazione collettiva. Questo tratto caratterizzante si ritrova anche nell’area della disciplina dei conflitti collettivi.
La nuova stagione dell’autoregolamentazione, aperta dal sindacato sul
finire del decennio ’70 (con risultati positivi soprattutto nelle industrie a ciclo continuo e nel settore elettrico) (61), riceve all’inizio degli anni ’80 il
supporto del legislatore. L’art. 11, commi 4-6, della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 suggerisce l’introduzione di procedure di
(58) Il principio è valorizzato in T. Treu, Intervento alla Tavola rotonda su « Crisi economica, mobilità dei lavoratori e garanzia dell’occupazione. . », in Riv. Giur. Lav. , 1976, I, spec.
pag. 587.
(59) Su quest’ultimo aspetto v. , fra gli altri, M. D’Antona, Commento agli artt. 5 (commi 13) e 17, in M. Persiani (a cura di), Commentario alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in Nuove Leggi
Civ. Comm. , 1994, n. 4-5, pag. 923 e segg.
(60) Cfr. F. Liso, Le nuove regole, op. cit. , pag. 159.
(61) V. , anche per i successivi sviluppi, F. Carinci, Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali:
dall’autoregolamentazione alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in Riv. Giur. Lav. , 1990, 1, spec. pag.
464 e segg.; M. Rusciano, Lo sciopero nei servizi essenziali, in Dir. Lav. Rel. Ind. , 1988, spec. pag.
398 e segg.
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
125
composizione del conflitto e impone l’adozione di codici sindacali, predeterminati nei loro contenuti minimi obbligatori (come in seguito modificati dall’art. 2, primo comma, 2° periodo, legge n. 146 del 1990, testo originario), come requisito di ammissione delle delegazioni sindacali alle procedure contrattuali (art. 11, quinto comma, legge n. 93) (62).
Con l’avanzare del decennio ‘80, a fronte di una conflittualità sempre
più concentrata proprio nei servizi pubblici (a cominciare dal settore dei
trasporti), diventa sempre più forte la critica circa l’efficacia dei codici di
autoregolamentazione, un’efficacia comunque limitata – secondo l’opinione prevalente – ai sindacati e ai loro iscritti (63). Da più parti si caldeggia
l’intervento della legge a regolare almeno i profili socialmente più carichi di
ripercussioni negative (64).
Le due fondamentali opzioni che si dividono il campo sono quella della regolazione per legge (che si materializzerà da lì a poco in un d.d.l. a iniziativa del sen. G. Giugni) e quella (auspicata in particolare dalla Cisl) della cd. « contrattualizzazione » (65). La ricerca di un elemento di convergenza tra le due opzioni diverrà punto focale del parere reso nel dicembre 1987
da un comitato di giuristi incaricati da Cgil, Cisl, Uil (v. oltre).
(62) Cfr. anche per riferimenti F. Santoni, Lo sciopero, Napoli, 1994, pag. 103 e segg. In
quello stesso contesto, nelle imprese a partecipazione statale si assiste a un interessante esperimento. Vengono stipulati accordi che regolano le procedure di prevenzione dei conflitti collettivi, i più importanti dei quali sono i protocolli d’intesa tra il gruppo Iri e Cgil, Cisl, Uil del
18 dicembre 1984 e del 16 luglio 1986 (sulla portata e sul contenuto procedimentale e istituzionale del protocollo del 1984 v. , fra gli altri, M. Pedrazzoli, Sull’introduzione per via contrattuale di comitati consultivi paritetici nel gruppo I.R.I. , in Riv. It. Dir. Lav. , 1985, I, pag. 217). Nonostante l’indubbio interesse, l’esperimento non ha successo: gli organi paritetici non decollano, non riuscendo a divenire sedi di composizione dei contrapposti interessi (cfr. il paragrafo
del protocollo su Procedure e sedi negoziali per prevenire e risolvere i conflitti collettivi aziendali, in
Riv. It. Dir. Lav. , 1985, III, pag. 16); di conseguenza, è spesso difficile per i lavoratori e le loro
organizzazioni sentirsi vincolati dalle clausole contrattuali che disciplinano il ricorso allo sciopero. Per un bilancio di questa esperienza v. M. Ricci, B. Veneziani (a cura di), Tra conflitto e
partecipazione, Bari, 1988.
(63) Cfr. , fra gli altri, U. Romagnoli, Introduzione, in Commentario della Costituzione, Norme
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, art. 40, a cura di Romagnoli e
Ballestrero, Roma, 1994, pag. 14 e segg.; M. Persiani, Autoregolamentazione dello sciopero ed
efficacia del contratto collettivo, in Dir. Lav. , 1989, I, pag. 6 e segg.; R. Pessi, La regolamentazione
legislativa dello sciopero nei servizi essenziali, ivi, 1988, I, pag. 48.
(64) L. Gaeta. Lo sciopero come diritto, in M. D’Antona (a cura di), Letture di diritto sindacale ecc. , Napoli, 1990, pag. 447. Che quelli dello sciopero e della « autoregolamentazione nel settore privato e pubblico » fossero temi all’ordine del giorno lo si evince dal fatto che ad essi fu
dedicato il 9° Congresso dell’Aidlass, svoltosi a Fiuggi dall’8 al 10 aprile 1988.
(65) Le proposte di parte imprenditoriale sono dirette all’eteroregolamentazione tout court,
per via legale, del diritto di sciopero (come evidenziato nei documenti di quel periodo). Cfr. il
progetto redatto da G. Bognetti e approvato dal Comitato Direttivo della Federmeccanica nell’ottobre 1987 (uno stralcio del progetto è leggibile in Riv. It. Dir. Lav. , 1988, III, pag. 11).
ADL 1/2011
126
PARTE PRIMA . SAGGI
La presentazione al senato il 29 luglio 1987 del d.d.l. recante « Norme
di sostegno all’autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza », a iniziativa del sen. G.
Giugni e altri (Atto Senato n. 317) (66), che faceva seguito a ripetuti episodi di lotta sindacale attuati da coalizioni spontanee di lavoratori (Cobas)
insoddisfatti dei contenuti di alcuni contratti collettivi da poco rinnovati,
poneva all’ordine del giorno una tematica di cruciale importanza.
Restava centrale, nella proposta Giugni, il « patto di civiltà » offerto dalle organizzazioni sindacali all’utenza con la formulazione, in piena autonomia, di quei « codici » ai quali la legge avrebbe dovuto fare rinvio, in modo
da rendere vincolanti per tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti, modalità di
esercizio del diritto di sciopero compatibili con la salvaguardia di quel nucleo essenziale di beni e interessi, costituzionalmente tutelati, che nei servizi pubblici trovavano concreta realizzazione. E invero l’art. 2 del d.d.l. n.
317, dopo aver fissato il principio che lo sciopero deve essere attuato con
modalità che quei beni salvaguardino, le identifica con quelle determinate
dai codici di autoregolamentazione previsti dalla legge n. 93 del 1983, ovvero, nei settori in cui questa legge non si applica, con quelle eventualmente stabilite nei contratti collettivi o in delibere dei sindacati dotati di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970.
Il d.d.l. n. 317, insomma, si collocava in un solco ben conosciuto, che l’esperienza aveva dimostrato fecondo: quello della legislazione di sostegno.
Talché avrebbe potuto ben dirsi, a sua difesa, che la legge non si sarebbe
sovrapposta alle autonome decisioni del sindacato, né avrebbe mirato a coartarle, ma anzi a valorizzarle, impedendo che il « patto di civiltà » offerto
dalle confederazioni perdesse di credibilità agli occhi dell’opinione pubblica, a seguito dell’atteggiamento recalcitrante di gruppi e coalizioni micro-settoriali o corporativi.
Particolarmente importante era l’apparato sanzionatorio, articolato nei
seguenti profili: a) sul piano retributivo, vi era la previsione – già contenuta nell’art. 171, secondo comma, legge n. 312 del 1980 – di trattenute per
l’intero turno di lavoro, anche per scioperi « brevi » i cui effetti sul servizio
si risentissero al di là dell’effettiva durata dell’astensione dal lavoro; b) sul
piano disciplinare, era prescritta la possibilità di sanzioni per il solo fatto di
aver scioperato in contrasto con quanto previsto dai « codici » cui il d.d.l. faceva riferimento; c) sul piano sindacale, era prevista la sospensione, in danno dei sindacati che proclamassero e attuassero scioperi in contrasto con
(66) Il d.d.l. è leggibile in Riv. It. Dir. Lav. , 1988, III, pag. 4. Sul contenuto del d.d.l. v. G.
Giugni, Una legge a sostegno dell’autoregolamentazione, in Notiz. Giur. , 1987, n. 11-12, pag. 17;
nonché il commento di G. Pera, in Foro It. , 1987, V, pag. 511.
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
127
quelle regole, del beneficio di percezione delle quote associative per trattenuta diretta ai lavoratori; d) lo strumento più importante, e certo centrale,
nell’economia del progetto era dato dalla nuova regolamentazione dell’istituto della « precettazione », allora previsto dal r.d. n. 383/34 (67). Ulteriore
profilo del progetto Giugni era quello che riguardava la costituzione di
commissioni di indagine sui conflitti in atto a livello regionale e locale (68).
Ai primi di ottobre del 1987 si registrò un forte rialzo di temperatura sul
tema della regolamentazione. Furono gli scioperi dei macchinisti dei treni
a far scoppiare l’incendio. Seguì una lettera del Segretario generale della
Uil G. Benvenuto all’allora presidente del Consiglio G. Goria, con la richiesta ivi contenuta di « dare efficacia generale ai codici di autoregolamentazione attraverso lo strumento della legge » (69).
Il 28 gennaio 1988 venne presentata al senato – ove nel frattempo era iniziato l’iter del d.d.l. n. 317 (esaminato, in sede referente, dalle commissioni lavoro e affari costituzionali insieme ad altri quattro progetti di legge) (70) –
una proposta delle segreterie di Cgil, Cisl e Uil recante « Regole sul conflitto
nei servizi pubblici essenziali ». Particolarmente proficuo, ai fini dell’elaborazione della « piattaforma » sindacale unitaria, fu il lavoro e il « parere di massima » reso da un comitato di giuristi, nominato dalle tre confederazioni tra
esperti di diverso orientamento culturale e politico (71).
(67) Si trattava del potere, in capo al prefetto, di emettere provvedimenti amministrativi
aventi contenuto di ordine, diretto agli scioperanti, di adeguarsi alle modalità di sciopero consentite dai codici di autoregolamentazione e in genere di assicurare una minima funzionalità
del servizio. La disobbedienza all’ordine avrebbe continuato a essere sanzionata ai sensi dell’art. 650 Cod. Pen. , ma l’emissione di un tale provvedimento era circondata da opportune
cautele: il progetto n. 317 prevedeva che il prefetto dovesse sentire preliminarmente i sindacati maggiormente rappresentativi e che l’ordine, una volta emesso, potesse essere soggetto al
vaglio di legittimità, e, in un certo senso, anche di merito, da parte del Tar.
(68) La commissione aveva il dovere di convocare le parti, indagare sulle cause dello sciopero, comunicare con la pubblica opinione ed eventualmente proporre alle parti stesse misure come il referendum, o sollecitare il potere di precettazione. Il d.d.l. conferiva, tra l’altro, a una
commissione nazionale di indagine il potere di invitare le organizzazioni sindacali a fare ricorso al referendum sia sulla materia dello sciopero, sia sulla sua continuazione. Per alcune osservazioni critiche v. S. Sciarra, Il “conflitto fra gruppi” nei servizi pubblici . . . , relazione al convegno internazionale su « Sciopero e servizi pubblici in Europa », Napoli, 25-26 marzo 1988,
pagg. 15 e 16 del dattiloscritto.
(69) Per una ricostruzione critica degli avvenimenti v. M. Pivetti, Obiettivo: verso una regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici, in Quest. Giust. , 1988, pag. 370 e segg.
(70) Per un esame v. G. Pera, Sui progetti di regolamentazione dello sciopero, in Riv. It. Dir.
Lav. , 1988, I, pag. 277; M. Rusciano, Lo sciopero nei servizi essenziali, op. cit. , pag. 437; C. Pisani, Resta il nodo delle sanzioni, in Lav. Inf. , 1988, n. 1, pag. 6.
(71) Il comitato era composto da P. Alleva, S. Benvenuto, E. Cardi, F. Carinci, M. D’Alberti, E. Ghera, L. Mariucci, M. Pedrazzoli, G. Perone, M. Rusciano, T. Treu. La proposta
sindacale e il parere dei giuristi, formalizzato in un documento consegnato alle segreterie con
ADL 1/2011
128
PARTE PRIMA . SAGGI
Il documento delle confederazioni – che con il progetto Giugni condivideva la medesima prospettiva metodologica (72) – suscitò la massima meraviglia anche nella stampa, perché si era raggiunta una sorta di miracolosa
unità di opinioni in una materia in cui si stavano confrontando orientamenti « libertari » e « repressivi » in modo astratto (73). Il concetto fondamentale che sdrammatizza il problema teorico e politico è che non occorre
creare nessuna legislazione più o meno restrittiva, o arbitrariamente restrittiva, perché i limiti al diritto di sciopero esistono già come limiti ordinamentali, nella misura in cui il singolo servizio pubblico realizzi un diritto
della persona costituzionalmente tutelato. Tanto è vero che quella che poi
diventerà la legge n. 146 del 1990 si apre proprio con un’elencazione esemplificativa dei servizi pubblici ai quali corrisponde la realizzazione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato (art. 1, secondo comma).
Con questa impostazione il problema diventava un altro: non introdurre autoritativamente da parte del legislatore, o consensualmente da parte
del sindacato e dei datori di lavoro, limiti prima inesistenti per il diritto di
sciopero, bensì rendere visibili limiti già esistenti – ed esistenti da sempre,
ossia fin dal riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero (74) – ma
non ancora resi evidenti da disposizioni legislative o contrattuali collettive.
In questa visuale, quindi, l’accordo tra le parti auspicato da quella che poi
diventerà la legge n. 146 del 1990 (art. 2, secondo comma), per ogni singolo settore, intorno alla salvaguardia dei minimi di funzionamento del servizio pubblico essenziale (minimi che rappresentano il limite di compressione del diritto primario da contemperare con lo sciopero), non ha un carattere costitutivo e nemmeno ricognitivo in senso cogente, ma fondamentalmente indicativo di un’adeguatezza sociale della misura di compressione
consentita del diritto primario.
E solo per questo si spiegava allora perché, in mancanza di autoregolamentazione, il minimo di funzionamento del servizio pubblico essenziale
potesse essere stabilito anche unilateralmente dall’ente gestore (75); perché
federali il 18 dicembre 1987, si trovano in Lav. Inf. , 1988, risp. pagg. 137-141 e pagg. 11-19. Per
un commento v. M. D’Antona, Diritto di sciopero e collettività ecc. , in Foro It. , 1988, V, col. 188.
(72) Ossia quella di una legislazione di sostegno delle organizzazioni sindacali, che identificava nell’attività negoziale collettiva la fonte prioritaria della disciplina da applicarsi a contemperamento dell’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti a lavoratori e utenti: così G. Ghezzi, Diritto sindacale e del lavoro, op. cit. , pag. 122.
(73) Si vedano le considerazioni critiche di G. Pera, op. ult. cit. , pag. 278.
(74) Già nella Costituzione, infatti, secondo la costante giurisprudenza della Consulta, è
insita la necessità di contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti costituzionali garantiti: cfr. , fra le altre, Corte cost. 17 marzo 1969, n. 31.
(75) La possibilità di determinazione unilaterale ad opera del datore di lavoro (da compiersi, in difetto di accordo, solo « nei limiti della presente legge »), introdotta nel secondo
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
129
questo lo faceva a suo « rischio e pericolo », rischiando appunto di travalicare una linea invisibile e di esporsi così all’azione di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 (come modificato
dall’art. 6, primo comma, legge n. 146 del 1990). Solo qualora il datore di lavoro individuasse correttamente il punto di equilibrio tra diritto di sciopero
e diritto della persona soddisfatto dal servizio pubblico, la sua determinazione del minimo di funzionamento sarebbe risultata lecita. Ne conseguiva
che quella sorta di accertamento consensuale dei limiti dello sciopero, ossia
della misura di residua funzionalità del servizio comunque da salvaguardare, era da intendere come una sorta di garanzia per ambedue le parti (76).
Il paragone più calzante adottato per illustrare la non semplice costruzione concettuale fu quello del rapporto tra la determinazione giuridica e
giudiziale della retribuzione sufficiente e la contrattazione collettiva con i
suoi livelli salariali tabellati. La retribuzione sufficiente è un valore costituzionale (art. 36, primo comma) che le parti sociali tramite la contrattazione
collettiva possono aiutare a individuare come dato socialtipico, talché nove
volte su dieci il giudice guarderà proprio alle tariffe collettive per decidere
dell’adeguatezza o meno della retribuzione nel singolo caso. Ma ciò non toglie che il giudice potrebbe, invece, ritenere la stessa clausola retributiva
del contratto collettivo non conforme al precetto costituzionale. Allo stesso
modo, sarebbe la medesima legge n. 146 del 1990 « ad attribuire alla contrattazione collettiva la competenza a indicare quella che dovrebbe presumersi essere la regolazione socialtipica dell’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali, salvo l’eventuale valutazione di congruità da
parte della Commissione di garanzia e di rispondenza all’art. 40 Cost. da
parte della magistratura » (77). Anche l’individuazione, attraverso l’accordo
comma dell’art. 2 dell’articolato licenziato dalle commissioni lavoro e affari costituzionali del
senato il 9 giugno 1988 (in Riv. Giur. Lav. , 1988, I, pag. 217), fu poi abbandonata nella disciplina varata dall’aula il 14 luglio 1988 (v. oltre), che opterà invece per un sistema « aperto »: in
caso di dissenso fra le organizzazioni sindacali, da un lato, e le organizzazioni contrapposte,
ovvero l’ente o l’impresa erogatrice, dall’altro, le parti, esaurite le eventuali procedure di composizione contrattualmente previste, « sono tenute » a chiedere l’intervento della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, la quale, vagliate le circostanze, esprime « un
parere » non vincolante.
(76) Senza tacere peraltro che, a stretto rigore, in questa impostazione, anche l’evidenziazione consensuale della linea di separazione tra lecito e illecito poteva essere contestata dal
singolo prestatore di lavoro, proprio in quanto l’accordo collettivo comunque non poteva, ontologicamente, assumere il carattere costitutivo né determinativo dell’implicito limite costituzionale: cfr. G. Ghezzi, Lo sciopero nei servizi pubblici: considerazioni sul testo approvato dal Senato, in Riv. It. Dir. Lav. , 1989, I, pag. 55.
(77) F. Carinci, L’autoregolamentazione nella legge 12 giugno 1990, n. 146 (testo della relazione tenuta all’assemblea della consulta giuridica della Cgil, Roma 5 febbraio 1991), in Riv. It.
Dir. Lav. , 1991, III, pag. 81.
ADL 1/2011
130
PARTE PRIMA . SAGGI
collettivo, di una certa misura di garanzia residua di funzionalità del servizio pubblico essenziale in caso di sciopero potrebbe dal giudice essere ritenuta eccessiva, e quindi in realtà costituzionalmente illegittima, ancorché
nove volte su dieci bisognerà attendersi un giudizio di conformità; giudizio
che sarebbe, invece, assai più dubbio in caso di definizione unilaterale da
parte del datore di lavoro di quei livelli di funzionamento.
In questo schema concettuale, l’invenzione certamente più rilevante –
ipotizzata nella « piattaforma » sindacale unitaria – era costituita da quella
che poi fu chiamata « Commissione di garanzia dell’attuazione della legge »
(e che tanto nella proposta Giugni del 1987, quanto nell’art. 12 del testo
unificato approvato dal senato il 14 luglio 1988, prendeva il nome di « Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici »). Questa, lungi dall’essere un organismo dotato di poteri normativi e/o amministrativi e giurisdizionali, costituiva piuttosto una sede di confronto e riflessione mediata
da soggetti di alta reputazione scientifica e politica, che consentiva sia ai
singoli datori e prestatori di lavoro, sia alle parti sociali, di individuare l’attendibile punto di conciliazione tra diritto di sciopero e diritto della persona soddisfatto attraverso il servizio pubblico. La proposta fu sostenuta e
avanzata in maniera convincente in particolare da F. Carinci, il quale indicava appunto in una commissione con questi compiti la chiave di volta che
avrebbe reso coerente e stabile l’intera costruzione. In definitiva, tutta la
problematica dei limiti del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali finiva, per così dire, con l’assomigliare a un appuntamento in orbita tra
due astronavi, con la « Commissione di garanzia » (come poi fu chiamata)
in funzione di stazione di controllo.
Le parti più significative e controverse del testo esaminato dalle commissioni lavoro e affari costituzionali del senato – e approvato (in testo unificato con i progetti di legge presentati da Pci, Psi, Dc e Pri) dall’aula di Palazzo Madama il 14 luglio 1988 – riguardavano, in linea di massima e per
quanto concerne in senso stretto l’esercizio del diritto di sciopero, i soli servizi pubblici. L’insieme delle altre norme, tese a ridisciplinare alcuni profili
di carattere processuale e amministrativo, riguardava invece altri aspetti
del conflitto. Il d.d.l. risentiva in queste parti l’influenza esercitata dalla
« piattaforma » sindacale unitaria presentata al senato e dall’iniziativa dell’opposizione parlamentare concretatasi in una proposta di legge (78).
Il d.d.l. passò alla camera dei deputati per l’approvazione definitiva sul(78) Cfr. la proposta di legge n. 2521 recante « Norme in tema di azione per la repressione
della condotta antisindacale », presentata alla camera il 24 marzo 1988 a iniziativa degli on.
Ghezzi e Rodotà. I testi dei progetti presentati da Psi, Dc e Pci sono leggibili in Riv. It. Dir.
Lav. , 1988, III, risp. pagg. 3-18 e pagg. 168-186.
ADL 1/2011
ANDREA ALLAMPRESE
131
l’onda di un consenso vasto. Questo non era però un segno univoco. Il progetto di legge, che nel frattempo aveva assunto il n. 3039, era il frutto di una
mediazione tra posizioni quanto mai divaricate, dipanatasi prima all’interno delle tre confederazioni (v. supra) e poi all’interno della commissione
lavoro del senato grazie all’opera paziente del presidente G. Giugni. L’equilibrio raggiunto al senato era così precario che nessun attore della partita (confederazioni, organizzazioni imprenditoriali, maggioranza di governo e opposizione) sembrava intenzionato a rimettere in discussione
quel poco o quel tanto che era riuscito a ottenere (79).
Pertanto, le non poche modiche che il testo subì nei due anni (dal 20
luglio 1988 al 24 maggio 1990) durante i quali fu sottoposto all’esame della camera dei deputati non alterarono il connotato metodologico che distingueva il d.d.l. Si trattava di un intervento legislativo che intendeva muoversi su un piano « pluriordinamentale », in conformità sostanziale con le
premesse poste a base della ricordata piattaforma sindacale unitaria: da
una parte, le regole negoziali (in via di autodisciplina e in sede contrattuale); dall’altra, le regole di legge che modificano anche talune previsioni nell’ambito del pubblico impiego; per un verso, la riforma della precettazione;
per altro verso, l’istituzione di un organismo di valutazione e giudizio « sociale », inteso anche come strumento per la trasparenza delle cause e delle
modalità del conflitto nei servizi pubblici (80).
Le modifiche che la camera apportò al testo licenziato dal senato riguardavano, invece, essenzialmente le norme relative all’istituto della precettazione e alla Commissione di garanzia. Il potere di emanare il provvedimento di precettazione passava dal presidente della giunta regionale al
prefetto (art. 8 del testo unificato con le concorrenti proposte di legge, predisposto dalla commissione lavoro della camera); inoltre, si attribuiva anche ai « soggetti che promuovono lo sciopero » la facoltà di impugnare la
precettazione, con ciò di fatto riconoscendo le nuove realtà sindacali (art.
10). L’art. 13 del testo unificato conferiva alla Commissione di garanzia
compiti più ristretti rispetto a quelli previsti nell’articolato licenziato dal senato: i suoi compiti, infatti, erano focalizzati sulle modalità di svolgimento
del conflitto, piuttosto che sulle sue cause e sulle possibilità di addivenire a
una soluzione dello stesso (81). In linea generale il testo del d.d.l. rispec(79) Cfr. M. D’Antona, La legge sullo sciopero nei servizi essenziali e le tendenze del diritto sindacale, in Riv. Giur. Lav. , 1989, I, pag. 10.
(80) Cfr. G. Ghezzi, Lo sciopero nei servizi pubblici ecc. , op. cit. , pag. 42.
(81) Durante l’iter parlamentare, all’ampio obiettivo di « valutazione e di indagine sull’andamento delle relazioni sindacali e dei conflitti colletti di rilevante interesse nazionale, riguardanti amministrazioni o imprese erogatrici di servizi » si sostituisce il compito più ristretto di « valutare l’idoneità di misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del
ADL 1/2011
132
PARTE PRIMA . SAGGI
chiava la posizione unitariamente assunta dalle confederazioni, che sottolineavano l’urgenza di una sua rapida approvazione. Non mancarono invece
prese di distanza e doglianze delle associazioni degli imprenditori rispetto
al testo in gestazione (82).
Il d.d.l. , comunque, riuscì a superare gli ultimi ostacoli (83) e guadagnò
il traguardo dell’approvazione alla camera il 24 maggio 1990. Si giunse così all’ultima lettura ad opera delle commissioni riunite lavoro e affari costituzionali del senato. Il presidente Giugni, esprimendo un forte senso di responsabilità sociale e politica verso l’obiettivo finale, optò per il ritiro dei
suoi emendamenti al testo del d.d.l. e il provvedimento fu deliberato dalle
suddette commissioni il 7 giugno 1990. In questo gesto si può scorgere un
impegno verso valori condivisi, che finiva per mettere in secondo piano
istanze intellettuali e politiche individuali anche non irrilevanti (84).
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati » (art.
12, primo comma, testo unificato). Cfr. da ultimo A. Pilati, Il conflitto collettivo nei servizi essenziali, in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro. Commentario, I (Le fonti. Il diritto sindacale), a
cura di C. Zoli, Torino, 2007, pag. 677.
(82) In un documento della Confindustria predisposto, nel luglio 1989, in vista dell’audizione presso la Commissione lavoro della Camera venivano confermate le valutazioni critiche
già espresse in altre occasioni, motivate dal fatto che il d.d.l. non risolveva alcune questioni ritenute cruciali: a) la mancata identificazione dei soggetti legittimati a proclamare lo sciopero;
b) l’esigenza di definire la nozione di sciopero legittimo, escludendo le forme di sciopero che
non consistessero in una astensione collettiva dal lavoro; c) l’ingiustificato ampliamento della
nozione di condotta antisindacale (cfr. art. 7 del testo unificato); d) la necessità di regolamentare le astensioni dal lavoro anche in settori diversi da quello dei servizi pubblici essenziali. Più sfumata appariva la posizione dell’Intersind: cfr. Audizione del Comitato ristretto della
Commissione lavoro della Camera sul testo unificato del disegno di legge in materia di regolamentazione del diritto di sciopero, Roma, 25 luglio 1989, dattiloscritto.
(83) Il lavoro parlamentare portò, fra l’altro, alla soppressione dell’inciso « fatte salve le
norme previste dai codici di autoregolamentazione per le organizzazioni che le abbiano adottate », già presente nell’art. 2, primo comma, della proposta di legge n. 3039. Il suddetto inciso, in combinato disposto con l’art. 4, primo comma, della stessa proposta di legge, sembrava
implicitamente prevedere un obbligo sanzionato in capo ai singoli lavoratori (iscritti o no all’organizzazione sindacale), oltre che di effettuare le prestazioni contrattualmente e legislativamente ritenute indispensabili di rispettare le diverse – e presumibilmente più ampie – limitazioni contenute nei codici di autoregolamentazione. A seguito della modifica in parola, il
rinvio della norma sanzionatoria di cui all’art. 4, secondo comma, del testo unificato ai « commi 1 e 3 dell’articolo 2 » assumeva un altro significato, riferendosi alla violazione, da parte dei
singoli, degli obblighi di prestazioni minime derivanti soltanto dalla legge o dal contratto collettivo.
(84) Si v. le osservazioni critiche formulate dal sen. G. Giugni nel corso della 13 seduta
delle commissioni 1° e 11° riunite (cfr. Atti Senato, X legislatura, 7 giugno 1990, pag. 799 e
segg. ).
ADL 1/2011
GIURISPRUDENZA
N OTE D I C O M M E NTO
Cass., Sez. Lav., 29 marzo 2010, n. 7531 – Pres. Roselli – Est. Picone –
Meridiana S.p.A. c. R.A.
Inidoneità fisica del lavoratore – Impossibilità di svolgere mansioni alternative – Licenziamento – Riconducibilità al giustificato motivo oggettivo –
Causa di immediata risoluzione del rapporto – Preavviso – Esclusione.
L’impossibilità sopravvenuta, totale e definitiva, della prestazione di pilota di aeromobile costituisce una causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione neppure provvisoria ai sensi dell’art. 2119 Cod. Civ., con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’istituto del preavviso di cui all’art. 2118 Cod. Civ.
Premesso in fatto
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello di Meridiana SpA e
conferma la decisione non definitiva del Tribunale di Tempio Pausania n. 222 del 2004,
recante l’accertamento che la risoluzione del rapporto di lavoro, comunicata al dipendente comandante pilota R.A. in data 8 maggio 2003 in esito a giudizio medico-legale di
non idoneità permanente al volo, configurava licenziamento per giustificato motivo oggettivo e attribuiva al lavoratore il diritto al periodo di preavviso, con le relative conseguenze economiche.
2. La Corte di appello di Cagliari ritiene che l’inidoneità del pilota al volo non equivale all’impossibilità assoluta della prestazione di lavoro e va ricondotta alla fattispecie
di risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo non dipendente da causa
imputabile al dipendente e non esclusiva del diritto al preavviso anche in presenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione dedotta in contratto; il principio era desumibile altresì dall’art. 11 del c.c.n.l., che contemplava il diritto del pilota non più idoneo ad essere preferito nelle assunzioni di personale di terra (escludendo il preavviso in tale evenienza); in ogni caso, dalle disposizioni contrattuali in tema di diritto al preavviso nei casi di risoluzione del rapporto per malattia, inidoneità o infortunio si evinceva che il diritto in questione era negozialmente riconosciuto anche nell’ipotesi di accertata inidoneità
definitiva al volo.
3. Il ricorso di Meridiana SpA si articola in due motivi ed è ulteriormente precisato
con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso R.A.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata l’erronea interpretazione della L. n.
604 del 1966, art. 3 e degli art. 2118 e 2119 c.c., perché nella fattispecie non ricorreva l’i-
ADL 1/2011
134
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - NOTE DI COMMENTO
potesi dell’impossibilità parziale della prestazione di lavoro e quindi di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, ma quella dell’impossibilità assoluta sopravvenuta, causa di
estinzione del rapporto indipendente dalla volontà di recesso del datore di lavoro.
Si sostiene che oggetto del contratto di lavoro era la prestazione lavorativa di pilota;
che l’inidoneità alle mansioni aveva determinato il venir meno della causa del contratto
e la cessazione del rapporto si era verificata trenta giorni dopo la pronuncia di inidoneità permanente espressa dell’Istituto medico legale, ai sensi dell’art. 13, lett. b, comma 5,
c.c.n.l.; che il diritto al preavviso non è correlato alla non imputabilità della causa di cessazione del rapporto al lavoratore, ma alla perdurante, inalterata, efficacia del contratto
nel periodo previsto, con tutti i relativi diritti e doveri, tra i quali l’obbligo del lavoratore
di rendere la prestazione; in ogni caso, anche escludendo l’estinzione di diritto del rapporto di lavoro, l’impossibilità di darvi esecuzione non consente di riconoscere il diritto
a compensi, anche a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli
artt. 1362 e segg. c.c., in relazione all’interpretazione degli artt. 11, 13 e 15 del c.c.n.l. piloti Meridiana, nonché vizio della motivazione. La sentenza impugnata è censurata per
aver ritenuto che le disposizioni contrattuali, da una parte, escludessero che l’inidoneità
del pilota fosse causa di impossibilità di continuazione del rapporto di lavoro, a causa
della preferenza accordata per le assunzioni di personale di terra;
dall’altra, affermato che il diritto al preavviso, riconosciuto dall’art. 13 nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per malattia, inidoneità e infortunio non dipendenti da
causa di servizio, sussistesse anche nel caso di inidoneità permanente e specifica dichiarata dall’Istituto medico-legale. Si sostiene che la preferenza nelle assunzioni presuppone proprio la necessaria e automatica risoluzione del rapporto di lavoro con il pilota specificamente inidoneo; che l’ipotesi dell’impossibilità temporanea protratta oltre un certo
termine, che legittima il recesso con preavviso del datore di lavoro, non è assimilabile a
quella dell’inidoneità specifica, regolata dall’art. 13, lett. b, comma 5, nel senso che la
conservazione del posto è garantita soltanto per trenta giorni dopo la pronuncia dell’organo sanitario, ma senza diritto al preavviso.
2. La Corte giudica il ricorso fondato alla stregua delle considerazioni di seguito
svolte.
3. L’istituto del preavviso, regolato nell’art. 2118 cod. civ., corrisponde all’esigenza di
preavvertire tempestivamente il lavoratore della data di cessazione del rapporto, al fine
di consentirgli di trovare per tempo una nuova occupazione C (Cass. 9 giugno 1994 n.
5596). Il rapporto di lavoro prosegue a tutti gli effetti durante il relativo periodo, che
perciò è caratterizzato dalla cosiddetta efficacia reale (Cass. 1° giugno 1991 n. 6178, 6
agosto 1987 n. 6769; Cass. 6 febbraio 2004, n. 2318).
4. Peraltro, il preavviso è istituto che presuppone l’esercizio del potere di recesso dal
rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro, mediante negozio unilaterale recettizio.
Si pone quindi il problema se i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per le specifiche ipotesi previste dalla legge, siano suscettibili di risoluzione soltanto a seguito di iniziativa del datore di lavoro, ovvero se operi anche l’estinzione determinata dell’impossibilità sopravvenuta prevista in generale per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in ragione della definitiva alterazione del sinallagma (artt. 1256 e
1463 cod. civ.).
(Omissis)
8. Occorre perciò fornire risposta al quesito se il pilota dichiarato definitivamente
inidoneo al volo possa eseguire una qualche prestazione di lavoro nel periodo di preavviso, condizione questa essenziale, in quanto l’obbligo del datore di lavoro di corrispon-
ADL 1/2011
MARCO FERRARESI
135
dere l’indennità sostitutiva presuppone la scelta di non pretendere l’esecuzione di una
prestazione di lavoro fino alla scadenza del periodo.
In linea generale, il licenziamento per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle mansioni cui è adibito il lavoratore, viene ricondotto all’ipotesi del giustificato motivo
oggettivo (con diritto al preavviso) proprio perché non si può escludere l’impiego del dipendente in mansioni diverse (ancorché debba negarsi nel caso concreto, e in ciò sta la
giustificazione del recesso, che la continuazione del rapporto corrisponda ad un apprezzabile interesse delle parti: vedi Cass. 2 luglio 2009, n. 15500; 6 novembre 2002, n.
15593; Cass. S.u. 7 agosto 1998, n. 7755). Ebbene, con riguardo allo speciale rapporto di
lavoro dei piloti, deve escludersi l’indicata evenienza per il caso di inidoneità permanente al volo, che è l’unica prestazione lavorativa dedotta in questo particolare contratto di
lavoro. Non è configurabile, infatti, per il datore di lavoro, uno ius variandi che consenta di inserire il pilota nell’ambito del personale di terra senza che si produca una novazione del contratto e ciè è dimostrato, all’opposto di quanto ritenuto dal giudice del merito, proprio dalla contrattazione collettiva menzionata dalla sentenza impugnata, che
garantisce al pilota inidoneo al volo un diritto di preferenza per le “nuove” assunzioni
del personale di terra (art. 11). In conclusione, essendo precluso al datore di lavoro pretendere contrattualmente l’esecuzione di una prestazione diversa dal “volo”, va ravvisata nella fattispecie una causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione, neppure provvisoria ai sensi dell’art. 2119 c.c., con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’istituto di cui al precedente art. 2118 c.c.
9. Stabilito che non spetta per legge al pilota di aeromobile definitivamente inidoneo al volo il diritto al preavviso in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, occorre ancora verificare se il diritto gli sia ugualmente attribuito dalle disposizioni del
contratto collettivo, come ha ritenuto il giudice del merito con quella che si presenta a
tutti gli effetti come una seconda e alternativa motivazione. Questa motivazione è censurata con il secondo motivo di ricorso che merita anch’esso accoglimento per questa
parte (per la l’altra parte del motivo, concernente l’art. 11 del c.c.n.l., si rinvia alle considerazioni svolte sub n. 8).
10. La sentenza impugnata reca l’accertamento che il diritto al preavviso è contemplato dalle norme contrattuali per i licenziamenti intimati alla scadenza dei periodi di
comporto previsti per il caso di malattia, inidoneità ed infortuni non dipendenti da causa
di servizio (art. 13, lett. B), mentre, nel disciplinare l’ipotesi dell’inidoneità permanente e
specifica, il contratto non menziona l’indennità di preavviso. Giunge tuttavia alla conclusione del riconoscimento del diritto al preavviso anche nel caso di risoluzione del rapporto per inidoneità permanente e specifica al volo sul rilievo che nelle ipotesi di malattia, inidoneità e infortunio sussiste ugualmente l’impossibilità di eseguire la prestazione.
11. Siffatta conclusione merita le critiche della parte ricorrente perché, in violazione
dell’art. 1362 c.c., non risultano esaminate nella loro interezza le disposizioni contenute
all’art. 13, punto n. 5, lett. b), del contratto, relative alla disciplina della risoluzione del
rapporto di lavoro a seguito di “inidoneità permanente e specifica dichiarata dall’istituto
medico-legale, senza che siano trascorsi 24 mesi di malattia continuativa”. Soltanto l’esame di queste disposizioni avrebbe consentito di stabilire se l’ipotesi considerata costituisse una mera specificazione di quella più generale del licenziamento al termine del
periodo di comporto per malattia, inidoneità, temporanea o permanente, e infortuni non
dipendenti da causa di servizio; oppure se, al contrario, fosse da ritenere una causa di risoluzione del rapporto di lavoro del tutto autonoma, con la conseguente necessità di determinare il significato da attribuire alle parole usate nel contemplare la risoluzione del
rapporto di lavoro alla scadenza dei termini fissati, senza alcuna menzione della corresponsione dell’indennità di mancato preavviso.
ADL 1/2011
136
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - NOTE DI COMMENTO
12. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnava deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, perché nel
nuovo giudizio si proceda: a) a dare applicazione al principio di diritto secondo il quale
l’istituto del preavviso contemplato dall’art. 2118 c.c., non può trovare applicazione, salvo che la legge o il contratto non disponga diversamente, allorché l’esecuzione della prestazione di lavoro dedotta in contratto sia divenuta totalmente e assolutamente impossibile, come avviene nel caso del pilota di aeromobile inidoneo al volo, che può rendere
una diversa prestazione di lavoro nell’ambito del “personale di terra” soltanto in esecuzione di un contratto di lavoro diverso; b) ad accertare se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro controverso attribuisca l’indennità di mancato preavviso anche
in caso di risoluzione del rapporto con pilota inidoneo permanentemente al volo, compiendo l’indagine precisata al punto n. 11.
(Omissis)
Marco Ferraresi
Ricercatore dell’Università di Pavia
INIDONEITÀ PERMANENTE AL VOLO,
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE E
GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI LICENZIAMENTO
Sommario: 1. La fattispecie concreta. – 2. Mansioni di volo, esercizio del ius variandi e risoluzione di diritto. – 3. Assorbimento dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro nel giustificato motivo oggettivo di licenziamento. – 4. Non configurabilità della
“giusta causa oggettiva” e decorso del periodo di preavviso.
1. – Con questa sentenza la Cassazione si pronuncia sulla qualificazione della sopravvenuta e definitiva inidoneità all’esercizio delle mansioni di
pilota di aeromobile, quale causa di estinzione del rapporto di lavoro per
sopravvenuta impossibilità della prestazione.
Nella fattispecie in esame, a seguito di visita medico-legale viene accertata l’inidoneità permanente del lavoratore all’esercizio delle mansioni
suddette. I giudici del merito riconducono la fattispecie al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, di cui all’art. 3 della l. n. 604 del 1966, attribuendo dunque al lavoratore il diritto al periodo di preavviso o alla sua
indennità sostitutiva (diritto che, secondo il lavoratore, si sarebbe in ogni
modo desunto dalle disposizioni contrattuali collettive).
La società ricorrente ritiene invece che la condizione personale del lavoratore configuri una impossibilità assoluta sopravvenuta della prestazione, causa di estinzione automatica del rapporto in quanto non dipendente
dall’esercizio di una volontà di recesso da parte del datore e con esclusione,
pertanto, del preavviso. Del resto, il periodo di preavviso presupporrebbe
l’obbligo della prestazione, nel caso di specie non più possibile. Inoltre, il
ADL 1/2011
MARCO FERRARESI
137
contratto collettivo, contemplando specificamente questa ipotesi, prevedeva unicamente la conservazione del posto di lavoro per trenta giorni e un diritto di precedenza nelle “nuove assunzioni” di personale di terra.
La S.C. è dunque chiamata a dirimere il dubbio se l’impossibilità sopravvenuta, totale e definitiva, della prestazione di lavoro dia luogo ad una
automatica estinzione del rapporto, sulla base del diritto comune delle obbligazioni e dei contratti, oppure debba regolarsi ex l. n. 604 del 1966, dunque ai sensi della disciplina sui licenziamenti (e con diritto al preavviso).
A tal fine, ritiene anzitutto necessario verificare la possibilità di adibire
il lavoratore ad altre mansioni nell’ambito dell’organizzazione del datore.
Proprio la necessità di tale verifica, corrispondente per giurisprudenza costante all’obbligo di repêchage, farebbe propendere “in linea generale” per
la valutazione della condizione del lavoratore alla stregua del giustificato
motivo oggettivo di licenziamento. Tuttavia, la peculiarità dell’oggetto della prestazione dello speciale rapporto di lavoro dei piloti escluderebbe comunque la possibilità di collocare il lavoratore in altre mansioni, impedendo così l’esercizio del ius variandi. Così che l’unica soluzione atta a garantire un impiego al lavoratore divenuto inidoneo sarebbe quella – prevista dal
contratto collettivo – di una “nuova assunzione” presso il personale di terra. Ma, appunto, una nuova costituzione di rapporto di lavoro sottende la
necessaria estinzione del pregresso, per cui la pretesa adibizione ad altre
mansioni darebbe luogo, in realtà, ad una novazione contrattuale.
La Corte ritiene così che « essendo precluso al datore di lavoro pretendere contrattualmente l’esecuzione di una prestazione diversa dal “volo”,
va ravvisata nella fattispecie una causa di risoluzione del rapporto che non
ne consente la prosecuzione, neppure provvisoria ai sensi dell’art. 2119
Cod. Civ., con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’istituto di cui
al precedente art. 2118 Cod. Civ.».
La sentenza solleva numerose ed importanti questioni: preliminarmente, se l’adibizione del pilota a mansioni diverse da quelle di assunzione
comporti in ogni caso la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; se l’estinzione del rapporto sia disciplinata dalle norme del codice della navigazione, ivi incluse le fattispecie di risoluzione di diritto; se, escludendosi tale possibilità, l’inidoneità permanente del pilota di volo possa configurare
un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, con diritto al preavviso,
oppure una causa di estinzione dell’obbligazione ex art. 1256 Cod. Civ. e di
risoluzione del contratto ex art. 1463 Cod. Civ., oppure ancora una giusta
causa “oggettiva” ex art. 2119 Cod. Civ. (in queste ultime tre ipotesi senza
diritto al preavviso, salva diversa previsione contrattuale); se il decorso del
periodo di preavviso sia incompatibile con la sopravvenuta impossibilità
della prestazione.
ADL 1/2011
138
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - NOTE DI COMMENTO
2. – Come detto, la Corte con questa pronuncia afferma di aderire in linea di principio all’orientamento prevalente, secondo cui l’impossibilità
sopravvenuta della prestazione deve riguardarsi, agli effetti estintivi del
rapporto di lavoro, in base alla l. n. 604 del 1966. Essa tuttavia si domanda
se ciò valga anche per il caso di piloti divenuti totalmente inidonei al volo.
Per essi, infatti, non sarebbe in ogni caso esercitabile il ius variandi in
adempimento dell’obbligo di repêchage, posto che l’unico possibile oggetto
del proprio (speciale) contratto di lavoro è appunto costituito dalle mansioni di pilota.
In effetti, in virtù della specialità di tale contratto (1), il novero delle
mansioni esercitabili sembra circoscritto in un ambito più ristretto di quello normalmente praticabile ex art. 2103 Cod. Civ. L’art. 13, l. n. 300 del 1970,
infatti, non è tra le disposizioni direttamente applicabili ai lavoratori della
navigazione, ma tra quelle adattabili dalla contrattazione collettiva (cfr. art.
35, comma 3, l. n. 300 del 1970). Il mutamento di mansioni è invece direttamente regolato, per i piloti di volo, dall’art. 905 Cod. Nav., per il cui comma 2 “il comandante dell’aeromobile, nell’interesse della navigazione, ha
facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti, purché non sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado”. La disposizione, ritenuta assolutamente inderogabile in quanto finalizzata alla tutela di interessi pubblici,
permette dunque solo mutamenti temporanei e pur sempre inerenti alla
“categoria” e al “grado” (2).
(1) Sul significato di tale specialità, v. L. Menghini, I contratti di lavoro nel diritto della navigazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu - F. Messineo - L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 1996, pag. 61 e segg.; L. Scotti, Lavoro aereo e nautico – I) Diritto del lavoro, in Enc. Giur. Treccani, 1990; E. Minale Costa, Lavoro nella navigazione, in Digesto, Discipline privatistiche – Sez. commerciale, Torino, 1992, pag. 401 e segg. secondo
Corte cost. 3 aprile 1987, n. 96, « il contratto di arruolamento – sottotipo qualificato del rapporto di lavoro comune – inserisce l’arruolato nell’equipaggio della nave e nella comunità di
lavoro a bordo, che, con il complesso delle sue prestazioni, concorre al raggiungimento dei fini della spedizione marittima, ai quali non sono estranei interessi di ordine generale ».
(2) Cfr. Cass. 18 gennaio 1991, n. 443, che dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. dell’art. 35, l. n. 300 del 1970 nella parte in cui
non prevede la diretta applicazione dell’art. 13, l. n. 300 del 1970 al personale della navigazione, ritenendo sufficiente la tutela dettata dall’art. 334 Cod. Nav. (che regola il mutamento di
mansioni per i lavoratori marittimi, in termini analoghi a quelli dei piloti). In dottrina, v. L.
Menghini, I contratti di lavoro nel diritto della navigazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu - F. Messineo - L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano,
1996, pag. 416 e segg., il quale rileva come il problema del mutamento di mansioni si sia posto
solo per l’adibizione a mansioni superiori: anche in tal caso, l’art. 13, l. n. 300 del 1970 incontrerebbe il limite della disciplina pubblicistica, assolutamente inderogabile, sulle qualifiche
d’iscrizione e sui titoli professionali.
ADL 1/2011
MARCO FERRARESI
139
Anche la recente giurisprudenza di legittimità sembra confermare l’interpretazione restrittiva. La Cassazione ha infatti avuto modo di precisare
che, sebbene il compimento del sessantesimo anno di età inibisca l’esercizio dei compiti di pilota comandante e di copilota, esso non determina l’estinzione automatica del rapporto, potendo il pilota « essere adibito oltre
tale data e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età alle
mansioni di terzo pilota » (3): pur sempre, dunque, nell’ambito della (anche
se ridotta) abilitazione professionale. Inoltre, se al sessantesimo anno di età
il lavoratore non ha ancora maturato i requisiti pensionistici, « il datore di
lavoro è tenuto a rinvenire nell’organizzazione aziendale mansioni compatibili con la ridotta abilitazione del pilota » (4).
La S.C. sembra poi dare per scontata l’inapplicabilità al caso in esame
delle fattispecie estintive disciplinate dal codice della navigazione. Di esse
infatti non fa menzione, preoccupandosi unicamente dell’alternativa tra risoluzione di diritto comune o recesso di diritto del lavoro (nonostante la
sopra richiamata disposizione del contratto collettivo paia ricalcare una
ipotesi di risoluzione di diritto, differita al trentesimo giorno successivo all’accertamento della inidoneità al volo). Essa aderisce così implicitamente a
quell’orientamento giurisprudenziale e dottrinale che, successivamente alle pronunce della Corte costituzionale in materia (5), esclude (di massima)
la persistente applicabilità ai rapporti di lavoro nautico della relativa disciplina speciale, inclusiva di ipotesi di recesso ad nutum e di risoluzione di diritto, per assoggettarli alla normativa limitativa dei licenziamenti del lavoro
privato (6).
In definitiva, secondo la Corte, la totale inidoneità alle mansioni renderebbe impraticabile il repêchage e, di conseguenza, inapplicabile la regola del
giustificato motivo oggettivo di licenziamento, per integrare piuttosto una
causa di estinzione immediata, di “risoluzione del rapporto”, addirittura tale
da non consentirne nemmeno la provvisoria prosecuzione, “ai sensi dell’art.
2119”. Con l’effetto, conclusivamente, di escludere il diritto al preavviso.
Invero, tale ricostruzione non convince.
3. – Anzitutto, desta perplessità condizionare l’attrazione della impossibilità sopravvenuta della prestazione nell’area del giustificato motivo og(3) Cass. 30 giugno 2009, n. 15349.
(4) Cass., ult. cit. V. anche Cass. 28 aprile 2004, n. 8161.
(5) Corte cost. 31 gennaio 1991, n. 46; 3 aprile 1987, n. 96.
(6) V. Cass. 23 marzo 2009, n. 6979; 6 novembre 2002, n. 15593. In dottrina, cfr. ancora L.
Menghini, I contratti di lavoro nel diritto della navigazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu - F. Messineo - L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano,
1996, pag. 472 e segg. e pag. 641 e segg.
ADL 1/2011
140
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - NOTE DI COMMENTO
gettivo alla verifica dell’eventuale reinserimento del lavoratore in altra posizione dell’organizzazione datoriale (7). Infatti, l’obbligo di repêchage presuppone, e non fonda, l’applicabilità del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Solo allorché la fattispecie concreta sia ricondotta al vaglio di
tale principio è possibile effettuare l’anzidetta verifica. L’individuazione
dell’obbligo di repêchage è peraltro conclusione, non premessa, di una elaborazione giurisprudenziale intorno al concetto stesso di giustificato motivo oggettivo (8). La Corte, pur non giungendo a teorizzare tale inversione
(trattandosi di una pronuncia che, come si vedrà, verte in definitiva sul diritto al preavviso), incorre di fatto in una petizione di principio. Giova qui
ricordare che fattispecie di impossibilità sopravvenuta della prestazione,
per inidoneità fisica del lavoratore sono state qualificate dalla S.C. come
giustificato motivo oggettivo di licenziamento ancor prima che si formasse
un orientamento consolidato sull’esistenza dell’obbligo di repêchage in tali
casi (9). Il repêchage resta dunque una mera eventualità, dipendente dalla
sussistenza di condizioni di praticabilità in concreto.
Ad ogni modo, non si ritiene di doversi discostare dall’orientamento
predominante sia in dottrina sia in giurisprudenza, che riconduce alla regola del giustificato motivo ogni fattispecie di impossibilità sopravvenuta
della prestazione di lavoro per eventi inerenti la persona del lavoratore,
disapplicando il diritto comune.
Tale tesi si fonda su plurimi e convincenti argomenti. In primo luogo, è
d’uopo richiamare la specialità del regime lavoristico del recesso rispetto a
quello di diritto comune, con conseguente prevalenza del primo. Specialità, del resto, sorretta da una evidente ratio di tutela del contraente più debole, estranea alle fattispecie estintive di cui al codice civile.
Inoltre, risultano difficilmente praticabili ipotesi di estinzione “automatica”, come quella ex art. 1256, comma 2, Cod. Civ. (10), nel rapporto di
lavoro subordinato, posto che, nell’ambito delle prestazioni di durata destinate ad integrarsi in un’organizzazione, sembra ragionevole attendersi
(7) V. punto 8 della motivazione in diritto.
(8) M.T. Carinci, Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato, Padova,
2005, pagg. 20-21.
(9) V., ad es., Cass. 21 maggio 1992, n. 6106, per un caso di perdita definitiva della capacità lavorativa. È solo con Cass., Sez. Un., 7 agosto 1998, n. 7755 (in Riv. It. Dir. Lav., 1999, II,
pag. 170, con nota di G. Pera, Della licenziabilità o no del lavoratore divenuto totalmente inabile)
che l’organo di legittimità prende posizione per la sussistenza di tale obbligo nei casi di sopravvenuta inidoneità fisica.
(10) Mentre nella giurisprudenza più risalente è proprio sulla base dell’art. 1256 (in combinato disposto con l’art. 1463 Cod. Civ.) che vengono risolte le controversie in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, alla stregua dunque di fattispecie di risoluzione di
diritto: v., tra le tante, Cass. 21 gennaio 1988, n. 474.
ADL 1/2011
MARCO FERRARESI
141
che il creditore, il quale ritenga venuto meno l’interesse all’adempimento
dell’obbligazione di lavoro, esterni tale convincimento attraverso un atto
negoziale idoneo, ossia il recesso (11). Ed il recesso datoriale, per l’art. 1
della l. n. 604 del 1966, non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo (salvo naturalmente il regime di cui all’art. 2110 Cod. Civ.) (12).
Frequente è poi il richiamo giurisprudenziale dell’art. 1464 Cod. Civ.,
per il quale “quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte [ . . . ] può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”. Invero, dottrina autorevole ha contestato la diretta riferibilità del concetto di
impossibilità parziale, espresso dalla citata disposizione, alla prestazione di
lavoro, posto che la parzialità contemplata da detta norma dovrebbe inerire ad un facere istantaneo (13). Mentre, nei contratti di durata, sia che ci si
voglia rifare al principio per cui operae praeteritae sunt peritae (dunque le
prestazioni passate sono divenute definitivamente e totalmente impossibili), sia che si ritenga che le prestazioni di lavoro siano, di regola, sempre
eseguibili anche in seguito, dovrebbe al più parlarsi di impossibilità parziale ratione temporis. Ma allora l’interesse del creditore dovrebbe essere apprezzato piuttosto con riguardo alla perdita economica dovuta al protrarsi
della mancata esecuzione della prestazione, più che alla “residua” prestazione successiva alla eventuale cessazione dell’impedimento.
(11) Per Cass. 11 luglio 2001, n. 9407, nei casi di impossibilità sopravvenuta “le caratteristiche di personalità del rapporto di lavoro e le esigenze di certezza sulla sua permanenza concorrono a far ritenere necessario un negozio risolutivo”. Cass. 16 gennaio 1975, n. 176, in Foro
It., 1976, I, col. 220, pur aderendo all’orientamento allora del tutto prevalente secondo cui l’impossibilità sopravvenuta dovrebbe valutarsi ex artt. 1256 e 1463 Cod. Civ., non esclude che il
datore di lavoro possa scegliere di avvalersi delle forme del recesso ex lege n. 604 del 1966 per
manifestare l’assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico. Secondo P.
Ichino, Il contratto di lavoro – III, Milano, 2003, pag. 449, il disposto di cui all’art. 1256, comma
2, è da ritenersi riferito alle prestazioni istantanee, perché “solo queste, a ben vedere, non le
prestazioni a carattere continuativo, sono suscettibili di « ritardo » nell’esecuzione”. Di diverso avviso T. Schiavone, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, in Riv. It. Dir.
Lav., 2010, I, pag. 159, per la quale tuttavia “le peculiarità della materia lavoristica impediscono di considerare la sopravvenuta impossibilità di svolgimento delle mansioni contrattuali
[ . . . ] come causa di risoluzione di diritto” (ibidem, pag. 183). V. però, per una fattispecie di
contratto d’opera intellettuale, Cass. 18 novembre 2003, n. 17464, in base alla quale il provvedimento giurisdizionale di annullamento dell’atto di nomina a direttore generale di Asl determina la sopravvenuta e totale impossibilità della prestazione per il combinato disposto degli
artt. 1256 e 1463 Cod. Civ.
(12) Cfr. M.V. Ballestrero, Giusta causa e giustificato motivo soggettivo di licenziamento, in F.
Carinci (a cura di), La disciplina dei licenziamenti dopo le leggi 108/1990 e 223/1991, Napoli,
1991, pagg. 107-108.
(13) L. Mengoni, Note sull’inadempimento involontario dell’obbligazione di lavoro, in Riv.
Trim. Dir. Proc. Civ., 1950, pag. 282.
ADL 1/2011
142
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - NOTE DI COMMENTO
In ogni caso, la giurisprudenza sembra oggi eludere il problema, poiché, richiamato l’art. 1464 Cod. Civ., ritiene che l’apprezzamento dell’interesse del datore di lavoro, nelle ipotesi di impossibilità di esecuzione della
prestazione non riconducibili all’art. 2110 Cod. Civ., debba valutarsi con riguardo all’incidenza dell’impedimento sulla attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa (art. 3, l. n. 604 del
1966) (14).
In definitiva, il richiamo della fattispecie codicistica appare meramente
strumentale (ed eventuale) e volto a ricondurre al giustificato motivo oggettivo situazioni che non ineriscono direttamente all’organizzazione e all’attività d’impresa, ma traggono origine da condizioni personali del lavoratore, non ascrivibili a giusta causa o giustificato motivo (15) (e salvo, come
detto, l’obbligo del repêchage) (16).
Possono così integrare giustificato motivo oggettivo di licenziamento,
ad esempio, l’impossibilità sopravvenuta determinata dalla revoca di un
porto d’armi (17), di un tesserino per l’accesso all’area aeroportuale (18), la
scadenza di una patente di guida di un autotrasportatore (19), la carcerazione preventiva del lavoratore (20), la scadenza del visto o del permesso
di soggiorno (21) e, appunto, la sopravvenuta inidoneità fisica, qualora il
lavoratore non possa essere utilmente reimpiegato nell’organizzazione
d’impresa, eventualmente anche attraverso l’adibizione a mansioni inferiori (22).
Si è anche sostenuta l’applicabilità, ai casi di sopravvenuta impossibilità per inidoneità fisica, dell’art. 2110 Cod. Civ., in quanto dovrebbe tutelar-
(14) Questa sembra anche la tesi predominante in dottrina. Cfr. ad es. G. Pera, Licenziamenti: I, in Enc. Giur. Trecani, Roma, 1990, pag. 18.
(15) Per questo motivo, una parte della dottrina ritiene il richiamo dell’art. 1464 Cod. Civ.
sia null’altro che un omaggio formale alla tradizione civilistica o comunque ultroneo. Contra,
M. Napoli, La stabilità reale del rapporto di lavoro, Milano, 1980, pagg. 349-353, il quale tuttavia ritiene che la fattispecie della carcerazione preventiva costituisca un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta ex art. 1464 Cod. Civ., dove il persistente interesse del creditore all’adempimento dovrebbe accertarsi ex art. 3, l. n. 604 del 1966 (v. anche Id., Licenziamenti, in Digesto –
Discipline privatistiche, Sez. comm., Torino, 1993, pagg. 92-93).
(16) Diverso è invece l’orientamento con riguardo ai casi di cessazione definitiva dell’attività aziendale, per i quali la giurisprudenza richiama ancora l’impossibilità sopravvenuta di diritto comune: v. da ultimo Cass. 26 giugno 2009, n. 15073; 2 dicembre 2002, n. 17079.
(17) Cass. 25 luglio 2006, n. 16924.
(18) Cass. 17 marzo 2010, n. 6517; 14 aprile 2005, n. 7726.
(19) Cass. 19 dicembre 1998, n. 12719.
(20) Cass. 18 febbraio 1992, n. 1966.
(21) Cass. 11 luglio 2001, n. 9407.
(22) V. la recente Cass. 30 marzo 2009, n. 7701. Cfr. anche 14 ottobre 2010, n. 21203; 2 luglio 2009, n. 15500; 28 ottobre 2008, n. 25883.
ADL 1/2011
MARCO FERRARESI
143
si a fortiori la fattispecie, più grave, della impossibilità definitiva (23). Tuttavia, l’art. 2110 Cod. Civ. si riferisce alle sole ipotesi di impossibilità temporanea e, derogando al principio sinallagmatico che comporterebbe la sospensione dell’obbligazione retributiva durante il periodo protetto, è inapplicabile in via analogica in quanto norma eccezionale (24).
4. – Infine, non sembra configurabile una giusta causa “oggettiva”, come adombrata nella pronuncia in commento (“va ravvisata nella fattispecie
una causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione,
neppure provvisoria ai sensi dell’art. 2119 Cod. Civ.”). Della possibilità di
includere nella nozione di giusta causa anche eventi non riferibili a colpa
del prestatore di lavoro non vi è più traccia nel diritto vivente (25). Gli argomenti utilizzati in passato in senso estensivo, perlopiù facenti perno sull’ampia lettera dell’art. 2119 Cod. Civ. (anche in relazione al disposto di cui
all’art. 9, r.d. 13 novembre 1924, n. 1825 sull’impiego privato) (26), sono stati efficacemente confutati dalla dottrina (27). Sicché pare corretto affermare che « ciò che resta della c.d. “concezione oggettiva” della giusta causa
[ . . . ] consiste soltanto in questo: che [ . . . ] ai fini della sussistenza della giusta causa la mancanza del lavoratore deve essere valutata anche nella sua
(23) P. Ichino, Il contratto di lavoro – III, Milano, 2003, pagg. 448-449.
(24) Così, Cass. n. 7701 del 2009, cit. (e ivi ulteriori richiami), secondo cui, in caso di inabilità definitiva alle mansioni, il datore di lavoro non è tenuto ad attendere il decorso del periodo di comporto, in quanto l’art. 2110 Cod. Civ. “presuppone la diversa ipotesi dell’impedimento temporaneo del lavoratore affetto da malattia, tale da consentire, una volta che questa
sia cessata, la ripresa del lavoro senza rischi di ulteriore usura dell’integrità fisica”.
(25) Di una nozione oggettiva di giusta causa, infatti, la giurisprudenza non fa più uso, a
quanto consta, da Cass. 24 settembre 1991, n. 9953 (peraltro obiter dictum). In precedenza, cfr.
Cass. 7 maggio 1986, n. 3070, con riferimento ad un licenziamento, qualificato per giusta causa, di alcuni insegnati di religione sprovvisti della necessaria abilitazione all’insegnamento
della materia; Cass. 24 luglio 1968, n. 2688 (in Foro It., 1968, I, col. 2733, con nota di G. Pera,
Sull’evoluzione della “giusta causa” nel rapporto di lavoro subordinato), con riferimento però ad
una fattispecie di impossibilità sopravvenuta di effettuare la prestazione per ricovero del datore di lavoro in una clinica neuropsichiatrica.
(26) “Non è dovuta disdetta, né indennità nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto”: dove appunto il termine “mancanza”, poi sostituito dal più
neutro “causa”, denotava il carattere soggettivo. Secondo P. Ichino, Il contratto di lavoro – III,
Milano, 2003, pag. 479, ciò denoterebbe appunto la volontà del legislatore “di consentire il recesso in tronco per qualsiasi impedimento drastico alla risoluzione del rapporto, anche se di
natura oggettiva, quale l’impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione lavorativa”.
(27) V., anche per una ricostruzione storica, P. Tullini, Contributo alla teoria del licenziamento per giusta causa, Milano, 1994, pag. 233 e segg. Cfr. anche F. Mazziotti, I licenziamenti dopo la l. 11 maggio 1990, n. 108, Torino, 1991, pag. 25 e segg. Per una rassegna dottrinale, v. R.
Diamanti, Recesso per giusta causa, in O. Mazzotta (a cura di), I licenziamenti. Commentario, Milano, 1999, pag. 42 e segg.
ADL 1/2011
144
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - NOTE DI COMMENTO
suscettibilità di far venire meno la necessaria fiducia del datore nel futuro
regolare svolgimento del rapporto » (28).
Esclusa la possibilità di richiamare la giusta causa, residua il dubbio circa la praticabilità del recesso con preavviso. Quest’ultimo, secondo le parole della pronuncia in commento, « non può trovare applicazione, salvo che
la legge o il contratto non disponga diversamente, allorché l’esecuzione
della prestazione di lavoro dedotta in contratto sia divenuta totalmente e
assolutamente impossibile ».
Anche a non voler accogliere la tesi per cui il preavviso non lavorato,
per fatto non imputabile al lavoratore, costituisca comunque titolo per conseguire l’indennità sostitutiva (in quanto parte del “contenuto assicurativo”
del contratto di lavoro o, secondo altri, in conformità ad una ratio assistenziale ad essa immanente) (29), occorre preliminarmente considerare che il
preavviso sortisce effetti anche ad altri fini (per la maturazione del t.f.r., degli scatti di anzianità, per il conseguimento di aumenti retributivi derivanti
ad esempio dal rinnovo del contratto collettivo, ecc.).
La soluzione di tale questione, a ben vedere, è implicita nella prevalenza
da accordare al regime speciale del recesso nei rapporti di lavoro, rispetto alle ipotesi risolutive di diritto comune. Posto infatti che il licenziamento per
giustificato motivo è “con preavviso” (ex art. 3 della l. n. 604 del 1966), il termine di cui all’art. 2118 Cod. Civ. – in assenza come in questo caso della corresponsione della indennità sostitutiva in favore del prestatore, la quale sola
potrebbe consentire l’estinzione immediata del rapporto (30) – dovrà necessariamente essere concesso, a differenza di quanto potrebbe concludersi optando vuoi per la configurabilità di una giusta causa “oggettiva”, vuoi applicando le norme del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta.
Altro è domandarsi, però, se la mancata esecuzione della prestazione
obblighi in ogni caso il datore di lavoro a corrispondere l’indennità sostitutiva. Sul punto, salvo naturalmente voler aderire all’opinione sopra riportata circa la natura “assicurativa” di tale compenso, sembra che il principio di
corrispettività permeante lo svolgimento del rapporto di lavoro, che soffre
eccezioni nelle sole ipotesi tassativamente predeterminate dal legislatore,
dovrebbe far propendere per una risposta negativa.
(28) P. Ichino, Il contratto di lavoro – III, Milano, 2003, pagg. 479-480.
(29) In senso positivo, F. Mazziotti, I licenziamenti dopo la l. 11 maggio 1990, n. 108, Torino, pagg. 50-51; G. Pera, La cessazione del rapporto di lavoro, Padova, 1980, pag. 39; R. Del Punta, Studi giuridici sulla malattia, Milano, 1988, pag. 313. Così anche Cass. 3 giugno 1992, n.
6757. Contra, Trib. Milano 11 novembre 1977, in Orient. Giur. Lav., 1977, pag. 1247.
(30) Anche senza accettazione da parte del lavoratore, secondo l’orientamento che è andato consolidandosi negli ultimi anni: cfr. Cass. 4 novembre 2010, n. 22443; 5 ottobre 2009, n.
21216; 16 giugno 2009, n. 13959; 11 giugno 2008, n. 15495; 21 maggio 2007, n. 11740.
ADL 1/2011
MARCO FERRARESI
145
In definitiva, in fattispecie come quella in commento, è da ritenere che
il preavviso possa e debba essere concesso, pur in difetto di prestazione e
quindi di retribuzione, con effetti limitati alle sole conseguenze delle altre
vicende giuridiche eventualmente occorrenti medio tempore.
ADL 1/2011
Cass., Sez. Lav., 23 aprile 2010, n. 9700 – Pres. De Renzis – Est. Di Nubila – A.M.I.U. S.p.a. c. F.P.
Inidoneità fisica sopravvenuta – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Obbligazioni datoriali – Oneri probatori e repêchage.
L’inidoneità sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni contrattualmente previste integra un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3 legge n.
604 del 1966 da parte del datore di lavoro, sul quale ricade l’onere di dimostrare
l’impossibilità di una diversa, ma pur sempre apprezzabile, collocazione del lavoratore nell’attuale ambito aziendale, senza che tuttavia questo si traduca in un obbligo di modifica della struttura organizzativa.
Svolgimento del processo
1. F.P. adiva il Tribunale di Genova ed esponeva di avere prestato il proprio lavoro
alle dipendenze dell’AMIU, quale autista addetto alla raccolta rifiuti. Sottoposto a visita
medica e ritenuto non più idoneo alla guida dei mezzi pesanti, gli veniva prospettata l’assunzione alla dipendenze dell’ADEC come raccoglitore ed in tal modo veniva gravemente dequalificato. Subiva quindi una serie di vessazioni e di provvedimenti disciplinari; riportava vari infortuni sul lavoro, in particolare una lesione al tendine dovuta al
sollevamento di pesantissimi cassonetti. Previa nuova visita medica, veniva licenziato per
asserita impossibilità di utilizzazione in altre mansioni. Veniva tenuta una riunione congiunta con le organizzazioni sindacali, a sensi dell’art. 40 del vigente CCNL, ma senza
esito. In sede di procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., l’attore veniva reintegrato nel
posto di lavoro ed il provvedimento era confermato in sede di reclamo. Instaurato il giudizio di merito, l’azienda eccepiva che il lavoratore aveva totalizzato circa 500 giorni di
assenza nei primi due anni, aveva cercato in due occasioni di far passare come infortuni
sul lavoro episodi di comune malattia.
L’inidoneità al lavoro era stata confermata dall’Istituto di Medicina del Lavoro della
locale Università. Non esistevano possibilità di reinserimento.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, motivando nel senso che il F. poteva
essere adibito ai servizi interni, nell’ambito di apposita unità. Proponeva appello l’AMIU.
Resisteva il F. . La Corte di Appello di Genova riformava la sentenza di primo grado e respingeva la domanda attrice. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:
– è pacifico che il F. non è più in grado di svolgere le mansioni di ADEC;
– esistono nell’azienda n. 19,5 posizioni di “addetto ai servizi interni”, ma l’azienda
convenuta ha dimostrato che tale unità è al completo;
– vero è che nella citata unità figura una tale P., elemento di fatto inidoneo in via
temporanea, ma tale requisito non rileva in quanto la costituzione di tale unità era frutto
di una determinazione dell’azienda e non un obbligo;
– l’attore non ha allegato nel ricorso la possibilità concreta di “repêchage”;
– peraltro l’azienda ha provato che non era possibile utilizzare il F. nei servizi interni.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione F.P., deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’AMIU, la quale eccepisce “in limine” l’inammissibilità del ricorso avversario.
Le parti hanno presentato memorie integrative.
ADL 1/2011
STEFANO MARIA CORSO
147
Motivi della decisione
4. L’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’AMIU si fonda sulla mancanza di (valida) sottoscrizione da parte del difensore avv. Tufani, unico abilitato alla difesa in Cassazione, della procura. L’eccezione è infondata, in quanto ad una attenta lettura dell’atto si rileva che il mandato con l’autentica della firma del F. è sottoscritto dall’avv. Tufani, la cui firma corrisponde a quella in calce al ricorso stesso (pag. 36) ed alla
memoria integrativa.
5. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 40 del CCNL di categoria, L. n. 604 del
1966, artt. 5, 1 e 3, artt. 1366, 1363, 1364, 2103 e 2110 Cod. Civ., sotto il profilo che in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore occorre dimostrare
l’inesistenza di altre attività, anche di livello inferiore, nelle quali il lavoratore stesso può
essere utilizzato.
La Corte di Appello introduce una sorta di inversione dell’onere della prova, ritenendo che l’esito infruttuoso della riunione ex art. 40 citato esoneri l’azienda dal tentativo di “repêchage”.
6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione delle stesse
norme di cui al motivo primo, oltre a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5:
l’onere probatorio incombente sull’azienda deve essere valutato con particolare rigore. Nella specie, proprio mediante l’istituzione della figura dell’addetto ai servizi interni si è inteso fornire una più intensa tutela al lavoratore. Nella specie non si è dimostrato che l’unità operativa degli addetti ai servizi interni non potesse tollerare una presenza in più.
7. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce ulteriore vizio di motivazione
sul punto inerente all’organico dell’unità addetti ai servizi interni, perché la Corte di Appello non ha accertato se il numero delle unità stesse non fosse assolutamente immodificabile in aumento, tenuto anche conto che tale Traverso non poteva esservi compreso
in quanto invalido.
8. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra
loro strettamente connessi. Essi risultano infondati.
La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è
stato assunto (autista) e nelle quali è stato successivamente utilizzato (raccoglitore) costituisce giustificato motivo di natura oggettiva che legittima la risoluzione del rapporto
di lavoro. Tale giustificato motivo è stato integrato dalla giurisprudenza mediante la teoria del c.d. “repêchage”, vale a dire la dimostrazione che non è possibile assegnare il lavoratore a diverse mansioni. Nella specie, a prescindere da un onere di allegazione che
la Corte di Appello ha addebitato al lavoratore, il giudice di merito ha accertato la sussistenza del giustificato motivo e la mancanza di possibilità di “repêchage” con motivazione adeguata, immune da vizi logici o da contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni
possibilità di riesame e di censura in sede di legittimità. È stato infatti dato atto dell’esito infruttuoso di apposito incontro previsto al riguardo dal contratto collettivo con la
partecipazione delle organizzazioni sindacali; è stato accertato che nell’ambito dell’azienda esiste un congruo numero di dipendenti addetti ai servizi interni, vale a dire una
unità nella quale vengono collocati i lavoratore non idonei. Ma tale unità, come accertato dalla Corte di Appello, era completa e comunque devesi dare atto che la previsione di
una siffatta unità costituisce un di più rispetto al mero dato normativo, posto che la legge non obbliga il datore di lavoro a creare apposite unità dove collocare il personale non
altrimenti utilizzabile nelle mansioni proprie della produzione svolta. In sostanza, la
ADL 1/2011
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
148
Corte di Appello ha accertato l’impossibilità di utilizzare diversamente il lavoratore in altre mansioni e tale statuizione non è soggetta a diversa valutazione. In questa sede, non
è possibile riesaminare il merito, onde stabilire se uno o più lavoratori fossero inseriti
nella struttura in questione senza averne titolo. In definitiva, il ricorso per Cassazione si
risolve in una censura in fatto alla sentenza impugnata, onde va rigettato.
(Omissis)
Stefano Maria Corso
Dottorando di ricerca dell’Università L. Bocconi di Milano
INIDONEITÀ SOPRAVVENUTA DEL LAVORATORE
E LIMITI DEL “REPÊCHAGE” SECONDO UNA RECENTE
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Sommario: 1. L’inidoneità sopravvenuta e le obbligazioni datoriali. – 2. Repêchage ed oneri
probatori. – 3. Il principio di diritto.
1. – Il contratto di lavoro subordinato (art. 2094 Cod. Civ.) si presenta,
come un contratto a prestazioni corrispettive (v. artt. 1453 e segg. Cod.
Civ.) in quanto il datore di lavoro si obbliga alla retribuzione di una prestazione e il lavoratore presta la sua opera dietro corrispettivo.
Ciò non toglie che la particolare rilevanza della materia giustifichi la
previsione di ipotesi di permanere dell’obbligo della retribuzione pur in
mancanza della prestazione di lavoro.
Questa tutela (anche di rango costituzionale ex art. 35 Cost.) della stabilità del posto di lavoro (1) da un lato, trova giustificazione nei limiti che
l’iniziativa economica privata incontra laddove ad essa si contrappongano
l’utilità sociale e la dignità della persona (art. 41, comma 2, Cost.) (2), dall’altro non può non essere disciplinata con rigore dal legislatore, dovendosi riconoscere spazio all’interesse del datore di lavoro a mantenere alle pro(1) Per un approccio esaustivo al problema si vedano: G. Loy, Capacità fisica e rapporto di
lavoro, Milano, 1993 e L. Nogler, La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i “principi” costituzionali, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2007, pag. 598.
(2) La tutela della salute quale interesse collettivo e individuale e l’interesse specifico dal
datore di lavoro a che soltanto nei casi di effettiva malattia ci sia la traslazione a suo carico del
rischio di retribuzione senza controprestazione trovano una risposta in puntuali modalità di
controllo sulle condizioni di salute del lavoratore: da ultimo, cfr. S. Pizziolo, L’accertamento
dell’impedimento alla prestazione per ragioni di salute, in Lav. Giur., 2010, n. 7, pag. 665.
Più in generale cfr. R. Del Punta, Commento all’art. 2110, in Aa.Vv., La sospensione del rapporto di lavoro, a cura di P. Schlesinger, Milano, 1992, pagg. 375 e segg.
ADL 1/2011
STEFANO MARIA CORSO
149
prie dipendenze (e a retribuire sine die) soltanto chi lavora e produce; a poter organizzare la propria azienda in termini di razionalità ed efficienza e a
non caricarsi di oneri patrimoniali che – ove rispondenti, come nel caso, ad
una finalità assistenziale assolutamente innegabile – propriamente dovrebbero ricadere sulla collettività, più che sul singolo, sub specie di previdenza
ed assistenza sociale (3).
Nella fattispecie concreta – su cui è intervenuta la sentenza in esame –
il lavoratore, assunto con mansioni di guidatore di mezzi pesanti impiegati
nella raccolta dei rifiuti, prima è risultato inidoneo – per cause sopravvenute non precisate in motivazione, ma che potrebbero essere identificate in
“episodi di malattia comune” (e, quindi, non professionale) – allo svolgimento della mansione contrattualmente prevista, donde il suo impiego in
una mansione diversa (raccoglitore di rifiuti); poi è risultato fisicamente
inidoneo a detta ulteriore mansione causa l’aggravamento delle condizioni
fisiche (e, quindi, una causa sopravvenuta) determinato, secondo il lavoratore, da “vari infortuni sul lavoro, in particolare una lesione al tendine dovuta al sollevamento di pesantissimi cassonetti” e, secondo l’azienda, da
“episodi di comune malattia” che si è cercato di spacciare “come infortuni
sul lavoro”.
Di qui, a prescindere dalla corretta qualificazione delle lesioni, il licenziamento per il giustificato motivo oggettivo (4) rappresentato dalla soprav(3) Esplicita, nell’affermare che l’assegnazione del fisicamente inidoneo ad altre mansioni non deve tradursi nell’imposizione al datore di lavoro di “prestazioni assistenziali . . . vietate dall’art. 23 se non previste dalla legge”, è Cass., Sez. Un., 7 agosto 1998 n. 7755, in Mass.
Giur. Lav., 1998, pag. 876.
Sui rapporti tra libertà di licenziamento per ragioni organizzative e protezione degli interessi del prestatore d’opera si vedano, nella prospettiva dell’art. 41 Cost., P. De Carli, Costituzione ed attività economiche, Padova, 1978, pagg. 145 e segg.; M. Nuzzo, Utilità sociale e autonomia privata, Milano, 1975, pag. 135 e segg.; e F. Lucarelli, Solidarietà e autonomia privata, Napoli, 1970, pag. 423.
La normativa costituzionale impone infatti al legislatore ordinario di trovare un punto di
equilibrio tra le opposte esigenze, ma non prospetta soluzioni concrete su come comporre la
libertà di iniziativa economica con le prospettive di solidarietà e di socialità. La tutela di un
singolo lavoratore non può avvenire compromettendo gli equilibri finanziari e, quindi, il diritto al lavoro degli altri dipendenti (Corte cost. n. 316/1990. Si vedano, altresì, Corte cost. n.
356/1993 e n. 78/1958).
In dottrina si veda C. Cester, La sopravvenuta inidoneità del lavoratore tra itinerari giurisprudenziali e innovazioni normative, in Studi in memoria di M. D’Antona, I, Diritto e processo del
lavoro, Milano, 2004, pag. 573.
(4) La giurisprudenza – anche più recente – appare propendere per l’inquadramento della fattispecie nella variegata casistica del giustificato motivo oggettivo (ad es., Cass. 26 maggio
2005 n. 11092, Rep. Foro It., 2005, voce Lavoro (rapporto), n. 1476).
In dottrina cfr. G. Mannacio, Malattia e inidoneità permanente alle mansioni, in Lav. Giur.,
1992, pag. 1517; P. Campanella, Sul licenziamento per sopravvenuta inidoneità psicofisica del la-
ADL 1/2011
150
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
venuta inidoneità fisica del lavoratore che, nella prospettiva padronale (5), si
traduce in “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro” (art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604) con evidenti ricadute
sull’organizzazione del lavoro e sul regolare funzionamento dell’attività
produttiva e che come tali, giustificano, a seguito di congruo preavviso, l’esercizio del diritto di recesso diversamente illegittimo (6).
2. – L’inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle
mansioni contrattualmente previste non riafferma pienamente la libertà di
iniziativa economica privata del datore di lavoro: l’esercizio del diritto di
recesso deve infatti misurarsi con la verifica della sussistenza del nesso causale (7) tra il provvedimento di licenziamento e ragioni giustificatrici addotte ex art. 3 L. 15 luglio 1966 n. 604, cosicché il licenziamento intimato
potrà essere considerato illegittimo ove risulti che alla sua adozione vi erano alternative possibili e sempre di contenuto apprezzabile per il datore di
lavoro (8).
voratore, in Riv. It. Dir. Lav., 1997, II, pag. 614 e M. Papaleoni, Inidoneità sopravvenuta e repêchage, in Mass. Giur. Lav., 1998, pag. 876, in nota a Cass., Sez. Un., 7 agosto 1998, n. 7755, cit.
(5) Nella ricerca del punto di equilibrio tra vocazione al profitto ed obiettivi organizzativi, da un lato, e socialità e interesse dei lavoratori, dall’altro, il potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo viene ad essere ricollegato a ipotesi tra loro dissimili quali la riduzione del personale e l’inidoneità sopravvenuta del lavoratore.
In generale si vedano G. De Simone, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: l’instabile equilibrio tra le ragioni dell’impresa e i diritti dei lavoratori, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind.,
2002, n. 26, pag. 25; G. Fontana, Discrezionalità imprenditoriale e tutela giurisdizionale nei licenziamenti motivati da ragioni economiche, in Riv. Giur. Lav., 2001, I, pag. 340 e, più in specifico, E.
Gragnoli, La riduzione del personale fra licenziamenti individuali e collettivi, in Trattato di dir.
comm. e di dir. pubb. econ., diretto da Galgano, XXXX, Padova, 2006.
(6) Sull’argomento si veda, a titolo esemplificativo, ai fini di un puntuale approfondimento, F. Carinci, Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte, in Aa.Vv., Il lavoro subordinato, a cura di F. Carinci, I, coordinato da G. Proia, Torino, 2007.
(7) Da rilevare diversamente come autorevole dottrina escluda invece che la causa sia tra
i presupposti di validità posti a legittimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sottolineandone la problematicità della ricostruzione. Tra questi M. Napoli, La stabilità reale del rapporto di lavoro, Milano, 1980, pag. 153; G. Trioni, Contributo all’esegesi della legge 15 luglio 1966 n. 604, in Riv. Giur. Lav., 1967, I, pag. 27 e più recentemente E. Gragnoli, La
riduzione del personale fra licenziamenti individuali e collettivi, op. cit., pag. 6.
(8) Cfr. Cass. 7 gennaio 2002, n. 88, in Giur. It. Mass., 2002, c. 15, per cui “non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato
la soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto, se risultano l’effettività e il carattere non pretestuoso del riassetto organizzativo”. In quest’ottica risulterebbe ancora più
persuasiva la possibilità di configurazione del giustificato motivo oggettivo anche nell’ipotesi
di diversa attribuzione delle mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale: Cass. 20 dicembre 2001, n. 16106, in Giur. It. Mass., 2001, 497 e Cass. 29 marzo 2001, n. 4670, in Not. Giur.
Lav., 2001, pag. 379.
ADL 1/2011
STEFANO MARIA CORSO
151
In base al criterio del repêchage il datore di lavoro – pur in presenza di
un giustificato motivo – non può ricorrere al licenziamento qualora vi sia
una possibilità di adibire il lavoratore in altre mansioni (compatibili con il
suo stato fisico) richieste dall’organizzazione produttiva (9) configurando
una soluzione più favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale dell’art. 2013 Cod. Civ. (10).
Va detto subito che la previsione del repêchage appare molto più coerente con i giustificati motivi oggettivi rappresentati nella seconda parte dell’art. 3 l. n. 604 del 1966 e cioè con le “ragioni inerenti all’attività produttiva
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (11).
Appare del tutto logico che il provvedimento espulsivo venga sottoposto ad una prova di resistenza per verificare – ad esempio – se, nonostante
la chiusura di una filiale o di un reparto, l’introduzione di nuovi macchinari o l’informatizzazione dei servizi, l’esternalizzazione di alcune attività, la
cessione di un’attività produttiva o la chiusura di un cantiere, la soppressione totale o parziale di una posizione lavorativa, non vi sia la possibilità di
adibire il lavoratore ad altre mansioni, la cui necessità di svolgimento permanga nonostante la ristrutturazione aziendale, e che non risultino coperte adeguatamente da altri lavoratori.
Non sfugge come solo l’effettiva impossibilità riconosciuta di poter impiegare il lavoratore in altra mansione garantisca da un uso selettivo del
giustificato motivo di recesso per espellere soggetti non graditi (12).
(9) Per opportune puntualizzazioni sulla identificazione dei presupposti del repêchage cfr.
Trib. Milano 30 ottobre 2000, in Orient. Giur. Lav., 2000, I, pag. 1051, che si sofferma sull’onere del prestatore d’opera di indicare “circostanze di fatto utili a dimostrare o anche solo a fare
presumere l’esistenza, nell’ambito dell’azienda, di posti di lavoro utili”. Cass. 20 novembre
2001, n. 14592, in Giur. It. Mass., 2001, pag. 489 esclude la configurabilità del giustificato motivo oggettivo di licenziamento “qualora il lavoratore, pur non assegnabile all’attività già svolta, possa non di meno svolgerne un’altra compresa nella stessa mansione o in mansioni equivalenti per le quali persista l’interesse dell’imprenditore”. Sui delicati rapporti tra obbligo di
ripescaggio e legittimità del recesso si vedano, in generale, G. Gramoccia, Criteri di scelta del
lavoratore da licenziare per giustificato motivo, in Mass. Giur. Lav., 2002, pag. 268 e A. Pizzoferrato, Licenziamento per soppressione del posto di lavoro e impossibilità di ricollocare il lavoratore in
altre mansioni equivalenti, in Riv. It. Dir. Lav., 1998, II, pag. 327.
(10) Sulla legittimità di un accordo di dequalificazione, qualora si annunci un possibile recesso per inidoneità alle mansioni, si vedano per un attento profilo R. De Luca Tamajo, La norma inderogabile nel diritto del lavoro, Napoli, 1976, pag. 231 e E. Gragnoli, Il licenziamento, la
giusta causa e il giustificato motivo, dattiloscritto, 2010, pag. 92.
(11) Sottolineano che in tale caso l’impossibilità della prestazione è imputabile alla condotta (attiva o omissiva) del datore di lavoro Cass. 21 gennaio 2002, n. 572, in Dir. Lav., 2002,
pag. 425; Cass. 18 aprile 2000, n. 5066, in Not. Giur. Lav., 2000, 604 e Cass. 12 giugno 1995, n.
6601, in Dir. Prat. Lav., 1996, pag. 318. Resta, ovviamente, fermo quanto disposto dall’art. 4 legge n. 68/1999 (v., infra, nota 14).
(12) Per una più articolata analisi sul possibile utilizzo dell’istituto dei recessi come stru-
ADL 1/2011
152
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
Innanzitutto, a seguito del responso del medico competente circa lo
stato di salute del dipendente, il datore di lavoro non può accettare la prestazione lavorativa, nemmeno se il dipendente sia disponibile a svolgere altra mansione meno usurante e meno impegnativa, a tutela del primario bene giuridico quale è appunto la salute individuale del lavoratore (ovvero
anche di quella collettiva in presenza ad esempio di specifici elementi patogeni rischiosi per gli altri dipendenti) (13).
Diverso è il caso in cui, a seguito di parere medico indipendente non
sindacabile dal datore di lavoro, permanga una ridotta capacità lavorativa nel senso che il lavoratore è sicuramente inidoneo alle mansioni originariamente svolte, ma potrebbe proficuamente svolgere un’attività meno
impegnativa sul piano fisico ma comunque effettivamente funzionale alle esigenze dell’impresa (benché in precedenza non contrattualmente
prevista).
Sennonché, in tale caso, deve essere possibile adibire il lavoratore ad
una diversa attività almeno equivalente alle mansioni svolte precedentemente il manifestarsi della condizione di inidoneità o anche a mansioni
inferiori comunque apprezzabili alla luce dell’organizzazione aziendale
e, deve aggiungersi, non dequalificanti per il lavoratore alla luce dei basilari principi di buona fede e cooperazione (ex artt. 1366 e 2087 Cod.
Civ.).
A tal proposito diventa essenziale una ulteriore precisazione: quando
l’infortunio sia imputabile alla responsabilità del datore di lavoro non si è
legittimati al recesso e anzi sorge l’obbligazione per il datore di lavoro a reperire nell’ambito aziendale mansioni diverse e compatibili con le condizioni di salute del prestatore d’opera.
Tornando quindi alla disciplina generale del licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, la giurisprudenza giuslavorista è ormai pervenuta a delineare precisi e condivisibili principi di diritto alla cui
mento per intervenire sul mercato del lavoro si vedano F. Carinci, Discutendo intorno all’art. 18
dello Statuto dei lavoratori, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, I, pag. 35 e S. Liebman, La disciplina del licenziamento, in Dir. Rel. Ind., 2002, pag. 378.
(13) In giurisprudenza si è condivisibilmente affermato che il datore di lavoro che sia venuto a conoscenza della malattia del lavoratore deve recedere se vi sia certezza o rilevante
probabilità di un aggravamento delle condizioni di salute ove si protragga l’espletamento dell’attività lavorativa. Si vedano F. Limena, L’accesso al lavoro dei disabili, Padova, 2004; C. Cester, L’obbligo di cooperazione del datore di lavoro in caso di aggravamento dello stato di salute del
lavoratore inabile, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, n. 3, pag. 656, e S. Giubboni, Il licenziamento del lavoratore disabile tra disciplina speciale e tutela antidiscriminatoria, in Dir. Lav., 2008, pag. 427.
Nel senso che ai fini della collocabilità dell’invalido nell’organizzazione aziendale non assume rilievo la vacanza di posti in organico cfr. Cass. 13 novembre 2009, n. 24091, in Lav. Prev.
Oggi, 2010, n. 3, pag. 269.
ADL 1/2011
STEFANO MARIA CORSO
153
stregua la sopravvenuta inidoneità fisica permanente del lavoratore integra
un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro; detto licenziamento non può comunque essere intimato ove vi sia la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile – alla stregua di un’interpretazione del contratto inter partes secondo buona fede (14)
– a mansioni equivalenti, o eventualmente inferiori (15), di interesse aziendale; è illegittimo il licenziamento intimato senza che il datore di lavoro abbia precedentemente accertato se il prestatore d’opera possa essere addetto
a mansioni diverse e di pari livello; la possibilità di assegnare al prestatore
d’opera mansioni diverse e compatibili con il suo stato di salute non può tradursi in un obbligo per il datore di lavoro di modificare la propria struttura
organizzativa al fine di consentire un repêchage altrimenti impossibile.
La sopravvenuta inidoneità del lavoratore in conseguenza di malattia o
infortunio va valutata attraverso visite mediche e, in specifico, attraverso le
strutture pubbliche competenti (art. 5 Statuto lavoratori) (16).
Pur in un contesto normativo che si segnala per un trend crescente di
competenza e responsabilità del medico interno (17), è e rimane irrinunciabile che il controllo sulla esistenza e consistenza di una compromissione
della capacità lavorativa sia valutata da organi competenti indipendenti e
(14) Cass. 20 novembre 2001, n. 14592 cit. e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma 5
giugno 2001, in Lav. Giur., 2002, pag. 89 sottolineano l’obbligo del datore di lavoro di procedere al repêchage secondo buona fede. La inabilità al lavoro conseguente a condotta (attiva od
omissiva) ascrivibile al datore di lavoro è disciplinata dalla l. 12 marzo 1999 n. 68, sul diritto al
lavoro dei disabili, il cui art. 4 ricollega alla sopravvenuta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa un divieto di licenziamento per giustificato motivo qualora i lavoratori possano essere adibiti a mansioni equivalenti o inferiori e un obbligo di conservazione del trattamento economico più favorevole (trattasi di una ipotesi nella quale è consentita deroga al
principio di equivalenza delle mansioni di cui all’art. 2103 Cod. Civ.).
(15) Appare fonte di orientamenti giurisprudenziali contrastanti se permanga il diritto in
capo al lavoratore alla precedente retribuzione; per una soluzione affermativa Cass., Sez. Lav.,
5 aprile 2007, n. 8596.
(16) La norma citata nel testo (“accertamenti sanitari”) – che non realizza una ispezione
personale coattiva (Corte cost. 5 febbraio 1975, n. 23, in Riv. It. Dir. Lav., 1975, II, pag. 45) – è
integrata da una serie di norme che individuano I soggetti preposti al controllo sulle condizioni di salute del lavoratore, la comunicazione della malattia, l’indicazione della diagnosi, il
luogo e il tempo dei controlli, la sindacabilità della certificazione del medico curante e del referto del medico di controllo e, con specifico riferimento al profilo qui di interesse, il controllo sul (permanere del) l’idoneità alle mansioni. Da ultimo in materia di sorveglianza sanitaria
si segnala l’intervento del legislatore negli artt. 38 e segg. del d.lgs 3 agosto 2009 n. 106.
(17) Il riferimento è al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (come modificato ancora più recentemente dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, che ha rafforzato l’obbligo della sorveglianza sanitaria in linea con il disposto dell’art. 9 Stat. Lav. e che ha precisato (e sanzionato) la responsabilità del medico competente nominato dal datore di lavoro.
ADL 1/2011
154
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
pubblici, stanti le rilevanti implicazioni sociali ed individuali derivanti dall’accertamento (18).
Superato il problema dell’accertamento della sopravvenuta inidoneità
fisica al lavoro, diventa centrale il problema di come verificare l’esistenza
(o l’inesistenza) delle condizioni per il repêchage e cioè della praticabilità di
una collocazione del lavoratore in ambito aziendale sia pure in mansioni
diverse da quelle rispetto alle quali è stata obiettivamente accertata l’incompatibilità per ragioni fisiche.
La serietà e l’obiettività di tale verifica sono condizioni irrinunciabili se
si vuole perseguire il fine di consentire il licenziamento solo come extrema
ratio, tanto che nella sentenza in esame proprio la presunta mancanza di un
“particolare rigore nella valutazione di tale onere probatorio incombente
sull’impresa” assurgeva ad uno dei motivi, dedotti dal ricorrente, a sostegno della non corretta applicazione da parte della Corte di appello di Genova dell’art. 3 L. n. 604 del 1966 (19).
In base al canone onus incumbit ei qui dicit, l’onere di provare che l’organizzazione aziendale non consente alternative al provvedimento espulsivo
è – e non può non essere – a carico del datore di lavoro, anche per ragioni
di tipo pratico perché nessuno come lui è in grado di conoscere l’organizzazione del lavoro e quanto è funzionale alla migliore risposta alle esigenze
produttive nonché di verificare se sia praticabile l’alternativa al licenziamento rappresentata da una diversa collocazione del dipendente impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa (20).
(18) L’accertamento sanitario, ancorché effettuato da strutture pubbliche, non è vincolante per l’autorità giudiziaria che ha il potere di disporre accertamenti peritali di natura medica
e di motivatamente disattendere la valutazione sanitaria assunta dal datore di lavoro a base del
recesso che, conseguentemente, risulterà illegittimamente intimato. Sulle conseguenze di tale illegittimità (cui non fa da riscontro un dolo o una colpa del datore di lavoro “reo” di aver
fatto affidamento in una struttura pubblica) si veda Corte cost. 3 dicembre 1998, n. 420, in
Mass. Giur. Lav., 1999, pag. 137.
(19) Premesso che la prevalenza delle esigenze del datore di lavoro sul diritto alla conservazione del posto di lavoro presuppone l’esistenza riconosciuta di una effettiva necessità organizzativa, il licenziamento deve rappresentare la soluzione rispetto alla quale non vi sono alternative: l’unica risposta ad oggettive problematiche aziendali. Per la configurazione del recesso come extrema ratio (in un’ipotesi di licenziamento individuale per ragioni inerenti all’attività produttiva) si veda Cass. 20 maggio 2009 n. 11720, in Dir. Prat. Lav., 2010, n. 8, pag. 459.
Nel senso che spetta comunque al lavoratore licenziato riferire circa collocazioni alternative in
ambito aziendale cfr. Cass. 23 ottobre 2001, n. 13021, in Giur. It. Mass., 2001, pag. 429. In dottrina si vedano U. Carabelli, I licenziamenti per riduzione del personale, in Aa.Vv., I licenziamenti per riduzione del personale in Europa, a cura di B. Veneziani - U. Carabelli, 2001, pag. 217 e
S. Rossi Dettori, Commento all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, in Aa.Vv., I licenziamenti. Commentario, a cura di O. Mazzotta, 1999, pag. 349.
(20) Con i limiti del caso, vale anche per l’inidoneità sopravvenuta del lavoratore non ri-
ADL 1/2011
STEFANO MARIA CORSO
155
Onere a carico del datore di lavoro non significa insindacabilità della
sua valutazione o impossibilità di un controllo ab externo della verifica (asseritamente) fatta e della correttezza delle sue conclusioni.
L’assetto organizzativo di un’azienda non può che essere il risultato di
una scelta insindacabile dell’imprenditore, cosicché – come si è già ricordato – non è concepibile una coazione ad un mutamento della struttura organizzativa per consentire un repêchage altrimenti impossibile (21).
L’onere di verifica di una possibilità di collocazione alternativa del lavoratore non può tradursi in un obbligo di mantenimento comunque al lavoro (anche in assenza completa di esigenze aziendali) né può venir trasformato in una fictio iuris che voglia dissimulare l’automatismo in concreto del provvedimento espulsivo.
In questo delicato settore un ruolo decisivo è stato svolto dalla giurisprudenza alla ricerca di un ragionevole equilibrio tra l’esigenza padronale
di non caricare l’azienda di oneri impropri e l’aspettativa del lavoratore di
una conservazione del posto di lavoro sia pure a condizioni diverse (22).
L’onere probatorio a carico del datore di lavoro della impossibilità di
una diversa collocazione va inteso in termini di ragionevolezza (essendo
quasi una probatio diabolica la dimostrazione dell’inesistenza delle condizioni per una ricollocazione in altre mansioni o l’incapacità assoluta di sostenere il costo economico di un dipendente in più, oltretutto con capacità lavorativa compromessa) e va contemperato con l’onere a carico del lavoratore
che contesti il provvedimento espulsivo adottato (o in itinere) di facilitare la
propria diversa collocazione e di allegare la concreta esistenza di alternative
lavorative nell’ambito dell’organizzazione aziendale indicando con sufficiente precisione il posto nel quale ritenga di poter essere collocato (23).
tenuto “ripescabile” dal datore di lavoro la giurisprudenza sul dovere del giudice di controllare “l’effettività della dedotta ristrutturazione organizzativa, la sua incidenza sulla posizione
rivestita in azienda dal lavoratore e la sua inutilizzabilità in altro settore aziendale” (Cass. 16
dicembre 2000, n. 15894, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 340). All’indomani della legge n. 604
del 1966 cfr. G. Pera, Sindacabilità dei motivi di licenziamento in sede giurisdizionale, in Aa.Vv.,
Giusta causa e giustificati motivi di licenziamento nei licenziamenti individuali, Atti del Convegno
di Firenze, Milano, 1967, pag. 15.
(21) Si veda C. Zoli, I licenziamenti per ragioni organizzative: unicità della causale e sindacato giudiziale, in Studi in onore di E. Ghera, Bari, 2008, II, pag. 1357.
(22) Per una ragguardevole analisi giurisprudenziale si vedano Cass. 7 gennaio 2005, n.
239; App. Torino 12 novembre 202, in Giur. Piem., 2004, pag. 77; Trib. Firenze 4 luglio 2003,
in Riv. Crit. Dir. Lav., 2004, pag. 170; e in senso più estensivo, sulla necessità di ricercare una
collocazione compatibile con le nuove condizioni del lavoratore, anche modificando parzialmente l’organizzazione cfr. Trib. Bari 1 dicembre 2000, in Giur. Mer., 2002, pag. 82 e Trib. Milano 26 ottobre 1999, in Lav. Giur., 2000, pag. 169.
(23) La ineludibilità della verifica di una possibilità di repêchage è sottolineata da G. Del-
ADL 1/2011
156
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
Se è probatoriamente più agevole, per il datore di lavoro, individuare il
posto dove residuino interessi aziendali a mantenere la prestazione del dipendente altrimenti da licenziare, risponde ad analogo equilibrio di ripartizione dell’onere probatorio aspettarsi che sia il prestatore d’opera ad assolvere all’onere di indicare quale mansione si ritenga concretamente in
grado di espletare e quale sia il posto nel quale possa venir utilmente (anche per l’azienda) collocato.
Nella fattispecie oggetto della sentenza in esame si rinviene, innanzitutto, l’accertamento obiettivo dell’inidoneità al lavoro da parte dei medici
interni e la conferma di detta diagnosi da parte dell’Istituto di Medicina del
Lavoro della locale Università (la riconosciuta mancanza del presupposto
del giustificato motivo oggettivo del licenziamento renderebbe inutile il
passaggio alla verifica dell’esistenza delle condizioni per un repêchage). Entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto che il dipendente non era più
in grado di assolvere alle mansioni .
In secondo luogo, vi è precisa risultanza di “una riunione congiunta
con le organizzazioni sindacali” – come prevista dalla contrattazione collettiva vigente – per verificare in contraddittorio la rispondenza al vero di
quanto asserito dal datore di lavoro circa l’impossibilità di utilizzazione in
altre mansioni.
In terzo luogo, vi è precisa traccia di un articolato controllo di congruità da parte del giudice di merito sulle allegazioni delle parti contrapposte
circa l’esistenza di una possibilità di reinserimento (24).
Da un lato, il giudice di primo grado ha dichiarato illegittimo il licenziamento ritenendo possibile il repêchage del lavoratore e il suo impiego “ai
servizi interni, nell’ambito di apposita unità”; dall’altro il giudice di secondo grado ha dichiarato la legittimità del licenziamento perché, pur riconoscendo l’esistenza all’interno dell’azienda di una unità di “servizi interni”
compatibile con la capacità lavorativa residua del dipendente licenziato, ha
preso e dato atto che la possibilità di ricollocazione era da considerarsi teorica poiché “tale unità è al completo”.
la Rocca, Oneri probatori nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in Dir. Lav., 1998, II,
pag. 178.
(24) Come da ultimo ribadito dalla Cass., Sez. Lav., 2 luglio 2009, n. 15500 sulla scia di un
orientamento ormai consolidato, in generale l’onere probatorio dell’impossibilità di utilizzare
il lavoratore in altre mansioni equivalenti, oppure se ciò sia impossibile anche inferiori, spetta
al datore di lavoro, salvo tuttavia per il lavoratore dover indicare specificatamente le mansioni esercitabili e “provare la sua idoneità alle stesse, allegando quanto meno sue possibili collocazioni” (Cass., Sez. Lav., 19 febbraio 2008, n. 4068).
ADL 1/2011
STEFANO MARIA CORSO
157
3. – La Suprema Corte con queste premesse, esaminando il ricorso del
lavoratore contro la sentenza della Corte di appello che ha escluso il repêchage e riconosciuto legittimo il recesso del datore di lavoro, ha operato alcune puntualizzazioni di estremo rilievo.
In primo luogo ha dichiarato inammissibile la richiesta di esprimersi
circa la maggiore o minore legittimazione dei singoli lavoratori inidonei ad
accedere all’unità operativa di addetti ai servizi interni, riservata ai dipendenti aventi particolari difficoltà nell’espletamento delle proprie funzioni.
In tal modo ha ribadito l’impossibilità di un ulteriore confronto nel merito
delle diverse posizioni dei lavoratori inidonei e pertanto, rigettando i motivi di ricorso, ha sostenuto al contrario come la sentenza della Corte di appello fosse “immune da vizi logici o da contraddizioni”.
Date tali premesse appare legittima la decisione di non esaminare (proprio perché esclusivamente di merito) la questione della presunta maggior
titolarità del ricorrente ad essere collocato in detta specifica unità in quanto inidoneo in via indefinita rispetto ad altre posizioni di soggetti, a suo dire, solo temporaneamente non utilizzabili, perché il contenuto non discriminatorio e arbitrario della differenziazione delle posizioni assunta dal datore di lavoro già era passata al vaglio del giudice precedente.
La Suprema Corte afferma così il principio della inesigibilità dal datore
di lavoro di una modifica della propria struttura organizzativa per creare il
posto fino ad allora mancante e della insindacabilità dei criteri con i quali è
stata completata l’unità eventualmente esistente, trattandosi pur sempre di
una unità la cui istituzione non è prevista né ex lege né dalla contrattazione
collettiva, “posto che la legge non obbliga il datore di lavoro a creare apposite unità dove collocare il personale non altrimenti utilizzabile nelle mansioni proprie della produzione svolta” (25).
In secondo luogo, fulcro dell’analisi del giudice della legittimità diventa il tema della ripartizione degli oneri probatori, tra datore di lavoro e prestatore d’opera, in punto concreta possibilità di reinserimento nell’organizzazione produttiva e non ineluttabilità del licenziamento (26).
(25) Diversa è la soluzione nel caso di assunzione obbligatoria di categorie protette in
quanto il datore di lavoro è a conoscenza che un determinato organico postula l’obbligo di assunzione di un certo numero di invalidi ed il fatto di aver l’organico al completo non esime dagli obblighi di legge: in giurisprudenza si veda Cass. 13 novembre 2009, n. 24091, cit., con nota di Cerasi.
(26) Di ultimo assoluto rilievo è l’intervento legislativo di modifica d.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 (come modificato e aggiornato, ancora più recentemente dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
ad ulteriore riprova dell’attenzione costante rivolta a questa delicata e dibattuta tematica, come sottolineato nel Commentario a cura di L. Zoppoli - P. Pascucci - G. Natullo, con prefazione di F. Carinci, Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Milano, 2011.
ADL 1/2011
158
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
La Corte ha, innanzitutto, riaffermato che la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e l’aggravamento di detta inidoneità che rende il lavoratore inidoneo anche alle
diverse (e meno gravose) mansioni cui è stato adibito “legittima(no) la risoluzione del rapporto” per “giustificato motivo di natura oggettiva” (27).
Il passaggio dalla mansione originaria all’altra è già una applicazione
del principio del repêchage teorizzato dalla giurisprudenza e ormai pacificamente riconosciuto e condiviso.
La dimostrazione che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni diverse è stata raggiunta precedentemente in sede di merito con una
motivazione adeguata (e, come tale, insindacabile in sede di legittimità),
sia valorizzando quel peculiare momento di informazione e di contraddittorio rappresentato dall’ “apposito incontro previsto al riguardo dal contratto collettivo con la partecipazione delle organizzazioni sindacali”, sia
accertando l’esistenza in azienda di “una unità nella quale vengono collocati i lavoratori non idonei” e come tale possibile adeguata risposta alle esigenze del caso concreto”, sia – infine – accertando la veridicità dell’assunto (di provenienza padronale) circa la completezza dell’unità stessa, causa
la presenza di un “congruo numero di dipendenti addetti ai servizi interni”,
e la consequenziale impossibilità di inserirvi ulteriori lavoratori.
Interessante, come profilo conclusivo, è la soluzione data al problema
della individuazione del soggetto su cui grava l’onere della prova: la Corte
d’appello aveva rilevato che il lavoratore non aveva allegato la possibilità
concreta di repêchage a fronte della prova, da parte del datore di lavoro, di
non utilizzabilità del lavoratore nei servizi interni per mancanza di posti
disponibili.
Il lavoratore ricorrente si era lamentato di “una sorta di inversione dell’onere della prova” da parte della Corte d’appello che aveva ritenuto che
“l’esito infruttuoso della riunione ex art. 40” del contatto collettivo di categoria esonerasse l’azienda dal tentativo di repêchage.
La Suprema Corte ha superato la questione “a prescindere da un onere
di allegazione che la Corte (d’appello) ha addebitato al lavoratore”, ritenendo esaustiva la prova positivamente raggiunta della mancata possibilità
di repêchage e, quindi, implicitamente dando atto che gli elementi fattuali
offerti dall’azienda non lasciavano spazio per letture alternative.
In sintesi, l’assoluta inidoneità sopravvenuta non consente – per sua na(27) Esplicita previsione normativa, come si è accennato, si rinviene nell’art. 42 d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 (come modificato ex d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106) con specifico riguardo ai
provvedimenti adottabili in caso di sopravvenuta inidoneità alla mansione contrattualmente
prevista.
ADL 1/2011
STEFANO MARIA CORSO
159
tura – una diversa collocazione lavorativa in ambito aziendale senza che essa si risolva in una misura esclusivamente assistenziale: se apprezzabile sarebbe la disponibilità del datore di lavoro a caricarsi di detto onere finanziario, certo non censurabile né coercibile appare la dichiarata indisponibilità ad avvalersi di prestazioni apparentemente lavorative.
L’inidoneità sopravvenuta parziale (e cioè il permanere di un’idoneità
lavorativa sia pure circoscritta a mansioni meno gravose) va, invece, valutata in concreto per salvaguardare non tanto (e non solo) la retribuzione ma
anche l’inserimento in un contesto sociale che è di per sé gratificante e strumento di promozione sociale.
ADL 1/2011
GIURISPRUDENZA
S E N T E N Z E A N N O TAT E
Cass., Sez. Lav., 26 marzo 2010, n. 7373 – Pres. Ravagnani – Rel. Curzio
– D.P., M.M.T., D.P.R. nella qualità di eredi di D.B. c. Poste Italiane S.p.A.
Infortunio in itinere – Responsabilità civile del datore di lavoro – Infortunio occorso durante l’uscita dal luogo di lavoro – Percorso ordinario – Scelta di un via diversa non destinata al passaggio – Mancanza di alcun valido
motivo – Comportamento anomalo ed abnorme del lavoratore – Sussistenza del rischio elettivo – Non configurabilità della responsabilità civile del
datore di lavoro.
Nell’ipotesi di infortunio in itinere, la scelta del lavoratore di percorrere una via
diversa da quella ordinaria per uscire dal luogo di lavoro, in assenza di alcun valido motivo, costituisce comportamento anomalo ed abnorme idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra comportamento aziendale ed evento infortunistico.
Ne consegue che non potrà configurarsi alcuna responsabilità del datore di lavoro per i danni patiti dal prestatore in ragione dell’infortunio subito.
Fatto e diritto
Gli eredi di D.B., chiedono l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di
Napoli, pubblicata il 12 dicembre 2005, che ha riformato la decisione emessa dal Tribunale di Benevento, dichiarando cessata la materia del contendere sulla domanda relativa
alla condanna alla rendita da infortunio sul lavoro (capi a e b del ricorso introduttivo) e,
in accoglimento dell’appello di Poste italiane, ha rigettato le altre domande.
(Omissis)
La Corte d’Appello ha riformato la sentenza.Con riferimento alla domanda di accertamento della natura di infortunio sul lavoro e alla domanda di costituzione di una rendita, ha rilevato che la questione è stata superata a causa dell’intervento dell’INAIL, che
ha costituito la rendita, essendosi il giudizio incardinato dopo il 1 gennaio 1999.
(Omissis)
Quanto invece alla richiesta di risarcimento danno nei confronti delle Poste, l’ha rigettata perché, esaminando la dinamica dell’incidente, ha ritenuto che lo stesso sia stato
causato “da un comportamento anomalo del lavoratore”.
Contro tale decisione la difesa dei ricorrenti propone un ricorso articolato in sette
motivi.
Poste italiane ha depositato un controricorso con il quale chiede il rigetto dell’impugnazione.
(Omissis)
ADL 1/2011
162
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
Tutti i motivi di ricorso concernono la parte della domanda con la quale si chiede il
risarcimento ulteriore rispetto a quanto coperto dalla rendita.
Sul punto la domanda era stata di L. 1.500.000.000. Il Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda riducendone drasticamente l’importo. La Corte d’Appello l’ha rigettata integralmente, ritenendo che gli eredi del D. non abbiano fornito prova adeguata degli elementi costitutivi della responsabilità del datore di lavoro per questo risarcimento aggiuntivo, differenziale, rispetto a quanto già riconosciuto dall’INAIL. La Corte
di merito ha ricostruito molto analiticamente la dinamica dei fatti sottolineando che dalle prove testimoniali, dalla perizia e dalle fotografie sullo stato dei luoghi esaminate
emerge che il D., terminato il lavoro, uscì accompagnato dal padre, e, invece di utilizzare
la via normale costituita da una scala sulla destra adeguatamente attrezzata in termini di
sicurezza, utilizzò un’altra via, destinata non al passaggio dei dipendenti ma al carico e
scarico delle merci e degli automezzi. A causa di questa scelta, non necessitata e del tutto anomala ed imprudente, fatta peraltro con l’assistenza del padre, si determinò l’incidente. Nell’ambito di tale analisi la Corte evidenzia quanto segue:
– dall’istruttoria è emerso che la via ordinaria era costituita da una scala munita di
passamano e in regola con le norme antinfortunistiche;
– non è stato provato che quella uscita fosse ostruita da autovetture che impedivano
il passaggio (affermazione fatta dai ricorrenti, che era loro onere provare);
– la scelta, come è spiegato dal lavoratore in una lettera al direttore del 27 aprile
1999, fu fatta perché, “a causa del maltempo, decidemmo di scendere dalla scaletta di sinistra anche perché di fatto più vicina al punto in cui si era venuta a trovare la nostra automobile”.
Sulla base di tali elementi la Corte ha ritenuto che non vi sia un rapporto di causalità tra comportamento aziendale ed evento infortunistico, perché la caduta si è verificata
a causa della scelta del lavoratore (e del padre che lo accompagnava) di fare un percorso che li avrebbe condotti più vicino al posto dove si trovava la loro autovettura, ma che
non era il percorso ordinario per uscire dal luogo di lavoro; che è stato solo affermato,
ma non provato che il percorso ordinario fosse bloccato dalle auto in sosta; che la scelta
attribuibile solo al lavoratore costituisca un comportamento anomalo ed abnorme che
esclude ogni responsabilità del datore di lavoro.
Quella fatta dalla Corte di Napoli è una scelta conforme ai criteri che regolano la responsabilità del datore di lavoro e ai criteri sull’onere della prova per cui quando viene
scelto un percorso diverso da quello ordinario per accedere o uscire dal luogo di lavoro,
è il lavoratore che deve dare la prova della inagibilità o difficoltà di percorrere la via ordinaria.
(Omissis)
La Corte rigetta il ricorso (Omissis)
*
Rischio elettivo ed infortunio in itinere.
Con la decisione in epigrafe la Corte di Cassazione, confermando la sentenza
della Corte di Appello di Napoli, ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno differenziale avanzata dal sig. D.B., dipendente di Poste Italiane S.p.A., nei
confronti di quest’ultima, ritenendo che l’incidente si sia verificato a causa di un
comportamento anomalo ed abnorme del lavoratore. Secondo i giudici di legittimità, infatti, il prestatore di lavoro, portatore di handicap, nell’uscire dal luogo di
ADL 1/2011
FRANCESCO PAOLO RUBBIO
163
lavoro in compagnia del padre, invece di utilizzare la via normale costituita da una
scala munita di passamano e in regola con le norme antinfortunistiche, scelse di
percorrere un’altra via riservata al carico e scarico delle merci e degli automezzi.
Nel corso dell’istruttoria era emerso, inoltre, che l’uscita dalla via ordinaria non
era ostruita dalle macchine e che il ricorrente aveva deciso di percorrere l’altra, in
quanto più vicina al punto in cui era parcheggiata la sua automobile. Per la Cassazione, quindi, i giudici di appello correttamente avevano sostenuto l’insussistenza di alcun nesso di causalità tra l’infortunio e la condotta del datore di lavoro,
giacché il lavoratore aveva volontariamente scelto un percorso diverso da quello
ordinario per uscire dal luogo di lavoro, nonostante la via normale fosse agibile e
di non difficile percorrenza. Il Supremo Consesso, pertanto, ha rinvenuto nella
tenuta condotta del sig. D.B. gli elementi caratterizzanti il c.d. rischio elettivo, che
esclude la risarcibilità dell’infortunio in itinere.
La pronuncia in esame offre lo spunto per un indagare sulle caratteristiche
dell’infortunio in itinere e del rischio elettivo
L’infortunio in itinere, ossia quello occorso al lavoratore durante il tragitto
percorso per recarsi da casa al lavoro e viceversa, è una figura di origine giurisprudenziale e dottrinale, che ha ricevuto espresso riconoscimento normativo nel
2000 con il d.lgs. n. 38. L’articolo 12 di tale provvedimento legislativo fissa la disciplina dell’istituto integrando gli articoli 2 e 210 del Testo Unico n. 1124, del
1965, mediante una parificazione complessiva tra tale tipo di infortunio e quello
sul lavoro, analogamente a quanto era già avvenuto negli altri Paesi Europei (per
una ricostruzione dell’istituto si veda G. Corsalini, Gli infortuni sulle vie del lavoro, Padova, 2005; M. Persiani, Diritto della previdenza sociale, Padova, 2009).
Relativamente al periodo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 38
del 2000, dunque, i criteri per l’indennizzabilità dell’infortunio in esame vennero fissati dalla giurisprudenza, la quale col tempo ampliò considerevolmente
il campo di applicazione della fattispecie.
In un primo momento, si riteneva che l’occasione di lavoro prevista dagli articoli 2 e 210 del t.u., fosse elemento indefettibile per la sussistenza dell’infortunio in itinere (cfr. A. De Matteis, L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, Torino, 1996, pagg. 85 segg.; A. Fontana, Dottrina e giurisprudenza a confronto sull’« occasione di lavoro », in Riv. Inf. Mal. Prof.,
1998, pag. 421 e segg.). Conseguentemente, si considerava non indennizzabile
l’incidente stradale determinato dal generico rischio della strada. Quest’ultimo
però diveniva specifico del lavoro e, quindi, indennizzabile, ogni qualvolta esso
veniva aggravato da precipue condizioni di tempo e di luogo qualificanti il tragitto casa-lavoro, come ad esempio: la necessità di percorre una determinata
strada che conduceva esclusivamente al posto di lavoro o che, comunque, presentava per il lavoratore pericoli maggiori rispetto alle vie ordinarie di comunicazione; la necessità di utilizzare mezzi privati, in quanto il posto di lavoro era
irraggiungibile con i mezzi pubblici, oppure raggiungibile, ma non in tempo
utile rispetto al turno di lavoro. In tali situazioni, quindi, la trasformazione del
rischio generico in specifico era funzionalmente collegata alle modalità di tempo e di luogo con cui il prestatore era tenuto a fornire la sua prestazione lavora-
ADL 1/2011
164
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
tiva, e cioè a circostanze che rientravano nell’ambito del rischio professionale
(tale orientamento trovava fondamento nell’elaborazioni dogmatiche di F. Carnelutti, Gli infortuni sul lavoro (Studi), Roma, 1913, vol. I, pag. 127 e segg. e pag.
209 e segg., secondo il quale il generico rischio della strada diventava rischio
specifico del lavoro nel caso di sinistri occorsi ogni qualvolta per recarsi al lavoro un operaio doveva percorrere una via lungo la quale si esponeva a pericoli diversi e maggiori di quelli che si correvano in un cammino normale; in tal
senso anche M. Barni- M. Graev, L’infortunio sulle vie del lavoro nei suoi percorsi
dottrinali e nei suoi fondamenti giurisprudenziali. Considerazioni per una nuova
dottrina, Milano, 1962, pag. 4, per i quali l’elaborazione dogmatica di Carnelutti
era l’unica in grado di realizzare una corretta valutazione dell’infortunio in itinere, tenuto conto sia dello spirito della legge, sia della realtà dei fatti. Per le pronunce giurisprudenziali vedi Cass. 19 febbraio 1988 n. 1745, in Mass. Giust. Civ.,
1988, pag. 419; Cass. 30 luglio 1987 n. 6625, in Riv. Inf. Mal. Prof., 1988, II, pag.
109 e segg.; Cass. 25 marzo 1986 n. 2128, in Mass. Giust. Civ., 1986, pag. 584;
Cass. 28 maggio 1982 n. 3300, in Not. Giur. Lav., 1982, pag. 462; Cass. 21 settembre 1963 n. 2599, in Dir. Lav., 1964, II, pag. 59 e segg.).
In un periodo successivo, la giurisprudenza mutava il proprio indirizzo, ritenendo sufficiente ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, la mera
finalità lavorativa del percorso o, meglio, la circostanza che l’evento fosse fondato sul fatto che il viaggio aveva come fine il lavoro (cfr. Cass. 13 aprile 2002 n.
5354, in Dir. Giust., 2002, n. 19, pag. 67; Cass. 14 febbraio 2002 n. 2172; Cass. 14
novembre 2000 n. 14715, in Mass. Giust. Civ., 2000, pag. 2316; Cass. 7 novembre
2000 n. 14460, in Giust. Civ., 2001, I, pag. 83 e segg.; Cass. 21 ottobre 2000 n.
13933; Cass.17 maggio 2000 n. 6413, in Dir. Giust., 2000, pag. 25 e segg., con nota di G. Riganò, Accidentato itinere giurisprudenziale. Un vuoto normativo (ora sanato) riempito dal diritto vivente. In dottrina tra i tanti cfr. C.M. Dalmasso, L’occasione di lavoro e rapporto di lavoro nella risarcibilità dell’infortunio in itinere, in
Giur. Mer., 1987, I, pag. 1097 e segg.; T. Tranquillo, La giurisprudenza tedesca
sull’occasione di lavoro nell’infortunio, in Riv. Giur. Lav., 1991, II, pag. 131; G.
Esposti, L’infortunio in itinere, in Dir. Prat. Lav., 1990, n. 32, pag. 2021). Secondo questa concezione, c.d. finalistica, non era più necessaria, quindi, la sussistenza di un quid pluris in grado di accrescere il pericolo cui era sottoposto un
qualsiasi utente della strada, poiché il nesso di causalità dell’infortunio in itinere veniva individuato nella circostanza che l’uso della pubblica strada era dovuto dall’obbligo di raggiungere il posto di lavoro e, dunque, riconducibile a fini
professionali. In tale situazione si ravvisava il rapporto finalistico o strumentale
tra l’attività di locomozione dal luogo di abitazione a quello di lavoro (e viceversa) e l’attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa (in tal senso
A. De Matteis, op. cit.; Cass. 17 maggio 2000, n. 6431; Cass. 17 maggio 2002, n.
7222, in Mass. Giur. Lav.; Cass. 19 maggio 1998 n. 455, in Foro It., 1998, I, col.
781; critico sull’adozione di tale criterio ermeneutico M. Persiani, Occasione di
lavoro e necessari limiti all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, in Mass. Giur.
Lav., 1987, pag. 391 [nota a Cass. 22 maggio 1987 n. 4657] per il quale l’orientamento in questione avrebbe stravolto i cardini della nozione stessa di occasio-
ADL 1/2011
FRANCESCO PAOLO RUBBIO
165
ne di lavoro). Il citato indirizzo ermeneutico sembrava superare la distinzione
tra rischio generico e rischio specifico o, addirittura, lo stesso presupposto del
rischio, in quanto l’occasione di lavoro sussisteva quando il viaggio era collegato al lavoro (in tal senso G. Corsalini, op. cit., pag. 46).
La Cassazione aveva, poi, fissato analiticamente i presupposti necessari per la
indennizzabilità dell’infortunio in itinere, richiedendo in particolare la necessaria
sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che
tale percorso doveva costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e tornare alla propria abitazione (Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320, in Riv. Inf.
Mal. Prof., 2002, II, pag. 19, con nota di G. Corsalini, Il percorso più lungo tra quelli possibili ed indennizzabili dell’infortunio in itinere; D. Moraggi, La tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in Il sistema di previdenziale sociale dei lavoratori privati (a cura di Antonio Sgroi), Torino, 2010, pag. 547) .
La copertura previdenziale e la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio in itinere era esclusa nell’ipotesi in cui l’evento si fosse prodotto a seguito di una condotta dolosa e non anche colposa del prestatore di lavoro (cfr.
Cass. 4 dicembre gennaio 2001 n. 15312; Cass. 6 marzo 1996 n. 1750), ovvero
nel caso di rischio elettivo. Quest’ultimo consisteva in un pericolo estraneo e
non riguardante l’attività lavorativa, poiché derivante da una decisione arbitraria del lavoratore, che affrontava volontariamente, sulla scorta di motivazioni o
di spinte soggettive, una situazione differente da quella relativa all’espletamento della prestazione lavorativa, determinando una causa interruttiva di ogni
nesso di causalità tra il lavoro ed il rischio tutelato (cfr. Cass. 23 giugno 2003, n.
2472, in Foro Amm., 2003, pag. 1911; Cass. 17 maggio 2002, n. 7222, cit.; Cass. 4
dicembre 2001, n. 15312; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363, in Riv. It. Dir. Lav., 2002,
II, pag. 183 e segg. con nota di D. Simonato, Occasione di lavoro e rischio elettivo:
il consolidarsi di un orientamento nella giurisprudenza di legittimità).
La categoria del rischio elettivo assunse col tempo una rilevanza sempre
maggiore, in quanto questo veniva elevato ad unico elemento di contenimento
della fattispecie dell’infortunio in itinere.
Ciò era frutto del capovolgimento nel procedimento di individuazione dell’infortunio in itinere, poiché la nozione di occasione di lavoro, e conseguentemente il nesso con l’attività lavorativa, iniziava ad essere misurata in negativo.
Infatti, per la configurazione dell’occasione di lavoro non era più necessario accertare, nelle modalità di causazione dell’evento infortunistico, la sussistenza
degli elementi costitutivi di essa, ma unicamente l’assenza del rischio elettivo.
La giurisprudenza, nell’individuazione di ciò che integrava rischio elettivo
utilizzava i criteri della ragionevolezza e della meritevolezza delle scelte operate dal lavoratore. Il primo veniva utilizzato per indagare sulla normalità o meno
del comportamento del prestatore, o meglio se esso fosse conforme agli standard comportamentali propri di un certo ambiente sociale in una determinata
epoca (A. Fontana, Infortunio in itinere e standard comportamentali, in Dir. Lav.,
II, pag. 493, nota a Cass. 3 agosto 2001, n. 10750; A. Fontana, Dottrina e giurisprudenza a confronto, op. cit.; M.T. Saffioti, La problematica identità dell’infortunio in itinere fra tradizione ed innovazione, in Dir. Lav., 1999, I, pag. 417 e segg.; S.
ADL 1/2011
166
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
Brun, L’infortunio in itinere tra gli incerti confini del « rischio elettivo » e i dubbi di
legittimità costituzionale: i nodi non risolti dalla riforma del 2000, in Riv. It. Dir.
Lav., 2005, II, pag. 795 e segg., nota a ordinanza della Corte Costituzionale n. 1
dell’11 gennaio 2005). Relativamente, invece, alla verifica sulla meritevolezza,
assumevano rilievo decisivo le motivazioni sottese alla scelta del lavoratore finalizzate alla realizzazione di esigenze, costituzionalmente tutelate, di carattere
personale, familiare e sociale (G. Alibrandi, Ancora in Tema di infortunio in itinere, in Mass. Giur. Lav., 1993, pag. 262, nota a Cass. 25 gennaio 1993, n. 807).
Nessuna considerazione avevano, invece, in giurisprudenza le esigenza di tutela di interessi di natura sindacale, giacché la copertura assicurativa veniva esclusa per gli infortuni occorsi nel tragitto effettuato per recarsi o per tornare da assemblee o manifestazioni sindacali (Cass. 4 novembre 1993, n. 10875, in Foro It.,
1994, I, col. 717; G. Alibrandi, Infortunio sul lavoro in occasione di sciopero, in
Mass. Giur. Lav., 1998, pag. 515, nota a Cass. 2 febbraio 1998, n. 956).
I criteri suindicati sono stati utilizzati dalla giurisprudenza antecedente alla riforma del 2000 per ascrivere nella categoria di rischio elettivo l’infortunio
occorso al lavoratore che sceglieva di utilizzare non il percorso ordinario o normale che legava il luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa, ma uno più
lungo, ovvero più breve ma più pericoloso, senza alcun apprezzabile motivo
(come ad esempio la maggiore scorrevolezza del traffico). In sostanza, per la
giurisprudenza, in assenza di alcuna giustificazione, la scelta dell’assicurato di
percorrere la via peggiore tra le diverse possibili veniva configurata come “rischio elettivo”, in quanto idonea a determinare una situazione tale da escludere un vincolo con la prestazione lavorativa (Cfr. Cass. 18 agosto 2003, n. 12072,
in Mass. Giust. Civ., 2003, pag. 1903; Cass. 1 febbraio 2002, n. 1320 con nota di
G. Corsalini, Il percorso più lungo tra quelli possibili ed indennizzabilità dell’infortunio in itinere, op. cit., pag. 19). Ovviamente, nel caso in cui esistevano più percorsi tutti normali nei termini sopraindicati era irrilevante, ai fini indennitari, su
quale di questi percorsi l’incidente fosse avvenuto.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stata estesa anche agli eventi occorsi in itinere alle persone assicurate, ovvero a quelli verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, salvo il caso
di interruzioni o di deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque,
non necessitate, e ancora le ipotesi di guida in stato d’ebbrezza o senza patente.
Tale disposizione, in linea ed in applicazione dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, esclude la risarcibilità dell’infortunio in itinere nell’ipotesi di rischio elettivo e di condotta dolosa del lavoratore nella causazione
dell’evento. Stante il tenore letterale dell’articolo 12, è configurabile il rischio
elettivo ogni qualvolta il prestatore, senza alcun apprezzabile motivo nel recarsi dall’abitazione al lavoro e viceversa non percorre la via normale o ordinaria,
ma un’altra più lunga o più pericolosa (cfr. INAIL, Le linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere, Direzione Centrale Prestazioni INAIL, 4 maggio 1998, in Riv. Inf. Mal. Prof., punto 4.1.2.), lett. A3) dove si legge: Percorso normale è l’itinerario giustificato dalle condizioni di viabilità. In genere coincide con il
ADL 1/2011
FRANCESCO PAOLO RUBBIO
167
percorso più breve e diretto; tuttavia, può essere giustificato anche un percorso più lungo e meno diretto se risulta più logico in relazione allo stato delle strade (ad es. evidente minore pericolosità, oppure senza presenza di traffico eccessivo). In tal caso, la copertura previdenziale e la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro vengono meno, in quanto il comportamento del prestatore è considerato abnorme ed
arbitrario, al di là della semplice condotta colposa. Invero, in assenza di alcuna
valida ragione, il prestatore di lavoro sceglie di percorrere una via che lo espone ad un rischio di infortunio maggiore rispetto a quella ordinaria. Ovviamente,
alla luce del riparto dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 del Cod. Civ.,
l’assicurato che voglia, comunque, conseguire l’indennizzo dall’INAIL ed il risarcimento del danno dal datore di lavoro dovrà dimostrare che la scelta di percorrere una via diversa da quella ordinaria è stata determinata dall’impossibilità di usufruire della via normale, ad esempio, in quanto inaccessibile.
Ritornando alla pronuncia in commento, si ritiene che nella stessa sia stata
fatta corretta applicazione dei principi regolatori della materia, così come elaborati dalla giurisprudenza. Occorre, infatti, precisare che alla fattispecie esaminata dai giudici di legittimità non trova applicazione ratione temporis il d.lgs.
n. 38 del 2000, giacché l’incidente sul lavoro si è verificato nel 1998, ossia anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento. La Corte ha correttamente
escluso la risarcibilità dell’evento, poiché in presenza della via normale di uscita dal luogo di lavoro, corredata di tutti i presidi per le persone portatrici di handicap, il disabile si è esposto ad un rischio abnorme, percorrendo una via del
tutto anomala destinata all’attività di carico e scarico delle merci. Diversamente,
ove quest’ultimo avesse scelto la strada ordinaria, un eventuale infortunio sarebbe stato certamente indennizzabile.
Francesco Paolo Rubbio
Dottorando di Ricerca in Diritto dell’Impresa dell’Università di Palermo
ADL 1/2011
Cass., Sez. Lav., 5 agosto 2010, n. 18279 – Est. De Renzis – PM Fuzio –
Vod. Om. N.V. c G.P.P.
Diritto alla privacy – Diritto alla difesa – Bilanciamento tra diritti.
Nelle controversie in cui si configura una contrapposizione tra diritti aventi copertura costituzionale va applicato il c.d. criterio di gerarchia mobile, dovendo il
giudice procedere di volta in volta ed in considerazione dello specifico thema decidendum alla individuazione dell’interesse da privilegiare a seguito di una
equilibrata comparazione tra diritti in gioco, volta ad evitare che la piena tutela
di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico.
Il doveroso rispetto del diritto alla privacy non può legittimare una violazione del
diritto di difesa che, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24
Cost., comma 2), non può incontrare nel suo esercizio ostacoli ed impedimenti nell’accertamento della verità materiale a fronte di gravi addebiti suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli alla controparte in termini di un irreparabile
vulnus alla sua onorabilità e, talvolta, anche alla perdita di altri diritti fondamentali, come quello al posto di lavoro
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 14.12.2004 il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso proposto
da G.P.P. e per l’effetto dichiarava l’illegittimità del licenziamento a lui intimato con lettera del 5.02.2003 dalla datrice di lavoro VODAFONE OMNITEL N.V., disponeva l’immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.
Il G. premetteva:
– di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 5.02.1996 al
21.12.2002 con mansioni di impiegato, (OMISSIS) categoria professionale CCNL metalmeccanici privati;
– di avere ricevuto lettera del 19.11.2002, con la quale la società gli contestava di avere
inviato ad una collega del reparto una serie di messaggi elettronici tramite computer e tale
comportamento aveva spinto la collega a chiedergli di desistere da tale atteggiamento;
– di avere risposto a tale lettera osservando di avere sempre tenuto un comportamento irreprensibile sia nei confronti dei superiori che della collega;
– che la Vodafone gli aveva irrogato in data 28.11.2002 la sanzione di tre giorni di sospensione;
– che successivamente la stessa società con lettera del 12.12.2002 gli aveva contestato un altro episodio, consistente nel tentativo, che sarebbe stato operato da esso ricorrente il giorno 26.10.2002 durante l’orario di lavoro e nei locali aziendali, di baciare o
toccare una collega, di cui la Vodafone aveva taciuto il nome:
– di avere risposto a tali generiche contestazioni con lettera del 13.12.2002 negando
ogni addebito:
– che nonostante tali giustificazioni la Vodafone con lettera del 12.12.2002. a lui pervenuta il 5.02.2003, gli aveva irrogato il licenziamento, tempestivamente impugnato.
ADL 1/2011
GIANVITO RICCIO
169
2. L’anzidetta decisione, appellata dalla Vodafone Omnitel, è stata confermata dalla
Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 6227 del 2005, la quale ha ribadito che la lettera di contestazione del 12.12.2002 era assolutamente vaga e priva di importanti e necessari elementi specificativi ed identificativi, con riguardo alle modalità della condotta
tenuta dal ricorrente nei confronti dell’ignota collega, della quale non si evidenziava alcuna reazione. Ne, ha aggiunto la Corte, nella lettera di contestazione veniva indicato il
tempo trascorso nella stanza chiusa, dove si sarebbe criticato l’episodio, nè si precisava
se il G. avesse desistito dalle profferte nei confronti della collega, se fossero presenti altri colleghi e se fossero intervenuti terzi.
La stessa Corte territoriale ha osservato che le giustificazioni dell’appellante circa la
presunta tutela della “riservatezza” della dipendente coinvolta non avrebbero potuto
prevalere sul diritto di difesa del ricorrente di conoscere il nominativo della persona offesa dal comportamento attribuito al G.
(Omissis)
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso la Vodafone lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
La ricorrente sostiene che l’impugnata sentenza fornisce un’interpretazione assolutamente fuorviante della richiamata norma, che impone la contestazione disciplinare
quale momento iniziale della procedura di irrorazione della sanzione, nonché del principio di specificità della medesima contestazione. La Corte territoriale in tal modo, aggiunge la ricorrente, perviene ad una soluzione del tutto aberrante, in virtù della quale
hi contestazione rivolta al G., particolarmente precisa e dettagliata, viene ritenuta con
una forzatura evidente, già ad una prima lettura, “assolutamente vaga e priva di importanti e necessari clementi specificativi ed identificativi”.
In sostanza la ricorrente osserva che la contestazione era stata precisa con la descrizione puntuale dei l’atti, anche con riferimento al luogo dello svolgimento dell’episodio
(“sala delle riunioni del D.A.S.” coincidente con “l’Ufficio del Team Leader adibito a sala riunioni”), sicché la mancata indicazione del nome della molestata in tale quadro non
assumeva alcuna rilevanza nè incideva sulle garanzie difensive dell’incolpato.
Con il secondo motivo del ricorso la Vodafone denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma
1, artt. 23 e 24.
Al riguardo osserva che, a prescindere dalle eccepita irrilevanza dell’indicazione del
nominativo della persona offesa, tale omissione trova comunque ampia giustificazione
nei principi che presiedono alla tutela della c.d. privacy, non potendosi far prevalere il diritto di difesa del ricorrente su quella della tutela della riservatezza della lavoratrice vittima dell’episodio.
2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stando la loro stretta
connessione, sono infondati.
2.1. È consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la previa contestazione
dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha
lo scopo di consentire al lavoratore (“immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che e integrati”) quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque in violazione dei dove-
ADL 1/2011
170
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
ri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. Ed è egualmente consolidato il dictum dei giudici
di legittimità secondo cui l’accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di una indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito (efr.
ex plurimis: Cass. n. 1562 del 3 febbraio 2003; Cass. n. 11933 del 7 agosto 2003; Cass. n.
11045 del 10 giugno 2004; Cass. n. 8303 del 21 aprile 2005; Cass. n. 7546 del 30 marzo
2006 n. 7546).
2.2. Orbene il giudice di appello ha temuto ben presente i richiamati principi e ha
proceduto alla verifica del contenuto della lettera di contestazione e degli elementi ivi
indicati giungendo alla conclusione che gli stessi fossero generici, tali da non consentire
di ricostruire il reale svolgimento dei fatti e le condotte dei protagonisti e tali da non
consentire un adeguato diritto di difesa dell’incolpato.
Lo stesso giudice su tale versante ha osservato che non era irrilevante la conoscenza da parte sua del nominativo della persona che si riteneva offesa e delle modalità della
asserita “violenza” (nella lettera di contestazione si accenna al fatto che la persona offesa sarebbe stata chiamata dal G. per farsi portare un caffè nella sala riunioni e nei suoi
confronti, una volta entrata, il medesimo G. avrebbe rivolto profferte di contenuto sessuale con tentativo, contro la sua volontà, di baciarla e toccarla). Ha aggiunto che la conoscenza soprattutto del nome della persona molestata avrebbe, se non altro, permesso
al ricorrente di contrapporre circostanze di tempo e di luogo incompatibili con la denuncia della lavoratrice importunata ed evidenziare anche eventuali situazioni pregresse, tali da fornire una diversa chiave di lettura dei fatti.
Se si considera inoltre – come si ricava da quanto riportati a pagina 6 della impugnata sentenza che il G. ha – in sede di interrogatorio libero dinanzi al primo giudice riferito taluni motivi di inimicizia e la sussistenza di pregressi rapporti sentimentali con
l’accusatrice – rapporti che avrebbero potuto anche evincersi dalla stessa lettera inviata
dalla N. alla società – non può non rilevarsi che una tempestiva individuazione della persona indicata come parte offesa della condotta del suddetto G. avrebbe consentito a
quest’ultimo di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, senza quelle limitazioni che il giudice d’appello – con una valutazione congrua e logicamente motivata ha
ravvisato nel caso di specie. valutazione congrua e logicamente motivata ha ravvisato nel
caso di specie.
Al riguardo va ribadito come il giudice di appello abbia osservato che neppure il
luogo in cui sarebbe avvenuto l’episodio incriminato, è stato ben individuato, riferendosi la lettera di contestazione alla “sala riunione del DAS”, mentre nella memoria difensiva della società si parla di “Ufficio Team Leader del call center DAS”. 2. A fronte, dunque,
di queste valutazioni così ampiamente articolate la società ha ribadito le sue censure, che
si traducono in un diverso apprezzamento del requisito di specificità della contestazione, come tale, secondo la richiamata giurisprudenza, non consentito al giudice di legittimità. D’altro canto tali vantazioni superano la verifica della logicità e congruità delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, non essendo stato sollevato sotto tale profilo alcun esplicito rilievo da parte della società ricorrente.
3. Sotto altro versante va rimarcato come il giudice d’appello abbia fornito una ragionevole risposta anche sull’altro punto relativo alla mancata indicazione del nome della persona offesa, che secondo la ricorrente troverebbe ampia giustificazione nei principi
che presiedono alla tutela della c.d. privacy, ribadendo che la comunicazione di tale nominativo, fin dal momento in cui l’accusa era stata formalmente formulata, rispondeva all’esigenza di permettere all’incolpato di esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa. E ciò proprio in relazione ad una vicenda in cui la conoscenza dei rapporti pregressi
tra i protagonisti avrebbe potuto consentire di verificare la portata di accuse così gravi.
ADL 1/2011
GIANVITO RICCIO
171
3.1. L’iter argomentativo del giudice d’appello – oltre a risultare come detto congruo
e logico – si presenta del tutto condivisibile anche sul piano giuridico.
Sono note le difficoltà di definire con una regola generale ed in maniera esaustiva
l’ambito applicativo della privacy nei casi in cui si debba procedere ad individuare un
equo bilanciamento tra tale diritto ed altro diritto anche esso a copertura costituzionale.
Sul punto è stata rimarcata nella materia in esame l’esigenza che si pervenga ad un
esito variabile cosi come patrocinato da una autorevole opinione dottrinaria, che nei casi di contrapposizione di diritti garantiti dalla Carta Costituzionale parla di gerarchia
mobile. Principio questo da intendersi – non come rigida e fissa subordinazione di uno
degli interessi all’altro – ma come concreta individuazione da parte del giudice dell’interesse da privilegiare tra quelli antagonistici a seguito di una ponderata valutazione della
specifica situazione sostanziale dedotta in giudizio con conseguente bilanciamento tra
gli stessi, capace di evitare che la piena tutela di un interesse possa tradursi nella limitazione di quello contrapposto tanto da vanificarne o ridurne il valore contenutistico.
Non si è mancato di osservare in dottrina – proprio in una materia attinente al diritto di riservatezza – che l’operazione di bilanciamento può condurre ad un arretramento
di tutela dei dati personali tutte le volte in cui nel conflitto di interessi il grado di lesione
della dignità dell’interessato sia di ridotta portata rispetto a quella che subirebbe il diritto antagonista, non potendo consentirsi all’interessato di trincerarsi dietro l’astratta qualificazione del suo diritto si da limitare in maniera rilevante il diritto di difesa della controparte.
La condivisione da parte di questa Corte di tale assunto induce ad affermare che il
richiamo ad opera di una parte processuale al doveroso rispetto del diritto alla privacy –
cui il legislatore assicura in sede giudiziaria idonei strumenti di garanzia – non può dunque legittimare, nei casi come quello in esame, una violazione del disposto di cui all’art.
24 Cost. che, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, non può incontrare nel
suo esercizio ostacoli all’accertamento della verità materiale a fronte di addebiti suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli alla persona dell’incolpato ed alla sua onorabilità o come nel caso in esame – anche alla perdita del diritto al posto di lavoro.
3.2. Ragioni di completezza motivazionale inducono a evidenziare – con riferimento a fattispecie aventi ad oggetto il diritto alla riservatezza come nella giurisprudenza di
legittimità si riscontri ripetutamente l’affermazione che il giudice di merito debba effettuare in caso di contrapposizione di diritti una comparazione tra gli stessi al fine di trovare un giusto equilibrio tra le posizioni delle parti in lite (cfr. al riguardo: Cass. 30 giugno 2009 n. 15327, secondo cui la riservatezza dei dati personali debba recedere qualora il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui sia necessario per la tutela dello stesso, cui adde – con espresso
riferimento al codice della privacy di cui al D.Lgs. 193 del 2003 – e sempre per la necessita di una valutazione comparativa tra il diritto protetto dalla suddetta normativa ed il
rango del diritto azionato Cass. 7 luglio 2008 n. 18584).
Per concludere il ricorso va rigettato e la sentenza impugnata va confermata sottraendosi la stessa alle numerose cesure che le sono state mosse perché il giudice d’appello – con una motivazione congrua e ineccepibile sul piano logico – ha, dapprima, ritenuto la contestazione dell’addebito priva della necessaria specificità ed ha, poi, operato sul piano giuridico un corretto bilanciamento tra privacy, diritto inviolabile della
persona, e diritto della difesa, anche esso inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Conclusione questa che si presenta come corollario del principio di diritto che – alla stregua del disposto di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, – va enunciato nel seguenti termini: Nelle controversie in cui configura una contrapposizione tra due diritti, aventi cia-
ADL 1/2011
172
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
scuno di essi copertura costituzionale, e cioè tra valori ugualmente protetti, va applicato
il c.d. criterio di gerarchia mobile, dovendo il giudice procedere di volta in volta ed in
considerazione dello specifico thema decidendum alla individuazione dell’interesse da
privilegiare a seguito di una equilibrata comparazione tra diritti in gioco, volta ad evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico. Ne consegue che il richiamo ad opera di una parte processuale al doveroso rispetto del diritto (suo o di un
terzo) alla privacy – cui il legislatore assicura in ogni sede adeguati strumenti di garanzia
– non può legittimare una violazione del diritto di difesa che, inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento(art. 24 Cost., comma 2), non può incontrare nel suo esercizio
ostacoli ed impedimenti nell’accertamento della verità materiale a fronte di gravi addebiti suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli alla controparte in termini di un
irreparabile vulnus alla sua onorabilità e, talvolta anche alla perdita di altri diritti fondamentali, come quello al posto di lavoro.
(Omissis)
*
Antagonismo fra diritto alla privacy e diritto alla difesa e criteri di bilanciamento.
Nel caso annotato, un datore di lavoro licenziava un dipendente per giusta
causa, consistente nelle molestie perpetrate in danno di una collega, della quale tuttavia veniva taciuto il nome nella lettera di contestazione. Il lavoratore impugnava il licenziamento, eccependo la genericità della lettera di contestazione
(nella quale oltretutto veniva omesso ogni riferimento alle eventuali reazioni
dell’ignota collega, al lasso temporale di svolgimento della condotta e all’eventuale presenza di terzi colleghi), ed il datore di lavoro si difendeva evidenziando che l’omissione era imposta dall’esigenza di proteggere la privacy della collega coinvolta nella vicenda.
L’esigenza di tutelare il diritto alla riservatezza del lavoratore nello svolgimento del rapporto di lavoro è questione già affrontata dallo Statuto dei Lavoratori «la prima legge italiana nella quale compaia il termine riservatezza per indicare l’oggetto di un diritto della persona » (P. Ichino, Il contratto di lavoro, Tratt.
CM, 2003, pag. 224). L’obiettivo delle disposizioni dello Statuto che affrontano
il tema è stato individuato nell’eliminazione di «quegli svolgimenti del potere organizzativo imprenditoriale che, per le loro modalità risultino lesivi della dignità del
lavoratore » (G.C. Perone, Lo statuto dei lavoratori, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino, 1986, vol. 15, pag. 805), attraverso un’armonizzazione dei «valori dell’efficienza produttiva con i valori soggettivi di cui è portatore il
fattore lavoro » (L. Mengoni, I poteri dell’imprenditore, in Diritto e Valori, il Mulino, 1985, pag. 398). Il ruolo centrale della normativa statutaria è riconosciuto
anche dal Codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) che ha previsto
un’esplicita clausola di salvaguardia ed il rinvio agli art. 4 e 8 Stat. Lav. (P. Tullini, Comunicazione elettronica, potere di controllo e tutela del lavoratore, in Riv. It.
Dir. Lav., 2009, I, pag. 324).
ADL 1/2011
GIANVITO RICCIO
173
Nella vicenda che ha dato origine alla sentenza annotata il diritto alla privacy non viene tuttavia in rilievo nelle consuete vesti di limite ai poteri datoriali, ma quale possibile limite al diritto di difesa del lavoratore nell’ambito del
procedimento disciplinare. Oltretutto, ciò che caratterizza la fattispecie concreta è il rilievo conferito alla riservatezza, non già del lavoratore parte in causa,
bensì di un terzo (la lavoratrice molestata); sicché l’operazione di bilanciamento, di cui meglio si dirà in seguito, opera tra un diritto del lavoratore ed un diritto di un terzo.
Il decisum della sentenza annotata si colloca nel solco di un costante orientamento giurisprudenziale che riconosce la supremazia del diritto di difesa sulle esigenze di privacy (si veda, ex plurimis, Cass. 30 giugno 2009, 15327; la prevalenza del diritto di difesa su ragioni di privacy è stata affermata anche nella
speculare ipotesi di «uso da parte del datore di lavoro dei dati raccolti ad esito di ispezione interna, sia ai fini della specifica contestazione degli addebiti sia al fine della tutela giudiziaria dei propri diritti »: Trib. Milano 9 dicembre 2007, in Riv. It. Dir.
Lav., 2008, II, pag. 838 con nota di S. Caffio). Tuttavia, la ratio decidendi, che si
condensa nell’evocazione del principio di bilanciamento dei diritti in gioco da
condurre secondo il criterio di “gerarchia mobile”, rende necessaria un’indagine che, premessi alcuni cenni sulla funzione della lettera di contestazione disciplinare nell’economia del procedimento disciplinare, sia volta a sondare la solidità logico-giuridica del percorso argomentativo seguito ed i confini applicativi
del principio.
Come noto la funzione della previa contestazione dell’addebito, richiesta
ex art. 7 Stat. Lav., è quella di consentire «al dipendente incolpato di indicare le sue
giustificazioni, nonché quella di fissare, con carattere d’immutabilità la condotta della
quale è incolpato il lavoratore stesso » (G. Amoroso, V. Di Cerbo, Statuto dei lavoratori e disciplina dei licenziamenti, Milano, 1997, pag. 125). Si tratta di una garanzia procedimentale desumibile dal canone generale del giusto procedimento, ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale
come un principio di civiltà giuridica e sintetizzato nella prescrizione «audiatur
et altera pars » (Corte cost. 29 novembre 1982, n. 204).
Coerentemente con tale assunto la giurisprudenza ha, a più riprese, puntualizzato che la contestazione deve essere sufficientemente specifica, ossia deve contenere i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità, in guisa
tale che, sulla sua base, sia consentita l’esatta individuazione dell’infrazione
contestata e del comportamento nel quale il datore ravvisa l’addebito disciplinare sanzionabile (Cass. 18 aprile 1995, 4337). Né rileva – nel senso di esonerare il datore da tale onere – l’eventuale conoscenza del fatto addebitato che il lavoratore si sia formato aliunde (Cass. 21 giugno 1988, 4240).
La specificità della contestazione disciplinare è quindi condizione indefettibile per il pieno esercizio del diritto di difesa (si vedano fra le altre Cass. 23
agosto 2006, 18377, Cass. 7 agosto 2003, 11933; in dottrina si veda R. Bortone,
Sub art. 7, in Lo Statuto dei lavoratori. Commentario, diretto da G. Giugni, Milano, 1979) oggetto del giudizio di bilanciamento nella vicenda in esame.
Il bilanciamento fra diritti o principi confliggenti è una tecnica di argomen-
ADL 1/2011
174
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
tazione molto usata in sede giurisprudenziale e che è venuta alla ribalta del dibattito dogmatico e teorico-giuridico (G. Pino, Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’identità personale, in Danno
e Resp., 2003, pag. 577). La premessa del problema è che, da un lato, si verifichi
un conflitto fra diritti di pari rango nella gerarchia delle fonti e, dall’altro, sia assente una regola di coordinazione fra i due diritti (U. Natoli, Conflitto di diritti,
in Digesto Discipline privatistiche – Sez. civile, III, 1988, pag. 447). L’adozione del
principio di bilanciamento si rende necessaria allorché l’ambito di applicazione
di ciascun diritto sia in astratto indipendente dall’ambito di applicazione dell’altro, ma ciò nonostante in concreto si verifichi una parziale sovrapposizione tra i
due diritti (quando si registra, dunque, una situazione riconducibile alla nozione di « incompatibilità » o « antinomia eventuale » elaborata da A. Ross, Diritto e
giustizia, Torino, 1965, pag. 122).
L’assenza di regole normative di coordinamento fa sì che l’operazione di bilanciamento venga compiuta secondo un criterio di “gerarchia mobile”, ove
l’aggettivo mobile esplicita l’afferenza al caso concreto dell’operazione di bilanciamento e la sua non necessaria riproducibilità in relazione a casi futuri (G. Pino, op. cit., pag. 580).
L’originaria elaborazione dottrinale del criterio ha messo in luce le inevitabili implicazioni valoriali dell’operazione di bilanciamento (R. Guastini, Principi di diritto e discrezionalità giudiziale, in Dir. Pubbl., 1998, pag. 653; non a caso
l’Autore definisce il criterio quale « gerarchia assiologica mobile »). Si è messo
in luce, più in generale, come «nel caso del bilanciamento fra principi in conflitto la
deliberazione giudiziale assuma direttamente, senza mediazioni, i tratti del giudizio
morale » (B. Celano, Giustizia procedurale pura e teoria del diritto, in M. Bausciu
(a cura di), Giustizia e procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e società internazionale, Milano, 2002, pag. 103).
È stato però osservato come il bilanciamento possa comunque risultare
controllabile razionalmente ove si esplichino l’insieme delle proprietà rilevanti
in presenza delle quali uno dei due principi in conflitto prevale sull’altro e si
enuclei dunque una regola che offra soluzioni riproducibili in casi analoghi (R.
Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, pag. 63).
Dando per assodato il rango costituzionale tanto del diritto di difesa (che
trova copertura costituzionale diretta nell’art. 24 Cost.) quanto del diritto alla
privacy (la cui tutela costituzionale viene collegata all’art. 2 Cost., G. Buttarelli, Profili generali del trattamento dei dati personali, in G. Santaniello (a cura di)
La protezione dei dati personali, Padova, 2005), occorre verificare la sussistenza o
meno di regole di coordinamento fra i medesimi. Nel fare ciò, stante l’assenza di
regole di coordinamento di livello costituzionale, occorre volgere lo sguardo alla disciplina contenuta nel Codice della privacy.
Il Codice della privacy, lungi dall’operare scelte rigide, assegna rilievo centrale alla previa qualificazione dei dati personali in gioco come ordinari (intesi
ex art. 4 lett. b come informazioni relative a persone fisiche, persone giuridiche,
enti o associazioni, identificati o identificabili anche indirettamente, mediante
ADL 1/2011
GIANVITO RICCIO
175
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale) o come “dati sensibili” (intesi ex art. 4 lett. d, quali «dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale »).
Quando siano in gioco dati ordinari, il Codice della privacy accorda un’indiscutibile prevalenza al diritto alla difesa prevedendo che essi possano essere
trattati senza consenso, purché i dati siano trattati esclusivamente per finalità
difensive e per il periodo strettamente necessario a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24 lett. f). Quando, invece, entrino in gioco dati
sensibili il legislatore rafforza la tutela del diritto alla riservatezza: da un lato,
viene richiesta una previa autorizzazione al trattamento dei dati da parte del garante e, dall’altro, quando entri in gioco una categoria particolare di dati sensibili (ossia quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un soggetto), si richiede che il diritto oggetto di difesa in sede giudiziaria sia di rango
pari a quello dell’interessato (art. 26, comma 4, lett. f) . Si è osservato, infatti, come l’esame delle disposizioni del codice della privacy riveli la natura multiforme del diritto alla riservatezza, che «si conforma come un diritto a consistenza concentrica, al cui centro si colloca la categoria dei dati sensibili » (G. Santaniello, Giustizia e privacy nell’ambito del trattamento di dati personali, in Foro Amm., 2000,
pag. 2933).
L’esame della normativa di riferimento induce a ritenere che, nella generalità delle ipotesi, il diritto alla difesa prevalga sempre sul diritto alla riservatezza: l’attività di bilanciamento è stata, cioè, compiuta a monte dal legislatore che
accorda prevalenza al diritto di difesa in sé, indipendentemente dalla natura dei
diritti oggetto di difesa. Solo nel caso in cui l’esercizio del diritto di difesa comporti la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
di un soggetto, l’ordinamento impone all’interprete un’operazione di bilanciamento fra il diritto alla riservatezza ed il diritto fatto valere mediante l’attività
difensiva (l’operazione di bilanciamento viene cioè demandata a valle all’interprete).
Nel caso di specie la mancata identificazione della lavoratrice molestata e
l’omessa puntualizzazione delle modalità di svolgimento del fatto contestato
sono circostanze sufficienti ad argomentare l’invalidità del licenziamento irrogato per il mancato rispetto dei dettami di specificità della contestazione disciplinare richiesti ex art. 7 Stat. Lav.
Né la riferibilità dei dati omessi alla “vita sessuale” della lavoratrice interessata (con conseguente nascita di un obbligo di non divulgazione in capo al datore di lavoro), che pure impone al Giudice il compimento di un’operazione di
bilanciamento fra gli interessi tutelati dall’art. 7 Stat. Lav. (e dall’art. 24 Cost.) e
quelli tutelati dall’art. 26 del Codice della privacy (e dall’art. 2 Cost.), appare
idonea a determinare la legittimità del licenziamento.
La Corte, infatti, conscia dell’insegnamento che bilanciare «non vuol dire
(nonostante quanto potrebbe suggerire il termine impiegato) “ponderare” ma piutto-
ADL 1/2011
176
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
sto “sacrificare”, “accantonare” un principio a favore di un altro seppure soltanto in
relazione ad uno specifico caso concreto » (G. Pino, op. cit., pag. 580), accorda prevalenza al diritto di difesa del lavoratore, strumentale nella fattispecie alla salvaguardia del posto di lavoro.
Gianvito Riccio
Dottorando di ricerca dell’Università di Pavia
ADL 1/2011
Trib. Pisa 6 maggio 2010 – Est. Tarquini – P. E. P. e Consigliera di parità
della provincia di Pisa c. INPS
Previdenza ed assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) – Mutualità,
pensioni – Personale delle esattorie e delle ricevitorie – Fondo di previdenza – Diritto alla restituzione del 75% dei contributi versati ex art. 32, comma 2, legge n. 377 del 1958 – Epoca della presentazione della domanda di
pensione – Tempestività dell’esercizio – Compimento dell’età pensionabile
– Trattamento discriminatorio in base al genere – Principio di parità retributiva ai sensi dell’art. 141 TCE – Rilevanza.
Al Fondo Esattoriali deve riconoscersi natura di regime pensionistico professionale (id est natura retributiva ai sensi dell’art. 141 TCE). La disciplina dettata per il regime pensionistico de quo, fissando differenziati requisiti anagrafici di accesso a pensione per donne ed uomini, determina immediatamente e
necessariamente un trattamento deteriore per le donne. Ne segue la contrarietà
del regime sopra detto al principio di diritto comunitario di parità retributiva
tra uomini e donne, ed il conseguente potere dovere di questo giudice di disapplicare le disposizioni che determinano il trattamento discriminatorio per motivi di sesso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7.2.2006 P. e la Consigliera di parità della Provincia di Pisa
convenivano l’I.N.P.S. davanti a questo giudice del lavoro, allegando essere stata P. dipendente dell’Esattoria Comunale di Pisa dal 1969 al 1972, quindi, in esito al trasferimento delle competenze della Esattoria Comunale alla banca Monte dei Paschi di Siena,
del detto istituto di credito fino al 31.1.1995.
(Omissis) la ricorrente aveva cessato definitivamente la sua attività lavorativa il
24.7.2003, accedendo al pensionamento di anzianità nell’AGO con decorrenza dal
1°.4.2004, medio tempore avendo percepito l’indennità di disoccupazione.
Già il 31.7.2003, ancora secondo la prospettazione del ricorso, P., per tutta la durata
del rapporto di lavoro con i diversi concessionari dei servizi di riscossione tributi iscritta, oltre che all’AGO, al Fondo speciale ex esattorie costituito presso l’INPS, aveva presentato all’Istituto domanda di rimborso del 75% dei contributi versati in detto Fondo,
secondo la previsione dell’art. 32 della L. 377/1958, con esito negativo.
(Omissis).
Ciò premesso quanto allo svolgimento della presente vicenda processuale, nel merito, in esito all’acquisizione della comunicazione INPS 26.4.2010 (richiesta e fornita ex
art. 213 c.p.c. ), i fatti rilevanti ai fini del decidere devono ritenersi pacifici o comunque
documentati.
È invero pacifico che P., nata il 24.11.1946, dipendente dal 30.11.1969 fino al
24.7.2003 di diversi concessionari dei servizi di riscossione tributi, sia stata iscritta dal
1.12.1969 fino al 31.3.2004 al Fondo speciale esattoriali costituito presso l’INPS, e sia titolare, con decorrenza 1.4.2004, di pensione di anzianità a lei liquidata nell’AGO (nel
ADL 1/2011
178
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
periodo compreso tra la cessazione dell’attività lavorativa e la data di decorrenza della
pensione la lavoratrice avendo percepito l’indennità di disoccupazione).
Risulta poi dalla citata comunicazione 26.4.2010 di provenienza dell’INPS come la
prestazione in godimento dell’assicurata sia stata costituita con i soli contributi versati in
suo favore nell’AGO.
È infine pacifico che l’attrice abbia richiesto, il 31.3.2003, il rimborso del 75% dei
contributi in suo favore versati presso il Fondo speciale, ex art. 32 della L. 2.4.1958 n. 377,
come modificato dall’art. 7 della L. 29.7.1971 n. 587, con esito negativo, l’Istituto avendo
negato il beneficio sul presupposto dell’avvenuta cessazione da parte di P. dell’attività lavorativa in data successiva al compimento da parte sua dei 55 anni, in contrario la norma
dell’art. 7 della L. 587/1971 consentendo il rimborso a domanda solo entro il “quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le norme del Fondo”, esso
fissato, dopo l’entrata in vigore della L. 27.12.1997 n. 449, a 60 anni per le donne e 65 per
gli uomini, conformemente al regime in essere nell’AGO.
(Omissis).
Disponeva poi l’art. 21 della L. 377/1958 che gli iscritti avessero diritto alla pensione
annua complessiva di vecchiaia, che qui interessa, quando avessero raggiunto almeno 15
anni di anzianità contributiva e 55 di età anagrafica se donne e 60 se uomini, i detti requisiti essendo stati tuttavia modificati dalla disposizione del comma 3 dell’art. 59 della
L. 27.12.1997 n. 449 che anche per gli iscritti al Fondo esattoriali ha previsto che, a decorrere dal 1°.1.1998, i trattamenti da detto Fondo erogati si conseguano “esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza”, così alla data di cessazione della prestazione
lavorativa da parte dell’attrice l’età anagrafica per il conseguimento delle prestazioni di
vecchiaia nel Fondo essendo di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
(Omissis).
Infine l’art. 32 della L. 377/1958 dispone che “l’iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di
aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto
dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà della prosecuzione volontaria di cui all’articolo 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l’ultimo contributo volontario versato, l’iscrizione al Fondo con i relativi diritti, sempreché non eserciti la facoltà di cui al comma successivo.
L’iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette può chiedere il pagamento, per una
volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell’importo dei contributi versati al Fondo ai sensi del primo comma, punto 1) dell’art. 10, senza interessi”.
E la facoltà appena detta è estesa, dall’art. 7 della L. 29.7.1971 n. 587 all’iscritto “il
quale, all’atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia
previsto dalla legge citata. Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le norme del
Fondo”.
È infine noto come, alla data del pensionamento della ricorrente, i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, a lei liquidata nell’AGO in relazione ai soli contributi
versati in detta gestione, fossero, indifferentemente per uomini e donne, 35 anni di contribuzione e 57 anni di età.
Così individuata la normativa di interesse essa con chiarezza individua quali fatti
costitutivi del diritto al rimborso dei contributi ex art. 7 della L 587/1971, oltre alla titola-
ADL 1/2011
GAETANA PENDOLINO
179
rità del prescritto requisito contributivo (circostanza nella specie pacifica), anche la cessazione del rapporto di lavoro presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette e un’età anagrafica, al momento della risoluzione del rapporto, per le donne non eccedente i
55 anni - a 60 essendo per loro fissata l’età pensionabile nel Fondo in esito alla previsione dell’art. 59 della L. 449/1997 - in contrario gli uomini potendo legittimamente richiedere il detto rimborso ove cessino la relazione negoziale presupposto dell’obbligo contributivo entro i sessanta anni.
Non può allora dubitarsi (ed invero non ne dubitano le parti) che una tale normativa determini un trattamento differenziato tra iscritti al Fondo in base al loro sesso giacché, come esposto in ricorso, le donne e solo loro, ove intendano proseguire il rapporto
di lavoro fino alla data di accesso alla pensione di anzianità (57 anni) non potrebbero
più, pur in presenza del richiesto requisito contributivo, beneficiare del rimborso del
75% dei contributi versati al Fondo, per loro l’ultimo momento utile per cessare il rapporto di lavoro ed avanzare la relativa richiesta essendo il compimento dei 55 anni.
Esse sole quindi si trovano nell’alternativa di rinunciare al rimborso dei contributi
per continuare l’attività lavorativa fino al compimento del requisito anagrafico della pensione di anzianità, ovvero di rinunciare a proseguire il rapporto di lavoro fino ai 57 anni
per ottenere il rimborso dei contributi, in tal caso tuttavia con ogni conseguenza in termini di perdita di ratei di pensione di anzianità ed eventualmente dello stesso diritto alla predetta pensione.
Deve allora convenirsi con le difese attrici che la disciplina normativa come sopra
descritta imponga un trattamento differente tra due categorie di aventi diritto in dipendenza esclusivamente del sesso e la differenza si traduca, sempre e necessariamente, nella riduzione delle facoltà assicurate ad una delle due categorie (le donne), il trattamento deteriore dipendendo quindi, in via esclusiva e necessaria, dal sesso.
Ciò posto è poi noto come il principio di parità retributiva tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore sia
affermato già dall’art. 141 n. 1 del TCE, il cui n. 2 primo comma, dispone altresì come per
retribuzione debba intendersi “il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo”.
E la Corte di Giustizia (con sentenza 8.4.1976 Defrenne) ha affermato come la parità retributiva rientri “negli scopi sociali della Comunità, dato che questa non si limita all’unione economica, ma deve garantire, al tempo stesso, mediante un’azione comune, il
progresso sociale ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli europei”, così il principio di parità di retribuzione costituendo principio fondamentale della Comunità Europea, con efficacia diretta verticale ed orizzontale (così il punto 12 della motivazione).
Affermazione alla quale segue, di necessità e per pacifica giurisprudenza, l’obbligo
del giudice nazionale, sia nelle controversie tra Stato nazionale e privati, sia in quelle tra
privati, di disapplicare la normativa nazionale eventualmente confliggente con il principio di diritto comunitario, salvo il caso di contrasto della norma comunitaria con i principi fondamentali della Costituzione (caso del quale qui non vi è questione).
Deve allora concludersi che ove anche le prestazioni a vario titolo erogate dal Fondo esattoriali potessero qualificarsi retribuzione, la disciplina sopra descritta, in quanto
si risolve nell’attribuzione alle donne, e solo a loro, di un trattamento deteriore in dipendenza della diversa loro età pensionabile nel Fondo, dovrebbe dirsi contrastare con il
principio comunitario di parità retributiva, con ogni conseguenza quanto alla sua disapplicazione nella specie.
Ora sul punto le condizioni alle quali prestazioni previdenziali (e le relative contri-
ADL 1/2011
180
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
buzioni) possono qualificarsi retribuzioni (piuttosto che provvidenze erogate in dipendenza di regimi legali di previdenza sociale) secondo il diritto comunitario si trovano da
ultimo ribadite nella decisione 13.11.2008 della Corte di Giustizia (Commissione delle
Comunità Europee contro Italia, relativa al regime differenziato di pensionamento dei
lavoratori pubblici in dipendenza del sesso).
In detta decisione la Corte ha richiamato l’ampia nozione di retribuzione di cui ai
suoi numerosi precedenti, ribadendo come, oltre al criterio della pertinenza del beneficio al rapporto di impiego, decisivi ai fini della identificazione di un regime pensionistico come professionale (e quindi retributivo nel senso della disposizione dell’art. 141 del
Trattato) siano ulteriori tre caratteri: che esso riguardi una categoria particolare di lavoratori, che le prestazioni siano determinate direttamente in funzione degli anni di servizio prestati e che il relativo importo sia calcolato in base all’ultimo stipendio del lavoratore (Corte di Giustzia Beune, punto 45; Griesmar, punto 30; Niemi, punto 47, nonché
Schönheit e Becker, punto 58).
Ora, facendo applicazione dei detti principi nella specie, sembra alla decidente indubitabile che al Fondo esattoriali debba riconoscersi natura di regime pensionistico
professionale (id est natura retributiva ai sensi del Trattato), ad esso essendo iscritta obbligatoriamente una categoria, invero assai, specifica di lavoratori (“i dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a
norma del R.D.L. 13.11.1924 n. 1823 compresi quelli facenti parte del personale subalterno…, che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale”, nonché “i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi
di credito ed esattoria, sempreché il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale” a norma degli artt. 8 e 9 della L. 377/1958), ed erogando la gestione de qua prestazioni di vecchiaia determinate immediatamente in funzione
degli anni di servizio ed in misura quantificata in relazione all’ultima retribuzione percepita dagli assicurati, a norma del già citato art. 23 della L. 377/1958 (secondo il quale
“all’iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d’importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell’ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35”).
E si è sopra esposto come la disciplina dettata per il regime pensionistico de quo, fissando differenziati requisiti anagrafici di accesso a pensione per donne ed uomini, determini immediatamente e necessariamente un trattamento deteriore per le donne (costrette, si è detto, ad un’alternativa, tra percezione della pensione di anzianità nell’Ago al
raggiungimento dell’età anagrafica prevista dalla legge e rimborso dei contributi versati
nel Fondo, invece non richiesta agli uomini, i quali, a parità di età anagrafica ed anzianità assicurativa, possono ottenere entrambe le provvidenze).
Ne segue la contrarietà del regime sopra detto al principio di diritto comunitario di
parità retributiva tra uomini e donne, ed il conseguente potere dovere di questo giudice
di disapplicare le disposizioni che determinano il trattamento discriminatorio per motivi di sesso (e quindi gli artt. 32 e 21 della L. 377/2008, quest’ultimo come modificato dall’art. 59 della L. 449/1997 e l’art. 7 della L. 587/1971), così riconoscendo all’attrice le stesse facoltà dalla legge attribuite ad un assicurato nel Fondo esattoriali di pari anzianità
anagrafica e contributiva e di sesso maschile.
In accoglimento del ricorso deve pertanto affermarsi il diritto della ricorrente ad ottenere il riscatto del 75% dei contributi versati al Fondo Speciale ex esattorie e per l’effetto condannarsi l’INPS al pagamento in suo favore della corrispondente somma, oltre
accessori di legge.
(Omissis)
ADL 1/2011
GAETANA PENDOLINO
181
*
Il trattamento pensionistico degli iscritti all’ex Fondo Esattoriali e il principio comunitario di parità retributiva tra uomini e donne.
Con la sentenza in epigrafe, concernente una particolare vicenda processuale relativa al trattamento pensionistico dei dipendenti delle Esattorie, il Tribunale di Pisa offre lo spunto per affrontare questioni di più ampio e attuale interesse.
Prima di entrare nel vivo della sentenza si rende utile una preliminare ricostruzione della disciplina del Fondo Esattoriali (ora “Fondo per impiegati dipendenti dai Concessionari del Servizio di riscossione dei tributi e delle altre
entrate dello Stato e degli Enti Pubblici”) istituito presso l’Inps allo scopo di integrare le pensioni dovute agli iscritti o ai loro superstiti dall’assicurazione generale obbligatoria (di seguito AGO), cui gli stessi iscritti sono assoggettati. Il
Fondo eroga agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la
pensione dovuta dall’assicurazione obbligatoria in un’unica soluzione “non potendo attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le
condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto
al Fondo” (v. Cass., Sez. Lav., 3 aprile 1986, n. 2298, in Inf. Prev., 1986, pag. 487;
Cass., Sez. Lav., 11 giugno 2007, n. 13637, in Giust. Civ. Mass., 2007, pag. 6). La
normativa vigente non prevede la liquidazione della pensione di anzianità a carico del Fondo. Gli iscritti, però, che possono far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo e cessino l’attività lavorativa prima che sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile possono, previa costituzione della posizione assicurativa nell’AGO, ottenere la pensione di anzianità a carico dell’AGO stessa.
La controversia de qua verte, in particolare, sulla spettanza da parte della ricorrente del rimborso del 75% dei contributi versati in detto Fondo previsto
dall’art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 (come modificato dall’art. 7 della l.
29 luglio 1971, n. 587) secondo cui tale facoltà spetta all’iscritto al Fondo il quale, all’atto della cessazione dal servizio, abbia conseguito il requisito minimo di
contribuzione per la pensione di vecchiaia e a condizione che sia esercitata entro il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le
norme del Fondo.
Sulla base della predetta normativa, la lavoratrice ricorrente, iscritta sia all’AGO sia al Fondo speciale, cessata definitivamente la sua attività lavorativa all’età di cinquantasette anni, aveva inoltrato domanda di rimborso all’Inps, accedendo, successivamente, come previsto dalla normativa allora vigente, alla pensione di anzianità a carico dell’AGO. L’Inps aveva respinto la domanda assumendo essere stata la stessa avanzata, e la cessazione del rapporto con il concessionario avvenuta, oltre la data di compimento da parte dell’attrice del cinquantacinquesimo anno di età, consentendo, invece, il citato art. 32 della l. n.
377 del 1958 il riscatto dei contributi solo entro il quinto anno antecedente il
compimento dell’età pensionabile nel Fondo medesimo, fissato per le donne ai
ADL 1/2011
182
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
sessanta anni di età e per gli uomini ai sessantacinque anni di età (come disposto dalla legge n. 449 del 1997 che ha equiparato i requisiti per il trattamento
pensionistico di vecchiaia erogato dal Fondo a quelli in essere nell’AGO).
Il tribunale, ricostruita puntualmente la normativa di riferimento, nell’accogliere le doglianze così come motivate in ricorso, evidenzia i profili discriminatori della disciplina a danno delle lavoratrici iscritte al Fondo. A parità di età
anagrafica (cinquantasette anni) e di anzianità contributiva (trentacinque anni), infatti, tutti i lavoratori e le lavoratrici possono accedere alla pensione di anzianità nell’AGO. Mentre, però, i colleghi uomini possono sia avere accesso a
quest’ultima sia, maturati i necessari requisiti di contribuzione, ottenere il riscatto del 75% dei contributi versati nel Fondo speciale - essendo l’età di accesso al pensionamento di anzianità (cinquantasette anni) ben anteriore di oltre
cinque anni a quella per loro prevista per il pensionamento di vecchiaia nel Fondo (sessantacinque anni)- alle donne s’impone una scelta (poichè l’età di cinquantasette anni non potrà mai essere anteriore di oltre cinque anni a quella di
sessanta anni per le stesse fissata per il pensionamento di vecchiaia nel Fondo).
Le lavoratrici, di fatti, sono costrette a scegliere se rinunciare al rimborso
dei contributi per continuare l’attività lavorativa fino al compimento del requisito anagrafico della pensione di anzianità ovvero di rinunciare a proseguire il
rapporto di lavoro fino ai cinquantasette anni ponendovi fine ed inoltrando domanda entro il cinquantacinquesimo anno d’età per ottenere il rimborso dei
contributi, con ogni conseguenza in termini di perdita di ratei di pensione di
anzianità ed eventualmente dello stesso diritto alla predetta pensione.
La decisione si snoda attraverso un coerente percorso argomentativo che
può essere sinteticamente riassunto nei tre punti essenziali rappresentanti i passaggi logici in cui la stessa sentenza si specifica: 1) affermazione del principio
comunitario di parità retributiva; 2) sussunzione del trattamento pensionistico
de quo nell’ambito dei regimi previdenziali “professionali” retributivi; 3) riconoscimento di un trattamento discriminatorio in danno delle lavoratrici.
La parità retributiva tra donne e uomini per uno stesso lavoro sancita dall’art. 141 del Trattato della Comunità europea (ora art. 157 del nuovo Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea approvato a Lisbona) rientra per consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia negli scopi sociali della Comunità, “dato che questa non si limita all’unione economica, ma deve garantire, al
tempo stesso, mediante un’azione comune, il progresso sociale ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli europei” (v. Corte Giust.
CE 8 aprile del 1976, caso 43/75, in. Racc., 1976, I-455, noto come Defrenne II).
L’evoluzione della giurisprudenza comunitaria si è sempre più orientata nel
senso dell’estensione dell’ambito di applicazione dello stesso art. 141 attraverso, come si dirà più avanti, un allargamento della nozione di retribuzione (in
questo senso O. Bonardi, Da cavallo di Troia a leva di Archimede. Previdenza complementare e diritto antidiscriminatorio in Europa, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”, 83/2010, pag. 8) a cui ha fatto da contrappeso un parallelo restringimento della sfera applicativa della direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978,
79/7/CEE (relativa alla graduale attuazione del principio di parità di tratta-
ADL 1/2011
GAETANA PENDOLINO
183
mento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale) che, applicabile
ai soli regimi legali di sicurezza sociale, consente agli Stati membri di mantenere in vigore differenze di trattamento praticamente in tutti i settori nei quali
operano tradizionalmente meccanismi di tutela differenziata in relazione al genere (così S. Giubboni, Età pensionabile e parità di trattamento previdenziale tra
uomini e donne nel lavoro pubblico riformato, in Lav. Pubbl. Amm., 2009, n. 6, pag.
965). Proprio la disciplina dell’età pensionabile è annoverata dalla direttiva comunitaria tra quelle passibili di essere escluse, per discrezionalità del legislatore nazionale, dal rispetto del criterio di parità retributiva (art. 7, par. 1 della direttiva). Il problema dell’applicabilità del principio di parità in questione è risolvibile, dunque, sciogliendo a monte il nodo della qualificazione di un regime
pensionistico quale “regime legale” ovvero quale “regime professionale” rientrante nel concetto di retribuzione quest’ultima da intendersi, ai sensi dell’art.
141 stesso, come “il salario o trattamento normativo di base o minimo e tutti gli
altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal
datore di lavoro al lavoratore, in ragione dell’impiego di quest’ultimo”.
Detto in altri termini, un regime pensionistico configurabile quale regime
legale, interessante la generalità dei lavoratori, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva del 1979 che consente di diversificare la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia; i regimi pensionistici
qualificabili come “professionali” rientrano nella sfera applicativa dell’art. 141
del Trattato CE che vieta qualsiasi discriminazione retributiva in base al sesso.
Sono prestazioni previdenziali “professionali”, in particolare, quelle che rispondono ai tre principali criteri elaborati dai giudici comunitari a partire dalla
nota sentenza Barber (Corte Giust. CE 17 maggio 1990, C-268/88, in Racc.,
1990, pag. 1889 e segg. ) ovverosia le pensioni corrisposte in ragione di un intercorso rapporto di impiego che interessino soltanto una categoria particolare
di lavoratori, che siano direttamente funzionali agli anni di servizio prestati ed
il cui importo dipenda dall’ultimo stipendio del dipendente. Queste tipologie di
trattamento previdenziale, nell’ambito delle quali si possono pacificamente annoverare in primis le forme complementari, costituiscono una voce della retribuzione e rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione dell’art. 141 TCE
(v. Corte Giust. CE 6 ottobre 1993, C-109/91, Ten Oever, in Racc., I-4879; Corte
giust. CE 28 settembre 1994, C-7/93, Beune, in Racc., I-4471; Corte Giust. CE 29
novembre 2001, C-366/99, Griesmar, in Racc., I-9383,; Corte Giust. CE 12 settembre 2002, C-351/00, Niemi, in Racc., I-7007; tali criteri sono stati poi trasfusi
nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54/CE del 5 luglio).
Facendo proprie tali considerazioni, il giudice di Pisa ha correttamente riconosciuto la natura di regime pensionistico professionale al Fondo Esattoriale.
Si tratta, infatti, di una gestione cui sono iscritti obbligatoriamente tutti i dipendenti appartenenti ad una categoria specifica, che eroga prestazioni di vecchiaia
determinate immediatamente in funzione degli anni di servizio ed in misura
quantificata in relazione all’ultima retribuzione percepita dagli assicurati (art.
23 della l. n. 377 del 1958). Avendo natura retributiva, essa è soggetta al princi-
ADL 1/2011
184
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
pio di parità di cui all’art. 141 TCE, il quale non può dirsi rispettato a fronte di
una disciplina del Fondo stesso che, fissando differenziati requisiti anagrafici
di accesso al trattamento pensionistico in ragione del sesso, determini un trattamento discriminatorio a danno delle donne.
Le conclusioni cui giunge la decisione e, allo stesso tempo, il richiamo della
sentenza in questione all’iter argomentativo proprio della giurisprudenza comunitaria e, segnatamente, al ragionamento da ultimo ribadito nella decisione del 13
novembre 2008 della Corte di Giustizia (Corte Giust. CE 13 novembre 2008, C46/07, in Giust. Civ., 2009, 1, pag. 3) permette di accennare ad ulteriori e conclusive riflessioni con particolare riferimento alla necessità di una riforma organica
dei regimi previdenziali tanto del settore pubblico quanto del settore privato, soprattutto a seguito della normativa di emergenza emanata dal legislatore italiano
in un’ottica di adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario.
Come è noto, infatti, a seguito di tale ultima sentenza, con cui i giudici di
Lussemburgo hanno sostenuto che la gestione facente capo all’INPDAP non si
configura come un regime legale di pensionamento bensì come un regime professionale nei confronti del quale deve trovare piena applicazione il principio
della parità retributiva ai sensi dell’art. 141 TCE, è stata emanata la legge n. 102
di conversione del decreto legge n. 78 del 2009, prima, con cui il legislatore italiano ha previsto il graduale innalzamento del limite di età per la pensione di
vecchiaia delle dipendenti del pubblico impiego e la legge del 30 luglio 2010, n.
122, dopo, attraverso cui ha reso immediatamente operativo l’innalzamento
dell’età a 65 anni.
Al di là dei dubbi già ampiamente sollevati dalla dottrina con riguardo ai
passaggi logici fatti propri dalla sentenza di condanna dell’Italia (S. Giubboni,
Età pensionabile e parità di trattamento previdenziale tra uomini e donne nel lavoro
pubblico riformato, op. cit., pag. 965 e segg.; P. Bozzao, La Corte coglie nel segno
sbagliando mira: paradossi della previdenza nel pubblico impiego, in Dir. Lav. Merc.,
2009, 1, pag. 147 e segg.; P. Sandulli, Età pensionabile e parità donna-uomo per i
pubblici dipendenti: la Corte di giustizia fra omissioni e ridenominazioni, in Riv. Dir.
Sic. Soc., 2009, pag. 97 e segg.; V. Piccone, Principio comunitario di eguaglianza,
parità retributiva, età pensionabile, ibid., pag. 105 e segg.; G. Ciocca, La Corte di
giustizia, la parità retributiva e l’età pensionabile, ibid., pag. 125 e segg.; I. Corti,
La Corte di giustizia e l’età pensionabile delle donne: alcune osservazioni sull’eguaglianza di genere, ibid., pag. 133 e segg.; F. Pammolli e N. C. Salerno, Corte di
giustizia, età di pensionamento di vecchiaia per le donne e riforma delle pensioni e del
welfare in Italia, ibid., pag. 143 e segg.; B. Grandi, Le interferenze “di fatto” della
giurisprudenza della Corte di giustizia sul regime pensionistico dei pubblici dipendenti, ibid., pag. 199 e segg. ) gli esiti sono apparsi da subiti scontati, approdando la Corte di Giustizia ad una decisione cui non poteva non giungere (così O.
Bonardi, Da cavallo di Troia a leva di Archimede. Previdenza complementare e diritto antidiscriminatorio in Europa, op. cit, pag. 9 che richiama D. Gottardi, Lo
Stato di avanzamento dei lavori a livello delle istituzioni europee sulla parità di genere, in L. Calafà, D. Gottardi (a cura di), Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e
prassi applicativa, Roma, 2009, pag. 46).
ADL 1/2011
GAETANA PENDOLINO
185
Non può, però, dubitarsi del fatto che una riforma intrapresa nel senso della parificazione dei requisiti anagrafici di accesso alla pensione tra uomini e
donne nel pubblico impiego apra la strada a nuove problematiche che rimangono allo stato attuale irrisolte.
In linea di principio, infatti, benchè possa sembrare una lettura un pò estremista, le affermazioni poste a base della sentenza possono essere considerate
tout court estendibili a tutto il complesso delle regole pensionistiche e, “quando
dovesse essere richiesta di esprimersi anche sulla gestione INPS, sui coefficienti “Dini” e su tutte le altre regole di differenziazione uomo-donna in ambito
pensionistico la Corte non potrà non farlo secondo quegli stessi principi”(così
F. Pammolli e N. C. Salerno, La Corte di Giustizia Europea e le pensioni, in Editoriale Cerm, 29 novembre 2008, n. 15, pag. 4).
Come dimostra la sentenza che si commenta, inoltre, e come è stato già osservato in dottrina, l’inadempimento dell’Italia ai sensi dell’art. 141 TCE è evidente in materia di requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici complementari la cui disciplina è assoggettata alle regole vigenti nella previdenza di
base e il cui accesso avviene al raggiungimento dell’età pensionabile sempre
differenziate per uomini e donne (O. Bonardi, I destinatari della previdenza complementare, in A. Tursi (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2007, pag. 578; P. Olivelli, Donne e previdenza, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2008, pag. 377; S. Giubboni, Età pensionabile e parità
di trattamento previdenziale tra uomini e donne nel lavoro pubblico riformato, op.
cit., pag. 970 e segg. ).
Ma non è tutto. Sono già stati già sollevati dalla dottrina alcuni profili di illegittimità costituzionale delle nuove disposizioni in relazione all’art. 3 della
Costituzione per la “forte disparità di trattamento tra lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato” (così F. Ravelli, Età pensionabile nel pubblico impiego e discriminazioni di sesso secondo la Corte di giustizia (C-46/07), in
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 83/2009, pag. 15). La diversità di trattamento tra lavoratori pubblici e lavoratori privati basata su un elemento del tutto accidentale ed estrinseco quale la natura – pubblica o privata – del datore
difficilmente, infatti, potrebbe superare un sindacato di ragionevolezza.
Si tratta di casi che certamente non sono passati inosservati al legislatore,
ma riforme strutturali di così ampio respiro, non potendo essere attuate nel breve termine richiesto dagli impegni comunitari, necessitano di “un disegno sperabilmente e finalmente organico e sistematico” ormai forse ineludibile (così S.
Giubboni, Età pensionabile e parità di trattamento previdenziale tra uomini e donne
nel lavoro pubblico riformato, op. cit., pag. 972).
Gaetana Pendolino
Dottoranda di ricerca dell’Università di Padova
ADL 1/2011
App. Firenze 16 luglio 2010 – Pres. Pieri – Rel. Schiavone – Comune di
Pisa c. F. M. G., B. G., C. C., G. L., S. S., B. A.
Rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione – Stabilizzazione del
personale precario – Controversie sulla procedura di stabilizzazione – Giurisdizione del Giudice ordinario – Difetto – Giurisdizione del Giudice amministrativo – Sussistenza.
La procedura di stabilizzazione del personale precario, prevista dalla l. n. 296
del 2006 e dalla l. n. 244 del 2007, ha natura concorsuale, essendo discrezionale
sia in ordine all’an, sia in ordine al quantum dei posti da ricoprire e alle relative
professionalità, determinato sulla base della programmazione del fabbisogno
triennale. L’atto che esplicita la sussistenza dei presupposti previsti dall’ordinamento e le modalità di selezione del personale da stabilizzare, con cui l’amministrazione determina l’avvio della procedura, ha il contenuto di un bando di concorso. Di conseguenza, sulla legittimità delle forme di pubblicità adottate e sulla
congruità dei requisiti richiesti per l’inclusione nella procedura, la giurisdizione
spetta al giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 455 del 18/9/2009 il Tribunale di Pisa, giudice del lavoro, espletata l’istruttoria del caso, accoglieva parzialmente il ricorso di F. M. G., B. G., C. C., G. L., S.
S., B. A., dichiarando “il diritto dei medesimi a partecipare alle procedure di accesso alla stabilizzazione ex lege 296/2006 ed ex lege 244/2007, previa procedura selettiva, condannando
l’Amministrazione ad effettuare in loro confronto la selezione per l’accesso alle dette stabilizzazioni”. Disponeva quel giudice con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in
merito al calcolo delle differenze retributive.
Appellava il Comune di Pisa e, per i motivi meglio di seguito enunciati, concludeva
per la riforma della sentenza con conseguente integrale rigetto del ricorso di primo grado, sollevando in via pregiudiziale questione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello amministrativo.
Resistevano nel grado gli appellati per il rigetto del gravame con conferma della
sentenza impugnata.
All’udienza del 16/7/2010 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del
quale era data pubblica lettura.
Motivi della decisione
Come anticipato nella parte descrittiva dello svolgimento del processo, il Tribunale,
espletata istruttoria, accoglieva parzialmente il ricorso di F. M. G., B. G., C. C., G. L., S. S.,
B. A. con il quale avevano formulato, per la parte che qui interessa, le seguenti conclusioni: “1. accogliere il presente ricorso e per l’effetto, previo riconoscimento del carattere subordinato dell’intero rapporto di lavoro fra i ricorrenti ed il Comune di Pisa originariamente formal-
ADL 1/2011
ALESSANDRO LIMA
187
mente inquadrato come co.co.co., nonché disconoscimento del carattere fiduciario ai sensi dell’art. 90 t.u.e.l. dell’intero rapporto di lavoro fra i ricorrenti ed il Comune di Pisa e contestuale
riconoscimento del carattere subordinato del medesimo rapporto, rilevata di conseguenza la sussistenza di tutti i requisiti in capo ai ricorrenti per accedere alla stabilizzazione di cui alla finanziaria per l’anno 2007, ivi compresa la prova selettiva da questi sostenuta ed effettuata su incarico del Comune da parte della ditta Generale Industrielle, e ritenuta l’illegittimità del diniego alla domanda di stabilizzazione per il 2007 opposto dal Comune di Pisa ai ricorrenti, condannare il Comune di Pisa a procedere alla stabilizzazione dei ricorrenti ai sensi della medesima legge; 2. in via subordinata, rilevato e accertato quanto sopra, ritenuta l’illegittimità del diniego alla domanda di stabilizzazione per il 2008 opposto ai ricorrenti da parte del Comune di
Pisa, condannare il Comune di Pisa a procedere alla stabilizzazione dei ricorrenti ai sensi della
medesima legge; 3. in via ulteriormente subordinata, in riferimento ad entrambe le precedenti
conclusioni, condannare il Comune di Pisa a effettuare la prova selettiva per i ricorrenti, onde,
se superata, procedere alla loro stabilizzazione”. Seguivano ulteriori domande dirette ad ottenere il risarcimento da perdita di chance e/o il pagamento di differenze retributive.
Fermo restando la separazione delle domande relative al quantum della condanna
(punti 4 e ss.), il Tribunale accoglieva, però, soltanto la ipotesi subordinata sub n. 3, pronunciando il dispositivo sopra trascritto.
Per quanto attiene alla descrizione dello svolgimento del processo di primo grado e,
quindi, alla prospettazione che le parti hanno dato delle loro posizioni, ritiene la Corte di
dover integralmente richiamare, per relationem (C. 662/04, conf.: 2196/03) l’analisi e la
descrizione fattane dal primo giudice, atteso che le parti, in questo grado, non hanno
mosso alcuna contestazione relativa a questa parte della motivazione.
In assolutamente schematica sintesi si può, però, dire che in via di fatto è accaduto
che un gruppo di “lavoratori precari” del Comune di Pisa si è rivolto alla giustizia per veder stabilizzato il proprio rapporto di lavoro con la controparte sulla base delle surrichiamate norme del 2006 e 2007, specificando, in sostanza, che il Comune aveva proceduto alla stabilizzazione di alcuni altri precari senza comunicare loro l’avvio della procedura ed anzi facendo loro presente – di contro a specifiche istanze in merito – che detta
procedura era stata espletata ed esaurita con l’assunzione di specifiche professionalità.
Il Tribunale, dapprima rigettava il ricorso d’urgenza ex art. 700 Cod. Proc. Civ.,
quindi, in sede di giudizio di merito, accoglieva la suddetta domanda, sulla base del seguente ragionamento:
1. in via di fatto ha rilevato che tutti i precari fossero stati legati al Comune di Pisa, fino al 30/6/2005, in base a co.co.co. e, successivamente, dal 30/6/2005 al 26/2/2008, in
forza di contratti di lavoro subordinato a termine formalmente stipulati ex art. 90 d.lgs.
n. 267/2000;
2. quel giudice accoglieva le viste domande giungendo al convincimento che i primi
contratti non fossero in realtà dei co.co.co. ed i successivi non fossero caratterizzati dal
vincolo fiduciario/politico che caratterizza quella tipologia (ex art. 90 d.lgs. n.
267/2000), infatti, effettuata istruttoria, ha ritenuto che quei lavoratori in realtà fossero
stati assegnati a compiti istituzionali, senza alcun connotato politico e che il rapporto era
subordinato dall’origine;
3. ciò detto, ha però escluso di poter disporre la diretta stabilizzazione ma ha condannato il Comune a porre in essere la procedura selettiva alla quale ammettere i precari;
4. ha disposto, poi – come detto –, per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande dipendenti relative alle differenze retributive (avendoli riconosciuti come subordinati dall’inizio) e al risarcimento danni da perdita di chance.
Critica il Comune la detta decisione, concludendo, nel merito, per la non applicabilità della stabilizzazione ai contratti a termine ex art. 90 cit., stante l’esclusivo contenuto
ADL 1/2011
188
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
fiduciario del rapporto. Quel che più rileva, però, immediatamente è che la parte pubblica insiste nell’eccezione di difetto di giurisdizione – già ritualmente formulata –, in
quanto, a suo dire, i ricorrenti avrebbero lamentato sostanzialmente la mancata predisposizione di una procedura concorsuale per l’ammissione al pubblico impiego.
Il Tribunale – per superare l’eccezione – si è limitato a sostenere come, in realtà, si
trattasse di una lite in merito alla trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, benché – qui va detto – balzi subito agli occhi che si tratta di affermazione che mal si concilia con il contenuto della pronuncia di cui al punto sub 3, ove è ordinato lo svolgimento di una non meglio identificata procedura selettiva che solo eventualmente si potrebbe concludere con la detta trasformazione. E, nel merito, pur accertando che i rapporti de quibus fossero stati da sempre caratterizzati da natura subordinata, ha escluso che si potesse procedere a pronunciare sic et simpliciter il diritto degli attori alla stabilizzazione dei rapporti e, quindi, ha rigettato la domanda principale e la prima
subordinata di cui sopra con le quali era richiesta la condanna del Comune all’immeditata stabilizzazione dei rapporti fin dal 2007, per effetto della prima stabilizzazione o dal
2008 per la seconda.
In ordine al rigetto delle domande principali i ricorrenti di primo grado non hanno
interposto appello incidentale, né nell’atto di costituzione si rinviene alcuna manifestazione di volontà di insistere ex art. 346 Cod. Proc. Civ., nelle domande disattese, sostenendo essi, toto corde, la tesi del Tribunale della necessità di condanna dell’amministrazione al facere concreto di porre in essere una procedura selettiva alla quale far partecipare gli ora appellati.
Il ragionamento del primo giudice assunto dagli appellati si svolge sulla base del seguente sviluppo logico:
a. le invocate normative (L. n. 296/2006; 244/2007) rimettono alla discrezionalità
della p.a. la scelta se avviare o meno le procedure di stabilizzazione;
b. ove però – come nella specie – esse si determinino ad avviarle, deriva il loro obbligo (ex art. 97 Cost.) di consentire l’accesso a coloro i quali si trovino nelle relative condizioni soggettive, ponendo in essere adeguata pubblicità circa le procedure, il numero
e qualità delle professionalità interessate;
c. nel caso in cui – come incontestatamente è il presente – il numero degli aspiranti
sia superiore a quello dei posti disponibili, devono essere attuate procedure selettive e/o
di valutazione comparativa;
d. il Comune di Pisa deve essere condannato, quindi, a porre in essere nei loro confronti le procedure di accesso alle stabilizzazioni.
Il Tribunale ha escluso, come detto, che la legge consenta l’automatica stabilizzazione di tutti coloro avessero determinati titoli e, ritenendo necessario individuare un
numero di persone pari a quello dei posti ma inferiore a quello dei concorrenti, ha dunque comandato lo svolgimento di una procedura selettiva ad hoc tra i ricorrenti e gli ulteriori aventi titolo alla stabilizzazione.
Stando così le cose ed essendo – in ragione dell’effetto devolutivo – ormai questo
l’oggetto residuo del giudizio, è del tutto evidente che il Tribunale ha ritenuto fondate le
critiche mosse dagli allora ricorrenti circa le modalità di individuazione delle persone
che potessero partecipare a questa selezione.
Secondo quanto correttamente segnalato dal primo giudice, la normativa relativa
alla controversia consta dell’art. 90, d.lgs. n. 267/2000 (che la previsto la possibilità per
gli amministratori di enti locali di porre in essere contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la costituzione di uffici destinati all’esercizio di funzioni di carattere
politico, nella specie: tutti quelli qui coinvolti); delle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007
che hanno previsto piani di stabilizzazione del personale precario. Entrambi, però, riba-
ADL 1/2011
ALESSANDRO LIMA
189
dendo l’esclusione del “personale di diretta collaborazione degli organi politici”, come esplicitamente si rileva dalla seconda norma citata ma desumibile anche per la prima dal fatto che se la titolarità di incarichi di nomina politica non è requisito idoneo per partecipare alla riserva dei posti per ottenere semplici incarichi a tempo determinato (art. 1
comma 560, L. n. 296, cit.), a maggior ragione non è plausibile ritenere che essi possano
costituire titolo per la ben più importante stabilizzazione. Come visto, però, il Tribunale
ha ritenuto che le dette esclusioni non si applicassero ai ricorrenti de quibus avendo accertato come essi avessero espletato, in sostanza, mansioni di carattere istituzionale e
non meramente politico.
L’analisi delle procedure fissate dalle leggi di stabilizzazione (dato per ammesso,
poiché l’accertamento non rileva in ragione dell’obietto della censura mossa dall’appellante, il possesso di tutta la serie di requisiti soggettivi previsti) fa emergere la caratteristica per cui la detta stabilizzazione non solo debba avvenire previa espletamento di prove selettive (cfr.: art. 1, comma 558, L. n. 296/2006 e art. 3, comma 90, L. n. 244/2007),
qualora non già effettuate al momento dell’assunzione, quanto esse risultano subordinate all’accertamento del “numero dei posti disponibili in organico” (art. 1, comma 558, L. n.
296 cit.), ovvero alla predisposizione, “nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2008, 2009, 2010 di piani per la progressiva stabilizzazione”.
Ordunque, poiché la procedura si apre con la scelta discrezionale (amministrativa)
in ordine all’ ‘an’ (le amministrazioni “possono”, è più volte ribadito) della copertura di
determinati posti, nonché nell’ambito di stretti limiti in ordine al quantum dei posti e alle professionalità relative (discrezionalità identificata dalle norme con la previa individuazione del “fabbisogno triennale”), ne consegue che l’atto determinativo, contenente
l’esplicitazione di tutti questi presupposti ordinamentali, nonché le modalità di svolgimento, fra i concorrenti, della selezione per l’individuazione di un numero inferiore di
questi, in relazione ai posti concretamente designati, ha il contenuto di vero e proprio
bando di concorso finalizzato alla selezione dei migliori (ex art. 97 Cost.).
Da tanto ne deriva che, da un lato, della legittimità o meno delle forme di pubblicità adottate e, dall’altro, della congruità del tipo di requisiti previsti per l’inclusione nella
procedura, non potesse conoscerne il giudice ordinario, come pure egli non potesse essere chiamato, sempre in ragione dei noti criteri di riparto della giurisdizione ex art. 4, L.
n. 2248/1865, All. È, ad emettere l’eventuale ordine di porre in essere le procedure
omesse, ovvero di dettare quelle sostitutive rispetto a quanto invece realizzato.
Ed in effetti, qui non si tratta di atti di gestione di un rapporto già in corso, ovvero
del controllo della realizzazione di una rigida procedura stabilita per legge, bensì petitum sostanziale è la contestazione di un atto di macro organizzazione (nella specie individuato nella delibera n. 87 del 2/7/2007, richiamata anche nelle procedure di stabilizzazione attivate nell’anno 2008).
D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità in merito è assolutamente costante, come si evince, con lettura a contrario, dalle decisioni in punto di graduatorie per il personale scolastico, proprio al fine di individuare, sempre nell’ambito di procedure destinate all’assunzione di personale del pubblico impiego, il confine fra atti di gestione del rapporto ed atti di organizzazione della p.a. destinati alla sua costituzione.
Ha insegnato, infatti la Suprema Corte che: “In materia di graduatorie permanenti del
personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del
diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli
artt. 401 e 522 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al
giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs.
n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad
ADL 1/2011
190
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Non possono configurarsi, infatti, né l’inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs.
n. 165 del 2001), per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di
un atto di approvazione finale che individui i vincitori – trattandosi piuttosto dell’inserimento
di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili -, né
altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo)” (C. S.U.
n. 3399/08, conf.: 17466/09, 14290/07). Ed, infatti, che nella fattispecie si tratti di questione “inerente a procedure concorsuali” v’è prova pure nel fatto che il Tribunale, incontestatamente, abbia escluso di poter comandare nell’immediatezza l’assunzione (rectius:
stabilizzazione) dei ricorrenti, disponendo, invece, che essi siano assoggettati ad una individuanda procedura selettiva.
Né – contrariamente a quanto fatto dagli appellati – ha senso richiamare il disposto
di cui all’art. 63 T.U. n. 165/2001, relativo alla disapplicazione degli atti amministrativi
presupposti, in quanto si deve trattare di disapplicazione dalla quale non derivi, in ogni
caso, né un’attività di scelta discrezionale, sostitutiva di quelle libere rimesse alla p.a. e
nemmeno l’imposizione di un facere tipicamente amministrativo, come è nel caso di specie. Insomma, una volta eliminato dal mondo del diritto (oggettivo), sia pure incidenter
tantum, l’atto amministrativo ritenuto illegittimo, l’affermazione del diritto (soggettivo)
deve emergere direttamente, senza che debba essere svolta alcuna attività sostitutiva,
men che meno caratterizzata da discrezionalità.
In effetti, come risulta dagli atti, il Comune ha provveduto, in applicazione delle leggi di stabilizzazione sopra citate, ad assumere lavoratori con professionalità ben definite
(6 autisti di scuolabus, 4 insegnanti e un lavoratore già idoneo a prova concorsuale), evidentemente avendo necessità di tali specializzazioni. Sicché, imporre lo svolgimento
delle procedure selettive con inclusione degli appellati, che risultano avere mere competenze amministrative, vorrebbe dire imporre alla p.a. l’effettuazione di una selezione
di personale senza che vi sia il reale fabbisogno e comunque, prevaricando le prerogative di accertamento che la legge affida, come visto, alla discrezionalità (tecnica) della p.a.
Se poi si vuol dire che alla amministrazione fosse inibito lo svolgimento delle successive
procedure concorsuali pubblicamente bandite (per l’assunzione, per via ordinaria, di 10
istruttori amministrativi/contabili, 6 istruttori tecnici, 2 istruttori direttivi, 1 istruttore di
protezione civile) dovendo provvedere alla copertura di quei posti con le procedure di
stabilizzazione, allora vuol dire, a maggior ragione, che, venendo criticate le scelte discrezionali della p.a. nella prefissione del contenuto dei bandi di quei concorsi, questi
avrebbero dovuto formare oggetto di specifica impugnazione. Ma anche per questa via
sarebbe dovuta essere investita della questione l’AGA.
Ecco, dunque, che allora le critiche mosse alla sentenza di questa Corte 9/2/2010
(in causa Buti + altri c/ Croce Rossa avente ad oggetto sempre le medesime procedure
di stabilizzazione), risultano immotivate in quanto anche in quel caso fu negata la giurisdizione dell’AGO poiché ad essere stato criticato era il bando che, prevedendo determinate precondizioni, finiva con l’escludere i ricorrenti dalla possibilità di parteciparvi.
Alla stessa stregua, nel presente caso si lamenta che il Comune abbia posto in essere la procedura di stabilizzazione senza consentire loro di parteciparvi, sia – in via di fatto – per non aver dato adeguata pubblicità alla stessa, sia – in diritto – per aver previsto
delle professionalità che li escludevano, nell’un caso e nell’altro criticando nella sostanza la procedura di selezione. La quale, in sintesi, per essere sottoposta ai vincoli di cui sopra s’è detto, ha natura concorsuale e non può essere assimilata ad una procedura di mero accertamento di idoneità al posto.
La sentenza deve essere, dunque, riformata ed in accoglimento dell’eccezione in
ADL 1/2011
ALESSANDRO LIMA
191
questo senso sollevata dal Comune di Pisa, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO in favore del TAR, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge.
(Omissis)
*
La stabilizzazione dei lavoratori a termine e la nozione di procedura concorsuale ai fini dell’attribuzione della giurisdizione.
La sentenza in commento ha ad oggetto la giurisdizione in materia di stabilizzazione dei lavoratori a termine disposta dagli enti locali.
Alcuni dipendenti del comune di Pisa, pur essendo in possesso dei requisiti necessari per accedere alle procedure ex l. n. 296 del 2006 ed ex l. n. 244 del
2007, non erano stati coinvolti. Si erano quindi rivolti al giudice ordinario, chiedendo la condanna del Comune a procedere all’immissione in ruolo nei loro
confronti o, in subordine, a effettuare la prova selettiva e, ove superata, procedere alla loro stabilizzazione.
Il giudice di primo grado, ritenuta in capo ai lavoratori la sussistenza di tutti i requisiti previsti, aveva accolto il ricorso condannando il Comune ad effettuare la selezione nei confronti dei ricorrenti. Aveva invece escluso di poter statuire direttamente la loro stabilizzazione. Il Tribunale, in via preliminare, aveva
respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente,
ritenendo che la controversia inerisse alla trasformazione di rapporti a tempo
determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Contro questa sentenza il Comune di Pisa proponeva appello, insistendo
sul difetto di giurisdizione. Secondo l’ente, la controversia avrebbe riguardato
la mancata predisposizione da parte dell’Amministrazione di una procedura
concorsuale per l’ammissione al pubblico impiego.
Il giudice di secondo grado ha accolto l’appello. La Corte ha ritenuto che i
procedimenti previsti dalla l. n. 296 del 2006 e dalla l. n. 244 del 2007 avessero
natura concorsuale. Di conseguenza, le censure riguardanti la legittimità delle
forme di pubblicità adottate e la congruità dei requisiti previsti per la partecipazione ad essi rientrerebbero nella giurisdizione del giudice amministrativo.
La motivazione è incentrata sul fatto che la scelta dell’amministrazione di
attivare l’iter è discrezionale in merito all’an e in merito al quantum dei posti. In
particolare, l’avvio della procedura è subordinato all’accertamento della disponibilità di posti in organico. Il numero e le relative professionalità da ricoprire è
individuato sulla base di piani per la progressiva stabilizzazione predisposti
nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale. L’esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge e i criteri utilizzati dall’amministrazione per individuare i soggetti da coinvolgere sono esplicitati in un atto di
macro-organizzazione, avente « il contenuto di un vero e proprio bando di concorso finalizzato alla selezione dei migliori », che non costituirebbe un mero at-
ADL 1/2011
192
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
to di gestione del rapporto. Il procedimento previsto dalle leggi n. 296 del 2006
e n. 244 del 2007 non sarebbe neanche una « rigida procedura stabilita per legge ». La scelta di individuare i soggetti da includere sarebbe infatti rimessa alla
discrezionalità dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di programmazione del fabbisogno di personale.
Il quadro normativo è costituito dalle disposizioni della l. n. 296 del 2006
(legge finanziaria per il 2007) e della l. n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il
2008).
L’art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 2006 ha previsto la possibilità per le
autonomie regionali e locali di « procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre
2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore » della legge, « purché sia
stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge ». Per il personale assunto a termine mediante procedure diverse, la stabilizzazione è subordinata all’« espletamento di prove selettive ».
L’art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 ha previsto invece, « fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge », che per gli anni 2008 e 2009 « le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione [ . . . ] anche il
personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio [ . . . ] in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 ».
La sentenza in commento, pur condivisibile in merito alle conclusioni, necessita di alcune precisazioni.
In primo luogo la Corte d’Appello afferma correttamente che la causa non
concerne la contestazione di un atto di gestione di un rapporto di lavoro in corso, bensì di un atto di macro-organizzazione. La stabilizzazione comporta una
nuova assunzione, producendo quindi effetti novativi, e non semplicemente
modificativi, sul rapporto di lavoro (R. Garofalo, La stabilizzazione dei lavoratori precari, in M. Miscione, R. Garofalo, A. Muratorio, Lavoro e previdenza
nella legge Finanziaria 2007, in Lav. Giur., 2007, n. 2, pag. 120; D. Serra, L. Busico, La stabilizzazione dei precari del pubblico impiego, in Lav. Giur., 2009, n. 12,
pag. 1198; M.T. Spadafora, Le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 1 comma 519 L.
296/2006 (finanziaria 2007): natura e giurisdizione, in Lav. Pubbl. Amm., 2009,
n. 1, pag. 176. Contra Tar Campania-Napoli, Sez. IV, 24 gennaio 2008, n. 378, in
Comuni d’Italia, 2009, n. 3, pag. 1; Tar Sardegna-Cagliari, Sez. II, 4 agosto 2009,
n. 1431, in Foro amm. TAR, 2009, n. 7-8, pag. 2318). La legge infatti consente di
partecipare all’iter anche a soggetti che non siano più dipendenti dell’amministrazione (M.T. Spadafora, Le procedure di stabilizzazione del personale a tempo
determinato nelle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 1 comma 519 L.
296/2006 (finanziaria 2007): natura e giurisdizione, op. cit., pag. 186).
ADL 1/2011
ALESSANDRO LIMA
193
Tuttavia la natura amministrativa di un atto o di un procedimento non appare decisiva ai fini dell’attribuzione della giurisdizione (F. Carinci, Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, in Lav. Pubbl. Amm., 2002, n. 2, pag.
206). Non si può dunque attribuire rilevanza al fatto che «petitum sostanziale »
sia « la contestazione di un atto di macro-organizzazione » (nella specie la delibera con cui il comune di Pisa ha dato avvio alla procedura), come affermato
nella pronuncia che si commenta.
Secondo parte della dottrina, infatti, il riparto di giurisdizione tra giudice
ordinario e amministrativo in tema di lavoro pubblico privatizzato si basa sul
criterio della materia (F. Carinci, Una riforma “conclusa ”. Fra norma scritta e
prassi applicativa, in F. Carinci, L. Zoppoli, Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, tomo I, in Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Torino,
2004, pag. LI; D. Borghesi, La giurisdizione del giudice ordinario, in F. Carinci,
L. Zoppoli, Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, tomo I, op. cit., pag. 1217.
Tuttavia in dottrina e in giurisprudenza prevale la tesi che attribuisce rilievo alla natura della situazione giuridica lesa: cfr. S. Cassese, Il sofisma della privatizzazione del pubblico impiego, in Riv. It. Dir. Lav., 1993, n. 5, I, pag. 30; G. D’Auria,
La manovra finanziaria 2008: ombre e luci. Il personale pubblico, in Giorn. Dir.
Amm., 2008, n. 3, pag. 263; Tar Toscana-Firenze, 9 febbraio 2010, n. 233, in Foro
Amm. TAR, 2010, n. 2, pag. 416; Cass. Civ., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16041, in
Giust. Civ. Mass, 2010, pag. 78; Tar Veneto, Sez. II, 15 novembre 2007, n. 3646, in
Foro It., 2008, III, col. 230). Sono devolute al primo tutte le controversie relative
ai rapporti di lavoro « privatizzati », incluse quelle concernenti l’assunzione al
lavoro, ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, e al secondo le liti in materia
di procedure concorsuali per l’assunzione, ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del
2001.
Seguendo tale impostazione, che appare condivisibile in quanto l’art. 63 del
d.lgs. n. 165 del 2001 distingue le liti in materia di rapporto di lavoro privatizzato da quelle relative ai concorsi finalizzati all’assunzione, rendendo superflua
l’indagine circa la situazione giuridica lesa (D. Borghesi, La giurisdizione del
giudice ordinario, op. cit., pag. 1217), è quindi necessario, ai fini dell’attribuzione
della giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione, stabilire se esse siano o
meno di carattere concorsuale.
La Corte d’Appello ha ritenuto che l’iter procedurale previsto dalla l. n. 296
del 2006 e dalla l. n. 244 del 2007 fosse di tipo concorsuale, ma è giunta a tale
conclusione argomentando sulla base del fatto che esso si apre con la scelta discrezionale in merito all’an della copertura di determinati posti e in merito al
quantum di essi e alle relative professionalità, previa individuazione del fabbisogno triennale di personale.
Tuttavia, si deve ritenere più correttamente che una procedura sia concorsuale in quanto incentrata sul metodo comparativo tra più soggetti che aspirano all’assunzione (L. Fiorillo, Il reclutamento del personale pubblico: forme contrattuali stabili e flessibili, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dal d.lgs. n. 29/1993 ai d.lgs. nn. 396/1997, 80/1998 e 387/1998. Commentario
diretto da F. Carinci e M. D’Antona, tomo II, Milano, 2000, pag. 1040) e ca-
ADL 1/2011
194
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
ratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei
candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria (Cass. Civ., Sez. Un., 7
luglio 2010, n. 16041, cit.). Assume dunque rilevanza l’esistenza della concorrenzialità fra i partecipanti ad una selezione, anche per soli titoli, indetta per
l’assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni e aperta a soggetti in possesso di determinati requisiti (Cons. Stato, 5 giugno 2006, n. 3331, in Foro
Amm. CDS, 2006, n. 6, pag. 1858).
La giurisprudenza maggioritaria nega la natura concorsuale delle procedure di stabilizzazione. In esse mancherebbero un giudizio comparativo e
qualsiasi discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione (Tar Veneto, 15 novembre 2007, n. 3643, in Foro Amm. TAR, 2007, n. 11, pag. 3413; Tar
Veneto 15 novembre 2007, n. 3646, cit.; Tar Toscana, Sez. II, 23 gennaio 2009,
n. 88, in Foro Tosc., 2009, n. 1, pag. 80; Trib. Genova, 10 aprile 2009, in Riv.
Crit. Dir. Lav., 2009, n. 4, pag. 1089; Tar Umbria-Perugia, Sez. I, 20 maggio
2009, n. 258, in Foro Amm. TAR, 2009, n. 5, pag. 1402; Trib. Voghera 11 giugno 2009, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2009, n. 3, pag. 851; Tar Sicilia-Catania, Sez.
II, 26 ottobre 2009, n. 1739, in Foro Amm. TAR, 2009, n. 10, pag. 2975; Tar Toscana-Firenze, Sez. I, 9 febbraio 2010, n. 233, cit.; Cass. Civ., Sez. Un., 7 luglio
2010, n. 16041, cit.; Tar Sardegna-Cagliari, Sez. I, 28 settembre 2010, n. 2267,
in Red. Amm. TAR, 2010, n. 9). La stabilizzazione si concretizzerebbe quindi
in un avviamento al lavoro (Tar Lazio-Latina, Sez. I, 24 settembre 2008, n.
1240, in Foro Amm. TAR, 2008, n. 9, pag. 2492; Tar Liguria-Genova, Sez. II, 20
dicembre 2008, n. 2173, in Foro Amm. TAR, 2008, n. 12, pag. 3329), come nel
caso di assunzione tramite le liste di collocamento, ex art. 35, comma 1, lett. b,
d.lgs. n. 165 del 2001 e di assunzione o stabilizzazione dei c.d. lavoratori socialmente utili (Cons. Stato, Sez. V, 26 novembre 2008, n. 5844, in Foro Amm.
CDS, 2008, n. 11, pag. 3038, richiamata da Tar Liguria-Genova, Sez. II, 20 dicembre 2008, n. 1273, cit.). Essa implicherebbe il mero inserimento in una
graduatoria, in base a criteri fissi e prestabiliti, di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti e che vi aspirano (Tar Sicilia-Catania, Sez. II, 26
ottobre 2009, n. 1739, cit.; Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16041, cit.; Tar Sardegna-Cagliari, Sez. I, 28 settembre 2010, n. 2267, cit.). Di conseguenza, la
giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, ex art. 63, comma 1, d.lgs. n.
165 del 2001.
La Corte d’Appello di Firenze invece aderisce all’indirizzo giurisprudenziale minoritario che riconosce per le controversie inerenti alla procedura di stabilizzazione la giurisdizione del giudice amministrativo (Tar Puglia 19 gennaio
2008, n. 125, in Foro It., 2008, III, col. 419; Cons. Stato, Sez. V, 10 agosto 2010, n.
5541, in Red. Amm. CDS, 2010, n. 7).
L’avvio delle procedure ex art. 1, comma 558, l. n. 296 del 2006 ed ex art. 3,
comma 90, l. n. 244 del 2007 per coprire i posti vacanti in organico dipende da
una scelta discrezionale dell’amministrazione datrice di lavoro (Tar Veneto 19
ottobre 2007, n. 3342, in Foro It., 2008, n. 7-8, col. 420; Cass., Sez. Un., 1 luglio
2010, n. 15648, in Mass. Giust. Civ., 2010, n. 7-8; in dottrina A. Pozzi, La stabilizzazione dei precari del pubblico impiego: tecniche legislative tra illusioni e princi-
ADL 1/2011
ALESSANDRO LIMA
195
pi costituzionali, in Giur. Amm., 2007, n. 1, IV, pag. 36; B. Caruso, La regolazione “a doccia scozzese” del lavoro pubblico. Rigidi, flessibili, precari, di nuovo rigidi,
in Lav. Pubbl. Amm., 2008, n. 2, pag. 243; M.T. Spadafora, Le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni ai
sensi dell’art. 1 comma 519 L. 296/2006 (finanziaria 2007): natura e giurisdizione, cit., pag. 180), effettuata nell’ambito della programmazione del fabbisogno
di personale, come riconosciuto dalla Corte d’Appello. L’ente quindi non è obbligato ad attivare il procedimento, nè a porre in essere la stabilizzazione di
tutti coloro aventi i requisiti previsti dalla legge (B. Caruso, La regolazione “a
doccia scozzese” del lavoro pubblico. Rigidi, flessibili, precari, di nuovo rigidi, op.
cit., pag. 243-244), potendo limitarla ai soggetti in possesso delle professionalità di cui necessita.
Qualora l’amministrazione decida di avviare l’iter, non si può negare in ogni
caso che esso sia di tipo concorsuale. Dal quadro normativo delineato dalle due
leggi finanziarie citate emerge la necessità di una scomposizione dei procedimenti in questione, a seconda che i soggetti da immettere in ruolo siano stati assunti « mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme
di legge » o « mediante procedure diverse ». Deve farsi poi un’ulteriore distinzione tra il caso in cui i posti da ricoprire mediante stabilizzazione siano in numero superiore o pari agli aventi titolo e quello in cui invece i pretendenti siano
in numero maggiore.
Solo nell’ipotesi in cui siano già state sostenute le prove previste e non vi
siano più concorrenti rispetto al numero dei posti deve negarsi il carattere concorsuale della procedura, mancando qualunque discrezionalità dell’amministrazione nella scelta del personale da stabilizzare e qualsiasi procedura di tipo
comparativo. Tale caso dunque rientra nella materia delle « controversie concernenti l’assunzione al lavoro », con giurisdizione del giudice ordinario (A.
Pozzi, La stabilizzazione dei precari del pubblico impiego: tecniche legislative tra illusioni e principi costituzionali, op. cit., pag. 22).
Al contrario, qualora occorra effettuare le prove selettive, queste devono essere di tipo concorsuale, in conformità all’art. 97 Cost. (Tar Toscana-Firenze,
Sez. I, 9 febbraio 2010, n. 233, cit. Contra A. M. Perrino, Dalla flessibilità al rigore: la parabola del contratto a termine nel lavoro pubblico contrattuale, in Foro It.,
2008, III, col. 233).
Analogamente, la natura concorsuale della procedura deve essere affermata nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti aspiranti all’immissione in ruolo rispetto al numero dei posti disponibili, in quanto in tale evenienza deve essere instaurata una selezione di tipo comparativo (D. Serra, L. Busico, La stabilizzazione dei precari del pubblico impiego, op. cit., pag. 1204; M.T. Spadafora, Le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 1 comma 519 L. 296/2006 (finanziaria 2007): natura e
giurisdizione, op. cit., pagg. 183-184).
Nel caso di specie vi era un numero di aventi titolo alla stabilizzazione superiore a quello dei posti disponibili. Era quindi necessario che l’amministrazione ponesse in essere una scelta di tipo comparativo. Tale circostanza deter-
ADL 1/2011
196
PARTE SECONDA . GIURISPRUDENZA - SENTENZE ANNOTATE
mina l’inclusione della procedura tra quelle « concorsuali per l’assunzione ». La
giurisdizione sulle controversie di esclusione dalla stessa spetta quindi al giudice amministrativo, ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001.
Alessandro Lima
Dottorando di ricerca dell’Università di Padova
ADL 1/2011
GIURISPRUDENZA
R AS S E G NA
Irene Corso
Assegnista di ricerca dell’Università di Padova
IL LAVORO STRAORDINARIO: UNA LETTURA
DEGLI ATTUALI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
ALLA LUCE DEL D. LGS. N. 66/2003
Sommario: 1. Premessa. – 2. La definizione di « lavoro straordinario ». – 2.1. Segue: a) i “tempi”
rientranti nella nozione di « orario di lavoro ». – 2.2. Segue: b) il superamento dell’« orario
normale di lavoro ». – 3. Il previo accordo tra le parti quale presupposto per lo svolgimento di lavoro straordinario. – 4. Il compenso per lo straordinario legale e per lo straordinario contrattuale. – 5. Lo straordinario nelle attività per le quali la legge non prevede
un orario normale di lavoro. – 6. L’incidenza del compenso per il lavoro straordinario sugli istituti retributivi indiretti. – 7. I patti di conglobamento e di forfetizzazione dello
straordinario. – 8. La prescrizione del diritto al compenso per lavoro straordinario. – 9.
L’onere della prova dello svolgimento di lavoro straordinario. – 10. Le sanzioni amministrative.
1. – Gli orientamenti della giurisprudenza sia di merito che di legittimità sulle molteplici questioni che, direttamente o indirettamente, riguardano il lavoro straordinario sono per lo più consolidati. Si tratta, tuttavia, di
orientamenti formatisi con riferimento alla disciplina vigente prima del
d.lgs. n. 66/2003: una rassegna giurisprudenziale sull’argomento costituisce, pertanto, l’occasione, da un lato, per riflettere sulla tenuta degli attuali
orientamenti alla luce delle modifiche apportate alla disciplina dello straordinario dalla riforma sull’orario di lavoro, e, dall’altro lato, per fare il punto
sulle soluzioni giurisprudenziali delle questioni sulle quali tale riforma non
ha inciso.
2. – L’art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 66/2003 definendo « lavoro
straordinario » « il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come
definito dall’art. 3 » evoca la formulazione dell’art. 2108, comma 1, Cod.
Civ. e dell’art. 5 del r.d.l. n. 692/1923: per stabilire quando in concreto vi sia
lavoro straordinario è, quindi, necessario individuare, da un lato, i “tempi”
che rientrano nella nozione di « orario di lavoro » e, d’altro lato, i limiti del-
ADL 1/2011
198
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
la durata dell’« orario normale di lavoro », come già bisognava fare prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003.
2.1. – Sotto il primo profilo, al fine di accertare l’eventuale superamento dell’orario normale di lavoro e, conseguentemente, lo svolgimento di lavoro straordinario, la più recente giurisprudenza si è in più occasioni occupata della computabilità nell’orario di lavoro del tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro e per indossare la divisa aziendale.
Secondo la Corte di Cassazione il tempo necessario per raggiungere il
luogo di lavoro non rientra di regola nell’attività lavorativa vera e propria e,
quindi, non va sommato al normale orario di lavoro come straordinario (1),
salvo che lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione: l’esistenza
di tale requisito è riconosciuta, in particolare, con riferimento al tempo impiegato per lo spostamento dalla sede aziendale al luogo di svolgimento della prestazione, nei casi in cui il dipendente sia obbligato a presentarsi presso la sede aziendale e poi di volta in volta destinato in diverse località (2) e,
a maggior ragione, qualora il dipendente guidi l’automezzo aziendale per
trasportare operai e attrezzi di lavoro dalla sede aziendale al luogo della
prestazione (3) oppure, con riferimento al tempo impiegato per lo spostamento dal luogo di dimora al luogo di esecuzione della prestazione, quando il lavoratore debba svolgere le proprie mansioni in un luogo non predeterminato e diverso dalla sede aziendale (4) o sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti al tipo di prestazione, a risiedere in un determinato luogo (5). Viceversa, la Corte di Cassazione nega fermamente che il
tempo impiegato giornalmente dal lavoratore per raggiungere la sede di la-
(1) Cass. 1° settembre 1997, n. 8275, in Not. Giur. Lav., 1997, pag. 753.
(2) Cass. 14 marzo 2006, n. 5496, in Foto It., 2006, I, col. 2791, e in Not. Giur. Lav., 2006,
pag. 289; Cass. 22 marzo 2004, n. 5701, in Orient. Giur. Lav., 2004, pag. 58, in Riv. Crit. Dir.
Lav., 2004, pag. 601, con nota di Corrado, Tempo di viaggio e orario di lavoro: una conferma della Suprema Corte e una riflessione sul d.lgs. n. 66 del 2003, in Dir. Giust., 2004, pag. 105, in Not.
Giur. Lav., 2004, pag. 692, e in Lav. Giur., 2004, pag. 901; Cass. 11 aprile 2003, n. 5775, in Foro
It., 2003, I, col. 2396, e in Not. Giur. Lav., 2003, pag. 578; Cass. 9 dicembre 1999, n. 13804, in
Not. Giur. Lav., 2000, pag. 184; in tal senso anche la risposta ad interpello n. 13/2010 del Ministero del Lavoro.
(3) App. Napoli 24 febbraio 2004, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2004, pag. 596; Cass. 11 aprile
2003, n. 5775, cit., con riferimento alle ore svolte da un lavoratore con mansioni di boscaiolo
alla guida del pulmino aziendale per raggiungere, insieme ai colleghi, le zone montane di svolgimento della prestazione; Cass. 3 febbraio 2000, n. 1202, in Orient. Giur. Lav., 2001, pag. 14, e
in Not. Giur. Lav., 2000, pag. 536, con riferimento all’autista delle Ferrovie dello Stato addetto
al trasporto degli operai svolgenti lavori sulle linee.
(4) Cass. 9 dicembre 1999, n. 13804, cit.
(5) Cass. 14 marzo 2006, n. 5496, cit.
ADL 1/2011
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
199
voro durante il periodo della trasferta possa considerarsi come impiegato
nell’esplicazione di attività lavorativa, evidenziando come il disagio psicofisico e materiale del lavoratore sia in tal caso già compensato dall’indennità di trasferta (6).
L’unica sentenza di merito rinvenuta su fatti successivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003 ha invocato l’applicazione dei principi sopra descritti per escludere che il periodo necessario per compiere il tragitto dalla
sede aziendale al luogo della prestazione rientri nell’orario di lavoro quando il lavoratore sia libero di decidere se raggiungere il punto di raccolta o
presentarsi direttamente sul luogo dove è tenuto a effettuare la sua prestazione lavorativa, utilizzando mezzi di sua proprietà (7). La possibilità che il
descritto orientamento possa continuare ad essere confermato sembra
supportata dal fatto che l’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 66/2003 prevede
« che rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all’art. 5 r.d. 1955/1923 », ovvero
quegli stessi periodi – tra i quali era espressamente menzionato il « tempo
per recarsi sul posto di lavoro » – che già non costituivano « lavoro effettivo » ai sensi dell’art. 3 del r.d.l. n. 692/1923.
Per quanto, invece, concerne il tempo necessario per indossare e dismettere gli abiti da lavoro, la Corte di Cassazione, di solito distingue a seconda che il lavoratore abbia o meno la facoltà di scegliere il tempo e il luogo in cui vestirsi e svestirsi: tali operazioni nel primo caso sono considerate
strumentali e preparatorie rispetto alla prestazione lavorativa ed adempimento dell’obbligo di diligenza di cui all’art. 2104 Cod. Civ. e, conseguentemente, il tempo necessario per effettuarle non è computato nell’orario di
lavoro, nel secondo caso, invece, sono considerate eterodirette dal datore
di lavoro e, conseguentemente, il tempo necessario per compierle è computato nell’orario di lavoro (8). Tuttavia, mentre secondo l’orientamento
maggioritario perché il relativo tempo possa considerarsi eterodiretto – e,
(6) Cass. 22 marzo 2004, n. 5701, cit.; Cass. 3 febbraio 2003, n. 1555; Cass. 10 aprile 2001,
n. 5359, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 749; Cass. 3 febbraio 2000, n. 1170; Cass. 3 febbraio 2000,
n. 1202, cit.; Cass. 1° settembre 1997, n. 8275, cit.; in tal senso anche la risposta ad interpello n.
15/2010 del Ministero del Lavoro.
(7) Trib. Milano 23 giugno 2010, in Lav. Giur., 2010, pag. 953.
(8) Cass. 2 luglio 2009, n. 15492, in Orient. Giur. Lav., 2010, pag. 11; Cass. 25 giugno 2009,
n. 14919, in Orient. Giur. Lav., 2010, pag. 11, secondo cui però non può essere considerata nulla la clausola del contratto collettivo che esclude la retribuzione per le attività preparatorie e
per compensare stabilisce una maggiorazione della prestazione oraria; Cass. 22 luglio 2008, n.
20179, in Foro It., 2009, I, col. 2768; Trib. Milano 6 luglio 2007, in Orient. Giur. Lav., 2007, pag.
896; Cass. 8 settembre 2006, n. 19273, in Dir. Prat. Lav., 2008, pag. 1200; Trib. Milano 5 aprile
2006, in Orient. Giur. Lav., 2006, pag. 351; Trib. Genova 20 dicembre 2005, in Lav. Giur., 2006,
pag. 587 secondo cui, però, il descritto principio vale solo per la vestizione e non anche per la
ADL 1/2011
200
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
quindi, costituire tempo di lavoro – è sufficiente che la divisa debba essere
indossata in azienda (9), secondo un orientamento minoritario è a tal fine
decisivo che vi sia anche un controllo da parte del datore di lavoro sulla
quantità del tempo effettivamente impiegato (10).
Va, tuttavia, evidenziato come una recente sentenza della Corte di Cassazione (11), in tal senso preceduta da qualche sentenza di merito (12), pure sempre invocando l’art. 2104 Cod. Civ., sembri tuttavia orientata a superare la distinzione fondata sulla facoltà del lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in
cui indossare la divisa aziendale ed a valorizzare, piuttosto, il carattere dell’accessorietà e della strumentalità – e, quindi, esigibilità da parte del datore
di lavoro – dell’operazione rispetto alla prestazione lavorativa finale. A questo
orientamento sembrano riconducibili anche le pronunce che con riferimento ai tempi di vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione individuale hanno statuito che, poiché tali operazioni sono finalizzate ad una prestazione in conformità della legge, indipendentemente dal luogo in cui avvengano, il tempo necessario per compierle costituisce orario di lavoro (13).
Le sentenze di merito pronunciate con riferimento a fattispecie successive all’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003 hanno tutte confermato il descritto orientamento (14), ad eccezione, per quanto consta, solo di una sentenza del Tribunale di Monza in cui è stato posto in dubbio che, alla luce
della definizione di orario di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del
d.lgs. n. 66/2003, sia ancora possibile considerare orario di lavoro il tempo
necessario per indossare la divisa aziendale: l’attuale definizione di orario
di lavoro presupporrebbe, infatti, sia la messa a disposizione del datore di
lavoro sia l’esercizio delle attività/funzioni, escludendo che i due concetti
possano identificarsi, mentre le operazioni preparatorie, pur comportando
la messa a disposizione del datore di lavoro, non potrebbero considerarsi
anche esercizio di attività lavorativa (15).
svestizione; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15734, in Foro It., 2004, I, col. 89; Trib. Torino 27 settembre 2000, in Foro It., 2001, I, col. 360.
(9) Cass. 22 luglio 2008, n. 20179, cit.
(10) Cass. 8 settembre 2006, n. 19273, cit.
(11) Cass. 10 settembre 2010, n. 19358, in Lav. Giur., 2010, pag. 1137.
(12) App. Milano 20 ottobre 2005, in Lav. Giur., 2006, pag. 508; Trib. Milano 9 febbraio
1996, in Lav. Giur., 1996, pag. 500.
(13) App. Milano 27 gennaio 2010, in Orient. Giur. Lav., 2010, pag. 185; App. Milano 10 luglio 2008; Trib. Torino 29 novembre 1999, in Giur. Piem., 2000, pag. 138. Contra Pret. Roma 25
gennaio 1985, in Orient. Gur. Lav., 1986, pag. 121.
(14) Trib. Milano 19 settembre 2008, in Lav. Giur., 2009, pag. 207; Trib. Milano 20 novembre 2007, in Lav. Giur., 2008, pag. 854; Trib. Milano 17 gennaio 2007, in Orient. Giur. Lav.,
2007; App. Milano 20 ottobre 2005, in Lav. Giur., 2006, pag. 508.
(15) Trib. Monza 15 gennaio 2009, secondo cui il principio affermato dovrebbe a maggior
ADL 1/2011
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
201
Analoghi problemi di computabilità nell’orario di lavoro si sono posti
con riferimento ai “tempi” durante i quali il lavoratore è temporaneamente
inattivo, ma, comunque, pronto ad eseguire la propria prestazione in caso
di necessità. Tale ipotesi ha assunto rilevanza nell’ordinamento interno con
riferimento al periodo di tempo trascorso dall’autotrasportatore a bordo
del veicolo mentre è alla guida il secondo autista: in tal caso la Corte di Cassazione ha ritenuto che siano computabili come orario di lavoro effettivo
anche i periodi di inattività atteso che, dovendo il lavoratore rimanere costantemente pronto a mettere a disposizione la propria forza lavoro per
qualunque richiesta o necessità e non potendo il medesimo disporre liberamente di se stesso, l’assenza di attività lavorativa è meramente temporanea e non qualificabile come riposo effettivo (16). Ad analoga conclusione
era, del resto, già pervenuta la Corte di Giustizia nel considerare come rientrante nell’orario di lavoro e, se del caso, come lavoro straordinario ai
sensi della direttiva 93/104/Ce, il periodo di servizio di guardia svolto dai
medici delle unità di pronto soccorso secondo il regime della presenza fisica presso il centro sanitario (17). Considerato che la definizione di orario di
lavoro di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66/2003 costituisce una
mera trasposizione della definizione di orario di lavoro prevista dalla direttiva 93/104/Ce, è ragionevole dubitare della ammissibilità nell’ordinamento interno di interpretazioni che considerino la messa a disposizione del
datore di lavoro e l’esercizio delle attività/funzioni come criteri cumulativi
e non alternativi (18).
Diverso rimane, invece, il discorso con riferimento alla reperibilità, ovvero all’obbligazione del lavoratore di porsi nella condizione di essere
prontamente rintracciato al di fuori del proprio orario di lavoro e di raggiungere in un breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta. È pacifico, infatti, che l’oggetto di tale obbligazione differisca qualitativamente dalla prestazione di lavoro e che, vincolando in misura minore il lavoratore, possa essere remunerata con un compenso inferiore. Resta fermo, però, che, qualora il lavoratore venga effettivamente
chiamato durante il turno di reperibilità ed effettui la sua prestazione, le
ore dal medesimo lavorate dovranno essere computate come orario di laragione valere per le operazioni di svestizione, normalmente non sottoposte ad alcun controllo o direzione aziendale.
(16) Cass. 2 marzo 2009, n. 5023, in Foro It., 2009, I, col. 1738: probabilmente nell’affermazione di tale principio ha inciso in modo rilevante il fatto che nel caso di specie l’autotreno
fosse sprovvisto di cabina.
(17) Corte Giust. UE 9 settembre 2003, C-151/02, in Lav. Giur., 2003, pag. 1126, con commento di A. Allamprese, Attività di guardia medica e orario di lavoro.
(18) Cfr. Trib. Monza 15 gennaio 2009 citata in nota n. 15.
ADL 1/2011
202
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
voro e retribuite con le maggiorazioni eventualmente previste per lo straordinario (19).
2.2. – Come sopra accennato, la definizione di « lavoro straordinario »
presupponeva (e presuppone tutt’ora) anche la delimitazione dell’« orario
normale di lavoro »: ne consegue che non era (e non è tutt’ora) possibile riferire la disciplina legale dello straordinario a quelle attività per le quali il
legislatore non ha previsto un orario normale di lavoro (20).
Nessun dubbio si era mai posto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.
66/2003 in ordine alla qualificazione come straordinarie delle prestazioni
svolte oltre l’orario normale legale fissato in 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali dall’art. 1 del r.d.l. n. 692/1923 e poi, fermo il predetto limite giornaliero, in 40 ore settimanali dall’art. 13 della l. n. 196/1997 o, comunque,
eccedenti la media dei predetti limiti nel caso di ricorso all’orario multiperiodale (21) o nel caso di lavoro a turni (22). Le principali questioni emerse
concernevano la configurazione del limite giornaliero e del limite settimanale come alternativi o come cumulativi e l’identificazione del periodo di
riferimento del limite settimanale nella “settimana di calendario” (dal lunedì alla domenica) o in qualunque periodo temporale di sette giorni decorrente a partire da qualunque giorno: la giurisprudenza si è orientata nel
senso di considerare alternativi i limiti giornaliero e settimanale (23) e di far
coincidere, salvo diversa e più favorevole disposizione da parte dei contratti collettivi, il periodo di riferimento del limite settimanale con la settimana di calendario (24). Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003 non
(19) Cass. 19 novembre 2008, n. 27477; Trib. Milano 10 luglio 2001; Cass. 7 giugno 1995,
n. 6400; Cass. 9 settembre 1991, n. 8648.
(20) Eccezionalmente Trib. Bolzano 9 agosto 2004, in Lav. Giur., 2005, pag. 245, con
commento di D. Simonato, Orario di lavoro dei conducenti di automezzi e diritto comunitario, secondo cui l’ambito di applicazione dell’art. 13, comma 1, l. n. 196/1997 era tendenzialmente
omnicomprensivo e trovava applicazione al lavoro tout court indipendentemente dalla sua effettività e, quindi, anche nei confronti dei lavoratori discontinui.
(21) Cass. 5 gennaio 2001, n. 89, in Foro It., 2001, I, col. 459.
(22) Trib. Monza 20 gennaio 2009; Cass. 8 luglio 1994, n. 6446, secondo cui il lavoratore
turnista non ha diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario qualora risulti mediamente
rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana di lavoro.
(23) Così da ultimo App. Napoli 24 febbraio 2004, cit. Contra, nel senso che, in base all’art.
1 del r.d.l. n. 692/1923, eventuali superamenti dell’orario giornaliero contenuti nell’ambito
del massimo settimanale non erano sufficienti per far emergere la nozione legale di lavoro
straordinario, rimanendo la prestazione nei limiti di flessibilità previsti dalla legge cfr. Cass. 16
luglio 2002, n. 10312, in Orient. Giur. Lav., 2002, pag. 756.
(24) Cass. 7 agosto 2003, n. 11924; Cass. 2 settembre 2003, n. 12770; Cass. 16 gennaio
2001, n. 512, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 288; Cass. 5 gennaio 2001, n. 89, cit.; Cass. 4 dicembre 2000, n. 15419, in Lav. Giur., 2001, pag. 431, e in Orient. Giur. Lav., 2001, pag. 305; Cass. 3
ADL 1/2011
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
203
è più previsto un limite all’orario normale giornaliero e, quindi, non si pone
più un problema di coordinare tale limite con quello previsto per l’orario
normale settimanale; quest’ultimo limite, invece, anche nel vigente ordinamento sembra rimanere riferito alla “settimana di calendario”, considerato
che l’art. 3 del d.lgs. n. 66/2003, diversamente dall’art. 4 del medesimo decreto legislativo, riferisce il limite dell’orario normale alla settimana e non
ad un periodo di sette giorni (25).
Se poi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003 la contrattazione collettiva fissava un limite all’orario normale di lavoro inferiore a quello
predeterminato dalla legge, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza la stessa contrattazione collettiva poteva escludere la natura di
lavoro straordinario per la prestazione svolta oltre il limite contrattuale e
nei limiti di quello legale e disciplinarla in modo autonomo e diverso rispetto alla prestazione svolta oltre il limite legale (26): si parlava in tal caso
di straordinario contrattuale o lavoro supplementare proprio per evidenziarne la differente natura rispetto allo straordinario legale. Il d.lgs. n.
66/2003 sembra aver fatto proprio tale principio nel momento in cui all’art.
3, comma 2, ha previsto che, qualora i contratti collettivi stabiliscano una
durata dell’orario normale di lavoro in misura inferiore alle 40 ore settimanali, tale riduzione rilevi solo « a fini contrattuali ».
3. – Nonostante l’art. 5 del r.d.l. n. 692/1923 prevedesse il previo accordo tra le parti quale presupposto del lavoro straordinario, secondo la
Corte di Cassazione, l’esercizio del potere di richiederne lo svolgimento
doveva intendersi affidato alla discrezionalità del datore di lavoro, in ragione dei poteri direzionali di cui è titolare, e, rispetto all’esercizio di tale
dicembre 1985, n. 6057, in Not. Giur. Lav., 1986, pag. 551. Contra Cass., Sez. Un., 26 marzo
1982, n. 1889, in Riv. It. Dir. Lav., 1982, II, pag. 843.
(25) Di contrario avviso il Ministero del lavoro secondo il quale il riferimento della norma
alla settimana è idoneo a comprendere qualunque periodo temporale di sette giorni decorrente a partire da qualunque giorno (Circ. Min. lav. n. 8/2003).
(26) Cass. 26 settembre 2007, n. 20171; Cass. 16 luglio 2007, n. 15781, in Not. Giur. Lav.,
2007, pag. 647, e in Lav. Giur., 2008, pag. 192; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3475; Cass. 17 ottobre
2006, n. 22233, in Riv. It. Dir. Lav., 2007, II, pag. 355, con nota di M. Quaranta, Lo « straordinario contrattuale » nella giurisprudenza di legittimità; Cass. 13 luglio 2006, n. 15944; Cass. 17
marzo 2006, n. 5922, in Lav. Giur., 2006, pag. 914, e in Not. Giur. Lav., 2006, pag. 785; Cass. 1°
febbraio 2006, n. 2245; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2672; Cass. 24 marzo 2004, n. 5934, in Not.
Giur. Lav., 2004, pag. 659, e in Giust. Civ., 2005, I, pag. 458; Cass. 5 dicembre 2003, n. 18601,
in Not. Giur. Lav., 2004, pag. 474; Cass. 18 novembre 2003, n. 17575; Cass. 6 aprile 2002, n.
4953, in Foro. It., 2002, I, col. 2732; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2856, in Not. Giur. Lav., 2002,
pag. 476; Cass. 4 dicembre 2000, n. 15419, cit.; Cass. 8 agosto 2000, n. 10465, in Riv. It. Dir.
Lav., 2001, II, pag. 658, con nota di V.A. Poso, Ancora sulla nozione della retribuzione adeguata e
giusta ex art. 36 Cost.
ADL 1/2011
204
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
potere, il lavoratore, in conseguenza della sua condizione di subordinazione, si trovava in uno stato di soggezione: il suo rifiuto poteva, quindi,
considerarsi giustificato solo nel caso di comprovata arbitrarietà della richiesta del datore di lavoro, configurandosi altrimenti un inadempimento disciplinarmente rilevante (27). Dell’onere di provare in un eventuale
giudizio l’arbitrarietà della richiesta e, quindi, la giustificazione del rifiuto della prestazione, era, di regola, gravato il lavoratore, salvo fosse il datore di lavoro ad agire in giudizio per l’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare irrogata: in tal caso era, infatti, il datore di lavoro
a dover provare di aver esercitato il suo potere discrezionale secondo le
regole di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 Cod. Civ. (28). Nelle cause poi in cui il datore di lavoro si difendeva rispetto alla domanda di
pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario negando di
averne mai richiesto l’esecuzione la Corte di Cassazione affermava che la
richiesta poteva ritenersi implicita nella creazione delle condizioni che lo
avevano reso necessario e nella mancata contestazione del suo svolgimento, una volta venutone a conoscenza (29). Proprio in conseguenza del
fatto che lo svolgimento di lavoro straordinario presupponeva, quantomeno formalmente, il consenso delle parti, la giurisprudenza negava che
il lavoratore fosse titolare di un diritto e, pertanto, potesse, a fronte della
decisione del datore di lavoro di vietargli l’attività lavorativa straordinaria, agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno anche esistenziale (30).
A prescindere dalla conformità al dato normativo della configurazione
di un diritto potestativo del datore di lavoro di richiedere lo svolgimento di
lavoro straordinario, è probabile che la giurisprudenza confermi il descritto orientamento, considerato che l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003 riafferma il principio della consensualità del lavoro straordinario: rispetto alla previgente normativa è, tuttavia, ragionevole ipotizzare che uno dei criteri per valutare la conformità a correttezza e buona fede tanto della richiesta del datore di lavoro quanto del rifiuto del lavoratore venga individuato
nel principio, sancito dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 66/2003, secondo cui il
ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
(27) Cass. 21 febbraio 2007, n. 4011.
(28) Cass. 29 luglio 2009, n. 17644, in Orient. Giur. Lav., 2010, pag. 18, secondo cui, qualora le informazioni da parte del datore di lavoro siano state adeguate, prevalgono le esigenze
aziendali; Cass. 5 agosto 2003, n. 11821; Cass. 19 febbraio 1992, n. 2073.
(29) Cass. 20 febbraio 2009, n. 4269; Cass. 7 luglio 2006, n. 15499, in Lav. Giur., 2007, pag.
87, e in Not. Giur. Lav., 2006, pag. 789; App. Napoli 7 novembre 2006.
(30) App. Torino 29 settembre 2005, in Orient. Giur. Lav., 2005, pag. 548.
ADL 1/2011
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
205
4. – Nella maggior parte delle cause l’accertamento dello svolgimento
di lavoro straordinario è funzionale al riconoscimento del diritto del lavoratore al pagamento di eventuali differenze retributive. Va, innanzitutto,
premesso al riguardo che le questioni inerenti alla determinazione del compenso per il lavoro straordinario non si pongono esclusivamente nei casi in
cui la retribuzione sia corrisposta a tempo: l’art. 5 del r.d.l. n. 692/1923 prevedeva espressamente anche l’aumento sui cottimi nel caso di svolgimento
di lavoro straordinario. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno,
tuttavia, escluso che nei casi in cui i lavoratori siano retribuiti con il sistema
del cottimo misto e il loro ritmo produttivo rimanga entro il limite massimo
definito dalla legge e dalla contrattazione collettiva si possa affermare la
violazione dell’art. 36 Cost. per la sola circostanza che il compenso per il
cottimo non sia stato aumentato nel corso del tempo proporzionalmente al
compenso per il lavoro straordinario, valorizzando il fatto che nel cottimo
la retribuzione è determinata in vista del raggiungimento di un determinato risultato e non del tempo impiegato per conseguirlo (31).
Nella determinazione del compenso per lavoro straordinario legale rilevano due profili: la maggiorazione applicabile e la base di calcolo sulla
quale calcolare la maggiorazione.
Nel regime precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003 l’art. 5
del r.d.l. n. 692/1923 quantificava la maggiorazione per il lavoro straordinario in misura non inferiore alla 10% del corrispettivo per il lavoro ordinario. Per quanto, invece, concerneva l’individuazione della base di calcolo sulla quale applicare la maggiorazione legale, secondo il prevalente
orientamento della giurisprudenza, il giudice, in assenza di un principio
generale di onnicomprensività della retribuzione e pur in presenza di emolumenti aventi carattere di continuità e natura retributiva, avrebbe dovuto
prendere a riferimento i criteri previsti dalla contrattazione collettiva (32).
Proprio il fatto che la legge predeterminasse la maggiorazione dovuta per il
lavoro straordinario e che il contratto collettivo costituisse il parametro per
determinare la base di calcolo sulla quale calcolare tale maggiorazione
avrebbe dovuto precludere ai giudici il ricorso alla valutazione ex art. 432
Cod. Proc. Civ. per la quantificazione del compenso per il lavoro straordi-
(31) Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4813, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, II, pag. 894, con nota di M. Garattoni, Le Sezioni unite risolvono la questione dell’incidenza della retribuzione del lavoro straordinario sul c.d. cottimo misto dei ferrovieri, e in Mass. Giur. Lav., 2005, pag. 607, con
nota di N. De Marinis, L’equiparazione retributiva tra cottimo e straordinario. Il no delle Sezioni
Unite.
(32) Cass. 7 febbraio 2007, n. 2645, in Lav. Giur., 2007, pag. 102; Cass. 6 agosto 1998, n.
7745; Cass. 23 luglio 1998, n. 7251.
ADL 1/2011
206
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
nario (33): ricorre, invece, frequentemente nelle sentenze, anche della Corte di Cassazione, l’affermazione del principio secondo cui, nel momento in
cui il lavoratore riesce a provare le ore effettivamente svolte oltre l’orario normale e non remunerate, il suo diritto può dirsi certo (e non solo probabile) e,
quindi, il giudice può liquidare con valutazione equitativa ex art. 432 Cod.
Proc. Civ. l’ammontare della corrispondente retribuzione spettategli (34).
Maggiori questioni si ponevano per la determinazione del compenso
per lo straordinario cd. contrattuale. Secondo la prevalente giurisprudenza, la contrattazione collettiva, qualora avesse fissato un orario normale
massimo di lavoro inferiore alle 8 ore giornaliere o alle 48 ore settimanali,
avrebbe dovuto prevedere per lo straordinario contrattuale una retribuzione maggiore di quella prevista per il lavoro ordinario (35). Diversi erano, però, gli orientamenti della giurisprudenza sulla misura di tale maggiorazione. Secondo l’orientamento minoritario, essa avrebbe dovuto coincidere
con quella di cui al combinato disposto degli artt. 2108 Cod. Civ. e 5 del
r.d.l. n. 192/1923, salva la prova di un accordo fra datore di lavoro e lavoratore avente ad oggetto il prolungamento dell’orario normale contrattuale
fino al limite legale (36). Secondo l’orientamento maggioritario, invece, la
maggiorazione avrebbe anche potuto essere inferiore a quella prevista dalla legge per lo straordinario legale (37): in tal caso, infatti, non si sarebbe
configurata alcuna violazione né dell’art. 36 Cost., in quanto il diritto ad
una retribuzione proporzionata e sufficiente sancito da tale disposizione si
riferirebbe non ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale, comprensivo per lavoro straordinario (38), né dell’art. 5 del
(33) Cass. 21 aprile 1993, n. 4668.
(34) Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714, in Not. Giur. Lav., 2009, pag. 475; Cass. 14 agosto
1998, n. 8006; Cass. 1° settembre 1995, n. 9231; Cass. 21 aprile 1993, 4668; Cass. 13 febbraio
1992, n. 1801.
(35) Cass. 26 febbraio 2002, n. 2856, cit.; Cass. 2 dicembre 1991, n. 12913.
(36) Cass. 3 dicembre 2008, n. 28715, in Lav. Giur., 2009, pag. 412; Cass. 15 aprile 2002, n.
5380, in Arch. Civ., 2003, pag. 205; Cass. 30 maggio 1985, n. 3264.
(37) Cass. 26 settembre 2007, n. 20171; Cass. 16 luglio 2007, n. 15781, cit.; Cass. 15 febbraio
2007, n. 3475; Cass. 17 ottobre 2006, n. 22233, cit.; Cass. 13 luglio 2006, n. 15944; Cass. 17 marzo 2006, n. 5922, cit.; Cass. 1° febbraio 2006, n. 2245; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2672; Cass.
28 maggio 2004, n. 10350, in Orient. Giur. Lav., 2004, pag. 374; Cass. 24 marzo 2004, n. 5934,
cit.; Cass. 5 dicembre 2003, n. 18601, cit.; Cass. 18 novembre 2003, n. 17575; Cass. 6 aprile
2002, n. 4953, cit.; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2856, cit.; Cass. 4 dicembre 2000, n. 15419, cit.;
Cass. 8 agosto 2000, n. 10465, cit.
(38) Sulla base dell’interpretazione dell’art. 36 Cost. da ultimo riferita alcune sentenze riconoscono addirittura la legittimità di un compenso per lo straordinario contrattuale in misura inferiore al compenso per la prestazione ordinaria: cfr., ad esempio, Cass. 19 gennaio 2009,
n. 1173, in Lav. Giur., 2009, pag. 628; Cass. 24 marzo 2004, n. 5934, cit.; Cass. 14 marzo 2003
n. 3770.
ADL 1/2011
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
207
r.d.l. n. 692/1923 e dell’art. 2108 Cod. Civ., in quanto l’inderogabilità di tali
disposizioni avrebbe operato soltanto in presenza di violazione dei tetti
massimi di “orario normale” previsti da norme di legge. Diverse erano poi
le modalità attraverso le quali era possibile determinare il corrispettivo dello straordinario contrattuale in misura inferiore a quello dello straordinario
legale: ciò poteva avvenire sia direttamente, prevedendo una maggiorazione inferiore (39), sia indirettamente, incidendo sulla base di calcolo della
maggiorazione dello straordinario, ad esempio, assumendo come base di
calcolo sulla quale calcolare la maggiorazione la retribuzione ordinaria
mensile divisa per 30 anziché 26 giorni (40). In base al descritto orientamento, quindi, in caso di prestazione lavorativa non eccedente l’orario
massimo legale, il riconoscimento del diritto ad una retribuzione in misura
corrispondente a quella prevista per il lavoro straordinario legale presupponeva necessariamente una disposizione contrattuale, collettiva o individuale, che equiparasse la predetta prestazione allo straordinario legale (41).
La rilevanza delle descritte problematiche sembra ridimensionata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003, considerato che l’art. 5 di
tale decreto legislativo rimette ai contratti collettivi anche la determinazione delle maggiorazioni retributive per lo straordinario legale.
5. – Nonostante, come già osservato, non sia possibile riferire la disciplina legale dello straordinario a quelle attività per le quali il legislatore non
abbia previsto un orario normale di lavoro, la giurisprudenza riconosce anche ai lavoratori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme
di legge sull’orario normale di lavoro il diritto al compenso per lavoro
straordinario laddove la disciplina collettiva preveda anche per essi un orario normale di lavoro e tale orario venga in concreto superato oppure la
quantità delle ore svolte superi il limite della ragionevolezza, rendendo
particolarmente gravosa e usurante l’attività lavorativa svolta, con pregiudizio del diritto costituzionalmente protetto della salute e dell’integrità psicofisica: tale principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, in particolare, con riferimento al personale con funzioni direttive (42) o
(39) Cass. 9 febbraio 1994, n. 1292.
(40) Cass. 15 aprile 1997, n. 3212; Cass. 11 ottobre 1990, n. 9981, in Not. Giur. Lav., 2002,
pag. 476; Cass. 14 febbraio 1990, n. 1077.
(41) Cass. 9 gennaio 2002, n. 173, in Not. Giur. Lav., 2002, pag. 476.
(42) Cass. 13 febbraio 2006, n. 3056; Cass. 23 luglio 2004, n. 13882, in Not. Giur. Lav.,
2004, pag. 604 (funzionario); Cass. 21 agosto 2003, n. 12301, in Not. Giur. Lav., 2004, pag. 54
(dirigente); Cass. 22 agosto 2003, n. 12367 (impiegato direttivo); Cass. 7 agosto 2003, n.
11929, in Orient. Giur. Lav., 2003, pag. 552 (quadro); Cass. 16 giugno 2003, n. 9650, in Lav.
ADL 1/2011
208
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
addetto a mansioni discontinue (43).
Per quanto specificamente concerne il personale con funzioni direttive, la
giurisprudenza ha affermato che a tal fine è necessario considerare non tanto
l’elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l’elemento qualitativo relativo all’impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore (44) e
tener conto della flessibilità temporale richiesta agli appartenenti alla categoria e dell’eventuale funzionalizzazione dell’attività dei medesimi al raggiungimento di risultati predeterminati in totale autogestione (45). Solo eccezionalmente la Corte di Cassazione ha ritenuto che per un lavoratore con mansioni
direttive la presenza sul luogo di lavoro oltre l’orario normale fissato per gli
altri dipendenti costituisse, indipendentemente dallo svolgimento di attività
lavorativa, prestazione di per sé gravosa e usurante e, pertanto, fonte del diritto alla retribuzione per lavoro straordinario: all’affermazione di tale principio ha, però, probabilmente concorso in modo determinante la previsione
del contratto collettivo applicato secondo cui il personale direttivo avrebbe
dovuto “di massima” osservare l’orario degli altri lavoratori (46).
Analogamente, con riferimento alle mansioni discontinue la giurisprudenza ha evidenziato la variabilità, caso per caso, della loro onerosità, in relazione alla intensità ed alla natura della prestazione (47), specificando, però, che, essendo in tal caso la prestazione caratterizzata da attese non lavo-
Giur., 2004, pag. 77 (dirigente); Cass. 15 maggio 2003, n. 7577, in Not. Giur. Lav., 2003, 724
(dirigente); Cass. 10 febbraio 2000, n. 1491, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, pag. 680 (operaio intermedio); Cass. 14 ottobre 1999, n. 11616, in Not. Giur. Lav., 2000, pag. 121 (dirigente); Cass.
20 marzo 1997, n. 2476, in Not. Giur. Lav., 1997, pag. 301 (funzionario direttivo); Cass. 3 maggio 1990, n. 3680, in Not. Giur. Lav., 1990, pag. 743 (dirigente). Per la giurisprudenza di merito cfr. App. Napoli 7 novembre 2006; Trib. Napoli 14 febbraio 2006; Trib. Ivrea 8 febbraio
2006, in Lav. Giur., 2006, pag. 504; Trib. Siracusa 23 dicembre 2003, in Not. Giur. Lav., 2004,
pag. 467; Trib. Torino 13 giugno 2003, in Not. Giur. Lav., 2004, pag. 467; Trib. Terni 6 aprile
1999, in Not. Giur. Lav., 2000, pag. 58, con riferimento ad un caso in cui era lo stesso contratto
collettivo ad escludere il compenso per il lavoro prestato oltre l’orario normale.
(43) Cass. 8 gennaio 2009, n. 162 (mansioni di operatore di ripresa); Cass. 26 gennaio
2009, n. 1832, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, II, pag. 619, con nota di V. Pasquarella, Lavoro discontinuo e straordinario: tra diritto alla giusta retribuzione e contratti collettivi peggiorativi; Cass.
19 gennaio 2009, n. 1173, cit. (mansioni di operatore di ripresa); Cass. 3 febbraio 2000, n.
1202, cit. (autista delle Ferrovie dello Stato).
(44) Cass. 7 agosto 2003, n. 11929, cit.; Cass. 20 marzo 1997, n. 2476, cit.
(45) Trib. Pistoia 20 novembre 2004, in Not. Giur. Lav., 2005, pag. 101.
(46) Cass. 23 luglio 2004, n. 12882, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, II, pag. 260, con nota di O.
Mazzotta, Novità sul fronte del lavoro straordinario del personale direttivo?.
(47) Cfr., in particolare, Cass. 14 agosto 2008, n. 21695, in Not. Giur. Lav., 2009, pag. 412,
che ha considerato in contrasto con il principio di ragionevolezza la prestazione di un autista
di autotreni con un orario di 16 ore al giorno per 4 giorni alla settimana; Cass. 3 luglio 2003,
n. 10542, in Not. Giur. Lav., 2004, pag. 185 che ha considerato in contrasto con il principio di
ragionevolezza la prestazione di un operaio addetto alla distribuzione delle acque il cui ora-
ADL 1/2011
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
209
rate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le
energie psico-fisiche consumate, nell’accertare l’eventuale svolgimento di
lavoro straordinario è necessario considerare le modalità ed i tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da computare solo il tempo effettivamente impiegato nello svolgimento delle mansioni e non anche la durata delle
pause di inattività (48). Analogo principio è stato affermato anche con riferimento ai piazzisti, in considerazione del fatto che, svolgendo il loro lavoro al di fuori della sede aziendale, hanno ampia discrezionalità nella scelta
dei tempi e delle priorità nelle incombenze da svolgere, cosicché anche con
riferimento ad essi non è possibile applicare la presunzione di continuità
della prestazione per il periodo intermedio tra orario di lavoro iniziale e
orario finale (49). Ne consegue che con riferimento ai lavoratori adibiti a
mansioni discontinue, per i piazzisti e per le categorie di lavoratori ad essi
assimilabili assume particolare rilevanza la distinzione tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro e
la semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, in base alla diversa condizione in cui si trova il lavoratore: nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso anche qualora sia costretto a rimanere nella
sede di lavoro o a subire qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità (50).
rio giornaliero era di 12 ore e lavorava di giorno e di notte e con esposizione agli agenti atmosferici.
(48) Così Cass. 2 marzo 2009, n. 5023, cit.; Cass. 19 gennaio 2009, n. 1173, cit.; Cass. 8 gennaio 2009, n. 162; Cass. 9 giugno 2008, n. 15150, in Mass. Giur. Lav., 2009, pag. 90, con riferimento all’attività di maggiordomo o capo cameriere presso un palazzo principesco; Cass. 26
febbraio 2008, n. 5049, secondo cui dall’orario complessivo di un autotrasportatore andava
detratto il tempo della pausa pranzo, il tempo delle operazioni di carico e scarico della merce
e le pause di oltre 6.30 ore di sosta, in quanto, stante la loro considerevole durata, non potevano essere considerate periodi in cui l’autista era rimasto a disposizione; Cass. 20 aprile
2004, n. 7577, in Lav. Giur., 2004, pag. 1198; Cass. 5 novembre 2001, n. 13622, in Not. Giur.
Lav., 2002, pag. 53, secondo cui dall’orario complessivo di una cd. dama di compagnia andava detratto il tempo dalla medesima impiegato per svolgere i propri lavori di cucito; Cass. 3
febbraio 2000, n. 1202, cit.; Cass. 14 aprile 2000, n. 4886; Trib. Genova 4 marzo 2009, secondo cui nell’accertamento dell’orario di lavoro di un autotrasportatore andavano computate le
ore di guida, le ore di sosta a disposizione e le ore impiegate per le operazioni di carico e scarico in quanto l’autista è responsabile del mezzo. Analogo criterio di calcolo dell’orario di lavoro è stato applicato con riferimento ad autisti di autobetoniere in Trib. Bolzano 30 settembre 2009, pur qualificando questi ultimi non come lavoratori discontinui, ma come lavoratori
mobili e, quindi, soggetti alla disciplina generale in materia di orario di lavoro.
(49) Cass. 13 luglio 2004, n. 12913, in Orient. Giur. Lav., 2004, pag. 598.
(50) Cass. 2 marzo 2009, n. 5023, cit.
ADL 1/2011
210
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
La possibilità che il descritto orientamento giurisprudenziale possa essere confermato anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003 sembra supportata dal fatto che, come già in base all’art. 1, comma 2, e all’art. 3
del r.d.l. n. 692/1923, anche in base alla vigente disciplina risultano esclusi
dall’ambito di applicazione dei limiti all’orario normale di lavoro sia il personale direttivo (art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 66/2003) sia i lavoratori adibiti a mansioni discontinue (art. 16, lett. d, del d.lgs. n. 66/2003) sia i piazzisti (art. 16, lett. e, del d.lgs. n. 66/2003).
6. – La Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che, quando la
retribuzione deve essere presa a parametro per la quantificazione di altre
spettanze, il criterio della onnicomprensività, ovvero della inclusione in essa di ogni compenso corrisposto al lavoratore con caratteri di continuità e
obbligatorietà, non costituisce un principio generale dell’ordinamento, applicabile all’infuori delle ipotesi in cui ciò sia espressamente contemplato:
di conseguenza anche la retribuzione percepita per lo svolgimento di lavoro straordinario può rilevare ai fini della liquidazione degli istituti retributivi indiretti solo quando ciò sia espressamente previsto dalla legge o dal
contratto collettivo che li disciplina (51).
Per quel che concerne specificatamente il trattamento di fine rapporto,
in base all’art. 2120, comma 1, Cod. Civ., il compenso per lavoro straordinario può essere incluso nella base di calcolo di tale istituto solamente se il lavoro straordinario sia prestato in modo non occasionale. Il carattere della
non occasionalità viene interpretato dalla giurisprudenza valorizzando il
profilo causale dell’attribuzione, ovvero l’omogeneità del motivo o della ragione che l’hanno determinata rispetto al normale svolgimento del rapporto, piuttosto che la cadenza temporale dell’erogazione (52). I criteri di
quantificazione della retribuzione annua costituente la base di calcolo del
trattamento di fine rapporto fissati dall’art. 2120 Cod. Civ. possono, tuttavia, essere derogati anche in peius dalla contrattazione collettiva (53): deve
(51) Cass. 24 ottobre 2007, n. 22303, in Guida Dir., 2007, 49, pag. 60; Cass. 5 marzo 2007,
n. 5033; Cass. 2 settembre 2005, n. 17675; Cass. 5 aprile 2004, n. 6661; Cass. 25 giugno 2001,
n. 8628; Cass., Sez. Un., 4 aprile 1984, n. 2182, in Mass. Giur. Lav., 1984, pag. 157, e Cass., Sez.
Un., 4 aprile 1984, n. 2183, in Orient. Giur. Lav., 1984, pag. 792.
(52) Cass. 3 dicembre 2008, n. 28715, cit.; Trib. Napoli 11 novembre 2008, in Dir. Merc.
Lav., 2009, pag. 404, con nota di G. Tussino, L’incidenza del lavoro straordinario nella determinazione del calcolo del trattamento di fine rapporto tra vigente e pregressa normativa; App. Milano
29 ottobre 2008, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2009, I, pag. 226; Cass. 24 giugno 2008, n. 17145; Trib.
Milano 23 ottobre 2004, in Lav. Giur., 2005, pag. 491; Cass. 5 agosto 1996, n. 7177; Cass. 24
febbraio 1993, n. 2254, e Cass. 5 marzo 1993, n. 2714, in Giust. Civ., 1993, I, pag. 2077.
(53) Cass. 15 marzo 2010, n. 6204; Cass. 10 marzo 2009, n. 5707; Cass. 6 marzo 2009, n. 5569.
ADL 1/2011
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
211
trattarsi, però, di contratti collettivi stipulati successivamente all’entrata in
vigore della l. n. 297/1982, in quanto la reviviscenza di norme pettizie precedenti che disponessero in tal senso – nulle in base alla disciplina anteriore all’entrata in vigore della l. n. 297/1982 – potrebbe derivare solo da una
espressa manifestazione di volontà delle parti contraenti in tal senso (54). Si
segnala incidentalmente come sia oggetto di un contrasto giurisprudenziale l’ammissibilità della domanda di riliquidazione del trattamento di fine
rapporto qualora si sia formato il giudicato sull’inserimento nella base di
calcolo di alcune voci retributive e il lavoratore rivendichi l’inclusione di
voci differenti: proprio con riferimento a due distinti casi in cui il lavoratore con la seconda azione giudiziaria rivendicava il computo anche dei compensi per lavoro straordinario, la Corte di Cassazione ha ritenuto tale domanda dapprima ammissibile (55) e poi, a distanza di pochi mesi, inammissibile, per contrasto con il principio di correttezza e buona fede e con il
principio costituzionale del giusto processo (56).
Diverso, invece, era il discorso con riferimento all’indennità di anzianità, in quanto la retribuzione che ne costituiva la base di calcolo, ivi compresa quella per lavoro straordinario, doveva avere il carattere della continuità. La Corte di Cassazione ha precisato che la continuità del lavoro
straordinario non poteva fondarsi sull’accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l’orario normale ma doveva basarsi sul
carattere costante e sistematico di queste ultime, da individuarsi nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della
prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità,
transitorietà o saltuarietà della stessa (57). Le norme collettive poi che si discostavano da quanto previsto dall’art. 2120 Cod. Civ. in senso sfavorevole
al lavoratore erano considerate, in applicazione dei principi generali sul
(54) Cass. 13 gennaio 2010, n. 365, in Orient. Giur. Lav., 2010, pag. 172; Cass. 24 dicembre
1997, n. 17660, in Guida Dir., 2007, 42, pag. 79. Cfr., altresì, Trib. Cuneo 16 marzo 2000, in
Orient. Giur. Lav., 2000, pag. 434, secondo cui l’esclusione del compenso per lavoro straordinario dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto disposta dal CCNL metalmeccanici 5.7.1994 deve ritenersi applicabile anche alle quote del trattamento di fine rapporto maturate anteriormente all’entrata in vigore del suddetto contratto collettivo, qualora il rapporto di
lavoro sia cessato in vigenza dello stesso CCNL.
(55) Cass. 16 giugno 2008, n. 16206, in Dir. Giust., 2008.
(56) Cass. 3 dicembre 2008, n. 28719, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, II, pag. 711, con nota di L.
Ratti, Buona fede e giusto processo: presunti limiti alla frazionabilità della domanda giudiziale del
lavoratore.
(57) Cass. 18 febbraio 2008, n. 4014 in Not. Giur. Lav., 2008, pag. 600; Cass. 11 marzo
2005, n. 5362; Cass. 14 agosto 2004, n. 15889; Cass. 26 maggio 2004, n. 10172; Cass. 29 gennaio 2001, n. 1211; Cass. 14 giugno 1991, n. 6745, Cass. 5 agosto 1996, n. 7177; Trib. Napoli 11
novembre 2008, cit.
ADL 1/2011
212
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
rapporto tra legge e contratto collettivo, nulle per contrasto con norma imperativa e sostituite automaticamente ex art. 1419, comma 2, Cod. Civ. con
la norma violata (58).
Parzialmente diverso è, invece, sempre stato il discorso per la determinazione del compenso per ferie, festività infrasettimanali e tredicesima
mensilità: per questi istituti, in mancanza di una disciplina legislativa, è necessario di volta in volta fare riferimento alle modalità di calcolo previste
dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che lo straordinario sarà a tali
fini computato se e nei limiti in cui lo preveda la contrattazione collettiva,
salvo che, alla stregua di una corretta indagine di fatto riservata al giudice
di merito, non risulti una specifica volontà delle parti del rapporto individuale intesa ad ampliare l’orario normale di lavoro, conglobandovi lo
straordinario fisso e continuativo, e, quindi, a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria (59).
7. – Con riferimento al patto con cui le parti del rapporto di lavoro
quantificano il compenso del lavoratore in modo complessivo, conglobando in esso il corrispettivo per le prestazioni lavorative rese e ogni altro emolumento convenzionale o legale, come, ad esempio, il compenso per lavoro
straordinario (cd. patto di conglobamento), la giurisprudenza è costantemente orientata nel senso di considerare legittimo tale patto solo se da esso risultino gli specifici titoli cui è riferibile il compenso complessivo (60).
(58) Cass. 27 giugno 1996, n. 5934, in Giust. Civ., 1997, I, pag. 2254; Cass. 19 marzo 1994,
n. 2630; Cass. 16 aprile 1992, n. 4648; Cass. 19 giugno 1991, n. 6920.
(59) Trib. Milano 16 giugno 2009, in Lav. Giur., 2009, pag. 960; Trib. Milano 8 maggio
2009, in Lav. Giur., 2009, pag. 847; Trib. Milano 30 ottobre 2008, in Orient. Giur. Lav., 2008,
pag. 948; Trib. Cassino 14 ottobre 2008, in Lav. Giur., 2009, pag. 206; Cass. 24 ottobre 2007,
n. 22303, cit.; Cass. 5 aprile 2004, n. 6661, in Mass. Giur. Lav., 2004, pag. 544; Cass. 10 novembre 2003, n. 16852, in Mass. Giur. Lav., 2004, pag. 98; Cass. 29 luglio 2000, n. 9992, in Riv. It.
Dir. Lav., 2001, II, pag. 433; Cass. 14 gennaio 2000, n. 377, in Orient. Giur. Lav., 2000, pag. 437;
Cass. 9 dicembre 1999, n. 13780, in Orient. Giur. Lav., 2000, pag. 441; Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1984, n. 1075, in Orient. Giur. Lav., 1984, pag. 434, in Riv. It. Dir. Lav., 1984, II, pag. 431,
in Foro It., 1984, I, col. 679, in Mass. Giur. Lav., 1984, 8, e in Riv. Giur. Lav., 1984, II, pag. 44.
(60) Cass. 7 aprile 2010, n. 8255, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2010, pag. 540, con nota di A. Premoli, Il « patto di conglobamento »: requisiti di validità e onere della prova; Cass. 12 novembre
2008, n. 27027, in Not. Giur. Lav., 2009, pag. 49, e in Lav. Giur., 2009, pag. 299, con riferimento ad un’ipotesi di conglobamento dello straordinario nel cd. superminimo; Cass. 19 novembre 2007, n. 23911, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2008, II, pag. 610; Trib. Ivrea 8 febbraio 2006; Trib.
Bolzano 9 agosto 2004, cit., secondo cui il patto di conglobamento in base al quale il lavoratore viene retribuito in base al numero e alla destinazione dei viaggi effettuati sarebbe, comunque, illegittimo per violazione dell’art. 10 Regolamento CEE n. 3820/85; Cass. 4 giugno 2002,
n. 8097, in Orient. Giur. Lav., 2002, pag. 214. Contra, nel senso di ammettere che, pur in assenza di un patto di conglobamento, sia possibile ravvisare la volontà delle parti di compensare
ADL 1/2011
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
213
Solo attraverso la specificazione dei titoli sarebbe, infatti, possibile superare la presunzione che il compenso stabilito è dovuto quale corrispettivo
della sola prestazione ordinaria e verificare, con una valutazione necessariamente effettuabile solo ex post, l’effettivo riconoscimento al lavoratore di
un trattamento non inferiore rispetto a quello dovutogli per legge o per
contratto collettivo. L’omessa specificazione dei titoli assume, tra l’altro, rilevanza anche sotto il profilo contributivo: grava, infatti, sul datore di lavoro, debitore dell’obbligazione contributiva, l’onere di dimostrare che l’eventuale importo erogato al lavoratore a titolo di indennità varie costituisce
l’adempimento di un determinato istituto retributivo (61).
Per quanto specificamente concerne il conglobamento della retribuzione per il lavoro straordinario, l’orientamento giurisprudenziale descritto trova un immediato riscontro anche nell’attuale disciplina sull’orario di
lavoro: l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 66/2003 pone, infatti, in capo al datore di lavoro l’obbligo di computare in modo separato e distinto il lavoro ordinario e il lavoro straordinario.
Parzialmente diverso è il discorso per la clausola di forfetizzazione dello straordinario, clausola con cui le parti del rapporto di lavoro prevedono
un compenso fisso e determinato a forfait per il lavoro straordinario, indipendentemente dall’effettivo svolgimento. Tale patto, solitamente stipulato
quando, per le modalità di svolgimento del lavoro, è difficile contenere la
prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e/o il datore di lavoro ha
difficoltà a controllare l’orario effettivamente osservato dal dipendente, è
considerato valido solo qualora il compenso pattuito rappresenti il minimo
garantito e non il massimo, cosicché il lavoratore che abbia effettuato un
numero di ore di lavoro straordinario superiore a quello corrispondente alla forfetizzazione conserva il diritto al riconoscimento dell’eventuale trattamento differenziale (62). Il compenso per lavoro straordinario forfetizzato
non può, comunque, considerarsi quale normale retribuzione in virtù della
continuità dell’erogazione e della mancata verifica da parte del datore di lavoro sull’effettivo espletamento di lavoro straordinario, con la conseguenza che esso non è coperto dalla garanzia di irriducibilità della retribuzione
e può essere unilateralmente escluso dal datore in conseguenza di una di-
anche il lavoro straordinario con la retribuzione corrisposta al lavoratore in misura notevolmente superiore a quella prevista dal c.c.n.l. di settore, cfr. Trib. Vicenza 13 gennaio 2003, in
Rass. Giur. Lav. Veneto, 2003, pag. 84.
(61) Trib. Genova 29 agosto 2006.
(62) Cass. 18 agosto 2004, n. 16157; Cass. 26 maggio 2000, n. 6902, in Orient. Giur. Lav.,
2000, pag. 448; Trib. Torino 22 ottobre 1997, in Lav. Giur., 1998, pag. 331 e in Giur. Piem., 1998,
pag. 58; Cass. 24 giugno 1986, n. 4209, in Giur. It., 1986, II, pag. 1668.
ADL 1/2011
214
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
versa organizzazione del lavoro che comporti la verifica delle prestazioni
straordinarie effettivamente rese dal lavoratore e del pagamento delle stesse (63). Tale conclusione è, del resto, coerente con il principio per cui non si
configura una lesione della garanzia retributiva prevista dall’art. 2103 Cod.
Civ. neppure quando la diminuzione della retribuzione a seguito dell’adibizione alle nuove mansioni consegua al fatto che lo svolgimento di queste
ultime non implichi più lavoro straordinario fisso o continuativo (64).
8. – La giurisprudenza sia di legittimità (65) che di merito (66) è unanime nel riconoscere che i crediti del lavoratore subordinato per prestazioni
di lavoro straordinario siano assoggettate alla prescrizione quinquennale
di cui all’art. 2948, n. 4, Cod. Civ. in considerazione della loro accessorietà
rispetto al credito periodico alla retribuzione, la quale per i lavoratori subordinati viene di regola pagata a scadenze fisse, e senza che in senso contrario possa assumere rilevanza la circostanza che il lavoro straordinario sia
prestato occasionalmente, ossia senza il carattere della periodicità richiesto
dall’art. 2948. Resta, tuttavia, fermo che la retribuzione per prestazioni di
lavoro straordinario concorre a determinare la base di calcolo del trattamento di fine rapporto anche quando il relativo diritto sia ormai prescritto:
in tal caso, infatti, le retribuzioni rilevano non come componenti del trattamento di fine rapporto, ma solo come base di computo del medesimo e,
poiché il diritto al trattamento di fine rapporto sorge in capo al lavoratore
alla cessazione del rapporto di lavoro, solo da questa data decorre il termine di prescrizione dello stesso (67).
9. – È pacifico che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso
per il lavoro straordinario legale o contrattuale abbia, secondo il disposto
dell’art. 2697 Cod. Civ., l’onere di dimostrare la sussistenza di eventuali li(63) Trib. Milano 2 maggio 2003, in Lav. Giur., 2003, pag. 1177.
(64) Cass. 18 novembre 1997, n. 11460, in Not. Giur. Lav., 1997, pag. 837, e in Riv. Dir. Lav.,
1998, II, pag. 259, con nota di Conte, La nozione di retribuzione riducibile a norma dell’art. 2103
c.c.; Cass. 16 febbraio 1989, n. 924; Cass. 12 febbraio 1985, n. 1189, in Riv. It. Dir. Lav., 1985, II,
pag. 196.
(65) Cass. 20 gennaio 2010, n. 947, in Not. Giur. Lav., 2010, pag. 164; Cass. 10 novembre
2004, n. 21377, in Mass. Giur. Lav., 2005, pag. 201, con nota di L. Perina, Sul potere ufficioso del
giudice di applicare una prescrizione di durata diversa da quella indicata dalla parte; Cass. 2 febbraio 2004, n. 1837, in Arch. Civ., 2004, pag. 1460; Cass. 28 aprile 2003, n. 6607, in Arch. Civ.,
2004, pag. 266; Cass. 3 gennaio 2001, n. 39, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 347; Cass. 18 gennaio
1999, n. 431.
(66) Trib. Monza 20 gennaio 2009; App. Bologna 26 maggio 2008, in Lav. Giur., 2008,
pag. 1170.
(67) Cass. 10 ottobre 2007, n. 21239, in Lav. Giur., 2008, pag. 309.
ADL 1/2011
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
215
mitazioni dell’orario di lavoro introdotte dalla contrattazione collettiva e
da un patto individuale, di aver espletato l’orario normale di lavoro, legale
o contrattuale, e quindi di aver proseguito oltre il suddetto orario, senza
che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo
per il fatto che manchino contestazioni sull’orario di inizio del lavoro e senza che l’assenza di tale prova possa essere supplita da una valutazione equitativa del giudice ex art. 432, atteso che tale norma riguarda la valutazione
del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza
(68). Il giudice può, tuttavia, legittimamente valutare gli elementi di prova
raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in
termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all’orario normale (69): talune pronunce ammettono eccezionalmente la possibilità di procedere anche in via
equitativa ai sensi dell’art. 432 Cod. Proc. Civ. nei casi in cui sia stata fornita la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa per un orario superiore a quello retribuito, ma perduri l’incertezza sulla misura del lavoro
ulteriore rispetto a quello minimale quantificato (70). Anzi, la stessa Corte
di Cassazione riconosce che, soprattutto quando l’arco di tempo da valutare è notevolmente ampio e/o la natura della prestazione rende particolarmente difficoltoso l’accertamento delle ore lavorate, è sufficiente che il giudice di merito ricostruisca in via presuntiva ed indiziaria l’orario di lavoro,
non essendo pensabile che il lavoratore possa essere gravato dell’onere di
provare ciascuna ora di straordinario (71). Molto rare e soprattutto di merito sono, invece, le pronunce che aderiscono ad una interpretazione molto
più rigida, affermando che la prova del lavoro straordinario svolto deve essere specifica ed avere ad oggetto ogni giornata per la quale si rivendicano
differenze retributive (72). Analogo rigore la Corte di Cassazione dimostra
nei casi in cui lo stesso lavoratore nello stesso periodo abbia svolto in favo(68) Trib. Savona 23 febbraio 2009; Trib. Pavia 17 febbraio 2009; Trib. Monza 27 gennaio
2009; App. Potenza 9 luglio 2008; Trib. Napoli 10 gennaio 2007; Cass. 25 giugno 2006, n.
12434, in Lav. Giur., 2006, pag. 1223; Cass. 14 marzo 2006, n. 5496, cit.; Cass. 13 febbraio
2006, n. 3056; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389, in Dir. Prat. Lav., 2003, pag. 1281, e in Dir. Giust.,
2003, pag. 98; Cass. 20 giugno 2002, n. 9006, in Lav. Giur., 2002, pag. 1102; Cass. 17 ottobre
2001, n. 12695, in Not. Giur. Lav., 2002, pag. 476, in Dir. Prat. Lav., 2002, pag. 864, e in Orient.
Giur. Lav., 2002, pag. 103.
(69) Cass. 12 maggio 2001, n. 6623, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 690; Cass. 29 gennaio
2003, n. 1389, cit.
(70) Cass. 31 gennaio 2007, n. 2195; Cass. 20 dicembre 2001, n. 16098; Trib. Ivrea 8 febbraio 2006.
(71) Cass. 26 febbraio 2008, n. 5049; Cass. 25 maggio 2006, n. 12434, cit.
(72) Trib. Monza 15 gennaio 2009; Cass. 22 dicembre 1999, n. 14466, in Not. Giur. Lav.,
2000, pag. 341.
ADL 1/2011
216
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
re di un unico soggetto prestazioni fra loro disomogenee, onerando il lavoratore della prova delle percentuali di tempo dedicato all’una piuttosto che
all’altra attività (73).
Una categoria di lavoratori con riferimento ai quali nell’accertamento
del lavoro straordinario svolto è particolarmente importante la prova presuntiva è quella degli autotrasportatori. In tema di accertamento del lavoro
prestato e, quindi, dello straordinario eventualmente svolto da tali lavoratori, la giurisprudenza è, infatti, unanime nel riconoscere che i dischi cronotachigrafi in originale o in copia fotostatica, ove da controparte ne sia
disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non
possono da soli fornire la piena prova, stante la preclusione sancita dall’art.
2712 Cod. Civ., dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario e
dell’effettiva entità degli stessi, occorrendo, a tal fine, che la presunzione
semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro
nell’esercizio dei propri poteri istruttori (74).
I descritti principi in tema di onere della prova trovano applicazione
anche nell’ipotesi in cui il lavoratore riconosca di aver ricevuto un compenso per il lavoro straordinario svolto, ma ne deduca l’insufficienza rispetto alle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte: in tal caso, infatti, egli è tenuto a provare la quantità di lavoro svolto e non remunerato,
mentre sul datore di lavoro incombe l’onere di dimostrare di aver corrisposto una retribuzione sufficiente ed adeguata alla qualità e quantità del
lavoro prestato (75).
10. – È molto raro rinvenire pronunce della Corte di Cassazione sulle
sanzioni amministrative connesse alla violazione della disciplina sul lavoro
straordinario. Si segnala al riguardo una sentenza relativamente recente
(73) Cass. 25 maggio 2006, n. 12434, cit., con riferimento ad una fattispecie in cui il lavoratore svolgeva attività di lavoro subordinato e attività di natura politico-sindacale.
(74) Trib. Genova 4 marzo 2009; Trib. Rieti 2 dicembre 2008; App. Milano 12 marzo 2007,
in Lav. Giur., 2007, pag. 1260; Cass. 20 dicembre 2001, n. 16098; Cass. 8 luglio 1994, n. 6437,
in Orient. Giur. Lav., 1994, pag. 827, in Riv. It. Dir. Lav., 1995, II, pag. 447, con nota di A. Vallebona, Prova del lavoro straordinario e dischi cronotachigrafi, e in Mass. Giur. Lav., 1994, pag. 524;
Trib. Bolzano 9 agosto 2004, cit., che impropriamente riconosce alle copie dei dischi cronotachigrafi, disconosciuti dal datore di lavoro, il valore di “piena prova” se supportate da ulteriori elementi, anche di carattere indiziario e presuntivo.
(75) Trib. Ariano Irpino 14 ottobre 2008, in Lav. Giur., 2009, pag. 206; Cass. 16 febbraio
2009, n. 3714, cit.; Cass. 9 febbraio 2009, n. 3194; Trib. Milano 12 agosto 2003, in Lav. Giur.,
2004, pag. 87; Cass. 17 ottobre 2001, n. 12695, cit.; Cass. 1° settembre 1995, n. 9231; Cass. 21
gennaio 1993, n. 739.
ADL 1/2011
PARTE TERZA . RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
217
sulle modalità di calcolo della sanzione prevista dall’art. 9, seconda parte,
del r.d.l. n. 692/1923 per la violazione dell’art. 5-bis del medesimo regio
decreto legge ovvero per l’omessa comunicazione, entro il termine delle 24
ore, alla Direzione Provinciale del Lavoro del ripetuto superamento del limite settimanale fissato per le ore di straordinario (76). La rilevanza del
principio in tale sentenza affermato – qualora l’infrazione si riferisca a più
di 5 lavoratori e/o a più di 50 giorni in un anno, si configura un unico illecito cui deve applicarsi un’unica sanzione – è apprezzabile non tanto in relazione alla disciplina normativa cui la stessa si riferisce (art. 9, seconda
parte, del r.d.l. n. 692/1923, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del
d.lgs. n. 213/2004) quanto per l’interpretazione delle vigenti norme sanzionatorie che adottano analogo criterio per la quantificazione della sanzione irrogabile, quale, ad esempio, quella prevista dall’art. 18bis, comma 6,
del d.lgs. n. 66/2003 per la violazione dell’art. 5, comma 3 e comma 5, del
medesimo decreto legislativo (ma l’applicazione dello stesso principio potrebbe essere estesa, mutatis mutandis, anche alle norme introdotte dall’art.
7 della l. n. 183/2010 per sanzionare la violazione dell’art. 4, comma 2, dell’art. 7, comma 1, dell’art. 9, comma 1, e dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n.
66/2003).
(76) Cass. 7 giugno 2005, n. 11775, in Orient. Giur. Lav., 2005, pag. 293.
ADL 1/2011
ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO
Condizioni di abbonamento
L’abbonamento decorre dal 1o gennaio e scade il 31 dicembre successivo. In
ipotesi il cliente sottoscriva l’abbonamento nel corso dell’anno la scadenza è
comunque stabilita al 31 dicembre del medesimo anno: in tal caso l’abbonato
sarà tenuto al pagamento dell’intera annata ed avrà diritto di ricevere gli arretrati editi nell’anno prima dell’inizio dell’abbonamento.
L’abbonamento si intenderà tacitamente rinnovato per l’anno successivo in
assenza di disdetta da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza
del 31 dicembre, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a.r.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro e non
oltre un mese dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine
saranno spediti contro rimessa dell’importo.
Abbonamento per il 2011: Italia r 164,00; Estero r 193,00
Il pagamento potrà essere effettuato tramite gli incaricati della Casa Editrice sottoscrivendo l’apposita ricevuta intestata a WKI Srl – Cedam, oppure con un versamento intestato a WKI Srl – Cedam – Viale dell’Industria 60 – 35129 Padova – utilizzando le
seguenti modalità:
– Conto corrente postale 205351;
– Bonifico Cassa di Risparmio del Veneto Agenzia - Padova - via Valeri - CIN C • ABI
06225 CAB 12163 • c/c 047084250184 • IBAN IT 30 C 06225 12163 047084250184;
– Carta di credito Visa, Master Card, Carta Sì, American Card, American Express, Diners Club, Eurocard specificando il numero e la data di scadenza.
Egregio abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono
registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in
Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono
trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi
dell’art. 130, comma 4, del D.lgs. n. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto della presente vendita.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, fra cui il
diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di
legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY
– Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax
al numero: 02.82476.403.
QUADERNI DI ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO
Ordinati da Mattia Persiani e Franco Carinci
1. Rappresentanze e contributi sindacali dopo i referendum. A cura di Arturo Maresca, Giuseppe Santoro Passarelli e Lorenzo Zoppoli
(1996).
2. Nuove forme di retribuzione e attualità dei principi costituzionali. Atti dell’incontro di studio, Roma 3 febbraio 1997 (1998).
3. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione: una riflessione venticinque anni dopo. Atti dell’incontro di studio, Roma 28 gennaio
1999 (1999).
4. Parlamento e concertazione. Atti dell’incontro di studio, Roma 18
febbraio 1999 (1999).
5. Problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricerche, giurisprudenza, e prospettive di riforma. AA.VV. (2003).
6. Previdenza complementare: esperienze e prospettive. Giancarlo
Falcucci (2004).
7. Diritto del lavoro e riforme universitarie. Stati giuridici, carriere
dei docenti ed ordinamenti didattici. AA.VV. (2007).
8. Lavoro autonomo e riforma delle professioni. A cura di Sandro
Mainardi e Andrea Carinci (2008).
9. Tecnica e politica delle citazioni. AA.VV. (2009).
00117565
ISBN 978-88-13-30640-3
10. Percorsi di ricerca e di carriera: i convegni, i concorsi e le conferme. AA.VV. (2011).
& 37,00