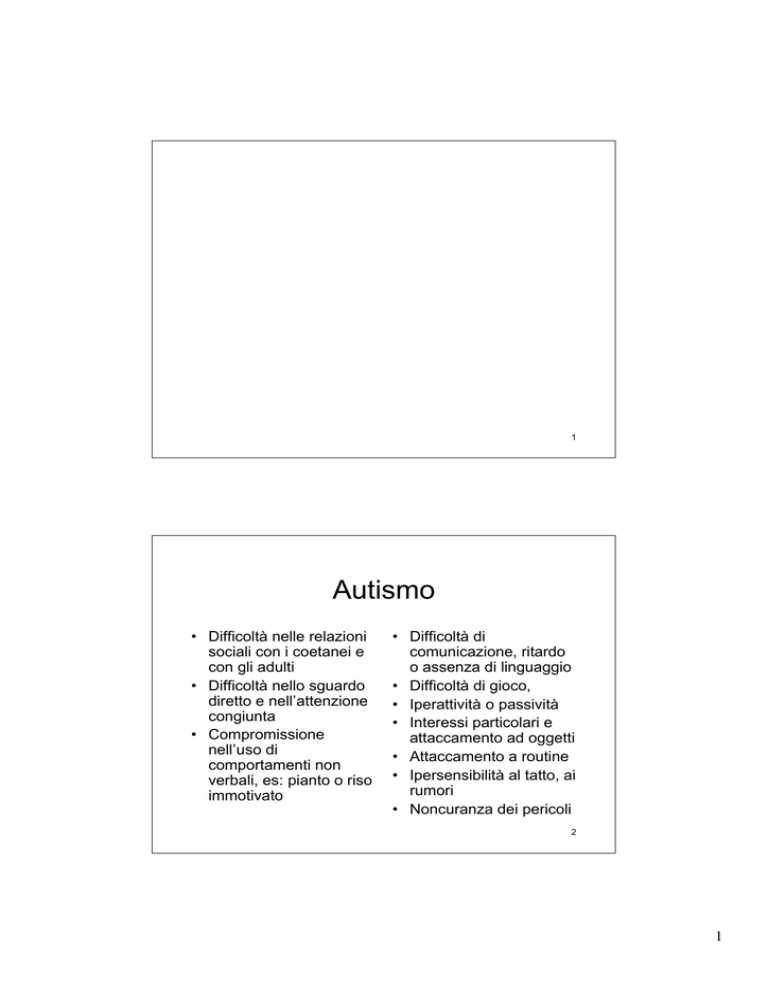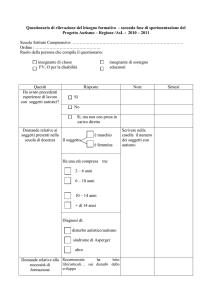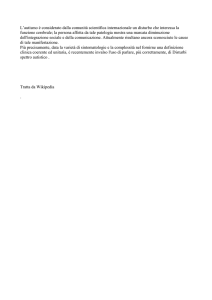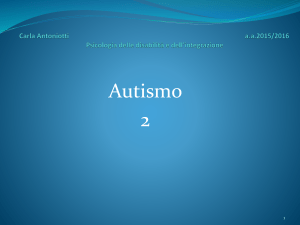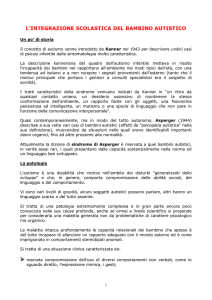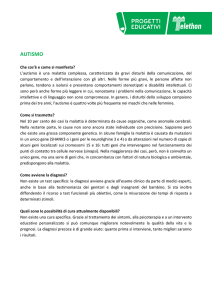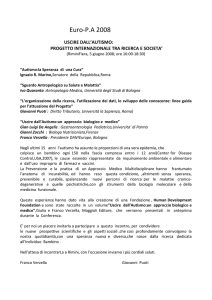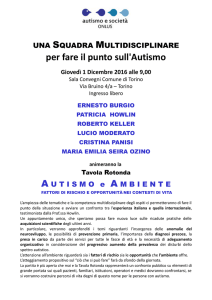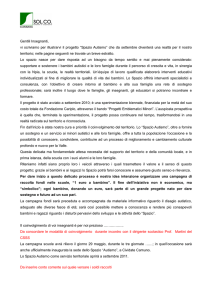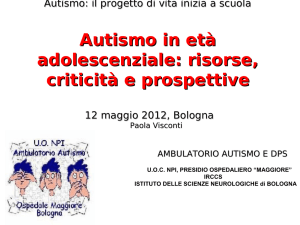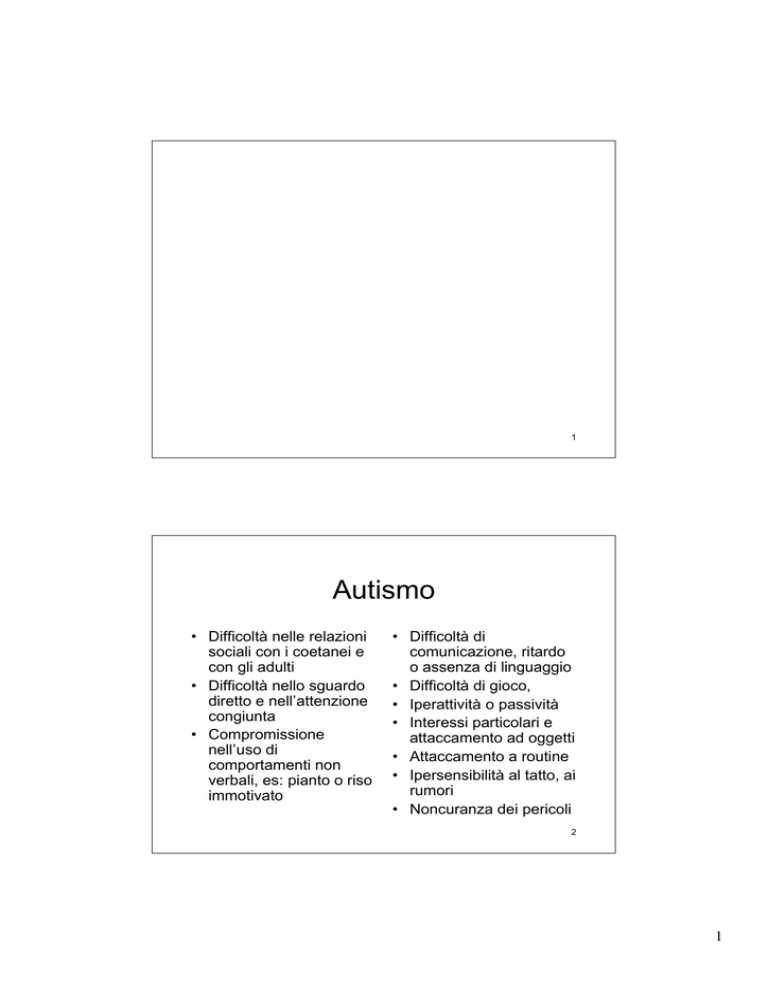
1
Autismo
• Difficoltà nelle relazioni
sociali con i coetanei e
con gli adulti
• Difficoltà nello sguardo
diretto e nell’attenzione
congiunta
• Compromissione
nell’uso di
comportamenti non
verbali, es: pianto o riso
immotivato
• Difficoltà di
comunicazione, ritardo
o assenza di linguaggio
• Difficoltà di gioco,
• Iperattività o passività
• Interessi particolari e
attaccamento ad oggetti
• Attaccamento a routine
• Ipersensibilità al tatto, ai
rumori
• Noncuranza dei pericoli
2
1
L’ipotesi percettiva
Un altro modo di
“vedere”!
Urville by Gilles Trehin
3
… Il mio modo di essere era completamente incomprensibile agli
occhi di chi mi circondava. Toccavo continuamente ogni cosa;
tastavo con le dita gli incavi delle bottiglie, i braccioli del divano
e le maniglie delle porte, strofinavo il palmo della mano sui
corrimano curvi. Sentivo la necessità di toccare tutte queste
cose perché avevo bisogno delle loro curve e rotondità ma
nessuno, intorno a me, immaginava che fosse questo tipo di
bisogno a provocare in me quel comportamento. Per loro
dimostravo unicamente di essere strana e a volte irritante, ma
io non pensavo affatto di essere né strana né irritante. Sapevo
solo che ciò che facevo era una necessità, per me,
d’importanza vitale. Però, agli occhi degli altri, tutto questo non
meritava alcun rispetto.
(Gunilla Gerland, Una persona vera – Phoenix: Roma).
4
2
Domini che contribuiscono a formare il
fenotipo comportamentale
Linguistic
o
Sociale
Comportament
ale
Emozionale
Motorio
Cognitivo
Neuropsicologia
dell’autismo
1. Teoria della mente;
2. Riconoscimento delle emozioni e delle
espressioni facciali;
3. Teoria della coerenza centrale;
4. Funzioni di programmazione e di controllo;
5. Disturbi del linguaggio e della funzione
mnesica;
6
3
1. Teoria della mente
Per teoria della mente si intende la
consapevolezza della propria attività
pensante e della attività pensante altrui,
consapevolezza da cui dipende la
comprensione del comportamento
umano.
7
Teoria della mente
Capacità di riflettere sulle emozini , sui desideri e sulle
credenze proprie e altrui e di comprendere il
comportamento degli altri in rapporto non solo a quello che
ciascuno di noi sente, desidera o conosce, ma in rapporto a
quello che ciascuno di noi pensa che l'altro sente, desidera
e conosce
(Baron-Cohen, 2000)
Il bambino autistico sarebbe incapace di comprendere e
riflettere sugli stati mentali propri e altrui e,
conseguentemente, di comprendere e prevedere il
comportamento degli altri
4
Esiste una relazione causale tra
il gioco di finzione e lo sviluppo
della teoria della mente (A.
Leslie, 1987).
Il gioco di finzione sottintende
un livello cognitivo elevato e si
va delineando dai 2 anni in poi.
9
Al mancato sviluppo delle
capacità di teoria della mente
sarebbero dovuti il deficit
sociale e comunicativo
evidenziato nell’autismo.
10
5
Compiti di teoria della mente
di primo livello.
1. Sally e Anne
2. Compito degli smarties
11
2. Riconoscimento delle emozioni
e delle espressioni facciali
I bambini con autismo appaiono in difficoltà
già nel riconoscimento di espressioni
fondamentali quali gioia, tristezza, paura e
rabbia. Le difficoltà aumentano nel
riconoscimento di emozioni complesse
quali la sorpresa.
12
6
3. La teoria della coerenza
centrale
I bambini autistici presentano
difficoltà nell’integrare informazioni
a differenti livelli e le informazioni
vengono processate in modo
frammentario e con attenzione ai
particolari.
13
Coerenza centrale
Capacità di sistematizzare in un sistema coerente le
molteplici esperienze parcellari che investono i
nostri sensi, di cogliere lo stimolo nel suo
cmplesso, di accedere dal particolare al generale
(Frith e Happé,1994)
●
●
●
●
Il bambino autistico presenta
un'incapacità di cogliere lo stimolo nel suo
complesso
un'elaborazione segmentata dell'esperienza
una difficoltà di accedere dal particolare al
generale
una polarizzazione su frammenti dell'esperienza
7
Alla WISC-R:
“disegno con cubi” +++++
“comprensione” e
“ordinamento di figure” -----(norme di buon senso e di
logicità).
15
I comportamenti ripetitivi
potrebbero essere interpretati
come frammenti di azioni più
complesse che vengono
decontestualizzate e ripetute
senza possibilità di inibirle.
16
8
Il deficit di coerenza centrale
spiegherebbe i comportamenti
ripetitivi e le isole di abilità.
17
Funzioni esecutive
Si intende una serie di abilità che sono determinanti
nell'organizzazione e nella pianificazione dei
comportamenti per la risoluzione dei problemi:
Working memory
Flessibilità cognitiva
Controllo inibitorio
Pianificazione
Molti dei comportamenti autistici sarebbero l'espressione
di un deficit di tali attività
9
4. Funzioni di programmazione e di
controllo
I bambini autistici presentano un
deficit di funzioni esecutive ossia,
non sono in grado utilizzare e
mantenere delle corrette procedure
di problem solving per il
raggiungimento di uno scopo.
19
Le funzioni esecutive
riguardano:
1. Capacità di inibire una risposta
o posticiparla;
2. Abilità di pianificare una
sequenza di azioni;
20
10
3. Capacità di rappresentarsi
un compito;
4. Selezionare le informazioni
rilevanti da tenere in memoria;
5. Attenzione flessibile.
21
Comportamento ripetitivo:
1. deficit di inibizione;
2. scarsa flessibilità.
22
11
Ipotesi di malfunzionamento
delle aree prefrontali
•
•
•
•
•
•
Mancate strategia di problem-solving;
Deficit nelle capacità astrattive;
Stereotipie, ostinazione nella monotonia;
Ristretta gamma di interessi;
Attaccamento ad oggetti insoliti;
Interesse per aspetti non funzionali degli
oggetti (odore, tatto, etc.)
23
Teoria socio-affettiva
Parte dal presupposto che l'essere umano nasce con
un a predisposizione innata a interagire con l'altro.
Viene definito anche “empatia non inferenziale e
intersoggettività primaria”
Secondo tale teoria, già nel neonato ci sarebbe una
innata predilezione per gli stimoli di natura sociale
(Hobson,1993)
Nell'autismo ci sarebbe una innata incapacità,
biologicamente
determinata,
di
interagire
emozionalmente con l'altro
12
5. Disturbi del linguaggio e
della funzione mnesica
Sintassi spesso conservata.
Invece:
1. Ecolalia immediata e differita;
2. Deficit di comprensione (ci si affida
alla sintassi anziché alla semantica);
3. Deficit di pragmatica e prosodia;
25
4. Carenza dell’uso di linguaggio
socialmente utile (avvio di
conversazione, turnazione, etc.);
5. Deficit nel richiedere e condividere
informazioni;
6. Deficit nella memoria uditiva, buona
la memoria procedurale.
26
13
6. Disturbo della eccitazione e
della reattività
I tracciati EEG di b. autistici
evidenziano una condizione di
ipereccitabilità (omeostasi
inibizione-eccitazione a livello
della sostanza reticolare)
27
diversi profili clinici
1. Prevalenza di ipereccitabilità;
2. Prevalenza di ritiro ed apatia, quale
meccanismo di difesa ad una
condizione di eccessiva stimolazione;
3. Persistenza e rapida mutabilità di
entrambe le situazioni (profilo più
frequente)
28
14
Teoria socio-affettiva
Parte dal presupposto che l'essere umano nasce con
un a predisposizione innata a interagire con l'altro.
Viene definito anche “empatia non inferenziale e
intersoggettività primaria”
Secondo tale teoria, già nel neonato ci sarebbe una
innata predilezione per gli stimoli di natura sociale
(Hobson,1993)
Nell'autismo ci sarebbe una innata incapacità,
biologicamente
determinata,
di
interagire
emozionalmente con l'altro
Anomalie Neurologiche
• Anomalie Funzionali
• Anomalie Anatomiche
15
Anomalie Funzionali
Il Sistema Nervoso Centrale dei soggetti
con DGS processa le informazioni
attivando circuiti neuronali distinti
rispetto a quelli impiegati da soggetti
con sviluppo tipico, particolarmente per
stimoli socialmente rilevanti
16
17
Double-click to add graphics
Anomalie neuroanatomiche
• Riduzione della circonferenza cranica alla
nascita con improvviso ed eccessivo
accrescimento tra i 2-3 ed i 6-14 mesi di
vita
• Incremento volumetrico della sostanza
bianca con decremento delle strutture
corticali
– lobo frontale
– cervelletto
– strutture limbiche
– amigdala
– ippocampo
18
Alterazioni neuroanatomiche
cerebrali microscopiche
• Corteccia cerebrale
–
–
–
–
riduzione densità neuronale
riduzione volume microcolonne corticali
Neuroni ectopici
Disorganizzazione neuronale
• Corteccia cerebellare
– Riduzione numero cell del Purkinje
– riduzione numerica cell granulari
• Nuclei cerebellari
– Displasia del nucleo dentato
– Sostanza grigia ectopica sottocorticale
– Alterazioni volumetrica delle cellule
Alterazioni neuroanatomiche
cerebrali microscopiche
• Nucleo olivare inferiore
– Alterazioni volumetriche cell
– Displasia olivare
• Ippocampo
– Aumento densità cellulare
– Riduzione volume cell
– Riduzione arborizzazioni dendridiche
• Amigdala
– Aumento densità cellulare
– Riduzione volume cell
19
Etiopatogenesi
●
Fattori genetici
Concordanza del 60% in gemelli monozigoti contro
lo 0% in gemelli dizigoti
Concordanza sale al 92% in gemelli omozigoti Se
si includono i disturbi della comunicazione ed i
disturbi dell'interazione sociale la concordanza
sale al 92% in gemelli omozigoti e al 10% in
dizigoti o fratelli
Disturbo legato al cromosoma X (modello di
ereditarietà)
Ereditarietà di tipo multigenico
Etiopatogenesi: genetica e comorbilità
●
Sclerosi Tuberosa ( TSC1-9q; TSC2-16p)
●
FRA-X (nucleotidi ripetuti CGG crX)
●
Neurofibromatosi
●
Sindrome di Prader-Willi (15q11-q13)
Contiguità genica-linkage disequilibrium
20
Etipatogenesi: fattori genetici
Ereditarietà di tipo multigenico
●
7q31-q33: regione legata al linguaggio
frequente familiarità per disturbi del linguaggio
●
7q22-q33: gene RELN
disturbi cognitivi e ritardo mentale legati ad
alterazione della migrazione neuronale corticale e
cerebellare
●
15q11-q13: gene subunità recettore GABAa
elevata frequenza di epilessia nell'autismo
●
17q11-q12: gene 5-HTT
alterazione attività dopaminergica nel lobo
prefrontale e compromissione funzini esecutive
DSM IV- TR: cos’è?
Il DSM IV TR, manuale statistico e
diagnostico dei disturbi mentali, è un testo
redatto da una commissione di esperti
nominata dall’APA Associazione Americana
degli Psichiatri
Elenca le definizioni dei disturbi mentali che
incontrano il consenso degli psichiatri e della
comunità scientifica internazionale
Per ogni disturbo, descrive i sintomi e le linee
guida per formulare una corretta diagnosi
42
21
Disturbo autistico
Disturbi Mentali
Disturbi diagnosticati nell’infanzia, nella
fanciullezza o nell’adolescenza
Disturbi pervasivi dello sviluppo
Disturbo autistico
43
Interazione sociale
A.
Marcata compromissione nell’uso di svariati
comportamenti non verbali, come lo sguardo
diretto, l’espressione mimica, le posture corporee,
e i gesti che regolano l’interazione sociale
B. Incapacità di sviluppare interazioni con i coetanei
adeguate al livello di sviluppo
C. Mancanza di ricerca spontanea della condivisione
di gioie, interessi o obiettivi con altre persone (per
esempio non mostrare, portare, né richiamare
l’attenzione su oggetti di proprio interesse)
D. Mancanza di reciprocità sociale o emotiva
44
22
Comunicazione
A.
Ritardo o totale mancanza dello sviluppo del
linguaggio parlato (non accompagnato da un
tentativo di compenso attraverso modalità
alternative di comunicazione come gesti o mimica)
B. In soggetti con linguaggio adeguato, marcata
compromissione della capacità di iniziare o
sostenere una conversazione con altri
C. Uso di linguaggio stereotipato e ripetitivo o
linguaggio eccentrico
D. Mancanza di giochi di simulazione vari e
spontanei, o di giochi di imitazione sociale
adeguati al livello di sviluppo
45
Repertorio di interessi
A. Dedizione assorbente a uno o più tipi di
interessi ristretti e stereotipati anomali o per
intensità o per focalizzazione
B. Sottomissione del tutto rigida ad inutili
abitudini o rituali specifici
C. Manierismi motori stereotipati e ripetitivi
(battere o torcere le mani o il capo, o
complessi movimenti di tutto il corpo)
D. Persistente ed eccessivo interesse per parti
di oggetti
46
23
Autismo
chi decide di cosa si tratta?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS
Attraverso l’ ICD 10
Autismo infantile 299.00
L’American Psychiatric Association APA
Attraverso il DSM IV Text Revision
Disturbo Autistico F84.0
47
Criteri per la diagnosi
Devono essere presenti almeno
2 criteri per l’interazione sociale
1 criterio per comunicazione
1 criterio per il repertorio di interessi
L’esordio deve avvenire prima dei tre
anni
Diagnosi differenziale
48
24
Autismo:
manifestazioni e disturbi associati
Ritardo Mentale
Profilo di sviluppo “irregolare”
Capacità verbali più deboli di quelle non verbali
Possono essere presenti “isole di abilità”
Il linguaggio espressivo può essere superiore alle abilità di comunicazione
Sintomi “comportamentali” (aggressività, iperattività, autolesionismo…)
Risposte bizzarre a stimoli sensoriali
Disturbi dell’alimentazione
Disturbi del sonno
Anomalie dell’umore e dell’affettività
Paure, fobie
In adolescenza, nelle persone con buon funzionamento, può comparire la
depressione
49
Autismo:
condizioni mediche associate
Sintomi o segni neurologici aspecifici (es:
riflessi primitivi, ritardato sviluppo della
dominanza di lato …)
Condizione neurologica o altra condizione
medica generale (es: Sindrome dell’x
fragile, Sclerosi Tuberosa …)
Nel 25% dei casi si sviluppano convulsioni
50
25
Autismo:
caratteristiche collegate all’età
Nei neonati e nella prima infanzia
Difficoltà a stare in braccio
Mancanza di attenzione condivisa
Mancanza di contatto visivo
Mancanza di sorriso e reciprocità sociale
Mancanza di risposta alla voce dei genitori
Apparente sordità
Movimenti stereotipati o attività ripetitive
Difficoltà nel gioco
Difficoltà o avversione al contatto fisico o alle
manifestazioni d’affetto
51
Autismo:
caratteristiche collegate all’età
Nei bambini in età prescolare
Prendere la mano dell’adulto per ottenere oggetti
Difficoltà nello sguardo diretto
Nell’adolescenza
Repentine variazioni dei problemi di comportamento
Maggiore disponibilità all’interazione
Negli adulti
Attenuazione dei problemi di comportamento
52
26
Autismo: prevalenza
5 casi su 10.000
(da 2 a 20 casi su 10.000)
la sindrome di Asperger di 2,5/10000
(Fombonne,2003);
l’autismo NAS ha un’incidenza maggiore
ma difficile da stimare.
53
Autismo:
decorso
Esordio prima dei tre anni
Presentazione dei sintomi fin dalla nascita
Regressione dopo il primo anno (fra i 12 e i 21 mesi)
Il decorso è continuo
Una piccola percentuale riesce, in età adulta, a
vivere e a lavorare in maniera indipendente
Un terzo riesce a raggiungere una parziale
indipendenza
I restanti necessiteranno di cure ed assistenza per
tutta la vita
54
27
Autismo:
familiarità
Il 5% dei fratelli ha maggiori
probabilità di presentare il disturbo
autistico
Ci sono maggiori rischi (imprecisata la
percentuale) che i fratelli presentino
altri tipi di disturbi
Le persone dotate hanno antecedenti
familiari (percentuali non precisate)
55
Autismo:
diagnosi differenziale
Disturbo di Rett
Disturbo disintegrativo dell’infanzia
Disturbo di Asperger
Schizofrenia
Mutismo selettivo
Disturbo dell’espressione del linguaggio
Ritardo mentale
Disturbo da movimenti stereotipati
Disturbo misto dell’espressione e della ricezione
del linguaggio
56
28
Autismo:
cosa non è?
Non è una malattia, bensì “gli autismi”
rappresentano le conseguenze di differenti
“malattie” (o condizioni patologiche)
Non deriva da un cattivo rapporto fra la madre e il
bambino, benché molti genitori vengano
fortemente provati dalla presenza di un figlio con
autismo
Non è una “psicosi”, ma una forma di handicap
Non è sinonimo di isolamento, benché l’isolamento
possa essere uno dei sintomi, ovvero una
conseguenza dei disturbi più frequentemente
osservati nell’autismo
57
Hanno detto…
• “… di professionisti vostro figlio ne incontrerà
tanti, ma come genitori ha solo voi due …”
(un professionista)
• “Sono genitore e professionista. Come
professionista andrò in pensione. Ma come
madre non andrò in pensione mai” (C. Trehin)
• “Il vostro è un lavoro difficile, e bisogna avere
delle motivazioni personali per farlo. In ogni
caso, è una scelta. Voglio bene a mio figlio,
ma non ho scelto io che fosse autistico.
Questa è la differenza fondamentale fra noi 58
due.” (un padre)
29
Diagnosi Differenziale
• Autismo ad alto funzionamento
• Sindrome di Asperger
due diagnosi o un continuum?
59
Sindrome di Asperger
• Non si riscontra alcun ritardo clinicamente
significativo nel linguaggio (parole singole
entro i due anni e frasi comunicative entro i
tre anni), sono possibili goffagine motoria ed
“abilità isolate”
• Compromissione qualitativa dell’interazione
sociale
• Interessi ristretti, ripetitivi e stereotipati
60
30
La storia
• Nel 1944 Hans Asperger descrisse 4
bambini tra i sei e gli 11 anni che
presentavano una “psicopatia autistica”
• Nel 1943 Kanner aveva pubblicato la
descrizione di 11 bambini con “disturbi
autistici del contatto affettivo”
• 1981 L. Wing rende nota la diagnosi
61
Alterazione qualitativa
dell’interazione sociale
• Alterazione dello sguardo, della mimica facciale,
delle posture corporee e dei gesti che regolano
l’interazione sociale
• Incapacità di sviluppare con i coetanei relazioni
adeguate al livello di sviluppo
• Incapacità nel condividere emozioni (deficit di
attenzione congiunta);
• Mancanza di reciprocità sociale ed emotiva.
62
31
63
64
32
65
Alterazione qualitativa e/o
quantitativa della
comunicazione
• Ritardo o totale mancanza del linguaggio;
• In soggetti con linguaggio adeguato,
compromissione della capacità di iniziare e
sostenere una conversazione;
• Uso di linguaggio ripetitivo, stereotipato,
eccentrico;
• Mancanza di giochi di simulazione o di giochi di
imitazione.
66
33
67
Comportamento, interessi e
attività ristretti, ripetitivi e
stereotipati
• Dedizione assorbente a uno o più interessi
ristretti e stereotipati;
• Sottomissione rigida a inutili abitudini o
rituali specifici;
• Manierismi motori stereotipati e ripetitivi;
• Persistente ed eccessivo interesse per
parti di oggetti.
68
34
69
70
35
71
72
36
73
74
37
75
Sintomi prodromici (I° anno di
vita):
•
•
•
•
•
•
la sfuggenza dello sguardo,
l’assenza del sorriso,
il disinteresse per l’altro e per l’oggetto,
l’eccessiva calma o l’estrema irritabilità,
l’insofferenza al contatto corporeo,
l’incapacità a modulare la postura quando preso in
braccio,
• la scarsa propositività ed iniziativa nell’interazione,
• la scarsa reattività alla voce o al volto umano.
76
38
I bambini con disturbi dello spettro autistico
presentano una grande eterogeneità ma vi sono
sempre difficoltà di base in 2 aree fondamentali e
precoci dello sviluppo:
1. La capacità di
attenzione
congiunta;
2. La capacità di
usare simboli.
77
Per capacità di attenzione congiunta si intende
l’abilità del bambino di condividere l’attenzione e
le emozioni, di esprimere intenti e di impegnarsi in
interazioni sociali reciproche.
78
39
79
Sulla capacità di usare simboli si fonda la comprensione
del significato espresso attraverso gesti convenzionali,
parole e forme verbali più avanzate, e l’abilità di
impegnarsi nell’uso appropriato di oggetti finalizzato al
gioco d’immaginazione. (Wetherby, Prizant &Schuler,
2000).
80
40
LA VALUTAZIONE
SINTOMI – LIVELLO – ABILITA’
81
VALUTAZIONE SINTOMATOLOGICA
Rileva i comportamenti sintomatici,
identificando così il disturbo oppure
escludendo la diagnosi
Strumenti per la valutazione sintomatologica:
• DSM IV TR (Manuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi Mentali
• ICD 10
• CARS (Childhood Autism Rating Scale) - (Schopler et
al., 1988)
• ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) –
(Lord et al., 2000)
• ADI (Autism Diagnostic Interview – Revised) – (Lord et
al., 1994)
• GARS (Autism Behavior Rating Scale ) – (Gilliam, 1995)
82
41
DSM IV- TR
Il DSM IV TR, manuale statistico e
diagnostico dei disturbi mentali, è un testo
redatto da una commissione di esperti
nominata dall’APA Associazione Americana
degli Psichiatri
Elenca le definizioni dei disturbi mentali che
incontrano il consenso degli psichiatri e della
comunità scientifica internazionale
Per ogni disturbo, descrive i sintomi e le linee
guida per formulare una corretta diagnosi
Per l’autismo si fa riferimento a tre gruppi di
sintomi: comunicazione, socializzazione e
interessi
83
VALUTAZIONE FUNZIONALE
Individua i punti di forza e i punti di
debolezza
Strumenti per la valutazione funzionale P.E.P – R
(Psycho-Educational Profile) – (Schopler et al.,
1989)
• P.E.P. 3
• A.A.P.E.P.
• Vineland (Adaptive Behavior Scales (VABS) –
(Sparrow et al., 1984)
84
42
Valutazione funzionale
Identifica i punti di forza, di debolezza e le
“abilità emergenti”, cioè le potenzialità di
un individuo, che saranno l’obiettivo del
programma educativo individualizzato
85
•
•
•
•
•
PER – R
PEP3
AAPEP
VINELAND
…
86
43
P.E.P.R
Permette di valutare le diverse abilità di un bambino tra 1 e 6 anni,
definendo il livello di sviluppo raggiunto in sette aree evolutive:
•Imitazione
•Percezione
•Motricità fine
•Motricità globale
•Coordinazione oculo-manuale
•Area cognitiva
•Area verbale
87
PEP - R
La codifica delle risposte è data da
tre livelli di performances: Riuscito,
per le abilità acquisite, Emergente,
per le attività effettuate
parzialmente o con aiuto; Non
riuscito, per le abilità non acquisite
88
44
A.A.P.E.P. (Adolescent and Adult
Psycho Educational Profile)
Consente di identificare le diverse abilità del ragazzo in
sei aree evolutive:
•Abilità professionali
•Funzionamento autonomo
•Abilità di tempo libero
•Comportamento professionale
•Comunicazione funzionale
•Comportamento interpersonale
89
• La Scala A.A.P.E.P è costituita da tre sottoscale: la Scala di Osservazione Diretta, la
Scala Familiare, la Scala Scolastica/Lavorativa
• La codifica delle risposte è data da tre livelli di
performance:
– Superato (per le abilità raggiunte)
– Non superato (abilità non ancora acquisite),
– Emergente (abilità da potenziare)
90
45
VABS (Vineland Adaptive
Behavior Scales)
• Valutano l’autonomia personale dalla nascita fino
all’età adulta
• Intervista semistrutturata
• 540 item
• Quattro scale:
comunicazione - espressione, ricezione, scrittura
abilità quotidiane – personale, domestico, comunità
socializzaione – relazioni interpersonali, gioco e
tempo libero, regole sociali
abilità motorie – grossolane, fini
• La codifica è data da tre livelli: “abitualmente”,
“qualche volta”, “mai”
91
VALUTAZIONE NORMATIVA
• Identifica il livello intellettivo (Q.I.), mettendo il
bambino in relazione allo “sviluppo tipico”
• Permette di osservare le variazioni di prestazioni
nel tempo
Strumenti per la valutazione normativa:
• Scale Wechsler (per le persone con autismo
verbali: WIPPSI 4-6 anni (la nuova WIPPSI
arriva ai 7 aa); WISC-R e WiscIII dai 6 ai 16
anni; WAIS-R adulti)
• Scala di sviluppo Psicomotorio della Prima
Infanzia (Brunet Lezine)
• Leiter-R
92
46
Leiter – R
(Leiter International Performance
Scale - Revised)
Caratteristiche e modalità di
utilizzo
93
Caratteristiche generali
La scala Leiter-R è un test cognitivo
che valuta:
• Quoziente Intellettivo
• abilità mnesiche
• abilità attentive
94
47
Caratteristiche generali
• Non richiede comunicazione verbale fra
esaminatore e soggetto
• Non richiede che il soggetto legga e
scriva qualcosa
• E’ composta da items autoesplicativi
95
Perché una scala non verbale
• La prima versione venne utilizzata nel 1927,
nelle Hawaii
• La motivazione primaria fu l’incomunicabilità
in quel luogo tra esaminatori e soggetti
• La presenza sempre maggiore, in seguito
all’immigrazione, di soggetti stranieri, la rese
sempre più utile negli anni seguenti
96
48
Quando utilizzarla?
In generale in qualunque caso in cui
l’elemento verbale possa condizionare il
risultato generale
• Autismo
• Sordità
• Differenze culturali e linguistiche
• ADHD
• Lesioni cerebrali di origine traumatica
97
Modelli fattoriali gerarchici della Leiter-R
Intelligenza
Generale
(g)
ragionamento
Visualizzazione –
Visuo-spaziale
attenzione
memoria
Memoria di
riconoscimento
Span di memoria
98
49
Confronto con le scale Wechsler
Intelligenza: capacità generale dell’
dell’individuo di mettersi
in contatto con l’
l’ambiente e di affrontare risolutivamente
le differenti esigenze che da esso provengono
Fattori
intellettivi
(processi
cognitivi)
Entità
multideterminata
e sfaccettata
Fattori non intellettivi
(perseveranza,
entusiasmo, controllo
degli impulsi,
consapevolezza dei fini)
Tutte le abilità, siano esse intellettive che non, sono ugualmente importanti
nel determinare la capacità di intelligenza globale
Nelle scale Wechsler è possibile valutare, oltre al QI globale, un QI verbale e
un QI di performance
99
Dalla L.I.P.S. alla L.I.P.S.-R
• E’ stata aggiunta una batteria
(Attenzione – Memoria)
• Maggiore variabilità tra i subtest
• Sistema di siglatura più complesso ed
accurato
• Maggior quantità di informazioni
ricavabili
100
50
L.I.P.S.
• Il soggetto autistico, di fronte alla
presentazione della stessa tipologia
di materiale, incontrava meno
difficoltà
101
Il Materiale
• 3 leggii (2 VR, 1 AM)
• Cartoncini
• Forme in spugna
• Libretti di risposta
• Tavole illustrate
• Griglie di risposta
102
51
Caratteristiche specifiche
L.I.P.S.-R
• Può essere somministrato a soggetti da
2 a 20 anni
• E’ composto da due batterie (VR – AM)
• Ogni batteria è formata da dieci subtest
(media = 10, DS = 3)
• Ha diverse modalità di utilizzo
103
Modalità di utilizzo alternative
della scala Leiter-R
• misurazione completa del QI
• screening iniziale (scala breve di
QI)
104
52
Modalità di utilizzo
della scala Leiter-R
• In entrambi i casi viene usata la batteria VR
• I subtest vengono selezionati in base all’età
• La scala breve di QI fornisce indicazioni
provvisorie e una stima rapida del livello
intellettivo globale (alto, medio alto, medio
basso, basso)
105
Scala Completa di QI (2-5
anni)
Matching
2-5 anni
Classification
2-5 anni
Figure Ground
2-20 anni
Form Completion
2-20 anni
Sequential Orders
2-20 anni
Repeated Patterns
2-20 anni
106
53
Scala Completa di QI (6-20
anni)
Paper Folding
6-20 anni
Design Analogies
6-20 anni
Figure Ground
2-20 anni
Form Completion
2-20 anni
Sequential Orders
2-20 anni
Repeated Patterns
2-20 anni
107
Scala breve di QI (tutte le età)
Figure Ground
2-20 anni
Form completion
2-20 anni
Sequential Orders
2-20 anni
Repeated Patterns
2-20 anni
108
54
Suggerimenti pratici
•
•
•
•
Strutturare accuratamente il setting
Seguire l’ordine dei subtest
Organizzare il materiale in anticipo
Le numerose tipologie di materiali, la
posizione da tenere e la siglatura
complessa rendono preferibile la
somministrazione con la presenza di
due esaminatori
109
55