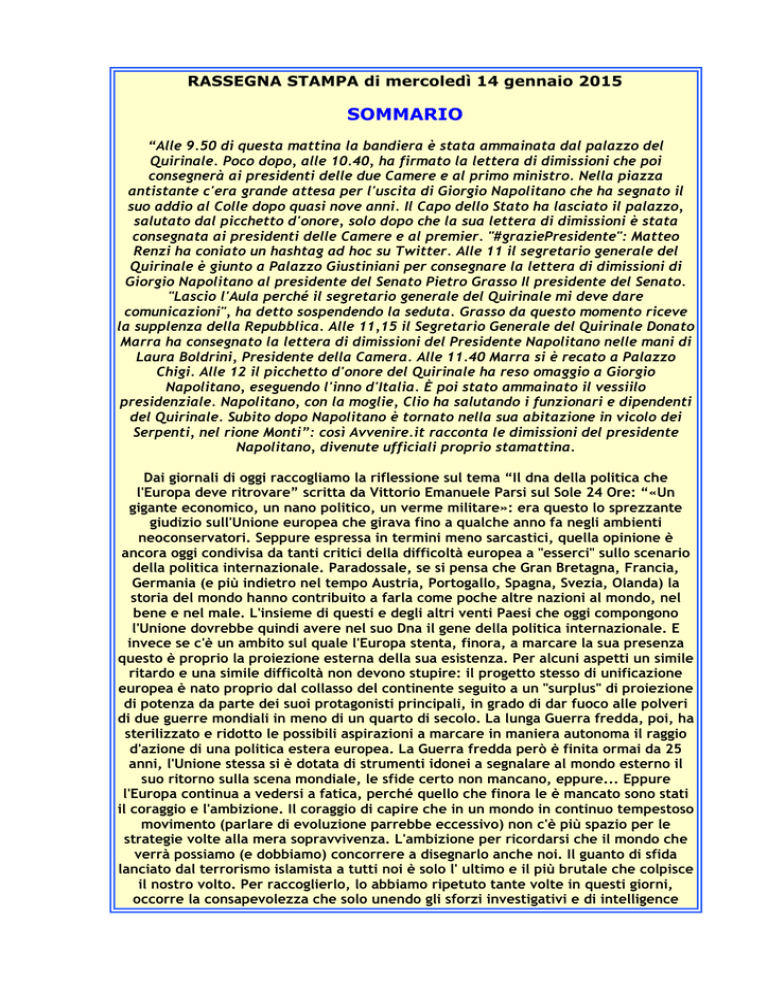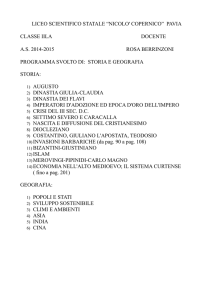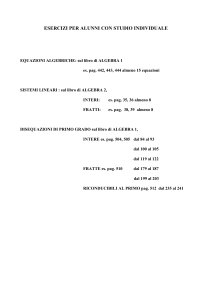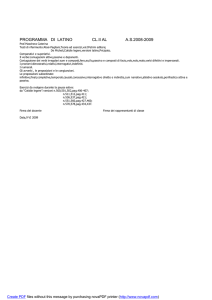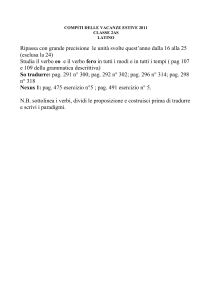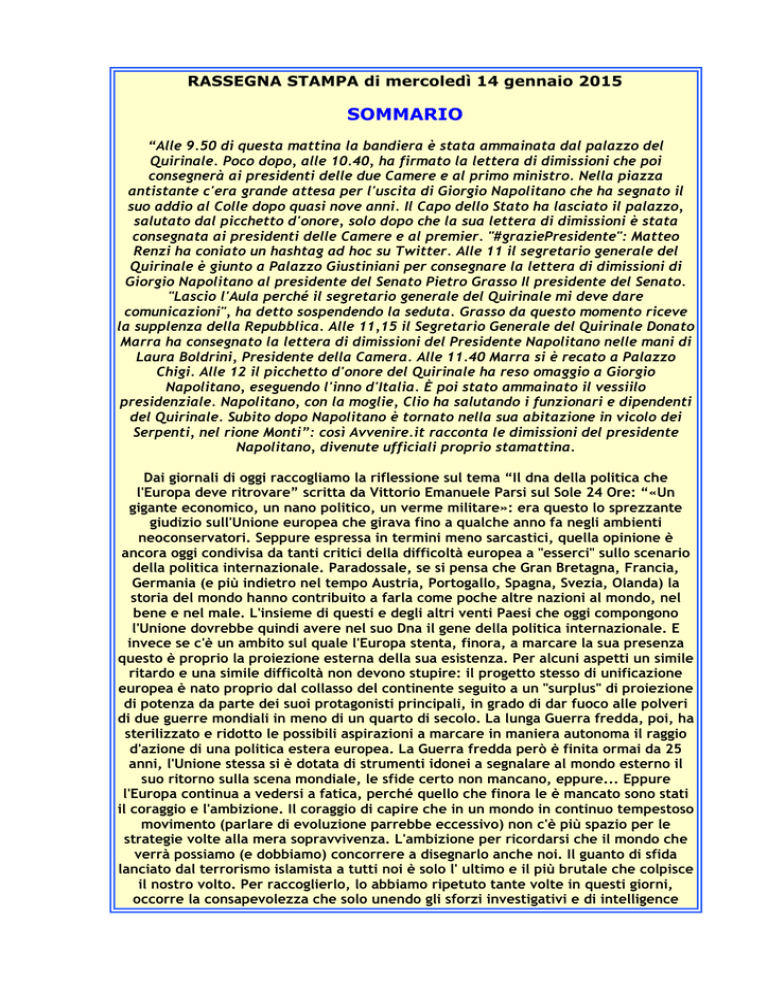
RASSEGNA STAMPA di mercoledì 14 gennaio 2015
SOMMARIO
“Alle 9.50 di questa mattina la bandiera è stata ammainata dal palazzo del
Quirinale. Poco dopo, alle 10.40, ha firmato la lettera di dimissioni che poi
consegnerà ai presidenti delle due Camere e al primo ministro. Nella piazza
antistante c'era grande attesa per l'uscita di Giorgio Napolitano che ha segnato il
suo addio al Colle dopo quasi nove anni. Il Capo dello Stato ha lasciato il palazzo,
salutato dal picchetto d'onore, solo dopo che la sua lettera di dimissioni è stata
consegnata ai presidenti delle Camere e al premier. "#graziePresidente": Matteo
Renzi ha coniato un hashtag ad hoc su Twitter. Alle 11 il segretario generale del
Quirinale è giunto a Palazzo Giustiniani per consegnare la lettera di dimissioni di
Giorgio Napolitano al presidente del Senato Pietro Grasso Il presidente del Senato.
"Lascio l'Aula perché il segretario generale del Quirinale mi deve dare
comunicazioni", ha detto sospendendo la seduta. Grasso da questo momento riceve
la supplenza della Repubblica. Alle 11,15 il Segretario Generale del Quirinale Donato
Marra ha consegnato la lettera di dimissioni del Presidente Napolitano nelle mani di
Laura Boldrini, Presidente della Camera. Alle 11.40 Marra si è recato a Palazzo
Chigi. Alle 12 il picchetto d'onore del Quirinale ha reso omaggio a Giorgio
Napolitano, eseguendo l'inno d'Italia. È poi stato ammainato il vessiilo
presidenziale. Napolitano, con la moglie, Clio ha salutando i funzionari e dipendenti
del Quirinale. Subito dopo Napolitano è tornato nella sua abitazione in vicolo dei
Serpenti, nel rione Monti”: così Avvenire.it racconta le dimissioni del presidente
Napolitano, divenute ufficiali proprio stamattina.
Dai giornali di oggi raccogliamo la riflessione sul tema “Il dna della politica che
l'Europa deve ritrovare” scritta da Vittorio Emanuele Parsi sul Sole 24 Ore: “«Un
gigante economico, un nano politico, un verme militare»: era questo lo sprezzante
giudizio sull'Unione europea che girava fino a qualche anno fa negli ambienti
neoconservatori. Seppure espressa in termini meno sarcastici, quella opinione è
ancora oggi condivisa da tanti critici della difficoltà europea a "esserci" sullo scenario
della politica internazionale. Paradossale, se si pensa che Gran Bretagna, Francia,
Germania (e più indietro nel tempo Austria, Portogallo, Spagna, Svezia, Olanda) la
storia del mondo hanno contribuito a farla come poche altre nazioni al mondo, nel
bene e nel male. L'insieme di questi e degli altri venti Paesi che oggi compongono
l'Unione dovrebbe quindi avere nel suo Dna il gene della politica internazionale. E
invece se c'è un ambito sul quale l'Europa stenta, finora, a marcare la sua presenza
questo è proprio la proiezione esterna della sua esistenza. Per alcuni aspetti un simile
ritardo e una simile difficoltà non devono stupire: il progetto stesso di unificazione
europea è nato proprio dal collasso del continente seguito a un "surplus" di proiezione
di potenza da parte dei suoi protagonisti principali, in grado di dar fuoco alle polveri
di due guerre mondiali in meno di un quarto di secolo. La lunga Guerra fredda, poi, ha
sterilizzato e ridotto le possibili aspirazioni a marcare in maniera autonoma il raggio
d'azione di una politica estera europea. La Guerra fredda però è finita ormai da 25
anni, l'Unione stessa si è dotata di strumenti idonei a segnalare al mondo esterno il
suo ritorno sulla scena mondiale, le sfide certo non mancano, eppure... Eppure
l'Europa continua a vedersi a fatica, perché quello che finora le è mancato sono stati
il coraggio e l'ambizione. Il coraggio di capire che in un mondo in continuo tempestoso
movimento (parlare di evoluzione parrebbe eccessivo) non c'è più spazio per le
strategie volte alla mera sopravvivenza. L'ambizione per ricordarsi che il mondo che
verrà possiamo (e dobbiamo) concorrere a disegnarlo anche noi. Il guanto di sfida
lanciato dal terrorismo islamista a tutti noi è solo l' ultimo e il più brutale che colpisce
il nostro volto. Per raccoglierlo, lo abbiamo ripetuto tante volte in questi giorni,
occorre la consapevolezza che solo unendo gli sforzi investigativi e di intelligence
potremo venire a capo di una minaccia tanto letale al nostro stile di vita. Tutto questo
però non basta. Considerato il legame oggettivo che esiste tra i terroristi nati e
cresciuti in casa nostra e il centro di irradiazione delle aberranti mistificazioni in
nome delle quali hanno dichiarato la loro violenta secessione dal consesso civile,
occorre che l'Europa sappia trovare una politica che sia non solo comune, ma anche
forte e determinata per concorrere a chiudere l'esperienza dello "Stato islamico" e
sostenere la riforma e il consolidamento del sistema regionale del Levante. Si tratta di
uno sforzo importante, sul quale l'Europa si gioca la sua credibilità, tanto più in un
momento storico in cui la potenza leader dell'Occidente e del mondo sembra essersi
smarrita. L'Unione europea potrà essere una "potenza pacifica" ma non potrà mai più
illudersi di essere solo una "potenza civile" e men che meno imbelle. La spinta a una
maggiore unità, a spostare più avanti possibile il processo di unificazione politica,
riscoprendo l'intima essenza politica dell'Unione, viene anche dall'interno dei suoi
confini. Nonostante gli indubbi maggiori progressi nel campo dell' edificazione del
mercato unico e di uno spazio economico comune, la grave crisi che da anni squassa
le nostre economie ha mostrato in maniera impietosa quanto siano pesanti e alla fine
insopportabili i costi derivanti da un'imperfetta unificazione. Se confrontata con
quelle dei principali competitors globali, l'economia europea appare in affanno,
incapace di rilanciarsi non solo e non tanto per una carenza oggettiva di risorse
finanziarie, ma soprattutto per l'incapacità di impiegarle utilmente. Interroghiamoci
sul come mai i famosi "parametri" di Maastricht non sono mai stati allentati per ridare
un po' di fiato ad economie asfittiche e in continuo peggioramento, o perché solo
dopo faticosi negoziati l'Europa sia riuscita (proprio ieri) ad accennare ad un mite
tentativo di superare le politiche del solo rigore finanziario, chiesto da anni da più
parti. O ancora, interroghiamoci sul perché le politiche economiche nazionali abbiano
talvolta finito per produrre una rincorsa al dumping fiscale che ha generato un gioco a
somma zero. La risposta sarebbe sempre la stessa: deficit di unità politica. È il ritardo
nel processo di unificazione che continua a far sì che ogni singola costituency politica
nazionale non possa "fidarsi" delle altre, e chieda quindi pegni costosi per ogni credito
concesso. Non è per nulla accidentale che all'interno della casa comune europea la
divergenza in termini economico-sociali abbia preso il posto della convergenza, con
un avvitamento che rafforza l'analogo, inaccettabile movimento che si produce anche
nelle singole società nazionali, creando diseguaglianze di opportunità francamente
inaccettabili. Il risultato di questa debolezza lo abbiamo sotto gli occhi: l'Europa, la
patria della democrazia e dell'uguaglianza politica come ci piace pensarla, oggi si
ritrova a temere l'esito del voto greco, ad aver paura di fronte all'esercizio del più
elementare diritto democratico di una delle più piccole delle nazioni che la
compongono. È tempo di cambiare tutto questo, prima che lo scorrere del tempo
decreti impietosamente la fine del più straordinario esperimento politico mai tentato
nella storia” (a.p.)
3 – VITA DELLA CHIESA
L’OSSERVATORE ROMANO
Pag 1 Senza equivoci di g.m.v.
Pag 8 Con la riconciliazione nel cuore
Papa Francesco incontra gli esponenti delle varie comunità religiose dello Sri Lanka
AVVENIRE
Pag 1 La fraterna diversità di Enzo Bianchi
Vangelo della pace e dialogo tra le fedi
Pag 15 La ferita dei preti pedofili e il discernimento che serve di Maurizio
Patriciello
CORRIERE DELLA SERA
Pag 17 L’invito del Papa ai leader religiosi: denunciare la violenza in nome di
Dio di Gian Guido Vecchi
LA NUOVA
Pag 8 Bergoglio e le mosse anti-Islam di Orazio La Rocca
Pag 11 “Libertà e credo religioso, il problema ora esiste” di Claudio Baccarin
Il dibattito nella Chiesa del Nordest
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO
AVVENIRE
Pag 3 Le nuove assunzioni in Fiat, primo test per il Jobs act di Leonardo Becchetti
Come sta cambiando il mercato del lavoro in Italia
LA NUOVA
Pag 23 Economia, segnali di ripresa per il 2015 di Gianni Favarato
I dati del report provinciale: nell’ultimo anno si è ridotto il numero delle procedure di
crisi aziendale, dei lavoratori in mobilità e dei cassintegrati
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA
CORRIERE DEL VENETO
Pag 11 In laguna corsa al divorzio facile, in una settimana 50 richieste di Alice
D’Este
L’avvocato: tribunali alleggeriti. Il sacerdote: più complicato ripensarci. Paolo e Lucia, la
decisione dopo dieci anni di vita separata: “Due incontri allo sportello e 16 euro, non
potevo crederci”
LA NUOVA
Pag 18 Venezia, omissioni e nomine tra il sacro e il profano di Franco Miracco
IL GAZZETTINO DI VENEZIA
Pag XVI Mira si attiva per i tre fratelli di Luisa Giantin
Pag XXI Un milione di persone per il presepe di sabbia di Giuseppe Babbo
Jesolo: record di presenze nelle varie edizioni con i quasi centomila visitatori di
quest’anno
8 – VENETO / NORDEST
CORRIERE DEL VENETO
Pag 1 Se la politica arriva a scuola di Massimiliano Melilli
Perché (e come) parlarne
Pagg 6 – 7 I medici e i miracoli del Santo: “Non c’è prova, la scienza è altro” di
Michela Nicolussi Moro e Renato Piva
Silvio Garattini: “Guarigioni inspiegabili, ma sono soltanto limiti della medicina”. In fila
per l’aiuto ultraterreno, il popolo che invoca e ringrazia
… ed inoltre oggi segnaliamo…
CORRIERE DELLA SERA
Pag 1 La figura che non vorremmo di Michele Ainis
Pag 5 Terna di nomi. E cresce l’ipotesi Veltroni di Francesco Verderami
Pag 20 Houellebecq: “Lo ammetto, adesso ha paura anch’io. Devo essere
irresponsabile per continuare a scrivere. L’uomo non ne può più della sua
libertà” di Stefano Montefiori
Pag 36 La vera radice dell’estremismo di Vittorio Messori
LA REPUBBLICA
Pag 1 I sogni e le fatiche di un Sisifo al Quirinale di Eugenio Scalfari
Pag 19 Vivere in Europa ai tempi della paura, così il terrorismo distrugge la
società di David Grossman
IL SOLE 24 ORE
Il dna della politica che l'Europa deve ritrovare di Vittorio Emanuele Parsi
AVVENIRE
Pag 3 I bambini arruolati in odio alla vita di Marina Corradi
L’orrore dei fanciulli usati per uccidere
IL GAZZETTINO
Pag 1 Non sono Charlie ma voglio che Charlie viva di Dario Calimani
Pag 1 Per re Giorgio è come il giorno della liberazione di Mario Ajello
LA NUOVA
Pag 1 Quell’idea di Europa e nazione di Gianfranco Pasquino
Pag 1 Quanto vale la libertà d’espressione di Vincenzo Milanesi
Torna al sommario
3 – VITA DELLA CHIESA
L’OSSERVATORE ROMANO
Pag 1 Senza equivoci di g.m.v.
Amicizia, dialogo, solidarietà: con tre parole il Papa ha presentato la sua visita in Sri
Lanka nel discorso pronunciato all’arrivo nell’isola, che ha celebrato con la tradizionale
definizione di «perla dell’oceano Indiano». E da questo desiderio di incontro sono subito
apparse segnate le prime ore a Colombo, dove Francesco è stato accolto con rispetto e
simpatia dal presidente, eletto da qualche giorno. Di religione buddista, Maithripala
Sirisena ha detto infatti che il viaggio papale è l’occasione di ricevere dall’ospite le
benedizioni per l’alto incarico assunto, aggiungendo che la canonizzazione del beato Vaz
è un onore per il popolo srilankese. In un Paese che per un trentennio è stato lacerato
da un sanguinoso conflitto civile intrecciatosi a pretesti religiosi e all’indomani del
discorso al corpo diplomatico dove è tornata la condanna dell’uso della religione falsata
da ideologie di violenza, il Pontefice ha dedicato il primo giorno della visita alla necessità
del dialogo. Tema centrale già sviluppato dal Papa nell’incontro con i rappresentanti
degli episcopati dell’Asia durante il viaggio in Corea. Nel processo di risanamento, che
deve privilegiare la verità, è fondamentale in Sri Lanka il ruolo dei «seguaci delle varie
tradizioni religiose»: buddisti, induisti, musulmani, cristiani. E certo non solo cristiani,
anche se i cattolici sono nel Paese un’importante minoranza, erano i moltissimi srilankesi
assiepati lungo i trenta chilometri che separano l’aeroporto dalla capitale per salutare
Francesco, per tutto il tempo in piedi sulla papamobile. Sulle orme di Paolo VI e Giovanni
Paolo II, che negli scorsi decenni hanno visitato il Paese, il Papa ha rilanciato, in un
suggestivo incontro con centinaia di esponenti religiosi, la dichiarazione del Vaticano II
sulle religioni non cristiane, ripetendo che la Chiesa «nulla rigetta di quanto è vero e
santo in queste religioni». Affermazione approvata dal concilio mezzo secolo fa, ma che
risale a una convinzione antichissima nella tradizione cristiana: già matura in età
patristica e un millennio più tardi, all’inizio dell’età moderna, base delle pionieristiche
missioni gesuitiche in India, Giappone, Cina. Sviluppando il tema del dialogo, il Papa ha
detto che «deve fondarsi su una presentazione piena e schietta delle nostre rispettive
condizioni». In questo modo emergeranno certo le differenze, ma anche quanto le
religioni hanno in comune. E, questa è la convinzione di Francesco, «nuove strade si
apriranno per la mutua stima, cooperazione e anche amicizia», com’è apparso nel
grande incontro di Colombo. Se questo comune «desiderio di sapienza, di verità e di
santità» riveste un significato particolare in Sri Lanka, dove dopo la guerra civile sono
necessari il risanamento e l’unità, le parole di Francesco assumono però un valore
generale in un tempo devastato in diverse regioni del mondo dal terrorismo
fondamentalista. Sì, «non si deve permettere che le credenze religiose vengano abusate
per la causa della violenza o della guerra» ripete il Papa. E bisogna essere «non
equivoci» nel denunciare le violenze.
Pag 8 Con la riconciliazione nel cuore
Papa Francesco incontra gli esponenti delle varie comunità religiose dello Sri Lanka
«Per troppi anni gli uomini e le donne di questo Paese sono stati vittime di lotta civile e
di violenza. Ciò di cui ora c’è bisogno è il risanamento e l’unità». Nel pomeriggio di
martedì 13 gennaio, parlando agli esponenti delle varie comunità religiose dello Sri
Lanka, riuniti nella Bandaranaike Memorial International Conference Hall di Colombo,
Papa Francesco ha parlato di «riconciliazione» e ha esortato tutti a vivere in armonia
senza «dimenticare la propria identità, sia essa etnica o religiosa» e a non permettere
l’abuso della religione per giustificare la violenza e la guerra.
Cari Amici, sono grato per l’opportunità di partecipare a questo incontro, che riunisce
insieme, tra gli altri, le quattro comunità religiose più grandi, parte integrante della vita
dello Sri Lanka: Buddhismo, Induismo, Islam e Cristianesimo. Vi ringrazio per la vostra
presenza e per il caloroso benvenuto. Ringrazio anche quanti hanno offerto preghiere e
benedizioni, e in modo particolare esprimo la mia gratitudine al Vescovo Cletus
Chandrasiri Perera e al Venerabile Vigithasiri Niyangoda Thero per le loro cortesi parole.
Sono giunto in Sri Lanka sulle orme dei miei predecessori, i Papi Paolo VI e Giovanni
Paolo II, per dimostrare il grande amore e la sollecitudine della Chiesa Cattolica per lo
Sri Lanka. È una grazia particolare per me visitare la comunità cattolica locale,
confermarla nella fede in Cristo, pregare con essa e condividerne le gioie e le sofferenze.
Ed è ugualmente una grazia l’essere con tutti voi, uomini e donne di queste grandi
tradizioni religiose, che condividete con noi un desiderio di sapienza, di verità e di
santità. Nel Concilio Vaticano II la Chiesa Cattolica ha dichiarato il proprio rispetto
profondo e duraturo per le altre religioni. Ha dichiarato che «nulla rigetta di quanto è
vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto [quei] modi di agire
e di vivere, [quei] precetti e [quelle] dottrine» (Nostra aetate, 2). Da parte mia,
desidero riaffermare il sincero rispetto della Chiesa per voi, le vostre tradizioni e le
vostre credenze. È in questo spirito di rispetto che la Chiesa Cattolica desidera
collaborare con voi e con tutte le persone di buona volontà, nel ricercare la prosperità di
tutti gli srilankesi. Spero che la mia visita aiuterà ad incoraggiare ed approfondire le
varie forme di collaborazione interreligiosa ed ecumenica, che sono state intraprese negli
anni recenti. Queste lodevoli iniziative hanno offerto opportunità di dialogo, essenziale
se vogliamo conoscerci, capirci e rispettarci l’un l’altro. Ma, come insegna l’esperienza,
perché tale dialogo ed incontro sia efficace, deve fondarsi su una presentazione piena e
schietta delle nostre rispettive convinzioni. Certamente tale dialogo farà risaltare quanto
siano diverse le nostre credenze, tradizioni e pratiche. E tuttavia, se siamo onesti nel
presentare le nostre convinzioni, saremo in grado di vedere più chiaramente quanto
abbiamo in comune. Nuove strade si apriranno per la mutua stima, cooperazione e
anche amicizia. Tali sviluppi positivi nelle relazioni interreligiose ed ecumeniche
assumono un significato particolare ed urgente nello Sri Lanka. Per troppi anni gli uomini
e le donne di questo Paese sono stati vittime di lotta civile e di violenza. Ciò di cui ora
c’è bisogno è il risanamento e l’unità, non ulteriori conflitti o divisioni. Certamente la
promozione del risanamento e dell’unità è un impegno nobile che incombe su tutti coloro
che hanno a cuore il bene della Nazione e dell’intera famiglia umana. Spero che la
collaborazione interreligiosa ed ecumenica dimostrerà che, per vivere in armonia con i
loro fratelli e sorelle, gli uomini e le donne non devono dimenticare la propria identità,
sia essa etnica o religiosa. Quanti modi ci sono per i seguaci delle diverse religioni per
realizzare questo servizio! Quanti sono i bisogni a cui provvedere con il balsamo della
solidarietà fraterna! Penso in particolare alle necessità materiali e spirituali dei poveri,
degli indigenti, di quanti ansiosamente attendono una parola di consolazione e di
speranza. Penso qui anche alle molte famiglie che continuano a piangere la perdita dei
loro cari. Soprattutto, in questo momento della storia della vostra Nazione, quante
persone di buona volontà cercano di ricostruire le fondamenta morali dell’intera società!
Possa il crescente spirito di cooperazione tra i dirigenti delle diverse comunità religiose
trovare espressione in un impegno a porre la riconciliazione fra tutti gli srilankesi al
cuore di ogni sforzo per rinnovare la società e le sue istituzioni. Per il bene della pace,
non si deve permettere che le credenze religiose vengano abusate per la causa della
violenza o della guerra. Dobbiamo essere chiari e non equivoci nell’invitare le nostre
comunità a vivere pienamente i precetti di pace e convivenza presenti in ciascuna
religione e denunciare gli atti di violenza quando vengono commessi. Cari amici, vi
ringrazio ancora per la generosa accoglienza e per la vostra attenzione. Che questo
fraterno incontro confermi noi tutti negli sforzi per vivere in armonia e diffondere le
benedizioni della pace.
AVVENIRE
Pag 1 La fraterna diversità di Enzo Bianchi
Vangelo della pace e dialogo tra le fedi
Era inevitabile che il viaggio e le parole di papa Francesco in Sri Lanka venissero lette
anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Parigi: mezzi di comunicazione e
opinioni pubbliche abituate a dare alle tragedie un peso specifico diverso a seconda della
distanza del luogo dove accadono, faticano a cogliere la dimensione insieme locale e
universale insita nel ministero del Vescovo di Roma. Quando il Papa afferma che «non si
deve permettere che le credenze religiose vengano abusate per la causa della violenza o
della guerra» lo fa rivolgendosi ai rappresentanti religiosi di una nazione particolare,
pensando a una specifica Chiesa locale di esigua minoranza che ha vissuto come tutti gli
abitanti di quel Paese anni di sanguinosa guerra civile. Eppure il suo messaggio conserva
una portata ben più ampia. La tragedia di Parigi non è dimenticata, così come non sono
dimenticati gli orrori della Nigeria, ma lo sguardo, il cuore e il pensiero di questo pastore
universale vanno in primo luogo alle vittime che scorge negli occhi dei suoi interlocutori
nello Sri Lanka, alle migliaia di persone uccise, torturate, imprigionate in questi anni. E
sono parole che vogliono essere non solo balsamo per le ferite, ma anche stimolo
all’azione, appello alla dignità presente in ogni essere umano, invito alla riconciliazione,
alla collaborazione, alla solidarietà. Così, riallacciandosi al documento conciliare Nostra
aetate, papa Francesco ricorda che «per vivere in armonia con i loro fratelli e sorelle, gli
uomini e le donne non devono dimenticare la propria identità, sia essa etnica o
religiosa» perché, anche se il «dialogo farà risaltare quanto siano diverse le nostre
credenze, tradizioni e pratiche», questo non farà che incrementare la consapevolezza di
«quanto abbiamo in comune ». Le tradizioni religiose, pur nella loro diversità, sono
sempre «desiderio e ricerca di sapienza, di verità e di santità» e per questo ci sono vie
da condividere e cammini di collaborazione che devono essere aperti o confermati per il
bene comune di un popolo e dell’umanità. Quello di Francesco è un appello al rispetto
reciproco, così come inteso dal Concilio: non un insieme di buone maniere, non un
indifferentismo etico, ma una consapevolezza che nell’altro è impressa in modo
indelebile l’immagine di Dio e questo non può che aprire alla «mutua stima, alla
cooperazione e anche all’amicizia ». Infatti, come ha ricordato il Papa all’arrivo
all’aeroporto di Colombo, «la diversità non è una minaccia», ma occasione di dialogo
autentico, di confronto nella verità per perseguire insieme una pace ritrovata. Guardare
con misericordia e compassione al qui e ora, a volti e persone concrete e vicinissime,
senza dimenticare l’orizzonte più vasto della convivenza globale: questa non è strategia
diplomatica, non è elaborazione di un’egemonia mondiale, ma è sollecitudine del pastore
che conosce le sue pecore, che sa dove vivono e di cosa si nutrono, qual è il loro
“prossimo” che sono chiamate ad amare anche quando dovesse presentare un volto
nemico. Ed è, al contempo, lo sguardo lungimirante di chi sa che locale e universale
interagiscono profondamente, e che l’intera famiglia umana è ferita quando anche una
sola persona è uccisa, così come l’umanità tutta è salvata quando una sola vita viene
riscattata dalla violenza e dall’odio mortifero. Non c’è persona che non abbia una voce, e
dunque tutti devono essere ascoltati, liberi di esprimere ciò che li fa soffrire nel duro
mestiere del vivere, tutti devono essere pronti ad accettarsi reciprocamente, a
riconoscere la dignità di ciascuno e a riconciliarsi, vincendo il male con il bene. A
Colombo, come a Parigi, come in Nigeria o in Siria, ciascuno deve avere non solo il
diritto ma la gioia di poter vivere, approfondire, testimoniare la propria fede religiosa,
trovando e donando accoglienza, rispetto fraterno, cura e sollecitudine verso le proprie
sofferenze. Questo non è oscuramento dell’annuncio cristiano ma evangelo della pace,
buona novella annunciata a tutti, a cominciare dai poveri e degli afflitti.
Pag 15 La ferita dei preti pedofili e il discernimento che serve di Maurizio
Patriciello
Credo sia giusto parlarne. A Napoli un prete cinquantenne di una diocesi calabrese è
stato colto in flagrante mentre in un internet point tentava di violentare un ragazzino. Il
vescovo lo ha immediatamente sospeso a divinis. Proviamo grande vergogna.
All’adolescente, alla sua famiglia, alla sua città chiediamo perdono mille volte. Non
abbiamo parole da dire e nulla da giustificare. Dobbiamo solo arrossire in volto e lo
facciamo con angoscia. Lo facciamo noi preti insieme a questo sventurato confratello,
sperando e pregando che queste cose non accadano più. È vero: nessun uomo ha la
capacità di leggere nell’animo di un altro uomo. È vero: certe volte il cuore è un
guazzabuglio ignoto allo stesso portatore. Però qualcosa dobbiamo avere imparato dopo
tanta sofferenza. Intanto leggo che il prete in questione, dopo aver rinunciato a un
incarico che il suo vescovo intendeva affidargli, era tornato in famiglia e non dava più
notizie da mesi. Qualcosa di strano, dunque, si notava già, perché nessun prete può
sparire all’improvviso né rimanere senza incarichi. Egli deve dar conto al suo vescovo e
alla diocesi di ogni spostamento. Non siamo meteore impazzite. Siamo un presbiterio, un
corpo, una famiglia. Nessuno lavora in proprio né si sceglie il posto. Cosa faceva questo
confratello, originario di Agrigento e ordinato a Cosenza, a Napoli? Occorre essere più
severi verso i preti che hanno difficoltà a camminare in comunione con la propria diocesi.
La misericordia, da esercitare sempre e verso tutti, deve andare di pari passo con la
fermezza, la prudenza, la giustizia. Bisogna riconoscere che tante fatiche pastorali di
molti preti coscienziosi e trasparenti vengono neutralizzate da notizie come questa.
Bisogna ammettere che, immediatamente dopo la giovanissima vittima, siamo noi
sacerdoti a pagare le conseguenze di questi odiosi peccati e reati. Notizie come questa ci
gettano nello sgomento e nell’imbarazzo di fronte alle comunità parrocchiali e civili.
Questo non è giusto. Il dramma dei preti pedofili deve finire. La bacchetta magica non la
possiede nessuno. Chi, però, sa di portare dentro problemi irrisolti deve trovare l’onestà
e il coraggio di lasciarsi aiutare prima di fare guai. Qualche segnale queste persone
problematiche lo danno sempre. Occorre coglierlo. È giunto il momento di discutere di
queste cose tra noi, con i vescovi e i fedeli, con più coraggio e parresia e smetterla di
definire 'fragilità' quelle che sono patologie da curare. Iniziamo dai seminari, da quei
luoghi benedetti dove i giovani chiedono di entrare perché la loro presunta vocazione
venga sottoposta a seria e reiterata verifica da parte di superiori ed esperti. Per la
formazione dei futuri preti, le diocesi debbono investire il meglio delle risorse e del
personale, perché si possa fare vero discernimento. Per capire se il postulante è
chiamato alla castità, se intende servire Cristo nei poveri e nella Chiesa, se ha raggiunto
un equilibrio psico-affettivo. Per cercare di capire se chi entra in seminario lo fa perché il
fuoco divino gli divora il cuore oppure pensa - anche inconsciamente - di risolvere o
camuffare problemi personali. È difficile. Perciò insegnanti, psicologi, parroci, direttori
spirituali hanno bisogno di lavorare insieme, sotto la guida dello Spirito Santo e del
vescovo. Valutando chi può continuare il cammino e chi no. Ai seminaristi non va
nascosto che gli verrà chiesto molto e che nessuno più è disposto a perdonare certi
odiosi peccati. La gente al prete consegna il cuore che va curato, custodito, amato e mai
maltrattato o tradito. Meglio chiudere le parrocchie per mancanza di preti che affidare a
persone problematiche, fattesi ordinare con l’inganno, parte del popolo di Dio.
CORRIERE DELLA SERA
Pag 17 L’invito del Papa ai leader religiosi: denunciare la violenza in nome di
Dio di Gian Guido Vecchi
Colombo (Sri Lanka) L’accoglienza è stupefacente, i colori, i bambini, i tamburi e le
danze tradizionali, una quarantina di elefanti bardati a festa che sollevano le proboscidi
al passaggio della papamobile, centinaia di migliaia persone di varie fedi lungo i trenta
chilometri dall’aeroporto alla nunziatura in un paese dove i cattolici sono il 7,2 per cento
e prevalgono buddisti (70 per cento della popolazione), induisti (12,6) e musulmani
(9,7). Francesco torna in Asia, «culla delle religioni del mondo», nel viaggio che dopo lo
Sri Lanka lo porterà nelle Filippine, e arriva subito al punto: «Per il bene della pace, non
si deve permettere che le credenze religiose vengano abusate per la causa della violenza
o della guerra. Dobbiamo essere chiari e non equivoci nell’invitare le nostre comunità a
vivere pienamente i precetti di pace e convivenza presenti in ciascuna religione e
denunciare gli atti di violenza quando vengono commessi». Il volo Az 4000 atterra alle
4,22 della notte italiana, dopo avere sorvolato tra gli altri i cieli dell’Iran (con
telegramma di Bergoglio dall’aereo all’ayatollah Ali Khamenei: «Le assicuro le mie
preghiere per la nazione e il suo popolo, invocando su di lei le benedizioni
dell’Onnipotente di pace e prosperità»), in un paese che ha conosciuto gli «orrori» di
trent’anni di guerra civile tra singalesi e tamil. Il Papa dice d’essere «convinto» che le
religioni abbiamo «un ruolo essenziale» per «promuovere «riconciliazione, solidarietà e
pace». Anche prima della partenza, parlando ai diplomatici, aveva contrapposto gli
«orrendi massacri» del fondamentalismo che «rifiuta Dio stesso, relegandolo a un mero
pretesto ideologico» alla «fede sincera, che apre all’altro». Ma per questo «bisogna che
tutti lavorino assieme e abbiano voce», scandisce ora. Le condizioni sono la libertà
religiosa e l’ascolto reciproco: «Tutti devono essere liberi di esprimere le proprie
preoccupazioni, le proprie aspirazioni e paure. Ma soprattutto devono essere pronti ad
accettarsi l’un l’altro, a rispettare le legittime diversità ed imparare a vivere come
un’unica famiglia». Il vento dall’oceano non mitiga il caldo dell’«isola splendente»: dopo
il viaggio notturno e un’ora nell’auto sotto il sole a salutare la folla, Francesco è provato
e salta il pranzo con i vescovi locali per riposare un poco prima dell’incontro con i leader
delle altre religioni. Il coro di benedizione dei buddisti, uno scialle giallo posato sulle
spalle del Papa dal rappresentante induista, il musulmano che parla di pace. E Francesco
che ricorda come nel Concilio la Chiesa abbia dichiarato che «nulla rigetta di quanto e
vero e santo nelle altre religioni». L’importante è che tutti siano chiari, però. Niente
equivoci: «Come insegna l’esperienza, perché tale dialogo ed incontro sia efficace, deve
fondarsi su una presentazione piena e schietta delle nostre rispettive convinzioni»,
spiega Bergoglio. «Certamente tale dialogo farà risaltare quanto siano diverse le nostre
credenze, tradizioni e pratiche. E tuttavia, se siamo onesti nel presentare le nostre
convinzioni, saremo in grado di vedere piùchiaramente quanto abbiamo in comune.
Nuove strade si apriranno per la mutua stima, e anche amicizia».
LA NUOVA
Pag 8 Bergoglio e le mosse anti-Islam di Orazio La Rocca
«Anche in Asia si deve andare. Benedetto XVI non ha avuto tempo di farlo. Per questo è
importante che io vada nello Sri Lanka e nelle Filippine, dove sono stato invitato». A
poche ore dalla storica marcia degli oltre due milioni di francesi che, insieme a una
cinquantina di capi di Stato e di governo, domenica scorsa hanno detto no al terrorismo
islamico, papa Francesco questa mattina sbarca a Colombo, nello Sri Lanka, per un
pellegrinaggio internazionale - il settimo del suo pontificato, il terzo in Oriente dopo
Terra Santa e Corea del Sud - che lo porterà anche nelle Filippine, da dove rientrerà in
Vaticano il 19 prossimo. Un viaggio denso di attese e di significato che - benché
programmato da mesi - va naturalmente ad inserirsi nello spirito della manifestazione
parigina in materia di condanna senza se e senza ma di ogni forma di violenza che punta
a stroncare il dialogo e l’incontro tra civiltà diverse, differenti modi di pregare e di vivere
la fede. Tematiche, tra i punti cardini del pontificato di papa Bergoglio, che saranno
certamente al centro anche di questo settimo viaggio pontificio nei due importanti Paesi
asiatici dove le comunità cristiane e cattoliche da sempre convivono, tra problemi e
difficoltà, con altre realtà religiose a partire dall’islam. Fu lo stesso papa Francesco a
preannunciare il suo terzo pellegrinaggio in Sri Lanka e Filippine lo scorso anno
sull’aereo di ritorno dalla Giornata Mondiale della gioventù del Brasile. «Devo andare in
Asia perché papa Benedetto non ha potuto farlo», specificò rispondendo ai giornalisti. «È
giusto che io vada», aggiunse, come a voler dimostrare che le Chiese periferiche hanno
sempre e comunque un posto privilegiato nel cuore del successore di Pietro.
Specialmente in momenti come questi, con milioni di cristiani costretti a subire violenze
e massacri. Ma anche di fronte a nuove vittime innocenti come i redattori della rivista
satirica francese Charlie Hebdo, la comunità ebraica parigina, gli oltre 2 mila morti
ammazzati dalla furia fondamentalista sedicente musulmana in Nigeria. Di fronte a tanto
dolore, papa Francesco ha sempre risposto con la preghiera per le vittime e con l’invito
al dialogo e all’incontro, senza pronunziare mai parole di vendetta, promuovendo
sempre e ovunque la Chiesa madre dei poveri, vicina agli ultimi, con tenerezza e
misericordia, senza operare distinzioni tra religioni differenti o scelte politiche di colore
diverso. Scelte pastorali che all’inizio del nuovo anno hanno trovato spazio anche nella
nomina di tre nuovi cardinali creati per rafforzare la presenza della Chiesa in Oriente e
rispondere sul piano pastorale alle insidie del fondamentalismo. Le tre nuove porpore
asiatiche fanno parte dei 20 cardinali che saranno creati nel Concistoro del 14 febbraio
prossimo e che nel Collegio cardinalizio faranno incrementare il peso delle Chiese
periferiche. Comunità composte anche da poche migliaia di fedeli, come Tonga, isola
dell’arcipelago dell’Oceano Pacifico, dove i cattolici sono appena 14 mila, per i quali
Francesco ha elevato alla dignità cardinalizia monsignor Soane Patita Paini Mafi, primo
porporato di Tonga che con i suoi 53 anni sarà il più giovane membro del Collegio
Cardinalizio. Tra i 15 elettori, altrettanto significative le nomine del vietnamita Pierre
Nguyen, arcivescovo di Hà Noi, del birmano Charles Maung Bo, salesiano, arcivescovo di
Yangon, e del tailandese Francis Xavier Krieng-sak Kovithavanij, arcivescovo di
Bangkok. Monsignor Maung Bo è il primo cardinale birmano, un paese dove
notoriamente i diritti umani non godono di ottima salute. Non meno importante il ruolo
assegnato ai neo porporati di Nuova Zelanda, Etiopia, Uruguay, Panama, Messico,
esortati da Francesco ad essere sempre più vicini alle istanze dei poveri delle loro terre.
Esortazioni che non è azzardato immaginare che saranno rilanciate da papa Francesco
anche nel viaggio in Sri Lanka e Filippine. Senza farsi condizionare da prudenze
diplomatiche e prassi curiali. Anche questa è rivoluzione. Rivoluzione bergogliana.
Pag 11 “Libertà e credo religioso, il problema ora esiste” di Claudio Baccarin
Il dibattito nella Chiesa del Nordest
Padova. «Per la prima volta nella storia le civiltà, le religioni e i popoli si confrontano, ma
ci accorgiamo di essere ancora privi di un vocabolario relazionale. Per ascoltarsi e capirsi
non basta essere insieme nello stesso luogo e nello stesso momento». Don Giovanni
Brusegan, delegato vescovile per l’Ecumenismo e per la Pastorale della cultura e
dell’università della Diocesi di Padova, s’interroga, dopo le stragi di Parigi, sul rapporto
tra libertà di espressione (e in particolare di satira) e rispetto del credo religioso. «In
realtà», sottolinea don Brusegan, «si tratta di un nervo scoperto, assai fragile, all’interno
di una corretta concezione democratica. Il problema esiste se vogliamo coniugare una
vita democratica con la libertà religiosa. Il bilanciamento creativo tra questi due aspetti
è fondamentale; serve pertanto un’educazione responsabile. Anche la libertà può
diventare una violenza e suscitare violenza se non si pone il limite del rispetto dell’altro.
Il cristianesimo, che certo in passato ha fatto degli errori, si trova a confrontarsi con
civiltà che hanno compiuto ben altri processi. Ogni civiltà ha il diritto di esistere, ma ora
abbiamo tutti bisogno di una capacità di lettura più valorialmente fondata». Per don
Brusegan un ruolo fondamentale è affidato al mondo dell’informazione: «Un tempo
ognuno leggeva la sua rivista preferita. Oggi, con la massmediatizzazione
dell’informazione, le notizie si approcciano a ciascuno di noi. Non è vero che le persone
possono selezionare i messaggi; le notizie ci aggrediscono, il lettore-consumatore viene
sedotto. C’è quindi l’esigenza di un pluralismo, ma nel rispetto dei valori plurali».
Secondo don Bruno Cescon, direttore dell’ufficio Comunicazioni sociali e direttore
responsabile del settimanale Il Popolo, della Diocesi di Concordia-Pordenone, «la libertà
religiosa richiede sempre, come scrive Max Weber, autore molto noto fra i laici, un
esercizio responsabile. La responsabilità riguarda sempre il rispetto per ciò in cui
credono le persone: un confine alla libertà è dato dal valore delle persone stesse. È
logico che non si possa reagire, allo scherno e alla ridicolizzazione dell’esperienza
religiosa, uccidendo delle persone. Uccidere è un assurdo e una pazzia, tanto più se la
violenza brutale degli uomini pretende d’invocare Dio». Per don Cescon, «è lecito invece
reagire in modo democratico a qualsiasi forma di disprezzo del contenuto ideale delle
persone. Purché questo contenuto non sia offensivo della dignità umana. Il credo
costituisce per le persone, e questo non va sottovalutato, una ragione della propria
identità. Ovviamente va ancora una volta sottolineato che la cultura non deve
ammettere come possibile la sospensione della vita di altre persone. In fondo civiltà è
mettere in pratica l’assioma universale “non uccidere”. Ma si eviti, talvolta, di uccidere
con le parole». Sul rapporto tra libertà di satira e rispetto del credo religioso ha preso
posizione, in un editoriale pubblicato domenica, anche don Sandro Vigani, direttore
responsabile di Gente veneta, settimanale della Diocesi di Venezia. «Condanniamo senza
“ma “ e senza “se” le terribili stragi di Parigi; condividiamo l’indignazione delle centinaia
di migliaia di persone che, in tutto il mondo, hanno manifestato la propria partecipazione
alla Francia per quanto è accaduto». Tuttavia, sottolinea don Vigani, «noi non siamo
Charlie. Se nel giornale la satira mette alla berlina il mio Dio, quello per il quale, assieme
a milioni di altri cittadini del mondo, cerco di vivere la mia vita, io soffro e con me parte
della società costituita dai miei fratelli di fede. La satira, allora, rispetta la mia libertà di
persona e la dignità di quella parte della società? Oppure alimenta quell’intolleranza
contro la quale dice di voler combattere?».
Torna al sommario
5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO
AVVENIRE
Pag 3 Le nuove assunzioni in Fiat, primo test per il Jobs act di Leonardo Becchetti
Come sta cambiando il mercato del lavoro in Italia
Il nuovo anno è partito con una notizia importante per l’industria e il mondo del lavoro:
la Fiat-Chrysler che annuncia mille nuovi posti di lavoro nello stabilimento di Melfi, per
far fronte alle esigenze del mercato. Le assunzioni non beneficiano ancora delle norme
(e degli incentivi) del Jobs act, ma l’aggancio dovrebbe avvenire quando il
provvedimento sarà in vigore (proprio ieri il governo ha trasmesso alla Camera i due
decreti attuativi, quello sul contratto a tutele crescenti e sulla riforma degli
ammortizzatori sociali, ndr). Anche alla luce di questo segnale è forse il caso di porsi una
domanda: quale potrà essere, concretamente, l’impatto del Jobs act sul mercato del
lavoro italiano e sul nostro elevato tasso di disoccupazione? Proviamo a capirlo
analizzando quattro diversi casi. Nel primo ipotizziamo che il datore di lavoro si aspetti
una domanda di lavoro temporanea e le sue aspettative saranno confermate dai fatti.
Nel vecchio scenario avrebbe usato una tra le varie forme contrattuali a tempo
determinato mentre nel nuovo potrebbe optare per il nuovo contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti reso in molti casi più vantaggioso del primo per gli
sgravi fiscali all’assunzione e per la possibilità di licenziamento individuale con
indennizzo contenuto (due mesi di stipendio pieno per ogni anno di lavoro). Nel secondo
caso il datore di lavoro si aspetta una domanda di lavoro temporanea, ma è smentito dai
fatti perché le condizioni del mercato migliori di quelle attese la trasformano in domanda
permanente. Nel vecchio scenario avrebbe dovuto non rinnovare il vecchio contratto a
tempo determinato trasformandolo in uno a tempo indeterminato. Nel nuovo scenario si
tiene il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti con qualche piccolo vantaggio
in termini di costi di transazione non dovendo rinegoziare la forma contrattuale. Il terzo
scenario è quello in cui l’attesa è per una domanda di lavoro permanente che si rivela
tale. In questo caso il contratto sarebbe stato a tempo indeterminato (con possibilità di
reintegro in caso di licenziamento) nel vecchio scenario e diventa a tempo indeterminato
con tutele crescenti nel nuovo scenario (e possibilità di reintegro solo per licenziamenti
discriminatori e disciplinari ove il giudice verifichi l’insussistenza della motivazione). Il
quarto scenario è quello di un’aspettativa di domanda di lavoro permanente che invece
si trasforma per un peggioramento inatteso della situazione di mercato in una necessità
di lavoro temporanea. In questo caso nel vecchio scenario il datore di lavoro si trova
bloccato dal rischio di reintegro mentre nel nuovo caso avrà la possibilità di licenziare
per motivi economici pagando un indennizzo a chi era stato assunto con il contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti. Possiamo pertanto aspettarci una significativa
sostituzione di contratti a tempo determinato con contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti nel primo e nel secondo scenario e una maggiore flessibilità del datore di
lavoro nel prendere decisioni sulla propria manodopera (soprattutto nel secondo e nel
quarto scenario in cui il quadro di mercato si rivela diverso dalle aspettative). Le quattro
situazioni prospettate ci dicono anche che l’effetto sul saldo totale dell’occupazione
dovrebbe essere modesto. La maggiore flessibilità di movimento del datore di lavoro in
alcuni dei casi prospettati si bilancerà con un minor turnover volontario di chi ha i vecchi
contratti. Chi prima aveva valutato l’opportunità di cambiare lavoro infatti ci penserà due
volte, per evitare di dover perdere sicurezze e passare al nuovo contratto. Poiché una
parte importante dei guadagni di produttività nel sistema avviene attraverso i
trasferimenti da un posto di lavoro ad un altro si tratta di un handicap che gli estensori
della legge dovrebbero provvedere a correggere in qualche modo. Ad esempio con la
portabilità del contratto per i lavoratori già assunti anche se questo aumenterebbe le
disparità con i nuovi. Sappiamo bene in realtà che la creazione di posti di lavoro dipende
in larga parte da fattori diversi dalle caratteristiche del contratto. Francesco Daveri ha
ricordato sul Corriere della Sera qualche giorno fa quello su cui battiamo da tempo,
ovvero che il primo fattore che colloca il nostro paese molto indietro nella classifica di
quelli in cui fare impresa è quello dei tempi della giustizia civile, quasi tripli rispetto alla
media europea. È su questo tasto che il governo dovrebbe mostrare i suoi muscoli. Oltre
agli aspetti di sistema paese i fattori macroeconomici hanno un peso preponderante nel
determinare i saldi occupazionali come dimostra la politica americana post crisi
finanziaria confrontata con quella dell’Ue. Politiche monetarie e fiscali fortemente
espansive da un lato e via del 'rigore espansivo', dall’altro hanno fatto la differenza di
diversi punti del tasso di disoccupazione decidendo i destini di milioni di persone dai due
lati dell’oceano. Il lato sicuramente migliore del Jobs act è il passo avanti verso un
sistema con un sussidio universale di disoccupazione e un reddito minimo di cittadinanza
attraverso Naspi, Asdi e Disc-coll (ovvero i sussidi per chi è licenziato, il reddito per chi
versa in condizioni di povertà alla scadenza del sussidio e l’introduzione di un primo
parziale sussidio anche per i lavoratori precari che perdono il lavoro). La rete di
protezione sarebbe potuta essere più robusta se ad essa fossero stati destinati gli 80
euro. Il Jobs act appare dunque essenzialmente come una razionalizzazione da un
vecchio sistema dove gli alti costi di assunzione e licenziamento implicati dai vecchi
contatti a tempo indeterminato erano aggirati dalle imprese accedendo alla giungla delle
varie forme a tempo determinato (e il trattamento dopo la perdita di lavoro era
fortemente discriminante tra chi aveva accesso alla cassa integrazione e chi no) verso
un modello dove il contratto unico a tutele crescenti dovrebbe sostituire quelli a tempo
determinato. Dal lato del lavoratore il cambiamento sul posto di lavoro è più psicologico
che reale perché la precarietà del contratto a tempo indeterminato non è poi molto
diversa da quella del contratto a tempo indeterminato con tutele crescenti. Può certo
sperare di convincere col tempo il suo datore di lavoro di 'essere la persona giusta', ma
purtroppo il successo del matrimonio tra un lavoratore e l’impresa non dipende solo dalle
sue doti, ma molto più dalle condizioni di mercato. Il successo dell’impegno del governo
sugli altri fronti sarà decisivo per rendere più propizia possibile la nuova era che inizia
col Jobs act.
LA NUOVA
Pag 23 Economia, segnali di ripresa per il 2015 di Gianni Favarato
I dati del report provinciale: nell’ultimo anno si è ridotto il numero delle procedure di
crisi aziendale, dei lavoratori in mobilità e dei cassintegrati
La crisi economica continua ad imperversare, ma in provincia di Venezia va un po’
meglio o meno peggio, che dir si voglia. Gli ultimi dati dell’agenzia Veneto Lavoro –
aggiornati a novembre 2014 – confermano un andamento «stabilmente negativo» del
numero di procedure di crisi aziendali aperte (1.307 in tutto) e di lavoratori coinvolti
(35.622) con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Se guardiamo, però, ai dati veneziani
relativi al periodo gennaio-novembre 2014 – forniti dalla rete dei Centri per l’Impiego al
Servizio delle Politiche Attive del Lavoro nei 44 comuni della Provincia di Venezia – si
nota che dopo aver «toccato il fondo» della crisi cominciata nel 2008, si comincia a
vedere una evidente riduzione del numero delle crisi aziendali avviate e delle ore di
cassa integrazione. Una tendenza che se fosse confermata nei prossimi mesi potrebbe
finalmente indicare una inversione di rotta della crisi cominciata nel 2008. Il report
fornito dall’Ufficio Vertenze Collettive della Provincia di Venezia conferma, infatti, che tra
gennaio e novembre del 2014, sono state concluse 263 pratiche di crisi aziendali, con
una riduzione del 18% in meno rispetto al medesimo periodo del 2013 che ne aveva
registrate 320. Anche il numero di lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali (5.529
in tutto) è calato – tra gennaio e novembre 2014 – del 16% . Sostanzialmente
stazionario è invece il numero di iscritti alle liste di disoccupazione dei Centri per
l’Impiego provinciali (26.577 tra gennaio e novembre di quest’anno a fronte dei 28.970
del 2013 e dei 25.905 del 201). Osservando le singole tipologie di ammortizzatori sociali
richiesti, si nota un calo del ricorso alla cassa integrazione straordinaria (cigs e contratti
di solidarietà) e delle mobilità, rispettivamente del -18% e del -14%. I settori più
coinvolti per numero di pratiche concluse sono metalmeccanica (85 pratiche concluse),
edilizia (27) e commercio (23). Il numero dei lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori
sociali, si concentra nei settori più colpiti, ovvero: il metalmeccanico (1.908 lavoratori),
commercio (695) e edilizia (533). Va detto, in ogni caso – come puntualizzato dal
servizio per le politiche attive per il lavoro della Provincia ora commissariata – il ricorso
ai cosiddetti ammortizzatori misti (cigs e mobilità) è cresciuta, ma va aggiunto che solo
le pratiche relative a due specifiche aziende e al 55 % di ammortizzatori misti, l’handler
aeroportuale Ata Italia e la Pancas International srl. Le motivazioni che spingono le
aziende a ricorrere agli ammortizzatori sono per il 40% di aziende «la crisi di mercato»,
per il 18%, il «fallimento» per il 17%, l’8% per cessata attività, il 7% per la chiusura di
un ramo aziendale, il 6% «per necessità di ristrutturazione e riorganizzazione interna»
ed il 3% per termini chiusura del lavoro in appalto. Il numero dei lavoratori sospesi dalle
aziende – in conseguenza del ricorso con il ricorso alla cassa integrazione (cigs) o alla
mobilità – che tra gennaio e novembre del 2013 erano stati 6.545, nello stesso periodo
del 2014 si sono ridotti a 5.529. Insomma, una luce in fondo al tunnel si vede e
potrebbe aprire una fase più positiva e incoraggiante grazie soprattutto alle ripresa delle
produzioni per l’export (+ 17,6 %) e al turismo balneare e culturale che la stessa
Confindustria veneziana ha evidenziato nel suo ultimo report.
Nel solo mese di novembre hanno firmato la Did (dichiarazione di disponibilità
immediata ad un lavoro) per l’inserimento nelle liste di disoccupazione dei Centri per
l’Impiego (Cpi) della provincia di Venezia, 4.201 persone. In tutto, tra gennaio e
novembre dell’anno scorso, le iscrizioni alle liste dei disoccupati sono state 26.577, delle
quali 5.758 riguardano giovani sotto i 25 anni, ben 12.780 di uomini e donne con un’età
tra i 26 e i 45 anni, mentre gli over 45 sono 8.039. Rispetto al novembre del 2013, c’è
stato un aumento del +44%. «Osservando l’andamento del 2014 mese per mese e
rapportandolo ai medesimi mesi dell’anno 2013 – spiegano i tecnici del Servizio Politiche
Attive del Lavoro della Provincia –, si nota che non c’è un trend né di calo, né di rialzo
dei disoccupati. Infatti, ci sono i mesi in cui il numero delle Did è inferiore rispetto al
2013 (gennaio, marzo, giugno, luglio, agosto, settembre) e ci sono i mesi in cui è
superiore (febbraio, aprile, maggio, ottobre, novembre)». Per valutare il trend generale
si deve, piuttosto, osservare l’andamento del cumulativo (gennaio-novembre) nel corso
degli anni. Solo nell’anno 2013, infatti il numero delle Did rilasciate (pari a 27.120 iscritti
nelle liste di disoccupazione tra gennaio e novembre) era superiore rispetto al 2014 (pari
a 26.577 unità). Si tratta, dunque, di una variazione positiva con una riduzione delle
persone in cerca di un lavoro pari al -2%. Confrontando, però, il numero dei disoccupati
iscritti alle liste tra gennaio e novembre del 2014 e confrontandoli con quelli degli anni
precedenti, si riscontra un aumento delle persone che cercano un lavoro. Nel 2014,
rispetto al 2008 (quando erano 17.965 ) gli iscritti alle liste che hanno firmato il modello
Did sono aumentati del +70%. Il maggior numero di disoccupati in cerca di lavoro tra
gennaio e novembre 2014 (32%) si è rivolto al Cpi Venezia-Mestre, il 23% al Cpi di San
Donà-Jesolo, il 14% a Portogruaro, il 12% a Mirano, l’11% al a Dolo e l’ 8% a ChioggiaCavarzere.
Sos dei sindacati dei chimici di Cisl e Uil per il rischio di vedere chiudere definitivamente
a Porto Marghera – dopo la sfilza di chiusure di fabbriche chimiche e siderurgiche –
anche la storica azienda che produce vetri speciali, Pilkington. «Ad oggi abbiamo
un’unica certezza – scrivono i sindacati in una lettera aperta inviata al prefetto,
Domenico Cuttaia –, mancano pochi mesi al termine del terzo anno di contratti di
solidarietà. Per il resto nulla». «Le Istituzioni locali dopo una blanda discussione –
scrivono ancora i sindacati al Prefetto – non si sono più fatte sentire e il ministero dello
Sviluppo che doveva riconvocare le parti ogni 6 mesi per un monitoraggio della
situazione, sembra scomparso. A questo si deve aggiungere la mancanza di segnali da
parte dell'azienda che confermi l'importanza e la strategicità del sito locale». Nessuna
prospettiva di ritornare al lavoro è stata prospettata, infatti, presentata ai 170
dipendenti dell’azienda controllata dalla multinazionale giapponese Ngs e, inoltre, visto
che l'ultima legge di Stabilità non ha rifinanziato al 70% il fondo per i contratti di
solidarietà, con la prospettiva «di ulteriori difficoltà di garantire un reddito a questi
lavoratori per sostenere le loro famiglie». «Per tutti questi motivi – conclude la lettera
aperta dei sindacati che hanno scritto anche al ministero dello Sviluppo – confidando
nella sensibilità da lei espressa e dimostrata sino ad ora dal Prefetto nelle vertenze che
hanno interessato il mondo del lavoro e visto l'imminente incontro con il responsabile
europeo del comparto edilizia di Nsg-Pilkington, siamo a chiederle un urgente incontro
con tutte le parti interessate».
Torna al sommario
7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA
CORRIERE DEL VENETO
Pag 11 In laguna corsa al divorzio facile, in una settimana 50 richieste di Alice
D’Este
L’avvocato: tribunali alleggeriti. Il sacerdote: più complicato ripensarci. Paolo e Lucia, la
decisione dopo dieci anni di vita separata: “Due incontri allo sportello e 16 euro, non
potevo crederci”
LA NUOVA
Pag 18 Venezia, omissioni e nomine tra il sacro e il profano di Franco Miracco
Sì, Venezia, se intesa come sede patriarcale, non si trova nell’elenco delle prossime
elevazioni al cardinalato. Non è dato sapere se accadde qualcosa nella Venezia marciana
al tempo del cardinale Scola, che si congedò da patriarca secondo ispirazioni inconsuete,
e se quel qualcosa sia stato poi oggetto di particolari considerazioni vaticane.
Comunque, il patriarca Moraglia certamente è a conoscenza che, per esempio, all’inizio e
al termine della magnifica e, per vari motivi, eroica impresa della costruzione della
Salute ci furono due patriarchi - Giovanni Tiepolo e Alvise Sagredo - mai nominati
cardinali. Addirittura, il Sagredo, quando il Senato della Repubblica lo nominò patriarca,
non era nemmeno prete, lo divenne subito dopo e fu un buon patriarca;mentre Giovanni
Tiepolo fu per davvero una “personalità esemplare della vita religiosa della Venezia
seicentesca”. Dunque, l’imporporarsi da patriarca sarà pure significativo, ma il patriarca
di Venezia è pur sempre il patriarca di una chiesa più che millenaria e che, più volte, con
porpora o senza porpora, contribuì ad esaltare il “mito” di Venezia. Se da una parte
Roma nega, almeno per il momento, dall’altra alcune menti profane non distratte hanno
notato gli importanti riconoscimenti giunti da Roma a due “servitori dello Stato”che bene
hanno operato a Venezia e nel Veneto, ma non solo. Caterina Bon Valsassina, a seguito
della più recente riforma del ministero per i Beni e le Attività culturali, è stata posta dal
ministro Franceschini al vertice della Direzione generale educazione e ricerca, che è
servizio da inventare e di cui,stando al titolo, indubbiamente c’è molto bisogno, se si
vuole dare vigore e senso agli studi storico-artistici e a ciò che occorre per rifondarli. Ma
la Bon Valsassina - da anni risiede Venezia - è una storica dell’arte che si è formata
validamente a Firenze e che nel 2009 ha diretto la Soprintendenza speciale per il polo
museale veneziano(Gallerie dell’Accademia ecc.). Il suo breve impegno è però servito a
dar vita al progetto di qualificazione e organizzazione di strutture e obiettivi destinati a
creare le nuove, rinnovate, ripensate, anche restaurate Gallerie dell’Accademia. Forte
della non facile esperienza veneziana, non a caso la Bon Valsassina viene chiamata a
Milano, dove, da tempo immemore, si attende di adeguare gli standard museali della
Pinacoteca di Brera a quanto ci si aspetta per uno tra i più preziosi e tormentati musei
del mondo. La lunga storia professionale della nuova direttrice generale è così fitta di
esperienze sul campo e di meriti scientifici che, forse,per riassumerla in un solo capitolo
è sufficiente ricordare che la Bon Valsassina ha diretto per nove anni l’Istituto Centrale
per il Restauro, tra i piú riconosciuti primati italiani nel settore. In quel periodo, la nostra
“veneziana acquisita” seguì i cantieri per il restauro impossibile degli affreschi della
Basilica Superiore di Assisi e quelli della Torre di Pisa e della Fontana del Bernini a Piazza
Navona. Chi, invece, è nato in Veneto e ha operato ottimamente nella nostra regione in
qualità di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto è Ugo
Soragni, architetto con forti vocazioni storico-artistiche. È diventato Direttore generale
dei Musei. Con Soragni si è di fronte a un dirigente ministeriale che ha attraversato nelle
sue tante “missioni” l’Italia da sud a nord: dalla Puglia alle Marche, dal Friuli Venezia
Giulia al Veneto, e, ogni volta, attivando progetti e procedure secondo quanto previsto
dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tra l’altro, Soragni non ebbe vita facile
durante la giunta Orsoni, riuscendo comunque a dare contributi decisivi volti a impedire
il grottesco progetto della cosiddetta Torre Cardin, oppure nel riordino della devastante
“politica” delle megapubblicità a Piazza San Marco e dintorni o nell’aspro confronto sul
discutibilissimo passaggio in Bacino delle Navi incompatibili. Per concludere, come si
vede, all’interno delle strutture pubbliche ci sono energie, saperi e competenze in grado
di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione. Inoltre,
le nostre Università riescono ancora a fornire storici dell’arte o architetti capaci di
entrare con merito e passione nei ranghi della Pubblica amministrazione. Al contrario, la
nuova riforma del Ministero, si pone, mediante bando internazionale, alla ricerca di
figure esterne, di manager esperti in gestione museale, eccetera eccetera. Ma costoro
(chissà che stipendi pensano di poter ottenere?) saranno portati, è ovvio, a imitare i
modelli privati in tutto e per tutto, avendo però ricevuto dallo Stato appena gli occhi per
piangere. Di qui il pericolo di pasticci mortificanti destinati a umiliare gli Uffizi, Brera,
Capodimonte, nonché le Gallerie dell’Accademia. Per intenderci: i tanto auspicati
manager potranno pure fare mostre sull’esempio, si fa per dire, di “Pinturicchio, Van
Gogh passando per Tutankhamon” o “Da Tiziano a Paperino”, ma, se lo faranno, sarà
solo sulla pelle di ciò che “metteranno in vendita” agli Uffizi o a Brera o alle Gallerie
dell’Accademia. Oimè, la Venezia in cui viviamo e che non vogliamo é proprio quella del
“mettersi in vendita”.
IL GAZZETTINO DI VENEZIA
Pag XVI Mira si attiva per i tre fratelli di Luisa Giantin
«Siamo al corrente della situazione». L'assessora alle Politiche sociali Francesca Spolaor
conosce personalmente uno dei tre fratelli e ammette che i servizi sociali sono al
corrente della situazione di Luca, Roberto e Albano Fabris, i tre fratelli di Mira che da
qualche tempo vivono per strada e dormono al freddo in un garage. «Purtroppo l'alloggio
per soli uomini a Mira è completo - spiega Spolaor - e tra padri separati e persone in
gravi difficoltà economiche non riusciamo a far fronte alla situazione. Per i tre fratelli
stiamo cercando una soluzione idonea, ma non è facile». In parrocchia a San Nicolò le
condizioni in cui vivono i Fabris la conoscono bene, come hanno raccontato loro stessi
ieri. «La situazione dei tre fratelli è complessa - spiega don Gino Ciccutto, parroco a S.
Nicolò di Mira - Non conosco la loro storia nei dettagli perché prima abitavano a piazza
Vecchia ma so che almeno due dei tre fratelli hanno lavorato per qualche tempo e poi
hanno perso il lavoro non solo per problemi legati alla crisi. Al di là dell'aspetto
propriamente economico - afferma il parroco di Mira Taglio - da quando hanno perso la
mamma si sono sentiti smarriti, privati di quella che certamente era la loro guida e la
loro sicurezza. Purtroppo però come parrocchia non possiamo fare molto. Da tempo li
abbiamo inseriti all'interno di un progetto parrocchiale che prevede il sostegno a un
centinaio di famiglie della zona. Ogni quindici giorni forniamo loro una borsa della spesa
con generi alimentari ma purtroppo i tre fratelli non hanno neppure un posto dove poter
cucinare e quindi possiamo fornire loro solo cibi secchi. Purtroppo le necessità sono tante
e noi facciamo ciò che possiamo, magari facendo rete con Caritas e Comune. So ricorda don Gino - che era stato proposto loro di alloggiare almeno per qualche
settimana, nel periodo più freddo, nella casa alloggio di Marghera, ma hanno rifiutato».
La Caritas invece, nella Casa di San Raffaele in via Riscossa a Mira dove Luca, Albano e
Roberto hanno chiesto di andare, ospita per la notte sono extracomunitari. «Purtroppo
siamo strutturati così - spiega Francesco Vendramin - svolgiamo un servizio di prima
accoglienza per persone straniere di sesso maschile e comunque al momento non
avremmo neppure posto, anche volendo. In realtà, in accordo con il Comune, ospitiamo
una volta a settimana un mirese che utilizza le nostre strutture per lavarsi e non si
ferma a dormire. A Mestre c'è il dormitorio e se c'è la volontà tutto si può fare».
Pag XXI Un milione di persone per il presepe di sabbia di Giuseppe Babbo
Jesolo: record di presenze nelle varie edizioni con i quasi centomila visitatori di
quest’anno
Abbattuto il muro di un milione di presenze. È il risultato ottenuto dal presepe di sabbia
di piazza Marconi che domenica scorsa ha registrato 5.283 visitatori. Quanto è bastato
per superare i 90.024 visitatori di questa edizione e oltrepassare così il numero di un
milione complessivo di presenze registrate in tutte le edizioni della mostra. Un grande
risultato per l’iniziativa organizzata dal Comune che potrebbe, visto che alla chiusura di
Sand Nativity mancano ancora più di due settimane (ultimo giorno utile per visitarla il 1.
febbraio), diventare quella dei record assoluti. Tra le giornate con più visitatori va
segnalata quella del 4 gennaio, quando in coda si sono messi ben 8.026 visitatori.
Numeri che se da una parte confermano l’alto gradimento che continua ad ottenere
questa mostra, dall’altra dimostrano anche la continua capacità attrattiva della città che
anche nei mesi invernali, nonostante comunque le poche presenze negli alberghi,
continua a registrare buone presente tra i turisti pendolari. Ovvero turisti che arrivano in
giornata dalle province limitrofe per concedersi la classica gita al mare. Esattamente
come accaduto anche nello scorso fine settimana, grazie all’evento dei «SaNtimbanchi»
in piazza Drago. «È un risultato che ci aspettavamo - ha commentato il sindaco Valerio
Zoggia - Un obiettivo che è stato centrato e che ora speriamo possa anche portare un
buon incasso in termini di offerte per le cinque associazioni benefiche alle quali abbiamo
deciso di devolvere la somma raccolta. Un grazie, per la bellissima edizione di
quest’anno dedicata a San Giovanni Bosco, va rivolto a tutti gli artisti che hanno lavorato
alle sculture, all’Istituto Salesiano che ci ha supportato, a chi come sempre ha
assemblato il presepe e anche a tutti i collaboratori dell’Amministrazione comunale».
Torna al sommario
8 – VENETO / NORDEST
CORRIERE DEL VENETO
Pag 1 Se la politica arriva a scuola di Massimiliano Melilli
Perché (e come) parlarne
Nelle scuole superiori di questo Paese, l’educazione civica (soprattutto) e la «politica»
rimangono spesso un tabù. Purtroppo è lungo l’elenco di temi e fenomeni di fatto messi
al bando: dal sesso alle unioni gay sino alla geopolitica, una cappa di silenzio avvolge i
programmi didattici. A differenza dell’Europa dove gli argomenti in questione sono pane
quotidiano per docenti e studenti, l’Italia sconta un ritardo incomprensibile. All’istituto
tecnico Ceccato di Thiene, è bastato che un’insegnante di lettere assegnasse la traccia di
un tema ad una classe di terza - «Gli immigrati sono una risorsa, convinci il tuo
compagno leghista», per suscitare una levata di scudi. A partire, comprensibilmente,
dalla Lega, che ha accusato di «fare politica» (di sinistra, naturalmente) in classe a
discapito dell’istruzione e della formazione. Se da un lato la traccia è infelice nella
titolazione - un’altra forma avrebbe azzerato sul nascere reazioni e polemiche - dall’altro
il presupposto del compito appare quasi ovvio. Proviamo a spiegare perché. In un
territorio come il Veneto, centrale rispetto al fenomeno immigrazione, la Lega, fin dalle
origini, ha avuto una posizione molto critica. La storia degli stessi leader del Carroccio
rimanda all’immigrazione stessa. Da Bossi a Gentilini passando per Borghezio e Maroni
già ministro dell’Interno fino a Tosi, Zaia e Bitonci, da anni lo stato maggiore leghista
coniuga in mille modi diversi ma quasi sempre oltranzisti e a volte «pesanti» la parola
immigrazione, rappresentando comunque la sensibilità di una fetta della popolazione.
Dunque interrogarsi sulla natura dei flussi, sul ruolo dei cittadini stranieri fra noi,
immaginare perfino un dialogo con un compagno leghista, non pare uno scandalo. Tutti
temi che peraltro hanno riflessi sulla vita quotidiana. Pertanto, parlarne (e scriverne) in
una scuola superiore, dovrebbe essere «scontato» e far parte organicamente del ciclo di
studi. Non guasterebbe, d’altra parte, anche la tematizzazione del rapporto fra sinistra e
immigrazione, ritenuto da più parti «buonista», nell’ottica di una visione completa del
fenomeno, senza alcun pregiudizio. A parte l’azzardo di qualche coraggioso e preparato
docente che non scade nell’ideologismo, in Italia tutto ciò non esiste. In tale scenario
s’inserisce la vicenda della circolare firmata dall’assessore all’Istruzione Elena Donazzan,
con la quale auspica che le famiglie degli studenti musulmani condannino apertamente
gli attentati terroristici di Parigi. Di più. La Donazzan scrive: «Se non si può dire che tutti
gli islamici sono terroristi, è vero che tutti i terroristi sono islamici». La circolare è stata
inviata ai dirigenti scolastici del Veneto, chiedendo che a scuola si affronti il tema del
terrorismo di matrice islamica. Per converso, giusta o sbagliata che sia la posizione della
Donazzan, vanno respinte e condannate le offese e le minacce rivolte all’assessore dal
sito «La Scienza del Corano», il cui ideatore, Anas Abu Jaffar, vissuto a Belluno, ha
sperimentato l’alto livello di civiltà e la qualità dell’accoglienza. Tutto ciò, comunque, non
può non farci riflettere sulla «radicalità» della circolare della Donazzan se messa a
confronto con l’atteggiamento equilibrato della Francia davanti all’orrore delle stragi di
Parigi. Il ministro all’Istruzione Najat Valland Belkacem, in un incontro con i Rettori, ha
invitato tutti a non mettere sullo stesso piano l’Islam e i fratelli Kouchi, musulmani e
terroristi, fedeli e assassini. Proprio in questa fase così delicata, luoghi comuni e facili
equazioni, ha detto il ministro, offenderebbero la storia e il ruolo della democrazia
francese, da sempre sensibile verso l’immigrazione e le religioni. Ancora. La Belkacem
ha documentato il ruolo fondamentale della comunità musulmana in Francia.
«Nonostante il sangue sparso dai terroristi fondamentalisti – ha detto - non possiamo
cancellare di colpo anni di convivenza pacifica e dare all’islam la colpa di quanto
accaduto».
Pagg 6 – 7 I medici e i miracoli del Santo: “Non c’è prova, la scienza è altro” di
Michela Nicolussi Moro e Renato Piva
Silvio Garattini: “Guarigioni inspiegabili, ma sono soltanto limiti della medicina”. In fila
per l’aiuto ultraterreno, il popolo che invoca e ringrazia
Padova. E’ vero, Sant’Antonio è conosciuto come «il Taumaturgo», ovvero l’operatore di
prodigi. Per il popolo è «il Santo dei miracoli». Il primo l’ha compiuto proprio su se
stesso: era il santo della parola, il frate predicatore, e la sua lingua è stata ritrovata
incorrotta a 32 anni dalla morte, l’8 aprile 1263, quando San Bonaventura, allora
ministro generale dell’Ordine francescano, aprì la cassa contenente le spoglie di Antonio
per spostarle dalla chiesetta di Santa Maria Mater Domini appunto in basilica. Ma la
gente non gli vuole bene «per interesse». Il vero motivo lo sussurra un frate giovane,
nel chiostro della Magnolia interno al santuario di Padova: «Antonio è amato in tutto il
mondo per la sua grande capacità di stare vicino alle persone, di non farle sentire sole.
Forse perché anche lui in vita ha molto sofferto». Prima la malaria, poi la malattia che
l’ha portato in cielo a 36 anni lo rendono più «umano», più simpatico a chi combatte
ogni giorno con un quotidiano difficile. Ecco perché gli ultimi tre miracoli, annunciati con
grande cautela dal padre rettore Enzo Poiana, hanno suscitato più «l’effetto emulazione»
che sorpresa. Il primo riguarda una bimba veronese, Kairyn, nata sana nonostante una
diagnosi prenatale di tumore, «sparito» dall’ultima ecografia dopo la supplica della
famiglia a Sant’Antonio. La piccola è stata battezzata proprio domenica in basilica.
«Ringrazio Dio e Sant’Antonio per la grazia che ha ricevuto la mia bimba - scrive il papà
Michele su Facebook - un anno di un periodo triste che poi si é rivelato il più bello di
tutti. Averla battezzata a Padova è un’emozione grande, che solo quelli che hanno
partecipato sanno spiegare. Li ringrazio di essere venuti. Vi adoro famiglia e amici, oggi
è stato uno dei giorni più belli della mia vita e vedere dopo il battesimo la gente
estranea avvicinarsi per vedere o toccare la mia bimba miracolata da Sant’Antonio mi ha
riempito il cuore di gioia». La seconda grazia, emersa nelle stesse ore, è stata concessa
ad una coppia definita sterile dai medici, per l’infertilità diagnosticata al marito. Eppure
dopo aver partecipato, nel 2014, alla messa che ogni febbraio padre Poiana dedica
appunto agli aspiranti genitori e aver chiesto l’aiuto di Antonio, i coniugi in questione
sono diventati genitori di Giovanni. L’ultimo prodigio arriva da Springfield, dove già a
settembre una delegazione dei frati del Santo aveva certificato che un bimbo muto di 8
anni dopo la supplica di amici aveva detto «mamma». La storia riguarda una signora in
carrozzella per un tumore al cervello che, dopo essersi rivolta al «taumaturgo», si è
alzata in piedi, ha ripreso a camminare e ha visto la sua neoplasia regredire del 70%.
«Tutti questi casi saranno valutati dai medici - ha detto padre Poiana, che ha informato
il delegato pontificio Giovanni Tonucci - per adesso si parla di altri miracoli di Antonio».
Sui quali però gli stessi camici bianchi frenano. «Riguardo il caso della coppia infertile, se
il presunto problema riguardava l’uomo bisogna ricordare che a volte tale diagnosi viene
tracciata anche in presenza di un numero esiguo di spermatozoi - spiega il professor
Carlo Foresta, direttore del Centro di crioconservazione dei gameti maschili dell’Azienda
ospedaliera padovana -. Con l’esperienza ho invece imparato che basta un unico
spermatozoo per fecondare l’ovocita. Ecco perché prima di parlare di miracolo
bisognerebbe studiare bene la cartella clinica del paziente». Ma chiedere informazioni in
merito non è stato possibile: la legge sulla privacy lo vieta. Nessuna prova scientifica è
stata resa pubblica nemmeno dai genitori di Kairyn. «Le indagini prenatali, cioè sul feto,
possono evidenziare la compatibilità di alcuni parametri anomali con determinati
problemi, ma non c’è mai la certezza della diagnosi - precisa ancora il professor Foresta
-. Per esempio, se come in questo caso si è formata una sacca di liquido sul viso della
bambina, la vedi come una macchia nera e puoi ipotizzare il tumore, ma fino al parto
non ne avrai la sicurezza. Non è la prima volta che ad un secondo esame si esclude la
patologia pensata inizialmente. Bisogna sempre essere molto cauti nell’interpretare le
indagini strumentali». Stessa posizione presa dal professor Renato Scienza, primario
della Neurochirurgia di Padova, a proposito della «guarigione» dal tumore al cervello
della donna americana. «Ci sono casi di neoplasie che regrediscono fino a scomparire del
tutto per cause ignote anche agli specialisti - rivela -. Sono miracoli? Noi uomini di
scienza li riteniamo eventi che sconfinano nell’incapacità della medicina di spiegare tutto.
Non conosciamo l’intero sapere, meno che meno quando si tratta del cervello, ecco
perché accadono alcuni fenomeni che non siamo in grado di capire. Va poi chiarito che
non di rado si può sbagliare la prima diagnosi, non per imperizia ma per il limite di
alcune metodiche di indagine. Magari si giudicano maligne lesioni che non lo sono.
Oppure - aggiunge il neurochirurgo - ci si può imbattere in tumori con caratteristiche
aggressive che si perdono col tempo. Seguo pazienti operate trent’anni fa di metastasi al
cervello scatenate dal cancro alla mammella e non solo sono ancora tra noi ma
conducono una vita normale. Infine ci sono tumori che, se trattati bene, spariscono del
tutto». Fatto sta che, come sottolinea lo stesso Scienza, l’ospedale dove lavora ed è
riferimento nazionale, è stato costruito vicino a una chiesa. «Certo, la fede e l’aspetto
psicologico influiscono positivamente sulla capacità di reagire alla malattia - conviene il
primario - e non sono pochi i pazienti che prima di sottoporsi al controllo sullo stato del
tumore a un anno dalla comparsa mi dicono che preferiscono prima andare al Santo. Io
mi guardo bene dal trattenerli, ma poi la scienza parla chiaro».
Padova. E’ il volto della scienza. Fondatore, nel 1963, e direttore dell’Istituto di ricerche
farmacologiche «Mario Negri» di Milano, è docente di Chemioterapia, fa parte del
«Gruppo 2003», cioè il team di ricercatori italiani più citati nella letteratura scientifica
internazionale, è il «papà» dell’European Organization for Research on Treatment of
Cancer e l’autore di una lunga serie di pubblicazioni. Il professor Silvio Garattini è una
garanzia in tema di ragione e medicina. Difficile parlare con lui di miracoli.
«Diciamo piuttosto questo - dice subito - esistono malattie che per cause a noi ancora
ignote guariscono da sole».
Parliamo anche di tumori?
«Sì e tale regressione è scientificamente documentata, anche se nessuno conosce il
motivo del processo alla base del fenomeno».
E come si possono inquadrare tali accadimenti? Settori della scienza ancora inesplorati?
«E’ molto difficile dare loro un nome. Ma una certezza c’è: il termine miracolo non
esiste. Nella scienza esistono solo l’errore o l’ignoranza, nel senso che non sappiamo
perché certi fatti succedano. Non possiamo chiamarli miracoli, ma eventi che non
riusciamo a spiegare».
O che sono frutto di diagnosi sbagliate.
«Eh sì. Molte diagnosi sono errate, non si tratta di eccezioni. Spesso però si correggono
strada facendo, attingendo a nuove informazioni o utilizzando altre metodologie di
indagine».
Cosa può essere successo, per esempio, nel caso della coppia dichiarata infertile e che
poi ha avuto un figlio?
«Parliamo di un settore molto delicato. La capacità di concepire può variare a seconda di
una serie di condizioni, fisiologiche, psicologiche e ambientali, alle quali i soggetti
interessati sono esposti. Tanto è vero che esistono molte coppie per anni inutilmente alla
ricerca di un figlio e poi, quando ormai non ci sperano più, finalmente esaudite».
Insomma, magari l’esame accurato delle cartelle cliniche dei presunti miracolati
potrebbe fornire una spiegazione razionale?
«Sì, se esaminati nel dettaglio, determinati eventi possono essere razionalmente
illustrati. Nella scienza non esistono i miracoli, la fortuna o la sfortuna, ma c’è la
consapevolezza che le nostre conoscenze arrivano fino a un certo punto».
Difficile dirlo a chi riceve la grazia.
«Ma nessuno vuole impedire alle persone di avere una fede, di credere nella propria
religione. Qui la discussione va affrontata su un altro piano: le nostre conoscenze sono
molto imperfette. La verità è che la scienza dispone di una piccola frazione del sapere e
bisogna essere così umili da riconoscerlo e da ammettere ciò che non sappiamo. Perché
solo tale consapevolezza ci spinge a comprendere che per superare i limiti dobbiamo
lavorare di più e un po’ meglio».
Il timore di qualcuno è che la diffusione di notizie su guarigioni miracolose possa
infondere false speranze nei malati o convincere i più gravi a rivolgersi a qualcosa di più
«alto» della medicina.
«I due concetti vanno chiariti e separati bene. Se stiamo male dobbiamo sempre
rivolgerci al medico, non si discute. Prima di tutto bisogna essere responsabili. Poi però,
come dicevo prima, nulla ci vieta di pregare e di credere se ci fa stare meglio. Come si
dice: aiutati che il ciel ti aiuta. Se rivolgersi alla religione e ai santi può essere un
supporto psicologico per il malato e aiutarlo a sopportare meglio la sofferenza, a reagire,
a lottare, ben venga. Nell’affrontare la malattia, soprattutto le patologie serie, l’aspetto
psicologico è fondamentale, ma non va confuso con l’approccio razionale al problema».
Probabilmente il ricorso all’irrazionale diventa indispensabile nel momento in cui la
medicina non riesce a fornire la soluzione sperata.
«Purtroppo la medicina non raggiunge sempre i risultati sperati, ma è anche vero che i
progressi ci sono continuamente. E che dagli errori si impara».
Professore, lei è mai stato chiamato a dover «certificare» un miracolo?
«No, non mi è mai capitato. Ma mi sono imbattuto in casi dall’esito inspiegabile per le
attuali conoscenze a nostra disposizione. Come dicevo, è uno stimolo per continuare
nella strada del sapere».
Padova. «I miracoli? Ci credo, sì, altrimenti non verremmo qui». Occhi chiusi, fronte in
alto, un palmo che accarezza per lunghi minuti la pietra nera che, da dietro, chiude la
tomba di Antonio. Sara, con i suoi 34 anni e il papà, è nella basilica del Santo per
ringraziare. «Nuova» veneta nata nel Beneventano, da Treviso, città in cui vive, è
tornata a Padova per confermare un legame. «Non riuscivo ad avere un figlio. Sono
venuta qui, ho pregato Sant’Antonio e una settimana dopo ho saputo di essere
incinta...». E’ successo quattro anni fa, ieri a giudicare dal lampo negli occhi di questa
giovane donna. «Mio figlio? Si chiama Antonio e sta benissimo». La ragazza quasi
incrocia le dita: «Ho avuto una brutta gravidanza ma poi è andato tutto bene». E’
d’accordo sul fatto che il santo padovano abbia un legame speciale con moltissimi ma
non sa dire perché: «Sono andata anche a San Giovanni Rotondo, qui è speciale ma non
saprei... Perché tanti amano Antonio? E’ un fatto di cuore, forse...». Miracoli. A stare per
un po’ sotto queste cupole alternate a guglie che paiono matite, ti fai l’idea che la
credenza sia un fatto di carne. Perdita e ritrovamento, dolore che diventa gioia
insperata, vuoti che si riempiono e futuri che si aprono dietro porte sbarrate fino a pochi
istanti prima: spirito e corpo, uniti dalla pietra, dalla fede nel potere di un uomo morto il
13 giugno del 1231, nove secoli fa. «Grazie perché il 26 giugno (del 2013, ndr ) hai
salvato mio figlio Matteo e mio marito Antonio, evitando il tragico epilogo... Ho sentito la
tua presenza su di noi». E’ l’ex voto di Monica D., uno dei tanti che coprono i fianchi
della tomba del santo. Parole scritte dopo un incidente stradale e dopo la preghiera ad
Antonio, santo mediatore di grazia. Sant’Antonio si invoca per bisogno: «Fai ritornare il
sorriso a questa ragazza, la salute e fai andare via il dolore», scrive Maria Pia P. nel suo
voto in attesa di risposta. Marilena, milanese in trasferta a Padova con l’amica Anna
Maria, «non particolarmente religiosa» eppure qui, nella casa del Santo, spiega la
propria via (naturale, panteistica?) al miracolo: «Credo nella possibilità dei miracoli in
quanto manifestazione di un qualcosa di soprannaturale che ci governa, nel bene e nel
male». Ma perché si chiede proprio a questo santo? «Si va da sant’Antonio perché si ha
questa fede, e io invidio chi ce l’ha. Sono le stesse persone che sentono con il cuore di
poter guarire, lo sentono a tal punto che alla fine guariscono per davvero...». Sembra
più potere dell’autosuggestione che divino intervento, ma si chiama comunque miracolo.
Claudio, padovano, «età verso i sessanta, dai», è della stessa convinzione. «E’ il terreno
della religione. Le persone credono fermamente, quindi può essere che quel che
chiedono si avveri». E Claudio ci crede, davvero e fino in fondo? «Dipende, bisogna
essere molto sensibili e profondamente religiosi. Io non lo sono». Ha sfiorato la pietra
nera, è rimasto in silenzio, solo con se stesso: «La mia professione? Scriva che sono
avvocato e tanto basta», si schermisce Maurizio. Elegante, alto, brizzolato, impossibile
non definirlo persona distinta: «Non credo nell’eccesso di miracoli, questo si può dire».
Dunque non ha invocato grazie, per sé o altri: «No, ero un po’ in tensione e cercavo
quiete...». Un caso di scetticismo religioso, si potrebbe dire. Ma gli atteggiamenti, le
disposizioni verso sant’Antonio e il suo potere di taumaturgo sono moltissime,
infinitamente diverse l’una dall’altra. Laura, cinquant’anni, ieri pomeriggio premeva un
fazzoletto blu a pois bianchi contro la pietra di Antonio. E’ rimasta a lungo, immobile, a
tratti singhiozzante. «Si, ho chiesto aiuto. No, non voglio parlarne. I voti si fanno in
silenzio o non servono». Saluta e se ne va, senza altre parole. La preghiera a
Sant’Antonio, stampata a grandi lettere su foglio bianco cellophanato, dice quasi tutto:
«Sono venuto qui a pregarti spinto dalla mia necessità e fiducia nella tua bontà... So di
essere debole nella fede... Rinnovala in me». Rita e Mirko, ventenni, hanno appena
lasciato la «solita» tomba. La ragazza viene da Amantea, Cosenza; il ragazzo è di
Treviso. «Miracoli? Non so se crederci o meno. Direi che essendo fedele ci devo credere
in qualche modo... Se ho chiesto qualcosa prima? No, ho pregato e basta». Una donna
spinge una carrozzina all’interno della basilica. Sulla seduta c’è Rosa, 19 anni, gambe
ferite da un incidente, più di un anno fa. E’ bella Rosa, molto. Andrete sulla tomba a
pregare? «Sì, stiamo andando». Le gambe come vanno? «Meglio, ma non ancora bene».
Speri nel santo? «Spero che mi aiuti. In ogni caso venire qui regala coraggio e serenità.
So che camminerò presto e spero di farlo bene. E’ il secondo aspetto quello in dubbio,
dicono i medici. Ma qui senti che non sei solo, ed è importante». Come e più di un
miracolo, forse.
Torna al sommario
… ed inoltre oggi segnaliamo…
CORRIERE DELLA SERA
Pag 1 La figura che non vorremmo di Michele Ainis
Ogni presidente della Repubblica scrive la storia, però è vero anche il contrario: è la
storia che scrive i presidenti. Ciascuno di loro è figlio d’una particolare stagione politica,
civile, culturale, e la influenza, ma soprattutto ne viene influenzato. Rammentiamocene,
quando potremo vergare un giudizio a mente fredda sull’esperienza di Giorgio
Napolitano al Quirinale. Rammentiamocene, mentre ci sospinge l’urgenza d’individuare il
nome del suo sostituto. Perché una cosa è certa, nell’incertezza in cui nuotiamo giorno
dopo giorno: l’uomo che uscirà dal Colle, al termine del settennato, sarà un uomo
diverso da quello che v’era entrato. I precedenti, d’altronde, sono inconfutabili. Il caso
più vistoso fu Cossiga: per cinque anni silente ed ossequiente, dal 1990 si trasforma in
«picconatore» del sistema, insulta questo o quel capopartito, monta sul ring contro i
magistrati, blocca sistematicamente le leggi approvate dalle Camere (con la media d’un
rinvio a bimestre). Anche il suo successore, tuttavia, ospitava un mister Hyde sotto
l’abito del dottor Jekyll. Scalfaro aveva criticato a muso duro l’interventismo di Cossiga,
e infatti nel 1992 - quando giurò da capo dello Stato - promise di ripristinare la
centralità del Parlamento, garantendo il self-restraint (l’autocontrollo) nell’esercizio delle
proprie funzioni. Risultato: divenne il più interventista fra i nostri presidenti. Ben più di
Napolitano, messo in croce per il battesimo dell’esecutivo Monti. Scalfaro nominò sei
presidenti del Consiglio, fra i quali almeno tre (Amato, Ciampi, Dini) posti sotto l’esplicita
tutela presidenziale. E decise due interruzioni anticipate della legislatura, compresa
quella davvero eccezionale del 1994, benché il Parlamento fosse capace d’esprimere una
maggioranza in sostegno del governo. Potremmo continuare ancora a lungo in
quest’esercizio di memoria. Potremmo evocare il nome di Pertini, eletto nel 1978 durante i nostri anni di piombo - per garantire la tenuta delle istituzioni, poi
perennemente scavalcate dal nuovo presidente attraverso il colloquio diretto con la
pubblica opinione. Potremmo ricordare la traiettoria di Segni: nel 1962 esordisce
anch’egli criticando l’attivismo del predecessore Gronchi, ma sta di fatto che nel biennio
della sua presidenza usa per otto volte il potere di rinvio, quando in tutte le legislature
precedenti le leggi rispedite alle Camere erano state appena sette. Senza dire dei fatti
del 1964, su cui permane ancora un’ombra: nel bel mezzo d’una crisi di governo, Segni
riceve ufficialmente al Quirinale il comandante dell’arma dei carabinieri, artefice del
«piano Solo». Quale lezione possiamo allora trarre da questi remoti avvenimenti? Una
doppia lezione, un corso universitario in due puntate. Primo: contano gli accidents of
personality, come dicono gli inglesi. Conta il carattere, la tempra individuale. Perché al
Quirinale risiede un potere monocratico, che ogni presidente usa in solitudine. E quel
potere - scriveva nel 1960 il costituzionalista Carlo Esposito - non viene affidato alla Dea
Ragione, bensì a un uomo in carne e ossa, con i suoi vizi e con le sue virtù. L’esperienza
solitaria di ciascun presidente può acuire i vizi, o altrimenti può esaltare le virtù.
Dipende. Ma lo sapremo solo a cose fatte, a bilancio chiuso. Secondo: contano altresì gli
accidents of history, se così possiamo dire. Conta la storia, con i suoi imprevedibili
tornanti. Dopotutto è questa la ragione che rese un primattore Scalfaro, al pari di
Napolitano. A differenza di Ciampi - che visse gli anni più stabili della Seconda
Repubblica - l’uno e l’altro si sono trovati a navigare il fiume lungo le sue anse terminali.
Scalfaro alla sorgente, Napolitano alla foce. Anche se l’epilogo di quest’esperienza
ventennale è ben lungi dall’essersi concluso. Ma in entrambi i casi si conferma un’altra
profezia di Esposito, che dipingeva il presidente come «reggitore» dello Stato durante le
crisi di sistema. Poi, certo, ogni crisi può abbordarsi in varia guisa. Ancora una volta,
dipende: dagli uomini, così come dalle circostanze. Scalfaro distingueva fra governi
amici e nemici, sicché nel maggio 1994 salutò il primo gabinetto Berlusconi con un
altolà, esigendo per iscritto la sua «personale garanzia» circa il rispetto della
Costituzione. Per Napolitano tutti i governi erano amici, e infatti nel novembre 2010
salvò lo stesso Berlusconi dalla mozione di sfiducia, ottenendone il rinvio al mese
successivo. La sua bussola, insomma, si chiamava stabilità. Anche se nel frattempo
l’edificio diventava sempre più instabile e sbilenco, anche se talvolta uno scossone può
riuscire salutare. O almeno era quest’ultima la ricetta di Cossiga, una ricetta opposta a
quella offerta da Napolitano. In conclusione, non c’è una conclusione univoca dettata
dalla storia. O forse sì, c’è almeno un monito. Attenzione a scegliere una figura dimessa
e scolorita: sarebbe un errore. In primo luogo perché il soggiorno al Colle accende colori
insospettabili nei suoi vari inquilini. In secondo luogo perché la tormenta non si è affatto
placata, ci siamo dentro mani e piedi. La Seconda Repubblica rantola, la Terza non ha
ancora emesso i suoi vagiti. E in questo tempo di passaggio serve un capo dello Stato,
non un capo degli statali.
Pag 5 Terna di nomi. E cresce l’ipotesi Veltroni di Francesco Verderami
Roma. Sul Quirinale è il momento di contarsi per contare. E se Renzi non mette in
dubbio la parola di Berlusconi, «ha detto che voterà con noi e io gli credo», vuole capire
se ha davvero fondamento l’altra garanzia fornita dal Cavaliere: «A breve incontrerò
Fitto e i miei gruppi saranno uniti». La corsa per il Colle inizia ufficialmente oggi, e il
premier chiede all’alleato dell’opposizione di stringere i suoi ranghi, «io deve badare a
compattare i miei». Si vedrà se il leader del Pd riuscirà ad arrivare puntuale
all’appuntamento, «alla quarta votazione avremo il nuovo capo dello Stato», o se la sua
scommessa si rivelerà un azzardo. Molto dipenderà dal grado di tenuta del capo dei
forzisti ma soprattutto dalla tattica che verrà adottata per evitare le insidie del voto
segreto. Arcore è la Fortezza Bastiani di Berlusconi, che in attesa di sapere cosa disporrà
Renzi sul Quirinale si sporge dai camminamenti per scorgere la sagoma di un
messaggero: da quel deserto, d’altronde, non arrivano più nemici ma solo un ufficiale di
collegamento. È Verdini. È lui che spiega al Cavaliere come comportarsi: «Renzi ti
proporrà una serie di candidati e noi potremo scegliere». Il leader di Forza Italia inizia
così a sfogliare i petali della rosa, a modo suo: «Avrò l’agibilità, non avrò l’agibilità...». È
un chiodo fisso, non smette di parlarne, mentre attorno a lui i fedelissimi sbirciano sui
suoi fogli i nomi dei quirinabili: Mattarella, Gentiloni, Fassino. Il Cavaliere storce il naso.
In realtà, in fondo al sentiero che porta alla presidenza della Repubblica, quella terna
(forse) nasconde il vero candidato. Confalonieri sostiene che «nella storia del Quirinale
sono salite personalità sbiadite, però pensi di eleggere uno sbiadito e poi magari ti ritrovi
un Pertini». Il Colle visto da Arcore è un santuario laico da cui Berlusconi si attende il
miracolo, e la sua Fortezza Bastiani è un ottimo punto di osservazione per vedere tutti
quelli che si agitano con i loro messaggi e le loro telefonate, grazie alle quali l’ex premier
può dimenticare l’estrema debolezza politica del momento. Fassino - per accreditarsi gli ha fatto sapere che da Guardasigilli non ebbe mai alcun atto ostile contro di lui sulla
giustizia, «e quanto a standing internazionale sono stato ministro del Commercio
estero». Persino Prodi gli manda a dire. O meglio, alcuni prodiani - non si sa se
autorizzati o mossi da iniziativa personale - hanno contattato rappresentanti
berlusconiani del mondo dello spettacolo e dell’informazione per affidare un pensiero da
consegnare al Cavaliere. Ma il Professore non ha detto a più riprese di non essere «in
corsa»? Vero, ma «in corsa» lo potrebbero sospingere gli avversari di Renzi nelle prime
tre votazioni, quelle in cui il premier ha dichiarato che «si voterà scheda bianca», quelle
in cui il leader del Pd sarà maggiormente vulnerabile. Se il Professore iniziasse a salire
nei consensi sarebbe complicato arrestarne poi la marcia. A meno da non proporre un
nome che sia «all’altezza di Prodi e di Marini», come chiede Bersani a mo’ di sfida. E il
capo democrat - per parare il colpo e fermare la corsa del fondatore dell’Ulivo - medita
di lanciare in pista il primo segretario del Pd, quel Veltroni che - per dirla con autorevoli
membri del governo - «più sta fermo più sta dentro i giochi». Se così fosse, gli
oppositori interni di Renzi avrebbero difficoltà a respingere la proposta del loro
segretario. Se così fosse, altro che terna: vorrebbe dire che Berlusconi qualche garanzia
deve averla data sul candidato secco. Proprio Bersani ieri sentiva aria di grande intesa:
«Il premier dice che per il capo dello Stato partirà dalla quarta votazione e l’opposizione
non protesta?». Di più. Tra i ranghi forzisti c’è chi sottovoce si mostra disponibile a
votare eventualmente Veltroni, accreditando di fatto la tesi che la debolezza politica del
Cavaliere lo porterebbe ad accettare anche «un esponente del Pd» pur di stare in gioco.
Ma è questo il vero gioco o la soluzione ventilata ieri da Palazzo Chigi è una mossa
tattica, fatta nell’urgenza del momento, per stoppare gli oppositori del premier? E
l’accordo- semmai fosse stato già chiuso con Berlusconi - comprende anche l’area dei
centristi che stanno nel governo? Perché ieri Alfano ha detto no a un candidato al Colle
che sia frutto «delle primarie del Pd». Tra tanti interrogativi, una cosa è certa: Renzi
oltre la sesta chiama potrebbe perdere il controllo della situazione in Parlamento, perciò
ha bisogno di presentarsi ai blocchi di partenza con un candidato forte. I rischi di un
protrarsi della corsa sono stati analizzati a Palazzo Chigi come ad Arcore, dove a
Berlusconi è stato prospettato che - in caso di stallo - potrebbe prendere corpo anche la
candidatura di Grasso. Raccontano che il Cavaliere abbia avuto un sobbalzo: «Un
magistrato anche al Quirinale? Ci manca questo». Fosse per lui, un nome ci sarebbe,
uno che gli fa ricordare la sua gioventù politica: «Tra tutti, l’unico è D’Alema ad avere il
profilo dell’uomo di Stato. E sarebbe garante degli accordi. Ma purtroppo...». Purtroppo
Renzi non lo vuole. E se invece fosse Veltroni?
Pag 20 Houellebecq: “Lo ammetto, adesso ha paura anch’io. Devo essere
irresponsabile per continuare a scrivere. L’uomo non ne può più della sua
libertà” di Stefano Montefiori
Dopo l’attentato a Charlie Hebdo , il più celebre scrittore francese Michel Houellebecq ha
lasciato Parigi, protetto dalla polizia. Il giorno del massacro alla redazione, il 7 gennaio,
è uscito in Francia per Flammarion il suo ultimo romanzo, Sottomissione, che sarà nelle
librerie italiane domani, edito da Bompiani. Houellebecq immagina una Francia del 2022
dove il presidente musulmano Ben Abbes vince le elezioni, islamizza la società e
progetta di ricreare in Europa e nel Mediterraneo una sorta di impero romano, unito
dall’Islam. Houellebecq aveva sospeso la promozione del suo libro, ma ha scelto di
mantenere l’impegno preso con il Corriere della Sera .
Michel Houellebecq, lei ha paura?
«Sì, anche se è difficile rendersi conto completamente della situazione. Cabu per
esempio, uno dei disegnatori uccisi, non era del tutto cosciente del rischio, c’era in lui
l’anima sessantottina mescolata con una vecchia tradizione di mangiapreti, e in Francia
essere un mangiapreti espone a un processo in tribunale che in genere si vince. Penso
che Cabu non abbia colto che la questione è ormai di un’altra natura. Siamo abituati a
un certo livello di libertà di espressione, e non ci siamo fatti una ragione del fatto che le
cose sono cambiate. Anche io sono un po’ così, a livello inconscio. Ma l’idea della
minaccia ti viene in mente, ogni tanto...».
Come ha vissuto il 7 gennaio, che avrebbe dovuto essere la sua giornata, quella della
pubblicazione del libro atteso da mesi ?
«Quando ho saputo dell’attacco a Charlie Hebdo ho chiamato il mio amico Bernard
(l’economista Bernard Maris, tra le vittime, ndr ), ma non pensavo che fosse coinvolto.
Collaborava con loro, non immaginavo che fosse alla riunione di redazione. Ho
continuato a chiamarlo, dalle 12 alle 16, non rispondeva. Poi ho saputo».
Pensa che dopo gli attentati di Parigi la libertà di espressione sarà più difficile da
esercitare? Nonostante l’immensa manifestazione di domenica?
«Sì, certo. Niente sarà più come prima. Sicuramente è più dura, per esempio per un
disegnatore che comincia adesso».
Ma «Charlie Hebdo» ricomincia con un nuovo numero che ha in copertina Maometto.
Forse quel che è successo potrebbe al contrario dare forza ai giovani.
«Adesso non c’è problema, faranno lo stesso tutti i disegnatori di Francia anzi del
mondo. Dopo non so».
Lei è sulla copertina del numero uscito la mattina stessa della strage. Il nuovo «Charlie
Hebdo» riparte da Maometto. Che cosa pensa di questa scelta?
«Sì, è quel che bisogna fare, è la scelta giusta. Charlie Hebdo ha sotto la testata la
scritta “giornale irresponsabile”. È questo il loro motto, ed è giusto che restino fedeli alla
loro linea».
Lei aveva paura anche mentre scriveva il suo romanzo?
«No, per niente. Quando si scrive non si pensa affatto a come verranno accolte le
proprie parole. Scrittura e pubblicazione sono due fasi separate. È adesso che uno
capisce i rischi».
Il libro non mi è sembrato islamofobo, anzi al limite islamofilo. Ma in fondo neanche
quello, l’Islam viene abbracciato un po’ per opportunismo.
«È così. I miei grandi riferimenti in letteratura sono Dostoevskij e Conrad. Entrambi
hanno dedicato romanzi all’argomento di attualità più importante dell’epoca, ossia gli
attentati anarchici e nichilisti, la rivoluzione russa che covava. Sono molto diversi nel
modo di trattare il soggetto, ma questi rivoluzionari per loro si dividono in due tipi:
farabutto cinico o naif assurdo, talvolta altrettanto pericoloso. Io descrivo invece, quasi
unicamente, dei farabutti cinici attraversati talvolta da un pizzico di sincerità».
Questa parte di sincerità, che finisce per essere sconfitta, la si vede anche nel momento
chiave del romanzo, quando il protagonista François si rivolge alla Vergine nera di
Rocamadour, ma desiste, non trova la fede.
«Sì quella è la svolta del romanzo. È li che ho deluso i miei lettori cattolici, oltre a quelli
laici. Nel progetto iniziale il protagonista si converte al cattolicesimo, ma non sono
riuscito a scriverlo. L’avanzata islamica mi è parsa più credibile».
La settimana scorsa era cominciata con la parola chiave «Sottomissione»; si è conclusa
con titoli come «La rivolta di Parigi», «La Francia in piedi», a proposito della marcia. È
sorpreso dalla reazione dei suoi concittadini?
«Non credo che quella marcia pur immensa avrà enormi conseguenze.La situazione non
cambierà nel profondo, torneremo con i piedi per terra».
Davvero per lei è solo un episodio quindi?
«Sì. Non vorrei sembrare cattivo... Ma invece un po’ sì. Quando c’è stato l’incendio della
redazione, il primo attentato a Charlie Hebdo nel 2011, non pochi dei colleghi giornalisti
e dei politici dissero “sì, la libertà va bene, ma bisogna essere un po’ responsabili”.
Responsabili. Questa era la parola fondamentale».
Anche a lei, di recente, è stato chiesto se non sente di avere una responsabilità in
quanto grande scrittore. La trova appropriata questa domanda?
«No, io mi sento sempre irresponsabile e lo rivendico, altrimenti non potrei continuare a
scrivere. Il mio ruolo non è aiutare la coesione sociale. Non sono né strumentalizzabile,
né responsabile».
Qual è il problema alla base di tutto, in Francia?
«È il punto di partenza del libro. Il Paese è sempre più a destra ma la rielezione di un
presidente di sinistra non è totalmente impensabile. E questo è destabilizzante».
Il Front National era assente dalla marcia di Parigi.
«Sì, sembra che non li abbiano voluti. Se vogliamo parlare nello specifico del Front
National, hanno due deputati e il 25% dei voti (alle Europee, ndr )... C’è uno scarto
evidente. Il Front National ha un peso nella società che non corrisponde affatto alla sua
rappresentanza parlamentare. Mi domando fino a che punto una situazione simile sia
sostenibile, con questa astensione poi. C’è un sistema che dovrebbe essere democratico
e che non funziona più».
Hollande ha detto che leggerà il suo libro. È curioso di conoscere la sua opinione?
«No, dell’opinione letteraria dei politici mi interessa poco. Se François Hollande sarà
rieletto presidente nel 2017 forse molte persone emigreranno. Per ragioni fiscali ed
economiche, per l’idea che è difficile fare granché in Francia, un Paese che appare
bloccato. E poi potremmo vedere qualcuno alla destra del Front National che si
innervosisce e passa a un’azione violenta».
Nel suo romanzo la guerra civile sembra cominciare, poi per fortuna si ferma subito. Ma
lei mi sta dicendo che nella realtà questa le sembra un’ipotesi possibile.
«Sì, è un’ipotesi possibile. Sono allarmista, certo. Declinista no, perché ci sono cose
bizzarre e positive che accadono in Francia, per esempio abbiamo una demografia molto
alta, una cosa tutto sommato misteriosa».
Il grande soggetto del suo libro è in generale il ritorno della religione.
«Sì, è un fenomeno che i media non riescono a cogliere, pensano che la religione sia un
fenomeno passato di moda. Ma prima di domenica le grandi manifestazioni di piazza
sono state le manif pour tous . Fatte da cattolici molto diversi da quelli che mi ricordavo
da giovane, ovvero gente complessata e all’antica oppure di sinistra insopportabilmente
perbenista (ride, ndr )».
Ha letto «Il Regno», il romanzo di Emanuel Carrère, e il suo testo su «Sottomissione»
pubblicato dal «Corriere»?
«Si. Carrère ha capito certe cose fondamentali del mio libro».
Per esempio la tentazione di liberarsi della libertà?
«Si. Della libertà l’uomo non ne può più, troppo faticosa. Ecco perché parlo di
sottomissione. È un piacere parlare di Emanuel Carrère e del suo libro che ho molto
amato».
Carrère spera che possa esserci una relazione feconda tra l’Islam e la libertà cara alla
civiltà europea erede dei Lumi. È uno scenario possibile?
«I miei valori non sono quelli dell’Illuminismo. Ora, senza andare verso un progetto di
fusione grandioso alla Carrère, diciamo che Cattolicesimo e Islam hanno dimostrato di
poter coabitare. L’ibridazione è possibile con qualcosa che è davvero radicato in
Occidente, il Cristianesimo. Mentre con il razionalismo illuminista mi pare inverosimile».
Rispetto al 2001 e alla sua celebre dichiarazione «l’Islam è la religione piu stupida del
mondo», lei ha chiaramente cambiato opinione sull’Islam. Come mai?
«Ho riletto con attenzione il Corano, e una lettura onesta porta a supporre un’intesa con
le altre religioni monoteiste, che è gia molto. Un lettore onesto del Corano non ne
conclude affatto che bisogna andare ad ammazzare i bambini ebrei. Proprio per niente».
È il dibattito cruciale. I terroristi sono pazzi che stravolgono il messaggio dell’Islam, o la
violenza è inerente alla natura stessa di quella religione?
«No, la violenza non è connaturata all’Islam. Il problema dell’Islam è che non ha un
capo come il Papa della Chiesa cattolica, che indicherebbe la retta via una volta per
tutte».
I suoi romanzi hanno sempre una parte di osservazione della società e un tocco
profetico, a cominciare dal capitalismo applicato ai sentimenti di «Estensione del dominio
della lotta»...
«Sì, è stata la mia prima scoperta (ride, ndr )».
...per continuare con turismo sessuale e terrorismo di massa, clonazione, Francia
trasformata in parco giochi per ricchi turisti, fino alla sottomissione all’Islam.
«Comincio dall’osservazione della realtà, ma resta letteratura. So che è difficile da
credere ma l’Islam, nel romanzo, all’inizio non c’era. Uno dei motivi che mi hanno fatto
scrivere il libro, oltre al fatto che essere ateo mi è diventato insopportabile, è che
tornando in Francia dall’Irlanda mi sono reso conto che la situazione era molto peggiore
di quanto pensassi. Ho pensato che le cose potevano precipitare in modo spiacevole, e
questo mi ha sorpreso». L’intervista finisce, ci salutiamo. «Spero che avremo l’occasione
di rivederci in circostanze più felici», conclude lo scrittore.
Pag 36 La vera radice dell’estremismo di Vittorio Messori
Del rabbi Giuseppe Laras - eminente nell’ebraismo italiano non solo per cultura ma
anche per sensibilità religiosa - ho sempre apprezzato la schiettezza nell’esporre le sue
convinzioni. Così, nell’articolo di ieri su questo giornale, non esita a iniziare affermando
che «siamo in guerra, siamo solo agli inizi eppure non vogliamo prenderne coscienza».
Da realista, sarei propenso a dargli ragione: terminata, per collasso e abbandono del
campo da parte del nemico, la Terza guerra mondiale (detta «fredda», ma pur sempre
guerra), ecco la nuova Pearl Harbor, in un mattino di un 11 settembre a New York. Ecco,
diciamolo con la chiarezza di Laras, la Quarta guerra mondiale. L’ipocrisia dell’ideologia
oggi egemone, la political correctness, ha tentato e tenta esorcismi, costruendo, per
tranquillizzarsi, un ideale di «islamismo moderato», da incoraggiare e accrescere
ripetendo il mantra del «dialogo». Ma chi conosce davvero il Corano, chi conosce la
storia e la società cui ha dato forma in un millennio e mezzo, sa che non hanno torto
quei musulmani che chiamiamo «estremisti» (usando le nostre categorie occidentali) a
gridare, kalashnikov alla mano, che un maomettano «moderato» è un cattivo
maomettano. O, almeno, è un vile che Allah punirà. Quanti, tra coloro che si
scandalizzano per questo, quanti hanno letto per intero, senza censure mentali, il
Corano e magari anche le monumentali raccolte di hadith, i detti attribuiti al Profeta? Un
amico francese, religioso cattolico a Gerusalemme e noto biblista, mi raccontava di
recente che, nel loro convento, serviva da sempre, come factotum, un ormai anziano
musulmano. Onesto, gran lavoratore, di tutta fiducia, faceva ormai parte della famiglia e
tutti quei religiosi gli volevano bene, sinceramente ricambiati. Un venerdì, l’uomo tornò
dalla moschea con un’aria accasciata. Il superiore della casa, insistendo, riuscì a farlo
parlare. Disse: «Oggi l’imam che dirige la preghiera ci ha detto, nella predica, che nel
giorno del trionfo di Allah e del suo Profeta, nel giorno che presto verrà e in cui
libereremo questa Santa Città da ebrei e cristiani, tutti gli infedeli che non faranno
subito professione di fede dovranno essere uccisi. Così vuole il Corano cui noi tutti
dobbiamo obbedire». Una pausa, e poi: «Ma non tema, padre, sa che io vi voglio bene,
so come fare, se dovrò sopprimervi troverò il modo di non farvi soffrire». L’aneddoto,
purtroppo, è autentico. Come autentiche sono le domande poste, con cortesia e insieme
con crudezza, da Giuseppe Laras e che possono, credo, riassumersi così: è possibile, per
il mondo islamico, accettare quella tolleranza, quella distinzione tra politica e religione,
quella eguaglianza tra persone di diverse fedi, quel rifiuto - senza eccezioni - della
violenza, quelle realtà insomma su cui basare un mondo, se possibile meno disumano?
Come si sa, nel 1948, gli allora non molti Stati islamici già indipendenti che sedevano
alle neonate Nazioni Unite rifiutarono di firmare la «Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo», affermando che non corrispondeva alla loro prospettiva di persona e di
società. Una società, tra l’altro, dove la schiavitù non era ufficialmente abrogata, dove
vigeva, e vige, una poligamia nella quale la donna è relegata in un ruolo di
sottomissione, dove il non musulmano è cittadino inferiore, sottoposto a una pesante
tassa e a una serie codificata di pubbliche umiliazioni. Sarà mai possibile giungere
almeno a un modus vivendi o lo scontro dovrà continuare e magari aggravarsi, perché
tanto diversi resteranno i valori fondamentali? Tutto è possibile, s’intende, a Dio, a
Jahvé, ad Allah, a seconda delle fedi, ma, a viste solo umane, l’obiettivo non sembra
raggiungibile. In effetti, l’Islam non solo è diviso a tal punto che sono quotidiani i
massacri tra sciiti e sunniti o tra altre comunità in lotta cruenta tra loro. Ma, soprattutto,
non esiste una autorità superiore, in grado di prendere decisioni vincolanti per i fedeli,
come il Papa per il cattolicesimo. Anzi, non esiste nemmeno un clero né esistono
gerarchie religiose all’interno delle comunità. Tutto è lasciato a uomini soli, con in mano
solo un libro - immutabile - di millequattrocento anni fa. Il Califfato ottomano, abolito
nel 1924 da Kemal, era una finzione a servizio del sultanato e, in ogni caso, la sua
evanescente autorità non era riconosciuta al di là dei confini dell’impero turco. Ma anche
se tornasse, che potrebbe fare un «Papa della Mecca» che non avrebbe la grande,
liberante risorsa di quello di Roma: la risorsa, cioè, di una Scrittura approfondibile
secondo i tempi e le situazioni pur senza rinnegarla, flessibile pur senza tradirla, divina
ma affidata alla ragione di credenti che con essa devono affrontare i secoli? Il
Cristianesimo, prima è ben più che un libro, è un incontro tra vivi, tra gli uomini e il
Cristo vivo, con la ricchezza e la duttilità che nasce dalla vita. Ma così non è il Corano,
anzi ne è il contrario, con il testo originale custodito in Cielo accanto ad Allah, eterno,
immodificabile, dettato parola per parola a Muhammad, con le sue sentenze da
osservare sempre e comunque in modo letterale, con la sua rigidità che deve sfidare
ogni cultura, costi quel che costi. Possibile trarre, da qui, un «moderatismo»
maomettano? Se questa è la situazione, il rabbino Laras non nasconde una
preoccupazione: «C’è una tentazione che può profilarsi sia nel Cristianesimo sia nella
politica europea: quella di lasciar soli gli ebrei e lo Stato di Israele per facilitare una pace
politica, culturale e religiosa con il mondo musulmano». Per lui, questa sarebbe «una
strategia fallimentare» i cui effetti disastrosi per i cristiani si sarebbero già visti. Dice,
infatti: «Dopo che quasi tutti i Paesi islamici si sono liberati dei “loro” ebrei, si sono
concentrati con violenze e massacri sulle ben nutrite minoranze cristiane». Su questa
convinzione del rabbino dovrebbe aprirsi, però, una discussione: la persecuzione in atto
dei battezzati ha cause, crediamo, più complesse dello sfogo su di essi di una religione
violenta alla ricerca di vittime. Una discussione di grande importanza, e proprio per
questo non affrontabile in spazi così ridotti. Per ora, basti prendere sul serio
l’avvertimento di Laras: c’è una guerra e non è opportuno mascherarla dietro gentilezze
occidentali verso gli antagonisti e con severi rimbrotti alle «cassandre» che si limitano a
constatare una realtà drammatica.
LA REPUBBLICA
Pag 1 I sogni e le fatiche di un Sisifo al Quirinale di Eugenio Scalfari
Oggi Giorgio Napolitano darà le dimissioni e se ne andrà dal Quirinale. Tornerà nella sua
casa di via dei Serpenti e il suo ufficio sarà a Palazzo Giustiniani come spetta a tutti
quelli che hanno ricoperto la carica di presidenti della Repubblica. L'aveva già fatto più
d'un anno fa, alla scadenza del suo settennale mandato aveva preparato gli scatoloni
con dentro le carte di pertinenza propria degli anni trascorsi, le sue private memorie e
tutte le altre che non interessano gli archivi di Stato ma soltanto la persona che ha
ricoperto quella che è la più alta istituzione chiamata a tutelare la Costituzione e le
prerogative del Presidente coordinando la leale collaborazione tra poteri
costituzionalmente distinti e talvolta anche contrapposti. Va aggiunto però che, oltre a
queste essenziali funzioni, è auspicabile anche che la figura del Presidente abbia un
tratto paternale verso gli italiani e che i cittadini possano avvertire questo tratto che è al
tempo stesso protettivo dei loro diritti e dei loro bisogni ma anche severamente
educativo verso i loro difetti pubblici. Il privato è libero, il pubblico invece esclude la
corruzione, la malafede, l'evasione fiscale, l'arbitrio dei forti contro i deboli e dei ricchi
contro i poveri e gli esclusi. Una volta chiesi a Giorgio - al quale mi lega una conoscenza
molto antica e una profonda stima da quando quasi nove anni fa fu eletto al Quirinale qual è il suo giudizio su Papa Francesco. Mi rispose che questo Papa interpreta il suo
ruolo in un modo che andrebbe imitato da tutti coloro che rappresentano e debbono
tutelare i diritti ma anche i doveri di tutti e in particolare dei deboli, degli esclusi, dei
poveri e delle minoranze che hanno una visione comune diversa da quella della
maggioranza. Ebbene questo dovrebbe essere il ruolo anche del Capo dello Stato. E'
auspicabile che lo tengano presente i parlamentari che parteciperanno al "plenum" del
29 gennaio per eleggere insieme ai rappresentanti delle Regioni il nuovo presidente della
Repubblica. La vita politica di Napolitano ebbe inizio, come quella di molti giovani della
sua e della mia generazione, con l'iscrizione all'università di Napoli nell'autunno del
1942. Ho letto nella sua autobiografia e lui stesso me l'ha raccontato nei nostri numerosi
e amichevoli conversari, che i suoi amici erano di sentimenti antifascisti e utilizzavano
cautamente le opportunità offerte dalle diverse articolazioni del Guf di Napoli, compreso
il giornale "IX maggio". I Guf (Gruppi universitari fascisti) erano in molte città sedi di
università, organizzazioni dove i giovani manifestavano sentimenti di "fronda" e il partito
concedeva questa larvata opposizione consapevole che i giovani non accettano quasi mai
passivamente le visioni politiche della precedente generazione. A me capitò a Roma
qualche cosa di analogo ma a differenza di Napolitano i miei amici ed anche io eravamo
fascisti o perlomeno tali ci credevamo. A me capitò però di essere espulso dal Guf
nell'inverno del 1943 per un articolo scritto su "Roma Fascista": evidentemente la fronda
aveva sorpassato i limiti che il partito poteva sopportare. Napolitano, dopo questo
periodo di antifascismo senza partito di riferimento, si orientò verso i comunisti e si
iscrisse a quel partito nel 1945, quando il Sud era già stato liberato dalle armate
angloamericane e i partiti antifascisti non erano più clandestini. Va aggiunto però che il
Pci aveva da tempo abbandonato il massimalismo di Bordiga e con il Congresso di Lione
era stato praticamente rifondato seguendo le indicazioni politiche e culturali di Gramsci e
di un gruppo dirigente i cui maggiori esponenti erano Togliatti, Longo, Terracini,
Negarville, Scoccimarro, Tasca. I giovani che negli anni successivi dettero la loro
adesione avevano accettato l'ideologia leninista-marxista. Ma dal Congresso di Lione in
poi quell'ideologia era stata "contaminata" con una lettura gramsciana che teneva anche
presente la rivoluzione liberale di Gobetti, gli scritti marxisti di Antonio Labriola e
addirittura lo storicismo di Benedetto Croce. Fu quella più o meno l'epoca nella quale
aderirono al Pci persone come Amendola e Ingrao e Alicata che facevano parte di questa
nuova "leva" e così anche Napolitano, più giovane di loro ma con la stessa duplice
cultura politica: il marxismo, la rivoluzione liberal-gobettiana e il liberalsocialismo dei
fratelli Rosselli e di "Giustizia e Libertà". Questa fu anche la cosiddetta "doppiezza" di
Palmiro Togliatti il quale però fu anche, in quegli anni di clandestinità, uno dei leader del
Comintern l'organizzazione che rappresentava tutti i partititi comunisti, sia quelli che si
erano formati nell'Europa orientale e addirittura in altri continenti come la Cina, il sudest asiatico e alcuni territori africani, sia in paesi occidentali. Ricordo queste vicende
perché altrimenti non si capirebbe la storia politica di Giorgio Napolitano e di altri
militanti del Pci. Non si capirebbe cosa è stato quel partito che, dopo Togliatti e Longo,
fu guidato da Enrico Berlinguer. Il percorso che seguì il Pci con il nuovo segretario mise
in secondo piano l'ideologia, da un certo momento in poi si staccò da ogni sudditanza nei
confronti di Mosca e si identificò soprattutto con la classe operaia rappresentata da
Trentin e da Lama, con i braccianti guidati da Di Vittorio e con i ceti più deboli della
società italiana.
La "doppiezza" di Togliatti e del gruppo dirigente del Pci, al di là dell'ideologia
marxistaleninista che durò fino allo "strappo" di Berlinguer, si verificò soprattutto in un
pragmatismo che Togliatti applicò con tratti molto evidenti. Anzitutto con il
riconoscimento del governo Badoglio nel 1944 che durò fino alla liberazione di Roma
quando fu sostituito da Bonomi. Ma soprattutto dalla decisione di sostenere la nascita
dell'assemblea costituente che fece del Pci un partito italiano e costituzionale e non una
semplice sezione italiana del Cominform come era per esempio il Partito comunista
francese. Togliatti, quando fu oggetto di un attentato molto grave che rischiò di costargli
la vita, ordinò che il partito non facesse dimostrazioni di alcuna violenza. Durante i
dibattiti alla Costituente cercò accordi con la Dc tutte le volte che era possibile e votò
addirittura per il riconoscimento costituzionale del trattato lateranense e del Concordato
(articolo 7) che videro invece il voto contrario del Partito socialista e del Partito d'azione.
Napolitano a quell'epoca era ancora un dirigente locale ed era particolarmente vicino a
Giorgio Amendola che condivideva pienamente la "doppiezza" togliattiana
accentuandone però il costituzionalismo. Sarebbe stato molto favorevole ad una
unificazione col Partito socialista di Pietro Nenni nel periodo in cui quel partito era ancora
alleato del Pci. Quando però l'alleanza si ruppe l'ipotesi di una riunificazione diventò
impensabile. Nel frattempo ci fu la repressione in Ungheria del tentativo di quel paese
d'uscire dalla "tutela" sovietica. Intervennero le truppe sovietiche e i loro carri armati
impedirono che quel tentativo avesse successo. Il Pci non era ancora nelle condizioni di
rompere i suoi legami ideologici e politici con Mosca e fu dunque solidale con la
repressione, ma molti intellettuali e dirigenti, tra i quali ricordo Antonio Giolitti, uscirono
dal partito. Napolitano, per quanto so, rimase profondamente turbato da quella
repressione ma restò fedele alla linea di Togliatti. Un mutamento comunque avvenne
perché poco tempo dopo nacque una vera e propria corrente guidata da lui e da
Macaluso, che fu chiamata "mi- gliorista" o "riformista" e che si schierò pubblicamente
contro Mosca quando ci fu una seconda repressione a Praga contro il socialismo di
Dubcek. Napolitano in quegli anni era deputato e al tempo stesso dirigente nazionale del
partito; sempre più lontano dall'ideologia comunista, la corrente da lui guidata puntava
verso una nuova alleanza con la socialdemocrazia europea. In questo senso accolse
positivamente la segreteria di Berlinguer, della quale tuttavia fu anche critico perché,
distaccatosi da Mosca, restò tuttavia comunista mentre Napolitano sempre più puntava
verso un accordo con l'Internazionale socialista europea.
Ma parliamo ora del Presidente della Repubblica che proprio oggi lascerà il suo secondo
mandato. E' il solo caso d'un incarico al Quirinale della stessa persona che aveva dato le
dimissioni alla scadenza del suo settennato. La Costituzione non dice nulla a questo
proposito il che significa che esso è possibile come sono altrettanto possibili le dimissioni
anticipate. Del resto il Presidente, accettando il secondo mandato, aveva già
preannunciato che non l'avrebbe certo compiuto. Era stato pregato di accettarlo da tutte
le forze politiche, con la sola eccezione per altro scontata di Grillo e del suo Movimento.
Altre soluzioni non c'erano dopo il voto negativo contro Prodi avvenuto per il voto
contrario di 101 franchi tiratori del Pd. Spiegarne il motivo è semplice: alcune riforme
assai urgenti non erano state ancora votate a cominciare da quella sul lavoro, dalla
riforma costituzionale del Senato e dalla legge elettorale. Il governo Renzi e l'interesse
generale del paese avevano bisogno che quel percorso procedesse, mentre
l'impossibilità di trovare un successore al Quirinale avrebbe inevitabilmente obbligato a
nuove elezioni. La fine della legislatura avrebbe dovuto utilizzare la legge esistente per
volontà della Corte costituzionale dopo l'annullamento del "Porcellum", con un sistema
proporzionale che avrebbe quasi certamente creato due diverse maggioranze tra la
Camera e il Senato e quindi una totale ingovernabilità. Questa è stata la ragione del
secondo incarico a Napolitano che già si era dimesso. "Non supererò comunque la
scadenza dei miei novant'anni " aveva preannunciato. Poi la fatica d'un incarico pieno di
impegni nazionali e internazionali ha accentuato il peso che gravava sulle sue spalle e
questo lo ha indotto a far coincidere le sue dimissioni con la fine della presidenza
semestrale europea gestita dal primo luglio scorso da Matteo Renzi. Appunto oggi il
presidente si dimetterà con una lettera ai presidenti del Senato e della Camera, il primo
dei quali eserciterà la supplenza al Quirinale fino al momento in cui il successore sarà
stato eletto. Si apre dunque da oggi una fase della massima importanza e delicatezza
per le istituzioni e per il paese.
Bisogna dire che le prerogative del Capo dello Stato in Italia sono notevolmente diverse
da quelle degli altri paesi europei. Nella loro quasi totalità in quei paesi il Capo dello
Stato non ha alcun potere effettivo; si limita a firmare le leggi votate dal Parlamento e
proposte dal premier. Fa eccezione la Francia dove c'è un semipresidenzialismo con un
governo nominato dal presidente e un'assemblea parlamentare che ha limitate capacità
di controllo sulla pubblica amministrazione e sulla legislazione. In Italia quelle
prerogative sono numerose e fanno del nostro Presidente il garante della Costituzione e
della leale collaborazione tra le istituzioni e i poteri che ciascuna di esse rappresenta.
Tocca a lui di promulgare le leggi e se non le ritiene conformi a rinviarle alle Camere per
una loro seconda deliberazione; nomina il presidente del Consiglio e i ministri da lui
proposti; scioglie le Camere anticipatamente se per una qualunque ragione la loro
funzionalità fosse bloccata; nomina una parte dei componenti della Corte costituzionale;
presiede il Consiglio superiore della magistratura, cioè l'organo di controllo del potere
giudiziario; è il titolare esclusivo del diritto di grazia; nomina i senatori a vita entro il
limite complessivo di cinque ai quali si aggiungono i capi dello Stato che abbiano
terminato quella loro funzione. Aggiungiamo anche che è irresponsabile giudiziariamente
fin quando ricoprirà il suo mandato, salvo reati penali colti in flagranza. Naturalmente
queste prerogative sono molto elastiche. L'elastico può essere allentato o teso evitando
però la sua rottura. Durante il periodo della partitocrazia, che durò per tutta la
cosiddetta prima Repubblica guidata dalla Dc e dai suoi alleati, le prerogative del Capo
dello Stato furono di fatto confiscate dai partiti di maggioranza. L'opposizione comunista
accettò quella confisca: erano i tempi della guerra fredda, il mondo intero era diviso in
due, il deterrente della bomba atomica di fatto produceva una stabilità internazionale e
nelle varie nazioni aderenti all'uno o all'altro schieramento, un immobilismo politico da
tutti accettato. Quella stagione cessò con la caduta del muro di Berlino e soprattutto con
la riunificazione delle due Germanie. Da allora le prerogative del Capo dello Stato
italiano hanno recuperato il peso che dovevano avere e tutti i partiti, nessuno escluso,
hanno recuperato la possibilità di costruire una maggioranza di governo o di esercitare
un ruolo d'opposizione che prepari una prossima alternanza sempre nel quadro tracciato
dalla Costituzione esistente. In che modo Napolitano ha gestito, in questo quadro, i
poteri che la Costituzione gli ha conferito? E fino a che punto ha teso l'elastico?
Il nostro è un paese politicamente fragile e la fragilità è pressoché inevitabile perché ha
come riscontro la fragilità politica dell'Europa. E' un tema che emerge soprattutto in
tempi di crisi, quando tutti siamo chiamati a sopportare sacrifici e a veder frustrate le
speranze del futuro. Ma non dipende solo da questo. Napolitano ha studiato a fondo la
nostra vita pubblica e non soltanto sui libri: l'ha vissuto come dirigente di partito prima e
come presidente della Repubblica poi; quello è un osservatorio che spazia sull'intera
classe dirigente, non soltanto politica ma economica, professionale, militare, sui docenti,
sui tecnici, sugli scienziati, sui giovani che cercano il futuro, sui vecchi che hanno
un'esperienza da mettere in comune. Ebbene, per qualche ragione motivata dalla storia
del nostro paese, noi non abbiamo un "establishment". Abbiamo individui spesso
intelligenti, ancor più spesso furbi e amanti del far da sé, ma se per establishment si
intende una classe dirigente che anteponga realmente gli interessi collettivi ai propri e
della propria più ristretta cerchia, allora l'establishment in Italia non c'è e non c'è mai
stato. Napolitano nei quasi nove anni di Quirinale ha fatto il possibile e addirittura
l'impossibile per compiere e far compiere qualche passo avanti in quella direzione. Ha
trovato persone che erano pronte a mettersi insieme a lui e da lui guidate in questa
difficilissima strada. E questo è avvenuto ma non è stato sufficiente. Sisifo sollevava i
massi e li faceva avanzare verso la vetta della montagna, ma è un personaggio
mitologico e quindi divino. Non c'è nessuno che abbia quei poteri. Lo si vorrebbe e infatti
la nostra immaginazione ne ha creato il mito proprio perché nella realtà non può
esistere. Questa è la tristezza che Napolitano ha sentito emergere dentro di sé, o
almeno così io credo per quanto possa aver capito dei suoi pensieri e della sua diagnosi
della realtà. In altri paesi le classi dirigenti, portatrici di una solida visione del bene
comune, ci sono e la loro esistenza distingue quei paesi dagli altri. Forse ci sarebbe se
l'Europa diventasse un continente federato e non confederato, come ancora è.
Napolitano questo lo sa, infatti non ha cessato di ricordare ripetutamente agli italiani ed
anche agli europei che il nostro obiettivo è di avanzare sulla strada dell'unità politica
dell'Europa. Lui la pensa come Altiero Spinelli e il suo manifesto di Ventotene, la pensa
coma la volevano De Gasperi, Adenauer e quegli statisti che prevedevano fin da allora
l'evoluzione della società moderna e l'avvento di una società globale dove gli Stati hanno
dimensioni continentali per poter confrontare e risolvere tutte le contraddizioni, le
diseguaglianze, la povertà, i mutamenti del clima, le ondate migratorie, i conflitti locali.
Ho chiesto a Napolitano molte volte nelle nostre conversazioni qual era il suo sogno
europeo e lui mi ha sempre risposto auspicando che l'Europa diventi veramente uno
Stato con ampi poteri sovrani. Ma ci vorranno anni per realizzare questo obiettivo. Ho
chiesto anche se ci sono personalità di peso internazionale che cerchino di far avanzare
l'Europa su questo percorso e lui mi ha risposto che certamente ci sono queste
personalità anche da noi e naturalmente anche in Europa ma non hanno ancora avviato
il percorso verso un vero Stato europeo. Forse l'insorgere di un terrorismo come quello
che ha insanguinato in questi giorni Parigi e che minaccia di trasformarsi in una vera e
propria guerra, ha l'aspetto positivo di stimolare la nascita degli Stati Uniti d'Europa.
Sisifo è un mito, ma noi dobbiamo sperare e operare affinché diventi una realtà.
Pag 19 Vivere in Europa ai tempi della paura, così il terrorismo distrugge la
società di David Grossman
Testo non disponibile
IL SOLE 24 ORE
Il dna della politica che l'Europa deve ritrovare di Vittorio Emanuele Parsi
«Un gigante economico, un nano politico, un verme militare»: era questo lo sprezzante
giudizio sull'Unione europea che girava fino a qualche anno fa negli ambienti
neoconservatori. Seppure espressa in termini meno sarcastici, quella opinione è ancora
oggi condivisa da tanti critici della difficoltà europea a "esserci" sullo scenario della
politica internazionale. Paradossale, se si pensa che Gran Bretagna, Francia, Germania
(e più indietro nel tempo Austria, Portogallo, Spagna, Svezia, Olanda) la storia del
mondo hanno contribuito a farla come poche altre nazioni al mondo, nel bene e nel
male. L'insieme di questi e degli altri venti Paesi che oggi compongono l'Unione
dovrebbe quindi avere nel suo Dna il gene della politica internazionale. E invece se c'è
un ambito sul quale l'Europa stenta, finora, a marcare la sua presenza questo è proprio
la proiezione esterna della sua esistenza. Per alcuni aspetti un simile ritardo e una simile
difficoltà non devono stupire: il progetto stesso di unificazione europea è nato proprio
dal collasso del continente seguito a un "surplus" di proiezione di potenza da parte dei
suoi protagonisti principali, in grado di dar fuoco alle polveri di due guerre mondiali in
meno di un quarto di secolo. La lunga Guerra fredda, poi, ha sterilizzato e ridotto le
possibili aspirazioni a marcare in maniera autonoma il raggio d'azione di una politica
estera europea. La Guerra fredda però è finita ormai da 25 anni, l'Unione stessa si è
dotata di strumenti idonei a segnalare al mondo esterno il suo ritorno sulla scena
mondiale, le sfide certo non mancano, eppure... Eppure l'Europa continua a vedersi a
fatica, perché quello che finora le è mancato sono stati il coraggio e l'ambizione. Il
coraggio di capire che in un mondo in continuo tempestoso movimento (parlare di
evoluzione parrebbe eccessivo) non c'è più spazio per le strategie volte alla mera
sopravvivenza. L'ambizione per ricordarsi che il mondo che verrà possiamo (e
dobbiamo) concorrere a disegnarlo anche noi. Il guanto di sfida lanciato dal terrorismo
islamista a tutti noi è solo l' ultimo e il più brutale che colpisce il nostro volto. Per
raccoglierlo, lo abbiamo ripetuto tante volte in questi giorni, occorre la consapevolezza
che solo unendo gli sforzi investigativi e di intelligence potremo venire a capo di una
minaccia tanto letale al nostro stile di vita. Tutto questo però non basta. Considerato il
legame oggettivo che esiste tra i terroristi nati e cresciuti in casa nostra e il centro di
irradiazione delle aberranti mistificazioni in nome delle quali hanno dichiarato la loro
violenta secessione dal consesso civile, occorre che l'Europa sappia trovare una politica
che sia non solo comune, ma anche forte e determinata per concorrere a chiudere
l'esperienza dello "Stato islamico" e sostenere la riforma e il consolidamento del sistema
regionale del Levante. Si tratta di uno sforzo importante, sul quale l'Europa si gioca la
sua credibilità, tanto più in un momento storico in cui la potenza leader dell'Occidente e
del mondo sembra essersi smarrita. L'Unione europea potrà essere una "potenza
pacifica" ma non potrà mai più illudersi di essere solo una "potenza civile" e men che
meno imbelle. La spinta a una maggiore unità, a spostare più avanti possibile il processo
di unificazione politica, riscoprendo l'intima essenza politica dell'Unione, viene anche
dall'interno dei suoi confini. Nonostante gli indubbi maggiori progressi nel campo dell'
edificazione del mercato unico e di uno spazio economico comune, la grave crisi che da
anni squassa le nostre economie ha mostrato in maniera impietosa quanto siano pesanti
e alla fine insopportabili i costi derivanti da un'imperfetta unificazione. Se confrontata
con quelle dei principali competitors globali, l'economia europea appare in affanno,
incapace di rilanciarsi non solo e non tanto per una carenza oggettiva di risorse
finanziarie, ma soprattutto per l'incapacità di impiegarle utilmente. Interroghiamoci sul
come mai i famosi "parametri" di Maastricht non sono mai stati allentati per ridare un
po' di fiato ad economie asfittiche e in continuo peggioramento, o perché solo dopo
faticosi negoziati l'Europa sia riuscita (proprio ieri) ad accennare ad un mite tentativo di
superare le politiche del solo rigore finanziario, chiesto da anni da più parti. O ancora,
interroghiamoci sul perché le politiche economiche nazionali abbiano talvolta finito per
produrre una rincorsa al dumping fiscale che ha generato un gioco a somma zero. La
risposta sarebbe sempre la stessa: deficit di unità politica. È il ritardo nel processo di
unificazione che continua a far sì che ogni singola costituency politica nazionale non
possa "fidarsi" delle altre, e chieda quindi pegni costosi per ogni credito concesso. Non è
per nulla accidentale che all'interno della casa comune europea la divergenza in termini
economico-sociali abbia preso il posto della convergenza, con un avvitamento che
rafforza l'analogo, inaccettabile movimento che si produce anche nelle singole società
nazionali, creando diseguaglianze di opportunità francamente inaccettabili. Il risultato di
questa debolezza lo abbiamo sotto gli occhi: l'Europa, la patria della democrazia e
dell'uguaglianza politica come ci piace pensarla, oggi si ritrova a temere l'esito del voto
greco, ad aver paura di fronte all'esercizio del più elementare diritto democratico di una
delle più piccole delle nazioni che la compongono. È tempo di cambiare tutto questo,
prima che lo scorrere del tempo decreti impietosamente la fine del più straordinario
esperimento politico mai tentato nella storia.
AVVENIRE
Pag 3 I bambini arruolati in odio alla vita di Marina Corradi
L’orrore dei fanciulli usati per uccidere
Il bambino ha lineamenti asiatici e capelli lunghi e neri. In mano tiene una calibro 9, ma
dimostra dieci anni, e chi lo guarda in un primo istante pensa che quella sia un’arma
giocattolo: un bambino che gioca alla guerra, con una pistola che sembra vera. Ma poi il
ragazzino punta l’arma e spara, e uccide due prigionieri in ginocchio. Il video spedito dal
Califfato al mondo da al-Hayat Media, braccio mediatico dell’Is, finisce con il bambino
che promette che crescerà, e ucciderà ancora. Allora anche le bambine kamikaze che
Boko Haram in Nigeria ha usato in questi giorni per fare stragi nelle piazze e nei mercati,
non sembrano più episodi isolati, ma anelli di una catena in un disegno di orrore. Perché
c’è qualcosa di peggio che massacrare uomini inermi, e questo qualcosa prende forma se
a dare la morte sono dei bambini. Bambine usate come serbatoi di esplosivo, con chissà
quali parole strappate alle famiglie e poi convinte o minacciate e costrette e spinte al
patibolo loro, e altrui. Bambini arruolati in un macabro inganno, nell’età in cui alla
guerra si gioca; e, magari, dapprima inorgogliti e fieri di essere presi sul serio dai
grandi, dai soldati veri – ignorando il buio di disperazione in cui vengono attratti e
sospinti. Bambini utilizzati in fondo come cose, come carne docile, che ubbidisce e
esegue e non sa, in quale laccio è stata presa. Se la strategia del jihad, declinata
secondo le diverse latitudini ma in un’unica oscura nota, è di sconvolgere, sgomentare
l’Occidente, ribaltandone la stessa visione del mondo, allora le bambine nigeriane, il
ragazzino del video di al-Hayat sono i simboli di questa perversione: in cui non basta
dare la morte, ma occorre che la diano i bambini, a testimoniarci che nulla davvero di
intoccabile resta, in comune, fra i terroristi e noi. Certo, non è la prima volta che i
ragazzini vengono arruolati e combattono, è successo nei secoli passati così come nelle
ultime ore del nazismo, è stato fenomeno di massa nella guerra civile ugandese come in
altre guerre africane e tribali; ma ciò che è nuovo oggi è l’uso propagandistico, da parte
del terrorismo islamico, dei bambini, quasi in un vanto, quasi fosse un primato di onore
l’arruolare anche loro, quelli che non capiscono e non sanno, e farne portatori di morte.
Quasi che l’obiettivo di questa crociata di innocenti fosse, più che la lotta contro il
nemico, la negazione stessa dell’uomo. Un annichilimento di cui poi restano, come è
accaduto nella guerra civile ugandese, le facce di quelli che furono costretti a sparare e a
uccidere; e negli occhi di quegli ex bambini il lascito appunto di un annientamento, di
una tenebra che sarà poi terribilmente difficile dissipare. Il passo in più, la soglia
traversata da questa nuova guerra del terzo millennio è, oltre all’arruolamento dei
fanciulli, il vantarsene, il farne oggetto di propaganda. Come a rivendicare un primato di
disumanità; mentre, nella macchina inarrestabile e convulsa che è il web, ci saranno
magari coetanei del bambino giustiziere dell’Is che vedranno quella esecuzione, quella
promessa di crescere e uccidere, e forse desidereranno di fare altrettanto. La strategia
del marketing adattata all’annientamento dell’uomo. Perché che questo nemico voglia in
verità, e oltre alle sue affermazioni, solo il nulla e la morte, è il sospetto che è
ragionevole coltivare, guardando alle stragi di innocenti, ai massacri di cristiani che
compie con spaventevole efficienza in quelle parti del mondo, in cui può allargarsi e
dominare indisturbato. E se di questo occorresse ancora una prova, guardate quelle
bambine portate al massacro come agnelli, quel ragazzino del video, fiero di essere già
'grande'. È la sovversione delle radici della umana convivenza, il non fermarsi davanti
alla faccia di un bambino e anzi servirsi proprio della sua debolezza, per farne un mezzo
di morte. Negando, oltre alla sua fanciullezza, proprio ciò che è, nella natura degli
uomini, un bambino: cucciolo da proteggere, e figlio che continua la nostra storia. Ma
forse il senso profondo dell’annientare i bambini è proprio questo: una radicale
avversione alla vita che continua, un odio profondo a quella che verrà.
IL GAZZETTINO
Pag 1 Non sono Charlie ma voglio che Charlie viva di Dario Calimani
Quali sono i limiti della satira? Ho il diritto di uccidere chi offende il mio Dio? È un Dio
quello che dopo aver creato l’uomo chiede a un altro uomo di ucciderlo? O quello che
chiede di sfregiare una ragazzina che vuole studiare? Io penso di no, ma mi rendo conto
che non tutti la pensiamo allo stesso modo. Spesso ‘Charlie Hebdo’ ha fatto satira
antisemita, e per questo il giornale mi può stare poco simpatico; magari ha anche
confuso e prodotto confusione fra ebrei e Israeliani, e non ha fatto certo divulgazione
culturale obiettiva; forse non lo comprerò, ma non per questo ho mai desiderato
distruggerne i giornalisti: me lo ha impedito la mia cultura, non solo la legge del mio
paese. Allora, mi chiedo – e non avrei osato chiedermelo ieri – da dove viene la cultura
che manda un uomo a uccidere per difendere la sua idea di Dio?
Quel che è certo è
che esiste una fetta di società e di cultura che fa un uso spregiudicato della religione. Lo
fanno i coloni in Israele, per giustificare l'appropriazione indebita di brandelli di terra, ma
lo fanno soprattutto, terroristicamente, alcuni settori dell’Islam, appoggiati e ‘compresi’
da più ampi settori dell’Islam ai quali piace riconoscere in Israele la colpa di ogni male e
l’obiettivo da annientare. Se poi si colpisce soltanto un povero ebreo che vive magari in
Svezia, poco male. Il petardo fa rumore comunque. Il terrorismo è la prassi di una
minoranza? Non ne siamo certi, e ciò a cui stiamo assistendo dovrebbe dirci quanto si
stia diffondendo l’idea di un Islam espansionista, che vuole imporre i suoi modelli
ideologici senza condividere nulla dei modelli civili dei paesi presso i quali cerca ospitalità
o rifugio. Gli islamici moderati sono sicuramente una grandissima maggioranza, ma i
terroristi e i loro sostenitori non sono più un numero esiguo, e non sono più così lontani,
e non siamo sicuri che siano del tutto soli. Se non ci fanno effetto le teste decapitate
dalle bestie dell’ISIS, nella lontana Siria o i duemila massacrati di Boko Haram nella
lontanissima Nigeria, devono egoisticamente preoccuparci la ventina di morti nel centro
dell’Europa. Se a farci comprendere il rischio che corre l’Europa sono stati gli
avvenimenti di Parigi, diciamo allora, con infinitissimo imbarazzo, che era ora che
accadesse. È come se l’Europa lo avesse atteso con trepidazione. Alla Francia, in questo
momento, va naturalmente tutta la solidarietà del mondo civile, ma la Francia si sveglia
oggi di fronte alla ferita che le viene inferta al cuore. Non si è accorta prima degli
attentati alle scuole ebraiche e alle sinagoghe, si è dimenticata del giovane Ilan Halimi
torturato e massacrato nelle banlieue, ha sorvolato sulle migliaia di ebrei che stanno
cercando rifugio in Israele. Recupereremo speranza votando Marine Le Pen? Tutti oggi si
vantano di affermare “Je suis Charlie”. Bene, IO NON SONO CHARLIE, perché Charlie
può non essermi piaciuto in tempi passati, e tuttavia Charlie aveva il diritto di continuare
a vivere anche se non era proprio me stesso. Ma io non sono neppure l’Islam, perché
certo Islam può non piacermi e quell’altro Islam, quello dal volto gradevole, non l'ho mai
sentito vicino agli ideali del rispetto altrui, specie quando non si trattava di rivendicare i
propri diritti, ma quelli dell’altro. Credo che, rinunciando alla vuota retorica che è di
moda, il motto da adottare sia “Io non sono Charlie, ma Charlie ha, ciò malgrado, il
diritto di vivere”. Il rispetto, poi, ciascuno di noi se lo deve anche guadagnare. Io sono
per la convivenza civile e per il rispetto reciproco. E sono a favore dei rapporti civili con
chi sa distinguere il diverso da sé e rispettarlo in quanto diverso. In un rapporto di
perfetta reciprocità. È troppo facile amare il prossimo, quando lo senti uguale a te. Il
problema è sopportare chi non ti piace, senza per questo meditare di sopprimerlo. Del
resto, se così non fosse, non saremmo brutalmente umani.
Pag 1 Per re Giorgio è come il giorno della liberazione di Mario Ajello
È come se fosse, per lui, il giorno della liberazione. Sennò, a proposito della mattinata di
oggi, in cui Giorgio Napolitano lascerà il palazzo del Quirinale dopo quasi nove anni, egli
non avrebbe utilizzato l'espressione «prigione». Ma rivolgendosi a una piccola
studentessa, sulla piazza del Colle, durante la festa della polizia, una metafora così ci
può stare. La bimba gli chiede se è felice di fare rientro nella sua abitazione privata, che
poi è a due passi dalla sede presidenziale, e Napolitano le risponde con un umanissimo
sorriso da nonno: «Certo che sono contento di tornare a casa. Qui si sta bene, è tutto
molto bello, ma insomma si sta un po' chiusi, un po' come in prigione. E si esce poco».
All'idea di uscire di più, Napolitano si sta così piacevolmente abituando che sembra già
aver cambiato passo e ritmo nella camminata. Appare più leggero nei suoi movimenti. Il
format del pensionato non gli si addice - anzi sarà presentissimo nella politica attiva già
per le votazioni del successore: lui è un grande elettore, al contrario di Renzi e di
Berlusconi che saranno pure i king maker ma non stanno in Parlamento - ma «farò tante
passeggiate» è il messaggio che in queste ore si sente di esprimere. E capiterà magari di
incontrarlo, come accadeva un tempo, prima che fosse eletto sul Colle, mentre si aggira
lungo i Fori Imperiali ammirando la grande bellezza. Adesso, nelle ultime ore di questi
nove anni, qualche telefonata agli amici della giovinezza. Come Raffaele ”Duddù” La
Capria, per ricordare insieme a lui l'ultima volta - il 15 novembre scorso a casa del
regista che faceva il compleanno - che entrambi hanno visto il comune sodale dei tempi
del liceo, Francesco Rosi, amatissimo e appena scomparso. Ieri, dopo il saluto ai
corazzieri, quello ai dipendenti della Presidenza della Repubblica. Una piccola folla.
Nessun brindisi. Nel Salone delle Feste. Napolitano si commuove verso la fine del suo
discorso. Che non ha nulla di retorico. «Sono contento di questi nove anni». E aggiunge:
«Vorrei che il Quirinale restasse un punto di eccellenza della Pubblica Amministrazione».
Lo ascoltano, con una punta di orgoglio. Napolitano, salutandoli, vuole farli sentire una
squadra che non scioglie le righe. Ora parla così, con tono nient'affatto crepuscolare, con
nessuna posa da sovrano che abdica, con l'aderenza alla realtà che è stato un suo segno
distintivo insieme al fastidio vibrante nei confronti dei predicatori di sfiducia e di chi
alimenta «un clima sociale troppo impregnato di negatività»: «Il mio augurio al Paese è
che sia unito e sereno. Anche perché viviamo in un mondo molto difficile. Abbiamo visto
nei giorni scorsi che cosa è accaduto in un Paese vicino e amico come la Francia». E
ancora: «Siamo molto incoraggiati dalla straordinaria manifestazione di Parigi. Però,
insomma, sempre stando attenti a stare in guardia senza fare allarmismo». Ecco,
Napolitano resta Napolitano fino alla fine. Ma è come se un surplus di calore - di
misurato calore, naturalmente - lo stia attraversando in questo passaggio esistenziale.
Verrebbe quasi, ma solo quasi e sapendo di esagerare, da chiamarlo Giorgio il Caldo: e
sarebbe un nuovo soprannome tardivo ma affettuoso da aggiungere a quello che gli
affibbiarono ai tempi in cui era ragazzo nella sua Napoli. Lo chiamavano Giorgio 'o sicco
(il magro) per distinguerlo dal suo maestro politico Amendola, denominato Giorgio 'o
chiatto (in quanto assai più robusto del suo allievo). Vecchie storie, che però ritornano
perché ogni nuovo passaggio di vita - come questo che sta compiendo Napolitano contiene anche un ripensamento dei capitoli precedenti, anche o soprattutto i più
lontani. Qui e ora ci sono gli scatoloni con i libri già traslocati dall'appartamento del Colle
a quello privato. E anche i recipienti con altri volumi e altre carte sono arrivati da tempo
nello studio da presidente emerito che Napolitano ha a disposizione a Palazzo Giustiniani
(così come ce l'ha Carlo Azeglio Ciampi). E così il politico «totus politicus» che entrò
nove anni fa in queste stanze, dopo aver ricoperto incarichi istituzionali ai massimi livelli
come il ministro dell'Interno e il presidente della Camera, adesso ne esce come un uomo
di Stato che è riuscito a sintonizzarsi con gli umori profondi del Paese e con uno
soprattutto: il desiderio dell'Italia, quella migliore, di non essere eccitata. Del resto
regalandogli il suo libro "Kaputt", nella Napoli sconvolta e distrutta appena uscita dalla
seconda guerra, Curzio Malaparte scrisse questa dedica: «A Giorgio Napolitano, che non
perde la calma neppure nell'apocalisse». Non un luogo freddo, ecco, ma una zona di aria
ben temperata non solo dal punto di vista politico ma anche da quello espressivo e del
linguaggio: il Quirinale nell'epoca di Giorgio - e guai a chiamarlo Re Giorgio o peggio
Cool George - questo è stato. E comunque ieri notte è stata l'ultima notte che Napolitano
ha trascorso qui dentro, nel suo appartamento al secondo piano - ma guardandolo da
fuori è il primo piano - nel palazzo che fu dei papi. Adesso da chi verrà occupato il suo
spazio? Uno degli ultimi libri ad essere stato portato via di qui s'intitola «Le istituzioni
della democrazia». Opera di Giuliano Amato a cui ha collaborato - in veste di
introduttore di uno dei capitoli, insieme a Giulio Napolitano, figlio di Giorgio - Sabino
Cassese. Due personalità che, non sotto forma di carta, potrebbero succedere a
Napolitano ma non è questo il tema adesso. È quello del distacco dal potere. E oggi, nel
caso di Napolitano, avverrà al suono dell'Inno di Mameli nel cortile. Senza troppe
fanfare. Senza tocchi personali o note di colore, come accadde per esempio con
Francesco Cossiga il quale, lasciando anticipatamente il Colle, volle che fosse suonato
per lui l'inno della Sardegna. Si chiude il sipario. Oggi si smonta il palcoscenico. E non
c'è nulla di più teatrale dell'assenza di teatralità.
LA NUOVA
Pag 1 Quell’idea di Europa e nazione di Gianfranco Pasquino
Il Presidente che se ne va ha fatto tutto il possibile per “tenere insieme” un sistema
politico che stava disgregandosi. Ha fatto moltissimo, secondo alcuni anche troppo.
Probabilmente se ne va con un po’ di amarezza e di preoccupazione, consapevole che il
sistema non è ancora messo in sicurezza e che proprio la scelta del suo successore
potrebbe produrre forti tensioni. Due stelle polari hanno guidato l’azione di Napolitano
per quasi nove lunghissimi anni: un’idea di nazione, una visione dell’Europa. Come quasi
nessun altro prima di lui, il presidente Napolitano ha inteso rappresentare “l’unità
nazionale” come il suo fondamentale compito a norma di Costituzione. L’ha fatto
spingendo i partiti politici e i loro dirigenti a trovare accordi e a prendere decisioni
condivise. Le “larghe intese” sono state una delle modalità di rappresentare l’unità
nazionale e di procedere a riforme, socio-economiche e istituzionali, tuttora, però,
incompiute. L’ha fatto opponendosi a scioglimenti anticipati del Parlamento, richiesti da
una classe politica composta da ignavi e da presuntuosi, che avrebbero logorato le
istituzioni e gli stessi cittadini elettori senza risolvere nessun problema. L’ha fatto
nominando tre capi del governo e sostenendoli fin dove poteva con il suo prestigio, le
sue indicazioni, i suoi consigli, preziosissimi perché derivanti da cinquant’anni di onorata
esperienza politico-parlamentare. L’ha fatto, infine, "predicando" i valori della libertà,
della partecipazione, dell’appartenenza a una stessa comunità, del senso civico,
dell’impegno politico. Sono valori tanto più credibili poiché da lui non soltanto
annunciati, ma coerentemente praticati. Quella visione d’Europa, di un continente che si
unifica politicamente anche perché condivide una storia, tragica, ma superata, che è
fondato su valori occidentali diventati universali, che si oppone alla violenza e al
fondamentalismo di tutti i tipi, ha fatto la sua (ri)comparsa nella grande marcia di Parigi.
Il Presidente Napolitano, sulla scia del grande combattente federalista Altiero Spinelli,
l’aveva fatta sua, interpretata e manifestata da almeno quarant’anni. L’ha ripetutamente
richiamata nell’assoluta consapevolezza che unicamente in Europa, grazie all’Unione
Europea, agendo credibilmente e responsabilmente, l’Italia e gli italiani (ri)troveranno la
strada della crescita, non soltanto economica, ma politica e culturale. I capi di governo e
di Stato europei e molte università in Italia e nel continente hanno dato ampio
riconoscimento all’europeismo di Napolitano che, purtroppo, continua a non essere
pienamente, in maniera convinta e operosa, tradotto in comportamenti proprio in Italia.
Chiarissimo, ampio e positivo il lascito di Napolitano potrà durare esclusivamente se chi
gli succederà, uomo o donna, avrà, se non le sue stesse, probabilmente inimitabili,
qualità, almeno la volontà e le capacità per svolgere i difficilissimi compiti che l’Italia ha
di fronte. Napolitano è stato molto più di un arbitro, ancorché severo, e di un garante
autorevole. Ha voluto e saputo essere il garante dei cittadini, non dei dirigenti di partito,
il garante del buon funzionamento delle istituzioni, non dei detentori delle cariche. Il
Presidente Napolitano è anche stato, nei limiti della Costituzione ma, talvolta, anche
proiettandosi per necessità oltre, senza mai violarla, un protagonista. Questo suo
innegabile protagonismo ha anche significato l’ineludibile presa d’atto che la
Costituzione, da lui celebrata nel 2008 come una splendida sessantenne con poche
rughe, è esigente con tutti, dai cittadini al Presidente della Repubblica, ai quali impone
doveri democratici. Indiscrezioni suggeriscono che Napolitano, tornato, in veste diversa,
Senatore a vita, si appresta a votare il suo successore. Auguriamo a lui e a noi tutti che
il successore sia più che degno, quindi non una persona di basso profilo e di limitata
autonomia politica, altrimenti turbolentissimi saranno i tempi della Repubblica.
Pag 1 Quanto vale la libertà d’espressione di Vincenzo Milanesi
Oggi è in edicola il nuovo numero di Charlie Hebdo, come promesso, il primo dopo la
strage. Eppure, la questione rimane aperta. Ed è destinata a rimanere tale,
probabilmente. Perché la domanda non ha una risposta immediata, e condivisa:
pubblicare o no la vignette satiriche su Maometto? Sappiamo che per i musulmani la
pubblicazione di quelle vignette - disegnate per far ridere o, meglio, sorridere di
credenze religiose altrui da coloro che quelle credenze ritengono frutto di credulità e
causa di comportamenti socialmente negativi - è considerata una derisione della fede,
ritenuta dal credente portatrice dell’unica verità. Sono una bestemmia, un’offesa non
solo ad Allah e al Profeta, ma anche a tutti i credenti nell’Islam. Ecco allora ben definita
la questione. Da una parte, c’è il valore della libertà di stampa, che è sinonimo di libertà
di pensiero che attraverso la stampa si esprime. Quel valore è venuto facendosi, nella
storia della civiltà europea almeno da cinque secoli, un principio di civiltà giuridica
ritenuto irrinunciabile. Per ragioni che non è neanche il caso qui di ricordare. Senza di
esso non sarebbe possibile nemmeno la democrazia, poiché l’esercizio della libertà del
pensiero di tutti i cittadini e la sua pubblica espressione sono la premessa di una forma
di governo democratica dello Stato. Ma, almeno in apparenza, c’è un altro valore morale
in gioco, un principio etico di cui non può essere, in sé, sottovalutata l’importanza. Ed è
quello del rispetto della sensibilità religiosa di chi pratica una fede ritenendola fonte di
salvezza, sulla base di un annuncio che viene direttamente dalla divinità. Ma c’è davvero
qui l’esistenza di un conflitto di valori? Che è cosa che spesso accade nella vita morale,
che anzi può essere definita, per l’uomo che non rinuncia a ragionare, come il terreno su
cui si confrontano valori contrapposti ogni volta che si compiono scelte di
comportamento non “in automatico”, quando cioè le situazioni richiedono una riflessione
su come agire. C’è però, nel caso in questione, una sorta di asimmetria tra i valori
ritenuti in gioco, riflettendo sulla quale può forse essere abbozzata un’analisi in grado di
aiutarci a decidere come comportarci. Il principio della libertà di espressione, anche
quando ciò che viene espresso può apparire offensivo di una sensibilità altrui, tutela un
diritto che è un bene per tutti. E fonda una società di eguali. Forse, più che un valore in
sé, potrebbe essere definito come un principio che rende possibile a tutti,
indistintamente, esprimere i propri valori, in una società pluralista, quella in cui esiste un
“politeismo dei valori” esprimibili da ciascuno nelle forme che meglio crede. Anche
deridendo la divinità altrui, se lo ritiene opportuno. Pronto però ad accettare che altri
deridano quella in cui egli crede con altre vignette, che possono essere altrettanto
dissacranti, se ne sono capaci. Perché tutti crediamo in qualche “divinità”, in qualche
valore che riteniamo “sacro”. Anche l’ateo più convinto di essere “senza dei”. Il
musulmano che non accetta il principio della libertà di espressione pretende invece che
sia rispettato il suo dio, ma senza reciprocità. E per ottenere questo rispetto è
addirittura pronto, come nel caso dei fondamentalisti fanatici in azione nel nostro tempo,
a uccidere. Il principio del rispetto della sensibilità religiosa non può più allora essere
invocato dal musulmano. Appunto perché diventa pretesa che tutti, nella società
politeista, rispettino il suo dio, senza che, reciprocamente, egli sia disponibile a
rispettare la divinità altrui. Non solo quella dei cristiani o degli ebrei, ma anche quella
costituita, per dir così, dalla libertà di pensiero, principio fondante di una società “laica”,
in cui ha diritto di cittadinanza il politeismo degli dei e dei valori. Che in una società non
confessionale, che proprio per questo si dice “laica”, è un valore sacro esattamente
come la sua propria divinità per il credente. Il valore che il musulmano fondamentalista
in questo caso difende è, insomma, un valore solo per lui. Quello della libertà di
espressione è un valore per tutti. Ecco perché sarebbe una tragedia, per la civiltà non
solo dell’Occidente, ma dell’umanità intera, l’autocensura dei giornali per quelle vignette.
Torna al sommario