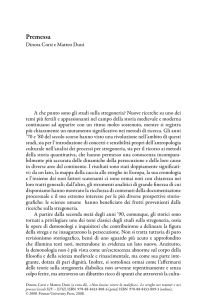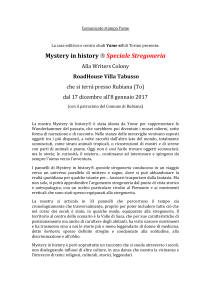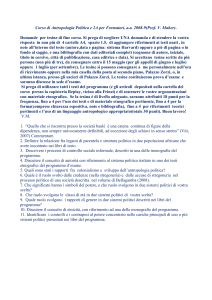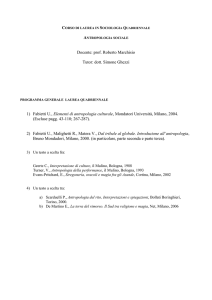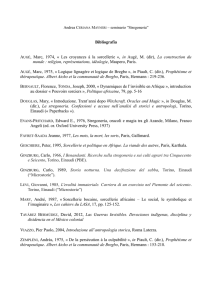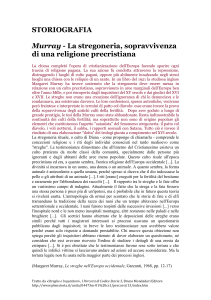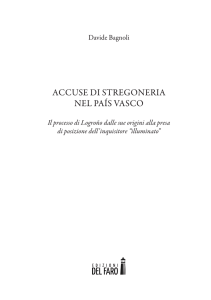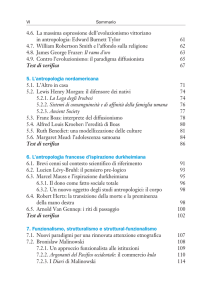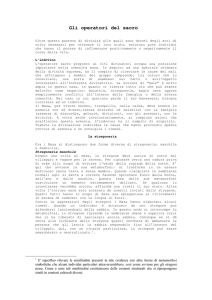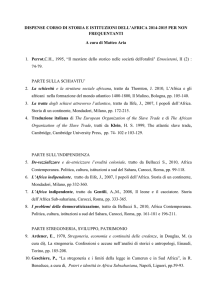da: Pier Paolo Viazzo, Introduzione all’antropologia storica,
Roma-Bari, Laterza, 2000
Capitolo quarto
Antropologi, storici e stregoni
Sotto la spinta della polemica antipagana dei primi secoli cristiani, e più tardi della teorizzazione
demonologica medievale, magia e stregoneria sono venute configurandosi lungo tutta la storia
occidentale come antitesi diabolica della religione. A questa condanna in termini morali si è
sovrapposta, con la rivoluzione scientifica e con l’Illuminismo, una non meno pesante e forse ancor
più decisiva condanna di natura intellettuale, che ha portato a vedere nella magia nulla più che un
insieme di credenze empiricamente false, oscuro retaggio di un’umanità primitiva e superstiziosa.
Nella sua conferenza su Anthropology and History, Evans-Pritchard non aveva potuto fare a meno
di constatare che di magia e stregoneria si erano occupati ben più gli studiosi delle società primitive
che non gli storici dell’Europa, ma aveva sostenuto che a suo parere non esistevano ragioni perché
questi due fenomeni non potessero essere legittimo oggetto di indagine anche per gli storici della
civiltà occidentale1. Keith Thomas era stato tra i primi storici a raccogliere l’invito di EvansPritchard e a mettersi al lavoro. L’antropologia, scriveva nel suo articolo del 1963 a cui più volte
abbiamo fatto riferimento, non aveva scoperto leggi universali sulla magia e sulla stregoneria, ma
una qualche familiarità con la letteratura antropologica avrebbe impedito agli storici di soccombere
alla tentazione di vedere nelle pratiche magiche semplici sopravvivenze irrazionali da spiegare in
termini volterriani come inganno clericale o come credulità popolare2. Prendendo la parola al
convegno dell’associazione degli antropologi sociali britannici del 1968, lo stesso Thomas aveva
tuttavia dovuto smorzare facili entusiasmi da parte degli antropologi ricordando che la stregoneria
era «un argomento che la maggior parte degli storici considera periferico, per non dire bizzarro»3.
Vent’anni dopo la situazione era sorprendentemente cambiata. Nel panorama storiografico
internazionale, osservava Carlo Ginzburg, la stregoneria era passata «dalla periferia al centro, fino a
diventare un tema non solo rispettabile ma addirittura di moda»4. Questa rapida e imprevista fortuna
era in parte il sintomo di una più generale tendenza storiografica verso lo studio della storia di quei
gruppi marginali – dalle donne ai contadini – che nelle cosiddette fonti ufficiali erano generalmente
rappresentati in maniera inadeguata. «Ma nell’importanza assunta dalla stregoneria», rilevava
ancora Ginzburg, «entra anche un elemento più specifico (anche se connesso al precedente):
l’influenza crescente esercitata dall’antropologia sulla storia. Non è un caso che il classico libro
sulla stregoneria tra gli Azande, pubblicato da Evans-Pritchard più di cinquant’anni fa, abbia fornito
1
a Alan Macfarlane e Keith Thomas un inquadramento teorico per i loro studi sulla stregoneria nel
XVII secolo»5.
1. Lo studio antropologico della magia e della stregoneria da Frazer a Evans-Pritchard
Evans-Pritchard ha sempre evitato nei suoi scritti ogni sfoggio di erudizione, e soprattutto nelle sue
monografie etnografiche i riferimenti bibliografici di carattere teorico sono ridotti al minimo. A
Julian Pitt-Rivers, suo allievo a Oxford nei primi anni del secondo dopoguerra, confidò un giorno
che a suo parere i «paludamenti accademici» erano inutili per i lettori che ignoravano una certa
teoria, e superflui per coloro che invece la conoscevano; e a questo proposito portò come esempio la
sua monografia sul pensiero magico degli Azande, un libro che intendeva essere una critica della
teoria della mentalità primitiva di Lévy-Bruhl, ma nel quale il nome di questo studioso veniva
menzionato una volta soltanto in una nota a piè di pagina6. Frutto di una ventina di mesi di ricerca
sul terreno condotti nel Sudan meridionale tra il 1927 e il 1930, Witchcraft, Oracles and Magic
among the Azande si presenta in effetti a prima vista come un’opera puramente etnografica, che si
propone di descrivere e rendere intelligibili al lettore occidentale un insieme di credenze e di
comportamenti lontani dalla sua mentalità. Per assolvere questo compito, tuttavia, Evans-Pritchard
non aveva potuto fare a meno di porsi una domanda di ampia portata teorica: «il pensiero degli
Azande è talmente diverso dal nostro da permetterci solamente di descrivere le loro parole ed
azioni, senza comprenderle, oppure è essenzialmente analogo, benché espresso in un idioma al
quale non siamo abituati?»7. Erano gli stessi cruciali interrogativi che si erano posti antropologi
evoluzionisti come Tylor e Frazer, e sui quali era più recentemente tornato Lévy-Bruhl. Ed è in
effetti sulle tesi avanzate da questi studiosi – come testimoniano due articoli apparsi nel 1933 e nel
1934 in un oscuro bollettino dell’università del Cairo8 – che Evans-Pritchard aveva riflettuto a
lungo al ritorno dal campo, quando per tre anni aveva insegnato sociologia nella capitale egiziana.
Per meglio comprendere l’importanza di uno studio genuinamente etnografico ma al tempo
stesso profondamente teorico come quello di Evans-Pritchard è dunque opportuno ricordare, seppur
brevemente, le tesi di questi studiosi. Il primo punto da notare è che il problema dei rapporti tra
magia, scienza e religione aveva dominato i primordi della riflessione antropologica. Frazer, in
particolare, nelle numerose edizioni del suo famosissimo The Golden Bough aveva tentato
ingegnosamente di dimostrare, attraverso sconfinate analisi comparative, che l’intera esistenza delle
più primitive tra le popolazioni studiate dagli etnologi era pervasa da comportamenti e credenze
2
magiche e che tali comportamenti e credenze erano riconducibili a due principi basilari. «Se
analizziamo i principî di pensiero su cui si basa la magia», aveva scritto, «troveremo probabilmente
che essi si risolvono in due: primo, che il simile produce il simile, o che l’effetto rassomiglia alla
causa; secondo, che le cose che siano state una volta a contatto, continuano ad agire l’una sull’altra,
a distanza, dopo che il contatto fisico sia cessato»9. Era il primo principio, quello della «magia
omeopatica», che conduceva il selvaggio a ritenere che lo spillone piantato in una bambola di cera
equivalesse a una pugnalata nel corpo del nemico, mentre era il secondo principio, quello della
«magia contagiosa», a convincerlo di poter nuocere a un nemico agendo sui suoi capelli. Frazer non
si era però limitato a sostenere che la visione del mondo del primitivo era essenzialmente magica;
aveva aggiunto che una tale visione del mondo, lasciando trasparire una teoria della causalità
fondata sulla credenza in forze impersonali, tendeva a opporsi alla religione e ad avvicinarsi a un
atteggiamento di tipo scientifico. Proprio questa somiglianza permetteva tuttavia di valutare l’abisso
che separa la magia dalla scienza e, per implicazione, il livello mentale del primitivo da quello
dell’uomo moderno colto. Al pari delle leggi scientifiche, i due principi magici fondamentali (che
Frazer chiamava non a caso «legge di similarità» e «legge del contatto») costituiscono il punto
d’arrivo di un’osservazione del mondo naturale, ma a differenza delle leggi scientifiche essi si
basano su «associazioni di idee» totalmente erronee.
Frazer pubblicò l’ultima edizione del suo più celebre lavoro nel 1922, dunque nello stesso
anno in cui apparvero in Francia La mentalité primitive di Lévy-Bruhl e in Inghilterra gli Argonauts
of the Western Pacific di Malinowski. Filosofo di formazione e di interessi, ma influenzato dalla
scuola sociologica francese e come Durkheim e i suoi allievi propenso a utilizzare ampiamente
materiali etnografici, Lévy-Bruhl suggeriva l’esistenza di una differenza radicale tra la mentalità del
civilizzato e quella del primitivo: quest’ultima sarebbe stata infatti caratterizzata da un pensiero
«prelogico» che non conosceva i principi di identità, contraddizione e causalità su cui poggiano i
procedimenti logici occidentali e consentiva pertanto di accettare ciò che ai nostri occhi appare
impossibile, incredibile, assurdo. Come abbiamo visto, le tesi di Lévy-Bruhl colpirono Marc Bloch,
che nel completare la stesura del suo libro sui re guaritori stava tentando di spiegarsi come le
popolazioni francesi e inglesi di antico regime avessero potuto «accettare come reale un’azione
miracolosa, anche se smentita in modo persistente dall’esperienza»10. Molte perplessità suscitavano
invece in un antropologo come Malinowski, che facendo leva sulla sua prolungata esperienza di
campo denunciava la tendenza di studiosi da tavolino come Frazer o Lévy-Bruhl a concentrarsi
sugli aspetti più sorprendenti o bizzarri della vita dei primitivi, ignorando la grigia normalità della
maggior parte della loro esistenza e accentuando così la differenza tra civilizzati e «selvaggi».
3
Uno degli obiettivi principali della produzione scientifica e della pubblicistica di
Malinowski negli anni venti fu quello di dimostrare quanto questa differenza fosse stata
indebitamente esagerata. «Il professor Lévy-Bruhl», scriveva in un saggio del 1925 dedicato
specificamente a magia, scienza e religione, «ci dice, in poche parole, che l’uomo primitivo … è
irrimediabilmente e totalmente immerso in una struttura mentale ‘mistica’. Incapace di osservazione
spassionata e coerente, privo del potere di astrarre, ostacolato da una ‘risoluta avversione al
ragionamento’, egli non è in grado di ricavare alcun beneficio dall’esperienza, di costruire o di
capire neanche le più elementari leggi della natura» 11. Ma davvero il selvaggio era completamente
immerso in un universo «mistico», privo di conoscenze basate sull’esperienza, incapace di
esercitare un qualche dominio razionale sul suo ambiente? La risposta di Malinowski, che utilizzava
con grande forza persuasiva il materiale etnografico da lui raccolto nelle isole Trobriand, era che in
realtà il primitivo distingue con chiarezza la sfera della magia dalla sfera delle attività empiriche, e
sa benissimo che in condizioni normali il buon esito di un raccolto o di una pesca dipende
unicamente dalla sua abilità e dalla sua esperienza: alla magia – non diversamente dal civilizzato, in
fondo – ricorrerà soltanto per assicurare il successo di un’impresa incerta e pericolosa o per
fronteggiare un evento eccezionale contro cui nulla possono le sue conoscenze tecnico-scientifiche.
Quando cominciò ad occuparsi a fondo delle tesi di Lévy-Bruhl, anche Evans-Pritchard era
reduce da una lunga ricerca intensiva sul terreno, e non poteva non concordare con Malinowski
nell’addebitare all’inesperienza etnografica del filosofo francese una fuorviante accentuazione dei
caratteri «mistici» dei comportamenti e delle credenze dei primitivi. Ma questa non è che una delle
numerose critiche che Evans-Pritchard rivolge al filosofo francese nel suo saggio del 1934: quando
Lévy-Bruhl ci contrappone ai primitivi, si domanda ad esempio Evans-Pritchard, chi siamo noi e chi
sono i primitivi? E’ sensato attribuire una stessa mentalità al filosofo della Sorbona e al contadino
bretone?12 Con tutto ciò, trent’anni più tardi Evans-Pritchard poteva affermare di essere stato «uno
dei pochi antropologi, in Inghilterra o in America, ad avere parlato in favore di Lévy-Bruhl»,
sottolineando quelli che gli sembravano gli aspetti più originali e fecondi delle sue teorie13. Di
Lévy-Bruhl aveva apprezzato un orientamento sociologico che si contrapponeva alle spiegazioni in
termini di psicologia individuale fornite dagli evoluzionisti: per Tylor e Frazer l’uomo primitivo
credeva nella magia in quanto, partendo dalle proprie osservazioni, ragionava in maniera scorretta,
mentre per Lévy-Bruhl il suo ragionamento era determinato dalle rappresentazioni collettive della
società a cui apparteneva. Il punto più importante, secondo Evans-Pritchard, era però che LévyBruhl, a dispetto di quanto il termine «prelogico» sembrava suggerire, non si era proposto –
diversamente dagli evoluzionisti – di tracciare lo sviluppo della razionalità umana da forme inferiori
4
a forme superiori, ma aveva cercato di ricostruire i modi di funzionamento di una razionalità diversa
dalla nostra e ad essa incommensurabile:
Lévy-Bruhl non sostiene che i primitivi mancano di intelligenza, ma che le loro credenze sono
incomprensibili per noi. Questo non significa che noi non possiamo seguire i loro ragionamenti. Possiamo far
ciò in quanto essi ragionano in una maniera del tutto logica; tuttavia essi partono da premesse differenti –
premesse che sono per noi assurde. Hanno la capacità di ragionare, ma ragionano usando categorie differenti
dalle nostre. Sono logici, ma i principi della loro logica non sono i nostri, non sono cioè quelli della logica
aristotelica14.
Evans-Pritchard ha scritto che nel 1934 la sua difesa di Lévy-Bruhl aveva dovuto essere in buona
parte esegetica, essendo sua convinzione che «uno studioso debba essere criticato per ciò che ha
detto, e non per ciò che gli si attribuisce di aver detto»15. Leggendo queste righe è però difficile non
sospettare che la sua interpretazione non sia stata soltanto corretta e penetrante, ma abbia arricchito
e precisato le intuizioni di Lévy-Bruhl riconsiderandole alla luce di quanto era emerso dalla ricerca
tra gli Azande.
Fin dai primi giorni passati sul campo, scrive Evans-Pritchard nelle pagine introduttive di
Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, era divenuto evidente che gran parte
dell’esistenza di questa popolazione centroafricana era percorsa dal concetto di mangu, una nozione
che si può rendere in inglese con witchcraft e in italiano con «stregoneria». Ogni evento funesto o
spiacevole (dalla morte di un parente in seguito al crollo di un granaio fino al comportamento
scontroso di una moglie) era attribuito al mangu, un termine che designava sia una sostanza
materiale che secondo gli Azande si trovava nei corpi di certe persone e si trasmetteva
ereditariamente, sia una supposta emanazione psichica di questa sostanza. La sostanza mangu
poteva essere scoperta nei morti attraverso un’autopsia, ma più spesso veniva diagnosticata nei vivi
mediante il ricorso a un oracolo (soroka) che permetteva di individuare il colpevole. Una volta
individuato il colpevole, i parenti della vittima potevano affrontarlo direttamente, oppure portare
l’accusa di fronte alla corte di un principe, o ancora affidarsi all’azione di una magia di vendetta.
Stregoneria, oracoli e magia erano i tre lati di un triangolo dai caratteri inconfondibilmente
«mistici», per usare il termine di Lévy-Bruhl. Il fitto tessuto etnografico che emerge dalle
osservazioni condotte sul campo da Evans-Pritchard, e soprattutto dai testi delle molte
conversazioni da lui avute nei venti mesi trascorsi sul campo, rivela però che gli Azande non
percepivano gli avvenimenti in maniera radicalmente diversa da noi occidentali, come Lévy-Bruhl
aveva supposto: ad esempio, i parenti della vittima vedevano benissimo che erano state le termiti a
erodere il sostegno del granaio e a provocarne il crollo, e sapevano dunque perfettamente come era
5
avvenuta la disgrazia. Ma perché la disgrazia si era abbattuta proprio su quel loro parente? Era a
questa seconda domanda, ben più profonda e radicale da un punto di vista esistenziale, che la
credenza nella stregoneria dava risposta.
Una delle ragioni che rendono la monografia del 1937 un punto di svolta nello studio
antropologico della magia e della stregoneria è che essa, mettendo in luce l’esistenza presso gli
Azande di due ben diverse teorie della causalità, permise di individuare una cruciale debolezza nelle
precedenti discussioni della magia e determinò in ultima analisi un riorientamento della ricerca. Lo
studio in termini astratti dei rapporti tra magia e scienza fu quasi del tutto abbandonato e
l’attenzione degli antropologi si concentrò sul ruolo esplicativo e consolatorio che sistemi
istituzionalizzati di credenze «magiche» hanno avuto e hanno tuttora in moltissime di quelle società
che si è soliti definire tradizionali. L’efficacia e la stessa sopravvivenza di questi sistemi di credenze
dipendono peraltro dalla loro coerenza interna e dalla capacità di difendersi dall’infiltrazione di
elementi esterni che possano minarne l’autorità. Offrendo una ricca e precisa esemplificazione
etnografica di quelle che in Lévy-Bruhl erano spesso rimaste brillanti intuizioni, in una serie di
affascinanti capitoli Evans-Pritchard faceva comprendere al lettore che l’insieme di idee imperniate
sul concetto di mangu costituiva un sistema dotato di struttura logica: azioni e deduzioni a prima
vista curiose o assurde risultavano del tutto razionali se riportate ai postulati basilari che
governavano l’universo conoscitivo zande. Il materiale raccolto da Evans-Pritchard mostrava inoltre
come una straordinaria plasticità permettesse al sistema di reagire con successo a quelle che un
occhio occidentale avrebbe giudicato contraddizioni o falsificazioni fatali. Se ad esempio un evento
posteriore avesse dimostrato che l’oracolo aveva sbagliato nell’emettere un verdetto, la fede
nell’oracolo non veniva meno: l’errore veniva attribuito alla violazione di un tabù o di una delle
regole procedurali che dovevano essere seguite nella consultazione dell’oracolo, o si poteva
addirittura ipotizzare che lo stesso oracolo fosse stato stregato e reso inefficiente.
Questa rivoluzionaria analisi di un sistema di pensiero «primitivo» molto doveva allo
stimolo dei lavori di un filosofo come Lévy-Bruhl, e non stupisce che abbia a sua volta influenzato
numerosi filosofi, e in modo particolare alcuni dei maggiori epistemologi della seconda metà del
Novecento. Il primo epistemologo a farne ampio uso fu probabilmente Michael Polanyi, che nel
1958 sostenne che la stabilità delle teorie scientifiche era dovuta a meccanismi di difesa del tutto
simili a quelli messi in evidenza da Evans-Pritchard nella sua analisi del pensiero zande16.
Tracciando un audace parallelo che avrebbe certo sorpreso Frazer, Polanyi suggerì che le comunità
di scienziati impegnate nella difesa delle loro teorie sono per molti versi non meno impermeabili
all’evidenza empirica di quanto possa esserlo una tribù africana. Erano tesi che anticipavano di
qualche anno quelle avanzate da Kuhn, che nel 1962 doveva contribuire in maniera dirompente ad
6
appannare l’immagine popperiana della scienza come sistema aperto, descrivendo con grande
incisività le strategie messe in atto dalle comunità scientifiche per preservare la stabilità dei
«paradigmi», e soprattutto la tendenza degli scienziati ad apportare migliorie e a ricercare difetti
negli esperimenti piuttosto che nella teoria17 – strategie e comportamenti che, come è stato notato,
presentano «innegabili ‘arie di famiglia’ con le elaborazioni secondarie e i meccanismi difensivi
descritti da Evans-Pritchard a proposito degli Azande»18. Si comprende che il libro di EvansPritchard abbia attirato l’attenzione di Paul Feyerabend, che assegnando nel suo fortunatissimo libro
Against Method un posto d’onore ai lavori degli antropologi sulla stregoneria, e in particolare a
quello di Evans-Pritchard, ha reso definitivamente familiari gli stregoni zande ai filosofi della
scienza19.
A fare di Witchcraft, Oracles and Magic un testo decisivo per lo studio antropologico della
stregoneria non furono però soltanto l’individuazione da parte di Evans-Pritchard di due diverse
teorie della causalità e la dimostrazione etnografica dell’esistenza di meccanismi di difesa capaci di
garantire una stabilità quasi omeostatica a un sistema di pensiero. Un terzo e non meno importante
contributo consiste nell’avere per la prima volta saputo porre in relazione un insieme di credenze
«mistiche» con la struttura sociale soggiacente. Tra gli Azande la credenza nella stregoneria forniva
una spiegazione alle sventure postulando, anziché misteriosi e spesso lontani esseri soprannaturali,
soltanto il sinistro potere e la malevolenza di esseri umani ben conosciuti dalla vittima e dai suoi
parenti, e trovava una drammatica espressione in accuse che non colpivano a caso ma tendevano a
dirigersi verso categorie ben definite di individui. In una società rigidamente stratificata come
quella zande, nessuna accusa veniva rivolta dalla gente comune a un nobile: le accuse si muovevano
orizzontalmente, per così dire, e i primi nomi ad essere sottoposti al responso dell’oracolo erano
generalmente quelli di vicini con i quali vi erano stati attriti, e che venivano quindi sospettati di
inimicizia e ostilità. Accusati potevano essere sia uomini sia donne, ma erano gli anziani a suscitare
più spesso il sospetto, mentre i bambini non venivano ritenuti capaci di stregoneria. Non limitando
la sua analisi alle credenze, ma registrando accuratamente anche la direzione e la frequenza delle
accuse, Evans-Pritchard disegnava una mappa delle tensioni interpersonali che percorrevano la
struttura sociale di una comunità. Apriva così la via a una lunga serie di studi che si sarebbero
concentrati soprattutto sulla distribuzione sociologica e sulla direzione delle accuse, mostrando che
i tratti morfologici di gruppi sociali diversi potevano essere correlati a una diversa distribuzione
delle accuse e, secondo alcuni antropologi, anche a tipi diversi di rappresentazione collettiva delle
caratteristiche di streghe e stregoni20.
Nei primi due decenni del secondo dopoguerra questo filone di ricerche sulla sociologia
delle accuse di stregoneria è stato uno dei più fiorenti nell’ambito dell’antropologia sociale. Queste
7
ricerche hanno confermato che le accuse tendono a coinvolgere persone che secondo le aspettative
della propria società dovrebbero intrattenere rapporti amichevoli, come i vicini tra gli Azande, ma
che nei fatti si trovano in disaccordo o addirittura in situazioni di aperto conflitto. In più, hanno
mostrato che l’accusa di stregoneria può rappresentare un mezzo efficacissimo per troncare una
relazione sociale e viene molto sovente usata per portare un conflitto alle estreme conseguenze e
produrre effetti politici quali la fissione di un lignaggio o la divisione scismatica di una popolazione
di villaggio21. Per l’antropologo le accuse di stregoneria erano dunque uno strumento di grande
sensibilità per misurare sul terreno il livello di tensione sociale e ricercarne le cause, ma le
regolarità che emergevano da una letteratura sempre più ricca sembravano offrire anche utili
indicazioni comparative. Nell’introdurre il convegno dell’associazione degli antropologi sociali del
1968, Mary Douglas deplorava che, delle vie aperte dalla monografia di Evans-Pritchard, questa
fosse stata di gran lunga la più battuta. Witchcraft, Oracles and Magic aveva voluto essere prima di
tutto un libro di sociologia della conoscenza, e «ci si sarebbe attesi che stimolasse una serie di studi
sui condizionamenti sociali della percezione. Ha invece generato studi di micropolitica»22. Il nitido
quadro analitico cumulativamente costruito da questi studi, e la straordinaria qualità della
descrizione e dell’analisi che caratterizza i migliori di essi, non potevano tuttavia lasciare
indifferenti gli storici che verso la metà degli anni sessanta si trovavano ad affrontare, sia pure in
contesti molto diversi, temi simili a quelli investigati dagli antropologi soprattutto in Africa. Ed è in
effetti di questo quadro analitico che si servono ampiamente, proprio a partire dalle relazioni
presentate al convegno del 1968, alcuni degli storici che hanno contribuito in maniera decisiva
all’edificazione di quello che è stato definito il «nuovo paradigma» nello studio storico della
stregoneria, un paradigma inequivocabilmente storico-antropologico.
2. Due paradigmi nello studio storico della stregoneria
La pubblicazione del De crimine magiae di Christian Thomas, il filosofo e giurista tedesco più noto
con il nome latinizzato di Thomasius, inaugurava nel 1701 un secolo di dibattito illuministico su
magia, stregoneria e demonologia. La «caccia alle streghe» scatenatasi verso la fine del medioevo si
era conclusa solo da pochi decenni e gli intellettuali europei si domandavano se la stregoneria
dovesse considerarsi un delitto da punire o piuttosto una fantasia da compatire. Un secolo e mezzo
più tardi, in un clima saldamente positivista, le credenze magiche apparivano ormai confinate al
popolino o ai selvaggi – dunque oggetto di studio appropriato per la nascente antropologia – mentre
8
i processi di stregoneria venivano sempre più visti come una macchia nella storia europea di cui era
tempo che iniziassero a occuparsi gli storici.
Uno dei primi frutti di questa nuova stagione di ricerca fu nel 1862 La Sorcière, un libro
audace in cui Jules Michelet, il grande storico della rivoluzione francese, studiava la figura della
strega dall’«età leggendaria» di cui si potevano ancora trovare tracce nel folklore europeo fino alla
sua età più propriamente storica, documentata dagli atti dei processi inquisitoriali23. Michelet era da
più di dieci anni caduto in disgrazia a causa del suo rifiuto di prestare giuramento al nuovo governo
francese dopo la fine della seconda repubblica, rifiuto che gli era costato l’allontanamento prima
dall’insegnamento universitario e
poi dalla direzione della sezione storica degli Archivi. La
pubblicazione di questo libro che affrontava argomenti scabrosi e non rifuggiva dal linguaggio forte
non contribuì certo a riguadagnargli il favore delle autorità: la prima edizione fu immediatamente
mandata al macero e sostituita da un’edizione espurgata24. Era anche un’opera di difficile
classificazione: un libro di storia, documentato su carte d’archivio, ma anche un libro scritto come
un romanzo, con uno stile che suscitò l’entusiasmo di Victor Hugo25. Questa «duplicità feconda»,
ha scritto Roland Barthes, uno dei suoi maggiori estimatori moderni, poneva in luce «un taglio
nuovo del reale», fondando «quella che si potrebbe chiamare un’etnologia o una mitologia
storica»26. Già amata dalla scuola delle «Annales», al pari di altre opere di Michelet, come esempio
avanti lettera di storia integrale e di antropologia storica27, La Sorcière è indubbiamente un libro che
colpisce oggi tanto per la sua impronta «protofemminista» (è una storia della figura femminile della
strega, non della stregoneria) quanto per una scrittura sorprendentemente vicina ai canoni
postmodernisti. Ma nella seconda metà dell’Ottocento questa ambiguità di genere allontanò
ulteriormente Michelet dalla storiografia positivista, e La Sorcière non lasciò tracce immediate.
Molto più influente fu un contemporaneo di Michelet, il tedesco Wilhelm Gottlieb Soldan,
un teologo liberale che nel 1843 aveva dato alle stampe la prima storia sistematica dei processi alle
streghe (un lavoro di cui lo stesso Michelet si era ovviamente servito), avviando un’opera di
raccolta, pubblicazione e interpretazione delle fonti processuali che doveva essere proseguita da
storici come Henry Charles Lea, George Lincoln Burr, Wallace Notestein e soprattutto Joseph
Hansen, che nel 1901 pubblicò una monumentale raccolta di materiali (le Quellen und
Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter) destinata
a rimanere un punto di riferimento obbligato per almeno tre generazioni di studiosi28. Soldan, Lea,
Burr, Notestein e Hansen sono i più noti rappresentanti di quello che nel 1972, quando già stava
profilandosi un modo nuovo di avvicinarsi alla stregoneria europea, è stato definito il «paradigma
soldaniano»29. Una delle caratteristiche di questo «paradigma», che ha dominato la ricerca sulla
stregoneria europea per più di un secolo, è stata la dura critica alle gerarchie ecclesiastiche e civili
9
responsabili della caccia alle streghe. Di idee dichiaratamente liberali, questi studiosi si sono
occupati quasi esclusivamente degli aspetti inquisitori e giuridici dei processi, denunciando la
scorrettezza delle procedure seguite e condannando i modi di formulare le domande e un sistema di
acquisizione delle prove che non aveva esitato a far ricorso alla tortura o ad altri mezzi di estorsione
delle confessioni. Ingiustamente accusate, e processate seguendo procedure arbitrarie e ripugnanti
agli occhi del giurista moderno, nei lavori degli esponenti del «paradigma soldaniano» le vittime
della caccia alle streghe venivano lodevolmente, anche se tardivamente, riabilitate. La possibilità
che le confessioni rese agli inquisitori potessero contenere un «nocciolo di verità», e che la
stregoneria avesse dunque avuto una qualche reale consistenza, non veniva neppure presa in
considerazione.
Una rotta del tutto diversa seguì Margaret Murray, che nel 1921 pubblicò un volume sulla
stregoneria europea dal titolo inevitabilmente destinato a suscitare controversie e dal sottotitolo
significativo: The Witch-Cult in Western Europe. A Study in Anthropology. La Murray, lo si è
visto30, non era propriamente un’antropologa, ma conosceva certamente bene la letteratura
antropologica e in particolare gli studi comparativi di Frazer. Soprattutto possedeva una sensibilità
antropologica che la spingeva a porre ai documenti quelle domande che avrebbero portato un paio
di decenni più tardi Geoffrey Gorer a raccomandare i suoi libri come esempi del contributo che
l’antropologia poteva offrire alla ricerca storica. Sin dalle prime pagine del suo libro la Murray
prendeva nettamente le distanze da quegli scettici, antichi e moderni, che avevano negato ogni
credito alle affermazioni delle donne e degli uomini che avevano confessato di essere streghe e
stregoni, sostenendo che gli accusati «soffrivano di allucinazioni, di isteria o, per usare un termine
moderno, di ‘autosuggestione’»31. L’incredulità degli storici moderni non poteva far dimenticare
che nel periodo dei processi alle streghe lo scetticismo era venuto da personalità che la Murray non
esitava a definire grigie e mediocri – nobilotti di campagna, predicatori fanatici, addirittura
ubriaconi – mentre alla realtà della stregoneria avevano prestato fede «le menti più brillanti, le
intelligenze più profonde, gli investigatori più grandi», primo fra tutti Jean Bodin, il filosofo
politico francese che nel 1580 aveva pubblicato un trattato sulla Démonomanie des Sorciers in cui
confutava vigorosamente le argomentazioni degli scettici32. Era dunque necessario che la questione
venisse sottoposta a un riesame critico e libero da pregiudizi, tralasciando le opinioni dei
commentatori e attenendosi unicamente ai «fatti documentati». Ma questo non era sufficiente. «E’
solo mediante un’accurata comparazione con i dati dell’antropologia», scriveva la Murray, «che i
fatti si collocano al loro giusto posto e una religione organizzata si rivela ai nostri occhi»33.
Inserendo in un quadro coerente gli elementi frammentari e disparati che emergevano dalle
confessioni di streghe e stregoni, l’antropologia consentiva di risolvere un immenso rompicapo,
10
facendo riaffiorare – tessera dopo tessera – l’immagine dimenticata di un insieme organico di culti
della fertilità animale e vegetale dalle antichissime radici preagricole, che nel tardo medioevo e nei
primi secoli dell’età moderna era ancora, sotto la coltre cristiana, la religione dominante delle masse
rurali europee. Le prove dell’esistenza di quella che secondo la Murray non era soltanto
un’accozzaglia di superstizioni isolate ma una vera e propria religione, caratterizzata da ministri del
culto, rituali, simbologie e calendari festivi comuni a tutto il territorio europeo, venivano soprattutto
dalle descrizioni che gli accusati avevano fatto del sabba. I processi celebrati tra il XV e il XVII
secolo da un capo all’altro dell’Europa lasciavano infatti trasparire una straordinaria uniformità di
testimonianze da parte di coloro che sostenevano di avere partecipato a questi convegni notturni. La
Murray era consapevole delle obiezioni che potevano venire rivolte alla sua tesi: innanzitutto che le
confessioni erano state estorte sotto tortura, e poi che queste descrizioni venivano «messe in bocca»
agli accusati dagli inquisitori e dai redattori dei verbali degli interrogatori seguendo modelli diffusi
in tutta Europa dalla manualistica demonologica. La Murray replicava però che «anche concedendo
che queste testimonianze siano state rese sotto tortura e in risposta a domande allusive, rimane
ancora una massa di particolari che non possono essere ignorati»34. I questionari di cui si servivano
gli inquisitori potevano deformare e uniformare le descrizioni fornite dagli accusati nei loro tratti
generali, ma non potevano dar conto di certi particolari a prima vista insignificanti e invece decisivi
per segnalare la diffusione di pratiche e credenze straordinariamente simili fra di loro e decifrabili
alla luce dei risultati a cui era giunta la ricerca antropologica comparativa sulle religioni primitive e
sui loro riti di fertilità.
Immediate reazioni negative da parte degli studiosi che aderivano al «paradigma
soldaniano» naturalmente non mancarono35, ma le ardite teorie proposte da The Witch-Cult in
Western Europe conobbero ugualmente un successo rapido e vasto. La migliore dimostrazione
dell’autorevolezza in materia che veniva riconosciuta alla Murray già pochi anni dopo la
pubblicazione del suo libro fu probabilmente l’incarico di redigere la voce «Witchcraft» per la
quattordicesima edizione dell’Encyclopaedia Britannica, apparsa nel 1929. Le sue tesi erano però
destinate a perdere terreno non meno rapidamente. A minarne la base fu soprattutto, a parere di
Carlo Ginzburg, il fatto che la Murray, per sostenere la realtà degli eventi menzionati nella
descrizione del sabba, era stata «costretta a tacerne gli elementi più imbarazzanti – il volo notturno,
le trasformazioni in animali – ricorrendo a tagli che si configuravano come vere e proprie
manipolazioni testuali»36. Era un peccato capitale che gli storici positivisti non potevano perdonare.
Già nel 1931 il suo secondo libro sulla religione delle streghe fu un insuccesso37, e nel 1940 la voce
ammirata di Gorer era ormai pressoché isolata. Non era comunque la voce di uno storico, ma di un
antropologo: presentare come esempi del contributo che l’antropologia poteva offrire alla storia
11
proprio i libri di un’autrice che aveva commesso il più grave dei peccati di cui poteva macchiarsi
uno storico aveva quasi il sapore della provocazione.
In realtà Gorer aveva intuito quanto gli storici avrebbero iniziato a comprendere solo un
quarto di secolo più tardi. Per il momento la caccia alle streghe continuò a essere considerata un
capitolo secondario e doloroso della storia religiosa dell’Occidente e il suo studio continuò a
occupare, in ambito storiografico, una posizione periferica e neppure troppo rispettata. Lo studio
della stregoneria come insieme di credenze e pratiche rituali continuò a essere affidato a folkloristi e
antropologi. L’unica eccezione di rilievo fu probabilmente rappresentata da Lucien Febvre (non a
caso uno dei grandi estimatori di Michelet), che in un breve articolo del 1948 prendeva spunto dalla
pubblicazione di un volume su processi di stregoneria celebrati in una zona della Franca Contea nei
primi anni del Seicento per porre ai lettori delle «Annales» quello che gli sembrava un problema di
primaria importanza. «Come spiegare che gli uomini più intelligenti, più colti, più integri di
un’epoca» abbiano potuto tutti, senza distinzione di religione, credere nella realtà della stregoneria?
Come spiegare «che un Bodin, il grande Jean Bodin, uno degli spiriti più vigorosi del suo tempo,
uomo curioso che di tutto si è occupato e nel modo più felicemente personale: lingue, diritto, storia,
geografia, matematica, astronomia … sia la stessa persona che nel 1580 ha pubblicato uno dei libri
più rattristanti di quest’epoca, quel trattato sulla Démonomanie des Sorciers di cui non si contano
più le edizioni?»38. Al di là della sua travolgente retorica, questo passo di Febvre ci permette di
cogliere con nitidezza la differenza tra la sua posizione e quella della Murray. Per quest’ultima, che
si proclama una «credente» nella realtà della stregoneria, il fatto che Jean Bodin e altri suoi
contemporanei di grande cultura e intelletto avessero prestato fede alle confessioni di streghe e
stregoni non stupisce. Per Febvre, che alla realtà della stregoneria non crede, questo fatto costituisce
invece un problema che non si può risolvere semplicemente «parlando con disdegno della credulità
dei nostri padri del tempo di Enrico IV e Luigi XIV e considerandoli con disgusto dei selvaggi»39.
Riecheggiando alcune tesi avanzate pochi anni prima nel suo libro sull’incredulità nel XVI secolo 40,
a cui non erano estranee suggestioni lévy-bruhliane, Febvre suggerisce che «nella sua struttura
profonda la mentalità degli uomini più illuminati della fine del XVI secolo e dell’inizio del XVII
deve aver differito, e radicalmente, dalla mentalità degli uomini più illuminati del nostro tempo. Tra
noi e loro devono aver avuto luogo delle rivoluzioni; di quelle rivoluzioni dello spirito che
avvengono senza rumore e che nessuno storico si cura di registrare»41.
Era un programma storiografico che, direttamente ispirato da queste considerazioni di
Febvre, avrebbe dato i suoi primi importanti risultati solo una ventina d’anni più tardi con la
pubblicazione di Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle di Robert Mandrou e, al di là
della Manica, del lungo e famoso saggio di Hugh Trevor-Roper sulla caccia alle streghe del XVI e
12
XVII secolo42. Se il libro di Mandrou voleva essere prima di tutto uno studio accurato della
psicologia collettiva di un preciso gruppo sociale, quello dei magistrati, e dei dibattiti che avevano
permesso la nascita di una nuova giurisprudenza, il saggio di Trevor-Roper si proponeva di spiegare
per quali ragioni le credenze nella stregoneria si fossero trasformate, proprio negli anni che segnano
l’inizio della rivoluzione scientifica, in una forza esplosiva capace di scatenare la più selvaggia e
insensata persecuzione conosciuta dal mondo occidentale prima degli orrori del XX secolo. La
spiegazione offerta da Trevor-Roper era in ultima analisi una variante della teoria del «capro
espiatorio». Nei primi decenni dell’età moderna si sarebbe prodotta una particolare congiuntura
storica che richiedeva un’assegnazione di responsabilità per le sventure e le tensioni che
travagliavano l’Europa: il ciclo epidemico della peste, la ripresa delle guerre di religione, i rigorismi
di Riforma e Controriforma. In una società europea dilaniata al suo interno da conflitti sociali e
religiosi, la stregoneria sarebbe divenuta una sorta di nevrosi collettiva e gli uomini e soprattutto le
donne accusate di stregoneria sarebbero state le vittime di questo delirio e di una credulità che in
misura crescente si era impadronita degli strati più elevati e colti della popolazione europea.
Al saggio di uno studioso illustre come Trevor-Roper va riconosciuto, ancor più forse che al
libro di Mandrou, l’indubbio merito di avere per la prima volta conferito legittimità e addirittura
prestigio alla stregoneria come tema storiografico. Questo saggio, tuttavia, oltre che discutibile in
alcune delle sue tesi, appare oggi del tutto estraneo all’impostazione delle ricerche storiche sulla
stregoneria condotte nei decenni seguenti: si tratta infatti, come ha osservato ancora Ginzburg, «di
una presentazione di carattere generale, che cerca di tracciare le linee fondamentali della
persecuzione della stregoneria, scartando sdegnosamente la possibilità di utilizzare il contributo
degli antropologi»43. Lo storico inglese non ha d’altra parte mai fatto mistero, prima e dopo il 1967,
della sua scarsa simpatia per l’antropologia. «Alcuni storici», scriverà nel 1973, «sono stati
recentemente molto attivi nel dirci che dovremmo introdurre più antropologia nello studio della
storia e che comprenderemmo meglio le attività degli uomini, ad esempio, nell’Inghilterra del
Seicento, se conoscessimo qualcosa di più sul comportamento di tribù sudanesi o bantu». TrevorRoper non era d’accordo. Le lezioni che l’antropologia era in grado di offrire allo storico non
potevano che essere semplici e generali, e non c’era quindi «nessun bisogno per gli storici
dell’Europa di seppellirsi nei particolari delle pratiche endogamiche o esogamiche delle tribù
polinesiane»44. A differenza di Margaret Murray, nelle sue ricerche sulla stregoneria non aveva
effettivamente sentito alcun bisogno di prestare attenzione ai particolari di quelle che a suo parere
erano soltanto credulità contadine o allucinazioni di donne isteriche45, quando non addirittura
«fantasticherie di montanari» i cui cervelli non potevano funzionare bene a causa dell’aria rarefatta.
Schierandosi dalla parte delle vittime della caccia alle streghe del XVI e XVII secolo, Trevor-Roper
13
era l’estremo rappresentante del paradigma storiografico positivista e liberale di cui Soldan aveva
gettato le fondamenta. Rispettava le vittime della persecuzione, assai meno le loro rustiche
credenze.
Non si rischia di sbagliare affermando che gli storici «filoantropologici» a cui Trevor-Roper
alludeva erano prima di tutto Keith Thomas e Alan Macfarlane, i quali a loro volta non avevano
nascosto la propria insoddisfazione nei confronti del saggio di Trevor-Roper, di cui non
apprezzavano soprattutto il fatto che si trattasse, per riprendere le parole di Ginzburg, di una
«presentazione di carattere generale». Tracciando a grandi linee la storia dell’esplosione e del
declino della caccia alle streghe e concentrandosi sulla ricerca delle cause di questi mutamenti,
Trevor-Roper dava come scontato che sulla stregoneria europea si sapesse tutto ciò che c’era
fattualmente da sapere. Proprio nel 1967 il ventiseienne Macfarlane aveva completato a Oxford,
sotto la guida di Thomas, una tesi di dottorato basata su approfondite analisi degli atti processuali
conservati negli archivi dell’Essex46 e aveva potuto rendersi conto che in realtà sulla stregoneria si
sapeva pochissimo. Le note a piè di pagina del saggio di Trevor-Roper, constatava Macfarlane,
mostravano che «la documentazione era la stessa di quella usata da Lea, da Soldan, da Hansen e
dagli altri autori del XIX secolo che sono così costantemente citati», e le domande poste a tale
documentazione non erano diverse da quelle che avevano affaticato questi studiosi ottocenteschi: la
responsabilità della persecuzione ricadeva di più sui cattolici o sui protestanti? Sul clero o sulle
autorità civili? E come potevano queste superstizioni sopravvivere ancora nell’età del
Rinascimento?47 Presentando le loro relazioni al congresso dell’associazione degli antropologi
sociali britannici del 1968, il messaggio che Thomas e Macfarlane portavano era, da una parte, che
scavando negli archivi era possibile scoprire una quantità inimmaginata di materiale nuovo, e
dall’altra che a questo materiale era possibile e doveroso rivolgere domande nuove facendo tesoro
dell’esperienza di campo maturata soprattutto in Africa dagli antropologi.
Le due relazioni di Thomas e Macfarlane erano per più versi complementari l’una all’altra.
Quella di Macfarlane48 era frutto di una ricerca intensiva di tre anni condotta quasi esclusivamente
su materiale d’archivio relativo alla sola contea dell’Essex. Quella di Thomas49 presentava invece
alcuni risultati di indagini molto più vaste, riguardanti l’intera Inghilterra e basate in gran parte su
materiale non archivistico, che poco più tardi sarebbero confluite in Religion and the Decline of
Magic, un imponente volume che documentava la «rivoluzione senza rumore» che a partire dal
Seicento aveva portato al declino delle credenze magiche e a quello che Weber aveva chiamato
Entzauberung, il «disincanto» della società occidentale50. Insieme, esse costituiscono la prima
esemplificazione di un diverso modo di studiare storicamente la stregoneria europea, la prima
formulazione del nucleo del «nuovo paradigma».
14
Una prima componente fondamentale è l’applicazione della teoria antropologica al materiale
storico, un’applicazione che in questi due primi lavori di Thomas e Macfarlane si traduce
essenzialmente in una contestualizzazione sociale delle credenze e delle accuse di stregoneria e
nella ricerca delle loro funzioni. Con evidente soddisfazione i due storici comunicano ai colleghi
antropologi che la documentazione da loro analizzata mostra che anche nei villaggi inglesi dell’età
elisabettiana la credenza nella stregoneria serviva a spiegare le disgrazie che avevano colpito i loro
abitanti, che le accuse venivano metodicamente usate per risolvere un conflitto, e che i sospetti e le
accuse si dirigevano prevalentemente verso una particolare categoria: donne anziane, spesso vedove
e in ogni caso povere, che vivevano nello stesso vicinato dei loro accusatori e che negli atti
processuali venivano descritte dai testimoni come persone di cattivo carattere e di aspetto
minaccioso, sempre pronte a lanciare maledizioni contro chi non prestava loro l’aiuto richiesto. La
concentrazione delle accuse su questa particolare categoria sociale viene spiegata da Thomas e
Macfarlane collegandola a una trasformazione strutturale ricca di implicazioni profonde per la
società inglese della seconda metà del Cinquecento: la graduale sostituzione di un sistema nazionale
di assistenza al precedente sistema che affidava poveri e bisognosi alla carità della comunità locale
e del vicinato. Questa trasformazione avrebbe generato una tensione fra il tradizionale sentimento di
carità cristiana su cui ancora insisteva il clero locale e il risentimento verso quei poveri che
continuavano a ricorrere all’aiuto dei vicini benché le autorità civili scoraggiassero ormai questa
forma di assistenza. I capifamiglia tendevano a scacciare con modi bruschi le anziane mendicanti
che si presentavano alla porta di casa, ma la loro coscienza era tormentata. Sarebbe stato questo
diffuso senso di colpa, secondo i due storici inglesi, a fornire terreno fertile per accuse di
stregoneria che attribuivano alle donne anziane e alle loro maledizioni la responsabilità delle
disgrazie che si erano abbattute sulla casa, dalla malattia di un familiare alla morte di un animale.
La validità esplicativa del modello della «carità rifiutata» proposto da Thomas e Macfarlane
è stata in questi trent’anni messa più volte in discussione dagli studiosi di storia inglese dell’età
moderna51, e l’applicazione degli schemi interpretativi funzionalisti mutuati dall’antropologia
sociale degli anni sessanta può apparire oggi meccanica e quasi didascalica. Anche da queste brevi
annotazioni si comprende tuttavia la novità di studi che mostravano come la stregoneria di età
elisabettiana non potesse più essere vista come un delirio misteriosamente propagatosi in tutta
Europa, bensì come una credenza dotata di una sua razionalità, condivisa e manipolata da uomini e
donne che vivevano gli uni accanto alle altre. Non meno significativi erano gli aspetti più
strettamente metodologici. Soprattutto il lavoro di Macfarlane offriva una dimostrazione dei ricchi
dividendi che potevano derivare da una ricerca storica che, seguendo l’esempio degli antropologi,
15
abbandonasse il livello «anatomico» o «macroscopico» di lavori come quello di Trevor-Roper per
scendere al livello «istologico» o «microscopico» della contea o, ancor meglio, del villaggio.
Si tratta di un punto di notevole importanza, sul quale conviene soffermarsi dal momento
che questa scelta metodologica costituisce un tratto distintivo non solo del nuovo paradigma di
ricerche sulla stregoneria europea, ma più in generale di gran parte dell’antropologia storica. Il
primo passo dell’indagine di Macfarlane era consistito nell’identificare gli oltre 1200 processi di
stregoneria celebrati nell’Essex tra il 1560 e il 1680, i cui atti erano conservati nell’archivio storico
centrale della contea e in altri archivi52. Era un corpus documentario che poteva essere esaminato
superficialmente e rapidamente, come altri avevano già fatto in precedenza, o nel quale si poteva
invece entrare in profondità. Il bivio metodologico era in qualche maniera simile a quello che
conduce da una parte alla ricerca sul terreno di carattere estensivo, il survey work di Haddon e
Rivers, e dall’altro alla ricerca intensiva di stile malinowskiano. La consultazione di qualche
documento isolato, o anche la redazione di un regesto, ossia di un repertorio cronologico dei
processi contenente alcune informazioni essenziali sugli atti, possono essere completate in tempi
relativamente brevi; un’indagine intensiva può richiedere molti mesi o anni. Come ha scritto
Ginzburg ricordando le prime fasi della sua prima importante ricerca, condotta quasi
contemporaneamente a quella di Macfarlane, «l’idea di soffermarsi sulle lunghe e (così almeno
sembrava) ripetitive confessioni degli uomini e delle donne accusate di stregoneria era poco
attraente per studiosi ai cui occhi l’unico problema storico accettabile era costituito dalla
persecuzione della stregoneria, e non dal suo oggetto»53. L’idea di leggere con attenzione e studiare
fin nei minimi particolari questi atti è invece ben più attraente per lo storico che, come EvansPritchard tra gli Azande, voglia cercare di capire che cosa rappresentasse la stregoneria per «nativi»
lontani nel tempo, uomini e donne che a differenza dell’antropologo non può osservare e interrogare
direttamente, ma le cui voci gli giungono comunque attraverso il documento. Le confessioni sono
indubbiamente ripetitive, anche nel senso che generalmente le risposte degli imputati riecheggiano
le domande degli inquisitori. Leggendo le carte processuali accade però che di colpo «ci troviamo di
fronte a un vero e proprio dialogo: percepiamo voci distinte, diverse, addirittura contrastanti»; e non
solo parole, «ma gesti, silenzi, reazioni quasi impercettibili come un improvviso rossore …
registrati dai notai del Sant’Uffizio con puntigliosa minuzia»54.
La scelta metodologica di Macfarlane, di Ginzburg e di altri storici che hanno cercato di
dare alle proprie ricerche un taglio antropologico è stata naturalmente quella di immergersi in
profondità in una documentazione che a precedenti generazioni di studiosi era parsa così poco
promettente. Tale scelta ha avuto per questi pionieri dell’antropologia storica, e ha per chiunque
decida di compierla, l’effetto quasi magico di trasformare la documentazione, rendendola in un
16
certo senso nuova e più estesa. «Quando entrai per la prima volta nella grande stanza circondata da
armadi in cui erano conservati, in ordine perfetto, quasi 2000 processi inquisitoriali», ha ricordato
ancora Ginzburg, «provai l’emozione di un cercatore d’oro che s’imbatte in un filone
inesplorato»55. Fondi archivistici giudicati di poco interesse dagli studiosi della caccia alle streghe,
e del tutto insignificanti dagli storici politici, si nobilitavano e rivelavano una ricchezza di
informazioni che addirittura poneva gli storici in una posizione di vantaggio nei confronti degli
antropologi. Nel presentare le fonti e i metodi su cui si basavano i due volumi da lui dedicati a
Vidas mágicas e Inquisición, un altro lavoro storico-antropologico su magia e stregoneria apparso
nel 1967, Julio Caro Baroja non esitava a riconoscere che lo studio monografico di Evans-Pritchard
sugli Azande aveva offerto a storici e antropologi il modello da seguire, ma aggiungeva che, per
arricchire la teoria antropologica, «in Europa abbiamo il vantaggio di poter lavorare su un materiale
storico che è molto più abbondante di quello sui popoli primitivi»56.
Un ovvio vantaggio della documentazione storica, come notava con un pizzico di invidia lo
stesso Evans-Pritchard nella prefazione al volume che Macfarlane aveva tratto dalla sua tesi, era
quello di registrare variazioni nel tempo57. La letteratura antropologica suggeriva che in certe
società le accuse di stregoneria erano più frequenti che in altre, ma non era in grado di dirci se in
queste società le accuse fossero state più o meno frequenti nel passato. Un esame dei 1200 processi
celebrati nell’Essex tra il 1560 e il 1680 mostrava invece, ad esempio, che le accuse di stregoneria
erano state molto più frequenti tra il 1570 e il 1595 che non nei primi decenni del Seicento, e che
avevano comunque conosciuto forti fluttuazioni. Per un’antropologia sociale in crisi anche a causa
di un apparato teorico che sottolineava eccessivamente gli aspetti statici della struttura sociale, le
prospettive dinamiche offerte dal materiale storico erano evidentemente preziose. La forza
dell’antropologia consisteva però nella sua capacità di studiare la stregoneria, così come molti altri
fenomeni, all’interno di un ricco contesto etnografico ricostruito grazie a studi intensivi condotti
all’interno di piccole comunità. Per lo storico desideroso di emulare l’antropologo il problema era,
per usare ancora l’esempio di Macfarlane, quello di inserire le accuse di stregoneria documentate
negli archivi dell’Essex in un analogo contesto etnografico. Impresa non facile, dal momento che
anche limitando l’indagine a questa sola contea egli aveva a che fare con una popolazione di circa
100.000 persone per un periodo di oltre un secolo. Una possibile strategia era quella di far emergere
la dimensione microscopica del villaggio dalle informazioni contenute negli stessi atti processuali,
che riguardavano tuttavia una molteplicità di comunità locali. Alternativamente, si poteva
selezionare un piccolo campione di villaggi e applicare ad essi procedimenti di ricerca analoghi a
quelli adottati dagli antropologi sul terreno, non lavorando quindi sui processi come se si trattasse di
17
un insieme «chiuso» di informazioni, ma legando queste informazioni ad una varietà di altri dati
d’archivio.
Optando per questa seconda strategia, Macfarlane ha scelto tre villaggi vicini fra loro, situati
in una fascia centrale della contea in cui le accuse di stregoneria erano state particolarmente
numerose, e li ha seguiti intensivamente lungo un periodo di quarant’anni (1560-1599). Come ogni
antropologo appena giunto sul campo, Macfarlane ha collegato le informazioni contenute nelle carte
processuali a quelle fornite da atti notarili, libri parrocchiali e registri catastali, ed è riuscito in tal
modo a ricostruire intere genealogie, a stabilire la topografia dei villaggi, a determinare rapporti di
parentela, affinità e vicinato, il censo di molti abitanti, la loro religione – in una parola, a restituirci
in non piccola parte la struttura sociale di tre piccole comunità inglesi della fine del Cinquecento.
Era un procedimento che preludeva a quello di «ricostituzione totale» di cui Macfarlane sarà uno
degli ideatori e di cui ci occuperemo nel prossimo capitolo. Era anche una ricostruzione del contesto
etnografico palesemente guidata dalle preoccupazioni teoriche dell’antropologia sociale. A separare
la ricerca di Macfarlane da quella quasi contemporanea di Carlo Ginzburg sui «benandanti» del
Friuli non vi è soltanto la scelta di quest’ultimo di puntare il suo microscopio essenzialmente sugli
atti processuali senza tentare collegamenti sistematici con altri tipi di fonte, ma anche – come le
brevi citazioni riportate poco sopra hanno lasciato intravedere – l’interesse prevalente di Ginzburg
per le confessioni di stregoneria piuttosto che per le accuse, per le credenze in sé piuttosto che per le
loro funzioni sociali.
Ginzburg aveva iniziato a studiare i processi alle streghe molto precocemente, come
dimostra un saggio pubblicato, a poco più di vent’anni, nel 196158. Questo interesse era in parte
stimolato da letture antropologiche. Non si trattava però delle monografie di Evans-Pritchard e degli
antropologi sociali britannici, allora quasi del tutto sconosciute in Italia, ma piuttosto dei libri di
Ernesto De Martino, e in particolare del Mondo magico59, che avevano diretto la sua attenzione
verso le origini popolari delle credenze nella stregoneria e lo avevano portato a formulare l’ipotesi
che i processi avessero rappresentato uno scontro tra culture profondamente diverse60. Questa
ipotesi gli parve confermata pochi anni più tardi, quando nell’Archivio Arcivescovile di Udine si
imbatté in una serie di processi di stregoneria che rivelavano l’esistenza, nelle campagne friulane
del XVI e XVII secolo, di una sorta di associazione o confraternita rurale a cui appartenevano, per
destino, uomini e donne che erano nati «con la camisciola», ossia avvolti dalla membrana
amniotica, e che si autodefinivano «benandanti». Il termine non era sconosciuto. Nei lavori degli
studiosi delle tradizioni popolari friulane, «benandante» era registrato come sinonimo di
«stregone». Gli interrogatori analizzati da Ginzburg indicavano tuttavia che nei processi più antichi
i benandanti avevano dichiarato con forza di non essere streghe e stregoni, ma di essere anzi i loro
18
nemici più fieri. Quattro volte all’anno, nelle notti delle «quattro tempora» (i giorni, all’inizio di
ogni stagione, in cui la Chiesa prescriveva il digiuno), essi abbandonavano il proprio corpo, che
giaceva per alcune ore come morto. Chiamati da un messaggio divino o da un angelo si recavano in
spirito – «lassando il corpo a casa» – in un prato in cui si trovavano «li strigoni del diavolo» con i
quali ingaggiavano una battaglia, «noi con le mazze di finocchio et loro con le canne di sorgo». I
benandanti combattevano non solo «in favor di Christo», ma anche «per amor delle biave», in
difesa dei raccolti minacciati dai sortilegi degli stregoni: «una volta combattiamo il formento con
tutti li grassami, un’altra volta li minuti, alle volte li vini: et così in quattro volte si combatte tutti li
frutti della terra, et quello che vien vento [vinto] da benandanti quell’anno è abondanza»61.
Queste non erano confessioni di stregoneria, ma fermi dinieghi che ponevano gli sconcertati
inquisitori di fronte a elementi inattesi e del tutto estranei agli stereotipi demonologici. Ci sarebbe
voluto mezzo secolo perché i benandanti, premuti dagli inquisitori, modificassero le loro
dichiarazioni e si confessassero finalmente stregoni. Incompatibile con lo schema del sabba
diabolico, il quadro di credenze e pratiche rituali che affiorava dai primi processi denunciava in
compenso inconfondibili similarità con culti agrari ampiamente documentati nella letteratura
etnologica e folklorica. I benandanti, il volume in cui Ginzburg presentava i risultati delle sue
ricerche, apparve nel 1966, pochi anni dopo che il più importante dei due libri della Murray sulla
stregoneria, The Witch-Cult of Western Europe, era stato ripubblicato e nuovamente sommerso da
un’ondata di critiche. Ginzburg prendeva accuratamente le distanze dalle più arrischiate e fantasiose
delle tesi formulate dall’egittologa inglese, ma osservava anche che mancava un’altra
interpretazione complessiva della stregoneria popolare e che la teoria della Murray sembrava
comunque racchiudere «un nocciolo di verità»62. A sconcertare Ginzburg era soprattutto il fatto che
le battaglie notturne descritte dai benandanti trovavano un isolato ma sorprendente parallelo nella
confessione resa nel 1692 ai giudici di Jürgensburg, nella regione baltica della Livonia, da un uomo
di ottant’anni, un certo Thiess. Considerato dai compaesani un idolatra, il vecchio Thiess aveva
invece sostenuto di essere un lupo mannaro e aveva raccontato che tre volte l’anno, nelle notti di
santa Lucia, di Pentecoste e di san Giovanni, si recava in un luogo solitario e insieme ad altri lupi
mannari combatteva con fruste di ferro il diavolo e gli stregoni, che armati di manici di scopa
cercavano di rubare i germogli e distruggere i raccolti63. Il rinvenimento di credenze così simili in
regioni così lontane tra loro indicava un’area di diffusione molto vasta e suggeriva anzi «l’esistenza
di una connessione, non analogica ma reale, tra benandanti e sciamani», essendo molte le
caratteristiche di queste battaglie notturne che sembravano comporsi in un quadro coerente che
richiamava da vicino quello delle credenze e delle pratiche sciamaniche64.
19
Nei Benandanti Ginzburg non si era spinto oltre sulla strada della comparazione. Memore
della lezione di Marc Bloch, gli era sembrato che esorbitasse dai compiti dello storico tentare una
comparazione tipologica tra fenomeni che apparivano storicamente indipendenti65. Riteneva tuttavia
che folkloristi e storici delle religioni avrebbero potuto trarre dal materiale documentario presentato
nel suo volume «illazioni ben più vaste» attraverso «un uso più largo del metodo comparativo»66.
Rintracciare i fili che legavano le credenze friulane a quelle di aree lontanissime nello spazio ha
però rappresentato una sfida che ha continuato ad «alimentare sotterraneamente»67 gran parte del
lavoro di Ginzburg per vent’anni e che lo ha indotto a fare un uso sempre più largo del metodo
comparativo. Ne è testimonianza Storia notturna, apparso nel 1989, dove i casi dei benandanti e del
vecchio Thiess vengono ripresi come punti di partenza di un vertiginoso viaggio comparativo che
porta a identificare le radici dei culti agrari e dei rituali estatici delle campagne friulane del
Cinquecento nello sciamanesimo delle steppe siberiane. Questo comparativismo a vasto raggio non
ha certo incoraggiato i critici di Ginzburg a cancellare il suo nome dalla lista dei «Murrayists», alla
quale era stato iscritto quasi d’ufficio all’indomani della pubblicazione dei Benandanti68. Ma
Ginzburg può dirsi seguace della Murray in un senso più importante. Il «nocciolo di verità»
contenuto nella teoria della Murray consisteva innanzitutto «nella decisione di prendere sul serio,
contro ogni riduzione razionalistica, le confessioni delle streghe»69. Lo studio di Ginzburg ha
dimostrato per la prima volta in maniera convincente che le voci degli imputati e le loro credenze
potevano passare attraverso il filtro inquisitorio e giungere fino a noi – nel caso friulano, voci
verbalizzate in un italiano cinquecentesco che, insinuandosi nel latino in cui sono prevalentemente
redatti gli atti processuali, è sintomo e simbolo della coesistenza e dello scontro di due culture. La
pubblicazione dei Benandanti ha avverato la profezia di Gorer, il quale, un quarto di secolo prima,
aveva suggerito agli storici americani che seguendo l’esempio della Murray, e prestando fede alle
confessioni degli imputati di stregoneria, sarebbe stato possibile riportare alla luce «le credenze, le
pratiche e l’ethos di importanti gruppi delle popolazioni subalterne»70.
3. Stregoneria, inquisizione e etnografia
Nei trent’anni che ci separano dal convegno dell’associazione degli antropologi sociali del 1968 e
dalla pubblicazione dei lavori di Thomas e Macfarlane, gli studi storici sulla stregoneria hanno
conosciuto una straordinaria crescita, con un tasso addirittura accelerato nell’ultimo decennio 71, e
hanno fornito l’esempio più convincente dell’utilità di coniugare storia e antropologia. Una delle
20
ragioni principali di questo successo è indubbiamente stata la dimostrazione, così brillantemente
offerta dalle analisi di pionieri come Macfarlane o Ginzburg, delle potenzialità dei fondi archivistici
prodotti dall’attività inquisitoriale in Europa e nel Nuovo Mondo durante i secoli della caccia alle
streghe. Uno degli aspetti del lavoro di Macfarlane che suscitarono più scalpore fu l’uso di tecniche
di analisi quantitativa allora familiari agli storici economici ma assai meno ai loro colleghi che si
interessavano di stregoneria, quasi tutti specialisti di storia ecclesiastica o di storia delle idee,
oppure studiosi di tradizioni popolari. Sulla sua scia si è sviluppato un robusto filone di ricerca, che
facendo uso di strumenti statistici sempre più sofisticati ha legato le sue sorti alle fortune della
storia quantitativa, dominatrice degli anni settanta e ottanta ma oggi in fase di ripiego72. Nello
studio della stregoneria sono state però maggiormente battute le vie di una ricerca prevalentemente
qualitativa, che ha utilizzato l’archivio come terreno per indagini di carattere etnografico e le
domande dell’inquisitore come succedaneo, sia pure imperfetto, delle domande che l’antropologo
rivolge ai suoi informatori sul campo.
A segnare il trionfo di questo stile di ricerca fu, nel 1975, la pubblicazione di Montaillou,
village occitan di Emmanuel Le Roy Ladurie, un libro che ebbe un successo di vendite così
straordinario da diventare un caso di cui si occuparono ripetutamente i giornali di tutto il mondo 73.
In Montaillou non si parlava, a dire il vero, di stregoneria, ma piuttosto di eresia. La base
documentaria su cui il libro si fonda sono gli atti di un’inchiesta che l’inquisitore Jacques Fournier,
destinato a diventare papa con il nome di Benedetto XII, aprì nel 1320 per appurare se questo
piccolo villaggio pirenaico di contadini e pastori fosse stato ricettacolo dell’eresia catara. La fonte
archivistica aveva tuttavia molto in comune con i processi di stregoneria studiati da Ginzburg o da
Macfarlane. Anzi, il fatto che il poderoso manoscritto latino che registrava gli interrogatori
riguardasse una sola comunità, e che le testimonianze rese agli inquisitori contenessero una grande
quantità di informazioni sulla vita materiale e spirituale dei suoi 250 abitanti, incoraggiava ancora
di più lo storico a emulare l’antropologo. In un’introduzione significativamente intitolata
Dall’Inquisizione all’etnografia, Le Roy Ladurie dichiarava esplicitamente di avere preso come
modelli gli studi antropologici di comunità «contadine», a partire da quelli classici di Robert
Redfield, e il suo libro era in effetti organizzato secondo i canoni della letteratura etnografica:
iniziava con capitoli dedicati all’ambiente naturale e alla vita economica, per passare poi a
un’etnografia del matrimonio e delle reti di parentela, dei gesti e dei rituali, delle pratiche religiose,
delle credenze. Era ovviamente anche un libro profondamente intriso delle problematiche tipiche
della scuola delle «Annales», di cui Le Roy Ladurie era uno dei più autorevoli esponenti: la prima
parte del libro delineava gli elementi di «lunga durata», la seconda indagava la «mentalità» di questi
montanari medievali costretti dall’incalzare delle domande degli inquisitori a svelare anche gli
21
angoli più reconditi della loro vita privata. Punto di convergenza della tradizione storiografica di
Bloch e Febvre e di quella etnografica di Redfield, Montaillou era il risultato del più esplicito
esperimento di «antropologia storica» fino ad allora tentato (e, a giudicare dal suo successo
commerciale, anche il più riuscito).
Neppure uno storico poliedrico come Le Roy Ladurie poteva avere un controllo perfetto
della letteratura antropologica. Leggendo Montaillou, gli antropologi avevano perciò aggrottato le
ciglia di fronte a qualche citazione fuori luogo o a qualche applicazione superficiale delle loro
teorie, ma nel complesso erano rimasti non meno affascinati di centinaia di migliaia di altri lettori, e
gratificati nel vedere i loro metodi impiegati nello studio di una comunità lontana più di sei secoli.
Dieci anni più tardi le prime ventate postmoderniste avrebbero però reso l’atteggiamento di alcuni
antropologi decisamente più critico. Le Roy Ladurie aveva fatto notare che non mancavano certo
studi storici di villaggi medievali, ma che solo eccezionalmente – grazie a fonti come il registro
inquisitoriale di Jacques Fournier – era possibile imbattersi in «testimonianze dirette» degli abitanti
di questi villaggi. Uno dei principali obiettivi di Montaillou era stato quello di far emergere da tali
testimonianze le attività, le aspirazioni e le emozioni di umili e dimenticati montanari dei Pirenei e
di dimostrare che la loro cultura non aveva minore dignità di quella degli strati sociali più ricchi e
potenti di cui gli storici si erano sempre occupati. In un saggio contenuto in Writing Culture, il testo
che rappresenta la carta di fondazione dell’antropologia postmodernista, Renato Rosaldo ha
sostenuto che Le Roy Ladurie, valendosi dell’«autorità disciplinare» dell’etnografia, ha proposto ai
suoi lettori queste «testimonianze dirette» come resoconti non problematici e oggettivamente validi,
benché fossero state estorte dagli inquisitori come confessioni. Lo storico francese aveva inoltre
dato per scontato che le voci deformate comunque restituiteci dagli atti processuali, pur provenendo
da una cultura lontanissima nel tempo, fossero immediatamente comprensibili allo storico e al
lettore odierno. «Il tropo dello storico che fa udire in diretta ai lettori di oggi le voci dei contadini
medievali», scriveva con durezza Rosaldo, «suscita più scetticismo che apprezzamento tra gli
etnografi, abituati a riflettere sulla difficoltà di tradurre le culture»74.
Questi rilievi sono probabilmente troppo severi. In un saggio che sembra essere almeno in
parte una risposta alle critiche e allo scetticismo di Rosaldo, e non a caso intitolato L’inquisitore
come antropologo, Ginzburg non ha avuto difficoltà a riconoscere che documenti come i processi ai
benandanti friulani o il registro di Fournier non sono neutrali e che le situazioni di pesante controllo
inquisitoriale da cui sono emersi fanno sì che l’informazione che ci forniscono sia tutt’altro che
«obiettiva». Determinare le condizioni in cui un documento è stato prodotto costituisce tuttavia da
oltre un secolo il primo e fondamentale precetto metodologico dello storico. Per quanto le fonti
inquisitoriali possano essere più insidiose di altre, non è impossibile decifrarle una volta che si
22
impari «a cogliere dietro la superficie liscia del testo un sottile gioco di minacce e di paure, di
assalti e di ritirate»75. E’ dunque lecito, si è domandato Ginzburg, spingersi oltre «fino a sostenere,
come hanno fatto recentemente, in maniera più o meno esplicita, alcuni storici e antropologi (oltre a
vari filosofi e critici letterari) che un testo è in grado di documentare soltanto se stesso, ossia il
codice in base a cui è costituito?»76. In questa e in altre occasioni Ginzburg ha dichiarato la propria
avversione a trattare la fonte storica esclusivamente in quanto fonte di se stessa (vale a dire del
modo in cui è stata costruita) e non anche di ciò di cui la fonte racconta, sostenendo con buone
ragioni che quando si parla di «filtri e intermediari deformanti» non bisogna esagerare e che «il
fatto che una fonte non sia ‘oggettiva’ … non significa che sia inutilizzabile»77. Ridimensionato il
problema della «validità» delle testimonianze conservate nelle fonti inquisitoriali (e a fortiori in
altre fonti prodotte in situazioni meno violentemente squilibrate), rimane però l’altro problema
sollevato da Rosaldo, quello della «traduzione di culture», della comprensibilità di voci che ci
vengono da lontano nel tempo o nello spazio.
Questo problema aveva rappresentato, come si è visto, il centro delle riflessioni di EvansPritchard nel suo libro sulle credenze magiche degli Azande, e ancor prima di Lévy-Bruhl e di
Bloch nel suo studio sui re guaritori. All’antropologo esso si pone quasi quotidianamente, sul
terreno o nel momento di scrivere il suo resoconto etnografico, ma con particolare acutezza
riguardo a quelle che Lévy-Bruhl aveva chiamato credenze «mistiche», e non è un caso che verso la
metà degli anni settanta le nozioni di magia e stregoneria siano state oggetto di un importante
dibattito tra Keith Thomas e l’antropologa Hildred Geertz che prefigura alcuni dei più accesi
dibattiti attuali. Pur riconoscendo che Thomas aveva dato prova in Religion and the Decline of
Magic di una sconfinata erudizione unita a una non comune finezza di annotazione, la Geertz
riteneva che lo storico inglese avesse commesso un fatale errore epistemologico usando «religione»,
«magia» e «stregoneria» come termini analitici che rimandavano a fenomeni considerati
essenzialmente simili nelle più diverse culture, o comunque sufficientemente simili da giustificare
l’applicazione all’Inghilterra del XVI e XVII secolo di schemi interpretativi mutuati dalla letteratura
antropologica. Questo era, a parere della Geertz, un uso del tutto scorretto del lavoro di EvansPritchard: i termini inglesi witchcraft e magic erano stati adottati da quest’ultimo «in mancanza di
traduzioni migliori per quelle che egli dimostra essere idee intraducibili; è il carattere sistematico
del pensiero zande che lo rende intraducibile, ed è questo aspetto della presentazione di EvansPritchard che Thomas ignora»78.
Suggerendo che le pratiche e le credenze «magiche» degli Azande e delle popolazioni
inglesi dell’età elisabettiana sono comprensibili solo «nel quadro di una visione storicamente
particolare della natura della realtà, un’immagine culturalmente unica del modo in cui l’universo
23
funziona»79, l’antropologa americana forzava lievemente le posizioni di Evans-Pricthard verso
quelle che un paio d’anni prima il marito – Clifford Geertz – aveva difeso nei saggi riuniti in The
Interpretation of Cultures. Ma solo lievemente, e non illegittimamente: la cosiddetta «antropologia
semantica», una delle correnti antropologiche più vivaci dei primi anni settanta, e con più di un
punto in comune con l’antropologia interpretativa geertziana, aveva la propria roccaforte proprio a
Oxford tra gli allievi di Evans-Pritchard80. Non è purtroppo possibile esaminare più da vicino i
molti importanti problemi affrontati con perspicacia da Hildred Geertz nella sua discussione del
libro di Thomas, né considerare le valide argomentazioni portate da quest’ultimo a difesa del suo
lavoro. Non si può tuttavia fare a meno di notare come Thomas, che solo una dozzina di anni prima
aveva sostenuto che la storia doveva farsi antropologia, apparisse ora preoccupato dalle tendenze
relativistiche della nuova antropologia che si stava profilando all’orizzonte. Non negava che
l’antropologo avesse il diritto e forse il dovere di sospettare di ogni terminologia inadatta alla
comparazione interculturale. Era tuttavia portato a concludere che «la prospettiva più ampia
dell’antropologo odierno … distingue inevitabilmente i suoi metodi da quelli dello storico»81.
Sembrava il presagio di un nuovo distacco tra antropologia e storia, di una rapida dissoluzione di
quell’antropologia storica che era appena venuta formandosi. Contro le aspettative di Thomas,
l’antropologia geertziana ha invece goduto, in quest’ultimo quarto di secolo, di una straordinaria
popolarità tra gli storici e rappresenta oggi un punto d’incontro quasi ovvio tra le due discipline. Ma
non l’unico, come si vedrà nel prossimo capitolo, e certo non uno dei meno discussi.
Note
1
Evans-Pritchard, Anthropology and History cit., p. 59.
Thomas, History and Anthropology cit., p. 8.
3
K. Thomas, The Relevance of Social Anthropology to the Historical Study of English Witchcraft,
in Witchcraft Confessions and Accusations, a c. di M. Douglas, cit., p. 47 [trad. it. cit., p. 83].
4
C. Ginzburg, L’inquisitore come antropologo, in Studi in onore di Armando Saitta, a c. di R. Pozzi
e A. Prosperi, Giardini, Pisa 1989, pp. 24-5.
5
Ivi, p. 25.
6
Questo episodio è narrato da Pitt-Rivers nella prefazione alla seconda edizione del suo classico
volume The People of the Sierra, The University of Chicago Press, Chicago-London 19712, pp. xixii.
7
Witchcraft, Oracles and Magic cit., p. 4 [trad. it. Stregoneria, oracoli e magia tra gli Azande,
Franco Angeli, Milano 1976, p. 35].
8
E. E. Evans-Pritchard, The Intellectualist (English) Interpretation of Magic, in «Bulletin of the
Faculty of Arts, University of Egypt», 1 (1933), pp. 282-311, e Lévy-Bruhl’s Theory of Primitive
Mentality, in «Bulletin of the Faculty of Arts, University of Egypt», 2 (1934), pp. 1-36. Questi due
saggi costituiscono ora, con alcune modifiche, rispettivamente il secondo e il quarto capitolo di E.
E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion, Oxford University Press, Oxford 1965.
9
Frazer, The Golden Bough cit., p. 13 [trad. it. cit., p. 23].
2
24
10
Bloch, Les Rois thaumaturges cit., p. 421; vedi sopra p. 00.
Il saggio Magic, Science and Religion apparve originariamente nel 1925 nel volume collettivo
Science, Religion and Reality, a c. di J. A. Needham; fu ripubblicato nel 1948 in una raccolta di
saggi scelti di Malinowski curata da R. Redfield: Magic, Science and Religion and Other Essays,
The Free Press, Glencoe (Ill.) 1948. La citazione è tratta dall’edizione italiana, Magia, scienza e
religione, Newton Compton, Roma 1976, p. 37.
12
Cfr. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion cit., p. 87 [trad. it. Teorie sulla religione
primitiva, Sansoni, Firenze 1971, p. 155].
13
Ivi, p. 81 [trad. it. p. 147].
14
Ivi, pp. 81-2 [trad. it. p. 148].
15
Ivi, p. 81 [trad. it. p. 147].
16
M. Polanyi, Personal Knowledge, The University of Chicago Press, Chicago 1958, pp. 286-94.
17
Il riferimento è ovviamente a Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions cit.
18
C. Pignato, Arie di famiglia, analogie, modelli: prospettive teoriche e strategie cognitive nella
scienza e nell’antropologia, Circolo Semiologico Triestino, Trieste 1996, p. 25.
19
Si vedano P. Feyerabend, Against Method, New Left Books, London-New York 1975, p. 298 e
passim, e da ultimo G. Lolli, Beffe, scienziati e stregoni. La scienza oltre realismo e relativismo, Il
Mulino, Bologna 1998, pp. 153-9, che giudica peraltro pericolosa e non del tutto legittima
l’analogia.
20
Si veda in particolare M. Hunter Wilson, Witch-Beliefs and Social Structure, in «American
Journal of Sociology», LVI (1951), pp. 307-13.
21
Uno studio esemplare rimane quello di V. W. Turner, Schism and Continuity in an African
Society, Manchester University Press, Manchester 1957.
22
M. Douglas, Introduction: Thirty Years after «Witchcraft. Oracles and Magic», in Witchcraft
Confessions and Accusations, a c. di M. Douglas, cit., p. xiv [trad. it. cit., p. 4 (lievemente
modificata)].
23
J. Michelet, La Sorcière, Dentu, Paris 1862.
24
Su queste vicissitudini informa il catalogo Michelet. Sa vie, son oeuvre (1798-1874), Archives de
France, Hotel de Rohan 1961, p. 143. Una versione integrale apparve nel 1863 a Bruxelles presso
l’editore Lacroix, ed è su questa seconda edizione che è stata condotta la traduzione italiana
dell’opera di Michelet (La strega, Einaudi, Torino 1971).
25
In una lettera del 2 dicembre 1862 Hugo esprimeva a Michelet la propria ammirazione per La
Sorcière scrivendo: «Ce que j’en aime c’est tout, c’est le style vivant qui souffre avec le martyr;
c’est cette pensée qui est comme une dilatation de l’âme dans l’infini». Questo passo è riportato in
Michelet. Sa vie, son oeuvre cit., p. 143.
26
R. Barthes, La Sorcière, saggio introduttivo a Michelet, La strega cit., p. ix.
27
Cfr. Burguière, L’anthropologie historique cit., pp. 140-1.
28
Sulle origini e sugli sviluppi della ricerca storica sulla stregoneria, soprattutto in ambito tedesco,
informano concisamente W. Monter, The Historiography of European Witchcraft: Progress and
Prospects, in «Journal of Interdisciplinary History», II (1972), p. 435-51, e più recentemente W.
Behringer, Witchcraft Studies in Austria, Germany and Switzerland, in Witchcraft in Early Modern
Europe, a c. di J. Barry, M. Hester e G. Roberts, Cambridge University Press, Cambridge 1996, pp.
64-73.
29
Monter, The Historiography of European Witchcraft cit., p. 436.
30
Vedi sopra pp. 00-0.
31
Murray, The Witch-Cult cit., p. 9.
32
Ivi, pp. 10-11.
33
Ivi, pp. 9-10.
34
Ivi, p. 16.
35
Si veda in particolare la recensione di G. L. Burr in «American Historical Review», XXVII
(1922), pp. 780-3.
11
25
36
C. Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Einaudi, Torino 1989, p. xxii.
Murray, The God of the Witches cit. Sull’insuccesso di questo libro si veda Murray, My First
Hundred Years cit., pp. 104-5.
38
L. Febvre, Sorcellerie, sottise ou révolution mentale?, in «Annales E. S. C.», III (1948), p. 12.
39
Ivi, p. 14.
40
Febvre, Le problème de l’incroyance cit.
41
Febvre, Sorcellerie cit., p. 14.
42
R. Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIe siècle. Une analyse de psychologie
historique, Plon, Paris 1968; H. R. Trevor-Roper, The European Witch-Craze of the Sixteenth and
Seventeenth Centuries, in Trevor-Roper, Religion, Reformation and Social Change, Macmillan,
London 1967, pp. 90-192.
43
Ginzburg, Storia notturna cit., p. xv.
44
H. Trevor-Roper, What is Historical Knowledge for Us Today?, in The Historian between the
Ethnologist and the Futurologist, a c. di J. Dumoulin e D. Moisi, Mouton, Paris-The Hague 1973, p.
184. Che lo storico non debba cedere a improduttive curiosità su «tribù barbare in pittoreschi ma
irrilevanti angoli del globo» era già stato sostenuto da Trevor-Roper alcuni anni prima nel suo The
Rise of Christian Europe, Harcourt, Brace and World, New York 1965, p. 9.
45
Trevor-Roper, The European Witch-Craze cit., p. 177.
46
A. D. J. Macfarlane, Witchcraft Prosecutions in Essex, 1560-1680: A Sociological Analysis, D.
Phil. thesis, University of Oxford 1967. Preceduta da una prefazione di Evans-Pritchard, questa tesi
fu pubblicata tre anni più tardi con il titolo Witchcraft in Tudor and Stuart England. A Regional and
Comparative Study, Routledge and Kegan Paul, London 1970.
47
Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England cit., p. 9.
48
Witchcraft in Tudor and Stuart Essex, in Witchcraft Confessions and Accusations, a c. di M.
Douglas, cit.
49
The Relevance of Social Anthropology cit.
50
K. Thomas, Religion and the Decline of Magic. Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and
Seventeenth-Century England, Weindenfeld and Nicolson, London 1971. E’ interessante notare che
questo libro si sarebbe inizialmente dovuto intitolare Primitive Beliefs in Pre-Industrial England.
51
Cfr. J. Barry, Introduction: Keith Thomas and the Problem of Witchcraft, in Witchcraft in Early
Modern Europe, a c. di J. Barry, M. Hester e G. Roberts, cit., pp. 8-9.
52
Cfr. Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England cit., pp. 254-309.
53
Ginzburg, L’inquisitore come antropologo cit., p. 28.
54
Ivi, pp. 28-9.
55
Ivi, p. 24.
56
J. Caro Baroja, Vidas mágicas e Inquisición, vol. I, Taurus, Madrid 1967, p. 39.
57
E. E. Evans-Pritchard, Preface, in Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England cit., p. xv.
58
C. Ginzburg, Stregoneria e pietà popolare. Note a proposito di un processo modenese del 1519,
in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Lettere, storia e filosofia, serie II, XXX
(1961), pp. 269-87, ora in Ginzburg, Miti, emblemi, spie, Einaudi, Torino 1986.
59
E. De Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Einaudi, Torino 1948.
60
Cfr. C. Ginzburg, Prefazione a Miti, emblemi, spie cit., p. x.
61
Ginzburg, I benandanti cit., pp. 8-9.
62
Ivi, p. xiii.
63
Ivi, pp. 37-40..
64
Ivi, p. 40.
65
Cfr. Ginzburg, Prefazione cit., p. xi.
66
Ginzburg, I benandanti cit., p. xv.
67
Cfr. Ginzburg, Prefazione cit., p. xi.
68
Cfr. Ginzburg, Storia notturna cit., pp. xxi-xxiv.
69
Ivi, p. xxii.
37
26
70
71
Gorer, Society as Viewed by the Anthropologist cit., p. 28.
Cfr. H. Hodgkin, Historians and Witches, in «History Workshop Journal», XLV (1998), pp. 271-
2.
Sull’uso di tecniche statistico-quantitative nello studio storico della stregoneria informa G. F.
Jensen, Time and Social History. Prblems of Atemporality in Historical Analyses with Illustrations
from Research on Early Modern Witch Hunts, in «Historical Methods», XXX (1997), pp. 46-57.
73
E. Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Gallimard, Paris 1975. Il libro fu
prontamente tradotto in italiano con il titolo Storia di un paese: Montaillou, Rizzoli, Milano 1977.
74
R. Rosaldo, From the Door of His Tent: The Fieldworker and the Inquisitor, in Writing Culture, a
c. di J. Clifford e G. E. Marcus, cit., p. 79 [trad. it. cit., p. 113].
75
Ginzburg, L’inquisitore come antropologo cit., p. 29.
76
Ibid.
77
Questa posizione è sostenuta con fermezza nella prefazione a Il formaggio e i vermi cit., pp. xvxvi, da cui è tratta quest’ultima citazione. Si veda anche C. Ginzburg, Il giudice e lo storico,
Einaudi, Torino 1991, pp. 13-14.
78
H. Geertz, An Anthropology of Religion and Magic, I, in «Journal of Interdisciplinary History»,
VI (1975), p. 84.
79
Ivi, p. 83.
80
Cfr. E. Ardener, The New Anthropology and Its Critics, in «Man» (n. s.), VI (1971), pp. 449-67.
81
K. Thomas, An Anthropology of Religion and Magic, II, in «Journal of Interdisciplinary History»,
VI (1975), p. 94.
72
27