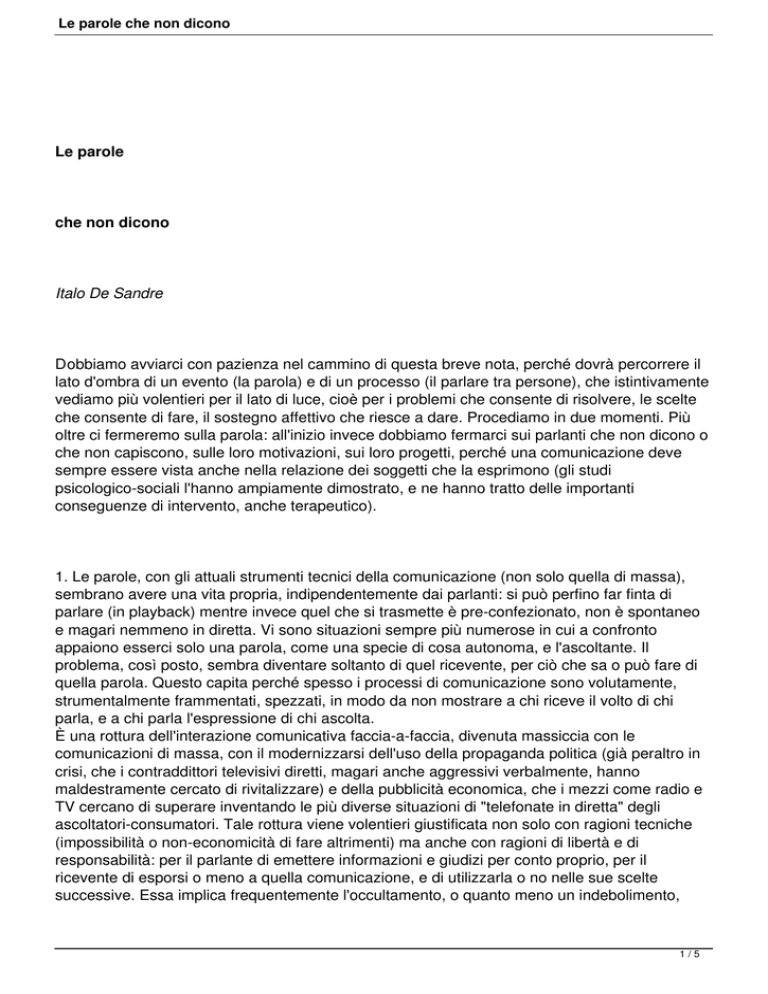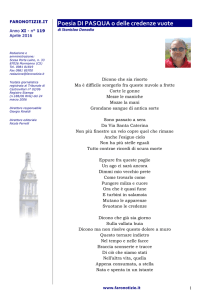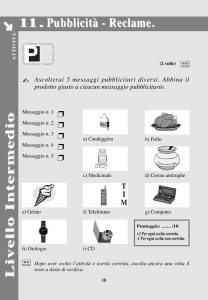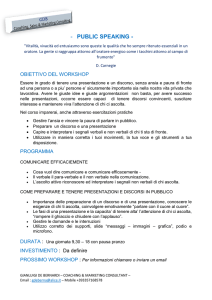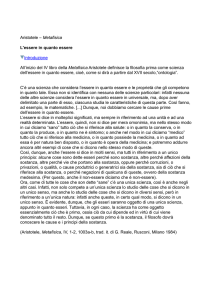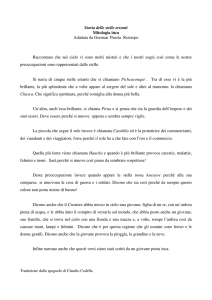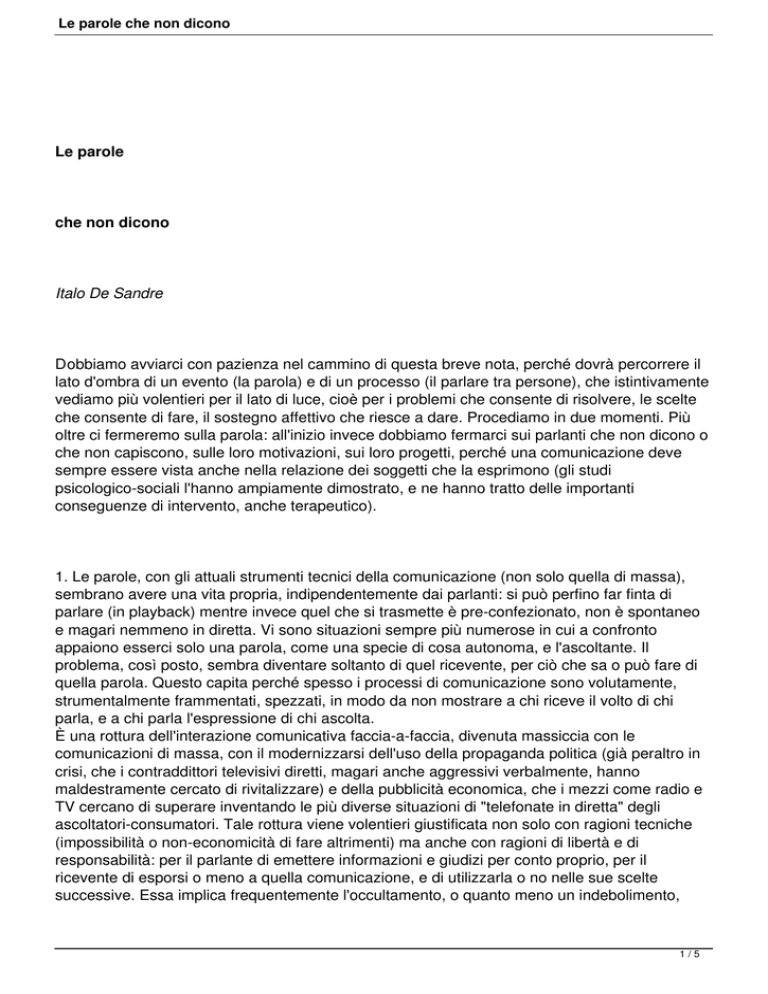
Le parole che non dicono
Le parole
che non dicono
Italo De Sandre
Dobbiamo avviarci con pazienza nel cammino di questa breve nota, perché dovrà percorrere il
lato d'ombra di un evento (la parola) e di un processo (il parlare tra persone), che istintivamente
vediamo più volentieri per il lato di luce, cioè per i problemi che consente di risolvere, le scelte
che consente di fare, il sostegno affettivo che riesce a dare. Procediamo in due momenti. Più
oltre ci fermeremo sulla parola: all'inizio invece dobbiamo fermarci sui parlanti che non dicono o
che non capiscono, sulle loro motivazioni, sui loro progetti, perché una comunicazione deve
sempre essere vista anche nella relazione dei soggetti che la esprimono (gli studi
psicologico-sociali l'hanno ampiamente dimostrato, e ne hanno tratto delle importanti
conseguenze di intervento, anche terapeutico).
1. Le parole, con gli attuali strumenti tecnici della comunicazione (non solo quella di massa),
sembrano avere una vita propria, indipendentemente dai parlanti: si può perfino far finta di
parlare (in playback) mentre invece quel che si trasmette è pre-confezionato, non è spontaneo
e magari nemmeno in diretta. Vi sono situazioni sempre più numerose in cui a confronto
appaiono esserci solo una parola, come una specie di cosa autonoma, e l'ascoltante. Il
problema, così posto, sembra diventare soltanto di quel ricevente, per ciò che sa o può fare di
quella parola. Questo capita perché spesso i processi di comunicazione sono volutamente,
strumentalmente frammentati, spezzati, in modo da non mostrare a chi riceve il volto di chi
parla, e a chi parla l'espressione di chi ascolta.
È una rottura dell'interazione comunicativa faccia-a-faccia, divenuta massiccia con le
comunicazioni di massa, con il modernizzarsi dell'uso della propaganda politica (già peraltro in
crisi, che i contraddittori televisivi diretti, magari anche aggressivi verbalmente, hanno
maldestramente cercato di rivitalizzare) e della pubblicità economica, che i mezzi come radio e
TV cercano di superare inventando le più diverse situazioni di "telefonate in diretta" degli
ascoltatori-consumatori. Tale rottura viene volentieri giustificata non solo con ragioni tecniche
(impossibilità o non-economicità di fare altrimenti) ma anche con ragioni di libertà e di
responsabilità: per il parlante di emettere informazioni e giudizi per conto proprio, per il
ricevente di esporsi o meno a quella comunicazione, e di utilizzarla o no nelle sue scelte
successive. Essa implica frequentemente l'occultamento, o quanto meno un indebolimento,
1/5
Le parole che non dicono
della responsabilità inter-soggettiva della comunicazione stessa. E l'estendersi di questa
interazione anonima è grave anche perché in qualche modo si autolegittima ad allargarsi
ulteriormente, alla ricerca di sempre nuove utenze, anche in campo religioso, là dove il rapporto
personale dovrebbe sempre essere presente e agito come tale. Credo che sia importante,
allora, non dare questa frammentazione e anonimizzazione dell'interazione comunicativa per
scontate e quindi valide.
2. Chi è che dice parole che non dicono, chi è che sente o ascolta parole che a lui non dicono
(più) nulla, a cui addirittura egli si fa sordo? La relazione tra chi parla e chi ascolta è
fondamentale perché in essa vi è un rapporto di influenza, di potere. Chi parla normalmente
esercita una sua libertà (libertà di opinione e di parola, uno dei più importanti e più banalizzati
diritti civili moderni), ma soprattutto vuole esercitare una sua influenza: di chi ha autorità e forza,
per comandare o persuadere gli altri da cui si attende di essere seguito; da chi non ne ha e
parla perché chi ha potere accolga la sua idea, la sua domanda. Colui che ritiene di aver
autorità, adesso più che mai deve fare i conti con la legittimazione (quanto accettato il suo
potere), con la credibilità (quanta fiducia e plausibilità a priori nei confronti delle sue parole), che
realmente gli vengono riconosciute. Entrambe oggi sono messe in questione, sono misurate
alla "prova dei fatti", perché chi ascolta, crede, obbedisce, vuol avere uno spazio per una
propria interpretazione, una propria decisione di conferma della lealtà o di differenziazione, e
comunque esige molto di più che chi ha autorità mostri la bontà-efficacia-giustizia degli
strumenti che adopera e dei risultati che riesce ad ottenere. Si pensi al figlio rispetto alle parole
del genitore, all'impiegato rispetto al dirigente, al dipendente rispetto al proprietario, ma anche
al fedele rispetto alle parole del prete! Molti che parlano perché hanno l'autorità di parlare (o
ritengono di averla), non si accorgono che forse hanno un codice culturale e di linguaggio
diventato parzialmente diverso da quello di coloro che dovrebbero seguirli, ma - ancor più in
radice - non si accorgono che è la loro autorità/autorevolezza che si è indebolita in quanto tale.
Non si tratta infatti solo di un problema di contenuti delle parole che non dicono, ma del
rapporto tra i comunicanti che non consente ai contenuti, magari capiti benissimo dagli
ascoltanti, di produrre alcun effetto trasformativo (possono fare anzi l'effetto opposto di quello
desiderato). Questo processo psicologico-sociale va letto anche in modo reciproco: colui che ha
autorità e non ha fiducia nei suoi sottoposti, nei suoi "fedeli", sente ma non ascolta le parole che
essi gli dicono, specialmente quelle parole con cui chiedono cose diverse da quelle che egli ha
già decise, con cui pongono problemi che mettono in questione le cose. Si può anche dire: colui
che non ascolta, di fatto anche se "a parole" o intenzionalmente può negarlo, non ha fiducia in
chi gli parla. E l'ascolto è una delle pratiche culturali e spirituali che viene poco esercitata oggi,
a tutti i livelli, sia alla base che al vertice delle istituzioni, politiche e religiose. Sono aspetti del
processo di comunicazione che vanno riconosciuti e vagliati, distinguendoli ma senza separarli,
senza pensare di poterli trattare e risolvere l'uno staccato dall'altro.
3. Vi è, a monte delle parole che non dicono, un altro aspetto legato sia al messaggio che alla
relazione che lega coloro che comunicano: la comunanza di codici (culturali, religiosi). Vi sono
parole che possono trasmettere una informazione strumentale, razionale, utile per risolvere un
2/5
Le parole che non dicono
problema, altre che possono trasmettere un segnale affettivo, emotivo, di espressività
personale. Se tra coloro che comunicano non c'è un codice culturale comune, non c'è sintonia
di aspettative rispetto ai discorsi che possono essere fatti: per esempio per uno che attende una
parola di affetto, la parola razionale che l'altro eventualmente gli dice può non essere nemmeno
capita, o capita ma non accolta. E viceversa, uno si attende un sostegno di amicizia e riceve
una spiegazione; un altro si attende una spiegazione e invece riceve un comando a credere
anche senza capire, o una parola emotiva. Queste differenze di registro possono certo far
sorgere anche sorprese positive; più spesso fanno sorgere delusioni, abbandoni, conflitti.
Anche sul piano religioso.
Vi è il problema anche dei vocabolari che cambiano, di parole il cui senso letterale non è più
capito, di forme linguistiche che diventano desuete per alcuni, o che sono di repertori linguistici
troppo specialistici: si tratta di problemi molto seri, che debbono fare i conti con la qualità
dell'alfabetizzazione che esiste in una certa collettività. Le esperienze dei socio-linguisti, o della
Scuola di Barbiana di don Milani, hanno mostrato che esistono molte disuguaglianze culturali in
termini di possesso e capacità d'uso delle parole, del vocabolario, del tutto ingiuste e
discriminanti. Queste disuguaglianze sono superate solo da una educazione più ampia e meglio
qualificata, in tutti i campi (economico, politico, culturale, religioso). Nel campo religioso, in
particolare, l'istruzione cresce ma è ancora poco diffusa ed ziti singolo, la comunicazione è
poca e spesso solo dall'alto al basso, unidirezionale, i repertori linguistici sono di tipo
teologico-razionale o di tipo rituale, al di fuori della familiarità e della padronanza dei ruoli
quotidiani delle persone. Eppure le stesse persone invece nella vita normale si sentono di avere
"più parola in capitolo", vogliono "dire la loro", farsi ascoltare. Il codice non è più così comune, il
repertorio dei "catechismi" viene da molti associato in quanto tale al linguaggio dell'infanzia, il
lessico teologico-ecclesiastico non viene capito, e il codice biblico è così ignorato e ritualizzato
(e poco conosciuto dagli stessi preti) che non dice che pochissimo rispetto alla sua ricchezza,
alla sua pluralità di stimoli. È il codice culturale (religioso) il primo problema, nel senso del
linguaggio e nel senso delle aspettative di azione (e quindi anche di discorso e di senso).
4. Ora che ci siamo soffermati un momento sull'importanza del soggetto della parola e del suo
interlocutore, della relazione che c'è tra di loro, e della affinità dei rispettivi codici simbolici, lingu
istici e di aspettative, è meno impreciso cercare di camminare nel lato d'ombra della parola vera
e propria, tra le parole che non dicono.
Vi sono parole che volutamente non sono più ascoltate, accolte, non più fatte proprie da chi pur
le ascolta. La parola qui ha un contro-effetto, la sua comprensione produce delle scelte che
vogliono differenziarsi, stimola l'identità di chi ascolta a voler essere e fare altrimenti. Un allievo
può ascoltare con attenzione il maestro, ma decidere di pensare e fare altrimenti: una sfida a se
stesso ed al maestro, la decisione di lasciarlo, oppure di cercare di sconfiggerlo come maestro.
Una prova impegnativa per il maestro, che a sua volta deve decidere cosa fare in questa sfida:
punire l'allievo, oppure abbandonarlo, fare in modo che vada via, oppure accettare di
mantenere la comunicazione anche se in termini più difficili, più problematici. Vi è un
cambiamento, non quello voluto nelle intenzioni o desideri dell'emittente, del maestro, di chi
credeva che la sua parola fosse accettata: un effetto non voluto, forse neanche previsto, eppure
così frequente nel bene e nel male, nella creatività o nella distruttività.
Vi sono parole che vogliono non-dire, vogliono nascondere, argomentare con volute parzialità e
3/5
Le parole che non dicono
unilateralità, parole che vengono taciute per interesse (inclusi gli "interessi superiori" magari
con "buone intenzioni", a fin di bene ecc.), con lo scopo di far arrivare a conclusioni di
convenienza dal punto di vista di chi parla, tacendo o svilendo altre cose: parole che vogliono
persuadere senza che chi ascolta abbia tutte le informazioni giuste per dare una risposta
consapevole e libera. Le élites dominanti, i partiti politici, le chiese, sono stati lungo tutta la
storia, e tuttora, fortemente criticati per questo tipo di parole, che sono state chiamate
ideologiche. Ma non si tratta di volere delle parole purificate da qualsiasi interesse, quanto la
scelta di non nasconderli, quegli interessi, in modo che gli altri possono valutarli, di non
manomettere fatti e argomenti in disaccordo, di non nascondere le incompletezze della propria
notizia. Il dialogo, come costruzione interattiva e discorsiva di un con-senso, è esattamente
l'opposto della comunicazione che usa parole ideologiche.
Vi sono parole banali, chiacchiere vuote che cercano di riempire altra vuoti. Parole che
contengono messaggi superficiali, generici, futili, detti per mostrarsi e per mostrare. Piccoli idoli,
che nascono da una cultura dei simulacri, per le quali lo «scambio simbolico» tra persone
potenzialmente intelligenti è ridotto ad uno scambio di simulacri di vita. La torrenziale intensità
dei talk, shows nazionali e locali, degli intrattenimenti radio-televisivi a base di conversazioni, di
esibizione dei punti di vista, al contrario di riuscire a superare la interruzione della
comunicazione sopra criticata, la banalizzano per eccesso. In realtà fanno emergere appunto più che le parole dette - gli idoli del "sé" esibiti da ciascuno, offerti per attirare e divertire, l'uno
accanto all'altro "democraticamente" (come diritto di parola ed opinione) e "concorrenzialmente"
(come confronto di convenienza). È un mercato culturale dove chi parla e chi ascolta, proprio
come al mercato, è insistentemente invitato a dare e prendere ciò che gli pare. Molte
conversazioni in incontri privati, anche in famiglia, o in incontri in treno, in viaggio, in vacanza,
sono del tutto simili. Ma forse anche nelle chiese ci sono parole usate come simulacri, come
idoli sacralizzati, superficiali, senza vita.
Vi sono parole che dicono troppe cose. Anche al di fuori di quella che prima chiamavo parola
ideologica (con la quale per esempio si possono volutamente dar da intendere troppe cose per
mettere in difficoltà l'ascoltante o dare a se stessi più possibilità di ragione), viviamo in una
cultura mondiale, con una storia in sviluppo rapidissimo, e di elevatissima complessità
(frammentazione, differenziazione interna, con grandi contraddizioni di valori e comportamenti),
nella quale per certe parole ai vecchi significati se ne sono aggiunti molti di nuovi. Si fa fatica ad
adoperarle perché gli altri possono capirle in modo diverso dal nostro, la loro plurivocità non
consente più di dare messaggi precisi. Molte parole dell'etica, della spiritualità, della religione,
possono essere così. Amore, alleanza, fiducia, libertà, verità, giustizia, compassione, bellezza.
Bisogna riuscire a fare chiarezza sui molti significati per mettere a fuoco quello corretto per
intendersi, ma forse bisogna anche non voler sopprimere la possibile ricchezza che la vita ha
immesso, ha stratificato dentro quella parola plurivoca, senza cercare sempre la
unidimensionalità del linguaggio, delle sfumature. Ogni parola contiene una genealogia, le
esperienze di generazioni diverse di parlanti, che vanno conosciute, di cui va fatta memoria.
Bisogna arrivare a dire parole più chiare e vitali, senza interrompere la comunicazione tra
significati di tempi diversi, facendo tesoro anche delle tensioni che le diversità generazionali
delle esperienze hanno fatto emergere.
Vi sono parole che non riescono ancora a dire. Parole che l'inesperienza, la non padronanza di
linguaggi, di repertori, di conoscenze, non riescono a rendere espressive. Ci sono delle cose,
dei problemi, dei vissuti, per i quali non abbiamo "le parole per dirlo", e pure vorremmo. Ma non
ne siamo gli specialisti, non saremmo autorizzati a parlare, e pure ne sentiamo il bisogno,
4/5
Le parole che non dicono
l'urgenza, la bellezza. Allora cerchiamo di appropriarci del parlare e di nuove parole nostre, di
nuovi codici, cerchiamo radici più profonde, la memoria nostra, dei nostri anziani, dei popoli,
delle donne, degli uomini, della loro sapienza. Cerchiamo di pensare noi in prima persona,
esprimendo la nostra esperienza, anche semplice ma diretta, autentica, anche se sappiamo di
fare degli errori, specialmente all'inizio. Capita sempre così quando dei "laici", cioè dei non
esperti rispetto a qualche materia, dei non professionisti, cercano di produrre una propria
parola, sentendo che essa ha una propria legittimità e credibilità. I più saggi vanno alle fonti
(della convivenza, della cultura, della religione), che sono prima e più a fondo dei principi e delle
norme esistenti. Andando alle fonti non si sviliscono principi e formule, ma li si re-interpretano, li
si arricchiscono. Girolamo diceva che la scrittura cresce con colui che la legge. La parola del
non-esperto deve cercare di crescere, di trovare i propri spazi, senza rifiutare o all'opposto
mimare gli esperti (se sono davvero tali), ma offrendo la diversità, la novità del proprio punto di
vista. Normalmente chi è esperto, come chi ha potere, è geloso di quelle parole, non di rado le
scoraggia, le svalorizza, o le fa tacere. Non solo per questo, ma per la sua validità in sé, c'è un
impegno a parlare, cercando parole nuove che si facciano capire anche dagli altri che ancora
non ne hanno.
Vi sono parole che non vogliono dire tutto, per sobrietà, che lasciano libertà a chi ascolta di
andare avanti per conto proprio: sono parole poietiche, parole poetiche, perché producono
significati che crescono, si trasformano con chi le ascolta, sono volutamente una "opera
aperta", che vogliono trasmettere una passione perché diventi con-passione. Sono pensate e
gettate come semi per coloro che sono disposti ad accoglierle nello stesso spirito, come semi,
che devono morire, mutare e germogliare. Parole di testimonianza dello spirito, religioso o
non-religioso che sia, parole che si offrono e non si impongono. Parole che non dicono tutto,
non vogliono avvolgere in una argomentazione, che in quanto tale spesso non ha bisogno di
coinvolgimento personale ma solo di analisi e di obbedienza logica. Mostrano un cambiamento
possibile, un allargamento dell'esperienza, che però dev'essere creato da chi ascolta, dalla sua
presa di parola e dalla sua esperienza, di senso e di relazione.
5/5