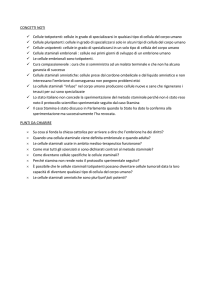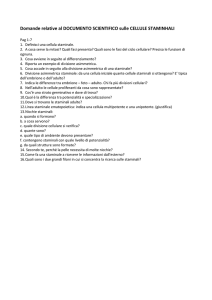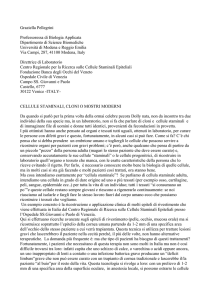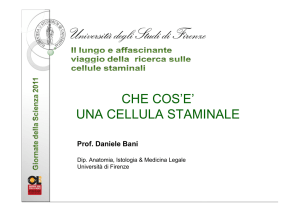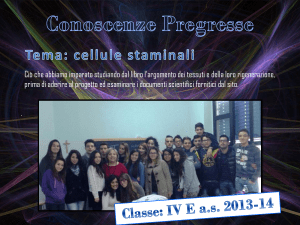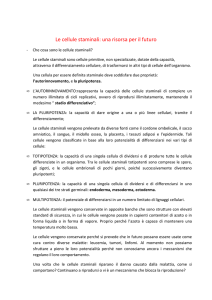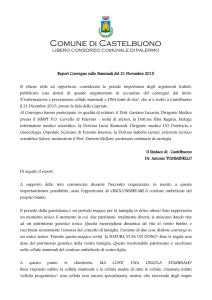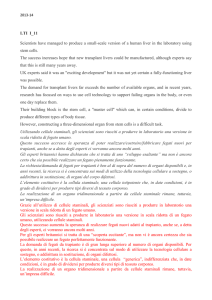MEDICINA DI LABORATORIO: IMMUNOEMATOLOGIA
17/03/2006 ORE 11:30-12:30
PROF D’ONOFRIO
CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE
Dopo la premessa sull’embriogenesi trattata nell’ora precedente, entriamo nell’ambito più specifico
delle cellule staminali emopoietiche: vedremo, alla fine del discorso o la prossima volta, che queste
cellule, che come vedete sono già il risultato di una maturazione e di una conseguente perdita di
potenzialità, hanno anche un’altra caratteristica molto importante, ed è quella della plasticità, cioè la
capacità di generare anche tessuti diversi da quello emopoietico. Si è visto sperimentalmente che, se
rimaniamo nell’ambito del mesoderma, le cellule emopoietiche staminali sono in grado di
rigenerare, ad esempio, il tessuto miocardio infartuato: queste potrebbero addirittura, in coltura,
dare luogo a cellule nervose, quindi a cellule appartenenti ad un altro foglietto embrionale. Questa
capacità di una cellula staminale già orientata in una direzione di dar luogo a tessuti diversi da
quelli in cui si trova è appunto nota come plasticità ed è uno degli aspetti che nei prossimi anni si
studierà di più.
Derivazione delle cellule staminali per uso terapeutico:
utilizzate in pratica: progenitori emopoietici
- adulto: midollo osseo e sangue periferico mobilizzato
- sangue di cordone ombelicale
utilizzo possibile
- fegato o midollo osseo fetale
utilizzo teorico (ormai possibile)
- cellule staminali mesenchimali
- cellule staminali embrionali
La cellula emopoietica è quella su cui sappiamo tutto e, da un punto di vista terapeutico, il trapianto
di queste cellule si pratica ormai da vent’anni (è considerata una procedura tecnicamente
relativamente facile). Tutto questo è stato possibile perché le cellule emopoietiche sono facili da
ottenere: le cellule staminali nervose, ad esempio, non possiamo prenderle altrove che in un
cadavere, oppure in un feto abortito, comunque in un materiale morto, procedimenti sicuramente
abbastanza complicati; al contrario i progenitori emopoietici, nell’adulto, si trovano nel midollo
osseo (rappresenta la loro sede canonica) e nel sangue periferico e quindi qui si possono raccogliere,
procedimento che, a livello clinico, è oggi il più utilizzato. La terza sorgente possibile è fornita dal
cordone ombelicale: quando c’è un parto, quel sangue che sta nel funicolo non viene gettato ma
criopreservato, cioè conservato a temperature molto basse in azoto liquido. Queste cellule staminali
sono utilizzabili a scopo trapiantologico: è da pochi anni che si sta percorrendo questa strada, il
problema è che all’interno di ogni singolo cordone il numero di cellule è basso, quindi ne servono
molti. In Italia, per legge, queste cellule staminali non possono essere usate a scopi autonomi e
personali, ma per donazione; non così in America dove sono presenti delle banche private che a
pagamento conservano il cordone ombelicale. La probabilità di un utilizzo di questo tipo in futuro è
estremamente remota: la legge degli altri paesi europei, così come quella italiana, vieta questo
business. Come vedete dallo schema sopra esposto, ci sono altre possibilità che si sperimentano:
una è quella delle cellule staminali embrionali, che però presenta complicanze di tipo tecnicobiologico ed etico. Poi quelle mesenchimali, dal mesoderma da cui derivano le componenti
emopoietiche e mesenchimali da cui a loro volta si formano endoteli, condrociti, osteoblasti e tutta
la cartilagine.
A rigore si definiscono cellule staminali totipotenti esclusivamente le cellule embrionali, che
possono dar luogo a qualsiasi tessuto: tuttavia, nella pratica comune, per cellula totipotente si può
anche indicare quella che dà origine a tutte le cellule midollari, quindi linfociti, cellule eritroidi,
granulocitiche, che sarebbe però più corretto definire cellule multipotenti o pluripotenti.
Schematizzando si può dire che da una cellula pluripotente si formano due cellule figlie, chiamate
cellule progenitrici emopoietiche: queste sono ancora ad uno stadio molto indifferenziato, tuttavia
hanno già perso alcune caratteristiche, quali quella dell’automantenimento. Il progenitore prolifera e
contemporanemante matura, cioè acquisisce delle capacità e delle proprietà che poi saranno tipiche
delle cellule mature. Quali sono i segni di maturazione delle cellule della linea eritroide? Uno di
questi è la produzione di emoglobina, che conferisce al citoplasma della cellula in maturazione un
colore grigiastro. Il processo maturativo prevede cellule inizialmente dotate di citoplasma blu (dato
dalla presenza di numerosi ribosomi ed RNA per la sintesi proteica) e un nucleo di grandi
dimensioni che, per condensazione, diventa picnotico fino ad essere espulso dalla cellula: questa
diventa quindi un reticolocita che, perdendo poi gli ultimi residui di RNA citoplasmatico, si
trasforma a sua volta in un globulo rosso maturo. Il reticolocita trascorre due giorni nel midollo
osseo e uno nel sangue periferico, ed è quindi qui che maturerà in globulo rosso. Da una staminale
si formano otto globuli rossi, e forse anche di più. Per avere, nel sangue, cellule mature (linfociti,
globuli rossi, piastrine, granulociti e monociti) si devono svolgere questi due fondamentali
processi: l’amplificazione, attraverso la proliferazione, e la differenziazione. Man mano che il
processo di maturazione, quindi di differenziazione, procede, diminuisce la capacità di
proliferazione delle cellule, che alla fine è nulla (l’unica cellula, nel sangue periferico, in grado
ancora di entrare in mitosi è il linfocita di memoria, mentre le altre sono ormai solo dei trasportatori
o di emoglobina, nel caso dei globuli rossi, o di granuli che vanno ad agire per esempio contro i
batteri, ed è il caso dei neutrofili; i monociti diventeranno macrofagi quando passano nei tessuti).
Nei primi anni del 1900 si discuteva molto sulle teorie monofiletica, cioè una sola cellula da cui
prendono origine tutte le cellule del sangue, e polifiletica, secondo la quale ogni cellula ha un suo
precursore: la prima delle due si è rivelata quella giusta. Adolfo Ferrata fu il primo a scoprire,
almeno in linea teorica, la cellula staminale emopoietica che egli stesso chiamò ematocitoblasto,
cioè una cellula multipotente. Dalla cellula multipotente prendono origine varie linee cellulari:
quella del sistema linfatico (che si divede poi in B e T), la serie eritroide, quella mieloide con i
granulociti e poi i megacariociti. Questi ultimi in realtà non si dividono, ma in seguito a numerose
mitosi si ingrossano determinando la formazione di una grande cellula che sfalda il suo citoplasma
in piastrine. Le cellule staminali sono simili a quelle della leucemia acuta e nei soggetti normali
sono circa 1/1000, quindi molto poche.
Riassumiamo ora le proprietà delle cellule staminali:
la capacità di autorinnovarsi: per divisione che può essere simmetrica ( da una staminale si
formano due cellule che maturano e due staminali) o asimmetrica (da una staminale se ne
forma una staminale e una che matura….scusate ma sull’asimmetrica non sono sicura..)
lunga sopravvivenza, quiescenti o in ciclo molto lento, ma alto potenziale proliferativo: le
cellule staminali non fanno numerose mitosi, ma sopravvivono a lungo e hanno un alto
potenziale proliferativo che normalmente non viene esplicato. E’ il substrato genetico che
regola questi processi: esistono infatti geni per la differenziazione lungo una certa linea
cellulare. E’ un discorso troppo lungo e complesso perché sia affrontato in questa sede,
tuttavia tenete presente che quando parliamo di fenomeni che riguardano la maturazione, la
proliferazione e la differenziazione, ci sono sempre dei geni che vengono attivati oppure
bloccati e che producono poi le modificazioni fenotipiche e morfologiche di queste cellule.
Quindi questo potenziale proliferativo, nella cellula staminale, non si esplica ma rimane
come una lentissima attività di fondo.
capacità di differenziare in elementi funzionalmente attivi appartenenti a più linee cellulari:
questa capacità non è propria di un solo tipo cellulare, ma di molti: per esempio una cellula
staminale emopoietica può essere chiamata staminale se produce sia linfociti, sia eritrociti,
sia granulociti.
sensibilità a citochine e molecole adese con azione istruttiva o selettiva: i geni che
controllano questi processi vengono attivati e disattivati anche in funzione di stimolazioni
provenienti dall’esterno della cellula: le citochine sono numerose sostanze che svolgono
funzioni relative alla sopravvivenza e alla proliferazione cellulare: una citochina di cui
abbiamo parlato prima è per esempio l’eritropoietina che favorisce la proliferazione delle
cellule eritroidi soprattutto bloccando i processi di apoptosi cellulare. Molto spesso queste
citochine sono fattori di crescita, cioè sostanze necessarie affinché le cellule messe in coltura
sopravvivano. Alcune di queste molecole non sono solubili ma vengono presentate da altre
cellule. Alcune delle citochine che agiscono a livello di diversi comparti maturativi sono
sotto riportate:
- sulle cellule staminali primordiali (proliferazione e differenziazione): SCF, IL-1, IL-3, IL6, IL-11, IL-12, G-CSF (fattore di crescita dei granulociti), M-CSF (fattore di crescita dei
monociti), GM-CSF (fattore di crescita di granulociti-monociti), LIF
-sulle cellule progenitrici (proliferazione e differenziazione): G-CSF, M-CSF, GM-CSF,
SCF, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-11, eritropoietina, LIF
-sulle cellule mature:
su granulociti e neutrofili: G-CSF, GM-CSF, M-CSF, SCF, IL-3 e IL-6
su eritrociti: eritropoietina
su eosinofili: IL-5
Da notare per esempio che l’eritropoietina esplica la sua funzione non sulle cellule staminali
primordiali, ma solo su quelle già in parte differenziate e avviate lungo una linea maturativa. Oggi
conosciamo anche la trombopoietina che agisce sui megacariociti.
Ci sono cellule stromali, anche dette mesenchimali, che non sono parte della progenie emopoietica,
ma servono come matrice del tessuto midollare e hanno la capacità, attraverso molecole di adesione,
di presentare alle cellule staminali ed ai progenitori emopoietici dei fattori di crescita: quindi non è
solo un meccanismo di tipo umorale, ma anche di cooperazione tra cellule stromali ed
emopoietiche.
L’azione istruttiva è quella che favorisce la maturazione lungo una certa linea, l’azione selettiva è
quella che blocca la maturazione lungo una certa linea e favorisce quella verso altre linee.
Passiamo ora ad un altro argomento, relativo al modo di studio di queste cellule staminali
emopoietiche: esistono diversi meccanismi, quelli sotto esposti si riferiscono a metodi di studio in
vivo, che non si usano in ambito clinico pratico, ma in quello della ricerca:
CS MURINE:
- ricostituzione emopoietica nell’animale letalmente irradiato: questo esperimento, che risale
al 1963, di Steeve e Mc Caller (direi che il nome suona più o meno così, ma non l’ho
trovato scritto da nessuna parte..scusate!), è alla base di tutte le nostre conoscenze sulle
cellule staminali ed ha fornito la prova della teoria monofiletica del 1910 di Adolfo Ferrata.
Si prende un topo e lo si irradia con dosi che lo portano a morte rapida. La morte
sopravviene in seguito a infezione, anemia ed emorragia, dovuti al danneggiamento
provocato dalle radiazioni a livello dei tessuti che proliferano rapidamente, quindi
l’intestino, ma, considerevolmente più importante, il midollo osseo: tale esito è dovuto
dunque alla distruzione delle cellule staminali, anche se ciò all’epoca dell’esperimento
ancora non si sapeva. A questo punto, dopo aver prelevato cellule staminali di midollo osseo
da un topo non irradiato, le inocularono su un secondo topo, irradiato: ciò permetteva la sua
sopravvivenza. Videro inoltre che questi topi, in seguito comunque sacrificati, avevano la
capacità di produrre cellule del sangue e questa volta si formavano delle colonie, cioè dei
gruppi di cellule, nella milza. I due autori avevano così scoperto quelle che chiamarono,
coniando un termine ancora oggi in uso, CFU-S, ovvero colon forming unit, (“s” sta per
spleen, milza), e dimostrarono che una sola cellula dava origine a una colonia clonale di
cellule contenenti ciascuna quelle differenziate del sangue, quindi megacariociti, eritroblasti
e precursori dei granulociti. Prendendo tali colonie, poi, riuscirono a riprodurre ancora
questa capacità. Oggi questo esperimento è praticato per valutare le proprietà delle cellule
staminali. Si può fare anche in vitro: se io ho raccolto delle cellule staminali dal sangue di
un paziente, per poi infondergliele nuovamente nel momento di un trapianto, posso metterle
in coltura per valutare il loro numero e vedere che capacità hanno di formare colonie:
usiamo questo come un test clinico per valutare il contenuto funzionalmente valido di
cellule staminali. Quando ho conservato cellule staminali in azoto liquido per un lungo
periodo di tempo, nell’ordine di anni, posso temere che si siano rovinate, quindi, prima di
utilizzarle per un trapianto, se ne analizza una piccola quantità per controllare che appunto
siano funzionalmente valide: è questo il test CFU ( senza “s” dato che non sono più
spleniche).
CS umane:
- recupero emopoietico in topi immunodeficienti (NOD/SCID) irradiati: dal punto di vista
sperimentale è interessante utilizzare cellule staminali umane per esperimenti in vivo su
animali; il problema che si presenta è quello del rigetto, superabile utilizzando topi con
immunodeficienza (ceppi di topi NOD/SCID) irradiati, tolleranti dunque all’inoculo di
cellule umane
- modello “fetal sheep”: le cellule umane sono inoltre trapiantabili nel feto di pecora.
Entrambi questi metodi sono piuttosto complessi e attuati in laboratori di ricerca piuttosto
che in ambito clinico e pratico.
analisi clonale: rappresenta lo studio di marcatori genetici. Un esempio è il caso della
leucemia mieloide cronica, malattia che è caratterizzata dal marcatore cromosomico dato dal
cromosoma di Philadelphia: questo risulta per traslocazione reciproca tra le braccia lunghe
dei cromosomi 9 e 22, quindi per fusione di due geni che producono una sostanza
enzimatica che è causa della leucemia, la tirosinchinasi, che oggi viene curata con dei suoi
inibitori. La presenza di tale marcatore citogenetico permette il riconoscimento delle cellule
mutate ovunque esse si trovino, quindi nonostante questa malattia si esprima inizialmente
soltanto nella serie granulocitaria, grazie al marcatore si vede invece che questa stessa
alterazione è presente anche negli eritroblasti, cioè nei precursori dei globuli rossi, o
addirittura nei linfociti: ciò permette di capire che la mutazione avviene a livello della
cellula staminale emopoietica. In generale questo metodo è applicabile per marcare, con una
certa lesione genetica, le cellule e seguirle in vivo.
Per coltivare cellule staminali, che daranno origine alle relative progenie, si prendono delle fiasche
di plastica o di vetro, si crea un ambiente favorevole utilizzando sostanze quali agar, metilcellulosa, che funge da supporto, e si inseriscono le cellule, si aggiungono quindi fattori di crescita
appropriati rispetto alla serie cellulare che si vuole coltivare (ad esempio eritropoietina per la serie
eritroide) e sostanze nutrienti: nel giro di pochi giorni, se fra le cellule seminate erano presenti
quelle staminali, si formeranno le colonie. Importante focalizzare l’attenzione sul fatto che queste
colonie sono clonali, cioè figlie di una sola cellula.
Esiste anche il metodo del test citofluorimetrico, di cui parleremo meglio la prossima volta.
Prendendo cellule del sangue periferico di un donatore, che magari è in attesa di un trapianto, le
analizzo con un grafico bidimensionale sulla cui ascissa c’è il parametro di scatter, cioè la
deviazione della luce prodotta da cellule con granuli, sulle ordinate la fluorescenza: quindi uso un
anticorpo monoclonale, o meglio un particolare antigene, che sta solo sulle cellule staminali e che si
chiama CD34, che mi permette di identificare la presenza o meno di staminali. La prossima volta
vedremo anche il metodo che permette la purificazione di tali cellule.
Il prof ha specificato nel bel mezzo della lezione di non impazzire ogni volta per copiare tutte
le tabelle i grafici&co proiettati perché in futuro si preoccuperà lui di farceli avere… i saluti
alla prossima ora di sbobinatura!
Chiara Piccininni