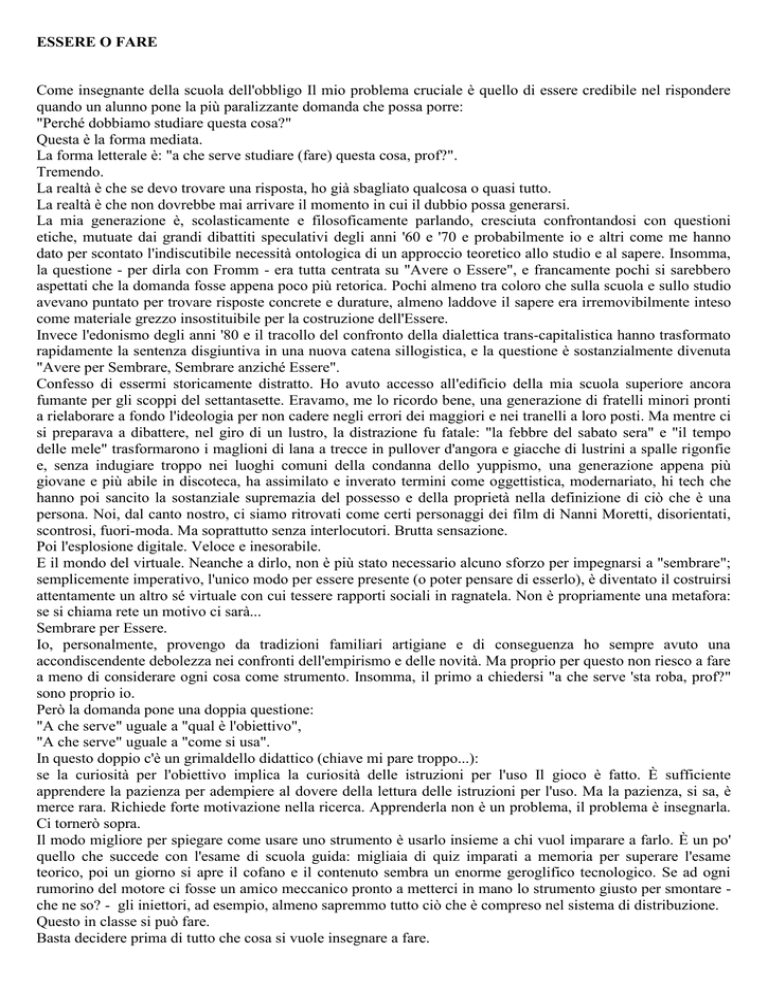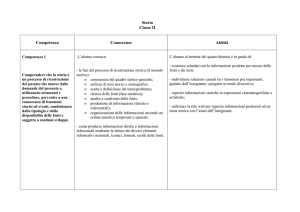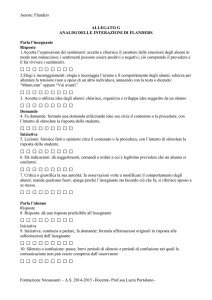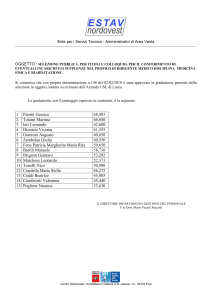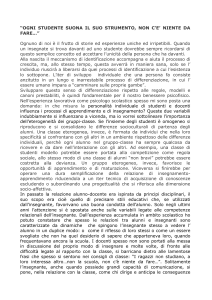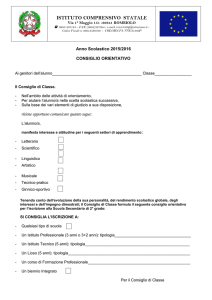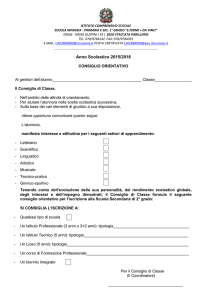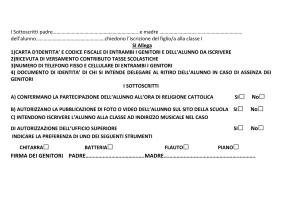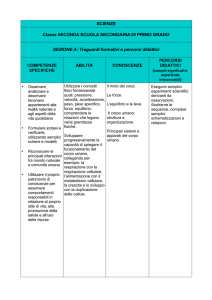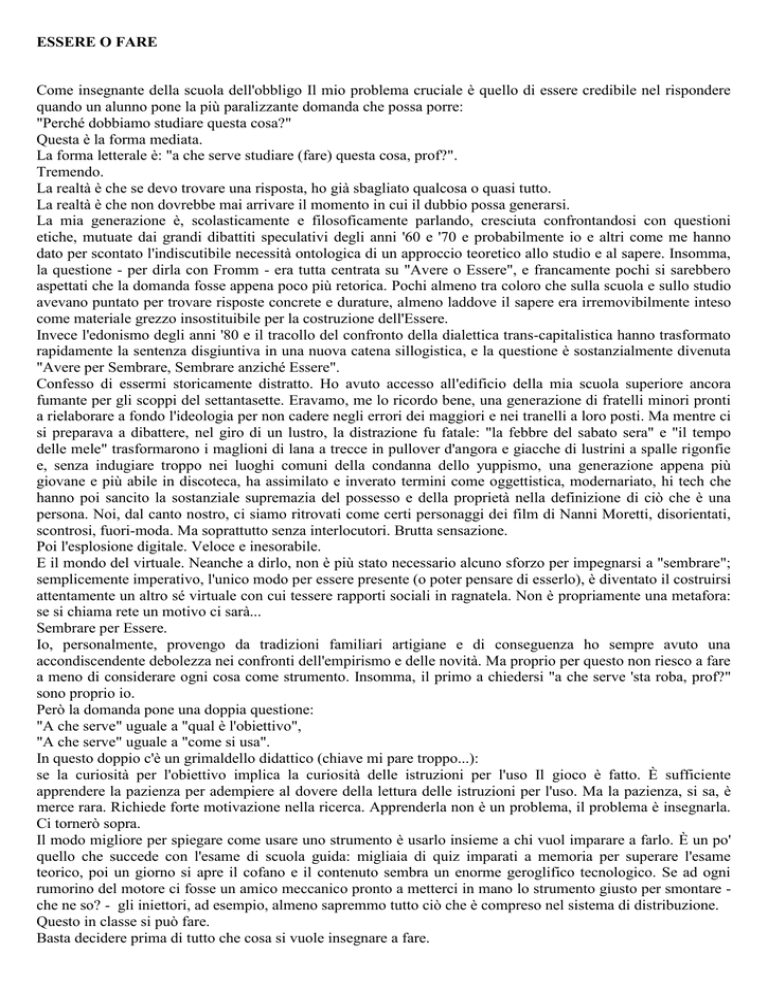
ESSERE O FARE
Come insegnante della scuola dell'obbligo Il mio problema cruciale è quello di essere credibile nel rispondere
quando un alunno pone la più paralizzante domanda che possa porre:
"Perché dobbiamo studiare questa cosa?"
Questa è la forma mediata.
La forma letterale è: "a che serve studiare (fare) questa cosa, prof?".
Tremendo.
La realtà è che se devo trovare una risposta, ho già sbagliato qualcosa o quasi tutto.
La realtà è che non dovrebbe mai arrivare il momento in cui il dubbio possa generarsi.
La mia generazione è, scolasticamente e filosoficamente parlando, cresciuta confrontandosi con questioni
etiche, mutuate dai grandi dibattiti speculativi degli anni '60 e '70 e probabilmente io e altri come me hanno
dato per scontato l'indiscutibile necessità ontologica di un approccio teoretico allo studio e al sapere. Insomma,
la questione - per dirla con Fromm - era tutta centrata su "Avere o Essere", e francamente pochi si sarebbero
aspettati che la domanda fosse appena poco più retorica. Pochi almeno tra coloro che sulla scuola e sullo studio
avevano puntato per trovare risposte concrete e durature, almeno laddove il sapere era irremovibilmente inteso
come materiale grezzo insostituibile per la costruzione dell'Essere.
Invece l'edonismo degli anni '80 e il tracollo del confronto della dialettica trans-capitalistica hanno trasformato
rapidamente la sentenza disgiuntiva in una nuova catena sillogistica, e la questione è sostanzialmente divenuta
"Avere per Sembrare, Sembrare anziché Essere".
Confesso di essermi storicamente distratto. Ho avuto accesso all'edificio della mia scuola superiore ancora
fumante per gli scoppi del settantasette. Eravamo, me lo ricordo bene, una generazione di fratelli minori pronti
a rielaborare a fondo l'ideologia per non cadere negli errori dei maggiori e nei tranelli a loro posti. Ma mentre ci
si preparava a dibattere, nel giro di un lustro, la distrazione fu fatale: "la febbre del sabato sera" e "il tempo
delle mele" trasformarono i maglioni di lana a trecce in pullover d'angora e giacche di lustrini a spalle rigonfie
e, senza indugiare troppo nei luoghi comuni della condanna dello yuppismo, una generazione appena più
giovane e più abile in discoteca, ha assimilato e inverato termini come oggettistica, modernariato, hi tech che
hanno poi sancito la sostanziale supremazia del possesso e della proprietà nella definizione di ciò che è una
persona. Noi, dal canto nostro, ci siamo ritrovati come certi personaggi dei film di Nanni Moretti, disorientati,
scontrosi, fuori-moda. Ma soprattutto senza interlocutori. Brutta sensazione.
Poi l'esplosione digitale. Veloce e inesorabile.
E il mondo del virtuale. Neanche a dirlo, non è più stato necessario alcuno sforzo per impegnarsi a "sembrare";
semplicemente imperativo, l'unico modo per essere presente (o poter pensare di esserlo), è diventato il costruirsi
attentamente un altro sé virtuale con cui tessere rapporti sociali in ragnatela. Non è propriamente una metafora:
se si chiama rete un motivo ci sarà...
Sembrare per Essere.
Io, personalmente, provengo da tradizioni familiari artigiane e di conseguenza ho sempre avuto una
accondiscendente debolezza nei confronti dell'empirismo e delle novità. Ma proprio per questo non riesco a fare
a meno di considerare ogni cosa come strumento. Insomma, il primo a chiedersi "a che serve 'sta roba, prof?"
sono proprio io.
Però la domanda pone una doppia questione:
"A che serve" uguale a "qual è l'obiettivo",
"A che serve" uguale a "come si usa".
In questo doppio c'è un grimaldello didattico (chiave mi pare troppo...):
se la curiosità per l'obiettivo implica la curiosità delle istruzioni per l'uso Il gioco è fatto. È sufficiente
apprendere la pazienza per adempiere al dovere della lettura delle istruzioni per l'uso. Ma la pazienza, si sa, è
merce rara. Richiede forte motivazione nella ricerca. Apprenderla non è un problema, il problema è insegnarla.
Ci tornerò sopra.
Il modo migliore per spiegare come usare uno strumento è usarlo insieme a chi vuol imparare a farlo. È un po'
quello che succede con l'esame di scuola guida: migliaia di quiz imparati a memoria per superare l'esame
teorico, poi un giorno si apre il cofano e il contenuto sembra un enorme geroglifico tecnologico. Se ad ogni
rumorino del motore ci fosse un amico meccanico pronto a metterci in mano lo strumento giusto per smontare che ne so? - gli iniettori, ad esempio, almeno sapremmo tutto ciò che è compreso nel sistema di distribuzione.
Questo in classe si può fare.
Basta decidere prima di tutto che cosa si vuole insegnare a fare.
Fare per me è la parola chiave.
Prima di tutto io FACCIO l'insegnante. Non sono un insegnante. È il mio mestiere, E mestiere è parola nobile
che associo ad arte. Che mi piaccia o no, la società in cui vivo si è, nel bene e nel male, formata sulla struttura
lentamente costruita dai praticanti delle arti e dei mestieri. Lungi da me fare l'elogio della massoneria o
mitizzare la figura dell'imprenditore (per deformazione giovanile mi viene ancora da chiamarlo "il padrone"),
ma finché il virus industriale non ha affossato l'ingegno della persona, impadronendosene per il "bene" della
produzione seriale, la società umana occidentale si è garantita inventiva, pluralismo e laicismo grazia alla
scintilla dei cosiddetti uomini liberi. Mi riferisco a quelli che riparando qualcosa e mettendo insieme pezzi rotti
vari, riuscivano ad inventarne un'altra. Non solo i grandi inventori, ma anche il primo intrecciatore di vimini,
colui che per primo ha pensato a sfruttare la caduta dell'acqua anziché lo scorrimento per muovere la ruota di un
mulino, chi ha macerato stracci per inventare la carta e un milione e più di altri. Non sappiamo i nomi di
costoro, ma sappiamo benissimo cosa hanno fatto e gliene siamo grati.
Per questo ai miei alunni spiego che io FACCIO l'insegnante e non lo sono. Non perché me ne siano grati,
ovviamente, ma perché sappiano che un mestiere è uno strumento per realizzare e che stare in classe è un
mestiere. Perché sappiano che loro FANNO gli alunni, non lo sono. Perché ognuno di loro capisca che può
essere il prossimo a cambiare la storia "inventando l'intrecciar di vimini". E facendo gli alunni arriveranno a
saper fare delle cose avendone la consapevolezza teorica.
"Essere o Fare" quindi? Non proprio.
"Fare per Essere", piuttosto.
Ma in realtà ho, in ventitré anni di insegnamento, maturato la sensazione che concentrandosi troppo sull'Essere,
anziché abbatterle, abbiamo sollevato un mucchio di difficoltà insormontabili e scoperto il fianco a tante
insinuazioni della cultura dell'immagine e del sembrare. Perciò preferisco una sana e ponderata distrazione da
sé. Mi piace tanto il modello dei Beatles: non si prendevano troppo sul serio, ma, quando facevano musica,
facevano musica sul serio, accidenti! Se questo modello non è sufficientemente aulico, allora voglio proporre
l'Umberto Eco autoironico dei Diari minimi o il Dante di "Guido, i'vorrei..." o un certo modo di divulgare la
scienza di Stephen Hawking: si direbbe proprio che restando concentrati su qualcosa da fare, il buonumore
aumenti e la gerarchia delle insormontabilità venga ridisegnata.
Facciamo!
Intanto facciamo!
Poi troveremo perfino il modo di far bene e poi benissimo.
Comportarsi con gli altri è il primo e più importante fare da insegnare e da apprendere.
È il viatico che conduce
al gioco di squadra,
alla solidarietà,
alla condivisione,
all'unità che porta alla soluzione del problema e alla realizzazione dell'opera.
Tutte competenze fondamentali per la formazione di un buon cittadino, che resta il mio obiettivo principale
quando faccio l'insegnante nella scuola dell'obbligo della Repubblica italiana.
L'IRRIVERENZA
Mettiamo i baffi alla Gioconda per capire chi è Leonardo.
Non sono uscito fuori di testa. Semmai lo sono sempre stato.
E non è un invito al vandalismo.
Piuttosto un gioco che magari si può fare su delle fotocopie di una riproduzione del quadro per usare il vecchio
trucco di "rovesciare" una lezione: proporre la fine (misteriosa) del racconto all'inizio e ripartire da zero per
dare al gesto iniziale un nuovo significato.
È una delle questioni più dibattute della storia dell'arte: chi è la donna rappresentata nella piccola tela di
Leonardo Da Vinci che tutti, ma proprio tutti, conoscono?
In realtà non so dire se la questione sia così importante. Forse filologicamente lo è, ma artisticamente la
questione potrebbe essere irrilevante ai fini dell'apprezzabilità dell'opera. Sta di fatto che l'interrogativo è ed è
sempre stato pressante.
Molti indizi portano ad identificare l'enigmatico, sfuggente, eppur rassicurante sorriso rappresentato da
Leonardo, con quello di Lisa Gherardini moglie di Francesco del Giocondo, commerciante di sete e amico del
padre dell'artista.
Una serie di incongruenze non trascurabili (la mancata contabilizzazione della commissione dell'opera nei
registri minuziosi del mercante, i riferimenti del biografo Vasari alle ciglia e sopracciglia inesistenti della
Monna Lisa che conosciamo e alla incompletezza dell'opera che invece appare perfettamente terminata) hanno
messo in dubbio l'attribuzione dell'identità della modella. È uscito fuori, poi, che esisterebbe un lavoro
catalogato come "Gioconda"; lavoro descritto incompleto e andato perduto, annoverato tra quelli che Leonardo
avrebbe ceduto al suo allievo prediletto Gian Giacomo Caprotti. La Monna Lisa del Louvre, perciò, sarebbe
qualcun altro.
Una nuova ricostruzione dei fatti pone l'attenzione sulle vicende che riguardano la vita di Giuliano de' Medici
duca di Nemours.
Leonardo trascorse i suoi ultimi anni in Francia, nel castello di Clos-Lucé, presso Amboise, invitato dal re
Francesco I che conobbe il da Vinci mentre l'artista era in viaggio al seguito di papa Leone X. Qui il cronista
Antonio De Beatis, segretario del cardinale Luigi d'Aragona, racconta di aver visto nello studio di Leonardo tre
opere che il pittore aveva portato con sé: Sant'Anna, San Giovanni Battista e il ritratto di una donna fiorentina
commissionato dal de' Medici. Giuliano, a differenza del fratello Giovanni (papa Leone X), era poco interessato
alle questioni politiche, ma molto attratto dall'arte e dalle donne. Mecenate e seduttore, ebbe innumerevoli
storie d'amore. Amore e dintorni, insomma. È un fatto che nel suo periodo di residenza ad Urbino ebbe un figlio
illegittimo in seguito ad una scappatella con una cortigiana del luogo, tal Pacifica Brandani. Non è chiara la
consistenza della relazione trai due e se addirittura Pacifica fosse consenziente, è però attestato nel libro degli
esposti della Confraternita di Santa Maria del Piano di Urbino che ad aprile del 1511 le nacque un figlio orfano
(la Brandani morì in seguito al parto) che da Giuliano sarà riconosciuto e nominato Ippolito.
Giuliano e Leonardo si incontrarono negli appartamenti papali pochi anni dopo, probabilmente intorno al 1514,
quando Leonardo risiedeva a Roma proprio per il favore ottenuto dal mecenate fiorentino. Qui Giuliano
avrebbe chiesto a Leonardo di ritrarre a sua immagine e fantasia il volto di una madre che ne confortasse la
mancanza al figlio Ippolito. E la richiesta faceva leva su un rapporto da amicizia trai due: molto probabilmente
Giuliano sapeva che Leonardo aveva vissuto una mancanza simile a quella di Ippolito, infatti era nato da una
relazione illegittima tra il padre, ser Piero e una sua servitrice, Caterina Buti, allontanata dalla famiglia
dell'illustre notaio subito dopo la sua morte.
Grande sarebbe stato il coinvolgimento emotivo di Leonardo nella realizzazione del ritratto.
Giuliano de' Medici, conte di Nemours, morì prima che Leonardo potesse completare l'opera. Non è difficile
immaginare per quale stretto legame con essa, il Maestro la tenne con sé fino alla fine dei suoi giorni.
È tutto vero? È tutto plausibile? Boh?
Però è bello pensare che il genio, l'architetto, l'ingegnere, l'inventore, lo scettico, il pensatore che tanto lustro ha
dato alla cultura del Rinascimento e alla storia italiana, che sempre è dipinto come un granitico,
imperscrutabile, misterioso monumento del fare e del sapere coniugati all'infinito, abbia custodito nella sua
opera più emblematica, la più intima e segreta delle sue fragilità. Forse non era la noia superba del genio che lo
spingeva troppo spesso ad abbandonare le sue opere all'incompletezza non appena risolto il passaggio chiave,
forse un'ansia più radicata e intima rendeva inquieto e tormentoso il suo vivere e il suo operato. È umano e
delicato immaginarlo confortarsi rispecchiandosi nel sorriso della madre che mai ebbe; rende spessore e
delicatezza ad un genio ed un artista che perfino nei suoi errori di progettazione più vistosi appare sempre
incrollabile.
Siete riusciti ad arrivare sin qui appassionandovi a questa storia tra i cavilli degli indizi e delle date che pure ho
scremato?
Dubito che un alunno della scuola dell'obbligo ci riuscirebbe.
Aggiungiamo i baffi alla Gioconda, allora. Senza alcuna paura di mancarle di rispetto.
E anche una lunga barba bianca.
Lentamente dovrebbe comparire qualcosa di Leonardo. Aggiungiamo ancora fino a farla somigliare a
Leonardo. Perché è inevitabile che nel volto di una madre ci siano i lineamenti del figlio. Soprattutto se è una
madre dal figlio immaginata. Allora sarà divertente andare a caccia degli indizi che possono svelare i segreti di
Monna Lisa, anzi, Monna Pacifica, a questo punto. Potremmo benissimo raccontare ed osservare insieme che,
in effetti, quel volto e quel sorriso sono più portatori di pace che di gioia, più "pacifici" che "giocondi". Come si
conviene ad un sorriso rivolto ad un bimbo impaurito. Che il suo sguardo ci segue sempre perché, lo sguardo di
una madre, anche una madre che non c'è, è sempre rivolto verso il figlio. Diamo umana fragilità al padre di tutti
i geni e avviciniamolo a noi comuni mortali, così potremo spiegare bene che da un dolore inguaribile può
nascere un capolavoro assoluto e immortale. Che in ogni dolore o fastidio c'è il pretesto per tirar fuori il piccolo
da Vinci che ognuno dentro ha. Insegniamo che da ogni dolore può nascere, facendo, una piccola grande
Monna Lisa. Se attraverso una docile irriverenza avremo reso più abbordabile e amico il più osannato degli
artisti, saremo tutti più convinti di poter agire come Leonardo. Se capiremo meglio l'umanità di Leonardo
riusciremo meglio a trovare la leonardità all'interno del nostro essere umani.
Mettiamo i baffi alla Gioconda per capire chi è Leonardo.
LA CURIOSITÀ
(Tolomeo o Copernico?)
L'immagine del grimaldello didattico mi piace perché prevede un allegro scasso. È propedeutico al
momentaneo crollo della certezza, al disorientamento del sapere acquisito che insinua il dubbio e genera
curiosità: la curiosità ansiosa e istintiva del momento di crisi (in senso etimologico, dal greco κρίσις) che
impone una scelta, cognitiva o operativa.
Se la pazienza è il carburante, la curiosità è il motore.
La curiosità genera l'abbrivio indispensabile di un percorso efficace per uno scolaro (parola desueta, ma
simpatica).
Per un giovane studente ha la proprietà di essere contemporaneamente una forma di sete ardente e di bevanda
superdissetante.
Per fortuna, incuriosire non è così difficile, soprattutto se si segue con ironia la tortuosa e vivace strada del
paradosso.
Mi è capitato di fare una riflessione sulle incongruenze valutative con cui molto spesso ho risolto i giudizi sui
miei alunni: è capitato di individuare tra gli ostacoli insormontabili di alcuni di loro, una radicata mancanza di
punti di riferimento personali (ovviamente non per colpa loro: conosciamo troppo bene il lavoro di erosione
operato dalle assenze familiari, dalle condiscendenze e dai compiacimenti compensativi, dai bombardamenti
degli input esteriori e superficiali) e, nel contempo, di denunciare un'incongrua pigrizia mentale e mancanza di
curiosa vivacità. Non mi è sempre stato chiaro che la seconda "falla" è una vera e propria autodifesa dalla
prima. I bambini/ragazzi nell'età della scuola dell'obbligo cercano certezze e punti di riferimento solidi
istintivamente, è inevitabile che si guardino bene dall'essere curiosi e speculativi, perché l'impostazione di un
procedimento dialettico, per quanto primitivo, impone di navigare a vista in mare aperto con continuità e di
cambiare punti di riferimento in continuazione. Non va bene affatto per chi non ha certezze cui aggrapparsi.
Non è un caso che la curiosità intellettuale è, sempre con le dovute fortunate eccezioni, presenza più diffusa nei
ragazzi che hanno vite socialmente e familiarmente più serene.
So di aver detto una cosa banale e scontata, ma sono dovuto arrivarci nel tempo e come tutti i traguardi
raggiunti, lo considero una preziosa conquista.
La curiosità ansiosa e istintiva del momento di crisi impone una scelta, cognitiva o operativa.
L'ho scritto poco sopra, e a rileggerlo, messo così, è davvero drammatico.
Quindi non va bene.
Bisogna invece porre la curiosità come un monolite rassicurante e alleato: non un sollevatore di problemi, bensì
un induttore di soluzioni.
E allora giù di grimaldello. Voglio far crollare il castello di carte per ricostruire il mazzo e poter scoprire quanti
giochi ci si possano fare.
La geografia, ad esempio.
Spesso la adoperiamo come contenuto del viaggiare e proponiamo ai nostri alunni di immaginarsi viaggiatori
per motivarli a scoprire luoghi e percorsi.
Può funzionare e può non funzionare.
Sicuramente i "curiosi già formati" troveranno diletto in questa simulazione e produrranno proficuamente. Ma
quell'alunno che sul pullman chiede continuamente "quanto manca, prof?", lo stesso che entrando agli Uffizi
implora "Quando torniamo in albergo, prof?", lo stesso alunno che alla presentazione del campo-scuola
naturalistico ha chiesto "Ma c'è il wi-fi in albergo, prof?", lui il gusto del viaggio proprio non può averlo,
semmai vuole essere già arrivato al paese in estate per mettersi a giocare con gli amichetti ritrovati, e se avesse
il teletrasporto lo userebbe sempre. Perché apprezzare il viaggio in sé richiede curiosità e pazienza e la curiosità
e la pazienza sono due obiettivi metodologici che producono eccellenza. Non possono essere pre-requisiti.
Per fare squadra bisogna far partire tutti dallo stesso pantano.
Per essere un buon allenatore bisogna dimostrare credibilmente il gusto di sporcarsi di fango.
Quindi se capita l'occasione per mettere tutti, squadra e allenatore, nello stesso disagio (possibilmente
divertente), l'occasione non va sprecata.
L'equinozio di autunno capita sempre ad anno scolastico da poco iniziato (fatte salve catastrofi astronomiche
imprevedibili); io, in qualità di insegnante di geografia, in prossimità dell'evento astronomico, non resisto mai
alla tentazione di utilizzare almeno un'ora di lezione per spiegarne i meccanismi e le implicazioni. Un po' di
consapevolezza cosmica, a mio giudizio, non guasta. E poi gli alunni a cui ci rivolgiamo amano le questioni
dello spazio quanto la mitologia greca e per questo dobbiamo ringraziare certi deformi cartoni animati e
telefilm che ci spalancano un portone per introdurre appassionati correttivi ed esplorazioni cognitive.
Un 22 o 23 settembre ero molto impegnato a gestire le tecnologie didattiche disponibili (lavagna e un paio di
gessetti colorati), per realizzare una comprensibile rappresentazione della terra, dell'eclittica, dei raggi solari,
mentre spiegavo i moti dell'asse terrestre durante la sua rivoluzione. Un banale e comprensibile lapsus fece sì
che accennai al moto del sole attorno alla terra omettendo la parola cruciale: "apparente".
Un'alunna concentrata e attenta, per puro senso del dovere, puntualizzò:
"Prof! Ha detto: - moto del sole attorno alla terra - invece che il contrario".
In una situazione normale ringrazierei per l'attenzione, mi scuserei strategicamente per la distrazione (gli alunni
apprezzano molto l'insegnante che riconosce i propri errori) e riprenderei a sprecar gesso alla lavagna.
Ma qui si trattava di massimi sistemi!
Non una data invertita o un'inversione del soggetto, una svista su una capitale o sul nome di un fiume: qui c'era
in ballo uno dei capisaldi della civiltà occidentale e mondiale. Uno dei punti chiavi della scienza e del sapere
moderno, il crocevia della lotta della conoscenza contro l'ottusità maligna dello sfruttamento dell'ignoranza.
E poi sono dispettoso.
Così, con malcelato divertimento, confermai, argomentando e indicando il cielo dalla finestra, la mia convinta
posizione tolemaica.
Ovviamente la classe divenne un furioso coro di proteste accese e convinte come vorremmo che sempre fossero
per qualsiasi nozione sia stata divulgata e poi contraddetta durante le ore di lezione: Aristarco di Samo,
Copernico e Galileo non avrebbero potuto essere più orgogliosi dei loro giovani discendenti e sostenitori. Così
discesi di non procedere all'inquisizione e di concedere una possibilità a quei pestiferi eretici urlanti:
"Dimostratemelo."
Tutte le braccia alzate:
"Prof! lo sanno tutti, dài!"
"Basta guardare su google Earth"
"Io vado su un satellite e faccio una foto"
"C'è scritto sul libro"
"Ho visto un film e un mucchio di documentari".
Stolidamente pervicace, malignamente consapevole della difficoltà per chiunque di dimostrare empiricamente il
moto della terra attorno al sole, ho continuato a smontare con fin troppa facilità le loro affermazioni, facendo
notare che al passar dei minuti il nostro astro continuava a spostarsi nel cielo mentre noi restavamo ben ancorati
al nostro solido e inamovibile pianeta. Pianeta piatto, per di più (un vero baro rilancia sempre oltre misura).
La situazione divenne allegramente surreale: sapevamo benissimo tutti quanti che mentivo spudoratamente, ma
nessuno era in grado di smontare la mia menzogna.
È a questo punto che mi sono giocato la carta "tutti giù per terra": "Ok! avete un pomeriggio per pensarci,
domani dovrete dimostrarmi che la terra gira intorno al sole e che non è piatta" (rilancio sapendo di coinvolgere
almeno a cena genitori e sorelle/fratelli maggiori. Tutti giù per terra!).
Il giorno dopo, ovviamente, nulla di fatto. Anche chi ha avuto la fortuna di incontrare a cena un fratello/sorella
maggiore paziente e studioso o un genitore allo stesso tempo non stremato dalla giornata lavorativa e in grado
di formulare una dimostrazione plausibile, non è in grado di ricomporre i brandelli di un discorso fin troppo
complesso fatto sbrigativamente tra secondo e contorno.
Il primo obiettivo è raggiunto: siamo tutti nel pantano perché abbiamo dato per scontato che la passerella del "si
sa" tenesse e allo stesso tempo ci stiamo divertendo per due motivi:
- Tutto ciò che è misterioso e sovversivo è divertente per definizione perché ha il sapore fresco della novità.
- Anche i non curiosi, abituati a rincorrere i furetti della classe, si sentono in gioco perché tutti, per una volta, si
annaspa dopo aver formulato le ipotesi più fantasiose e improponibili.
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
È chiaro che ho barato, ma ha funzionato perché l'inganno ha retto per secoli. E non perché l'umanità sia
stupida, bensì perché è cosa difficile da dimostrare per chiunque. Allora ho potuto raccontare di quei curiosi e
attenti osservatori del passato che hanno colto strani movimenti retrogradi (che vuol dire, prof?) di alcuni
pianeti nel cielo e, curiosi di sapere, si sono armati di pazienza e per giorni e giorni, per mesi e mesi, hanno
osservato e annotato tante traiettorie irregolari che potevano essere spiegate solo in un modo.
È una lezione frustrante, perché non svela un trucco facile da ripetere, però pone le basi per un sano scetticismo
speculativo. Immancabilmente genera da quel punto in poi un mucchio di richieste e chiarimenti in qualsiasi
ambito disciplinare perché più nulla (o quasi) sarà dato per scontato. Ma c'è anche il premio: dimostrare che la
tenda è "tonda" è infatti cosa molto più semplice; un facile esperimento da fare in riva al mare o dal molo di un
porto. Osservata la nave in partenza sparire all'orizzonte, è sufficiente trovare un punto di osservazione appena
un po' più alto del precedente per vederla riapparire. Proprio come fosse scivolata in fondo ad una discesa: la
superficie della terra è curva!
Restano la curiosità di verificare il funzionamento dell'esperimento e la pazienza di aspettare l'occasione per
poter verificare. Magari aspettare fino alle vacanze estive per avere l'occasione di vedere una barca allontanarsi
dalla riva. La pazienza figlia della curiosità: le basi di un metodo efficace.
E poi c'è la scuola che esce dall'aula, dalla lavagna, dalle conoscenze autoreferenziali e spiega una verità
piccola, ma segreta, del mondo di fuori, quello della "vita vera" e propone un punto di vista "diverso".
E l'orgoglio di saperla lunga.
INTERDISCIPLINARE
(Incidenti di percorso leggendo il Cantico delle creature)
So di non essere un buon insegnante, perché, tanto per cominciare, non sono capace di preparare fino in fondo
le lezioni. E infatti, quando entro in classe, non so esattamente cosa succederà. Diciamo che magari posso
prevederlo al massimo per il 51%. Tutto il resto dipende dalla band e da come ha voglia di partecipare alla jam
session.
Però mi piace improvvisare e seguire il tema ovunque vada.
In quel 49% (almeno) che resta, c'è tutto il bello del mio mestiere: quello che posso imparare dalla band e
quello che la band riesce a far suo e a produrre, c'è la risposta intellettuale e umana di ogni alunno, la sua
valutazione più sincera sul lavoro che si svolge in classe, la mia valutazione più oggettiva sul percorso didattico
che si snoda. Perché la scuola, per definizione, non può mai smettere di essere maieutica e non può legarsi
rigidamente ad un percorso programmato, né può esimersi dal proporre, sempre e comunque, un "sentiero
didattico" alternativo. Dico "sentiero" perché mi suggerisce un uso più libero e più gratificante dello sguardo
speculativo e, per certo, un ambiente più accogliente e meno combattivo.
L'orizzonte, inteso anche come panorama mentale, comprende il tutto possibile a partire dal punto di vista
dell'osservatore, sia esso fermo in contemplazione, sia esso in movimento alla ricerca di un riferimento.
È un'altra di quelle banalità per me preziose che ho assunto con il tempo: la vita è sempre interdisciplinare.
N. Ha undici anni, frequenta la prima media. Ha sguardo austero e dolce, parla con voce sottile ed educata ed è
poco più che uno scricciolo. Ma nei suoi occhi c'è un'energia ferma e triste, sicuramente dovuta al fatto di
essere rimasta orfana di padre troppo presto.
Mi piace leggere e commentare in classe il Cantico delle Creature perché Francesco d'Assisi vi ha racchiuso
dentro una venerazione per la natura e una gioia di vivere, che solo un amore senza condizioni può concepire.
Un allegro inno al pensiero positivo che mette l'essere umano di fronte alla responsabilità del voler essere felice
con quello che il mondo e la natura hanno da offrire. O quantomeno alla possibilità di trovare una stabile
serenità, che non è bene poco prezioso.
"Laudato sì’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po’ skappare"
È il passaggio chiave del cantico secondo me.
Difficile da affrontare al di fuori della logica figlia della devota fede che sembra pervadere il Santo.
Io, invece, vi ho sempre visto soprattutto la spensierata capacità dell'Uomo di Assisi di accettare serenamente la
vita nel suo tutto per quello che è e per come si propone. In fondo Forrest Gump ha nei confronti del vivere lo
stesso innocente e saggio candore.
"Che cosa c'è di positivo nella morte, prof?"
Avrei dovuto prevederlo, conoscendo la situazione dei miei alunni, ma, da un certo punto di vista, evitare un
percorso, per paura di inciampare in un passaggio sdrucciolevole, mi sembrerebbe più la rimozione della realtà
di una persona che una forma di rispettosa sensibilità.
La domanda di N. è una sentenza, però non è retorica. Anche se il tono è fermo, gli occhi di chi l'ha posta hanno
voglia di guardare e confrontarsi con una possibilità.
Però niente favole, prof; non in questa occasione.
Sul suo banco c'è una bottiglietta trasparente di acqua minerale. A dire il vero, da alcuni anni, sono spuntate su
tutti i banchi per un'epidemica diffusione, tale da farmi chiedere quando e come il fenomeno abbia preso il via.
Una volta tanto, quella bottiglietta non sarà lo strumento di pretesto di un alunno per interrompere la lezione
con un riempimento in bagno, ma la mia ancora di salvezza.
Laudato sì’, mi’ Signore, per sor’Acqua,
la quale è multo utile et humile et preziosa et casta
L'acqua è la chiave della vita, per come l'uomo intende la vita.
È una magia: è formata da due gas tra i più infiammabili esistenti in natura che, combinati insieme, producono
un liquido in grado di estinguere il fuoco. L'acqua ci ha permesso di respirare perché probabilmente l'ossigeno
che troviamo nell'atmosfera si è, in origine, scisso dall'idrogeno presente nell'acqua primordiale che riempiva
gli oceani. Noi stessi siamo in gran parte formati di acqua. Insomma, preziosa e fondamentale, l'acqua è
davvero sinonimo di vita. Molta ne usiamo, molta ne sprechiamo, forse non la apprezziamo abbastanza e
sicuramente non siamo tutti consapevoli di quanto lontano nel tempo ci porti: l'idrogeno è il primo elemento
che si è formato nell'universo. È una delle poche certezze che la scienza ha acquisito riguardo la nascita dello
sterminato luogo che conosciamo ancora così e così. Può essersi aggregato, fissato, trasformato in elio nel cuore
di una stella, ma non può essersi generato dal nulla in tempi recenti; perciò, quando beviamo un sorso di
idrogeno e ossigeno "mischiati", un sorso di acqua, anche di quella più fresca che possiamo trovare, noi
beviamo qualcosa di così antico che potrebbe essere nato con l'universo stesso, quasi 14 miliardi di anni fa.
L'Universo è un meccanismo che funziona così: produce, trasforma, modella, a volte in forme violente come
quando esplode una stella, ma non spreca e non butta nulla. Non si dimentica di nulla di ciò che lo compone.
L'oro, ad esempio, lo stesso con cui sono fatti gli orecchini o le catenine o i braccialetti che a volte indossiamo,
non può essersi formato sulla terra. Non c'è abbastanza energia. Quell'oro si può essere formato soltanto nel
nucleo di una stella, ma non una qualsiasi, bensì una così grande da esplodere in una supernova: una stella
gigante, nel momento in cui muore, produce oro e lo spara nel cosmo. Poi quell'oro e altri elementi e tutta la
polvere di stelle, residui dell'esplosione sospesi nell'universo, lentamente iniziano ad aggregarsi formando una
nuvola sempre più densa, al centro della quale, con un processo lento e inesorabile, si accende a causa della
compressione gravitazionale una nuova stella, come il nostro sole, e intorno a lei, magari, si formano pianeti
come quello su cui abitiamo. Dalla morte di una stella si è formata la vita che noi conosciamo, e gli elementi ad
essa necessari; anche il carbonio che è elemento fondamentale per la nostra struttura genetica. L'oro, così
prezioso sul nostro pianeta, è il ricordo della fine di una stella speciale che morendo ha dato il via all'inizio
della vita. Siamo polvere di stelle. Siamo polvere che tornerà alla terra. La morte non è il negativo della vita, è
il suo compimento. Ognuno può credere in quello che vuole, avere fede o non avere fede. Non importa. È un
fatto che siamo tutti polvere di stelle, che il nostro pianeta e il nostro sistema solare prima o poi finiranno
tornando a polverizzarsi nello spazio, e la polvere di stelle di cui siamo fatti e che per allora sarà stata parte
inscindibile della terra, tornerà nell'universo ad accendere altre e più brillanti stelle. Così qualcosa di noi, di
tutti noi, si ritroverà in un sole o in una luna e anche adesso, quando guardiamo una stella brillare o il nostro
sole, guardiamo qualcosa che è appartenuto ad un precedente ciclo di vita. È il nostro destino, essere tutti prima
o poi polvere di stelle o parte di una stella che brilla.
messor lo frate Sole,
sora Luna e le stelle,
frate Vento,
sor’Acqua,
frate Focu,
matre Terra,
sora nostra Morte corporale,
Probabilmente Francesco "sentiva" in modo istintivo tutto questo, e sapeva che la morte è un semplice e
misterioso strumento che l'universo usa per riproporre la vita. Mi piace immaginare l'Uomo di Assisi che canta
il ritornello di Istant Karma di John lennon:
" Well, we all shine on, like the moon and the stars and the sun. Yeah, we all shine on"
N. alla fine mi ha sorriso.
Qualche giorno dopo mi ha confessato che la storia della polvere di stelle le è sembrata più rassicurante di
quella delle reincarnazioni che le aveva raccontato la zia buddista.
Tra me e me ho ringraziato il mio amore per l'astronomia.
Ma soprattutto Neil deGrasse Tyson e il mio abbonamento a Sky.
LA DIDATTICA DI LEGOLAND
( la im-morale della Contro-favola)
Mirare a fare, sollecitando la curiosità e senza alcun timore reverenziale nei confronti del sapere.
Fare seriamente senza prendersi troppo sul serio.
Non è bene per un alunno investire psicologicamente troppo di sé stesso in ciò che fa. A pensarci con
attenzione, secondo me, non è bene per nessuno. Perché comporta sempre una posta in gioco troppo alta in caso
di non riuscita. Credo che lo stesso problema investa noi insegnanti: preferiamo far ascoltare un attore che legge
anziché leggere noi stessi drammatizzando, ricorriamo all'attività laboratoriale proposta dall'ente esterno
quando potremmo trasformare la classe in un laboratorio permanente. Forse perché temiamo che un eventuale
errore possa compromettere la nostra credibilità professionale di fronte ai ragazzi. Io invece trovo davvero
liberatorio rispondere ad un alunno: "questo non te lo so dire, però possiamo organizzarci e provare a scoprirlo
insieme". Anzi, succede che l'alunno in questione, tragga molta autostima dall'aver sollevato una questione
"misteriosa" che impone l'attenzione e la collaborazione di tutti: è un accadimento che definisce più attivamente
il suo ruolo nel gruppo.
In ogni errore c'è un lato buffo da sottolineare prima di iniziare il processo di attenta analisi che porta alla
correzione (Quante risate - devo esser sincero - mi sono fatto di cuore su alcuni marchiani errori di sintassi che
hanno stravolto il senso di una frase all'interno di un tema? Ed ho sempre ringraziato l'autore per il buon umore
profuso). Non è tempo perso riderci su insieme. Mica sto dicendo che bisogna prendere in giro l'alunno,
tutt'altro! Sottolineare l'esplosiva forza creativa dell'umorismo involontario lo aiuta ad imparare l'umorismo
meditato e l'autoironia. Nella classe autoironica alunni ed insegnati indossano la loro maschera trasparente
individuale che è la tuta da lavoro con cui saranno pronti a sporcarsi le mani per ottenere un buon lavoro di
squadra: fare seriamente senza prendersi troppo sul serio.
Del resto qualsiasi progetto didattico ha senso se ha un ampio margine di fallibilità, altrimenti non sposta di un
centimetro più in là l'orizzonte del sapere, né tantomeno del saper fare. Quindi è fondamentale che né
insegnanti, né alunni conoscano l'ansia dell'errore: il buon risultato è comunque motivante perché rappresenta
un passo in avanti, il risultato scadente non prevederà il dramma del fallimento.
Così succede che l'alunno che si cala a fondo e con gusto in questo ruolo di squadra, diventi più realista del re e
molto più inventivo dell'insegnante.
La prima forma di scrittura che insegno a realizzare all'inizio del triennio, come fanno molti altri colleghi, è la
favola classica. Ha canoni chiari e semplici, deve essere breve e quindi è veloce da realizzare, ha un obiettivo
ben chiaro e quindi non comporta complicazioni diegetiche né sintattiche. Insomma, costituisce un goal perfetto
per l'alumnus faber in fieri.
Per evitare ogni minima complicazione suggerisco di utilizzare un proverbio a scelta come morale della propria
favola; è anche l'occasione per riflettere sull'infallibilità cerchiobottista della saggezza popolare, visto che per
ogni proverbio dato è quasi automatico trovarne l'opposto: "chi fa da sé fa per tre" e "l'unione fa la forza"; "chi
va piano va sano e va lontano" e "chi ha tempo non aspetti tempo". È un bel momento di irriverenza per
celebrare tutti insieme il trionfo dell'attenta osservazione attiva sull'ingessata sentenziosità dei proclami
dogmatici.
La correzione delle favole scritte, in questo modo, diventa un momento di fiera enunciazione del proprio
prodotto d'autore.
Poi un alunno, forse per la consapevolezza della facilità con cui ha adempiuto l'incarico o forse proprio per un
istinto di dissacrante inventiva, propone una variazione:
"Prof, perché non scriviamo delle favole in cui la morale nasce dal mix di due proverbi diversi?"
Perché no?
La volpe e il pollaio
C’era una volta una volpe che si credeva tanto furba e che ogni notte si infilava di soppiatto nel pollaio,
rubacchiava qua e là pulcini e uova, poi scappava nel bosco dove i galli inferociti e le galline disperate ma molto
arrabbiate non l’avrebbero mai presa.
Non tutti nel pollaio erano sicuri che la ladra di uova fosse la volpe e per questo decisero di alternare i galli più
forti nei turni di guardia; la volpe per un po’ non poté avvicinarsi al pollaio, ma dopo qualche settimana i galli,
stanchi per il mancato riposo, non erano più in grado di proteggere il pollaio e la volpe poté tranquillamente
entrare e farsi una bella scorta di uova da portare nel suo rifugio.
Il mattino dopo i galli si erano ristabiliti, ma la volpe, col bottino che possedeva, ormai non aveva più bisogno di
rubare; aveva così giusto deciso di fare un picnic con una parte del bottino.
Ma mentre la volpe camminava per raggiungere la prateria, per la fame cominciò a mangiare.
Purtroppo sulla strada per la prateria incrociò il pollaio e i galli di guardia, vedendola ingozzarsi di uova, ebbero
finalmente la prova che lei fosse la ladra. La presero d’assalto, incominciarono a rincorrerla e ancora adesso
stanno scorrazzando veloci per le praterie.
La gatta frettolosa vien mangiando
Magrolino
C’era una volta in un bosco una mamma cavallo incinta; dopo pochi mesi partorì un piccolo puledro che venne
chiamato Magrolino perché era molto magro. Passarono gli anni e Magrolino era diventato bello e grande tanto
da poter cominciare ad andare da solo nella prateria vicino alla sua stalla. Un mattino Magrolino si alzò presto
per andare alla prateria. Salutò la mamma e si avviò, mentre andava, incontrò un maialino di nome Cicciottello
che passava di lì e gli chiese da che parte fosse la prateria verde; Cicciottello gli rispose che sarebbe bastato
seguire la strada dritta davanti a loro e sarebbe arrivato. Magrolino ringraziò e si avviò; ricominciando ad andare
non si accorse che Cicciottello lo stava seguendo di nascosto. Finalmente Magrolino era arrivato alla prateria e si
mise subito a mangiare l’erba appetitosa, mentre Cicciottello lo osservava da lontano pensando: ”Guarda, questo
quanto mangia, ed è magro! Io appena ingoio qualcosa ingrasso subito!”. Così ogni giorno Magrolino andava
alla prateria. Un giorno Cicciottello stanco di veder mangiare il cavallo e non vederlo ingrassare, cosparse l’erba
della prateria di una pozione ingrassante. Da quel giorno in poi Magrolino cominciò ad ingrassare, e nessuno
capiva il perché. Un giorno gli amici di Magrolino decisero di scoprire il mistero, e all’alba andarono nella
prateria con Magrolino. Scoprirono che era stato Cicciottello a fare tutto, allora si arrabbiarono molto con lui e
gli spiegarono che se voleva diventare magro poteva andare con loro a correre la mattina. Cicciottello correndo
ogni giorno dimagrì, ma non come Magrolino.
L’ erba cattiva ingrassa il cavallo.
Una vita da gatto
C'era una volta un gatto che era un po' stupido, ma allegro nonostante la sua immensa sfortuna.
Un giorno il gatto salì su una collina durante una bufera, venne colpito da un fulmine e ci rimase secco! Poco
tempo dopo salì sulla stessa collina un maiale operaio e mentre piantava un'antenna per i telefoni rimase stecchito
anche lui. Mentre stramazzava al suolo trasmise l'elettricità al gatto che si rianimò di colpo. Il gatto fu così felice
di non essere più morto che non si curò del suo avanzato stato di decomposizione e cominciò a trotterellare tutto
allegro qua è là, ma tra un saltello e l'altro perse uno zampino così dovette zoppicare per tutta la sua vita...o
morte!!!
La favola ci insegna a non saltellare qua e là mentre si è in decomposizione e che...
Gente allegra ci lascia lo zampino
Ecco servite delle contro-favole, ognuna delle quali corredata da una lisergica irriverente (im)morale.
Nasce dall'ironica intuizione di un alunno la didattica di Legoland: si smonta la forma compiuta di un
linguaggio e se ne ricompongono a piacimento i frammenti, si definiscono nuovi e dissacranti dogmi che non
affermano nulla, ma che funzionano come linee-guida e impongono un fantasioso metodo di costruzione.
Il risultato è caleidoscopico e richiede (e quindi sollecita) flessibilità concettuale e manipolazione di schemi
ossidati: quanto di meglio si possa chiedere ad uno scolaro della scuola dell'obbligo.
Il risultato stupisce, perché supera per inventiva e disincantata operatività quanto richiesto e lo stupore è un
elemento imprescindibile della vita di classe: solo un insegnante sa in che maniera è vivificante per lui essere
stupito dai giochi di prestigio degli alunni con cui lavora. Così come è energizzante per un alunno iniziare un
percorso di studio partendo da un piccolo gioco di prestigio concettuale di cui presto potrà padroneggiare il
trucco.
Il cerchio si chiude:
lo stupore genera curiosità,
la curiosità richiede pazienza per essere soddisfatta,
la pazienza conduce alla realizzazione.
METTERSI IN GIOCO
(Melodia in Bianco e Nero)
È evidente che quanto fin qui esposto, attiene strettamente ad una metodologia che dal punto di vista filosofico
si appella con forza ad una procedura intrisa di empirismo. E questo sicuramente scopre il fianco a tutte le sue
fragilità:
- Perché il margine di indeterminazione che si genera può essere così ampio da non essere controllabile o per
niente fertile;
- Perché la soluzione necessaria al progresso del percorso didattico molto spesso non è prevedibile e quindi non
anticipatamente programmabile;
- Perché la soluzione potrebbe non esserci affatto.
Tutte e tre le casistiche attengono alla quotidianità del vivere, direi.
Se la scuola deve essere palestra di vita - e sicuramente può esserlo in modo molto tutelato e protettivo - allora
tutte queste fragilità diventano i punti di forza di tale sistema procedurale. Ripropongono tutte le eventualità che
una persona può dover affrontare nel vivere e la simulazione controllata di tutte le risposte possibili a
prescindere dall'efficacia che riescano ad esprimere.
Il margine di indeterminazione dato dall'empirismo, inoltre, costituisce il territorio che conduce inevitabilmente
all'invenzione o quanto meno alla rielaborazione. Se nella scienza rappresenta l'incidente di laboratorio
imprevisto che porta alla nuova ricerca, in altri linguaggi è l'ambito privilegiato e indispensabile per la
composizione.
Nella musica jazz è in quella zona indeterminata che si sviluppa la composizione; potremmo dire che la musica
jazz altro non è che l'esplorazione di tutti gli sviluppi armonici e melodici possibili nel territorio
dell'indeterminazione compositiva: l'improvvisazione.
Se nel jazz l'improvvisazione è lo stato dell'arte della scrittura musicale, nel repertorio classico ne costituisce le
fondamenta: sappiamo per certo che sia Mozart che Beethoven eccellevano nell'improvvisare e che molto
probabilmente anche Bach ha praticato con maestria la scrittura musicale immediata (se non addirittura
estemporanea). Una verità storica è che quasi sempre un compositore inizia a comporre nel momento in cui
riesce a distaccarsi dalla sua preparazione e slitta più o meno pesantemente rispetto alle regole del codice
inseguendo un percorso alternativo.
D'altra parte - mi spiegarono bene negli anni del liceo - la palestra dello studio del greco è finalizzata proprio a
questo, ad "imparare" ad intuire. Il testo greco, per essere tradotto correttamente, chiede di essere intuito prima
ancora di essere tradotto nel vero senso della parola, e richiede spesso che sia trovata l'eccezione e il cavillo
grammaticali o sintattici che ne giustifichino la traduzione. Un processo dinamico e inventivo che sembra poco
corrispondere all'idea comune del concetto di "classico". Ed è curioso constatare, a tal proposito, che quasi tutto
ciò che viene considerato classico, e in quanto tale viene considerato modello da studiare e riprodurre, in realtà
si è palesato alla nascita con un tentativo - peraltro ben riuscito - di spostare più avanti il limite
dell'innovazione.
Questo vale per la musica, per le arti visive, per la letteratura, per la ricerca scientifica perfino.
Possiamo dire che "classico" sia sinonimo di "molto innovativo premeditato".
Ovviamente c'è una diretta proporzionalità tra preparazione e capacità compositiva o realizzativa, ma è
sbagliato pensare che la prima sia strettamente propedeutica alla seconda ed è sbagliato non valutare quanto la
seconda sia nutrimento per la prima.
Questo però è già un territorio scivoloso e specialistico che difficilmente può essere apprezzato se non nella
pratica vissuta in prima persona. E non è sufficiente - nel caso esemplificativo della musica - aver intrapreso e
portato a termine un percorso di formazione musicale standard: è necessario aver discusso a lungo con il
proprio strumento, averlo trascurato per dedicarsi ad arrangiamenti di altri strumenti, essersi misurati con la
composizione, con la scrittura di un testo da musicare e con l'esecuzione dal vivo, per rendersi conto di quanto
sia importante l'approccio estemporaneo per usarne proficuamente il linguaggio e per rendersi conto che, alla
fine, la musica stessa non è il fine del lavoro, bensì strumento (veicolo) di un'espressione.
Per questi è molti altri motivi, quindi, non è semplice, non sempre almeno, rendere queste esperienza
disponibile agli alunni di un gruppo classe.
Ma un insegnante deve mettersi in gioco in prima persona; per essere convincente e coinvolgente deve
diventare operativo nel dimostrare l'efficacia di ciò che sostiene. Perciò la cosa migliore che può fare è attingere
al proprio vissuto e ai propri interessi per realizzare una personalizzata dimostrazione della sinergia effettiva tra
realtà individuale e realtà collettiva. Che poi, in soldoni, significa portare un pezzo di vita vera a scuola.
Io, nel mio orizzonte personale, riservo alla musica uno spazio speciale ed ingombrante dato che la pratico da
ormai quarant'anni, e non riesco proprio ad evitare di riferirmi a lei come ad un modello non solo operativo, ma
anche di comportamento sociale. Perché è un territorio neutro dove tutto è possibile: intraprendere le sfide più
dure nel tentativo di primeggiare su tutti e vivere nel nome della competitività più sfrenata, rinchiudersi nel
proprio giardino dell'eden e contemplare la beatitudine di un rifugio aureo, condividere generosamente le
energie con altri per realizzare un'esecuzione e un ascolto che sia benessere comune. Credo che la maggior
parte delle persone che hanno praticato con una certa intensità la musica abbiano sperimentato tutte queste ed
altre varianti. Ed è un po' come aver interpretato o essersi adeguati a tanti ruoli sociali diversi, sperimentandone
benefici, svantaggi e frustrazioni.
A me piace pensare che la classe sia una Band.
Non la mia band: l'insegnante è solo quello che suona da più tempo, che conosce la musica degli anni sessanta e
settanta ed ha voglia di sentire dai giovani musicisti un po' di buona musica nuova mai ascoltata prima.
Così nasce Melodia in Bianco e Nero, un testo musicale elaborato dalla scomposizione di un repertorio
trasversale nei generi e nel tempo. Perché la musica è un continuo travaso di formulari ed espressioni tonali e
matematiche che non ammettono barriere e pretendono di essere reinventate continuando a somigliarsi e a
riecheggiare l'un l'altro.
I temi - da quelli di Vivaldi fino a quelli dei Queen - sono stati scomposti e ricomposti inseguendo il buon
umore, irridendo con affetto i protagonisti ed omaggiandone la grandezza, lasciando galleggiare e svolazzare le
citazioni di tutto ciò che è cantabile o suonabile: dalla filastrocca al sinfonico, dalla suoneria del cellulare al
classico del rock, una passerella caotica di tutto ciò abbiamo nelle orecchie, che appartiene alla memoria
individuale, ma che si scopre collettiva. Nasce un testo nuovo che è raccolta disordinata di testi abituali e
familiari, perché sulla tessitura musicale si scatena il potere evocativo della musica, il potere di rendere
essenziale e rassicurante lo sforzo di un ascolto e di un'esecuzione fatta tutti insieme, si scopre la capacità di
provare e suscitare la stessa emozione, la stessa risata e la stessa partecipazione personale. La musica, spogliata
dei suoi orpelli storico-accademici, si mostra nuda e popolare, linguaggio dinamico da maneggiare con
destrezza, ma senza paura, fatta di tanti mattoncini di lego pronti a raccontare le nostre espressioni emotive.
In Melodia in Bianco e Nero, alunni e non, possono riconoscere l'impegno del fare senza paura di sbagliare, la
voglia di prendere in giro sé stessi mentre si è indaffarati a districare una complessa partitura-mosaico buffa e
seducente che racconta e rende fruibile in modo confuso, ma coinvolgente, la storia della musica e le emozioni
che racconta.
SVELARE I TRUCCHI
L'esecuzione delle musiche eseguite all'interno di Melodia in Bianco e Nero utilizza dei meccanismi precisi per
suscitare il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore:
- la dissacrazione dei protagonisti:
da subito i musicisti si rivelano un po' cialtroni, un po' imbranati, un po' bambinoni. Nessun timore
reverenziale, quindi, perché sul palco sostanzialmente si gioca. Perfino la comparsa del direttore d'orchestra non
fa che diminuire la credibilità degli esecutori.
- il contrasto ritmico:
l'alternanza repentina dei tempi e dei ritmi impedisce l'assopimento dell'ascolto che è quindi sempre
favorevolmente predisposto alla variazione. L'inversione e lo scambio dei tempi tra temi resi attigui, genera
l'apprezzamento di una divertita e divertente giocolerìa che assimila famiglie di frasi musicali apparentemente
eterogenee; un effetto analogo si ottiene talvolta anche rendendo fluidi temi con ritmi e tempi dissimili
attraverso il dimezzamento della velocità di esecuzione, come avviene per il passaggio "morphing" da Take five
a Popeye.
- le variazioni su tema:
avvengono per "sconvolgimento" geo-storico e garantiscono sempre l'efficacia espressiva del tema. Il
maltrattamento dell'Inno alla gioia in otto lingue e in otto generi musicali diversi, da un lato chiarisce la
cristallina trasparenza delle definizioni etniche di un luogo attraverso l'identità musicale, dall'altro garantisce
l'inattaccabile tenacia di un tema musicale che spicca per semplicità armonica e grandiosità espressiva. Uno dei
monumenti incrollabile della musica di tutti i tempi, svela la sua natura: un canto melodico e lineare adagiato su
una struttura armonica semplice e ordinata. L'elegante potere della semplicità: il coro dell'Inno alla gioia
funziona esattamente come Imagine di John Lennon.
- la frammentazione:
le cesure tra i brani avvengono molto spesso in maniera irregolare, spezzando le misure in microunità di
difficile esecuzione che non vengono percepite come virtuosismi, bensì come agguati sonori. I brani prendono
alle spalle l'ascoltatore che è piacevolmente coinvolto dalla comparsa improvvisa di un brano ben noto in veste
bizzarra: l'esecuzione dei brani proposti alla "lavagna" ne è l'esempio più convulso.
- le citazioni:
I richiami ad altre forme espressive (il cinema, il teatro, la pittura, i fumetti) incoraggiano sistematicamente la
suggestione; l'esile trama dello spettacolo - citazione essa stessa dell'ingenua comicità del cinema muto procede con un continuo manifestarsi sul palco di personaggi e "contenuti" richiamati dal brano eseguito. La
realtà del concerto raccontato si confonde con le intrusioni surreali delle "epifanie" sceniche cancellandone il
confine: la musica rende tutto possibile!
- i dispetti musicali:
le conflittualità trai brani, apparentemente clownistiche, nascondono, in realtà, un efficace processo dialettico
votato non solo al divertissement, ma anche alla "consacrazione" dei topoi compositivi: il mix intrecciato quasi
spontaneo tra l'aria "la donna è mobile" e il "libiamo ne' lieti calici" ci racconta una breve e ridicola lotta per la
conquista del proscenio tra un tronfio tenore e un soprano alticcio, e nel contempo ci suggerisce molto
chiaramente alcuni punti fermi dei procedimenti compositivi del loro autore. Esiste poi un gioco dispettoso più
mirata all'individuazione degli schemi armonici ricorrenti e delle metriche melodiche multiformi: la
sovrapposizione dei brani e l'interscambiabilità dei testi, come avviene per due brani popolari dalla genesi
completamente distinta, ossia "Oh when the Saints go marchin'in" e "Quel mazzolin di fiori", che sono
perfettamente sovrapponibili, previo adeguato adattamento ritmico, tanto da formare una composizione a
canone incerto, e "disponibili" a scambiarsi il testo. È forse il meccanismo che meglio degli altri dimostra come
lo smontaggio libero e il ricomponimento fantasioso di parti eterogenee o opposte, produce un risultato
completamente diverso rispetto al punto di partenza.
- Le caricature:
riguardano, innanzi tutto, la gestualità, i tic, i luoghi comuni, le fisime degli interpreti della musica; ma sono da
intendersi, in seconda battuta, come l'esasperazione del mondo dei suoni e dei rumori da inglobare
scherzosamente nel mondo della musica compita: l'esecuzione di un brano al contrario, l'esecuzione di un brano
a velocità doppia con intonazione alzata come se fosse un nastro registrato ed alterato, l'esecuzione di brani a
singhiozzo come fossero riprodotti da un vecchio giradischi difettoso, l'imitazione di rumori inaspettati
attraverso l'uso degli strumenti.
In fin dei conti, fintanto che alla base riconosciamo una pulsazione su cui sincronizzare il nostro corpo e le
nostre emozioni, tutto è musica.