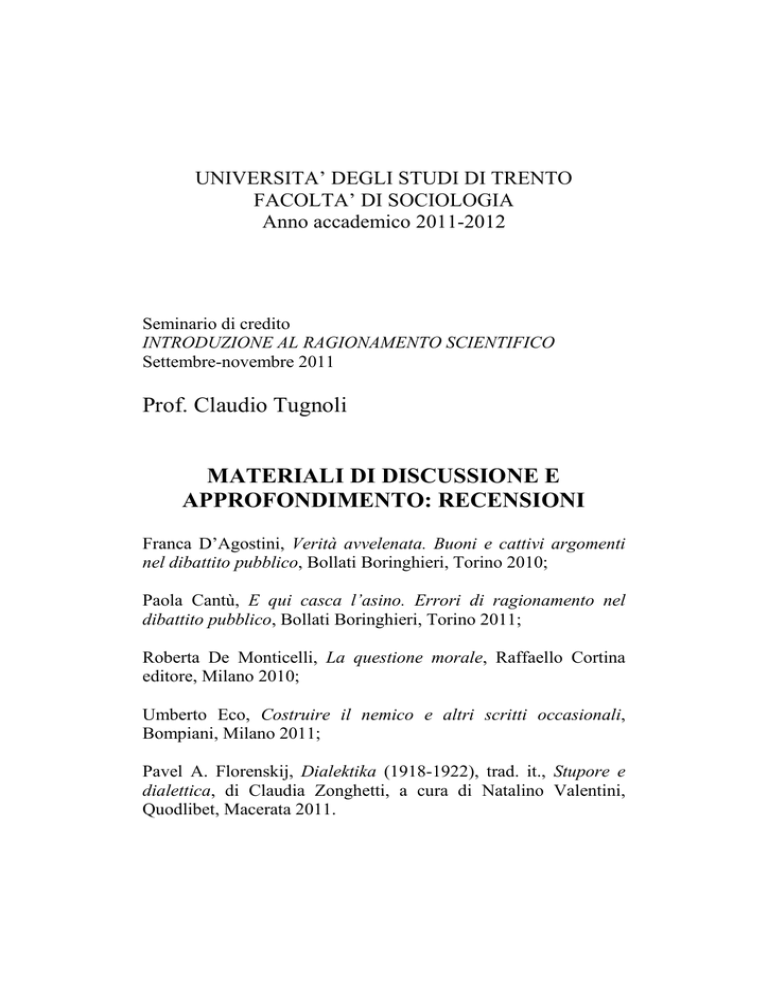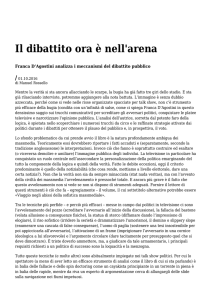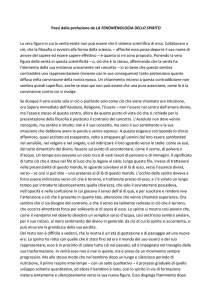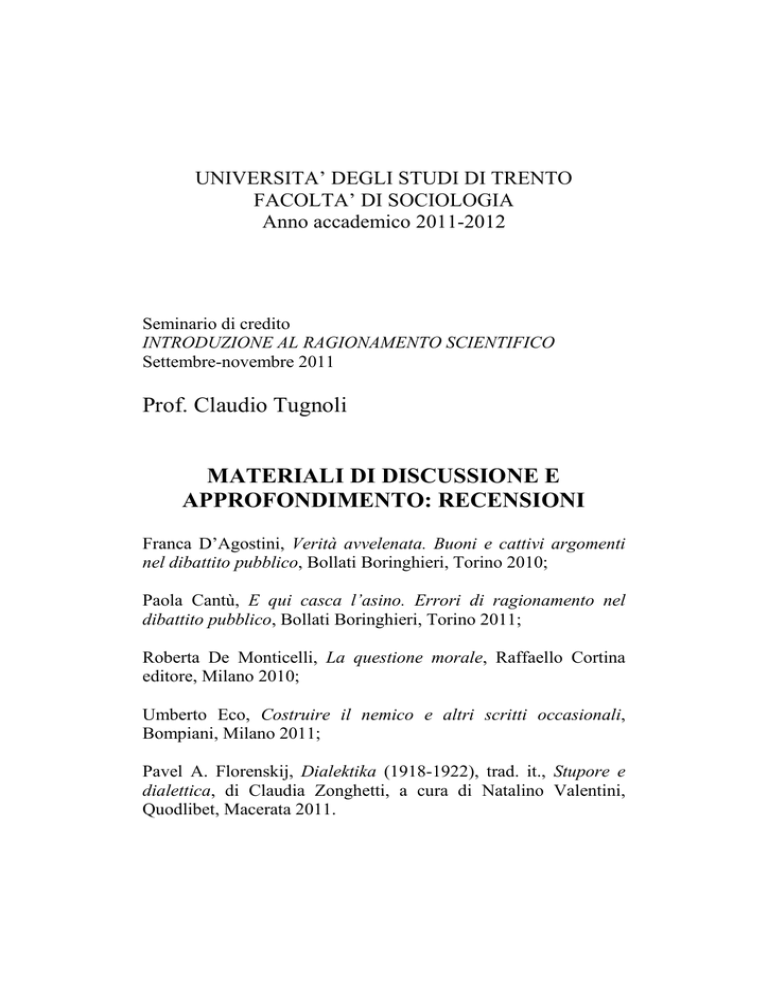
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA
Anno accademico 2011-2012
Seminario di credito
INTRODUZIONE AL RAGIONAMENTO SCIENTIFICO
Settembre-novembre 2011
Prof. Claudio Tugnoli
MATERIALI DI DISCUSSIONE E
APPROFONDIMENTO: RECENSIONI
Franca D’Agostini, Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti
nel dibattito pubblico, Bollati Boringhieri, Torino 2010;
Paola Cantù, E qui casca l’asino. Errori di ragionamento nel
dibattito pubblico, Bollati Boringhieri, Torino 2011;
Roberta De Monticelli, La questione morale, Raffaello Cortina
editore, Milano 2010;
Umberto Eco, Costruire il nemico e altri scritti occasionali,
Bompiani, Milano 2011;
Pavel A. Florenskij, Dialektika (1918-1922), trad. it., Stupore e
dialettica, di Claudia Zonghetti, a cura di Natalino Valentini,
Quodlibet, Macerata 2011.
Franca D’Agostini, Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti
nel dibattito pubblico, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 258.
In qualsiasi dibattito si trovano a confronto sostenitori di tesi
opposte o solo parzialmente diverse. Chiunque sostenga una
determinata tesi ha il dovere (morale) di fornire una
giustificazione (logica) della tesi che difende. Non si presenta una
certa tesi per gioco o per provocazione: la si presenta per
combattere un’opinione ritenuta falsa e dannosa, per quanto
accreditata, oppure per dare un contributo all’affermarsi di una
posizione teorica che si ritiene meritevole di essere conosciuta e
condivisa da tutti coloro che amano la verità. Chi avanza una tesi
comunica insieme la sua convinzione che la sua tesi sia vera. La
percezione della verità di una tesi e la disponibilità di mezzi per
dimostrare pubblicamente tale verità, non necessariamente
coincidono. Ma il pensiero non può esimersi dalla comunicazione,
che a sua volta ha come obiettivo quello di rendere pubblica una
verità privata. Una verità privata è sterile e monca, dal momento
che le manca il riconoscimento della sua universalità e oggettività
da parte di un’ampia classe di soggetti. Ed essendo questi soggetti
razionali, la comunicazione con cui si aspira a promuovere il
riconoscimento e l’assenso a una certa proposizione che il
sostenitore ritiene vera, dovrà avvalersi di mezzi razionali, ossia
produrre argomenti validi e quindi soddisfacenti. Il ragionamento
prodotto a sostegno di una certa tesi si compone di proposizioni di
cui alcune sono premesse e una, la conclusione, deve derivare
dalle premesse con necessità, se l’argomento è deduttivo, o con
probabilità, se l’argomento è induttivo. Un dibattito è razionale
quando le persone tra le quali si svolge rispettano alcune regole,
tra cui una è fondamentale: essi si impegnano a contribuire
affinché il dibattito si svolga al solo scopo di verificare la verità di
una certa tesi (e la falsità della tesi opposta) e non degeneri in uno
scontro tra contendenti condotto con armi improprie, al solo scopo
di distruggere l’avversario e affermare la propria superiorità
(intellettuale, morale o, in casi estremi, anche fisica). La
conoscenza delle tecniche argomentative non è distribuita
equamente tra le persone che partecipano a un dibattito, ma
proprio per questo il rispetto di regole fondamentali dovrebbe
impedire che la verità finisca sepolta dalle bordate retoriche del
partecipante più abile.
L’analisi delle condizioni alle quali dovrebbe svolgersi un
dibattito si avvale della logica e della teoria dell’argomentazione.
Le differenze tra la prima e la seconda (rispettivamente:
monologica/dialogica, esplicito/implicito) non implicano che
debba esserci antagonismo, quasi che la logica si occupi della
verità, mentre la teoria dell’argomentazione affronta le condizioni
di persuasività della comunicazione. Secondo D’Agostini la teoria
dell’argomentazione allarga e completa il campo della logica, dal
momento che la validità formale è un requisito necessario, ma non
sufficiente di una buona argomentazione. Oltre alla verità di
premesse e conclusione e alla validità della connessione o
derivazione della conclusione dalle premesse – che insieme ci
danno la correttezza di un argomento – un argomento ha bisogno
della persuasività (pp. 35-36). Che la relazione tra logica e teoria
dell’argomentazione non sia sempre pacifica si deve alla loro
frequente dissociazione pragmatica: un argomento può essere
perfettamente corretto, ma non persuasivo; e viceversa può essere
estremamente efficace nel convincere l’uditorio, ma soffrire di
una totale scorrettezza (premesse false, irrilevanza delle premesse
rispetto alla conclusione). Le cose si complicano quando vediamo
all’opera le fallacie, che assumono una surrettizia funzione
retorica, spesso efficacemente persuasiva. Per quanto scorrette sul
piano logico, le fallacie reclamano una valenza che ne fa
necessariamente oggetto della teoria dell’argomentazione. L’etica
della verità esige che le fallacie siano studiate dalla logica, per
difenderci dall’imbroglio in cui mira a irretirci un interlocutore
spregiudicato. Ma un dibattito ideale in cui le fallacie fossero del
tutto assenti e trionfasse in modo assoluto la correttezza degli
argomenti,
segnerebbe
anche
la
fine
della
teoria
dell’argomentazione, che continuerebbe a sussistere come sezione
della logica e non come disciplina a se stante, con un oggetto
proprio. Di conseguenza l’accordo tra logica e teoria
dell’argomentazione non è così scontato come sostiene Franca
D’Agostini. Il punto fondamentale è la natura delle fallacie
rispetto alla procedura argomentativa: concepirle come malattie
dell’argomentazione significa fare terra bruciata sotto i piedi della
teoria dell’argomentazione; e viceversa includerle tout court tra gli
oggetti di studio specifici della teoria dell’argomentazione implica
la loro legittimazione retorica. E se le fallacie sono trattate come
espedienti retorici, la logica è esautorata dal controllo della loro
validità. Ma se le fallacie sono sottratte alla competenza della
logica, allora la logica stessa viene messa da parte, giacché perde
di significato qualsiasi pretesa di controllo della correttezza (verità
e validità) degli argomenti. Le figure retoriche sono per la
maggior parte fallacie di vario genere, o strategie che per qualche
aspetto rappresentano una violazione di qualche principio o
precauzione della logica. Appare dunque affetta da irenismo
ecumenico la tesi di Franca D’Agostini, secondo cui un buon
argomento soddisfa i criteri e della logica e della retorica.
L’intersezione di logica e retorica potrebbe essere vuota! L’autrice
dà per scontato che un buon argomento possa essere oggetto di
studio della filosofia (in rapporto alla verità), della logica (in
rapporto alla validità) e della retorica (in rapporto alla
persuasività). Ma la nozione di verità è intesa diversamente nei
diversi contesti e per lo più la validità prettamente formale degli
argomenti non è percepita e diventa spesso irrilevante, quando
l’argomentazione adotta un’efficace strategia persuasiva – un
contesto nel quale le fallacie prendono il sopravvento in quanto
funzionali all’effetto di persuasione che deve prodursi. L’ideale
convergenza di filosofia, logica e retorica che D’Agostini vede
quale condizione di un buon argomento, urta con la realtà del
processo comunicativo e la pragmatica della comunicazione. Il
dissidio mi sembra insanabile, così che un certo tasso di
scorrettezza degli argomenti si deve dare per scontato. Direi
perciò che, invece di buoni o cattivi argomenti, si dovrebbe
parlare di diversi gradi intermedi tra due estremi, la logica e la
retorica. Un argomento logicamente corretto rischia di non
risultare persuasivo, al contrario un argomento estremamente
persuasivo è quasi certamente privo di qualche requisito formale.
Il rapporto tra logica e retorica è sempre un qualche
compromesso, con cui l’una e l’altra riescono a giustificare la
relativa competenza e ragione di esistere. Compromesso a metà
strada tra la sterile contemplazione solipsistica della verità senza
comunicazione e il trionfo di una comunicazione efficace senza
verità.
Per individuare e analizzare gli argomenti in un discorso o in
un testo scritto si dovrà identificare la conclusione o tesi da
dimostrare, distinguendola dalle premesse, esplicite o implicite.
La maggior parte degli argomenti del linguaggio comune
presentano premesse o conclusione implicite, che è possibile
esplicitare con l’analisi ricostruendo la forma normale del
ragionamento. Ad esempio la frase “uno di noi due deve lavare i
piatti e non sarò io”, si può facilmente ricondurre a un sillogismo
disgiuntivo, del quale la frase precedente è espressione contratta:
• Uno di noi due laverà i piatti
• Io non laverò i piatti
• Tu laverai i piatti
Tra gli argomenti totalmente impliciti Franca D’Agostini include
quelli esecutivi o ad lapidem. Esempi: Diogene di Sinope, per
confutare la definizione dell’uomo data da Platone come “bipede
implume”, portò in Accademia un pollo spennato; Antistene per
confutare Zenone che negava il movimento, si alzò e si mise a
camminare; un tizio chiese a un saggio taoista: Che cos’è la realtà
e il saggio gli rispose sferrandogli un pugno. Il pollo spennato, la
passeggiata di Antistene, il pugno del saggio taoista non sono
argomenti, ma ne fanno le veci. Svolgono la stessa funzione di
argomenti veri e propri, scrive D’Agostini, e possono essere
esplicitati ricostruendo le componenti proposizionali e i passaggi
dalla premessa alla conclusione. Ogni buon manuale di logica
codifica le principali regole di validità degli argomenti. La
nozione di verità è più sfuggente. Per sostenere la verità di una
proposizione che riassuma in sé una tesi qualsiasi, devo
individuare le premesse da cui essa discende, ma non posso
applicare questo metodo indefinitamente per verificare anche la
verità delle premesse, e poi delle loro premesse e così via. Quindi
la verità di una conclusione non è sperimentata direttamente:
l’argomento è valido quando essa discende dalle premesse, la cui
verità è condivisa dal mio interlocutore. La stessa conclusione può
discendere da premesse del tutto diverse e il mio interlocutore
potrebbe accogliere come vere le une ma non le altre.
La procedura argomentativa si rivela così essenzialmente
uno stratagemma retorico al quale si affida il compito di stabilire,
comunicare e convincere riguardo una verità che non può essere
colta direttamente in se stessa (se lo fosse, qualsiasi argomento
sarebbe superfluo). L’argomento rende plausibile una certa
proposizione che ne è la conclusione, ma di per sé non attesta la
verità della conclusione. La conclusione si fida di premesse con
cui ha un legame naturale, per così dire, nel senso che ne discende
senza sforzo, ma a loro volta quelle premesse dovrebbero essere
giustificate, e via dicendo. La prova ultima non giunge mai. Si
creano accordi su come stanno le cose nei vari settori della realtà,
si costruisce il consenso e si smantella, a seconda del punto di
vista. E tuttavia l’aspirazione alla verità è il movente
dell’argomentazione. Non bisogna confondere la forma
dell’argomento con il contenuto di cui è veicolo. La necessità di
dimostrare e comunicare la verità di una proposizione impone il
ricorso ad argomenti, la cui validità lascia tuttavia impregiudicata
l’impossibilità di una prova diretta della verità, tale da rendere del
tutto superfluo qualsiasi argomento. Naturalmente le proposizioni
non sono tutte vere o tutte false; alcune sono dubbie; per
sciogliere i dubbi è necessario ricorrere a qualche argomento. Chi
argomenta deve dimostrare di rispettare i criteri di verità, ma
questo non garantisce che la ricerca della verità sia il suo unico
movente.
Questo non significa che la verità sia introvabile e che ogni
tesi possa trovare una giustificazione plausibile, purché siano
individuati gli argomenti giusti. Lo scetticismo circa la verità è
metodologico, non tematico; riguarda la possibilità di un controllo
esaustivo e definitivo del contenuto di verità, non l’esistenza di
tale contenuto. Che la verità sia una nozione assoluta e fuori
discussione è dimostrato dal fatto che la sua negazione ne
rappresenta la conferma, come dimostrano gli esempi di
autocontraddizione illustrati da D’Agostini (p. 81). Proposizioni
come “la verità non esiste”, “nessun enunciato è vero” e simili,
non solo sono autocontraddittorie e quindi non vanno inserite in
un argomento, ma dimostrano anche l’impossibilità di negare la
verità. La nozione di vero è una condizione trascendentale dello
stesso linguaggio. Se anche non ci fosse nulla di vero, se fosse
tutto falso, sarebbe pur vero che nulla è vero. Perciò il falso non è
opposto e simmetrico al vero. La complementarità di vero e falso
è solo apparente, giacché anche per il falso vanno accertate le
condizioni di verità. Una proposizione vera nega la sua negazione,
nega la corrispondente proposizione falsa. “Cesare varcò il
Rubicone” implica una credenza relativa all’attraversamento del
Rubicone e la negazione della proposizione negativa “Cesare non
varcò il Rubicone”. Così si può dire che qualsiasi proposizione
vera attesta la propria verità e la falsità della proposizione
contraria. La nozione di verità come condizione trascendentale
rinvia alla nozione di vero come regola di corrispondenza con la
realtà stessa: deve esserci uno stato di cose, tale per cui una
proposizione è vera anziché falsa. Qualsiasi criterio che prescinde
dal riferimento alla realtà quale metodo per stabilire il grado di
verità di una proposizione deve fare i conti con la necessità di
includere infine richiami espliciti a esperienze che possano
convalidare l’enunciato prodotto.
Nonostante possano esserci scarse ragioni in difesa della
interpretazione realista della verità, D’Agostini richiama
l’attenzione del lettore sul fatto che sono numerosi gli enunciati di
cui sappiamo con certezza che sono veri. Ci sono enunciati la cui
verità è contingente (“piove”, “la porta è aperta”, e simili) e sono
anche incompleti dato che manca l’indicazione del luogo e della
data. Vi sono poi enunciati che sono veri (“le mucche sono
ruminanti”) o falsi (“Cavour fu primo ministro di Luigi XIV”)
indipendentemente dal contesto spazio-temporale. Vi sono anche
enunciati logicamente veri o tautologie (“piove o non piove”) o
logicamente falsi o contraddizioni (“piove e non piove”).
D’Agostini richiama infine l’attenzione su enunciati che è difficile
classificare in base alle categorie precedenti (“Chi ha tempo non
aspetti tempo”, “i neri hanno il senso del ritmo”, “a ciascuno va
dato secondo il merito” e simili), la cui caratteristica più evidente
sarebbe il fatto che sono discutibili. La verità di questi enunciati
va quindi stabilita tramite la discussione, è di natura controversiale
(p. 87).
Quando prendiamo posizione in una controversia possiamo
distinguere tra la realtà delle cose che percepiamo e la realtà che ci
è riferita da altri o dal consenso di massa. La seconda è la realtà di
cui ci fidiamo al punto che essa può influire sulla prima realtà,
quella percepita direttamente e personalmente, fino al punto da
cancellarla (p. 89). D’Agostini porta come esempio il romanzo di
Ethel Lina White, The Wheel Spins, del 1934, da cui Hitchcock
trasse il film The Lady Vanishes (1936), di cui Anthony Page nel
1979 fece un remake con lo stesso titolo. La storia in breve: una
donna incontra un’anziana signora su un treno. Si parlano,
prendono un tè insieme nella carrozza ristorante, poi ritornano nel
loro scompartimento e la donna si addormenta. Al risveglio la
signora è scomparsa. Dopo qualche tempo, la donna chiede ai
passeggeri se sanno dove sia la vecchia signora, ma tutti negano
concordemente che ci sia mai stata un’anziana signora. La donna
dubiterà di essersi sbagliata? (pp. 88-89). La verità pubblica è
quella cui diamo credito prestando il nostro consenso all’esistenza
di una realtà, quale è quella che ci viene riferita, la quale potrebbe
essere in contrasto con la realtà direttamente percepita. Il numero
di persone che sostengono la verità di una proposizione determina
un conflitto cognitivo con l’individuo che è intimamente convinto,
per esperienza diretta, che le cose stanno diversamente; il conflitto
viene risolto per lo più aderendo alla communis opinio.
D’Agostini prende in considerazione la forza degli
argomenti, riconducibile alla forza degli enunciati. In un
argomento deduttivo o le premesse sono sufficienti rispetto alla
conclusione che ne deriva, oppure non lo sono. In un argomento
induttivo invece si presenta un grado di maggiore o minore
probabilità della conclusione rispetto a determinate premesse; e
quindi l’aggiunta di nuove premesse può modificare la
conclusione. La forza di un enunciato è data dal suo contenuto
informativo, sia esso vero o presunto. Più un enunciato è preciso
nei dettagli, maggiore è il suo potere informativo e maggiore sarà
la sua forza, anche se è falso. Viceversa un enunciato può essere
vero, ma generico e quindi debole.
«La forza di un ragionamento o di un argomento, spiega
D’Agostini, si stabilisce valutando la relazione tra la forza degli
enunciati-premesse e la forza dell’enunciato-conclusione. Vale
cioè la seguente regola generale di massima: un ragionamento
induttivo è tanto più forte quanto più ha premesse forti o
conclusioni deboli. Per esempio:
Il 90% delle famiglie italiane ha la televisione
I Rossi sono una famiglia italiana
Dunque è probabile che i Rossi abbiano la televisione
è un ragionamento induttivamente valido e molto forte» (p. 96).
La formula attenuante “è probabile che” rende forte l’argomento.
La
rilevanza
è
fondamentale
nella
teoria
dell’argomentazione, ma non nella logica verofunzionale. La
prova di rilevanza funziona così: «Di fronte a un argomento “p, q,
dunque r” per stabilire la rilevanza mi chiedo: posso credere che p
e q siano vere, senza credere che r lo sia? Se posso farlo, le
premesse non sono rilevanti» (p. 98). La domanda è facile in
apparenza, se è vero che in molti casi, come dimostrano le fallacie
e la difficoltà di percepirle, la risposta non è facile. Infine la regola
della fecondità impone che la conclusione di un argomento non sia
la mera ripetizione delle premesse in altra forma o con le stesse
parole. La conclusione di un argomento dovrebbe produrre
qualche nuova informazione rispetto alle premesse. La regola
della fecondità vale per la teoria dell’argomentazione, ma non per
la logica, che si limita a stabilire la coerenza formale e la
deducibilità della conclusione dalle premesse.
D’Agostini contesta la linea di pensiero che vede nelle
nuove forme di comunicazione di massa un contesto inedito nel
quale il ruolo dell’argomentazione (determinazione di verità e
validità) è stato affossato, reso obsoleto da pratiche comunicative
che sono giustificate esclusivamente dal successo comunicativo,
che a sua volta è assicurato da fattori irrazionali ed emotivi
sostanzialmente imprevedibili. L’autrice sostiene che ancora oggi,
nonostante il moltiplicarsi delle modalità di comunicazione e di
scambio dell’informazione, valgono gli stessi criteri di ieri e lo
stesso metodo di valutazione di determinate tesi. Il meccanismo
della comunicazione pubblica nasconde molte insidie, ma le
strategie di pianificazione dell’inganno e la metodologia di
individuazione delle fallacie argomentative sono rimaste le stesse.
Si deve riconoscere che oggi l’informatizzazione mette a
disposizione degli individui una quantità impressionante di
elementi utili per capire e valutare l’attendibilità di un argomento.
La riflessione dell’autrice è ottimista: «Il nuovo cittadino che
emerge dal nuovo sistema comunicativo è dotato di strumenti di
valutazione per lo meno pari a quelli dei sistematici manipolatori,
e non è escluso che possa fronteggiare abbastanza bene il sistema
generale della manipolazione» (p. 106).
D’Agostini classifica le fallacie in base ai requisiti di un
buon argomento che sono: la validità formale, la forza o validità
induttiva, la verità delle premesse, la rilevanza delle premesse per
la conclusione, la fecondità della conclusione. Ciascuno di questi
requisiti può essere soddisfatto solo in apparenza e quindi si
avranno cinque famiglie di fallacie: formali, induttive, di falsa
premessa, di rilevanza, di circolarità. A queste si aggiungono le
due famiglie di fallacie, trasversali, classificate come pragmatiche
ed ermeneutiche. Sono preziose le osservazioni preliminari
dell’autrice, laddove segnala due difficoltà. La prima consiste nel
fatto che a volte la distinzione tra un argomento buono e uno
cattivo dipende dal contesto o dall’intonazione, senza contare che
spesso il migliore argomento può essere riformulato in modo da
farlo risultare fallace, circostanza ben nota agli antichi sofisti.
Tutto questo non autorizza però a dichiarare falsi tutti i discorsi.
La dialettica filosofica esiste per risolvere la difficoltà e
compensare la fragilità della verità. La seconda difficoltà consiste
nel fatto che le fallacie di rado si presentano in modo puro; nella
pratica dell’argomentazione si trovano per lo più combinazioni di
più fallacie. Aggiungerei che molti argomenti ingannevoli
possono prestarsi a diverse interpretazioni, non sempre
convergenti. Le due difficoltà rilevate da D’Agostini spiegano
forse perché il nostro codice prevede il carcere per chi commette
un’azione fallace, ma non per chi fa un discorso fallace. La
violazione delle regole del discorso non comporta alcuna
riprovazione, ma solo un’ovazione quando segna una vittoria
sull’avversario?
Vediamo dunque sinteticamente il quadro generale delle fallacie
proposto e illustrato da Franca D’Agostini:
Fallacie di rilevanza
ad hominem
tu quoque (variante dell’ad hominem) (Berlusconi dice: “Prodi si è
salvato grazie all’amnistia e alla modifica dell’abuso d’ufficio.
Quelle sì che furono leggi ad personam!”)
all’interesse (variante dell’ad hominem (esempio: “Berlusconi è
proprietario di televisioni, dunque quel che dice in materia di
legislazione televisiva è falso”)
per associazione (esempio: “Smith sostiene l’antiproibizionismo,
ma Smith è amico di criminali e barboni”: si nega quel che
sostiene X servendosi di argomenti ad hominem non contro X ma
contro qualcun altro che sostiene la stessa cosa)
ad personam e avvelenamento del pozzo; si distingue tra l’ad
hominem circostanziale e l’ad hominem generalizzato, detto a
volte ad personam, perché consiste in un attacco preventivo,
esaustivo e definitivo per delegittimare qualcuno in misura tale
che nessuno gli dia più il minimo credito da quel momento in poi.
Si può aggiungere che in un pubblico dibattito il discredito
prodotto dall’avvelenamento del pozzo si ritorce anche su chi vi
ha fatto ricorso, proprio in virtù del carattere grossolanamente
scoperto della fallacia dell’ad personam
ad verecundiam o ad auctoritatem; fallacia di non facile
individuazione, consiste nell’appellarsi alla coerenza tra la propria
affermazione e le dichiarazioni di qualche fonte potente o
influente, la cui autorità viene fatta passare come incontestabile
(papa, presidente della repubblica, scienziato, ecc.). La decisione
se si tratti di una fallacia o meno dipende dal grado di attendibilità
e competenza della fonte rispetto all’argomento in discussione. Si
tratta di una fallacia di varia interpretazione.
Strategie diversive
Non sequitur (“Non bisogna criticare la qualità scadente dei
programmi televisivi perché la televisione dà lavoro a molte
persone”)
Falsa pista (“X dice: questa guerra è ingiusta; Y ribatte: Ma i
nemici hanno ucciso molti dei nostri”)
Distrazioni (tutti i discorsi evidentemente pronunciati al solo
scopo di sviare l’attenzione dal tema in discussione)
Ignoratio elenchi (letteralmente: ignoranza della confutazione; è
la diversione in funzione di confutazione, con cui si sposta
l’attenzione dal centro del discorso, per smentire la tesi di un
avversario. Esempio: “X: Berlusconi ha invitato a cena
ripetutamente Tarantini, già noto per i suoi affari poco puliti: è
difficile pensare che non sapesse chi era. Y: Ma anche D’Alema
ha cenato con Tarantini”
Ad ignorantiam: fa appello all’ignoranza della tesi contraria per
dimostrare la tesi propriamente difesa. “Non conosco il mio
vicino, quindi non so se è una brava persona, dunque non è una
brava persona”. Molte varianti dell’ad ignorantiam sono simili
all’insinuazione. Puntuale l’osservazione di D’Agostini: «La
fallacia ad ignorantiam è così diffusa perché alle sue basi c’è una
combinazione di due impostazioni caratteristiche del pensiero
razionale: l’epistemicismo, ossia la tesi (ragionevole) secondo cui
posso dire che una proposizione è vera se e solo se è giustificata, e
il realismo, ossia la tesi (altrettanto ragionevole) secondo cui una
proposizione che non è vera è falsa, ossia: è vera la sua negazione.
Combinando le due tesi, abbiamo che se non ho giustificati motivi
per sostenere che p, allora p non è vero (per l’equivalenza di vero
e giustificato); ma se p non è vero, allora è falso (per
l’equivalenza di non vero e falso). Dunque: se non ho giustificati
motivi per sostenere che p, posso sostenere che non-p. E
naturalmente lo stesso vale anche per non-p» (pp. 120-121). Il
dogmatismo ad ignorantiam si presenta quando l’argomento ha
bisogno di essere delucidato da premesse aggiuntive, come
nell’esempio della stessa D’Agostini: «Non abbiamo prove del
fatto che un organismo della specie umana al quattordicesimo
giorno del suo sviluppo non abbia una coscienza; dunque non si
può interrompere lo sviluppo di un protoembrione umano per
prelevare cellule staminali» e in quello opposto e simmetrico:
«Non c’è alcuna prova del fatto che un organismo della specie
umana al quattordicesimo giorno del suo sviluppo abbia una
coscienza; dunque un protoembrione umano al quattordicesimo
giorno non è considerabile come un essere umano» (p. 121)
Alle emozioni, di cui sono varianti: ad baculum, ad populum, ad
misericordiam, ad metum (“Se non paghi il pizzo, non ti assicuro
che il tuo negozio non sia dato alle fiamme”; “tutti mi amano,
dunque io sono amabile”; “Ho famiglia da mantenere, non può
licenziarmi”; “Se la sinistra andasse al governo, il risultato
sarebbe questo: miseria, terrore, morte”)
Circolarità
Negli argomenti circolari si dà per presupposto ciò che si deve
dimostrare
Petitio principii (“Dio ha creato il mondo, dunque Dio esiste”;
circolarità procedurale: D’Agostini classifica come fallacie di
presupposizione le estrapolazioni dal contesto, che il Copi include
tra le fallacie di accento. L’autrice riproduce lo stesso esempio
dell’Introduzione alla logica di Copi-Cohen (Il Mulino, Bologna
1999), che riferisce l’estrapolazione di un discorso di Al Gore, da
cui si evinceva, falsamente, che Al Gore negasse l’esistenza di un
legame tra fumo e cancro ai polmoni, mentre nel discorso intero
Al Gore sosteneva esattamente il contrario (p. 125-126);
tra le fallacie di presupposizione si colloca la domanda multipla o
plurium interrogationum (“Perché lo sviluppo privato delle risorse
è tanto più efficiente dell’iniziativa pubblica?”);
la fallacia dell’uomo di paglia: si costruisce una tesi facile da
confutare e la si attribuisce all’interlocutore (esempio: “X sostiene
che la pena di morte è ingiusta; il suo oppositore dice che X
sostiene che non bisogna punire gli assassini, oppure che X
sostiene che tutti gli uomini sono buoni”)
Non-verità
Le premesse di un ragionamento o argomento possono essere
false; come è noto in tal caso l’argomento potrebbe essere valido,
ma non sarebbe corretto o fondato. Le fallacie che nascondono la
non-verità delle premesse possono essere verbali o concettuali, a
seconda che dipendano dall’uso delle parole o da errori riguardo le
qualità attribuite a un oggetto
Fallacie verbali:
di ambiguità o equivocità (esempio aristotelico dalle Confutazioni
sofistiche: “il male deve esistere, ciò che deve esistere è bene,
dunque il male è bene”. “Dovere” ha qui due significati diversi:
essere inevitabile e essere giusto. Altro esempio: “Combattere
sulle parole è insensato, la discriminazione è una parola, dunque è
insensato combattere sulla discriminazione”) (p. 129). L’esempio
aristotelico illustra egregiamente anche la quaternio terminorum
del sillogismo. Le fallacie verbali che nascondono la non-verità
con ambiguità sintattiche sono dette anche anfibolie (“Tutti i
ragazzi amano qualche ragazza”; “l’invidia dei vicini”; “ero
sbalordito nel vedere come picchiavano quei ragazzi”, dove
ragazzi può essere soggetto o complemento oggetto). Le fallacie
di accento consistono nelle diverse interpretazioni alle quali si
presta la stessa frase, se pronunciata ponendo l’enfasi su termini di
volta in volta diversi. L’equivocazione di accento sfruttata per fini
particolari dà luogo alla fallacia.
Fallacie concettuali:
Le fallacie concettuali si basano su equivocazioni delle relazioni
tra un oggetto e le sue proprietà. Esempio: “L’elefante è grigio ed
è un animale, dunque l’elefante è un animale grigio” è un buon
argomento; ma “L’elefante è un animale, un piccolo elefante è
dunque un animale piccolo” (p. 131). Gli stessi esempi ricorrono
nell’Introduzione alla logica di Copi-Cohen, che illustra così le
conseguenze della confusione tra significato assoluto e relativo dei
termini.
Fallacia come errore categoriale. Esempio: “Gli angoli ottusi
sono rossi”; “questo tavolo è triste”. Espressioni non vere ma
neppure false (p. 132).
Fallacie di vaghezza. La vaghezza è un problema che riguarda il
linguaggio comune e scientifico. Deriva dal fatto che la maggior
parte dei termini comprende tra i suoi significati dei casi limite, ai
quali non è certo se si possa applicare un certo termine. Ad
esempio a quale altezza un edificio dovrà essere classificato come
grattacielo? Fino a quale età si applica il termine “giovane” e da
quale età si è “vecchi”? Non sempre si possono stabilire dei
parametri (mobilissimi, come nell’ultimo caso). A quali
condizioni un essere umano inizia ad essere tale? La vaghezza del
significato dei termini è di importanza cruciale in ambiti quali la
politica, l’etica, la teologia.
Tra le fallacie concettuali D’Agostini include le fallacie di
composizione, quando si inferisce senza fondamento che una cosa
possiede una certa proprietà in base al fatto che una o più parti di
quella cosa hanno quella stessa proprietà. Ad esempio se i
componenti di una giuria sono determinati, non è detto che la
giuria sia determinata a produrre un verdetto contrario (p. 134). La
fallacia di divisione si commette invece quando si estende alle
singole parti di una cosa la proprietà che la cosa possiede in se
stessa.
La falsa dicotomia può essere classificata tra le fallacie di
presupposizione, come osserva D’Agostini. Es.: O sei con me o
sei contro di me. L’argomento presuppone che ci siano solo due
alternative, creando una specie di oscuramento cognitivo su altre
possibilità e alternative; nelle discussioni su qualsiasi argomento
la falsa dicotomia suscita un’impressione di esaustività che
favorisce l’efficacia dell’argomento e ne determina in gran parte
l’effetto persuasivo. La falsa dicotomia presenta la struttura logica
del dilemma. Una vera dicotomia, scrive D’Agostini, si ha quando
due eventi o stati di cose sono in rapporto mutuamente esclusivo e
congiuntamente esaustivo (p. 136): il verificarsi dell’uno esclude
il verificarsi dell’altro e viceversa; inoltre uno dei due deve
verificarsi o sussistere. «Per esempio: una porta deve essere aperta
o chiusa, e non c’è una terza possibilità. Notiamo però che ci può
essere esclusività senza esaustività, per esempio: se dico “questa
rosa è rossa” e tu dici “questa rosa è gialla”, le nostre asserzioni si
escludono reciprocamente, ossia possiamo aver ragione entrambi;
ma non c’è esaustività: potremmo aver torto entrambi, se per
esempio la rosa in questione fosse bianca. Invece se dico: “questa
rosa è rossa” e tu dici “questa rosa non è rossa”, i casi sono solo
due: ho ragione io o hai ragione tu, e uno dei due deve aver
ragione(la negazione infatti è l’artificio che nel nostro linguaggio
serve a esprimere la relazione di mutua esclusione e congiunta
esaustione, anche detta relazione di contraddizione). L’artificio
della falsa dicotomia consiste nel presupporre che una relazione di
questo tipo sussista tra eventi che potrebbero essere
reciprocamente esclusivi ma non congiuntamente esaustivi,
oppure non reciprocamente esclusivi» (pp. 136-137).
La fallacia detta slippery slope, o “argomento a domino” o “a
catena”, possiede una struttura del tipo: se p, allora accadrà che q
e se q, allora avverrà r e se r allora si avrà s. Dato che s è una
sciagura, allora ammettere p è una sciagura. Esempio: «Se le
truppe abbandonano il Vietnam, si affermerà il governo
comunista; se il governo comunista si afferma in Vietnam, i Paesi
confinanti diventeranno presto comunisti e tutta l’Asia presto sarà
rossa; se l’Asia diventa comunista, presto non si potrà fermare
l’avanzata del comunismo in Europa; se l’Europa diventa
comunista, l’America sarà sopraffatta; dunque se le truppe
abbandonano il Vietnam, l’America verrà sopraffatta» (pp. 137138). L’argomento a domino «è di natura concettuale, perché fa
riferimento a una struttura di pensiero tale per cui si vede una
specie di piano inclinato» (p. 137): una decisione apparentemente
buona è posta all’inizio di una catena causale che si conclude con
un disastro.
Si può facilmente osservare che passaggi logici
dell’argomento precedente corrispondono alla valida regola
d’inferenza, il sillogismo ipotetico. Nel ragionamento scientifico il
ragionamento a domino o a catena è molto frequente e non suscita
particolari obiezioni, se i singoli passaggi causali sono verificati.
Nel linguaggio comune e negli usi propagandistici invece la
consecutio di più passaggi causali non verificati impedisce al
destinatario dell’argomento di verificare i singoli nessi, asseriti a
priori. Quindi se l’ultimo anello della catena è un fatto negativo,
l’argomento diventerà discutibile, dato che assume una valenza ad
metum. Se al contrario è positivo, l’intero argomento sarà accolto
come valido, poiché risulta gratificante.
Diffondere una notizia falsa su di una persona o un fatto è
molto facile, dal momento che spesso una notizia falsa e
tendenziosa è accolta come vera da una maggioranza che non ne
sa nulla, mentre la minoranza che se ne rende conto non riesce o
non vuole intervenire pubblicamente per fare la rettifica. Le
smentite e le dimostrazioni in contrario non annullano l’effetto
persuasivo della menzogna sciorinata.
La generalizzazione indebita parte dall’osservazione di alcuni casi
particolari e la estende a tutto l’insieme. Si commette questa
fallacia quando si fa d’ogni erba un fascio. Nella scienza la
generalizzazione funziona come sillogismo induttivo se viene
sottoposta a controllo. Nella comunicazione pubblica e comune
può diventare facilmente uno strumento di manipolazione della
verità, se prevalgono la fretta e l’interesse di dimostrare a tutti i
costi una certa conclusione.
Un altro errore è quello commesso dal sillogismo statistico,
del tipo: ”La maggior parte degli F è G, X è F, dunque X è G”.
Una variante del precedente è la generalizzazione statistica,
ragionamento induttivo che si basa sulla campionatura e ha una
conclusone generale: “Su un campione di P l’n% sono Q, dunque:
l’n% de P sono Q”. Esempio: “Su cinquecento teenager italiani
l’80% guarda la televisione per più di tre ore al giorno, dunque
l’80% dei teenager italiani guarda la televisione per più di tre ore
al giorno” (p. 144). Qui la base dell’errore è rappresentata dalla
cattiva campionatura. Perché una generalizzazione statistica sia
accettabile il campione deve essere abbastanza ampio rispetto alla
totalità degli individui di quel tipo ed essere casuale, nel senso che
ciascun individuo di quel tipo deve avere la stessa probabilità di
entrare nel campione. La scelta del campione deve seguire criteri
rigorosi; un errore molto comune è quello di selezionare gli
intervistati all’interno di un indirizzario di abbonati a una rivista o
anche dell’elenco telefonico, che escluderebbe i cittadini privi di
telefonia fissa.
Le fallacie di accidente sono le generalizzazioni di un aspetto
accidentale di un fenomeno, come scrive D’Agostini. In ogni caso
l’accidente pretende di passare dall’osservazione di uno o più casi
a una regola generale per la quale quei casi non sono premesse
attendibili. La distinzione tra generalizzazione indebita e accidente
risulta quindi sfumata.
L’accidente converso consiste nell’applicare ingiustificatamente a
un caso particolare una regola generale che non è appropriata:
oggi dovrei saltare il pranzo come mi prescrive il medico, ma dato
che questa sera non potrò cenare, allora faccio un pranzo regolare.
D’Agostini classifica l’accidente e l’accidente converso come
violazioni dell’esempio e dell’analogia, due procedure basilari
dell’induzione.
1. Esempio: “Le donne hanno avuto vita difficile in ogni epoca
della storia, prima del Novecento: pensate a Ipazia, lapidata
dai cristiani; oppure alle presunte streghe bruciate sul rogo”.
Questa esemplificazione, scrive D’Agostini, è sbagliata,
essendo lacunoso e vago l’ambito da cui sono presi gli
esempi. Maggior forza e valore ha il controesempio o
exemplum in contrarium, noto nell’antichità: La regola
generale “Tutti i ruminanti hanno le corna” era falsificata
dal controesempio dei cammelli. In sostanza «un solo
esempio contrario confuta una tesi generale, ma un solo
esempio non conferma nulla. L’errore di esemplificazione
coincide con la generalizzazione indebita (e con la fallacia
naturalistica), nel caso in cui un solo esempio venga usato
per trarre conclusioni generali» (p.147).
2. Analogia: Consiste nell’affermare che i P sono Q notando
che gli R, che assomigliano ai P, sono anche tutti Q.
L’argomento analogico è sempre discutibile, si può però
proporre un controesempio. L’analogia è una procedura
difettosa, ma validissima sul piano euristico. La sua
sostenibilità può essere invalidata da un controesempio, allo
stesso modo in cui si può discutere l’esempio.
Altre fallacie induttive:
La fallacia dello scommettitore consiste nel credere che dopo una
serie di esiti sfavorevoli le giocate debbano avere esito positivo.
Ad esempio, il fatto che un certo numero non sia ancora uscito
non modifica in nulla le probabilità che esca nella puntata
successiva. L’uscita del rosso e del nero alla roulette sono eventi
indipendenti, la cui probabilità in questo caso è sempre ogni volta
del 50%. Un errore di probabilità un po’ comico è quello del
viaggiatore prudente. “Il signor X sa che le probabilità che su di
un aereo si trovi un terrorista con una bomba sono una su mille;
prima di partire dunque si munisce di una bomba, perché le
probabilità che su un aereo ci siano due terroristi con una bomba
sono una su un milione (1/1000 x 1/1000 = 1/1.000.000)” (p.149).
La fallacia di falsa causa indica una grande quantità di errori che
si commettono quando si scambia per causa qualcosa che non lo è
(o comunque non si hanno ragioni precise per ritenere che lo sia).
Una delle varietà più diffuse di falsa causa è nota come post hoc
ergo propter hoc. Ad esempio: l’epidemia è scoppiata dopo
l’arrivo di X in paese; dunque X ha portato l’epidemia.
La fallacia dell’evidenza soppressa è tipica degli argomenti
induttivi, essa consiste nella possibilità di modificare la
conclusione con l’aggiunta di nuove premesse. «La fallacia
consiste nell’ignorare o tacere dati che potrebbero essere in
contrasto con quel che si vuol sostenere» (p. 150).
Anche la fallacia naturalistica si può classificare tra le fallacie
induttive, che come è noto pretende di derivare le norme dai fatti,
cioè nel pensare che, poiché le cose stanno così, così dev’essere.
Una variante della fallacia naturalistica è l’ideologia del successo,
assumere quindi l’esito positivo come criterio della bontà di una
certa iniziativa. Essa non fa che giustificare i fatti, assegnando
loro un valore e una razionalità di tipo hegeliano. Assomiglia alla
teoria della provvidenza, secondo cui Dio fa emergere e premia il
meglio in ogni caso.
La stessa fallacia, ma di segno opposto, vediamo nel pensiero
apocalittico, che si presenta nei pessimisti sistematici, come nel
seguente ragionamento: “Le procedure argomentative non hanno
alcun valore in ambito pubblico, e la verità è irrilevante nel
confronto umano, dunque è inutile perseguire la verità e la
razionalità”. Qui si può osservare che «la fallacia naturalistica è
un errore tipico dei ragionamenti induttivi, infatti riguarda le
nostre riflessioni sulla realtà; ma è anche una fallacia di rilevanza:
dal fatto che le procedure argomentative non abbiano valore non
consegue che non debbano averne, e che dunque cercare di
promuoverne il corretto uso sia sbagliato» (p. 151). Molti
argomenti dei tradizionalisti si basano sulla confusione e
l’appiattimento di essere e dover essere, per cui le cose
dovrebbero andare come già vanno. Molti argomenti di bioeticisti
identificano “naturale” e “morale”, “innaturale” e “immorale”.
Non solo. Le accezioni di “naturale” sono le più diverse e
contrastanti.
Errori formali
Le fallacie formali sono errori deduttivi, aventi come schema
argomentativo un uso errato del condizionale, come gli schemi
speculari a modus ponens e a modus tollens.
Esempio: “se il rapinatore è entrato dalla finestra ci sono delle
impronte nell’aiuola; ma il rapinatore non è entrato dalla finestra,
dunque non ci sono impronte nell’aiuola” oppure: “Ogni profeta è
leader carismatico, dunque per essere un leader carismatico devi
essere religioso”, dove la fallacia è, rispettivamente, del falso
antecedente e del vero conseguente (p. 153). “Se sei incinta, il test
è positivo; il test è positivo, dunque sei incinta” non è sbagliato
nel caso specifico, per il fatto che ci troviamo davanti una doppia
implicazione.
Le fallacie pragmatiche sono errori nascosti che dipendono dalle
circostanze o dal contesto in cui si svolge l’argomentazione. Le
fallacie pragmatiche in senso stretto possono consistere in ciò che
si fa intendere con le parole senza esplicitarlo, oppure in ciò che si
fa con i gesti e i comportamenti. Le prime sono fallacie per
implicatura, le seconde fallacie esecutive.
Per implicatura: termine introdotto da Paul Grice. L’implicatura
dell’asserto “ho poco tempo” o “mi spiace ma devo andare” in un
appuntamento potrebbe essere: “non mi piaci, non se ne fa nulla”.
È facile interpretare in modo errato le implicature. E facile è anche
usare le implicature per produrre fallacie di qualsiasi tipo; si può
ricorrere all’implicatura per allusione (un tipo pragmatico di
vaghezza), come nell’esempio: “Su alcuni esponenti
dell’opposizione abbiamo un certo numero di dossier che ci
dicono che la loro moralità è altamente discutibile” (p. 158). Quali
dossier? Chi ne è l’autore?
Interessante il commento di D’Agostini, che osserva come le
fallacie per implicatura «spostano la responsabilità dell’errore:
chi sbaglia non è chi parla o scrive, ma chi recepisce le parole» (p.
158). Tuttavia va detto che tutte le fallacie, in qualche modo,
fanno sì che colpevole dell’inganno appaia la vittima e non il vero
autore: si pensi solo alle anfibolie o alle fallacie di equivocazione.
Le fallacie sono anzi essenziali nei procedimenti di
vittimizzazione, in cui si deve convincere la vittima di essere lei
stessa responsabile della persecuzione di cui è oggetto.
Smascherare gli inganni dei persecutori è dunque un’operazione
“sovversiva”, che scardina la persuasione che si insinua nelle
vittime riguardo la loro colpevolezza.
Lasciare intendere il falso dicendo il vero. Se dico “oggi sono
andato in chiesa” posso voler dire che abitualmente non vado in
chiesa ma oggi, sì, oppure che oggi, come sempre, sono andato in
chiesa.
Al termine di un colloquio con il presidente della repubblica,
Berlusconi dichiara che “sulla legge Gasparri non c’è stata alcuna
perplessità da parte del presidente della repubblica”; ma subito
dopo il Quirinale precisa che “nel corso degli incontri con il
presidente del consiglio Berlusconi il disegno di legge Gasparri
non ha formato oggetto di colloquio” (p. 159).
Immoralità contestuale. «Un caso insidioso di implicatura
immorale è il paradosso del ricatto. Maria viene a sapere che
Giacomo ha rubato un bel po’ di denaro e gli dice: “so che hai
rubato e ti denuncerò”. Poco dopo aggiunge: “ho bisogno di
soldi”. Giacomo dà a Maria 2.000 euro e Maria li accetta. Subito
dopo però denuncia Giacomo. Evidentemente Giacomo (indotto
da Maria) ha fatto un’inferenza dall’implicito: ha interpretato “ho
bisogno di soldi” come “se mi dai dei soldi non ti denuncio”» (p.
160). L’inferenza di Giacomo era giustificata dalla sequenza delle
frasi di Maria, che suggeriva implicature di un certo tipo, subito
smentite dai fatti. Quale dei due è moralmente peggiore?
Elogi distruttivi. L’implicatura ad personam si può ottenere per
associazione o per contrasto. Un esempio ci è dato dal ripetuto
elogio “…e Bruto è un uomo d’onore” nel Giulio Cesare di
Shakespeare, dove si assiste alla distruzione ironica di una persona
a colpi di elogi.
Formule definitorie. Sono espressioni tipiche, come quelle
foggiate in linguaggio politico, il cui uso attiva implicature
positive o negative, come “democratico”, “diritto di essere
informati”, “comunista”, ecc.
Molte fallacie condividono una caratteristica significativa: la
semplificazione riduttiva. «Le strategie di semplificazione hanno
lo scopo di far passare contenuti non veri rendendoli credibili
perché facilmente comprensibili: è molto più facile credere vere
tesi uniformanti, che trascurano la varietà e le differenze, piuttosto
che perdersi nei dettagli» (p. 163). L’osservazione di D’Agostini
corrobora l’interpretazione generale delle fallacie come strumenti
di vittimizzazione. L’identificazione di una vittima e la sua
espulsione non sopportano dubbi o sfumature, hanno bisogno
della massima semplificazione, quella dicotomica: bene-male,
colpevole-innocente, causa-effetto. Nell’universo mitico della
persecuzione vittimaria il male è tutto dalla parte del colpevole
destinato all’espulsione, mentre il bene è tutto dalla parte dei
persecutori, che si muovono nella convinzione – di cui cercano di
rendere partecipe anche la vittima – di aver individuato la sola
causa del male e di dovere quindi procedere alla sua eliminazione
allo scopo di purificare la comunità avvelenata dal conflitto e
ristabilire la pace interna.
Esecutive. Le fallacie esecutive sono comportamenti più o meno
visibili (gesti, intonazioni, ecc.) che rappresentano violazioni di
regole che sono condizioni inderogabili di un dibattito razionale.
Le fallacie esecutive non riguardano le parole, ma il contegno di
chi le usa.
Ad baculum esecutivo. Un capo, invece di dire a un sottoposto che
lo licenzierà se non la smette di fare opposizione, può
trasmettergli lo stesso messaggio e zittirlo fulminandolo con lo
sguardo o andando su tutte le furie o con altre modalità in grado di
suggerire realisticamente la sua intenzione di agire in un certo
modo.
Come esempio di ad baculum esecutivo D’Agostini riporta il
paradosso della deterrenza noto anche come dilemma nucleare. La
minaccia di ritorsione funziona solo se chi minaccia di reagire a
un attacco nucleare con un attacco che distruggerà l’intero pianeta,
viene a trovarsi nella situazione «di dover essere creduto
irrazionale per essere razionale» (p. 164). Fingersi irrazionali e
senza scrupoli può produrre un sicuro effetto in certi casi (come
dimostrano certe esternazioni di Vittorio Sgarbi in dibattiti
pubblici). Se la deterrenza spinta all’estremo non funziona, allora
la soluzione può consistere nel sottrarre le condizioni all’arbitrio
dei singoli con la deterrenza automatica. L’avvertimento di
ritorsione del capo di stato sarà allora il seguente: “Se
attaccherete, partirà automaticamente, e senza che io possa
fermarlo, un attacco nucleare che distruggerà il pianeta” (p. 164).
Una fallacia esecutiva è il riso sofistico. L’inversione di tono è un
espediente retorico già fissato da Gorgia, che suggeriva di
“combattere la serietà con il riso e il riso con la serietà”.
Berlusconi chiama Obama “abbronzato” (settembre 2009) per
dare sfogo al proprio imbarazzo razzista. L’espressione è così
ambigua che si può interpretare anche come apprezzamento del
tutto positivo, essendo l’abbronzatura un valore per i bianchi.
La provocazione è la più ovvia tra le fallacie esecutive: spingere
l’avversario a perdere il controllo, ad alzare la voce e ad insultare,
utilizzando varie tecniche (interruzioni frequenti, accenni ad
personam, disprezzo per cose e persone che l’avversario apprezza,
ecc.). La provocazione ha come obiettivo quello di provocare l’ira
nell’avversario, inducendolo ad assumere atteggiamenti di persona
collerica e irrazionale. Quando si ricorre alla provocazione, si è a
corto di argomenti.
Agire sulle condizioni. La più infantile tra le fallacie esecutive è
quella di fare rumore, parlare o ridacchiare mentre qualcuno sta
esponendo le proprie tesi. Frequente in parlamento, ma anche nei
congressi scientifici o nelle sedute di laurea. Si tratta di una
fallacia di uso controversiale: «lo scopo non è quello di agire
sull’avversario, ma sul convincimento del “terzo” che ascolta,
impedendo o disturbando le stesse condizioni dell’ascolto». (p.
167). La slealtà della fallacia esecutiva consiste nella distruzione
delle condizioni indispensabili a un confronto pubblico. In
generale, le fallacie esecutive segnano il passaggio della strategia
di vittimizzazione dal piano retorico argomentativo a quello
dell’azione diretta sul piano della comunicazione non verbale. I
passi successivi sono l’emarginazione, la persecuzione e la
lapidazione della vittima.
Fallacie ermeneutiche
Sono le violazioni delle regole fissate dalla tradizione
ermeneutica. D’Agostini riprende esplicitamente le principali
fallacie ermeneutiche da Verità e metodo di Hans Georg Gadamer.
- Anacronismo. Viola la regola della Zeitenabstand (distanza
temporale), stabilisce il dovere di contestualizzare il
-
-
-
-
contenuto dei discorsi o dei testi (possiamo rimproverare
Aristotele di non avere intuito i principi della relatività?)
La fallacia di sottovalutazione viola la regola detta
presupposto della perfezione, che stabilisce che, valutando
un testo, si deve presupporre che l’autore conosca alla
perfezione l’argomento di cui sta parlando: impossibile
comprendere a fondo un autore se si parte dal presupposto
che non sia autorevole in quello che dice. Si giustifica così
il principio di carità, che mi impone di rimuovere tutto ciò
che può compromettere la corretta comprensione di un
testo, come ad esempio una formulazione difettosa,
favorendo la valutazione critica corretta.
L’interpretazione è un processo circolare in cui
l’interpretante usa le proprie conoscenze per comprendere
ciò che viene detto. La precomprensione nel senso di
Heidegger (Essere e tempo, § 32) determina un circolo tra il
dato che si deve comprendere e le conoscenze preliminari di
chi lo comprende. Impossibile dunque eliminare i
pregiudizi di cui ci serviamo per giudicare: senza
conoscenze preliminari non capiremmo nulla di nulla.
Bisogna distinguere tra i pregiudizi che illuminano e quelli
che accecano, onde evitare che si producano errori causati
dai secondi (p. 170).
La fallacia di prevaricazione consiste nel far prevalere il
proprio linguaggio, violando la regola della fusione di
orizzonti, per la quale il risultato dell’interpretazione deve
consistere in una combinazione armonica dell’orizzonte
cognitivo dell’interprete e dell’interpretante. Non deve
prevalere, nel dialogo, uno dei due punti di vista e quindi
ogni sua violazione della regola della fusione di orizzonti
viola i principi dialogici ai quali dovrebbero ispirarsi i
dibattiti pubblici.
La fallacia dell’ultima parola consiste nell’ignorare che il
processo interpretativo è virtualmente infinito e quindi
nessun interprete può pretendere di avere l’ultima parola,
pretesa che dà corpo al dogmatismo, e nega una regola
primaria del confronto tra esseri razionali: l’idea che
qualsiasi opinione o proposizione deve poter essere
discussa. La fallacia dell’ultima parola è simile alla fallacia
ad verecundiam, «solo che l’autorità che si pretende
indiscutibile è lo stesso proponente» (p. 172).
Perché le fallacie hanno successo?
Alla domanda D’Agostini dà tre risposte: la prima risposta è il
principio di ignoranza: le fallacie ingannano perché i partecipanti
al dibattito ignorano le regole di cui esse sono violazioni. In
secondo luogo, le fallacie funzionano perché nella maggior parte
dei casi sono un’applicazione impropria di una regola. Ad
verecundiam e ad baculum sono buoni esempi di questa tesi,
sostenuta da Douglas N. Walton ed Erik C.W. Krabbe. Il
ragionamento ad verecundiam sarebbe perfettamente legittimo
quando l’autorità è un esperto; l’ad baculum è autorizzato quando
la posta in gioco è un bene irrinunciabile (la vita, la salute, la
salvezza da un pericolo grave, ecc.). Le fallacie di
generalizzazione non escludono la generalizzazione corretta. La
terza ragione di successo delle fallacie è la fragilità delle regole
argomentative e logiche. La scienza in che misura è autorevole? In
quali casi l’appello all’autorità è legittimo e in quali altri casi è
invece una fallacia ad verecundiam? La fallacia ad ignorantiam
deve la sua frequenza ai limiti della nostra conoscenza, che è
elusiva: «ci sono molte cose che non sappiamo, e che dovremmo
sapere per essere davvero certi di quel che sappiamo. Questo
significa che l’argomento all’ignoranza è una insidia racchiusa in
qualsiasi inferenza da premesse non matematicamente certe» (p.
174). Possiamo avere buone regole usate in modo improprio
oppure regole strutturalmente fragili: «È come appoggiare una
buona scala su un terreno fangoso e incerto, o appoggiare una
scala pericolante e mezza rotta su un terreno solido», commenta
D’Agostini, riportando una metafora di Adelino Cattani. Questo
però
non
significa
che
sia
inevitabile
arrendersi
all’argomentazione fallace, perché non c’è un ordine
incontrovertibile e una sicura razionalità nell’argomentazione.
D’Agostini indica la via d’uscita: «Il terreno incerto e fangoso è
precisamente lo spazio di azione del discorso fallace, quello in cui
anche la scala migliore si rivela inutile, e le regole razionali (la
ragione) risultano disarmate di fronte alla peggiore retorica. Ma il
terreno fangoso è il risultato dell’ignoranza pubblica delle regole,
è cioè esattamente determinato dalla prima causa di errore: il
principio di ignoranza» (p. 174-175).
Paola Cantù, E qui casca l’asino. Errori di ragionamento nel
dibattito pubblico, Bollati Boringhieri, Torino 2011, pp. 178.
È possibile mettere d’accordo la logica con la politica?
Nell’articolo di Oriana Fallaci, La rabbia e l’orgoglio, pubblicato
il 29 settembre 2001 sul Corriere della sera, Cantù trova molte
fallace, tra cui spicca quella ad metum, che consiste nella
drammatizzazione di un pericolo allo scopo di persuadere
l’uditorio a prendere posizione nel senso voluto da chi parla o
scrive. Le fallacie sono errori involontari di ragionamento oppure
infrazioni volontarie e quindi fraudolente di regole procedurali
universalmente condivise. Nel caso della Fallaci l’invito a
combattere l’islam subito e con la massima determinazione viene
giustificato evocando la distruzione certa della nostra cultura
quale conseguenza di un atteggiamento passivo e rinunciatario,
ammantato di umanitarismo, dinanzi alla minacciosa avanzata
dell’islam. Un ragionamento ad metum non è necessariamente
fallace, dipende dal contesto di riferimento, ma nell’articolo della
Fallaci esso si combina con la fallacia della brutta china, che si
caratterizza per l’omissione di dati rilevanti, asserendo
l’ineluttabilità di un esito che non è dimostrato nei passi
intermedi. L’articolo della Fallaci contiene anche la fallacia del
falso dilemma: «Poiché sottrarsi alla tragedia è avere paura della
guerra, l’alternativa che si pone è: o ci si fa del male o si muove
guerra al terrorismo» (p. 12).Il ricorso alla fallacia del falso
dilemma è di solito un espediente molto efficace, in quanto
insinua come inconfutabile ed esaustiva la bipartizione in due
alternative, in questo caso negative, una delle quali presentata
come male minore. «La fallacia dell’argomento risiede nella
semplificazione eccessiva delle alternative possibili, nella
riduzione di un problema alla contrapposizione tra due soluzioni
opposte, senza tener conto di sfumature, ipotesi intermedie, fattori
contestuali» (p. 13).
L’argomento che attacca una persona per screditarla
mettendola in cattiva luce, invece di confutare propriamente la tesi
sostenuta da quella persona, è una tipica fallacia ad hominem.
L’offensiva può colpire una persona sul piano cognitivo, morale,
professionale, sessuale e persino fisico; può denunciare il presunto
movente di chi sostiene una certa tesi, insinuando che questi abbia
interesse personale alla sua accettazione. Una versione molto
diffusa di argomento ad hominem consiste nel denunciare una
presunta incoerenza tra la tesi sostenuta in quel momento e altre
idee o tesi espresse dall’interlocutore in altre occasioni. Persino
difetti fisici (balbuzie, salivazione palesemente abbondante,
sovrappeso e altre caratteristiche giudicate indecorose dal codice
implicito) possono servire per attaccare una persona evitando di
confutare la sua tesi. L’argomentare tipico ad hominem sfrutta
slealmente ogni circostanza che si possa prestare alla distruzione
della figura dell’interlocutore. Una variante del ragionamento ad
hominem, il tu quoque sostiene l’inconsistenza di una tesi
mostrando che essa è in contraddizione con le idee e i
comportamenti di chi la propugna. A chi sostiene che il Corano
predica la pace, la fratellanza e la giustizia, si potrebbe obiettare
che esso contiene anche la legge del taglione e una considerazione
della donna come entità che conta meno di un cammello. Il tu
quoque è un ragionamento del tutto basato su elementi cognitivi;
la sua efficacia pratica è considerevole, consistendo nell’insinuare
l’esistenza di una contraddizione logica tra la tesi
dell’interlocutore e altre sue idee. Eppure queste idee sono
attribuite all’interlocutore senza una verifica: si presuppone che le
abbia e le sostenga. Sul piano logico l’argomento del tu quoque
introduce contenuti non pertinenti, per evitare di affrontare
direttamente la tesi che si vuole confutare. L’incoerenza
presupposta nell’interlocutore è abilmente sfruttata nel tentativo di
una confutazione deviata della tesi sostenuta.
L’argomento ad verecundiam cerca di gettare il ridicolo
sulla persona che sostiene una certa tesi o adotta un certo
comportamento. Il biasimo si fonda sul fatto che rifiutare una
certa tesi equivale a perdere considerazione sociale. Implicito è
l’appello all’autorità della tradizione. L’onere della prova è
scaricato sull’interlocutore: «Non è Oriana Fallaci a dover
argomentare contro l’uso del chador, contro la poligamia, a favore
dell’istruzione femminile e della libertà nelle cure sanitarie e nel
consumo di alcolici, bensì chi non condivide la sua posizione. Il
ridicolo in questo caso è espresso tramite attacchi generici alla
persona, condensati negli aggettivi spregiativi volgari “stupido”,
“scimunito”, “minchione”, “grullo”. Come nel caso della fallacia
ad hominem, l’errore del ragionamento consiste nell’introduzione
di dati non rilevanti, oltre che, in questo caso, offensivi e non
rispettosi» (p. 17). Una regola fondamentale che deve valere in
ogni discussione razionale, tesa alla ricerca della verità e non al
trionfo di un protagonista del dibattito, è quella per cui non deve
valere alcun divieto di mettere in dubbio una tesi, un presupposto,
un’idea qualsiasi sostenuta da chicchessia nel corso del dibattito.
Le invettive sarcastiche, ma anche molti discorsi che fanno leva su
forze irrazionali, danno per scontato l’assurdità di ammettere che
si possa discutere con l’interlocutore.
In un articolo pubblicato il 28 febbraio 2005 sul Corriere della
sera, Giovanni Sartori definisce assurda la pretesa di riconoscere
agli embrioni dei diritti equivalenti a quelli delle persone già nate,
sviluppando un argomento per analogia: come la soppressione di
un embrione o larva animale è totalmente differente rispetto
all’eliminazione di un adulto della stessa specie, allo stesso modo
l’uccisione di un embrione umano non si può paragonare alla
soppressione di un esemplare adulto. Sartori vorrebbe così
dimostrare che i diritti degli embrioni non coincidono con quelli
degli individui sviluppati. La fallacia di Sartori, secondo Cantù,
non consiste nell’argomentazione induttiva per analogia, di per sé
accettabile e corretta, ma nella pretesa di travestire un
ragionamento induttivo, la cui conclusione è quindi solo
probabile, con l’abito della necessità dimostrativa. Si tratterebbe
quindi di una fallacia di ambiguità, giacché «alla logica si fa
appello ora come logica induttiva (usando l’argomento per
analogia) ora come logica deduttiva formale (affermando che tutto
ciò che ne contraddice le conclusioni è assurdo)» (pp. 21-22). La
negazione di una conclusione è assurda solo quando la
conclusione discende con necessità dalle premesse, ma non è
questo il caso. In generale le argomentazioni adottate da chi si
prepara a sostenere o a confutare una tesi sono spesso invalidate
dalla presenza implicita di premesse la cui verità è data per
scontata o è abilmente sottratta alla discussione e al confronto.
Nella risposta di Roberto Colombo a Sartori (Corriere della sera, 3
marzo 2005) Cantù rileva due fallacie: una fallacia linguistica di
ambiguità riguardo al principio di identità, che è usato come
principio logico e insieme come principio dell’identità personale
nel tempo; e una seconda fallacia di petitio principi nascosta, che
consiste nel dare per scontato ciò che invece si dovrebbe
dimostrare.
Gli argomenti induttivi e causali si fondano sull’esperienza
e perciò sono inclusi nella categoria degli argomenti a posteriori.
In generale si tratta di argomenti in cui il nesso tra premesse e
conclusione è solo probabile (con diversi gradi di probabilità), ma
possono essere usati in modo fallace quando il nesso è apparente o
non sussiste. Gli stessi argomenti possono essere invalidi perché le
premesse non sono vere né condivise.
«Le liberaldemocrazie (…) oggi si trovano alle prese con un
indebolimento o una perdita della propria identità culturale,
soffocata dall’opulenza materiale oltre che minacciata dal
fondamentalismo islamico» (Marcello Pera, Democrazia e
libertà? In difesa dell’Occidente, discorso pronunciato in apertura
del Meeting dell’Amicizia, Rimini, 11 agosto 2005). Nel discorso
di Pera la perdita dell’identità culturale è correlata all’opulenza
materiale e al fondamentalismo islamico. La coesistenza dei tre
fenomeni tuttavia non dimostra che opulenza materiale e
fondamentalismo islamico siano all’origine della disgregazione
dell’identità culturale. «Si tratta, osserva Cantù, di un tipico
esempio di fallacia di non causa pro causa o della causa errata,
perché non è provato che l’evento presentato come causa di un
certo effetto ne sia veramente la causa» (p. 29). Tuttavia anche in
questo caso si può osservare come non sia chiaro che cosa si
intende con identità culturale (molti argomenti omettono di
chiarire il significato dei termini impiegati, commettendo fallacie
di definizione, quando un termine è definito in maniera troppo
ampia o troppo stretta, oppure in modo circolare, ambivalente o
contraddittorio). In questo caso e in molti altri si insinua inoltre
una premessa tacita: che sia esistito ciò di cui si lamenta il
degrado o la scomparsa – l’identità culturale, alla quale è attribuita
una natura tale da dover temere la dissoluzione ad opera di fattori
“esterni”. E se l’identità fosse necessariamente qualcosa di
mutevole, multiplo, ibrido e non fosse mai esistita un’identità
monolitica, intesa come sostanza originariamente pura?
Coloro che sostengono la tesi del relativismo culturale, per
cui ogni cultura merita uguale rispetto e va riconosciuta e accettata
nelle forme che le sono proprie, per il fatto che non possono
esserci criteri metaculturali di valutazione, dovranno tuttavia
ammettere che tale tesi è sostanzialmente metaculturale, dal
momento che produce un asserto universale, che deve valere per
tutte le culture. La tesi per cui non esistono valore morali assoluti,
e buono e cattivo valgono solo volta per volta nelle diverse
circostanze o finalità, è essa stessa un richiamo all’autorità
indiscussa della storia e ne deriva un atteggiamento che è rimasto
lo stesso da secoli. La tesi che professa il relativismo è sostenuta
con richiami alla massima evidenza, è asserita con argomenti
logici e ideologici e soprattutto implica il divieto (tacito) di
metterla in discussione, ad esempio mostrando che anch’essa è
soggetta alla condizione prevista per tutti valori, che valgono
diversamente volta per volta, in base alle circostanze. Se anche la
tesi del relativismo è un prodotto della nostra civiltà occidentale in
questo momento storico, perderà ogni carattere di assolutezza; se
invece la tesi relativista è fatta valere come assoluta, allora è
inevitabile l’autocontraddizione.
In ambito politico, etico e sociale spesso si usa l’argomento
del piano inclinato per ostacolare un progetto o impedirne la
realizzazione: si precorrono gli eventi illustrando una presunta
situazione catastrofica, inaccettabile per tutti, partendo dalla quale,
come nel ragionamento per assurdo, si retroagisce sulla premessa
per respingerla in quanto non degna di essere presa in
considerazione. La fallacia del piano inclinato è molto diffusa; è
singolare che sia usata consapevolmente come se fosse un buon
argomento, esprimendo una tendenza oggettiva, intrinseca alle
cose stesse e quindi irrefutabile. Più che di un errore si tratta
dell’esibizione di una procedura ritenuta infallibile da chi la
propone, spesso dichiarandola apertamente (la china scivolosa!).
Naturalmente, obietta Cantù, non c’è alcuna necessità che, una
volta adottata una certa misura o aperta la strada a un certo
trattamento, si scivoli inesorabilmente verso la catastrofe che si
trova alla fine di molti passaggi. Non è affatto scontato,
comunque, come vuole l’argomento (detto anche del pendio
sdrucciolevole o dell’argine che si rompe o della direzione o della
brutta china) che, una volta fatto il primo passo, non si possa
evitare di compiere i successivi fino al disastro finale.
Programmi e discorsi politici abbondano di fallacie di
ambiguità e di linguaggio pregiudizievole, utilizzate con
spregiudicata abilità allo scopo di creare il consenso attorno al
programma esposto. L’appello alle emozioni è sempre presente:
che cosa meglio di un timore profondo o di una speranza diffusa
può svegliare l’attenzione dell’uditorio e renderlo disponibile ad
agire nella direzione voluta? Il linguaggio della propaganda non
tollera le mezze misure, i semitoni, le sfumature: procede per
dicotomie e contrapposizioni, falsi dilemmi e rappresentazioni
dell’avversario come nemico. La propaganda costruisce un
nemico da battere, rappresentandolo come l’incarnazione del male
che dilaga come contagio mortifero. L’appello a unire le forze, a
schierarsi apertamente contro il male per sconfiggerlo
espellendone la causa, non è che l’inizio di una procedura assai
nota, consistente nell’individuare un capro espiatorio, una vittima
da espellere per risanare l’intera comunità, finalmente aggregata
attorno alla vittima uccisa. Ogni discorso di propaganda suona in
effetti come il primo passo verso il tutti contro uno della teoria
vittimaria. La tanto declamata dialettica democratica è una tecnica
che riproduce i passaggi iniziali dell’escalation vittimaria, laddove
si limita a individuare il nemico da linciare, la causa del male che
si deve rimuovere, mediante attacchi violenti alla sua persona, alla
sua dignità, al suo onore. Si potrebbe obiettare che manca la scena
finale, dove i linciatori si scagliano contro la vittima innocente e la
fanno a pezzi. In realtà di tanto in tanto la scena finale si presenta
in tutta la sua agghiacciante cruda bestialità (ad esempio
l’assassinio di Matteotti, di Moro, ecc.). Tutte le cosiddette
fallacie dell’argomentazione vanno considerate come tecniche per
eludere il compito di stabilire la verità di una certa tesi. Esse
pretendono di far valere una conclusione basandole su premesse
inconsistenti o irrilevanti: aprono la via all’affermazione non della
verità, ma di un rapporto di forza favorevole al protagonista. Le
fallacie sono tutte in qualche modo fallacie di rilevanza con cui si
voltano le spalle alla verità per dirigersi contro qualcuno da
piegare, convincere e infine, se necessario, da eliminare
fisicamente. Senza il contesto del processo di vittimizzazione le
fallacie rischiano di rimanere pratiche puramente retoriche o errori
involontari di chi parla o scrive. Le fallacie risultano
immediatamente intellegibili solo come strumenti di
individuazione della causa che sta al fondo del malessere diffuso.
Nelle società arcaiche le tecniche di vittimizzazione sono molto
rudimentali e consistono essenzialmente nel ricorso ai segni
vittimari (difetti fisici, provenienza ignota, carattere eccentrico,
anticonformismo, ecc. della vittima designata, alla quale sono
presto attribuiti i peggiori crimini, quali assassinio, incesto, ecc.).
Nelle società moderne i segni vittimari sono sostituiti dalle
fallacie opportunamente inserite nelle procedure argomentative.
Cantù non affronta queste implicazioni e rimane sul piano della
teoria dell’argomentazione.
La lettura della stampa presenta spesso esempi di fallacia di
non causa pro causa, quando l’evento presentato come causa di
un certo effetto di fatto non è la causa oppure è discutibile che lo
sia. Tale fallacia è spesso associata alla fallacia di causa
complessa (causa irrilevante), quando un evento è presentato
come causa principale di un certo effetto mentre in realtà esso è
solo concausa. Errore frequente perché, come spiegano gli
psicologi, gli uomini sono soggetti a biases di attribuzione
causale. Le attribuzioni sono di due tipi: esterne, quando la causa
dell’evento è individuata nella situazione esterna o in fattori
diversi dalla volontà degli individui e interne o disposizionali,
quando la causa dell’evento è individuata nella qualità di una
persona, sia questa la volontà o l’intelligenza (p. 75). Si può essere
indotti a far credere che un incendio non sia scoppiato per cause
fortuite, ma che sia doloso; o che un certo evento catastrofico sia
il risultato di un complotto, di un piano segreto ordito da poteri
occulti – teoria del complotto che è soggetta all’autoconferma, dal
momento che la segretezza dell’operazione pregiudica di per sé la
possibilità di ottenere prove evidenti della verità della teoria
stessa. L’attacco dell’11 settembre 2001 è stato il risultato di un
complotto? E chi erano i componenti del gruppo che in gran
segreto ha preparato ed eseguito il piano, terroristi islamici o
agenti dei servizi segreti americani? In genere eventi che suscitano
emozioni fortissime si ricordano più facilmente. L’errore di base
spesso si fonda sul meccanismo psicologico noto come euristica
della disponibilità, per cui prevale la tendenza a valutare un
evento come più probabile quando è facile richiamare alla
memoria numerosi ricordi di eventi simili (pp. 78-79). La maggior
parte degli incendi di vaste proporzioni sono ricondotti a
complotti, al dolo, con maggiore probabilità degli incendi di
piccole dimensioni. Molti giornalisti contribuiscono a diffondere
errori cognitivi riguardo la vera causa di eventi distruttivi, errori
che si possono ricondurre alla tendenza a semplificare la
rappresentazione della realtà in persone sprovvedute, ma non in
professionisti della comunicazione.
A sostegno della nostra tesi, giunge l’osservazione di Cantù
sulla satira di Beppe Grillo, i cui argomenti attaccano in forma
comica il bersaglio di turno nella sua persona, anziché affrontare
le sue idee e discuterle direttamente. E siamo d’accordo nel
rilevare che la retorica politica e il giornalismo d’assalto
commettono a piene mani fallacie ad hominem, palesi attacchi alla
persona, insulti veri e propri espressi in forma di battuta spiritosa.
Non si può essere del tutto d’accordo con Cantù, quando respinge
l’argomento di chi sostiene che gli insulti possono istigare attacchi
più violenti, fino ad arrivare all’assassinio, classificandolo come
esempio della fallacia della brutta china (p. 89). L’obiezione che,
ricorrendo alla fallacia della china scivolosa, non si indichi la
catena causale che conduce dall’insulto all’assassinio, non è
sostenibile senza una ricognizione del contesto: nel caso in cui
l’insultato sia un magistrato o un politico, si dà inizio a un
processo di selezione, isolamento e vittimizzazione che evoca il
linciaggio terminale e spesso vi conduce. Perché negare
l’evidenza schiacciante che gli attacchi rivolti a chiunque (anche
mediante il pettegolezzo, l’insinuazione o l’ingiuria privata)
favoriscono l’isolamento progressivo e la ripetizione di attacchi
simili, sempre più violenti, fino a concludersi nell’assassinio in
casi estremi? La mano assassina che fa il lavoro finale non è chi
ha dato inizio alla catena. Il contagio mimetico rispecchia una
tendenza dilagante che porta irresistibilmente al tutti contro uno
secondo modalità che rispecchiano la china scivolosa: vi sono casi
in cui la fallacia vera consiste nel negare l’evidenza della
progressione scivolosa con l’accusa che chi la sostiene cade nella
fallacia, appunto, della brutta china. Certamente, che ci fosse
davvero una pessima china e che fosse prudente fermarsi molto
prima, veniamo a saperlo post factum, quando ormai la violenza
estrema si è consumata. La differenza tra accusa fondata, accusa
ingiustificata, calunnia, insulto e confronto fisico è reale, ma
riguarda per lo più il modo e le circostanze in cui si consuma
l’assalto ad hominem. L’attacco alla persona, che a fondamento
del valore delle idee pone la forza di chi le sostiene, è una prova
del dominante disprezzo per la verità e della barbarie diffusa.
Nei dibattiti in Italia prevale, osserva Cantù, la tendenza a
sviluppare argomenti dilemmatici, fondati su dicotomie rigide,
con discussioni in cui la demonizzazione dell’avversario è la
procedura dominante (p. 90). Una cosa è certa: questo metodo
distorto uccide a poco a poco la democrazia, perché affievolisce la
fiducia delle persone nella possibilità di far valere la verità e
ingenera la micidiale persuasione che l’uso o la minaccia dell’uso
della forza sia l’argomento migliore per intimidire e sottomettere
l’interlocutore. Probabilmente il successo che incontra la retorica
dell’insulto e dell’attacco alla persona si deve al fatto che il
dibattito pubblico è una specie di surrogato del linciaggio della
vittima; e il fatto che si ripeta spesso genera un appagamento
perverso negli spettatori, che sono come pacificati e rasserenati
dallo sfogo che l’esaltato di turno, con la sua pubblica esibizione
di sgarbo licenzioso, assicura a tutti coloro che attendono di
godere comodamente sdraiati sul divano di casa.
La battuta di spirito è l’esibizione di numerose fallacie, ma
la ragione profonda consiste nel fatto che la comicità è una forma
elegante e diversiva di persecuzione vittimaria. L’abilità del
comico al servizio della critica anche corrosiva di idee, situazioni
e personalità politiche, è ben illustrata da Cantù nella sua analisi
delle battute di spirito di Maurizio Crozza nella copertina di
Ballarò. Merita una certa attenzione l’uso del paradosso e della
falsa analogia da parte del popolare comico. L’8 gennaio 2008
Crozza fa la satira di Walter Veltroni denunciando ironicamente la
contraddizione tra diverse idee e posizioni sostenute dalla stessa
persona: «Stiamo con i giovani precari ma anche con gli
imprenditori che li sfruttano. Stiamo con le donne che stentano a
tenere insieme il lavoro e la cura dei figli ma anche con i loro
mariti che se ne fregano e vanno a puttane. Perché tutti hanno
diritto a un futuro luminoso ma anche buio, a una vita serena ma
anche alla disperazione. Perché le giovani coppie che sono il
futuro del nostro paese devono avere davanti una prospettiva
positiva ma anche negativa» (p. 93). Molti argomenti utilizzati da
Crozza sono volutamente fallaci, il che li rende legittimi, in
qualche modo, dato che si smascherano da sé immediatamente,
producendo tuttavia un irresistibile effetto comico, come nella
satira seguente che, nella puntata di Ballarò del 22 gennaio 2008,
dipinge Mastella con una falsa analogia impiegata a scopo ironico,
intendendo apertamente il contrario di ciò che viene detto. Il
risultato è fortemente comico: «Mastella lei per me è un grande
statista. Uno statista lo si riconosce dalle sue gesta, non so per
esempio: Gandhi con la forza del suo pensiero ha liberato il suo
popolo dal giogo coloniale. De Gaulle con la forza del suo
coraggio ha liberato la Francia dai nazisti. Mastella con la forza
dell’indulto ha liberato 27.000 delinquenti dalle carceri» (pp. 9394).
Molto frequenti sono le generalizzazioni, le petizioni di
principio, le fallacie ad metum, combinate con la fallacia non
causa pro causa. Frequente è il ricorso all’argomento per cui si
deve limitare l’ingresso di stranieri in Italia in ragione del fatto
che chi si oppone al controllo dell’immigrazione in realtà
promuove la xenofobia, perché nasconde o criminalizza la
percezione sempre più diffusa di insicurezza, rendendola sempre
più esplosiva. Difendendo l’autore di un articolo razzista apparso
su Libero il 16 maggio 2008, in cui si lamentava lo scarso
impegno dei politici in Veneto «a disinfestare il Veneto dalla
monnezza rom e assimilati», il direttore Vittorio Feltri, a un lettore
indignato da espressioni così violentemente razziste, chiariva che
l’autore dell’articolo aveva auspicato un maggiore impegno nel
disinfestare la spazzatura dei rom, che nei loro campi sarebbero
poco rispettosi delle norme igieniche. «La mossa argomentativa di
Feltri, commenta Cantù, consiste nel correre ai ripari appellandosi
a una figura retorica nota come anfibolia e basata sull’ambiguità
del testo, che egli si premura di eliminare a favore
dell’interpretazione più caritatevole» (p. 104). Il ricorso allo
stereotipo denigratorio ottenuto attraverso generalizzazioni ad hoc
rappresenta una formidabile semplificazione della realtà di gruppi
umani, con cui si mira a giustificare interventi anche brutali, con
parole d’ordine semplici e chiare. La formazione dello stereotipo,
tuttavia, non sarebbe possibile senza l’intervento delle condizioni
che aprono la strada all’espulsione vittimaria. Allo stereotipo non
si giunge solo per via logica (fin troppo facile risulta individuare
la fallacia formale che vi conduce). Ma «analizzare in maniera più
approfondita le specificità del contesto in cui compare» (p. 108),
come scrive Cantù, obbliga a misurarsi con il processo vittimario.
La diffusa attività di killeraggio politico che emerge dai
mezzi di informazione è di tale gravità da indurre le persone
oneste e in buona fede a desistere dalla lettura della stampa. La
credibilità giornalistica è quasi azzerata. L’accusa che si rivolge ai
giornalisti è quella di spargere fango sugli avversari politici del
partito cui il giornale si ispira allo scopo di delegittimarli e
metterli fuori gioco. Il killeraggio politico non è una fallacia
argomentativa, osserva Cantù, perché non è effettuato nel corso di
una discussione, è invece «una strategia retorica di propaganda
negativa, che può essere usata da un candidato per mettere in
cattiva luce il suo avversario» (p. 149). Nel libro La verità
avvelenata di Franca D’Agostini, citato da Cantù, l’autrice
definisce avvelenamento del pozzo la fallacia con cui «si mira a
screditare o delegittimare in anticipo qualunque cosa un
avversario possa dire, insinuando che sia in cattiva fede o che sia
scientificamente, moralmente o politicamente inadeguato» (p.
146). La differenza rispetto alla fallacia ad hominem, di cui la
fallacia dell’avvelenamento del pozzo è stata tradizionalmente
considerata un caso particolare, dal momento che in essa si attacca
la persona e non la tesi sostenuta, consisterebbe nel fatto che
l’attacco alla persona è pervasivo e anticipato: esso si verifica
prima e fuori della discussione vera e propria; è una mossa
preventiva, una strategia che mira a demolire i presunti rivali
prima che possano muovere all’attacco, o per giustificare il rifiuto
di entrare in discussione con l’interlocutore.
La fallacia di avvelenamento del pozzo, che non è una
fallacia in senso stretto, rivela pienamente la natura violenta e
intimidatoria posseduta anche dalle altre più comuni fallacie, per
quanto in una forma più attenuata o mascherata. La calunnia
ottiene lo stesso effetto: proiettare nell’immaginario collettivo una
rappresentazione del tutto negativa di una persona, in modo tale
che il giudizio su ogni sua parola o azione sarà inesorabilmente di
condanna. L’intenzione ostile, il carattere di strategia di
costruzione del nemico di tutti e di demolizione della sua figura è
presente in tutte le fallacie. L’obiettivo non è la verità, ma la
vittoria ottenuta a qualsiasi prezzo. Le capriole della retorica e gli
abusi dell’argomentazione servono allo stesso scopo: far passare
come un mostro la vittima di turno agli occhi di tutti. Il giudizio
preventivo negativo deve essere unanime, definitivo, indiscutibile.
L’attacco mira a far credere che l’attaccato sia depositario di una
colpa inespiabile e che debba quindi essere isolato, espulso e, se
necessario, ucciso. Tra l’avvelenamento del pozzo, il killeraggio
preventivo, la macchina del fango che è diventata gran parte della
stampa, e l’attacco con l’arma bianca o all’arma da fuoco, la
differenza è nella forma, non nella sostanza, nei tempi e nei modi,
non nel risultato. L’avvelenamento del pozzo è anche il
qualunquismo etico con cui si mettono tutti sullo stesso piano,
facendo di ogni erba un fascio. Se tutti hanno torto, se sono tutti
furfanti, allora non c’è scampo per nessuno e la verità è
introvabile. Cantù cita un intervento di Roberto Saviano sul tema,
che illustra come nichilismo etico il qualunquismo assolutorio
professato da certa stampa collusa con la mafia: «Sostenere che
niente è pulito, scrive Saviano, tutto è sporco, tutti si è uguali nei
vizi e negli interessi. Dunque nessuno può fare la morale. La
macchina del fango vive di questo desiderio di mettere tutti sullo
stesso piano: tutti corrotti, tutti viziosi. Un meccanismo che si
riesce a bloccare quando non si contrappongono più santi a
demoni, ma piuttosto quando si dimostra che pur nella
contraddizione che è degli esseri umani, gli interessi sono diversi,
le azioni sono diverse. E anche le debolezze sono diverse» (p.
154). Esercitarsi a individuare le fallacie è indispensabile se si
respinge il nichilismo morale, se si è convinti che la posta in gioco
non è la demolizione dell’avversario, ma il riconoscimento della
verità. L’individuazione di una fallacia, a sua volta, non avrà
come obiettivo quello di togliere la parola all’interlocutore o di
delegittimarlo, ma solo quello di pretendere una spiegazione più
soddisfacente: qui sta «la differenza tra attaccare il valore di una
persona e attaccare il valore di un suo argomento» (p. 157).
Roberta De Monticelli, La questione morale, Raffaello Cortina
editore, Milano 2010.
All’origine di questo audace saggio di Roberta De Monticelli c’è
l’esigenza di misurarsi con il dato di fatto incontestabile di
un’illegalità diffusa nel nostro paese, di una «pratica endemica
degli scambi di favori, a tutti i livelli: cariche pubbliche a figli e
amanti, lo scambio di carriere politiche contro favori privati, i
concorsi pubblici (quelli universitari, per esempio) decisi sulla
base di accordi fra gruppi di pressione o cordate – quando non
addirittura di parentele – e non su quella del merito, lo
sfruttamento di risorse pubbliche a vantaggio di interessi privati, il
familismo, il clientelismo, le caste, la diffusa mafiosità dei
comportamenti, la vera e propria penetrazione delle mafie in tutto
il tessuto economico e nelle istituzioni, la perdita stessa del senso
delle istituzioni da parte dei governanti» (pp. 11-12).
Coraggiosamente impietosa è la diagnosi che l’autrice, docente
universitario, fa del mondo delle istituzioni e della politica, dove
da anni la legislazione è una macchina per produrre decreti a
favore di interessi di singoli politici o allo scopo di assicurare
l’impunità dei prepotenti. E che dire di una maggioranza di italiani
che sostiene questa permanente negazione di ogni senso di
giustizia, del bene collettivo, del senso dello stato, del valore
dell’onestà e del merito? Non possiamo credere, tuttavia, che la
carriera di Roberta de Monticelli in ambito accademico sia
progredita con le modalità e le strategie mafiose che lei stessa
lamenta, quindi abbiamo almeno un’eccezione della regola
perversa da lei denunciata. Si sa che la generalizzazione è un
artificio retorico per rendere più incisiva la protesta nei confronti
dell’indegnità.
All’origine della disinvolta e sistematica illegalità presente
nella società italiana De Monticelli vede il generale scetticismo
etico diffuso nel pensiero filosofico del Novecento: la convinzione
che non esista verità alcuna, che vi siano solo interpretazioni e non
fatti, che il giudizio di valore non sia né vero né falso, a differenza
del giudizio fattuale. Aggiungiamo una certa psicologia morale
preoccupata più di spiegare i comportamenti che di rafforzare il
senso di responsabilità dell’agente morale. L’indifferenza per i
valori morali avrebbe le sue radici nella stessa filosofia, che con le
ermeneutiche di vario conio rifugge da ogni nozione di verità
oggettiva e di presupposto comune e ineludibile. L’indulgenza di
ciascuno verso tutti è ricambiata e sostenuta da una complicità
così spudorata e insensata, che fa perdere il senso della vita
collettiva, inabissando il paese in uno sfrenato, cinico e beffardo
individualismo. L’arroganza estrema si manifesta nell’esibizione
dell’immoralità e il disgusto estremo è provocato da manigoldi
istituzionali che si vantano pubblicamente dei loro crimini, soprusi
e indecenze, nel circuito perverso e suicida di una demagogica
chiamata di correità in ogni settore della vita civile. De Monticelli
vede nei Ricordi del Guicciardini il paradigma del
giustificazionismo e dell’immoralismo programmatico che da
secoli regnano nel nostro paese. In una prosa leggiadra e posata,
nitida e imperturbabile, Guicciardini snocciola precetti di
immoralità come fossero perle di suprema saggezza, mentre «sono
la feccia precettistica della meschinità, del servilismo, della
doppiezza, del familismo, della diffidenza e della furbizia, belle
virtù ostentate con un piacere che sta fra il sarcasmo e la superiore
albagia dell’esprit fort, del disincantato conoscitore dell’umano e
del politico» (p. 34). Lo scetticismo metafisico, logico e pratico è
volto a giustificare la divinizzazione del tornaconto e del
disprezzo del prossimo: sospetto, paura e vendetta sono i soli
moventi dell’azione individuale? Francesco De Sanctis nella sua
Storia della letteratura italiana aveva definito i Ricordi «la
corruttela italiana codificata e innalzata a regola di vita» (p. 35).
Giacomo Leopardi nel suo famoso Discorso sopra lo stato
presente dei costumi degl’Italiani (1824) aveva individuato nel
disincanto, nel “disprezzo e l’intimo sentimento della vanità della
vita” l’origine della corruzione dei costumi degli italiani. Dalla
disperazione e dall’indifferenza morale deriva la disposizione di
«un pieno e continuo cinismo d’animo, di pensiero, di carattere, di
costumi, d’opinione, di parole e d’azioni […dove] il più savio
partito è quello di ridere indistintamente d’ogni cosa e di ognuno,
incominciando da se medesimo» (p. 40). Da tale disposizione non
deriva che denigrazione e derisione per il prossimo, unite alla
disistima di se stessi? Infatti, scrive Leopardi, «un uomo senza
amor proprio, al contrario di quel che volgarmente si dice, è
impossibile che sia giusto, onesto e virtuoso di carattere,
d’inclinazioni, costumi e pensieri, se non d’azioni» (p. 41).
Un abisso separa l’analisi di Leopardi dalla precettistica di
Guicciardini. Lapidariamente De Monticelli osserva che
l’interesse egoistico convive benissimo col servilismo e la
sudditanza, non l’autonomia individuale e il senso di dignità
personale: «Il “particulare” è l’individuo senza amor proprio» (p.
43). Leopardi vede il nesso oggettivo tra amor proprio e coscienza
morale; senza rispetto di se stessi non può esservi rispetto del
prossimo, della comunità di appartenenza, dell’intera umanità. In
Italia manca una classe dirigente responsabile e capace di progetti
ambiziosi, in grado di alimentare negli individui l’emulazione e il
giusto orgoglio di appartenere alla nazione italiana; e manca in
generale un’etica pubblica. Nulla possono eroici martiri isolati,
affogati nella melma dell’opportunistica rassegnazione al
malcostume, a riscattare o compensare la totale mancanza di
mores nazionali. Fabrizio Corona, il fotografo ricattatore, è
l’esemplare paradigmatico dell’immoralismo diffuso e approvato
dalla grande massa di italici. La parola d’ordine assunta a norma
del cinismo trionfante e autocompiaciuto è una dichiarazione dello
stesso fotografo: «Vedo l’affare, non la persona…prendo al
popolo per dare a me stesso….una nuova forma di Robin Hood»
(pp. 45-46). Indifferenza al crimine e ostentazione del crimine,
senza più neppure l’ipocrisia che raccomanda il Guicciardini: c’è
qualcosa di più osceno? La prassi consolidata di impiegare risorse
pubbliche a vantaggio di interessi particolari non ha bisogno di
nascondersi, ma può tranquillamente apparire alla luce del sole,
può divenire del tutto trasparente, ma «oggi, avverte l’autrice, non
è il nascondersi ma proprio l’apparire, come la lettera rubata di
Poe, che non si vede perché si vede troppo», così che «la
manifestazione universale è il modo nuovo della non-trasparenza»
(p. 50). A forza di apparire, con la ripetizione, matura
l’indifferenza a ogni prova del contrario. «Se basta apparire, tutto
appare invano: l’apparire non ha niente a che vedere con l’essere,
non lo vela né lo svela, non lo manifesta né lo cela. Non c’è alcun
essere dietro l’apparire, alcuna realtà, alcun modo in cui le cose
stanno in verità» (p. 51).
Quale prova del cinismo istituzionale della classe politica
italiana l’autrice cita l’affermazione sprezzante con cui Giulio
Andreotti liquidò l’assassinio di Giorgio Ambrosoli, ad opera
della mafia, del bancarottiere Michele Sindona: «Se l’è andata
cercando» (p. 52), le stesse parole usate dal mafioso che per
telefono aveva minacciato Ambrosoli. Il dovere morale, ciò che
ciascuno deve a tutti, è espressione di una personalità matura e
adulta. Ma come sottrarsi alla diffusa tendenza ad assecondare il
privilegio, ad avvalersi dell’eccezione e del favoritismo, da una
parte e dall’altra? Non v’è regola o criterio di giustezza morale
dell’azione individuale, tranne l’interesse privato o della propria
parentela. Il cantante Vasco Rossi, dimettendosi con furbizia da
star per allungare una carriera ormai pluridecennale, si è rivolto ai
fan con una regola di vita: “Fate quel che volete, ma fatelo bene”
(intervista televisiva, agosto 2011). Come dire: non importa che
cosa fate e come, l’importante è che vi giovi sul piano del vostro
piacere, interesse, inclinazione, carriera. Vasco Rossi: il guru
immoralista, che consiglia gli italiani di fare quel che già fanno, di
credere in ciò in cui credono già da secoli.
Il dilagare delle mafie è solo la conseguenza della mancanza
di etica pubblica; infatti, se il merito non può essere fatto valere
come argomento sufficiente, le persone che non accettano di
buttare al vento anni di formazione e di sacrifici per raggiungere
una certa meta professionale dovranno cercarsi una consorteria, se
escludono l’ipotesi di emigrare. Se il merito non ha peso decisivo,
contano l’appartenenza e la fedeltà a un uomo o a un’associazione
di potere. Per questo la pretesa di coloro che ostentano il loro
“essersi fatti da sé” suona sempre insincera, provocatoria,
depistante. L’autrice porta come esempio di mafiosità congenita le
corporazioni accademiche. Non è l’autocefalia dell’Università – la
sua autonomia assoluta di istituzione cha fa capo solo a se stessa −
che giustifica queste pratiche con i conseguenti conflitti di
interesse, giacché l’autocefalia ha senso solo se i comportamenti
dell’istituzione sono rigorosamente ispirati a norme inderogabili la
cui applicazione riflette la volontà di prescindere dall’interesse
privato per dare al merito la dignità di unico argomento e valore
decisivo nei risultati concorsuali. Tuttavia, chi si richiama al
merito, alla giustizia, all’interesse collettivo, è tacciato di
moralismo e di giustizialismo. Si getta fango su tutti, con la
pretesa che la chiamata universale di correità giustifichi e assolva
il reo. Omertà, servilismo, viltà e prepotenza vanno a braccetto nel
sudiciume imbellettato della società italiana. Nessuno vuole la
verità, nessuno chiede di dimostrare una qualsiasi asserzione;
secondo l’immoralismo dominante, si pretende solo che giovi a
qualcuno: a chi giova?, è la domanda espressione inequivocabile
di una «mancata relazione alla verità» (p. 62).
Alcuni esponenti di spicco della Chiesa cattolica si
dimostrano tolleranti verso l’immoralismo corallifero, la diffusa
convinzione che ciascun individuo è responsabile da ultimo per
ciò che fa. Le parole del cardinale Angelo Scola, riportate da De
Monticelli, espressione della crociata di CL contro i moralisti –
«diventa allora necessario liberare la categoria della testimonianza
dalla pesante ipoteca moralista che la opprime, riducendola, per lo
più, alla coerenza di un soggetto ultimamente autoreferenziale» –
sono un chiaro segno dell’appiattimento e adeguazione alla
generale richiesta di impunità per i crimini che accompagnano
l’esercizio del potere politico. “Moralismo” e “individualismo”
sono divenuti, anche per certi esponenti del clero, insulti che
nascondono il sostanziale «rifiuto di onorare la solitudine della
coscienza personale e la responsabilità ultima che ciascuno porta
di se stesso» (p. 66). Che cos’è il “soggetto ultimamente
autoreferenziale” se non l’individuo dotato di libero arbitrio? Del
resto, la tesi della creaturalità dell’uomo e il peccato originale non
vanno felicemente d’accordo con le nozioni di coscienza critica e
di coerenza morale. La libertà di coscienza peraltro è stata
riconosciuta dal Concilio Vaticano II (Dignitatis humanae),
ricorda l’autrice, ma l’affermazione della maturità morale
dell’uomo, della sua capacità di autodeterminazione non può
certamente spingersi troppo oltre, senza rendere l’uomo così
autosufficiente da non aver più bisogno della salvezza ad opera
del Cristo. L’opposizione tra una scelta fondata sull’autorità e una
maturata nell’intimità della propria coscienza – avanzata come
argomento da De Monticelli – rischia di risultare schematica e di
non tenere conto della posizione intermedia degli esseri umani,
che sono capaci di libertà non originariamente e a priori, ma solo a
certe condizioni e in seguito a un processo di maturazione che, dal
punto di vista teologico della Chiesa, non può prescindere dal
percorso sacramentale, dalla grazia e dalla continua rinascita sul
piano morale. La libertà insomma non può essere né si può
concepire come una condizione perfetta e originaria, come un
presupposto assoluto. Tuttavia non può essere messa in
discussione o negata da quanti potrebbero trarre vantaggi di potere
dal suo misconoscimento. Quindi la presunzione di libertà, come
la presunzione di innocenza, è un postulato indispensabile a difesa
della fragilità delle persone e a contenimento della cupidigia di
asservimento. Si dovrà consentire con De Monticelli su questo
punto: la capacità di autodeterminazione degli individui è fuori
discussione, giacché potrebbe essere negata solo da quanti hanno
qualche interesse a contestarla. Chi nega l’autonomia morale degli
esseri umani la nega anche a se stesso e delegittima quindi la
propria posizione, togliendo ogni giustificazione al privilegio
istituzionale di cui eventualmente gode.
Il cardinale Ratzinger in un discorso del 2005 suggerisce di
capovolgere l’assioma degli illuministi e riconoscere che «anche
chi non riesce a trovare la via dell’accettazione di Dio dovrebbe
comunque cercare di vivere e indirizzare la sua vita “veluti si deus
daretur”». È un passo che, secondo De Monticelli, illustra il
nichilismo morale che ha infettato anche la Chiesa. La Chiesa
proclama i non credenti incompetenti morali e chiede allo stato di
istituire norme che tutelino questa incompetenza. Norme dettate
dalla Chiesa, perché se Dio non c’è, Dio è la stessa Chiesa. Di qui
il nichilismo metafisico: «Quella stessa auto-deificazione che
veniva
imputata
all’uomo
moderno
(per
via
dell’autodeterminazione morale) ora la si rivendica sottobanco,
tentando di subordinare lo Stato e le sue leggi a una confessione
religiosa» (p. 77). Questo è il senso dell’invito, raccolto da certi
devoti sostanzialmente atei: bisogna fare come se Dio ci fosse.
La dignità e la libertà degli esseri umani sono possibili solo
in virtù dell’autodeterminazione, che consiste essenzialmente
nell’esercizio della ragione, di una facoltà razionale che è
appannaggio universale di tutti gli esseri umani. L’etica razionale
si fonda su valori condivisi. Senza logica non può esserci etica,
per questo è riprovevole chi fa asserzioni senza renderne conto o
fa affermazioni prive di fondamento o riscontro. De Monticelli
illustra efficacemente la circolarità di logica ed etica. L’esercizio
della filosofia non è che un rendere ragione, socraticamente, di
ogni cosa, prescindendo completamente e inesorabilmente da ogni
principio di autorità e da qualsiasi soggezione a fattori extra-logici
o extra-cognitivi. La ricerca socratica della verità non risparmia
nulla e nessuno. La filosofia è pedagogia, educazione della
persona a rendere conto delle proprie asserzioni con l’esercizio
rigoroso del pensiero. Violento e antisociale è sia chi agisce
ingiustamente violando le leggi, sia chi fa asserzioni eludendo
ogni dovere di chiarezza e giustificazione di quanto è asserito. Si
sa, il nichilismo etico è stato anche la conseguenza del rifiuto di
riconoscere l’esistenza di una verità oggettiva: quanta ermeneutica
nella seconda metà del Novecento ha sottilmente disquisito per
convincere (senza realmente dimostrare) che la verità non esiste,
che non ci sono fatti o evidenze di sorta, ma solo interpretazioni e
punti di vista, aprendo così la strada al più rassegnato e passivo
scetticismo, alla giustificazione perfetta di ogni manifestazione di
immoralità, al sociologismo giustificazionista? Chi identifica la
verità con un insieme di credenze pecca di idolatria; all’opposto
chi nega l’esistenza della verità spiana la strada a una pratica
sofistica della filosofia, toglie ogni legittimità al giudizio di valore
e apre il varco al relativismo qualunquista. «Chi usa senza
spiegazioni parole che hanno mille significati o nessuno, chi
afferma: “la verità non esiste” (e non si accorge di fare
un’asserzione che pretende di essere vera)» manca all’impegno
inderogabile di onorare la verità, «cercando e offrendo evidenza
per quello che si afferma» (p. 99). L’impegno a rendere conto
delle nostre convinzioni e azioni è un dovere che discende dalla
stessa ragione. La conoscenza di ciò che è giusto non è sufficiente
per attuarlo, ma è certamente necessaria. Rimane aperto il
problema della fondazione dei giudizi di valore. Non sempre è
possibile articolare una giustificazione completa e inappuntabile
dei giudizi formulati nelle più diverse circostanze. La distinzione
apparentemente razionale fatta valere dalla filosofia del
linguaggio del Novecento tra giudizi di valore e giudizi di fatto
può essere interpretata come una manifestazione della deriva
relativista subita dalla teoria della conoscenza e dall’etica. Eppure
è stata contestata da Putnam, che De Monticelli cita
opportunamente riportando l’esempio di giudizio “Nerone era
crudele”: è questo un giudizio di fatto o di valore?
De Monticelli prende posizione contro quella che lei chiama
“coscienza sprezzante”, una figura della filosofia del Novecento
fondata sulla prassi del sospetto per ciò che appare e del disprezzo
per ciò che è, quasi che l’atteggiamento scientifico implicasse la
negazione dei valori e la realtà in se stessa fosse priva di valore.
L’avalutatività della scienza come garanzia di oggettività ha
messo al bando i valori relegandoli nella sfera soggettiva. «L’idea
che la realtà in sé è priva di valori, che i valori li proiettiamo noi
nelle cose, è diventata una specie di ovvietà: ma è una falsa
ovvietà» (p. 113). La prevalenza del più forte, che gli antichi
avvertivano come ingiusta sostenendo la verità di quel giudizio, è
messa fuori questione dai moderni i quali, avendo escluso che i
giudizi di valore possano essere veri o falsi, si illudono di poter
formulare giudizi realistici avalutativi come se fossero asettici e
oggettivi, mentre al contrario riflettono il deprezzamento e il
disprezzo per la realtà sottoposta a giudizio. Il relativismo
ermeneutico, a differenza del positivismo scientista, nega
l’esistenza di una verità in se stessa, si mostra pluralista e
tollerante, nell’intento di misurarsi in modo indolore con il
pluralismo culturale e valoriale delle società occidentali. La
dottrina della verità che la Chiesa visibile rappresenta, condivide
con questo relativismo pluralista l’idea che «in materia di valore
non ci sia un modo in cui le cose stanno, indipendentemente da
quello che noi crediamo o sappiamo» (p. 119). Il vero e il certo
sono fatti coincidere e si nega che possa esistere una verità che
ancora nessuno conosce. Il papa negherà che ci siano ragioni cui
l’individuo razionale può accedere, a prescindere dalla sua fede.
Negando che esista una verità in sé, il relativista giustifica
l’affermazione violenta e spregiudicata del più forte e ne proclama
la vittoria. A sua volta il fondamentalista, non riconoscendo
alcuna competenza morale al non credente, attribuirà a se stesso la
facoltà di valutare e decidere per conto di tutti. L’esercizio
autonomo della ragione non conduce al relativismo e allo
scetticismo, ma preserva da queste derive; e la soggezione
all’autorità in materia di valore nega la dignità degli esseri umani,
senza offrire loro alcuna garanzia di possedere la verità. Negare a
vario titolo che sia possibile una ragion pratica in un mondo
plurale, significa in ogni caso estromettere l’ambito dei valori
dalla sfera della ricerca razionale e della scienza, riducendolo a un
campo di battaglia dove si fronteggiano volontà contrapposte e
divergenti. La domanda non è più: che cosa vale in se stesso?,
bensì: quale volontà prevarrà? È dunque una mera questione di
forza, “in uno qualunque dei suoi modi – la violenza, l’astuzia,
l’opportunismo, le consorterie, le clientele, la menzogna, oppure
invece il tatticismo politicante, il piccolo machiavellismo
endemico e servile della politica italiana” (p. 120).
La necessità di un accordo tra il pluralismo degli
orientamenti in una società democratica e aperta, e il presupposto
razionale dell’esistenza di una verità che bisogna cercare con un
percorso argomentativo, evitando sia il relativismo disfattista sia il
fondamentalismo autoritario (entrambi propensi ad accettare
soluzioni decisioniste dei problemi), impone il riconoscimento
dell’esistenza oggettiva dei valori e della loro gerarchizzazione
interna. De Monticelli chiama valori «una varietà infinita di
qualità caratterizzate da due tratti: la polarità (positiva o negativa)
e il grado comparativo (inferiore-superiore)» (p. 137). Senza
valori non ci chiederemmo ragione di cose vere, reali, che non
sono il risultato della distorsione proiettiva del soggetto:
l’ingiustizia, l’ignoranza, l’errore. Se il male non fosse una realtà
indubitabile, etica e diritto avrebbero ragion d’essere? I valori
sono qualcosa di oggettivo, tali che essi costituiscono la persona,
non il contrario. L’idea che i valori siano gusti personali, che
ciascuno è libero di preferire nella massima libertà, non assicura
alcuna civile convivenza, alcun rispetto della dignità umana;
dietro un’apparente tolleranza benevola, il relativismo nasconde la
negazione di ogni valore che non sia sostenuto da una forza
sufficiente e prepara l’irruzione dell’arbitrio assoluto nei rapporti
umani e tra stati, insinua una generalizzazione della logica della
guerra, si lascia facilmente ricondurre «all’idea già sofistica che
giusta è per definizione la volontà del più forte» (p. 150).
Una ragion pratica in un mondo plurale deve essere
possibile. Secondo De Monticelli se per etica non si intende la
disciplina del dovuto da ciascuno a tutti, non è possibile sfuggire
alle due derive del fondamentalismo e dello scetticismo. La prima
formula stabilisce che ciò che è dovuto da ciascuno a tutti «è lo
stesso diritto a vivere e fiorire secondo il proprio ethos, che si
chiede per sé» (p. 153). Tale formula contiene il riconoscimento
della libertà e della pari dignità di tutti gli esseri umani. Ma il
principio universalistico dell’etica è stato concepito e si è
affermato all’interno di un ethos, quello occidentale, lo stesso in
cui la filosofia compara i diversi ethe del pianeta. L’universalità, il
riferimento a tutti gli individui umani, sconta il paradosso di
provenire da un ethos particolare che si propone quale punto di
vista esterno e superiore a tutti gli ethe reali e possibili. Si può (e
forse si deve) presupporre un criterio trascendentale per
giustificare il principio universalistico, ma in linea di principio è
sempre possibile contestare il riferimento a tutti gli uomini come a
soggetti “eguali in dignità e diritti”. Un principio è universale
dovrebbe essere accettato da ciascuno e da tutti in virtù di un
argomento fattuale o logico, ma nel nostro caso non sembra
esservi alcuna via, né logica, né fattuale, che possa condurre
all’accettazione incondizionata di tale principio, talché è possibile
sostenere, sulla base della realtà concretamente visibile, che gli
esseri umani non sono e non possono essere soggetti “eguali in
dignità e diritti”. Se dobbiamo fare esercizio di ragione in misura
radicale, allora anche il principio universalistico ha bisogno di
essere fondato. E su che cosa si fonda la concezione degli esseri
umani come soggetti “eguali in dignità e diritti”? Se, ad esempio,
si fondasse tale universalità sull’aspirazione di ogni ethos a valere
universalmente, si coglierebbe alla radice il conflitto che oppone
gli ethe del nostro pianeta. Si dovrà distinguere tra prescrizioni
specifiche che sono compatibili con il principio universalistico e
direttive che non lo sono: che cosa si farà delle seconde? Si potrà
persuadere a revocarle semplicemente in base ad argomenti
razionali? Infatti riconoscere a ciascuno “il diritto a vivere e
fiorire secondo il proprio ethos, che si chiede per sé”, dovrebbe
impegnare al rispetto integrale dell’ethos altrui, con le molte
riserve del caso. Qui De Monticelli avverte che ciò che si
riconosce a ciascuno, l’ethos di ciascuno, il suum, ciò che si deve
a ciascuno, va inteso entro i limiti di un altro principio
universalistico, quello della pari dignità e dunque dei pari diritti.
Devo a ciascuno ciò che chiedo per me, ma con limiti precisi: ad
esempio, non posso pretendere che un altro diventi mio complice
in un crimine promettendogli di restituirgli il favore, dal momento
che in tal modo nego il principio di parità di diritti di tutti coloro
che il crimine calpesta direttamente o indirettamente (p. 155).
Politica ed etica ritornano così a ricongiungersi. La ragion pratica
è un antidoto al servilismo, alla passività, all’autoritarismo, al
dilagare della prepotenza e prevaricazione di ogni principio,
compreso quello della libertà e pari dignità degli esseri umani, che
devono essere riconosciuti eguali perché liberi e liberi perché
eguali. Il riconoscimento dell’eguaglianza non limita, ma esalta la
libertà di ciascuno. Se togliamo il valore della persona umana
come tale, togliamo la ragion d’essere delle democrazie, che
potrebbero prestare il fianco ad accuse di inefficienza,
conflittualità permanente, immobilismo. Ma le giustifica la
protezione di spazi di argomentazione e discussione, in cui
ciascuno è chiamato a rendere conto delle proprie azioni e
asserzioni. L’autonomia morale consiste nel fatto che l’individuo
ha la competenza morale ultima ed è quindi autorizzato a decidere
«riguardo all’uso della libertà che lo costituisce (quella libertà
riconosciuta come caratteristica della nostra specie ben prima che
fosse riconosciuto e giuridicamente protetto il diritto di usarla)»
(p. 175). Alcuni polemicamente mescolano l’autonomia con
l’arbitrio, ma sbagliando grossolanamente, perché l’autonomia
non è l’invenzione arbitraria delle proprie leggi, ma la capacità di
esercitare la ragione per riconoscerne la giustezza. La Chiesa è
così ostile all’individualismo etico da revocare il principio di
libertà di coscienza e negare il diritto di autodeterminazione degli
individui riguardo alla chiusura della vita, ma al tempo stesso
ribadisce senza sosta il principio della dignità della persona. Quale
dignità della persona, si chiede De Monticelli, che non implichi il
riconoscimento che l’individuo esiste prima dello stato e di ogni
altra comunità, mentre deve la propria dignità esattamente alla
capacità di autodeterminazione razionale, che consiste nel non
obbedire a nessuna legge esterna tranne che a quelle alle quali si è
dato il proprio assenso? Riconoscendo senza equivoci il valore
auto-sussistente della persona, lo stesso Antonio Rosmini non
insegnava che alle persone deve essere garantita la libertà di
vivere secondo il loro proprio principio eudemologico,
realizzando la felicità e la perfezione cui ciascuno aspira?
Umberto Eco, Costruire il nemico e altri scritti occasionali,
Bompiani, Milano 2011
Il relativismo culturale rappresenta l’estremizzazione della
necessità di riconoscere la diversità delle altre culture. Al tempo
stesso però noi occidentali siamo fieri della nostra indiscussa
superiorità sul piano politico, per l’organizzazione democratica, la
separazione tra stato e chiesa, ecc. Eco cita un libro di Giovanni
Jervis, Contro il relativismo, (2005), in cui il noto psichiatra,
deceduto nel 2009, denunciava le conseguenze nefaste del
relativismo: se ogni forma di società va rispettata e giustificata, si
assicurano l’immobilismo e la ghettizzazione dei popoli (p. 56).
Eco riconosce quindi la deriva inaccettabile rappresentata dalla
difesa a oltranza del relativismo culturale, ma poi non condivide
l’allarme destato in papa Ratzinger dal pluralismo etico, allarme
che sarebbe determinato dalla necessità di riconoscere una verità
assoluta. Al tempo stesso però Eco rigetta la concezione
strumentale e convenzionalistica della verità contenuta nella tesi
di origine nietzscheana per cui non vi sono fatti ma solo
interpretazioni. A suo modo Eco è un antirelativista se obietta al
relativismo: 1) se ci fossero solo interpretazioni, allora di che cosa
sarebbero interpretazioni le interpretazioni? 2) se le interpretazioni
s’interpretassero tra loro, dovrà pur esserci stato un oggetto o un
fatto che in esordio ha indotto all’interpretazione; 3) anche se
l’essere non fosse definibile, il problema della verità si
sposterebbe dall’oggetto al soggetto della conoscenza: anche
ammettendo che la verità sia un discorso metaforico, non ha
un’esistenza metaforica colui che pronuncia quel discorso. In
realtà, ci sono fatti e forze che sono fuori di noi e non sono
riconducibili a interpretazioni: di questo Eco non dubita.
L’assoluto in sé è inverificabile, dal momento che non è pensabile,
se consiste nell’identità di soggetto e oggetto. La dualità di
soggetto e oggetto è insuperabile, quindi l’assoluto inteso come
unità di soggetto e oggetto non può essere pensato: se lo fosse,
l’assoluto sarebbe solo oggetto. Quindi possiamo dubitare
dell’esistenza dell’assoluto o quanto meno della sua attingibilità,
ma esistono pur sempre forze naturali e fatti di assoluta evidenza
che contraddicono certe nostre interpretazioni. L’esistenza di una
realtà indipendente dal soggetto è un postulato necessario, ma può
essere asserita solo da un soggetto. La sola oggettività che
possiamo verificare è quella di proposizioni sulla cui verità tutti
sono d’accordo. Ma la verità assoluta trascende i soggetti che ne
presuppongono l’esistenza senza poterla attingere. L’assoluto
inteso come totalità di soggetto/oggetto include il soggetto che si
sforza di concepirlo senza riuscirvi. L’assoluto in senso
ontologico è inoggettivabile, ma è il fondamento dell’assoluto in
senso semantico, che invece è oggettivabile, giacché il significato
di “assoluto” si rende comprensibile unicamente in rapporto a
“relativo”. Assoluto e relativo sono termini relativi, come sopra e
sotto, nel senso che rinviano l’uno all’altro. Ma al tempo stesso il
rapporto semantico assoluto/relativo è antisimmetrico, talché
possiamo concepire la possibilità dell’esistenza dell’assoluto
indipendentemente dal relativo, ma non viceversa. E qui ci
poniamo sul piano ontologico. Perciò non possiamo dire, come fa
Eco, che l’assoluto non è pensabile, dovremmo anzi ammettere
che non possiamo non pensarlo, perché lo impone la necessità di
pensare il relativo in quanto relativo. Esseri pensanti che fanno
parte del tutto non possono evidentemente conoscere direttamente
il tutto in quanto tutto, ma devono poterlo concepire, devono
presupporne il concetto. Essi quindi lo concepiscono, anche se
non possono conoscerlo direttamente; devono ammettere che c’è
un assoluto, pur non avendo la possibilità di raggiungerlo. Il
paradosso ontologico dell’assoluto è nella doppia necessità che ci
sia e che non sia attingibile. Il risultato del paradosso è un
compromesso: la possibilità di concepire l’assoluto e
l’impossibilità di farne esperienza. Il tipo di esistenza che si deve
riconoscere all’assoluto non è solo noetica, altrimenti sarebbe
come dire che l’assoluto esiste in quanto è pensato, mentre
ontologicamente l’assoluto è per definizione ciò che sussiste
indipendentemente da ogni rapporto con il soggetto che lo pensa.
Il carattere antisimmetrico della relazione assoluto/relativo si
giustifica solo con la distinzione tra un assoluto semantico (per cui
assoluto e relativo devono essere pensati come correlati) e un
assoluto ontologico (per cui l’assoluto deve potere esistere ed
essere pensato come indipendente dalla relazione con il non
assoluto).
Dobbiamo
prendere
atto
che
ogni
scetticismo/relativismo assoluto è auto-contraddittorio, giacché
asserisce pur sempre l’esistenza di un assoluto, nel momento
stesso in cui nega ogni assoluto. “Nulla è vero”, o “la verità non
esiste” hanno senso solo se si presuppone l’esistenza della verità.
La verità vince su tutto, come già aveva osservato Agostino
d’Ippona. Se nulla è vero, è vero che nulla è vero; se non è vero
che nulla è vero, qualcosa è vero: sembra così confermata in
entrambi i casi l’esistenza di una verità in se stessa. Questo
impone la coesistenza armonica dei relativi in rapporto al
medesimo assoluto. Quando un sistema culturale rinnega il
proprio carattere relativo e si erge quindi ad assoluto, fa torto alla
verità oltre che violenza agli altri sistemi. Quando ciò che è
parziale cerca di prevalere come totalità genera una competizione
distruttiva e una distorsione del rapporto con l’assoluto.
L’assoluto si individualizza in un soggetto particolare nell’oblio
del vero assoluto, che viene così estromesso dalla Storia. La storia
hegelianamente intesa non è il processo di autorivelazione
dell’assoluto, bensì la sequela dei tradimenti dell’assoluto, di cui è
protagonista di volta in volta chi esce momentaneamente
vittorioso da uno scontro. L’assolutizzazione della vittoria
particolare in una lotta che rimane comunque aperta a future
sconfitte, come la storia di fatto dimostra, è in sostanza una
negazione dell’autentico assoluto il quale, per definizione, è
ontologicamente indipendente da qualsiasi rapporto con il relativo
– un relativo che tuttavia è tale solo in quanto fa riferimento
all’assoluto. La guerra di conquista è la manifestazione più
evidente della confusione tra l’assoluto semantico e l’assoluto
ontologico. Il riconoscimento dell’altro come relativo e di tutti i
relativi in rapporto all’assoluto in sé presuppone una coscienza di
tipo superiore, verso la quale l’umanità ha il dovere di
incamminarsi con la massima sollecitudine possibile.
Pavel A. Florenskij, Dialektika (1918-1922), trad. it., Stupore e
dialettica, di Claudia Zonghetti, a cura di Natalino Valentini,
Quodlibet, Macerata 2011.
Il pensiero è linguaggio e il linguaggio è pensiero: Florenskij
riconosce la loro inscindibile unità. Il compito del linguaggio in
generale è descrivere; la spiegazione è a suo avviso solo una
modalità descrittiva, spiegare significa descrivere in un
determinato modo, come fa la scienza, che si assume il compito di
spiegare i fatti che descrive. La scienza non potrebbe spiegare
qualcosa senza una descrizione di fondo, così che ogni
spiegazione è anche descrizione, anche se «una descrizione
particolare, di particolare densità, di profonda concentrazione, una
descrizione amorevolmente riflessiva» (p. 36). Tutto questo è
possibile attraverso il linguaggio, che è pensiero. La scienza è un
tipo particolare di linguaggio, caratterizzato da una particolare
densità. Se compito della scienza è quello di spiegare, nel senso di
fornire una descrizione simbolica o teoria molto più ampia e
profonda di qualsiasi descrizione del senso comune, la filosofia
non si pone al di sotto della scienza, ma sopra di essa; infatti la
filosofia è la sola in grado di aspirare a spiegare la realtà nel vero
senso della parola. La filosofia interpreta il significato più alto
della spiegazione, giacché «tende a una conoscenza totalmente
coerente e unitotale della realtà» (p. 37). La comprensione che
della vita ha il senso comune è priva di metodo, di coerenza, di
unità, di oggetto preciso. Il senso comune mescola tutti i punti di
vista, senza ordine, in modo arbitrario e volubile, offrendo un
risultato che si caratterizza per la sua indeterminatezza. La scienza
reagisce a questa assenza di ordine, a questa incoerenza,
delimitando una ben definita cerchia di oggetti, imbrigliando
l’attività dello scienziato, concentrando la sua attenzione e
proibendogli traslazioni da un campo all’altro. Tutto questo
comporta una scissione invalicabile tra i vari campi della scienza,
l’assenza di legame tra le scienze, sempre più specializzate. Non
esiste una scienza, ma molte scienze, che hanno in comune solo la
reciproca negazione, infatti ciascuna si presenta e si dichiara
incompatibile con gli oggetti di ogni altro campo disciplinare. Ma
la vita stessa a un certo punto manda in frantumi la teoria che
pretende di immobilizzarla costringendola entro l’artificio di un
costrutto teorico ritenuto immodificabile. Una scienza che vuole
sopravvivere dovrà allora aggiornarsi, modificarsi per tenere conto
dei nuovi eventi. Ma una volta eseguite le correzioni necessarie, la
scienza si chiude di nuovo nella pretesa di poter comprendere
l’intera vita. In realtà però la vita continua a mutare la scienza,
costretta a mutare anche radicalmente pur di seguire la vita stessa.
La storia della scienza diventa quindi una “rivoluzione
permanente”. Della scienza non rimane quasi nulla, tranne «la sua
esigenza di metodo, il suo esigere l’immutabilità e la limitatezza»
(p. 41). La scienza pretende di essere sempre uguale a se stessa,
anche se vediamo che la vita continua a scorrere come una
corrente inarrestabile che trascina con sé le costruzioni appena
terminate.
Considerando il caos della vita, la sua ricchezza disordinata,
si deve concludere che né le concezioni del senso comune, né le
scienze possono vantare una vera spiegazione della realtà, dal
momento che nella riflessione di Florenskij “spiegare” equivale a
fornire una descrizione esaustiva. Eppure l’esistenza della
filosofia dimostra che la vita può essere descritta. La filosofia va
oltre la rigidità mortifera della scienza e permette di conciliare la
coerenza con la completezza. Il Tempo, scrive, Florenskij,
smaschera la non verità della scienza; la filosofia dice di sì alla
vita e al tempo stesso elabora un pensiero vivo e vitale.
Riprendendo la leggenda riferita da Socrate nell’Eutifrone, per cui
Dedalo sarebbe stato il primo a scolpire statue con gli occhi aperti
e le gambe staccate – statue che quindi venivano legate perché
non fuggissero – Florenskij mostra come la dialettica alle sue
origini illustri la negazione della scienza da parte della filosofia: la
filosofia mette in questione qualsiasi proposizione, concetto,
presupposto, proprio perché essa consiste nella negazione
inesausta delle forme immobili, delle categorie immutabili, dei
dogmi presunti. Lo sforzo della filosofia protesa allo scioglimento
e superamento di ciò che sta fisso e immobile non ha altro nome
che Eros. «Nella contrapposizione del pensiero che “sta” fermo e
“immobile” col pensiero che “scappa e non vuol restare fermo
dove lo si pone”, c’è tutta l’ostilità tra Scienza e Filosofia» (p. 45).
L’opposizione di scienza e filosofia è la stessa che tra schiavitù e
libertà, morte e vita. La scienza, nemica della vita, pretende di
irrigidire, mummificare la vita stessa in schemi senza accorgersi
che la vita li travolge e li oltrepassa continuamente. La filosofia
nega questa negazione della vita rappresentata dalla scienza
stessa. La filosofia, il pensiero che cerca di inseguire la vita della
natura e ama entrare nei meandri delle passioni umane, non può
quindi sentirsi in una posizione di inferiorità rispetto alla scienza,
al contrario considera proprio compito quello di infrangere ogni
posizione teorica acquisita, ogni dogma consolidato tipico della
scienza. Florenskij non dice che l’opposizione tra filosofia e
scienza coincida con quella tra filosofi e scienziati; essa consiste
nell’opposizione originaria tra due metodi, come se la filosofia
avesse da sempre la funzione di mandare in frantumi le certezze e
gli schemi immobili della scienza, man mano che questi si
formano nel corso del tempo.
A differenza della scienza, opera di una élite, la filosofia è
per natura popolare e non si accontenta della descrizione
effettuata, essa mira a una compiutezza sempre maggiore, e
sceglie liberamente di volta in volta diversi punti di vista proprio
perché mobile come la vita. La filosofia si fa meditazione della
vita attraverso il linguaggio; essa non coincide con una sola
descrizione, ma consiste in una pluralità di descrizioni in
movimento. La filosofia è dramma; essa è la stessa dialettica, se
con questo termine intendiamo il movimento del pensiero che
cerca di raggiungere una concezione sempre più profonda. Solo la
filosofia dunque spiega veramente e autenticamente la realtà,
poiché solo il movimento della dialettica rappresenta la vera
coerenza rispetto alla mutevole e sterminata ricchezza della vita in
divenire. Solo la filosofia si conforma incessantemente all’oggetto
della conoscenza, perché solo la dialettica è «relazione viva con la
realtà» (p. 49). Il pensiero filosofico non è astratto, ma concreto e
sperimentale, giacché non si ferma ai simboli e non lavora su di
essi come la scienza, ma si serve dei simboli per penetrare la
realtà stessa. La scienza, sulla base di uno o pochi esperimenti,
costruisce uno schema e lo utilizza applicandolo meccanicamente
ai fenomeni; la filosofia non si accontenta di questo costrutto,
consapevole del fatto che nessuna risposta a una domanda può mai
essere la risposta ultima. La filosofia non nega, né respinge il
movimento della vita, al contrario vive in esso. La filosofia è
meraviglia che si rinnova con la vita stessa, il suo metodo è
stupore inesausto, mentre la scienza «pensa solo a consolidare
schemi e immagini che già più non turbano, ormai scontati, ormai
spenti» (p. 52).
Gli iniziatori della filosofia sono stati sempre consapevoli
che la dialettica è “stupore organizzato”, secondo l’espressione di
Florenskij, per questo l’educazione filosofica non mirava alla
trasmissione di teorie o schemi dogmatici, quanto invece alla
comprensione della vita nella sua mutevole varietà, nelle novità
che essa presenta a ogni istante. La filosofia ha sempre avuto,
secondo Florenskij, in quanto filosofia autentica, la capacità di
stupirsi e commuoversi dinanzi alla continua e inquieta creazione
della vita stessa. Rievocando la parole di Socrate nel Teeteto,
laddove sostiene che il filosofo in quanto tale è pieno di
meraviglia, Florenskij vede in Socrate il filosofo capostipite che,
con rinnovata ironia, si dichiara ignorante, giacché il vero sapere,
nel movimento dialettico, è ancora sempre da venire. Di qui la
tensione di un eros dialogico con cui «Socrate punta al cervello
per schiudere le sorgenti dello stupore affinché la realtà più
profonda possa presentarsi all’intelletto come una muta di
serpente, con una sensibilità rinnovata verso l’esistenza» (p. 55). E
tutti i filosofi successivi hanno visto nello stupore l’origine della
filosofia: «la sorgente della filosofia è un’uscita mistica da se
stessi, è l’estasi dell’aver raggiunto il prodigio, è esperienza
metapsicologica» (p. 57). Da Goethe a Schopenhauer, da Cartesio
a Kant, insomma presso tutti i pensatori è presente l’idea che ogni
grande pensiero nasce dal brivido della meraviglia. Anzi,
Florenskij avverte come il concetto di stupore sia presente tra i
filosofi indipendentemente dal loro orientamento. Cartesio,
analizzando le passioni dell’anima, avrebbe considerato sei stati
dell’anima come originari: ammirazione, amore, odio, desiderio,
gioia, tristezza. Ma la passione primigenia rimane l’ammirazione,
la prima di tutte le passioni secondo Cartesio. Stima e disprezzo,
ad esempio, sono forme di ammirazione, a seconda che
ammiriamo la grandezza o la piccolezza dell’oggetto stimato o
disprezzato. Dal disprezzo di se stessi può derivare l’umiltà; e così
via. Florenskij trova in Kant la considerazione più profonda sullo
stupore, che lo fa derivare dalla contemplazione di una finalità
oggettiva. L’impossibilità di conciliare una rappresentazione e la
regola da essa fornita con i principi già acquisiti, genera uno
stupore che si alterna al dubbio. Ma lo stupore si rinnova anche
quando il dubbio è superato. Florenskij riporta una citazione della
Critica del giudizio: «Ne consegue che l’ammirazione è un effetto
del tutto naturale delle finalità che osserviamo nell’essenza delle
cose (in quanto fenomeni) e che non può essere biasimata» (p.
66). Sulle orme di Kant Florenskij individua un nesso
fondamentale tra stupore, bellezza e perfezione. La finalità delle
cose in Kant non è che la bellezza, posta alla base di un giudizio
oggettivo e quindi rivelatrice di una certa perfezione della cosa
stessa.
L’apostolo Tommaso appare a Florenskij la figura simbolo
della filosofia. Tommaso non è scettico, ma pieno di stupore.
Tommaso, ricercatore di Verità, non chiede per negare o mettere
in dubbio, ma per rafforzare. A Tommaso si deve l’attestazione
della verità della resurrezione corporale del Cristo e l’attestazione
della verità dell’ascensione corporale di Maria, Madre di Dio. Con
la sua esigenza di attestare, certificare, verificare, Tommaso
diventa un campione della contemplazione spirituale, lasciando la
sua fede quale grande eredità. Giovanni evangelista ha visto in
Tommaso, scrive Florenskij, un principio a sé affine: «La
contemplazione dello Spirito si fonda sulla prova, la prova nasce
dallo stupore» (p. 69). E dallo stupore di Tommaso nasce anche la
sua fede. Lo stupore quindi genera la prova e consolida la fede.
Infatti la fede esiste in Tommaso prima della prova, ma vuole
essere verificata. Tommaso che esige di toccare le piaghe di Cristo
sarebbe così una metafora del procedimento filosofico, che tutto
mette in discussione e nulla accetta per acclarato definitivamente,
ovvio, indiscutibile. (Florenskij vede una certa assonanza tra lo
stupore, thauma, e thomas, che appare ancora più rilevante se si
considera che nel dialetto ionico thauma si pronuncia come
thoma. Tommaso però è un nome aramaico; l’antica
interpretazione ricordata da Florenskij gli conferisce il significato
di burrone, profondità imperscrutabile e anche gemello.). Il
linguaggio, se usato in modo autentico, si rivela dialettico per
natura; la parola viva non è che il ritmico alternarsi del domandare
e del rispondere, dell’uscire da sé e del ritornare a se stessi.
La dialettica insegna ad argomentare con formule che non
hanno valore in se stesse, ma solo in rapporto contestuale alla
realtà diveniente che di volta in volta è presa in esame. Il ricorso a
formule assolute, a giudizi validi per qualsiasi contesto, è il modo
di procedere della scienza e del dogma, ed è agli antipodi della
filosofia e della dialettica. L’obiettivo del pensiero deve essere
quello di comprendete la realtà viva nella sua attualità, non quello
di sovrapporre schemi rigidi, astratti, impersonali, alla realtà in se
stessa. Florenski considera la dialettica il solo metodo
autenticamente cristiano, che mira alla verità e non ad altro (alla
menzogna per amore del potere, ad esempio). «L’unica via
cristiana, scrive Florenskij, via umile del ragionamento, è la
dialettica: io affermo ciò che ora, nella data combinazione di
giudizi, nel dato contesto del discorso e di rapporti, è vero, senza
avere altre mire» (p. 93).
Claudio Tugnoli
02.01.2012