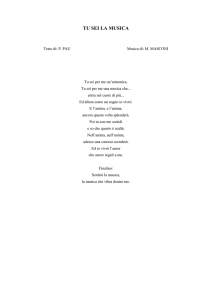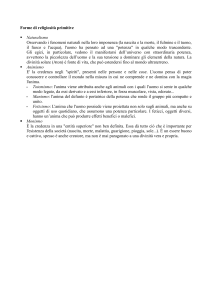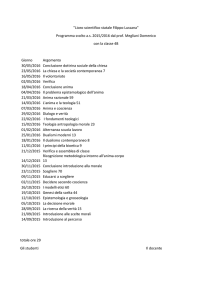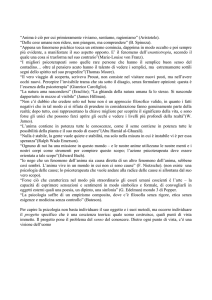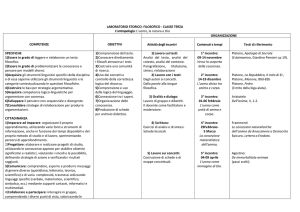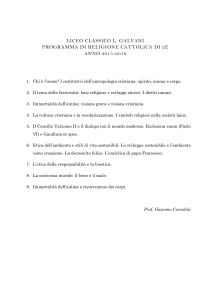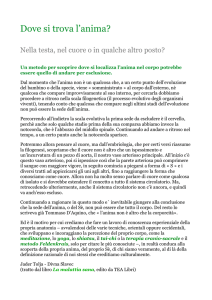L’ANIMA NEL MONDO PAGANO
Anna e Marco Bertè
Nella poesia greca
Per percorrere un rapido excursus sul tema dell’anima nella poesia greca e latina partiamo da questo
brevissimo testo attribuito all’imperatore Adriano, che regnò a Roma dal 117 al 139 d.C.,
tramandato nella Historia Augusta:
Animula vagula blandula
hospes comesque corporis
quae nunc abibis in loca
pallidula rigida nudula
nec, ut soles, dabis iocos
Piccola anima, dolce e vagabonda
ospite e compagna del corpo,
che ora te ne andrai in altri luoghi,
pallida, gelida e nuda,
e non giocherai più secondo il tuo costume
È una dolce tenerissima lirica, serena insieme e malinconica, inconsueta, a dire il vero, nella poesia
latina, che mal si accorda con la visione imponente e maestosa che su Adriano la storiografia e
l’icononografia ci hanno lasciato, ma che ben si addice invece a quella più intimistica, più pensosa e
meditativa che Marguerite Yourcenar ricostruisce nel suo celebre romanzo Memorie di Adriano. In
sostanza si tratta di un affettuoso addio di Adriano alla vita e come di un saluto a questa sua
animula, che è stata compagna e ospite del suo corpo e che ora è destinata ad andarsene pallida e
nuda in luoghi dove non sarà più possibile giocare e scherzare. Soffermiamoci solo un momento su
questo termine animula, che si troverà anche nell’iconografia più tarda, medievale e rinascimentale,
come una specie di fanciullino in fasce che esce dalla bocca del morente: questa rappresentazione
corporea ma tenera della morte e della vita che lascia il morente è detta appunto animula.
La poesia epica
Partiamo dunque dalla fine, per proporre alcuni momenti, alcune tappe significative della presa di
coscienza sull’anima che l’uomo greco a poco a poco acquisisce, percorso documentato nella
poesia. Premettiamo che non troveremo nella poesia greca nessun discorso e tanto meno nessuna
definizione sull’anima, che troveremo invece quando la poesia passerà il testimone alla filosofia. La
poesia latina, che prenderemo in esame in conclusione, composta quattro o cinque secoli dopo i testi
greci che leggeremo, sarà più comprensibile se ascoltata dopo l’excursus sulla filosofia.
Comincerò da molto lontano, dalle prime testimonianze scritte della consapevolezza di quel
qualcosa che saranno poi i filosofi a definire come anima. Partiamo dunque dal primo autore della
cultura occidentale, Omero. Nella poesia epica di Omero non troviamo una riflessione ma un
racconto, il piacere di un racconto di cui gli uomini e gli dei sono i protagonisti; la natura fa da
sfondo, ma non è il centro dell’attenzione del poeta. L’uomo-eroe è descritto da Omero in una
visione analitica: è un insieme di membra che si muovono. Il termine «corpo» (soma) è usato solo
per indicare il cadavere, cioè quello stesso insieme di membra che non si muovono più. Ciò che
muove le membra e fa sì che l’uomo agisca, e che i vari eroi siano così diversi fra loro (vedi per
esempio Achille e Ulisse) sono delle forze che non si vedono ma che suscitano pensieri, sentimenti,
passioni, emozioni. Così come non è usato in Omero un termine unico per indicare il corpo, così ci
sono tanti termini per indicare quello che poi chiameremo anima, spirito. Tre termini in particolare
rappresentano le funzioni di quella che noi chiamiamo anima: la psyché, parola che risale a una
radice che vuol dire spirare, respirare; thumòs, che viene da una radice che ha a che fare con il
fumo, che indica soprattutto passioni, emozioni, furore, coraggio, ardimento; e nous, che tutti
sappiamo che vuol dire mente. La psyché in particolare indica il respiro vitale; quando un uomo
muore questa esce dalla sua bocca o dalle sue ferite (come l’animula di cui si diceva). Quando
Omero parla della morte di un eroe usa questa formula:
Mentre parlava così la morte lo avvolse,
la vita (psyché) volò via dalle membra e scese nell’Ade,
2
piangendo il suo destino, lasciando la giovinezza e il vigore. (Iliade XVI,855-57; cfr. Iliade
XXII, 361-63)
È interessante vedere come spesso l’anima del defunto appare al vivente come fantasma o sogno:
E il sonno l’afferrò […]
ed ecco a lui venne l’anima (psyché)
del misero Patroclo,
gli somigliava in tutto, grandezza, occhi belli,
voce, e vesti uguali vestiva sul corpo;
gli stette sopra la testa e gli parlò parola:
«Tu dormi Achille e ti scordi di me,
mai, vivo, mi trascuravi, ma mi trascuri morto.
Seppelliscimi in fretta e passerò le porte dell’Ade.
Lontano mi tengono l’anime, fantasmi di morti,
non vogliono che tra loro mi mescoli di là dal fiume,
ma erro così, per la casa larghe porte dell’Ade.
E dammi la mano, te ne scongiuro piangendo: mai più
verrò fuor dall’Ade quando del fuoco m’avrete fatto partecipe […]»
E rispondendo gli disse Achille piede rapido:
«Perché, testa cara, sei venuto fin qui
e mi comandi queste cose a una a una? Sì, certo
compirò tutto quanto, obbedirò come chiedi:
ma vieni vicino e almeno un istante, abbracciati,
godiamoci il pianto amaro a vicenda!»
Tese le braccia, parlando così,
ma non l’afferrò: l’anima come fumo sotto la terra sparì stridendo. (Iliade XXIII, 62-101)
Nel libro XI dell’Odissea Ulisse ha la possibilità di evocare le anime dei morti. Gli appare, fra gli
altri, l’immagine della madre, che vorrebbe inutilmente abbracciare. La madre gli parla:
Questa è la sorte dei mortali, quando uno muore:
i nervi non reggono più l’ossa e la carne,
ma la forza gagliarda del fuoco fiammante li annienta,
dopo che l’ossa bianche ha lasciato la vita (thumos);
e l’anima (psyché) come un sogno, fuggendone, vaga volando. (Odissea XI, 217-222)
Omero, acuto osservatore, capace di cogliere anche i particolari più raffinati e sottili della realtà, ha
forgiato una lingua che può esprimere la poliedricità del reale, costruendo assai spesso vocaboli per
dire ciò che prima non era mai stato detto. Questa lingua di Omero resterà per secoli (dal decimo
circa, quando si datano i poemi omerici, a tutto il sesto ed inizio del quinto secolo a.C.) la lingua
della poesia, anche quando la poesia sarà espressione di mondi e di uomini molto diversi.
La poesia lirica
Già nel mondo omerico il tema dell’immortalità era presente e spesso cantato. L’uomo non può
accettare di sparire come una meteora, ma certo non si parla, per le ragioni già dette, di immortalità
dell’anima. Quel tanto di immortalità che uno può garantirsi è quella del ricordo, della fama:
«finché sarai ricordato, non morirai del tutto». Ma quando si comincia a percepire l’idea
dell’immortalità dell’anima, i tre termini di cui si diceva - psyché, thumos e nous – finiscono per
diventare sinonimi. In particolare psyché e thumos esprimono la parte interiore dell’io, quella
profonda e misteriosa, che se anche non si vede e non si può né si sa descrivere, rappresenta l’io
segreto, quello con cui si devono fare i conti.
Nel VII secolo abbiamo le prime espressioni di questo modo di fare poesia. È la poesia lirica
quella che ci guida, anche attraverso la suggestione della sua frammentarietà, lungo questo percorso
3
di presa di coscienza dell’anima. Il poeta non è più proiettato verso un mondo eccezionale, fatto di
grandiosi eventi, di eroi, di dei, per raccontarlo, ma è in ascolto profondo del suo io interiore
(possiamo dire anima), in dialogo con esso. Il poeta Archiloco, il più antico esponente di questo
nuovo genere, fra i tanti ci lascia questo frammento, che è una specie di dialogo col suo cuore
(thumos):
Cuore, cuore mio, sconvolto da tormenti senza scampo,
sorgi, i tuoi nemici vinci, opponendo ad essi il petto;
negli scontri corpo a corpo fortemente tieni il campo.
E, se vinci, la tua gioia non mostrare innanzi a tutti;
se sei vinto, non giacere in casa a lamentarti.
E gioisci delle gioie, addolorati dei mali,
ma non troppo: riconosci quale ritmo tiene gli uomini.
È la sua individualità che lo affascina, non per una forma di narcisismo, anzi, ma per la sua
complessità. I confronti e gli scontri, i dolori e le gioie non vengono dal di fuori, ma sono il modo di
reagire agli accadimenti esterni. Il poeta non racconta più, canta. Sa usare la parola, che è ancora
quella omerica, per dire altre cose, per esempio per cantare la compresenza impossibile eppure reale
di sentimenti opposti come l’amore e l’odio che possono travolgere l’anima. Anche il ricordo,
alimentato dalla poesia, è oggetto del canto lirico, è un po’ come il perdersi dell’anima nella
lontananza, nella contemplazione.
In Saffo, in particolare, i sentimenti fortemente vissuti quasi si manifestano all’esterno.
A me pare uguale agli dei
chi a te vicino così dolce
suono ascolta mentre tu parli
e ridi amorosamente. subito a me
il cuore si agita nel petto
solo che appena ti veda, e la voce
si perde sulla lingua inerte.
Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle,
e ho buio negli occhi e il rombo
del sangue alle orecchie.
E tutta in sudore e tremante
come erba patita scoloro:
e morte non pare lontana
a me rapita di mente.
La poesia può mantenere in vita chi è morto. Sia il poeta che chi è cantato dal poeta può continuare
a vivere.
Tu morta, finirai lì. Né mai di te
si avrà memoria; e di te nel tempo
mai ad alcuno nascerà amore,
poiché non curi le rose della Pieria [= poesia].
E sconosciuta anche nelle case dell’Ade,
andrai qua e là fra oscuri
morti svolazzando.
Il teatro tragico
Una volta innescato questo processo di ricerca del sé più profondo e della scoperta di quell’anima in
cui il poeta si immerge per cercare di capire e di esprimere il senso delle paure, delle gioie, degli
amori, delle angosce e del dolore, lo spirito non si ferma, si apre, anzi si dilata a considerare anche
il mondo fuori di sé, la città, la storia e la politica. Questo percorso è compiuto pur sempre dai poeti,
4
che hanno la chiave per comunicare con un pubblico che si allarga e si fa sempre più consapevole.
Il bisogno di indagare su se stessi diventa un imperativo categorico che è espresso da uno dei due
motti della sapienza apollinea a Delfi: conosci te stesso. Il culto di Apollo, combinato a Delfi con il
culto di Dioniso, diventa un punto di riferimento forte del sentire collettivo. La razionalità apollinea
e l’esperienza sconvolgente, eccitante, irrazionale dionisiaca in qualche modo si combinano.
L’uomo ha cioè colto in sé questa tensione fra razionale e irrazionale. La poesia ancora esprime in
nuove forme queste conquiste dello spirito. Nasce una espressione poetica nuova, molto complessa,
che riesce ad esprimere proprio la complessità del reale, scoperta dentro di sé ma anche fuori di sé.
E questa forma è il teatro tragico. La tragedia realizza un rapporto nuovo e irripetibile fra mito e
realtà: il mito serve ora al poeta per dare ai problemi politici e personali una dilatazione che supera i
loro contorni attuali, rendendoli universali. Pensiamo ad esempio al tema della giustizia nell’
Antigone o alla ricerca dell’identità e del rapporto colpa-pena nell’ Edipo Re.
La tragedia greca, ateniese, coi suoi tre grandi esponenti immortali, Eschilo, Sofocle,
Euripide, riesce a dare ragione di questa intuizione. Sono percorsi dell’anima che si possono
ricostruire solo accostando per intero le tragedie, cosa che qui non può essere proposta. La cosa che
più colpisce, leggendo le tragedie greche oggi, è per un verso l’attualità impressionante e per l’altro
come fosse possibile che un pubblico così numeroso, costituito da tutti gli uomini adulti di Atene –
il teatro di Dioniso, secondo calcoli degli archeologi, doveva contenere circa 18.000 spettatori –
seguisse con tanta passione questi spettacoli. Riusciamo a intuire qualcosa ascoltando Platone e
Aristotele che, partendo dalla considerazione che lo spettacolo teatrale è il momento culminante del
culto dionisiaco, lo presentano come esperienza estatica e catartica, cioè un’esperienza, non un
semplice divertimento. Platone dice che gli spettatori escono dal teatro colpiti (come bastonati);
Aristotele cerca di spiegare come lo spettatore, vedendo proiettati sulla scena, ingigantiti, i propri
sentimenti (ancora mi pare possiamo affermare che è l’anima la protagonista di questo evento),
immergendosi in ciò che vede si dimentica di sé e in questo dimenticarsi si purifica. Il teatro dunque
è un’esperienza prima spirituale che intellettuale e questo spiega il grande successo in un pubblico
che in gran parte doveva essere incolto, un successo che attraversa tutto il V secolo ad Atene e
coincide con la nascita, lo sviluppo, la crisi, la fine della democrazia. La fine della democrazia
segna la fine del teatro tragico.
La poesia ha accompagnato l’uomo greco in questa avventura – della conoscenza di sé e
dell’io profondo (anima) – e lo ha fatto con il mezzo che le è proprio: la parola ispirata e creatrice
che può toccare i vertici del sublime. È una ricerca che procede ancora e si approfondisce con altri
mezzi e con ben altri esiti. Lasciamo dunque la parola alla filosofia.
Nella riflessione filosofica
La poesia di Adriano pone i problemi della natura dell’anima, della sua relazione con il corpo e
della sua destinazione ultima. Cercheremo di dare un’idea di come la filosofia classica ha affrontato
questi problemi. Dato il tempo a disposizione ci limiteremo a Platone ed Aristotele e ad un breve
cenno a stoicismo ed epicureismo.
Platone
Platone distingue due piani della realtà: uno materiale e sensibile, costituito dal mondo in cui
viviamo e di cui abbiamo esperienza; ed uno immateriale ed intelligibile, costituito dal mondo delle
Idee. Le Idee non sono concetti, non hanno una esistenza mentale: sono cose in sé, forme pure, che
hanno una esistenza assoluta, autonoma, indipendente dalla esperienza che ne possiamo avere. Sono
oggetto e non prodotto della mente. Ci sono Idee estetiche, come il Bello in sé; Idee conoscitive,
come il Vero in sé; Idee etiche, come il Giusto in sé; Idee matematiche, come l’Eguale in sé, e così
via. Al vertice delle Idee, causa della loro essenza ed intelligibilità, c’è l’Idea del Bene. Il mondo
delle Idee, immateriale ed intelligibile, è il vero essere, perfetto ed immutabile: ciò che veramente è,
ciò che è sempre. Un mondo divino, che sta al di sopra degli stessi dei del politeismo greco. Al di
sotto del mondo delle Idee sta Il mondo in cui viviamo e di cui abbiamo esperienza, materiale e
sensibile, imperfetto e mutevole: ciò che non è veramente, ciò che non è sempre (ora c’è, ora non
5
c’è; ora è così, ora non è così). Il primo è modello e causa del secondo: questo è partecipazione e
imitazione di quello. Le cose belle, ad esempio, partecipano in qualche misura del Bello in sé, lo
imitano, ma ne rimangono irrimediabilmente lontane. È importante fissare bene questo: che le cose
materiali e sensibili, imperfette e mutevoli sono solo partecipazione e imitazione delle Idee. Vivere
tra le cose materiali e sensibili, imperfette e mutevoli significa essere tragicamente separati da ciò
che è immateriale ed intelligibile, perfetto ed immutabile, da ciò che è veramente e sempre. Bastano
questi pochi cenni per capire che l’uomo deve liberarsi dalle realtà sensibili e volgersi a quelle
intelligibili, liberarsi da questo mondo e volgersi al mondo delle Idee. Dobbiamo allora considerare
cosa sia l’uomo, come si collochi in questa realtà e quale sia, in particolare, la relazione tra l’anima
ed il corpo.
Come la realtà nel suo insieme si dispone su due piani, così l’uomo risulta composto da due
sostanze, l’anima ed il corpo. L’anima è immateriale ed ha una natura simile a quella delle Idee. Il
corpo è materiale ed appartiene al mondo sensibile. Tra anima e corpo vi è dualismo, anzi, una vera
e propria opposizione (che tuttavia negli ultimi scritti Platone attenua). Secondo Platone l’anima è
la vera essenza dell’uomo, tanto che egli giunge a dire che l’uomo è la sua anima. Il corpo è
qualcosa di estraneo ed ostile. Rifacendosi all’orfismo e ai Pitagorici, Platone dice che l’anima è nel
corpo come in una tomba (Gorgia), quasi a significare che in esso l’anima è come morta, o come in
un carcere (Fedone), sicché la morte corporea costituisce una liberazione.
A differenza del corpo, l’anima è immortale. L’immortalità dell’anima è dimostrata con vari
argomenti. Quello più ricorrente, che troviamo nel Fedone, nel Fedro e nelle Leggi, si fonda sul
principio che l’anima è principio di vita e di movimento. Essa ha perciò la vita in se stessa. Non può
quindi accogliere il suo contrario, cioè la morte. Dunque, è immortale.
Ma se l’anima è principio di vita, in cosa consiste la vita ch’essa dà? Quali sono le sue
attività vitali? Platone distingue tre facoltà: la concupiscibile, l’irascibile e la razionale. La
concupiscibile o appetitiva è all’origine dei desideri sensibili, indirizzati ai piaceri del mangiare, del
bere e dell’attività sessuale. L’irascibile o impulsiva dà luogo agli slanci ed impulsi che tendono al
bene come al male (coraggio, entusiasmo, aggressività, ecc.). La razionale o intellettiva presiede al
conoscere, al giudicare e al deliberare.
Una versione plastica di questa dottrina delle facoltà e della dinamica che si instaura fra esse
la troviamo nel Fedro con il mito della biga alata. Platone si rifà, qui come altrove, all’orfismo ed ai
pitagorici. Per l’orfismo l’anima è un principio immortale, di natura divina, caduto in un corpo per
una colpa originaria. Per espiare la sua colpa è condannata a reincarnarsi successivamente in vari
corpi, di uomini, animali e piante. È la metempsicosi o metemsomatosi, passaggio da uno ad altro
corpo. Ma può redimersi anche purificandosi grazie alla iniziazione orfica, consistente in riti segreti,
che culminano nella immedesimazione con la divinità. Alla morte fisica, nell’al di là, per gli iniziati
c’è la partecipazione alla vita divina, mentre per i non iniziati c’è la dannazione eterna. Pitagora ed i
pitagorici professano la stessa dottrina della reincarnazione, ma per essi la purificazione avviene
non in virtù di pratiche misteriche, ma grazie ad una vita ascetica, ad un rigoroso impegno morale
(che richiede fra l’altro l’esame di coscienza quotidiano) e soprattutto grazie allo studio della
struttura matematica della realtà. L’orfismo si coniuga così con il primato della contemplazione.
Platone accoglie questi principi, accentua il primato della contemplazione e ritiene che al termine
della vita si aprano all’anima tre possibilità: il premio d’una vita divina per chi si è purificato, ha
praticato la giustizia ed ha coltivato la filosofia; un eterno castigo, nel Tartaro, per chi ha praticato
l’ingiustizia; l’espiazione temporanea delle colpe anche attraverso il ciclo delle reincarnazioni per
chi ha commesso ingiustizie di cui si è pentito.
Ma torniamo al mito della biga alata. L’anima è rappresentata da una biga con le ali, che
vola nel cielo al seguito degli dei. È trascinata da due cavalli, uno bianco e uno nero, guidati da un
auriga. L’auriga rappresenta l’anima razionale, che guida le altre due anime. Il cavallo nero
rappresenta l’anima concupiscibile che tende verso il basso. Il cavallo bianco rappresenta l’anima
irascibile che tende verso l’alto. Quando l’auriga ed il cavallo bianco hanno il sopravvento, la biga
vola verso l’alto, fino a raggiungere la volta del cielo, da dove può contemplare, anche se solo a
6
tratti ed in parte, il mondo delle Idee. Se invece prevale il cavallo nero o il contrasto tra i due
animali è insanabile e l’auriga non riesce a controllare la biga, questa cade verso il basso e si
scontra con altre bighe anch’esse in difficoltà. Nella ressa e nei continui scontri le ali si
danneggiano e alla fine si staccano dalla biga. Questa allora precipita sulla terra, lontana dal mondo
delle Idee. Il mito raffigura così il destino dell’anima: la sua colpa originaria consiste nel cedere alla
attrazione esercitata dal mondo materiale, per cui si incarna in un corpo, cadendo in esso come in
una tomba o in un carcere. Inizia così il ciclo delle reincarnazioni. Una volta precipitata in un corpo
l’anima, diventata come morta, deve rinascere; resa prigioniera, deve liberarsi. E può rinascere e
liberarsi solo purificandosi dal male che l’ha vinta, solo convertendosi dal mondo corporeo al
mondo delle idee. Si tratta di una vera e propria conversione, un concetto tipicamente platonico,
affine alla teshuvà ebraica ed alla metánoia cristiana, che indicano un cambiamento radicale di vita,
un abbandono del peccato ed un ritorno a Dio.
La conversione è possibile solo richiamando alla memoria le Idee che l’anima ha
contemplato, anche se solo a tratti ed in parte, ma che poi, per la sua caduta nel corpo, ha
dimenticato. Questo processo è chiamato da Platone reminiscenza, che è non tanto il semplice
ricordare, ma il faticoso e difficile lavoro di richiamare alla memoria ciò che si è dimenticato. Essa
è possibile perché le cose sensibili, che l’anima vede e di cui ha esperienza, sono, come sappiamo,
partecipazione ed imitazione delle Idee. Possono quindi richiamarle. Osservandole, confrontandole,
traendone immagini e concetti, l’anima può risalire nuovamente al cospetto del mondo delle Idee.
Può tornare là donde è venuta e caduta. È una ricerca difficile e progressiva. Un processo assieme
cognitivo ed etico, di cui possiamo renderci conto soffermandoci sul mito della caverna e sul mito
di Eros.
Nel mito della caverna, contenuto nella Repubblica, l’anima è paragonata ad un prigioniero
incatenato in fondo a una caverna. Egli vede davanti a sé delle ombre. Da sempre non vede altro.
Crede perciò che le ombre siano la vera realtà. Ma quando viene liberato dalle catene e può volgere
il capo verso l’ingresso della caverna, scorge delle statuette, dietro alle quali arde un grande fuoco.
È esso che genera le ombre delle statuette, proiettate su una parete della caverna. Si rende conto
allora che più reali delle ombre sono le statuette. Risalendo faticosamente il pendio su cui si trova,
giunge all’aperto ed è accecato dalla luce che lo investe. Ma a misura che la luce gli rafforza la vista
egli può guardarsi attorno. Dapprima, con gli occhi ancora abbassati, intravvede in specchi d’acqua
il riflesso di alberi ed animali e poi, rafforzandosi ulteriormente la vista, può alzare gli occhi e
vedere gli stessi alberi ed animali di cui prima scorgeva solo le immagini riflesse nell’acqua; e vede
tutte le cose del mondo reale e lo stesso sole che le illumina. È chiara la simbologia del mito: il
prigioniero, come abbiamo detto è l’anima; la caverna è il carcere in cui il prigioniero è rinchiuso:
esso raffigura il corpo che impedisce all’anima di vedere la vera realtà. Questa può essere percepita
solo progressivamente, nella misura in cui il prigioniero - liberandosi, risalendo a fatica il pendio e
procedendo di grado in grado - acquista pian piano la vera conoscenza. Le ombre rappresentano
l’immaginazione, le statuette la credenza, i riflessi nell’acqua la ragione matematica e la visione
piena della realtà illuminata dal sole l’intellezione e dunque la conoscenza delle Idee. Il sole, che dà
vita e visibilità a tutte le cose, rappresenta l’Idea del Bene, che dà alle altre Idee esistenza ed
intelligibilità.
Qualcosa di simile è rappresentato nel Convito, con il mito di Eros. Eros non è né uomo né
Dio. Non è sapiente, perché solo gli dei sono sapienti e non è del tutto ignorante. Sa di non sapere e
desidera sapere. È filosofo. La filo-sofia è appunto amore e ricerca della sapienza. Eros ricerca ciò
che è vero, bello, buono. E la sua ricerca passa, anche in questo mito, attraverso vari gradi.
Dapprima ricerca l’amore dei corpi per generare nella bellezza. La generazione assicura così una
qualche forma di immortalità. Poi cerca l’amore delle anime in vista di una generazione spirituale.
Attinge poi la bellezza ed il bene riposti nelle arti, nella giustizia, nelle leggi e nelle scienze. Infine,
non ancora soddisfatto, procede nella ricerca fino ad attingere il Bello in sé, che coincide con l’Idea
del Bene. Nel Fedro Platone ritorna sul tema dell’amore e sostiene che Eros non è altro che il
desiderio della bellezza che «traluce» già nei corpi. Questo desiderio si impossessa dell’anima, fino
7
a fare rispuntare le ali e a consentirle, così, di rialzarsi a volo verso il mondo delle Idee. Eros è
mediatore fra il mondo sensibile ed il mondo intelligibile delle Idee.
Per Platone dunque l’anima è chiamata a distaccarsi dal corpo e riunirsi a quel mondo
intelligibile da cui proviene. La morte corporea è per l’anima liberazione, purificazione, salvezza.
Eppure, nonostante questa «fuga dal corpo», se l’anima può convertirsi, se può risalire al mondo
delle Idee a partire dal mondo corporeo, se può cogliere nei corpi il tralucere della bellezza, ciò non
può accadere se non con una qualche collaborazione del corpo e della stessa conoscenza sensibile.
«Ospite e compagna del corpo», secondo l’espressione di Adriano, pur essendo in esso come in una
tomba o in un carcere, intrattiene con esso anche una qualche familiarità. Se non altro perché anche
il corpo umano, come tutti gli altri corpi, in qualche misura imita il mondo delle Idee e ne partecipa.
Non per nulla Platone, proprio mentre lo qualifica tomba e carcere, lo dice anche segno e, in una
delle ultime opere (il Timeo), strumento dell’anima. Si pone così il problema di un superamento del
dualismo anima-corpo. È su questo problema che conviene ora interrogare Aristotele.
Aristotele
La differenza tra Aristotele e Platone è felicemente rappresentata dalla famosa «Scuola di Atene» di
Raffaello. In questo affresco sono raffigurati i più famosi filosofi greci. Al centro, in grande
evidenza ed affiancati l’uno all’altro stanno Platone ed Aristotele. Il primo punta il dito verso l’alto,
ad indicare il mondo delle Idee; il secondo tiene la mano rivolta verso il basso, ad indicare il mondo
della natura. Questa immagine interpreta bene la posizione di Aristotele. Vicino a Platone,
condivide con lui la ricerca delle cause ultime del reale. E però critica la visione del maestro, che
pone queste cause in un altro mondo. Egli cerca invece le cause ultime del reale nel reale stesso. È
in questo, non altrove, che occorre cercarne le tracce. È alla natura, ed in particolare all’universo dei
viventi, ch’egli rivolge la sua attenzione. Mentre Platone poneva le cause ultime del reale sensibile
in forme separate (le Idee), Aristotele (vissuto nel IV sec. a.C) pone queste cause in forme immerse
nel reale e inscindibilmente unite al mondo corporeo.
Il mondo di cui abbiamo esperienza, egli sostiene, è un insieme di realtà individuali o
sostanze in continuo divenire. Tutte le sostanze sono costituite da due principi, la materia e la
forma. La materia è ciò di cui le sostanze sono fatte. La forma è ciò che fa sì che una cosa sia ciò
che è, che funzioni o agisca in un modo determinato e che abbia perciò una identità ed una struttura
inconfondibili. Questi due principi sono inseparabili. Non esiste materia che non sia formata e non
esiste forma che non sia forma di una materia determinata. Tra la materia e la forma vi è un
rapporto di potenza ed atto. La materia tende a svilupparsi sempre meglio secondo la forma che gli
è propria. Ad esempio, la materia che ha già preso forma nel seme vegetale tende ad attuarsi
ulteriormente ed a svolgersi in pianta e da qui nei germogli, nelle foglie, nei fiori, nei frutti. Ed il
seme animale fecondato è sospinto ad articolarsi, a svilupparsi in un corpo, a nascere, a crescere e
così via. Vi è in ogni sostanza un dinamismo interno, un passaggio continuo dalla potenza all’atto,
una evoluzione incessante. Il passaggio dalla potenza all’atto è il divenire. Ogni divenire di cui
abbiamo esperienza è sempre un passare dalla potenza all’atto. Ora, affinché una sostanza passi
dalla potenza all’atto, occorre che vi sia qualcosa di esterno che sia già in atto e la faccia passare
dalla potenza all’atto. L’acqua, ad esempio, passa da calda in potenza a calda in atto grazie al fuoco,
che è caldo in atto.
Ma le cause del divenire, a loro volta, sono in divenire. Anch’esse passano dalla potenza
all’atto. Anch’esse, dunque, hanno bisogno, per diventare ciò che sono, di qualcosa di esterno già in
atto. Si pensi, ad esempio, alla successione delle generazioni. Possiamo procedere a ritroso, dai figli
ai genitori, da questi ai loro genitori e così via. Procedere, quindi, dal causato alla causa. Ma non è
possibile procedere all’infinito, anche risalendo, come fa Aristotele, alle sfere celesti, che col loro
movimento fanno muovere ogni cosa. Occorre risalire ad un ente immobile, che sia solo in atto,
forma pura, e che dunque non abbia in sé alcuna potenza (altrimenti anch’esso dovrebbe passare
dalla potenza all’atto e dunque muoversi). Tale ente è il primo motore immobile. È il Dio
aristotelico, atto e forma pura. Essendo atto e forma pura non è materiale, ma spirituale, puro
pensiero. Ed è un pensiero che pensa se stesso. Se infatti dovesse pensare ad altro, dovrebbe passare
8
dalla potenza all’atto ed essere condizionato da realtà inferiori. Pensando se stesso, pensa la cosa
più alta che esiste e, libero da qualunque preoccupazione per l’altro da sé, è assolutamente libero,
beato, senza speranza e senza timore. Il dualismo platonico, rifiutato da Aristotele, si riproduce così
in forma anche più radicale: da una parte vi è il mondo del divenire, in continua evoluzione;
dall’altra parte vi è l’essere puro, immobile, separato da ogni divenire. Ma se è così, come fa a far
passare tutte le cose dalla potenza all’atto? Come fa ad essere causa del divenire dell’intera realtà
naturale? La risposta di Aristotele è di una semplicità disarmante: il motore immobile è causa del
divenire come oggetto di desiderio e di amore; essendo quanto di più amabile e perfetto esista, attira
a sé tutte le cose e tutte le cose tendono a lui. Siamo di fronte ad un esito paradossale, ad un Dio
senza amore che è oggetto di amore. Di un Dio del genere, probabilmente, non sappiamo che
farcene. È il Dio dei filosofi denunciato da Pascal. Eppure, nel nostro discorso ha una funzione
importante, perché diventa il modello più alto cui l’uomo possa tendere. Ma con ciò si riapre ora più
direttamente la nostra riflessione sull’anima.
Torniamo dunque ai punti fondamentali enunciati sopra: Tutte le sostanze sono costituite da
due principi, materia e forma. Tra materia e forma vi è un rapporto di potenza ed atto. La materia
tende a svilupparsi secondo la forma che gli è propria. Il passaggio dalla potenza all’atto è il
divenire. Ogni divenire è sempre un passare dalla potenza all’atto. E, affinché una sostanza passi
dalla potenza all’atto, occorre che vi sia qualcosa di esterno che sia già in atto che la faccia passare
dalla potenza all’atto. Ecco: disponiamo, a questo punto, dei principi fondamentali per intendere il
discorso sull’anima.
Quando Aristotele studia l’anima, considera anzitutto l’anima (o le anime) di tutti i viventi e
non solo quella dell’uomo. L’anima è il principio vitale di tutti gli esseri animati. Ma cosa è
l’anima, così considerata? La risposta di Aristotele è netta: l’anima è la forma del corpo. Egli si rifà
al principio generale, secondo cui ogni essere è composto di due principi inseparabili: la materia che
è potenza e la forma che è atto. L’anima è dunque forma ed atto di quella materia che costituisce il
corpo. È necessario che l’anima sia sostanza in quanto forma del corpo naturale che ha la vita in
potenza. Tale sostanza è atto: dunque l’anima è atto di un corpo di siffatta natura (Sull’anima II,
1). L’espressione «corpo naturale che ha la vita in potenza» indica un corpo organico, cioè dotato
degli organi necessari per l’esercizio delle funzioni vitali.
Ma se l’anima è forma del corpo in questo senso, essa è necessariamente inseparabile dal
corpo. Se materia e forma (e dunque anima e corpo) sono inseparabili, l’anima non può
sopravvivere alla morte corporea. Non può essere immortale. Nemmeno, a rigore, l’anima
dell’uomo. Ma le cose non sono così semplici. Vediamo perché.
Aristotele distingue tre specie di anime, a seconda delle specie dei viventi e delle operazioni
loro proprie. Vi sono anzitutto le operazioni più elementari, come nutrirsi e riprodursi. Ad esse
corrisponde l’anima vegetativa, propria delle piante. Vi sono poi operazioni più complesse, come
sensazioni, immaginazioni, memoria, tendenze e desideri: ad esse corrisponde l’anima sensitiva,
propria degli animali, che esercita anche le funzioni dell’anima vegetativa. Vi sono infine le
operazioni ancora più complesse, come intendere, ragionare, deliberare, volere ed amare. Ad esse
corrisponde l’anima razionale, propria dell’uomo, che esercita anche le funzioni delle altre due
anime. L’anima dell’uomo, quindi, ha facoltà diverse, oltre a quelle strettamente razionali. Tutte,
peraltro, concorrono alla conoscenza, che ora dobbiamo analizzare.
Dobbiamo distinguere tra sensazione, immaginazione e pensiero. La sensazione coglie la
forma sensibile individuale dei singoli oggetti: questo albero, questa casa, questo uomo. Dalle
sensazioni si forma l’immagine delle varie specie di oggetti: le immagini di albero, di casa, di
uomo. L’immagine contiene la forma intelligibile, il concetto universale, che dice cosa è, ad
esempio, in generale, un albero, una casa, un uomo. Ma la contiene solo in potenza. Ora, affinché
questa forma possa essere condotta all’atto e pensata, occorre qualcosa che la faccia passare dalla
potenza all’atto e qualcosa che la riceva e la pensi effettivamente. Ciò che la fa passare dalla
potenza all’atto è l’intelletto attivo e ciò che la riceve è l’intelletto passivo o potenziale. Ma
leggiamo il testo di Aristotele.
9
Come in tutta la natura c’è qualcosa che è la materia per ciascun genere di cose (ed è ciò che
è in potenza tutte quelle cose) e un’altra che è la causa e cioè l’agente perché le produce tutte, al
modo che l’arte si rapporta alla materia, ne viene di necessità che anche nell’anima
[sottolineatura nostra] sussistano tali differenze. C’è pertanto un intelletto analogo [alla materia]
perché diventa tutte le cose e un altro [analogo alla causa agente] perché le produce tutte, al pari
di una qualità definita, come la luce, ché in certo senso anche la luce fa i colori in potenza colori
in atto. E questo intelletto è separato, immisto e impassivo, per sua essenza atto […] e questo
solo è immortale ed eterno. (Sull’anima III, 5)
Nell’anima dunque c’è un intelletto duplice: c’è un intelletto attivo, interamente in atto, che,
investendo con la sua energia le immagini che contengono le forme intelligibili in potenza, le
trasforma in forme intelligibili in atto, esattamente come la luce, investendo i colori in potenza, li
trasforma in colori in atto; e c’è un intelletto passivo, interamente in potenza, che, ricevendo queste
forme intelligibili ed assumendole come propria forma, pensa effettivamente. (E questo perché,
secondo Aristotele, ogni ente agisce secondo la forma che lo attua: possiamo esemplificare dicendo
che l’asino raglia perché attuato dalla forma asinina «ragliante» e l’uomo parla perché attuato dalla
forma umana razionale «parlante»). Ma solo l’intelletto attivo è immortale. L’intelletto passivo
muore con il corpo. E l’intelletto attivo, precisa Aristotele, è separato. Cosa significa questo?
Sempre nel trattato Sull’anima Aristotele dice che «quanto all’intelletto, sembra che sopravvenga in
noi con una sua esistenza sostanziale e che non si corrompa» (Sull’anima I, 4), mentre quello
passivo si corrompe con il corpo. Ma se «sopravviene», donde viene? e come? Più esplicitamente,
nel trattato Sulla generazione degli animali Aristotele, dopo aver sostenuto che l’anima vegetativa e
quella sensitiva si generano dal seme e dal feto, aggiunge: «Resta che il solo intelletto sopraggiunge
dal di fuori ed esso solo è divino, poiché alla sua attività non partecipa per nulla l’attività corporea»
(Sulla generazione degli animali II, 3). Ed allora? Donde viene? Come sopraggiunge? Noi saremmo
tentati di rispondere: viene da Dio, sopraggiunge per creazione. Ma l’idea di creazione è
assolutamente estranea alla filosofia di Aristotele.
In assenza di testi più espliciti, gli interpreti medievali hanno formulato tre diverse ipotesi:
Alessandro di Afrodisia identifica l’intelletto attivo con Dio stesso, cioè con la causa prima che
penetra ed opera in ogni cosa. Ma ciò contrasta con il principio aristotelico secondo cui Dio non
influisce sulle cose se non come causa finale. Averroè sostiene che l’intelletto attivo è una sostanza
separata distinta da Dio e a lui inferiore. Ma allora sarebbe una realtà trascendente che pensa in noi,
non saremmo noi a pensare (difficoltà, d’altra parte, conseguente anche alla tesi di Alessandro di
Afrodisia). Tommaso d’Aquino infine, adducendo proprio il fatto che è l’uomo stesso che intende e
non qualche realtà a lui esterna, pone l’intelletto attivo nell’anima. Cosa che, d’altro canto, come
abbiamo visto, Aristotele dice espressamente. Ma allora cosa significa dire che è separato? Ci
sembra che, allo stato dei testi disponibili, si possa rilevare nel suo pensiero una incertezza ed una
contraddizione. Da una parte dice che l’intelletto attivo è nell’anima e dall’altra che è separato; da
una parte che, almeno in quanto fa parte dell’anima, è forma del corpo e dall’altra che non ha a che
fare con il corpo. E dunque è ragionevole escludere che Aristotele pensi ad una immortalità
personale. E non è un caso, infatti, ch’egli non dica nulla sulla destinazione dell’anima dopo la
morte corporea. Non vi è traccia, in lui, di una vita nell’al di là. La forma di vita più alta, quella in
cui consiste la felicità, quella che più assomiglia alla vita degli dei, è la vita teoretica, dedita alla
filosofia ed alla contemplazione. In ciò Aristotele condivide le tesi di Platone. Ma la vita teoretica –
anche se assomiglia alla vita degli dei e richiama la condizione di Dio concepito come Pensiero di
Pensiero - ha luogo solo quaggiù e non si prolunga in un al di là che è estraneo al suo pensiero.
Proviamo a fare un primo bilancio. Platone afferma che l’anima è una sostanza separata che
si trova nel corpo come in una tomba o in una prigione e che deve quindi liberarsi dal corpo. Su
queste premesse fonda tutta la sua spiritualità. Ma poi, per tornare al mondo delle Idee da cui
proviene ed è caduta, ha pur sempre bisogno dei sensi e del corpo, se non altro per cogliere il
tralucere della bellezza nel mondo materiale e risalire di gradino in gradino fino a ciò cui aspira. Per
liberarsi dalla corporeità ha bisogno del corpo. Aristotele segue una via contraria. L’anima è forma
10
del corpo e destinata, quindi, a disgregarsi con il corpo. E tuttavia, per spiegare le operazioni più
caratteristiche dell’anima umana, vale a dire le sue operazioni intellettuali, è necessario ammettere
in essa qualcosa di separato dal corpo, qualcosa di divino ed immortale. Come questo sia possibile,
Aristotele non lo spiega o comunque non lo spiegano i testi che ci sono pervenuti. In ambedue i
filosofi – Platone ed Aristotele - corpo ed anima, mentre sembrano escludersi, si toccano e
richiedono a vicenda.
Stoicismo ed epicureismo
Lo stoicismo e l’epicureismo, fiorite nell’età ellenistica tra la fine del IV e la fine del III sec. a.C., in
un tempo in cui la realtà politica non consentiva più la partecipazione attiva alla vita della polis, si
concentrano sulla esistenza individuale e sull’impegno morale. Coniugano una visione di fondo
materialistica con un’etica rigorosa di tipo quasi ascetico.
Lo stoicismo - sviluppatosi originariamente ad opera soprattutto di Zenone, Cleante e
Crisippo - è una concezione di tipo panteistico. Tutta la realtà è ricondotta a Dio, concepito come
ragione universale e fuoco, tra loro coincidenti. Dio è in tutto e Dio è tutto. In lui ci sono i semi di
tutte le cose. A partire da essi si genera l’intera realtà, in modo assolutamente necessario: cose,
persone, eventi. Al compimento dei tempi si ha una grande conflagrazione e tutto ridiventa fuoco.
Ma a questo punto si ha una rigenerazione e tutto torna ad essere come prima: eterno ritorno. In
questa concezione l’anima è corporea come ogni cosa. Essa è un frammento di Dio, una scintilla del
fuoco eterno. Sopravvive alla morte per un tempo limitato e al massimo fino alla conflagrazione
successiva. In ogni caso, coerentemente con la visione materialistica, non c’è nessuna forma di
immortalità personale. Il bene sommo è la virtù, che consiste nell’aderire alla ragione universale, al
succedersi necessario degli eventi. Un aspetto di particolare interesse è quello politico-sociale.
Poiché l’anima è un frammento od una scintilla di Dio, tutti gli uomini sono accomunati in un unico
genere. Non c’è distinzione fra greco e barbaro, fra libero e schiavo. Tutti sono fratelli. Tutti devono
amarsi (filantropia), tutti fanno parte di un’unica città, che abbraccia il mondo intero
(cosmopolitismo).
Epicuro si rifà all’atomismo di Democrito, il grande filosofo presocratico cui si è ispirata
ogni forma di materialismo. La realtà è composta di atomi invisibili, variamente configurati, che si
muovono nel vuoto, aggregandosi e disgregandosi continuamente. L’anima è anch’essa un insieme
di atomi, più sottili e mobili degli altri, che permeano il corpo e come questo è destinata a
disintegrarsi. È perciò materiale e mortale. Non c’è quindi alcuna forma di vita al di là della morte
fisica. È famoso e rivelatore del suo orientamento il detto con cui esorta a non temere la morte.
«Quando noi ci siamo», egli dice, «la morte non c’è e quando c’è la morte noi non ci siamo», e
quindi non possiamo sentire, provare dolore o piacere. Con l’immortalità dell’anima è negata ogni
forma di vita al di là della morte fisica, ogni destino ultraterreno. Nonostante questo non approda ad
un’etica dei piaceri sensibili, ma ad una forma di vita di tipo ascetico. È vero che pone il bene nel
piacere, ma questo non è altro che l’assenza di dolore, fisico e morale. L’obiettivo pratico è la
liberazione del corpo dal dolore fisico e la liberazione dell’anima da ogni forma di turbamento. Da
ciò deriva il cosiddetto quadrifarmaco o quadruplice rimedio contro il dolore: liberarsi dalla paura
degli dei, dalla paura della morte, dalla paura del dolore e dal desiderio delle cose non necessarie. È
singolare questa insistenza sul concetto e sulla prassi della liberazione, che in qualche misura
ricorda la liberazione dal corpo, predicata dall’orfismo, dai pitagorici e da Platone.
Una ripresa del pensiero epicureo in ambito latino è il De rerum natura di Lucrezio, che
traspone in versi le dottrine del filosofo greco. Conviene allora, a questo punto, ridare la parola alla
poesia.
Nella poesia latina
Quando approdiamo alla poesia latina ci appare un mondo di poesia e di poeti molto diversi da
quelli greci. La ragione in fondo è semplice. La poesia latina, già nel suo nascere, è «dotta», nasce
cioè su un plafond culturale molto alto e si rivolge perciò stesso ad un pubblico piuttosto ristretto e
a sua volta colto. L’esperienza culturale poetica e filosofica greca nutre la poesia latina. Ad
11
esempio, pressoché tutti i maggiori poeti dell’età di Cesare e di Augusto (I sec. a.C.) hanno
frequentato la scuola epicurea dei Pisoni ad Ercolano. Noi sfioriamo appena questo grande campo
leggendo pochi ma significativi versi di Lucrezio, il vate dell’epicureismo, e di Virgilio.
Lucrezio nel De rerum natura trova nel suo maestro Epicuro la salvezza dalle angosce che
rendono così dolorosa la vita dell’uomo.
Dall’Inno ad Epicuro (III, 9-18; 28-30)
A noi tu sei padre, scopritore del vero
Tu ci provvedi di norme paterne
e noi dai tuoi libri, come nei boschi
fioriti vanno per tutto succhiando le api,
attingiamo parole dorate che vivono eterne.
Appena tu ci mostrasti l’essenza del mondo,
svelata dal tuo genio divino,
ecco sparire i terrori dell’animo,
aprirsi i confini all’immenso universo
e muoversi vedo nel vuoto le cose.
Allora un’ebbrezza quasi divina e un tremore
mi prende al pensiero che nuda in ogni sua parte
si sia la natura per opera tua rivelata.
Sull’anima (III, 34-40; 445-458)
Ora mi sembra che sia nei miei versi
da dire qual è la natura
così dello spirito come dell’anima:
bisogna scacciare, dissolvere questa paura
dell’Ade, che turba la vita dell’uomo
e la scuote fin giù nel profondo
tutto coprendo del nero color della morte
né lascia una gioia sussistere pura e serena.
Inoltre sentiamo che l’anima nasce
insieme col corpo e cresce e invecchia con lui.
Come il bambino vacilla nei passi
perché debole e tenero ha il corpo, così
a lui s’accompagna una debole mente;
ma poi, quando il tempo lo fa vigoroso, già uomo
cresce il giudizio e la forza dell’animo;
e quando alla fine battuto il corpo sia stato
dai colpi del tempo e stanche cadono le membra
e s’accasciano logore, ecco lo spirito zoppica,
la lingua s’inceppa, la mente s’annebbia
e tutto ci manca, tutto si perde e s’invola.
Ammettere dunque si deve che intera si dissipa
la sostanza dell’anima, simile al fumo
nell’alte regioni dell’aria, perché la vediamo
nascere e crescere insieme col corpo
e invecchiare sfinita con gli anni del corpo.
Virgilio raggiunge forse i livelli più alti nella poesia latina per la formazione culturale,
poetica e filosofica, e per la profondità dell’ispirazione. Nell’ Eneide, il poema epico che canta
l’epos e la storia di Roma, proprio al centro del poema, nel VI libro, visita il regno dei morti. Lì il
12
padre Anchise gli fa scorrere davanti le anime dei personaggi che faranno la storia futura di Roma.
E proprio qui, nei Campi Elisi, viene presentato il percorso che l’anima compie dalla vita alla vita,
passando attraverso la morte. Dopo un lunghissimo soggiorno di purificazione nel regno dei morti
che si conclude con l’immersione nel Leté, il fiume dell’oblio, se è giusta può risalire. Purificata e
dimentica del suo passato, l’anima nuova potrà rimettersi in cammino.
Di qui la razza degli uomini, e gli armenti e gli uccelli,
e i mostri che genera il mare sotto l’ondosa distesa.
Igneo vigore, principio celeste hanno queste
scintille, finché non le tardano i corpi languenti,
e non le ottundono terrosi organi, membra soggette a morire.
Di qui vien che temono e bramano, soffrono e godono
e mal distinguono lo spirito, chiuse nel buio d’un carcere cieco.
E quando con l’ultima luce le abbandona la vita,
non però tutto il male, non tutti radicalmente
i contagi del corpo se n’escono; per forza fin nel profondo
a lungo induritisi molti concrebbero insieme in strane maniere.
Perciò son soggetti alle pene, e dei mali passati
pagano il fio. Alcune s’espongono vuote,
sospese ai venti; ad altre nei gorgo profondo
è lavata la piaga del male, o bruciata nel fuoco:
patiamo tutti la nostra morte. Liberi poi siam lasciati
nell’ampio Eliseo (ma pochi le piane gioconde teniamo),
fino a che lunga stagione, compiutosi il giro del tempo,
toglie ogni macchia indurita, limpido lascia
il senso eterio e la fiamma del semplice spirito.
Tutte queste, quando per mille anni la ruota girarono,
il Dio le chiama sul fiume Lete, in gran folla,
che perdano i loro ricordi, e la volta del cielo
rivedano e provino voglia di ritornare nei corpi.
La tirannia del tempo ci ha obbligato a muoverci a volo d’uccello su questo patrimonio
inesauribile della poesia greca e soprattutto latina. Non abbiamo neppure accennato ad altri poeti,
Orazio per esempio, Giovenale, o al grande «romanziere» Apuleio, che nel suo «romanzo» ci
racconta la novella di Amore e Psiche. Chiudiamo ritornando da dove eravamo partiti, dalla poesia
di Adriano: nella sua semplicità richiama temi già incontrati: l’ animula che si stacca dal corpo suo
compagno, i luoghi senza luce dove vagherà. Colpisce soprattutto, se realmente è di Adriano, che l’
Imperatore, davanti alla morte, si senta davvero uguale a tutti gli uomini e che la sua animula non
abbia alcun segno distintivo. L’affetto con cui il poeta imperatore le si rivolge è dimostrato dal fatto
che sceglie termini mai prima usati, costruiti da lui per lei in questo malinconico addio.
Conclusione
Eraclito, uno dei più grandi pensatori presocratici, se non il maggiore, vissuto tra il VI ed il V sec.
a.C., ci ha lasciato un frammento che merita di essere qui evocato: «Per quanto tu cammini, ed
anche percorrendo ogni strada, non potrai raggiungere i confini dell’anima, tanto profonda è la sua
natura». Noi abbiamo percorso, anzi ripercorso, diverse strade, attraverso la poesia e la filosofia
pagane. E non abbiamo raggiunto i confini dell’anima. La riflessione filosofica non ha fornito una
concezione dell’anima convincente. E ciò, soprattutto, per quanto riguarda il rapporto dell’anima
con il corpo. Platone sostiene, come l’orfismo e i Pitagorici, il dualismo anima-corpo ed aspira a
liberarsi dal corpo, ma non può farlo senza ricorrere proprio al corpo ed alla corporeità. Aristotele fa
dell’anima la forma del corpo, ma poi è costretto a porre un intelletto divino e immortale separato
dal corpo. Stoicismo ed epicureismo, per vie diverse, negano l’immortalità, riducendo anima e
corpo ad un’unica matrice, quella materialistica. Certo, vi è una ricerca continua. Ma questa ricerca
13
traspare, paradossalmente, più nella poesia che nella filosofia. Abbiamo comunque incontrato molti
motivi che saranno poi caratteristici delle religioni: l’aspirazione a sfuggire alla morte e a proiettarsi
nell’aldilà di un destino immortale; il bisogno di purificazione, liberazione e salvezza; l’esigenza di
cogliere nelle profondità di se stessi qualcosa di inesauribile. Ecco, il messaggio più significativo,
forse, che ci viene consegnato dal mondo pagano è allora il monito di Delfi, quel Conosci te stesso
che è ripreso da Eraclito quando dice Ho indagato me stesso. È la ricerca di sé, testimoniata
appunto dalla poesia. Ad esso possiamo riallacciarci per interrogare la nostra interiorità e riprendere
il cammino.