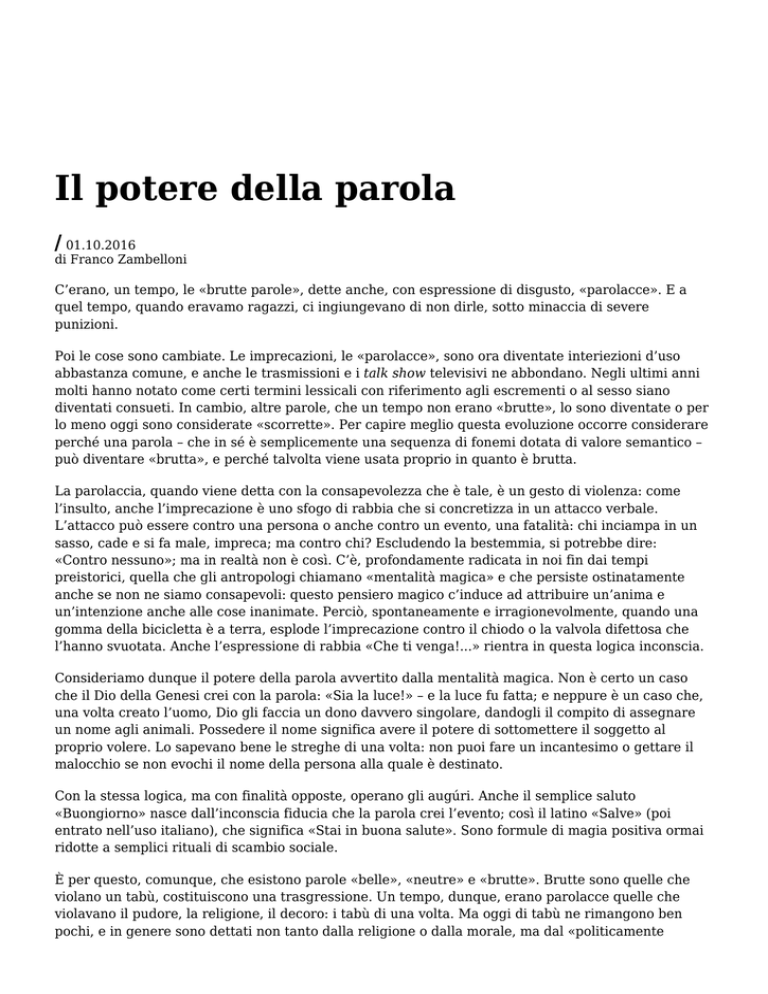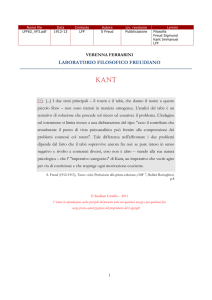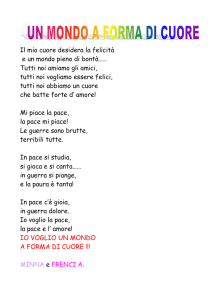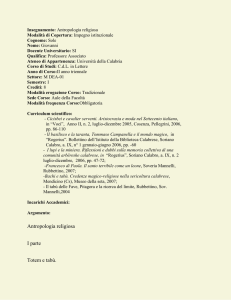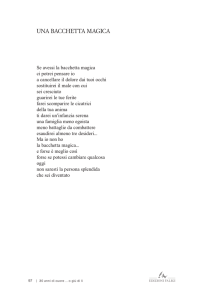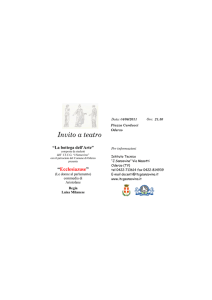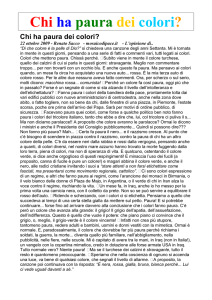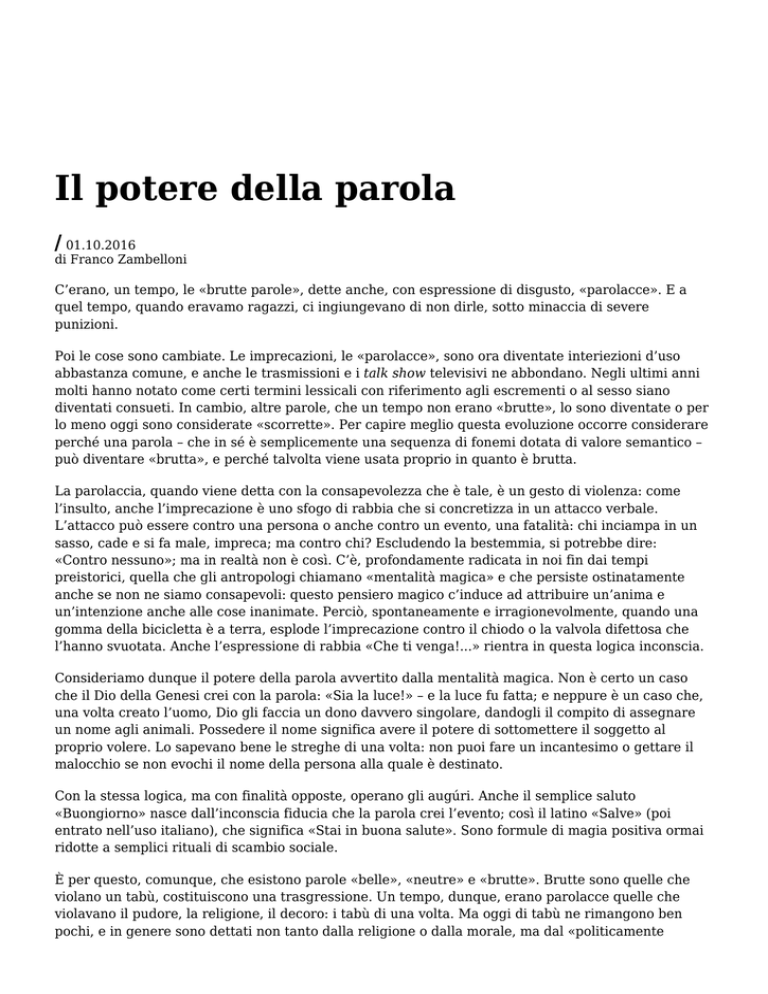
Il potere della parola
/ 01.10.2016
di Franco Zambelloni
C’erano, un tempo, le «brutte parole», dette anche, con espressione di disgusto, «parolacce». E a
quel tempo, quando eravamo ragazzi, ci ingiungevano di non dirle, sotto minaccia di severe
punizioni.
Poi le cose sono cambiate. Le imprecazioni, le «parolacce», sono ora diventate interiezioni d’uso
abbastanza comune, e anche le trasmissioni e i talk show televisivi ne abbondano. Negli ultimi anni
molti hanno notato come certi termini lessicali con riferimento agli escrementi o al sesso siano
diventati consueti. In cambio, altre parole, che un tempo non erano «brutte», lo sono diventate o per
lo meno oggi sono considerate «scorrette». Per capire meglio questa evoluzione occorre considerare
perché una parola – che in sé è semplicemente una sequenza di fonemi dotata di valore semantico –
può diventare «brutta», e perché talvolta viene usata proprio in quanto è brutta.
La parolaccia, quando viene detta con la consapevolezza che è tale, è un gesto di violenza: come
l’insulto, anche l’imprecazione è uno sfogo di rabbia che si concretizza in un attacco verbale.
L’attacco può essere contro una persona o anche contro un evento, una fatalità: chi inciampa in un
sasso, cade e si fa male, impreca; ma contro chi? Escludendo la bestemmia, si potrebbe dire:
«Contro nessuno»; ma in realtà non è così. C’è, profondamente radicata in noi fin dai tempi
preistorici, quella che gli antropologi chiamano «mentalità magica» e che persiste ostinatamente
anche se non ne siamo consapevoli: questo pensiero magico c’induce ad attribuire un’anima e
un’intenzione anche alle cose inanimate. Perciò, spontaneamente e irragionevolmente, quando una
gomma della bicicletta è a terra, esplode l’imprecazione contro il chiodo o la valvola difettosa che
l’hanno svuotata. Anche l’espressione di rabbia «Che ti venga!...» rientra in questa logica inconscia.
Consideriamo dunque il potere della parola avvertito dalla mentalità magica. Non è certo un caso
che il Dio della Genesi crei con la parola: «Sia la luce!» – e la luce fu fatta; e neppure è un caso che,
una volta creato l’uomo, Dio gli faccia un dono davvero singolare, dandogli il compito di assegnare
un nome agli animali. Possedere il nome significa avere il potere di sottomettere il soggetto al
proprio volere. Lo sapevano bene le streghe di una volta: non puoi fare un incantesimo o gettare il
malocchio se non evochi il nome della persona alla quale è destinato.
Con la stessa logica, ma con finalità opposte, operano gli augúri. Anche il semplice saluto
«Buongiorno» nasce dall’inconscia fiducia che la parola crei l’evento; così il latino «Salve» (poi
entrato nell’uso italiano), che significa «Stai in buona salute». Sono formule di magia positiva ormai
ridotte a semplici rituali di scambio sociale.
È per questo, comunque, che esistono parole «belle», «neutre» e «brutte». Brutte sono quelle che
violano un tabù, costituiscono una trasgressione. Un tempo, dunque, erano parolacce quelle che
violavano il pudore, la religione, il decoro: i tabù di una volta. Ma oggi di tabù ne rimangono ben
pochi, e in genere sono dettati non tanto dalla religione o dalla morale, ma dal «politicamente
corretto». L’allentarsi dei legami che una volta costituivano una comunità, la caduta dei limiti che un
tempo separavano il comportamento corretto da quello indecoroso, hanno fatto sì che le
imprecazioni e le bestemmie perdessero non poco di quell’effetto urtante e disgustoso che avrebbe
riempito d’indignazione i nostri avi. In cambio, si assiste a una progressiva censura di termini che
una volta non suonavano affatto sgradevoli: ad esempio, quelli relativi a un colore della pelle, o
quelli relativi all’età e alla condizione. «Vecchio» è una parola che viene sostituita da «anziano»;
quelli che una volta erano «invalidi» sono divenuti, col tempo, «handicappati», poi «disabili», e ora
«diversamente abili». Quello che una volta era un «matto» ora è uno «con disturbi mentali» o uno
«psicopatico». Le parole cambiano; purtroppo, la condizione rimane invariata.
Questi neologismi o eufemismi sono ovviamente inventati per non offendere, per eliminare parole
che in passato potevano implicare anche una condizione di inferiorità o di emarginazione sociale. Ciò
è conforme all’imperativo dominante del nostro tempo: tutti uguali, tutti ugualmente degni di
rispetto. Anche nelle parole, la nostra è la società più equa e più rispettosa dell’altro, di qualsiasi
condizione egli sia. Ma si sa: talvolta la parola serve anche per mentire.