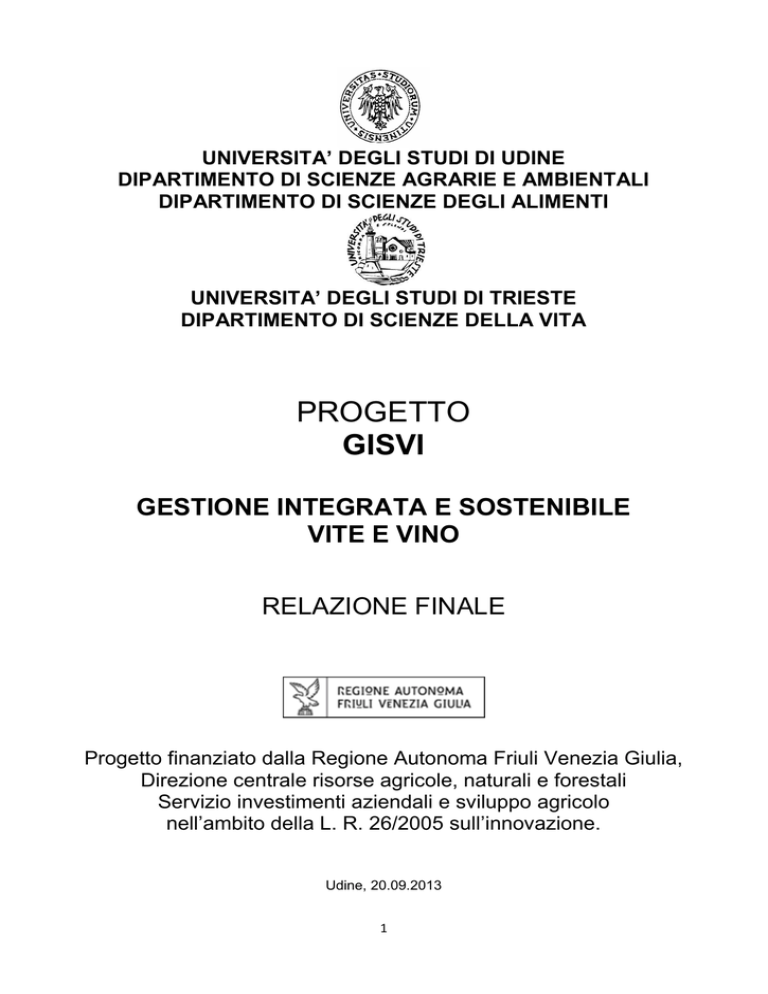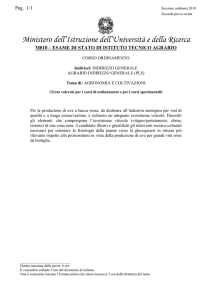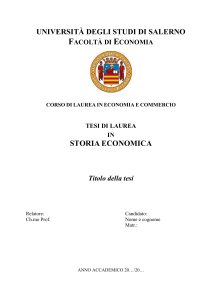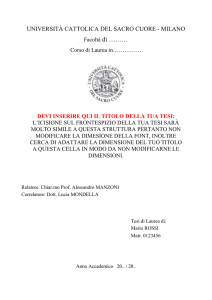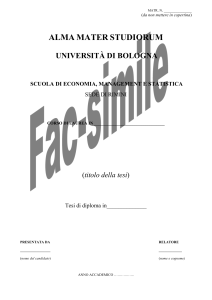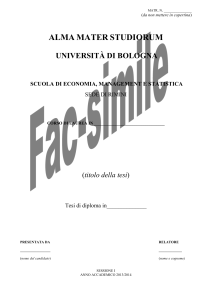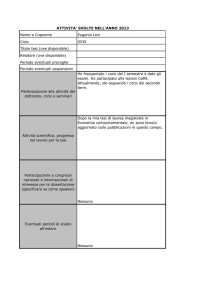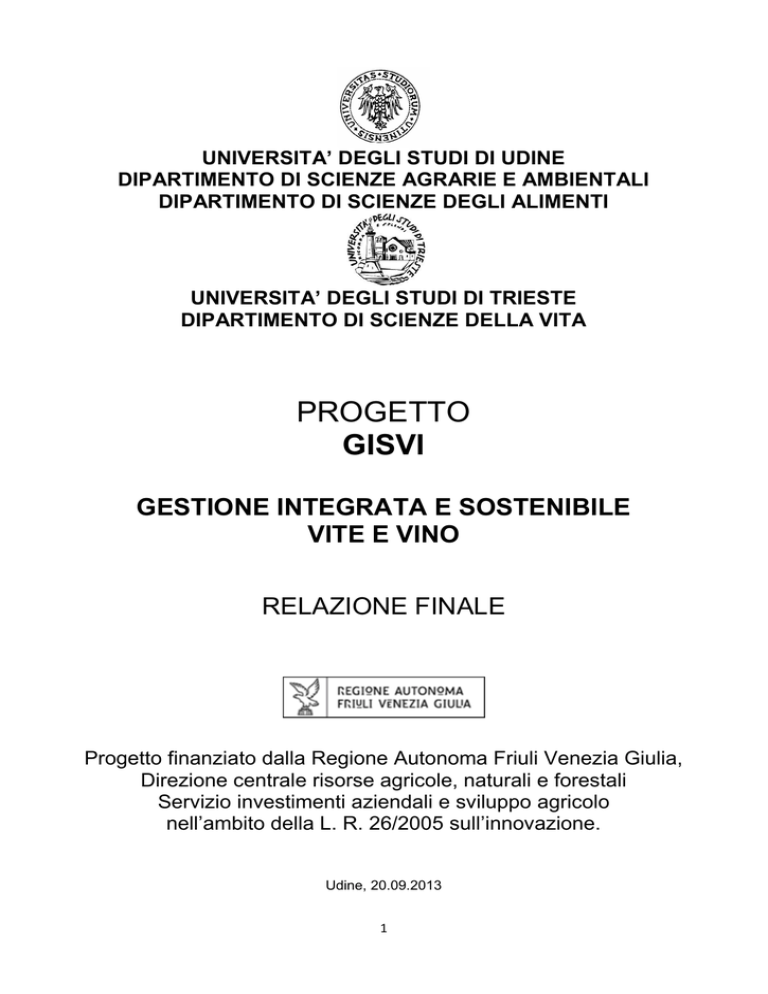
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
PROGETTO
GISVI
GESTIONE INTEGRATA E SOSTENIBILE
VITE E VINO
RELAZIONE FINALE
Progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali
Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
nell’ambito della L. R. 26/2005 sull’innovazione.
Udine, 20.09.2013
1
Alla stesura della presente relazione
hanno collaborato i ricercatori delle varie Unità Operative,
ciascuno per la parte di propria competenza.
2
Premessa
Il progetto “GISVI – Gestione integrata e sostenibile vite e vino” è stato finanziato dalla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della Legge Regionale n. 26 del 10
novembre 2005, cosiddetta “legge sull’innovazione” (articolo 17).
Il Progetto “Gestione Integrata e Sostenibile Vite-Vino” (GISVI) è un’iniziativa tecnicoscientifica che si è indirizzata verso il comparto vitivinicolo della Regione Friuli Venezia
Giulia, affrontando diversi aspetti di interesse per il settore.
L’approccio prescelto è stato quello interdisciplinare, attuato con attività di ricerca e
sperimentazione fra diverse unità di lavoro accademiche, in collaborazione con altre
strutture pubbliche e private del territorio friulano.
Al progetto hanno partecipato studiosi e ricercatori degli Atenei di Udine e Trieste con
competenze diversificate e complementari.
Lo studio ha affrontato aspetti agronomici, fisiologici, di selezione conservativa (di vitigni di
interesse regionale) e di protezione della vite da fitofagi, nonché di trasformazione
dell’uva.
Il criterio unificante di queste ricerche è stato quello della qualità della produzione (uve e
vini) e della riduzione dell’impatto ambientale delle attività agronomiche di campo ed
enologiche di cantina, della conservazione della biodiversità intravarietale, obiettivi che
possono essere conseguiti attraverso un miglioramento delle conoscenze su tutte le fasi
del processo produttivo e sul prodotto finale. Le diverse competenze messe in campo
hanno contribuito a delineare un’immagine articolata delle possibilità di ridurre l’impatto
ambientale dell’attività vitivinicola e di migliorare la qualità delle produzioni.
La durata prevista per il progetto era di 24 mesi dall’inizio delle attività, avvenuto in data 3
dicembre 2010. Nel corso del secondo anno, tuttavia, per poter meglio completare alcune
attività previste, è stata richiesta all’Amministrazione regionale, Direzione centrale risorse
agricole, naturali e forestali una proroga di sei mesi che è stata concessa: le attività
pertanto si sono concluse entro il 30 giugno 2013.
In questa relazione finale sono riportati i risultati scientifici e tecnici ottenuti dai vari gruppi
di ricerca partecipanti al progetto.
Il responsabile scientifico del progetto
Prof. Enrico Peterlunger
Udine, 20 settembre 2013
3
U.O. Viticoltura
Titolo del sottoprogetto: Strategie di gestione della carenza idrica per il miglioramento
qualitativo di uve coltivate in Friuli
Responsabile scientifico: Enrico Peterlunger
Collaboratori: Simone Diego Castellarin, Renato Frezza, Barbara Bucchetti, José Carlos Herrera
Nuñez
Dipartimento di scienze agrarie e ambientali, Università di Udine
L’effetto del deficit idrico sulla qualità delle uve e dei vini, è stato valutato su due varietà a bacca
rossa, Merlot e Pignolo e due varietà a bacca bianca, Ribolla Gialla e Tocai. La sperimentazione è
stata condotta per due anni, il 2011 e il 2012, presso i campi sperimentali dell’azienda agraria A.
Servadei, dell’Università di Udine. I filari delle quattro varietà sono stati suddivisi in parcelle nelle
quali sono stati applicati, in modo randomizzato, due trattamenti irrigui: controllo (C), ovvero piante
irrigate secondo i piani aziendali stabiliti, e deficit idrico (D), ovvero piante che dalla fioritura alla
raccolta sono state irrigate solo attraverso interventi di soccorso.
Monitoraggio delle condizioni idriche
Lo stato idrico delle piante è stato valutato mediante misure del potenziale idrico del fusto condotte
a cadenza settimanale con la camera a pressione di Scholander . Le piante irrigate delle tesi C
sono state mantenute ad un potenziale idrico compreso tra -0,4 e - 0,8 MPa nel corso di tutta la
stagione vegetativa. Le piante mantenute in deficit idrico della tesi D sono invece state
caratterizzate da valori di potenziale idrico più bassi rispetto a C in varie fasi della maturazione. Le
irrigazioni di soccorso sono state effettuate quando i potenziali idrici delle piante D raggiungevano
valori inferiori a -1,4 MPa.
Figura 1. Potenziale idrico del fusto per la varietà Merlot sotto copertura nel 2011 e 2012.
MERLOT 2011
MERLOT 2012
giorni dalla fioritura
20
30
40
50
60
70
80
90
giorni dalla fioritura
100
110
120
20
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
-1,4
-1,6
-1,8
40
50
60
70
0
potenziale idrico (MPa)
potenziale idrico (MPa)
0
30
C
D
invaiatura
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
-1,4
-1,6
4
C
D
invaiatura
80
90
100
110
120
I filari della varietà Merlot sono stati protetti da una struttura a tunnel con copertura in film EVA
(etilene e acetato di vinile) trasparente, allestita a partire da circa un mese dalla fioritura. In questo
modo si sono evitati i contributi idrici dovuti alle piogge e i potenziali idrici delle piante non irrigate
si sono differenziati da quelle irrigate da prima dell’invaiatura ed hanno mantenuto i potenziali idrici
più bassi di -1 MPa fino alla raccolta.
I filari delle altre tre varietà invece, non essendo stati protetti, hanno ricevuto anche apporti idrici di
tipo pluviometrico. Nel 2011 il contributo idrico fornito dalle precipitazioni atmosferiche nella prima
parte della stagione è stato abbastanza rilevante (185 mm di pioggia a Giugno, 148 a Luglio, 23
Agosto e 84 mm in Settembre) e i potenziali idrici delle tesi C e D si sono potuti differenziare più
tardi rispetto al Merlot e solo nell’ultimo mese di maturazione i potenziali della tesi D hanno
raggiunto valori inferiori a -1 MPa. Nel 2012 invece, i primi mesi della stagione produttiva si sono
presentati meno piovosi dell’anno precedente e, come per il Merlot, i potenziali idrici delle due tesi
si sono mantenuti differenziati da prima dell’invaiatura fino alla raccolta (114 mm di pioggia a
Giugno, 72 a Luglio, 94 Agosto e 201 mm in Settembre).
Figura 2. Potenziale idrico del fusto durante le annate 2011 e 2012 per le varietà in Pignolo, Ribolla e Tocai.
PIGNOLO 2011
PIGNOLO 2012
giorni dalla fioritura
20
30
40
50
60
70
80
giorni dalla fioritura
90
100
110
120
20
40
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
C
D
-1,2
invaiatura
-1,4
90
100
110
120
90
100
110
120
-0,8
-1
-1,2
C
D
-1,4
invaiatura
-1,6
RIBOLLA 2012
30
40
50
60
70
80
90
giorni dalla fioritura
100
110
120
20
0
-0,2
-0,2
potenziale idrico (MPa)
potenziale idrico (MPa)
80
-0,6
0
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
-1,8
70
-0,4
giorni dalla fioritura
20
-1,6
60
-0,2
RIBOLLA 2011
-1,4
50
0
potenziale idrico (MPa)
potenziale idrico (MPa)
0
30
C
D
invaiatura
40
50
60
70
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
-1,4
-1,6
-1,8
5
30
C
D
invaiatura
80
30
40
TOCAI 2012
giorni dalla fioritura
50
60
70
80
90
100
110
120
20
0
0
-0,2
-0,2
potenziale idrico (MPa)
potenziale idrico (MPa)
20
TOCAI 2011
giorni dalla fioritura
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
C
D
-1,4
-1,6
invaiatura
-1,8
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
C
D
-1,4
-1,6
invaiatura
-1,8
La maturazione delle uve è stata monitorata in varie fasi attraverso il campionamento degli acini e
le analisi dei loro principali componenti. A maturazione le uve sono state raccolte e analizzate. Nel
2011 sono state condotte le microvinificazioni relative alle diverse tesi.
In seguito vengono riportate le curve di maturazione delle uve relative alle quattro diverse varietà
nei due anni di sperimentazione, la composizione delle uve al momento della vendemmia e i dati
riguardanti i vini della stagione 2011.
VARIETA’ MERLOT
Figura 3. Curve di maturazione della varietà Merlot durante il 2011 e 2012
MERLOT 2012
2
1,5
1,5
1
C
D
0,5
peso acino (g)
peso acino (g)
MERLOT 2011
2
0
1
C
D
0,5
0
40
50
60
70
80
90
100
110
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
giorni dalla fioritura
25
25
20
20
15
10
C
D
5
zuccheri (°Brix)
zuccheri (°Brix)
giorni dalla fioritura
15
10
C
D
5
0
0
40
50
60
70
80
90
100
110
20
giorni dalla fioritura
30
40
50
60
70
80
giorni dalla fioritura
6
90
100
110
40
acidità (g/l acido tartarico)
acidità (g/l acido tartarico)
40
35
30
25
20
15
C
D
10
5
30
20
C
D
10
0
0
40
50
60
70
80
90
100
110
20
30
40
giorni dalla fioritura
3,5
3,5
pH
4
pH
4
3
2,5
60
70
80
90
100
110
100
110
3
C
D
2,5
C
D
2
2
40
50
60
70
80
90
100
110
20
30
40
giorni dalla fioritura
50
60
70
80
90
giorni dalla fioritura
1,5
1,5
1,25
1,25
1
0,75
0,5
C
D
0,25
antociani (g/kg uva)
antociani (G/kg uva)
50
giorni dalla fioritura
1
0,75
0,5
C
D
0,25
0
0
40
50
60
70
80
90
100
20
110
30
40
50
60
70
80
90
100
110
giorni dalla fioritura
giorni dalla fioritura
4
tannini (g/kg uva)
tannini (g/ kg uva)
5
3
2
C
D
1
0
3
C
D
0
40
50
60
70
80
90
100
110
20
giorni dalla fioritura
30
40
50
60
70
80
giorni dalla fioritura
7
90
100
110
Nei due anni di sperimentazioni le condizioni di carenza idrica hanno determinato una diminuzione
delle dimensioni dell’acino. I pesi degli acini delle tesi C e D hanno cominciato a divergere circa
all’invaiatura e da questo momento fino alla raccolta si nota un incremento di queste differenze.
L’accumulo degli zuccheri ha avuto un andamento sovrapponibile nelle uve delle tesi C e D per
quasi tutta la maturazione, negli ultimi giorni dalla raccolta tuttavia, in entrambi gli anni di
sperimentazione, le uve della tesi D manifestano un incremento di gradi Brix rispetto alla tesi C.
L’acidità ed il pH del succo non sono stati influenzati dai diversi trattamenti irrigui.
In riferimento alla composizione fenolica delle bucce la concentrazione di antociani e di tannini è
risultata maggiore nelle uve della tesi D rispetto a C. Durante il 2011 le differenze tra le
concentrazioni di questi metaboliti nelle uve delle due tesi si manifestano solo nelle ultime
settimane di maturazione, nel 2012 invece le differenze si iniziano a definire più precocemente e si
mantengono fino alla raccolta.
Merlot. Analisi uve alla vendemmia, 2011-2012.
Peso acino (g)
Produzione per
pianta (kg)
trattamento
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
C
1,85
1,44
4,65
3,32
22,2
23,2
3,5
3,5
6,0
5,9
0,79
0,80
1,05
0,95
D
1,46
1,14
3,42
2,09
23,3
24,6
3,5
3,6
5,9
6,0
1,35
1,49
1,37
1,43
Significatività
Effetto irrigazione
Effetto anno
ns
ns
***
***
Brix
pH
*
*
ns
ns
Acidità
ns
ns
Antociani
(g/kg uva)
*
ns
Tannini
(g/kg uva)
ns
ns
La tabella relativa all’analisi delle uve alla vendemmia mette in evidenza che nella varietà Merlot le
condizioni di deficit idrico hanno determinato un notevole calo nel peso dell’acino e conseguente
diminuzione della produzione per pianta. Per quanto riguarda la composizione dell’uva il pH e
l’acidità del succo non hanno subito variazioni in risposta ai due trattamenti irrigui, mentre la
concentrazione di alcuni soluti, quali zuccheri e antociani e tannini delle bucce, è aumentata nelle
uve della tesi D rispetto al controllo C.
8
Merlot. Vini 2011.
Titolo
alcolimetrico
(ml/100ml)
pH
Estratto secco
(g/l)
Acidità totale
(acido tartarico
g/l)
trattamento
C
12,79
3,55
27,5
5,8
D
13,42
3,40
29,3
6,2
Anche nei vini si sono manifestati gli effetti dovuti ai diversi trattamenti irrigui;
le analisi
biochimiche infatti hanno messo in evidenza che i vini provenienti dalle uve D presentano un grado
alcolico più elevato dei vini C ed un maggior contenuto di polifenoli, quali antociani e tannini,
responsabili del colore e della struttura del vino. Quest’ultimo dato trova conferma anche nelle
analisi sensoriali dalle quali è emerso che i vini D rispetto a quelli C presentano una colorazione
più intensa, abbinata ad una maggiore corposità e ad un incremento della componente aromatica
data da note quali frutti rossi, marmellata e spezie.
VARIETA’ PIGNOLO
Figura 4. Curve di maturazione della varietà Pignolo durante il 2011 e 2012
PIGNOLO 2012
2
2
1,5
1,5
peso acino (g)
peso acino (g)
PIGNOLO 2011
1
0,5
C
D
invaiatura
1
invaiatura
0
0
70
80
90
100
110
120
50
60
giorni dalla fioritura
70
80
90
100
giorni dalla fioritura
25
25
20
20
zuccheri (°Brix)
zuccheri (°Brix)
C
D
0,5
15
10
C
D
5
15
10
C
D
5
0
0
70
80
90
100
110
120
50
giorni dalla fioritura
60
70
80
giorni dalla fioritura
9
90
100
40
acidità (g/l acido tartarico)
acidità (g/l acido tartarico)
40
30
20
C
D
10
0
30
20
C
D
10
0
70
80
90
100
110
120
50
60
4
4
3,5
3,5
3
2,5
90
100
3
C
D
2
70
80
90
100
110
120
50
60
giorni dalla fioritura
70
80
90
100
giorni dalla fioritura
1,5
1,5
1,25
1,25
antociani (g/ kg uva)
antociani (g/kg uva)
80
2,5
C
D
2
1
0,75
0,5
C
D
0,25
0
1
0,75
0,5
C
D
0,25
0
70
80
90
100
110
120
50
60
giorni dalla fioritura
15
15
12
12
9
C
D
6
70
80
90
100
90
100
giorni dalla fioritura
tannini(g/ kg uva)
tannini (g/ kg uva)
70
giorni dalla fioritura
pH
pH
giorni dalla fioritura
3
0
9
6
C
D
3
0
70
80
90
100
giorni dalla fioritura
110
120
50
60
70
80
giorni dalla fioritura
Come visto per Merlot, anche nella varietà Pignolo gli acini della tesi D sono più piccoli rispetto al
controllo. La differenza tra il peso delle bacche delle due tesi non è molto accentuata, tuttavia si
10
manifesta in entrambi gli anni, per quasi tutte le date di campionamento. L’andamento dei gradi
Brix nel 2011 non risulta influenzato dall’irrigazione, nel 2012 invece durante gli ultimi due rilievi i
gradi Brix delle uve C sono risultati sensibilmente maggiori rispetto alla tesi D. Gli altri parametri
analizzati, cioè acidità e pH del succo e concentrazione di antociani e tannini delle bucce, sono
stati influenzati dai diversi regimi irrigui in modo non significativo.
Pignolo. Analisi uve alla vendemmia, 2011-2012.
Peso acino (g)
Produzione per
pianta (kg)
trattamento
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
C
1,33
1,47
2,0
1,17
23,3
22,1
3,7
3,6
5,5
6,2
1,12
1,16
3,59
4,2
D
1,21
1,30
2,2
1,19
23,7
19,8
3,8
3,6
5,2
5,9
1,13
1,19
3,23
4,0
Significatività
Effetto irrigazione
Effetto anno
ns
ns
ns
*
Brix
pH
ns
ns
Acidità
ns
ns
ns
*
Antociani
(g/kg uva)
ns
ns
Tannini
(g/kg uva)
ns
*
Da quanto osservato nei due anni di sperimentazione la produzione del Pignolo, si è rivelata
essere influenzata dalle condizioni di carenza idrica in modo diverso rispetto al Merlot. In questo
caso il peso dell’acino è diminuito di poco nella tesi D rispetto alla C, inoltre le condizioni di deficit
idrico non hanno provocato alcun incremento nel contenuto di metaboliti quali antociani e tannini
delle bucce, come visto invece per la varietà Merlot. Il contenuto di zuccheri, valutato in gradi Brix,
è risultato nel 2011 poco più elevato nella tesi D rispetto al controllo; nel 2012 invece la
concentrazione zuccherina è nettamente più elevata in C rispetto a D. Il pH e l’acidità del succo
invece non sono stati influenzati dall’irrigazione.
L’unica differenza emersa dalle analisi biochimiche dei vini relativi all’anno 2011 riguarda il loro
grado alcolico, che è risultato complessivamente minore nella tesi C rispetto a D. Anche l’analisi
sensoriale non ha rivelato differenze sostanziali tra i due trattamenti, a parte la componente
olfattiva che si è rivelata lievemente più intensa nei vini C.
11
Pignolo. Vini 2011.
Titolo
alcolimetrico
(ml/100ml)
pH
Estratto secco
(g/l)
Acidità totale
(acido tartarico
g/l)
trattamento
C
13,03
4,16
33,6
4,3
D
13,42
4,22
35,0
4,3
VARIETA’ RIBOLLA GIALLA
Figura 5. Curve di maturazione della varietà Ribolla durante il 2011 e 2012.
RIBOLLA 2012
2,5
2
2
1,5
1
C
D
0,5
peso acino (g)
peso acino (g)
RIBOLLA 2011
2,5
1,5
1
C
D
0,5
0
0
60
70
80
90
100
110
120
50
60
20
20
15
15
10
80
90
100
C
D
5
10
0
C
D
5
0
60
70
80
90
100
110
120
50
60
giorni dalla fioritura
70
80
90
100
90
100
giorni dalla fioritura
40
acidità (g/l acido tartarico)
40
acidità (g/l acido tartarico)
70
giorni dalla fioritura
zuccheri (°Brix)
zuccheri (°Brix)
giorni dalla fioritura
30
20
C
D
10
0
30
20
C
D
10
0
60
70
80
90
100
110
50
giorni dalla fioritura
60
70
80
giorni dalla fioritura
12
4
3,5
3,5
pH
pH
4
3
2,5
3
C
D
2,5
C
D
2
2
60
70
80
90
100
50
110
60
70
80
90
100
giorni dalla fioritura
giorni dalla fioritura
L’andamento del peso degli acini delle due tesi mette in evidenza che, soprattutto nel 2012, le
condizioni di carenza idrica hanno ridotto le dimensioni delle bacche. La concentrazione degli
zuccheri nel corso della maturazione nel 2011 è maggiore nella tesi D rispetto al controllo, nel
2012 invece le curve relative all’accumulo di zuccheri nelle due tesi sono praticamente identiche.
L’acidità del succo ha un andamento simile nelle due tesi tuttavia in quasi tutti i rilievi questo
parametro risulta inferiore nella tesi D rispetto a C. L’ effetto del regime idrico differenziato sul pH
si è manifestato solo nel 2011, quando il pH della tesi D è risultato più elevato rispetto alla C
soprattutto nelle ultime fasi di maturazione.
Ribolla. Analisi uve alla vendemmia, 2011-2012.
Peso acino (g)
Produzione per
pianta (kg)
trattamento
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
C
2,25
1,80
6,27
5,20
16,8
16,5
3,2
3,3
5,8
6,7
D
2,20
1,31
4,28
3,33
18,1
16,2
3,5
3,4
4,9
5,5
Significatività
Effetto irrigazione
Effetto anno
ns
ns
Brix
ns
**
*
ns
pH
ns
ns
Acidità
*
ns
L’analisi delle uve al momento della raccolta ha messo in evidenza che in Ribolla Gialla il deficit
idrico induce un calo nel peso dell’acino e di conseguenza della produzione per pianta. L’accumulo
degli zuccheri, così come il pH del succo non sono stati sostanzialmente influenzati dalle diverse
gestioni idriche. L’acidità titolabile, al momento della raccolta, si è presentata sensibilmente
inferiore nelle uve della tesi D rispetto al controllo. L’abbassamento dell’acidità titolabile delle uve
in risposta alla carenza idrica si è tradotto in una riduzione dell’acidità del vino, caratteristica che è
13
emersa sia dalle analisi biochimiche che da quelle sensoriali. Altre differenze tra le due tipologie di
vini non sono state riscontrate.
Ribolla. Vini 2011.
Titolo
alcolimetrico
(ml/100ml)
pH
Estratto secco
(g/l)
Acidità totale
(acido tartarico
g/l)
trattamento
C
9,50
3,24
20,5
6,7
D
9,85
3,25
18,5
5,7
VARIETA’ TOCAI
Figura 6. Curve di maturazione della varietà Tocai durante il 2011 e 2012
TOCAI 2012
2,5
2,5
2
2
1,5
1
C
D
0,5
peso acino (g)
peso acino (g)
TOCAI 2011
1,5
1
C
D
0,5
0
0
40
50
60
70
80
90
100
110
20
30
40
50
60
70
80
90
100
giorni dalla fioritura
25
25
20
20
15
10
C
D
5
zuccheri (°Brix)
zuccheri (°Brix)
giorni dalla fioritura
15
10
C
D
5
0
0
40
50
60
70
80
90
100
110
giorni dalla fioritura
20
30
40
50
60
70
giorni dalla fioritura
14
80
90
100
40
acidità (g/l acido tartarico)
acidità (g/l acido tartarico)
40
30
20
C
D
10
30
20
C
D
10
0
0
40
50
60
70
80
90
100
110
20
30
40
50
60
70
80
90
100
90
100
giorni dalla fioritura
4
4
3,5
3,5
pH
pH
giorni dalla fioritura
3
2,5
3
C
D
2,5
C
D
2
2
40
50
60
70
80
90
100
110
giorni dalla fioritura
20
30
40
50
60
70
80
giorni dalla fioritura
In questa varietà le curve di maturazione delle due tesi relative al 2011 sono sovrapponibili quasi
completamente, tranne che per gli ultimi rilievi. Nel 2011 infatti la differenziazione del potenziale
idrico tra le due tesi è iniziata solo un mese prima della raccolta, quindi l’effetto di questo fattore
ha potuto manifestarsi solamente nell’ultimo periodo di maturazione, quando si nota nella tesi D
rispetto alla C un calo del peso dell’acino e dei gradi Brix, ed un aumento del pH. Nel 2012 invece,
anno nel quale le condizioni di carenza idrica si sono stabilite dalle prime fasi di maturazione, le
curve di crescita e di accumulo di zuccheri delle due tesi iniziano a divergere precocemente. In
particolare si nota che il peso delle bacche della tesi D è minore di quello della tesi C da prima
dell’invaiatura, i gradi Brix invece risultano maggiori in D rispetto a C. L’acidità è più alta in D
rispetto a C solo prima dell’invaiatura, dopodiché questa tendenza si inverte nelle ultime settimane
di maturazione. Il pH è più alto nella tesi D prima dell’invaiatura e al momento della raccolta.
15
Tocai. Analisi uve alla vendemmia, 2011-2012.
Peso acino (g)
Produzione per
pianta (kg)
trattamento
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
C
1,79
1,47
3,18
3,27
21,9
21,5
3,6
3,7
5,6
5,1
D
1,66
1,28
3,08
2,52
20,4
23,4
3,7
3,8
4,9
4,4
Significatività
Effetto irrigazione
Effetto anno
ns
*
Brix
ns
ns
ns
ns
pH
Acidità
ns
ns
*
*
Anche in Tocai le condizioni di carenza idrica hanno determinato calo di produzione per pianta e
diminuzione dell’acidità del mosto e dei vini. Il Tocai si è rivelato una varietà particolarmente
sensibile alle condizioni di deficit idrico, infatti nel corso del secondo anno di sperimentazione,
durante il quale a causa della scarsità delle piogge lo stress idrico si è protratto per più lungo
tempo rispetto all’annata precedente, alcune piante della tesi D sono decedute improvvisamente.
Questi eventi non sono stati preceduto da evidenti sintomi di stress da parte delle piante o da
abbassamenti del potenziale idrico al di sotto di valori soglia, che avrebbero indotto al ricorso
dell’irrigazione di soccorso.
Tocai. Vini 2011.
Titolo
alcolimetrico
(ml/100ml)
pH
Estratto secco
(g/l)
Acidità totale
(acido tartarico
g/l)
trattamento
C
13,37
3,69
23,1
5,3
D
14,39
3,66
27,5
4,7
CONCLUSIONI
Questi risultati si presentano molto interessanti nell’ottica di un utilizzo ragionato delle risorse
idriche mirato all’ottenimento di prodotti di qualità, in particolare le sperimentazioni condotta sulle
quattro varietà hanno messo in evidenza come genotipi diversi dimostrino risposte specifiche alla
carenza idrica.
16
Nelle varietà Tocai, Ribolla Gialla e Merlot le condizioni di carenza idrica hanno comportato un calo
del peso medio dell’acino e conseguentemente della produzione per pianta. Per la varietà Merlot si
è osservato tuttavia che, a discapito della riduzione della produzione per pianta, le condizioni di
deficit idrico hanno permesso di ottenere uva e vino di qualità maggiori, soprattutto grazie
all’incremento della concentrazione di polifenoli, quali antociani e tannini.
Per Ribolla Gialla e Tocai invece, non si può affermare che la diminuzione della produzione,
osservata nelle tesi D, sia stata controbilanciata da un incremento nella qualità delle uve. In queste
due varietà a bacca bianca infatti le uve e i vini delle tesi D presentavano una minor acidità
rispetto alla tesi C. Questo tipo di effetto si è percepito anche dalle analisi sensoriali; l’acidità infatti
rappresenta una caratteristica importante per connotare vini bianchi freschi o spumantizzati, come
quelli che si ottengono da queste due varietà.
A differenza delle altre tre varietà i due anni di sperimentazione condotti in Pignolo non hanno
messo in evidenza sostanziali differenze né di tipo quantitativo, né qualitativo tra le uve e i vini
derivati dalle due tesi, a parte un lieve calo del contenuto zuccherino delle uve e conseguente
diminuzione del grado alcolico dei vini, osservato nella tesi D rispetto alla C.
PUBBLICAZIONI
1. B. Bucchetti, F. Cossarini, S.D. Castellarin, E. Peterlunger, 2012. Effetto dello stress idrico
e della cimatura tardiva su uve e vini della varietà Merlot. Atti del CONAVI, Convegno
Nazionale di Viticoltura, Società Orticola Italiana, Asti 10-12 luglio 2012 (in corso di
pubblicazione).
17
U.O. Chimica agraria
Titolo del sottoprogetto: Interazioni tra l’assorbimento di azoto e zolfo in barbatelle di
vite allevate in idroponica
Responsabile scientifico: Roberto Pinton
Collaboratori: Nicola Tomasi, Rossella Monte
Dipartimento di scienze agrarie e ambientali, Università di Udine
Il progetto GSVI, che prosegue le attività iniziate con il precedente progetto denominato
“Miglioramento delle produzioni viti-vinicole in Friuli Venezia Giulia: sostenibili, di qualità e nel
rispetto dell’ambiente” (Progetto “Villanova") e già finanziato dalla L.R. 26, ha come obiettivi
generali il miglioramento della qualità dei prodotti vitivinicoli della regione FVG e la riduzione
dell’impatto ambientale delle coltivazione, mediante azioni coordinate e integrate.
In quest’ottica si colloca l’attività dell’U.O. che ha considerato gli aspetti fisiologici della nutrizione
azotata e le interazioni tra l’azoto e altri nutrienti, importanti nel determinare le caratteristiche qualiquantitative del prodotto, quali lo zolfo. Obiettivo generale di questa U.O. era acquisire informazioni
utili per una migliore gestione dell’apporto nutrizionale in viticoltura che permetta, a parità di
qualità, una diminuzione dell’impatto ambientale della fertilizzazione e per impostare programmi di
miglioramento genetico per una maggior efficienza nutrizionale.
Descrizione dell’attività e risultati ottenuti
L'assorbimento del nitrato è stato ampiamente caratterizzato in numerose piante erbacee e
descritto come un processo dinamico e regolato dallo stato nutrizionale delle piante. Limitate sono
invece le informazioni relative ai meccanismi operanti nelle piante arboree da frutto e in particolare
quelle riguardanti la vite, per lo più ottenute con approcci di campo e di serra o applicando
particolari situazioni di stress.
In uno studio precedente era stato dimostrato che radici di barbatelle innestate di due cloni di
Chardonnay (R8 e VCR4) e Sauvignon (R3 e CL297), a diverso grado aromatico e caratterizzati
da risposta differente in campo alla concimazione azotata in termini di aromi primari presenti
nell’uva, quando poste a contatto con il nitrato dopo un breve periodo di deprivazione di azoto,
sviluppavano una maggior velocità di assorbimento dell’anione stesso (induzione); questa fase era
seguita da una diminuzione della velocità di assorbimento (retro-regolazione), dovuta all’accumulo
di nitrato e dei suoi metaboliti nella pianta. Le variazioni della velocità di assorbimento del nitrato
erano, tuttavia, dipendenti dal clone considerato e apparivano solo in parte influenzate dal
portinnesto.
18
Le informazioni sui meccanismi di assorbimento dello zolfo, e in particolare dell’anione solfato in
vite sono scarse, pur a fronte dell’importanza che questo elemento sta assumendo ai fini della
qualità e della salvaguardia della produzione.
E’ noto che l’assorbimento e il metabolismo del nitrato possono essere influenzati dalla
disponibilità di altri elementi nutritivi e che esistono, in particolare, interazioni tra l’assorbimento e il
metabolismo di azoto e zolfo.
Nella presente ricerca sono stati indagati gli effetti a breve termine che la variazione di disponibilità
di solfato in soluzione nutritiva, può determinare nei confronti dei meccanismi sottesi all’induzione
dell’assorbimento del nitrato. Per lo studio sono state utilizzate barbatelle dei due cloni di
Chardonnay (R8 e VCR4) e Sauvignon (R3 e CL297) innestate su K5BB ed è stato impiegato un
metodo di allevamento in idroponica, che permette di operare in condizioni di temperatura,
illuminazione e umidità controllate, e di modulare la disponibilità nutrizionale. Un primo obiettivo
era quindi la validazione di questo metodo di allevamento. Sono state utilizzate due diverse
condizioni sperimentali che prevedevano, dopo un periodo di crescita delle barbatelle in condizioni
di completa disponibilità nutrizionale, fasi di allevamento in cui erano imposti variabili livelli di
disponibilità delle fonti azotate e solfatiche.
1) Nella prima serie di esperimenti le barbatelle erano assoggettate a una fase di deprivazione di
nitrato e solfato per 10 giorni e successivamente una parte era sottoposta a trattamento per 24 ore
con entrambi gli anioni mentre una parte era posta a contatto con solo nitrato. Le misure della
velocità di assorbimento del nitrato hanno mostrato che in presenza di solfato, ambedue i cloni di
Chardonnay presentavano il fenomeno dell’induzione, ma con dinamiche differenti, confermando
precedenti osservazioni. Nel clone R8, infatti, il fenomeno avveniva più rapidamente e con
intensità maggiore. Quando le radici erano poste in soluzione priva di solfato, l’induzione era
ancora osservabile, ma in ambedue i cloni si verificava in tempi più lunghi. Un comportamento
simile era già stato osservato anche in piante erbacee, a conferma dell’esistenza di
un’interdipendenza tra assorbimento di nitrato e di solfato.
Anche nei cloni di Sauvignon trattati con nitrato si confermava l’andamento osservato in precedenti
ricerche, con il clone R3 che presentava una limitata induzione, mentre il clone CL297 non subiva
variazioni della velocità di trasporto del nitrato a seguito dell’esposizione delle radici all’anione. In
ambedue i cloni di Sauvignon l’omissione di solfato dalla soluzione di trattamento non modificava
significativamente la dinamica dell’assorbimento del nitrato. Questi dati indicano che queste piante
possiedono una scarsa o nulla reattività dei meccanismi di assorbimento del nitrato alle variazioni
di disponibilità esterne di nitrato e solfato.
Le misure della velocità di assorbimento del
35
SO42- condotte nelle medesime condizioni di
allevamento mostravano come le piante in precedenza deprivate di nitrato e solfato e
successivamente rifornite con entrambi gli anioni, presentassero una diminuzione della velocità di
19
assorbimento del solfato; al contrario, le piante che continuavano ad esserne deprivate
sviluppavano una maggior capacità di assorbimento del solfato con un aumento pressoché lineare
fino al termine dell’esperimento. Tale fenomeno è stato osservato e ampiamente caratterizzato
anche in altre specie vegetali e conferma la presenza di un meccanismo di de-repressione
dell’assorbimento di questo anione. Questi risultati sono anche in linea con quanto osservato in
colture cellulari di Vitis vinifera e Vitis rupestris.
In una seconda serie di esperimenti, le piante sono state sottoposte a un periodo di deprivazione
del nitrato di durata maggiore (20 giorni); per evidenziare il ruolo del solfato, l’anione, in questo
caso, era somministrato durante tutto il periodo di allevamento e del successivo trattamento (24
ore) ovvero rimosso, come il nitrato, per 20 giorni dalla soluzione di allevamento e durante il
successivo trattamento di 24 ore con nitrato.
Per quanto riguarda le misure di assorbimento del nitrato i risultati ottenuti hanno messo in luce
come l’omissione del solfato nella soluzione nutritiva determinasse una drastica diminuzione
dell’induzione di una maggiore capacità di assorbimento del nitrato, confermando come la carenza
di zolfo possa limitare la capacità delle radici di assorbire il nitrato e di rispondere alle variazioni
dell’anione nella soluzione esterna.
L’effetto di una prolungata deprivazione di zolfo era evidenziato anche dalle misure della velocità di
assorbimento del
35
SO42-: nelle radici di barbatelle deprivate per 20 giorni del nitrato e del solfato,
la velocità di assorbimento del
35
SO42- mostrava valori molto elevati e non ulteriormente
incrementabili.
Anche in questo caso, comunque, i diversi cloni di Chardonnay e Sauvignon si comportavano in
modo simile per quanto riguarda l’assorbimento del
35
SO42-, mentre permanevano le differenze
nell’assorbimento del nitrato, indicando un’interazione variabile tra l’assorbimento dei due anioni in
funzione del clone considerato. In questo caso, però, anche per il clone aromatico di Sauvignon
(R3) si osservava un effetto depressivo della carenza di zolfo sull’assorbimento del nitrato.
2) Oltre all’analisi fisiologica dei meccanismi di assorbimento del nitrato è stata eseguita l’analisi
molecolare valutando l’espressione di geni codificanti per proteine coinvolte nel trasporto e il
metabolismo dell’anione. Per questi esperimenti sono state utilizzate barbatelle dei due cloni di
Sauvignon (R3 e CL297) innestate su K5BB. In particolare sono state determinate le variazioni a
livello radicale nei livelli di trascritti dei seguenti geni: VvNRT2 (trasportatori del nitrato ad alta
affinità), VvNaxt (trasportatore coinvolto nell'efflusso del nitrato), VvNR1 (Nitrato-Riduttasi, enzima
coinvolto nella riduzione del nitrato a nitrito), VvNiR (Nitrito-Riduttasi, enzima coinvolto nella
riduzione
del
nitrito
ad
ammonio),
VvGS
(Glutammina-Sintetasi,
enzima
coinvolto
nell’organicazione dell'ammonio).
I risultati confermano che in vite non vi è una chiara relazione tra variazione dei livelli di trascritti di
NRT2 e velocità di assorbimento del nitrato, pur con una tendenziale minore espressione nelle
20
radici cresciute senza zolfo. E’ stato invece osservato come il livello di espressione di NAXT sia
maggiore nelle radici (R3 -S) che mostrano minore sviluppo dell’induzione dell’assorbimento
dell’anione quando deprivate di zolfo.
Per quanto riguarda i geni che codificano per enzimi coinvolti nel metabolismo del nitrato, in
condizioni di limitata disponibilità di zolfo è stata evidenziata una minore espressione di quelli
relativi alla riduzione dell’anione (Nitrato- e Nitrito- Riduttasi) e una maggiore espressione della
Glutammina-Sintetasi, primo enzima dell’assimilazione dell’ammonio.
Questi risultati suggeriscono che, in assenza di solfato, la riduzione del nitrato rallenti con
conseguente temporaneo incremento della concentrazione interna di nitrato che, a sua volta,
determinerebbe
limitazione
dell’influsso,
aumento
dell’efflusso
dell’anione
e
induzione
dell’assimilazione.
3) Considerando che è noto che la nutrizione può influenzare le caratteristiche qualitative dell’uva,
pur non essendo noti i meccanismi biochimici e molecolari alla base di questi effetti, è stato
condotto anche uno studio per verificare se le condizioni di allevamento imposte potessero
modificare alcune caratteristiche degli acini.
Per quanto riguarda questi esperimenti è da precisare che i risultati sono preliminari e
forzatamente riferiti ai cloni di Sauvignon, perché solo questi avevano prodotto grappoli, sia pur in
quantità limitata e variabile.
Dalle misure relative al grado zuccherino è emerso come tutti i campioni presentassero valori
superiori ai 20 °Brix, in alcuni casi arrivando fino a 23-24 °Brix. Ciò indicava come le piante
allevate in soluzione idroponica fossero riuscite a portare a termine il ciclo di maturazione dei frutti
garantendo una corretta fermentazione alcolica nonostante i valori di pH mediamente elevati
registrati nei succhi ottenuti dagli acini.
Nonostante il numero limitato di campioni è stato possibile eseguire un’analisi della varianza a due
vie che ha evidenziato l’influenza del trattamento sul peso medio dell’acino (utilizzando il clone e la
condizione nutritiva come fattori, P=0,027*) e l’influenza del clone sul grado zuccherino, condizione
non influenzata dal diverso trattamento con solfato (P=0,047*). L’incremento del peso medio degli
acini nei trattamenti deprivati di zolfo potrebbe indicare un’allocazione preferenziale dei metaboliti
in questi organi, in condizioni di carenza nutrizionale.
Riguardo alle analisi della concentrazione di 3-isobutil-2-metossipirazina (IBMP), composto
aromatico tipico del Sauvignon, è stata osservata una tendenza delle piante allevate in assenza di
zolfo (a prescindere quindi dal clone) a sintetizzare una maggior quantità del composto. Anche in
questo caso il numero limitato dei dati non permette di trarre conclusioni definitive, ma conferma la
potenziale utilità dei metodi di allevamento in ambiente controllato e soluzione idroponica per studi
relativi a questi caratteri.
21
Dalla ricerca è emerso chiaramente come le risposte alle fluttuazioni di nitrato nella soluzione del
terreno, che si verificano a livello fisiologico e molecolare in vite, siano determinate principalmente
dalle caratteristiche della cultivar e dello specifico clone, con differenze significative tra cloni
aromatici e non; appare inoltre confermato come il contributo dell’efflusso di nitrato, così come
indicato dall’analisi di espressione genica dei trasportatori di membrana, sia rilevante per
determinare il comportamento fisiologico delle radici.
E’ stato dimostrato che la scarsa disponibilità di solfato può modulare negativamente l’induzione
dell’assorbimento del nitrato, con effetti variabili in funzione della cultivar e del clone. Tale
osservazione è corroborata dall’analisi dell’espressione genica dei trasportatori e degli enzimi
coinvolti nel processo di acquisizione e assimilazione del nitrato. La disponibilità di solfato può
inoltre influenzare le caratteristiche del frutto con particolare riferimento al pH, grado zuccherino e
presenza di composti aromatici nel succo. I risultati di questa ricerca possono costituire
un’importante base di partenza per l’individuazione di parametri utili ai fini di una corretta gestione
della fertilizzazione in vite.
Attività di divulgazione e pubblicazione dei risultati:
R.
Monte,
N.
Tomasi,
S.
Cesco,
R.
Pinton
(2012)
Effetto
della
disponibilità
di zolfo sull’assorbimento di nitrato e di solfato in barbatelle di vite allevate in soluzione idroponica.
Riassunti del XXX Convegno Nazionale della Società Italiana di Chimica Agraria, Milano, p. 25.
R. Monte, N. Tomasi, S. Cesco, R. Pinton (2012) Interazione tra disponibilità di zolfo e nitrato in
radici di barbatelle di vite allevate in soluzione idroponica. Acta - Italus Hortus n. 7 - Atti del X
Convegno AISSA, Palermo, p. 31.
R. Monte, N. Tomasi, R. Pinton. Interazioni tra l'assorbimento di azoto e zolfo in barbatelle di vite
allevate in idroponica. Convegno sui risultati del primo anno di attività del Progetto GISVI Gestione integrata e sostenibile vite e vino, Azienda Agraria “A. Servadei”, Università di Udine, 19
aprile 2012.
R. Monte, N. Tomasi, R. Pinton. Interazioni tra azoto e zolfo in vite. Convegno conclusivo sui
risultati del Progetto GISVI - Gestione integrata e sostenibile vite e vino, Azienda Agraria “A.
Servadei”, Università di Udine, 20 giugno 2013.
22
U.O. Entomologia
Titolo del sottoprogetto: Controllo della tignoletta della vite con mezzi ecocompatibili
Responsabile scientifico: Pietro Zandigiacomo
Collaboratori: Filippo Buian, Francesco Pavan, Elena Cargnus
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali, Università di Udine
Introduzione
La tignoletta della vite (Lobesia botrana Denis & Schiffermüller) rappresenta il fitofago più
frequente e dannoso nei vigneti di diverse aree viticole italiane, quali quelle dell’Italia nordorientale; in talune zone più fresche si osserva anche la tignola della vite (Eupoecilia ambiguella
Hübner). In Friuli Venezia Giulia L. botrana compie due o tre generazioni all’anno; in alcune annate
particolarmente calde si può rilevare anche un quarto volo. Le larve della prima generazione
(generazione antofaga) erodono fiori e acini appena allegati (di norma non sono dannose), quelle
di seconda (prima generazione carpofaga) scavano in profondità gli acini ancora verdi, quelle di
terza (seconda generazione carpofaga) erodono piuttosto in superficie molti acini prossimi alla
maturazione. Le larve di un’eventuale quarta generazione si possono rilevare soprattutto nei
grappolini di seconda fioritura. I danni più che quantitativi sono di tipo qualitativo, poiché le ferite
aperte negli acini dalle larve di seconda e terza generazione possono favorire, in pre-raccolta, lo
sviluppo di marciumi, in particolare da muffa grigia (Botrytis cinerea Persoon).
Nelle aziende a conduzione convenzionale, gli interventi di lotta contro la tignoletta consistono
principalmente nell’utilizzo di insetticidi organici di sintesi (es. neurotossici come fosforganici,
indoxacarb, emamectina benzoato; regolatori di crescita come inibitori della biosintesi della chitina
e acceleratori della muta). Tuttavia, tali trattamenti comportano diversi problemi, fra i quali: la
possibilità di reperire residui di insetticidi sull’uva alla raccolta e poi nel vino (soprattutto se si
distribuiscono tardivamente contro la terza generazione); un impatto negativo sulla fauna utile
(predatori e parassitoidi) che concorre al controllo biologico di insetti e acari fitofagi; rischi per
l’utilizzatore di questi prodotti spesso piuttosto tossici.
Gli scopi della ricerca messa in atto dall’Unità Operativa di Entomologia del DISA erano quelli di
sperimentare nuove modalità di lotta contro la tignoletta, capaci di controllare tale carpofago senza
causare impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana, nonché di essere competitive dal
punto di vista economico se messe a confronto con le strategie di lotta convenzionali.
Materiali e metodi
Le sperimentazioni sono state effettuate negli anni 2011 e 2012 in diversi vigneti di pianura posti
nel territorio di pertinenza del Consorzio di Tutela Vini DOC Friuli Isonzo in provincia di Gorizia,
23
ove di norma la tignoletta della vite rappresenta un costante problema sia in seconda sia in terza
generazione.
Confronto dell’efficacia di due densità di erogatori nell’ambito della tecnica della confusione
sessuale
In precedenti esperienze la tecnica della confusione sessuale si era dimostrata efficace come la
lotta con insetticidi organici di sintesi, ma la sua diffusione era limitata per i costi più elevati. Le
prove si sono svolte in un vigneto di forma quasi quadrata di Pinot grigio di 10 ha, installando,
prima dell’inizio del primo volo della tignoletta, erogatori di feromoni a spaghetto. Il vigneto è stato
suddiviso in quattro parcelloni di 2,5 ha: in due sono stati applicati 500 erogatori/ha come da
indicazione della ditta fornitrice (densità standard), negli altri due, invece, sono stati applicati 350
erogatori/ha (con una riduzione del 30%). Due piccoli appezzamenti di Pinot grigio, non trattati con
insetticidi, situati nella medesima zona e appartenenti alla stessa azienda, sono stati utilizzati
come testimone. Pertanto, sono state messe a confronto tre tesi: densità standard di erogatori
(500 erogatori/ha), densità ridotta (350 erogatori/ha e testimone non trattato; ogni tesi è stata
replicata due volte. In ogni parcellone/vigneto sono stati effettuati i rilevamenti dell’attacco della
tignoletta su 100 grappoli (200 grappoli per tesi a confronto) della seconda e terza generazione.
Efficacia della defogliatura della fascia grappoli effettuata prima dell’inizio della schiusura delle
uova della seconda generazione
Precedenti sperimentazioni avevano messo in luce che la defogliatura manuale della zona dei
grappoli in coincidenza dei voli della tignoletta contribuiva a ridurne le infestazioni. Il contenimento
dell’attacco non era comunque tale da giustificare i costi dell’operazione. Le prove si sono svolte in
un vigneto di Chardonnay. La defogliatura, manuale e meccanica, è stata effettuata poco prima
dell’inizio della schiusura delle uova della seconda generazione della tignoletta (seconda metà di
giugno). Sono state messe a confronto tre tesi: defogliato manuale, defogliato meccanico
(defogliatrice pneumatica a due testate della ditta Olmi) e testimone non defogliato; ogni tesi è
stata replicata quattro volte in parcelle di 20 viti lungo quattro filari. Sulle parcelle in prova non sono
stati effettuati trattamenti insetticidi. In ogni parcella sono stati effettuati i rilevamenti dell’attacco
della tignoletta di seconda generazione su 50 grappoli (200 grappoli per tesi a confronto).
Confronto dell’efficacia di due insetticidi microbiologici a base di Bacillus thuringiensis
Precedenti esperienze avevano messo in luce una buona efficacia di Bacillus thuringiensis nel
controllo della tignoletta, ma inferiore, nonché poco costante, se confrontata con quella dei
tradizionali insetticidi organici di sintesi. Recentemente sono stati messi in commercio differenti
formulati di B. thuringiensis (B.t.). Accanto a quelli della varietà kurstaki, sono stati registrati anche
formulati a base della varietà aizawai. Questi insetticidi sono molto selettivi (colpiscono solo larve
di lepidotteri) e non lasciano residui tossici, tuttavia sono poco persistenti per cui per combattere le
larve di una generazione di tignoletta è necessario intervenire due volte. Il primo intervento è stato
24
posizionato nella fase inizio schiusura uova, mentre il secondo dopo una settimana. Le prove si
sono svolte nello stesso vigneto di Chardonnay della prova precedente in parcelle non defogliate. I
prodotti sono stati distribuiti con atomizzatore a spalla. Sono state messe a confronto tre tesi: B.t.
kurstaki, B.t. aizawai e testimone non trattato; ogni tesi è stata replicata quattro volte in parcelle di
20 viti lungo quattro filari. In ogni parcella sono stati effettuati i rilevamenti dell’attacco della
tignoletta di seconda generazione su 50 grappoli (200 grappoli per tesi a confronto).
Studio dell’interazione fra defogliatura e applicazione di insetticidi microbiologici a base di
Bacillus thuringiensis
Bt, essendo un prodotto esclusivamente di copertura, deve bagnare bene i grappoli per garantire
un’elevata efficacia. L’eccessivo vigore delle viti può rappresentare un ostacolo ad una adeguata
copertura dei grappoli. Nello stesso vigneto di Chardonnay delle due prove precedenti il
trattamento con le due varietà di B.t. è stato effettuato su parcelle defogliate o non defogliate
(manualmente o meccanicamente). La defogliatura è stata effettuata prima dell’inizio della
schiusura delle uova di seconda generazione, il trattamento con Bt subito dopo. Le modalità di
campionamento sono state analoghe a quelle delle due precedenti prove.
Analisi statistiche
Per valutare le eventuali differenze fra le tesi a confronto, i dati sono stati sottoposti all’Analisi della
varianza (ANOVA) e al test di Tukey.
Risultati
Confronto dell’efficacia di due densità di erogatori nell’ambito della tecnica della confusione
sessuale
In entrambi gli anni, la tecnica della confusione sessuale ha permesso la riduzione significativa
delle infestazioni della seconda generazione rispetto al testimone non trattato (fig. 1 e fig. 2). Non
si sono rilevate differenze significative fra le densità di installazione di 500 erogatori/ha e 350
erogatori/ha.
25
Fig. 1 – Numero di nidi larvali di tignoletta di seconda generazione osservati nelle tre tesi a
confronto nel 2011.
Fig. 2 – Numero di nidi larvali di tignoletta di seconda generazione osservati nelle tre tesi a
confronto nel 2012.
I campionamenti sulla terza generazione effettuati sul testimone hanno mostrato in entrambi gli
anni un’infestazione estremamente contenuta (così come nei parcelloni in confusione), per cui i
risultati non vengono presentati.
Efficacia della defogliatura della zona grappoli effettuata prima della schiusura delle uova della
seconda generazione
Nel primo anno di prova, la tecnica della defogliatura ha permesso la riduzione significativa delle
infestazioni della seconda generazione rispetto al testimone non defogliato (fig. 3). Non si sono
rilevate differenze significative fra la defogliatura manuale e quella meccanica.
26
Fig. 3 – Numero di nidi larvali di tignoletta di seconda generazione osservati nelle tre tesi a
confronto nel 2011.
Nel secondo anno di prova, la tecnica della defogliatura ha permesso la riduzione delle infestazioni
della seconda generazione rispetto al testimone non defogliato (fig. 4), ma, per la forte diversità di
attacco nelle parcelle, le differenze fra le tre tesi a confronto non sono risultate significative.
Fig. 4 – Numero di nidi larvali di tignoletta di seconda generazione osservati nelle tre tesi a
confronto nel 2011.
Confronto dell’efficacia di due insetticidi microbiologici a base di Bacillus thuringiensis
Nel primo anno di prova, l’utilizzo di B.t. ha permesso la riduzione significativa delle infestazioni
della seconda generazione rispetto al testimone non trattato (fig. 5). Non si sono rilevate differenze
significative fra il formulato a base di B.t. kurstaki e quello a base di B.t. aizawai.
27
Fig. 5 – Numero di nidi larvali di tignoletta di seconda generazione osservati nelle tre tesi a
confronto nel 2011.
Nel secondo anno di prova, l’utilizzo di B.t. ha permesso la riduzione delle infestazioni della
seconda generazione rispetto al testimone non trattato (fig. 6), ma, per la forte diversità di attacco
nelle parcelle, le differenze fra le tre tesi a confronto non sono risultate significative.
Fig. 6 – Numero di nidi larvali di tignoletta di seconda generazione osservati nelle tre tesi a
confronto nel 2012.
28
Studio dell’interazione fra defogliatura e applicazione di insetticidi microbiologici a base di
Bacillus thuringiensis
In entrambi gli anni, la defogliatura (manuale o meccanica) non ha migliorato l’efficacia di B.t.
aizawai e B.t. kurstaki (fig. 7 e fig. 8). Fra le tre tesi a confronto non si sono rilevate differenze
significative.
Fig. 7 – Numero di nidi larvali di tignoletta di seconda generazione osservati nelle tesi a confronto
nel 2011.
Fig. 8 – Numero di nidi larvali di tignoletta di seconda generazione osservati nelle tesi a confronto
nel 2012.
29
Conclusioni
Le sperimentazioni messe in atto nel biennio 2011-2012 hanno permesso di acquisire diverse
informazioni tecniche relative al controllo della tignoletta della vite, subito applicabili in campo dalle
aziende vitivinicole friulane, al fine di ridurre l’impatto dell’impiego degli insetticidi organici di sintesi
sull’ambiente e sulla salute umana, e nel contempo di contenere i costi della difesa.
A) Appare possibile ridurre del 30% il numero di erogatori/ha di feromone nell’ambito della tecnica
della confusione sessuale, in particolare se tale modalità di lotta viene effettuata su vigneti di
ampie superfici. Ciò consente di ridurre sensibilmente i costi della tecnica che sarebbero
decisamente inferiori a quelli di due trattamenti insetticidi (necessari nelle aree dove la tignoletta
completa un’importante terza generazione), con indubbi vantaggi economici ed eco-tossicologici.
Per motivi di cautela, nelle aziende ove la tecnica si applica per la prima volta potrebbe essere
utile effettuare, nel primo anno, un trattamento con criterio curativo contro le larve di prima
generazione sui grappolini in post-fioritura, utilizzando un formulato a base di B.t., per ridurre la
densità di popolazione, e quindi il potenziale di infestazione, della tignoletta.
B) La defogliatura effettuata all’inizio del volo degli adulti di seconda generazione o comunque
prima della schiusura delle uova della tignoletta riduce significativamente gli attacchi. Il
meccanismo per il quale si verifica la riduzione dell’infestazione, per altro, non è ancora noto. In
ogni caso, non sono state osservate differenze fra defogliatura manuale e defogliatura meccanica
(quest’ultima è molto più rapida e meno costosa). La defogliatura, tuttavia, presenta un’efficacia
inferiore rispetto ad un intervento insetticida, ma in ogni caso ha anche un effetto positivo nel
contenimento della muffa grigia e di altri marciumi.
C) Le due formulazioni di B.t., ovvero quella a base della var. kurstaki e quella a base della var.
aizawai, possono venir utilizzate indifferentemente per il controllo della tignoletta avendo mostrato
un’efficacia simile. Sono, invece, emerse alcune indicazioni che B.t. var. kurstaki sia più efficace
nei confronti dell’eulia (Argyrotaenia ljungiana Thunberg), un altro lepidottero carpofago che
occasionalmente attacca i grappoli, osservata nel vigneto sperimentale (dati non presentati).
D) La defogliatura manuale o meccanica eseguita prima del trattamento con B.t. non ne migliora
l’efficacia. Se da una parte la defogliatura permette di esporre meglio il grappolo al trattamento
(migliore copertura), dall’altra il grappolo risulta probabilmente più esposto alla radiazione solare
(in particolare ai raggi UV) in grado di degradare più rapidamente la sostanza attiva (endotossina)
responsabile della morte delle larve.
Ringraziamenti
Si ringraziano vivamente le aziende vitivinicole friulane che hanno permesso l’esecuzione delle
sperimentazioni nei loro vigneti.
30
U.O. Patologia vegetale
Titolo del sottoprogetto: Selezione massale-conservativa di vitigni autoctoni del Friuli
Venezia Giulia: verifica sanitaria dei vigneti di seconda generazione
Responsabile scientifico: Paolo Ermacora
Collaboratori: Francesca Ferrini, Ruggero Osler, Nazia Loi, Alberto Loschi,
Dipartimento di scienze agrarie e ambientali, Università di Udine
Il presente progetto ha continuato il lavoro intrapreso dalla Regione Friuli Venezia Giulia per
limitare il progressivo impoverimento delle risorse genetiche che sta interessando le principali
specie coltivate, ed in particolare le coltivazioni arboree e la vite, propagate dall’uomo in maniera
agamica. Questo impoverimento è stato spesso accentuato dalle scelte colturali, come la
selezione clonale, che favoriscono l’utilizzo di piante provenienti da un singolo individuo, e quindi
geneticamente identiche. Se la coltivazione in un appezzamento di piante tutte geneticamente
uguali è garanzia di uniformità di comportamento, la scarsa variabilità si può tradurre in scarsa
flessibilità o adattabilità a condizioni avverse.
Nel caso della vite, nel corso degli anni, la selezione clonale, ha portato all’ottenimento di materiale
che, pur garantendo ottimi standard sia fitosanitari che sotto il profilo produttivo, ha determinato di
fatto un impoverimento della biodiversità intraspecifica della vite. La ricchezza genetica
intraspecifica va invece conservata, per tutti i vitigni: essa costituisce oltretutto la base essenziale
per qualsiasi tipo di selezione futura, inclusa quella clonale. Per i vitigni autoctoni, la conservazione
della biodiversità intraspecifica assume ancora maggiore significato ed interesse. I vini autoctoni,
tipici, storici, erano infatti ottenuti da vigneti di popolazione.
In Friuli Venezia Giulia, la consapevolezza della necessità del recupero e della salvaguardia della
biodiversità di alcuni importanti vitigni autoctoni è stata manifestata da varie Istituzioni, Tecnici e
Viticoltori E' stato per questo avviato nel 2006 un progetto con il quale si sono voluti perseguire tre
obiettivi principali: a) la salvaguardia del più elevato livello possibile di biodiversità, all’interno di
quattro cultivar autoctone di vite; b) la costituzione di vigneti ad elevata biodiversità, dove poter
effettuare selezioni clonali, ma soprattutto da cui attingere materiale per la costituzione di vigneti di
popolazione; c) il confronto tra vini prodotti da uve monoclonali e da uve ottenute da vigneti ad
elevata biodiversità.
Il progetto si è basato su una selezione visiva, progressiva e continuativa. I criteri operativi della
selezione sono fondamentalmente quelli classici: si tratta di scartare, nei vigneti madre, le viti che
presentano sintomi manifesti da agenti virali o virus-simili, quelle con evidenti predisposizioni verso
malattie importanti, o con caratteri viticolo-produttivi non adeguati. La prima fase del progetto è
consistita nell’identificare vigneti interessanti, di almeno 50 anni di età, in varie località della
Regione. Sono stati così selezionati 12 impianti di Tocai Friulano, 6 impianti di Verduzzo Friulano,
31
5 di Refosco dal peduncolo rosso e 2 di Refosco di Faedis. I vigneti sottoposti a selezione erano
stati messi a dimora tra il 1900 ed il 1950. Identificati gli impianti, si è proceduto alla selezione
visiva, basata su visite primaverili, estive, ed in riposo vegetativo: infatti per disporre del maggior
numero di informazioni la pianta deve essere osservata nel suo insieme, più volte nel corso
dell'anno. Si sono scartate le piante con manifestazioni sintomatiche di virosi, fitoplasmosi o di
gravi malattie fungine ed è stato valutato il comportamento vegeto- produttivo. Dalle piante madri
selezionate nel corso di tre anni di osservazioni sono state raccolte nel 2009 delle gemme dalle
quali sono state ottenute delle barbatelle, che nel 2010 sono andate a costituire i vigneti di
seconda generazione. Questi vigneti, allestiti in zone vocate dei Colli Orientali del Friuli, sono stati
costituiti con disegno sperimentale; infatti, nello stesso appezzamento, oltre a viti provenienti dalle
selezioni massali-conservative, sono state contemporaneamente messe a dimora barbatelle
ottenute da selezioni clonali.
Nell’ambito di questa ricerca si è verificato, sui vigneti di seconda generazione, i risultati della
selezione massale conservativa effettuati sui vigneti originari. A questo scopo, oltre ad
osservazioni e rilievi di campo sono state utilizzate metodiche di laboratorio, in particolare per la
diagnosi di virosi e fitoplasmosi della vite.
A partire dalla tarda primavera 2011 sono stati monitorati sia i vigneti “madre” che gli impianti di
seconda generazione costituiti nel 2010.
In particolare sono stati rilevati i sintomi delle più
importanti virosi della vite e per le quali la legislazione prevede l’assenza nei materiali di
propagazione. Oltre ai rilievi visivi, su numeri statisticamente rilevanti di viti sono stati effettuati dei
prelievi di materiale per le analisi di laboratorio.
Si è svolta un'indagine sia sulla presenza di giallumi della vite (fitoplasmi) che dei principali virus.
In particolare sono stati ricercati gli agenti dell' Arabis Mosaic Virus (ArMV), del Grapevine Fanleaf
Virus (GFLV), del Grapevine Leaf Roll (GLRaV) 1 e 3 e del Grapevine Virus A e B (GVA e GVB).
Le analisi effettuate sono state di tipo sierologico (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay, ELISA)
per i virs e molecolare (Polymerase Chain Reaction, PCR e Restriction Fragment Length
Polymorphism, RFLP) per i fitoplasmi. I protocolli adottati hanno seguito quanto suggerito dai
protocolli di certificazione previsti per legge.
In totale dei 98 campioni di vite analizzati e raccolti a random (70 nel 2011 e 28 nel 2012), per
l'analisi molecolare, nessuno è risultato positivo per la presenza dei giallumi della vite. A margine
del progetto di selezione massale è stato condotto anche un monitoraggio per studiare nel tempo il
comportamento delle viti colpite da fitoplasmosi; questo aspetto si è rilevato piuttosto interessante
anche per acquisire informazioni epidemiologiche utili alla gestione delle malattie da giallumi in
vecchi impianti. A tal proposito è emerso come il recovery nelle fitoplasmosi sia un fenomeno
ricorrente e che può contribuire a ridurre l’incidenza della malattia senza ricorrere a reimpianti e
32
quindi all’eliminazione di ceppi che potrebbero avere un elevato interesse in termini di tutela della
biodiversità intravarietale.
Per quanto riguarda i virus della vite sono state analizzate, tra il 2011 ed il 2012, 96 piante di Tocai
Friulano, 57 di Verduzzo, 21 di Refosco di Faedis e 47 di Refosco dal peduncolo rosso (totale 221
campioni). Dalle analisi è emersa l'assenza di GVA, GVB, ArMV e GLRaV1 in tutti i campioni
analizzati. Per quanto riguarda il Verduzzo (fig. 2) è stata riscontrata la presenza di un 26% di viti
colpite da GFLV ed un 6% da GLRaV3; dati fortemente in diminuzione rispetto alle analisi
effettuate in precedenza sulle piante madri (rispettivamente 51% e 18%). Un trend analogo si è
avuto anche per il Refosco di Faedis (Fig. 3), che ha fatto segnalare un 8% di piante figlie infette
da GFLV, contro il 40% delle piante madri. Nel caso del Refosco dal peduncolo rosso (Fig. 4), si è
passati dal 2% di piante madri infette da GFLV, GLRaV1 e V3, ad uno 0% delle piante figlie. Per
quanto riguarda il Tocai Friulano (Fig. 5) c'è stata una sensibile diminuzione di piante infette da
GFLV (dal 22% delle piante madri al 7% delle figlie), mentre per GLRaV3 c'è stato un leggero
aumento (dal 5% al 9% delle figlie), probabilmente a causa dell'asintomaticità della malattia, per
cui non è stato possibile effettuare un'adeguata diagnosi visiva.
A supporto della selezione conservativa, ci sono quindi stati risultati confortanti già nella prima fase
del progetto, con percentuali di viti virosate variabili ma con alti numeri di piante negative. L’analisi
strumentale, effettuata in laboratorio, si è dimostrata essere un ausilio nei programmi di selezione
massale soprattutto per aiutare la selezione visiva dove i sintomi non sono ben evidenti.
La selezione massale è quindi un valido strumento per ottenere il miglioramento dello stato
fitosanitario della vite, garantendo la massima tutela della biodiversità intravarietale; la costante
assenza di sintomi da virus e fitoplasmi anche nelle prime fasi di vita dei giovani impianti di
seconda generazione ha fatto intraprendere con fiducia il percorso per la richiesta della
certificazione vivaistica del materiale per una sua eventuale diffusione sul territorio regionale.
Nel corso del Progetto è stata inoltre effettuata attività di divulgazione specifica per le tematiche
della selezione massale e conservativa dei vitigni autoctoni, ed in particolare è stata organizzata
una visita nei vigneti di seconda generazione in prossimità della vendemmia (settembre 2012); a
questa giornata in campo hanno preso parte numerosi viticoltori e tecnici del settore. Alcuni dei
risultati ottenuti nell’ambito di questa parte del Progetto sono stati pubblicati come Tesi di Laurea
della studente Luigi Serra dal titolo: Verifica dello stato fitosanitario di vigneti provenienti da
selezione massale, Università degli Studi di Udine, a.a. 2010-2011).
33
Fig. 1 Vigneto proveniente da selezione massale, azienda La Sclusa, Spessa di Cividale.
Fig. 2 Verduzzo Friulano confronto dei risultati ottenuti con analisi ELISA sui principali virus della
vite nei vigneti di prima e seconda generazione di selezione.
34
Fig. 3 Refosco di Faedis confronto dei risultati ottenuti con analisi ELISA sui principali virus della
vite nei vigneti di prima e seconda generazione di selezione.
Fig. 4 Refosco dal peduncolo rosso confronto dei risultati ottenuti con analisi ELISA sui principali
virus della vite nei vigneti di prima e seconda generazione di selezione.
35
Fig. 5 Tocai Friulano confronto dei risultati ottenuti con analisi ELISA sui principali virus della vite
nei vigneti di prima e seconda generazione di selezione.
36
U.O. Enologia
Titolo del sottoprogetto: Nuove soluzioni enologiche nel rispetto della qualità
Responsabile dell’unità operativa: Emilio Celotti
Collaboratori: Roberto Zironi, Franco Battistutta, Piergiorgio Comuzzo, Paola Ferraretto, Valentina
Cacciola, Isabel Ferran Battlò
Dipartimento di scienze degli alimenti, Università di Udine
Principali aziende che hanno collaborato alla ricerca:
Caeleno srl, VCR Rauscedo – Casa 40, Viticoltori Friulani La Delizia, Cantina Rauscedo, EVER
srl, Per alcune attività di laboratorio ci si è avvalsi della collaborazione del laboratorio del CIRVE
dell’Università di Padova, sede di Conegliano (TV).
Le attività di ricerca in ambito enologico hanno riguardato diversi aspetti che vanno dalla gestione
della qualità dell’uva in vigneto fino alla gestione delle fasi di affinamento dei vini. Le attività si sono
svolte presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti in collaborazione con alcune aziende
esterne, di seguito si riportano i principali risultati ottenuti.
Gestione della qualità delle uve in vigneto
Al fine di raccogliere le uve nello stato di maturazione tecnologica ottimale è stato applicato un
innovativo sistema di controllo rapido da campo in grado di verificare in tempo reale lo stato di
maturazione fenolica delle uve rosse. Il sistema già messo a punto e validato dall’Università di
Udine (PMI – Phenolic Meter Index) prevede la misura spettroscopica nel visibile della buccia
dell’uva rossa direttamente in campo, escludendo quindi buona parte delle analisi di laboratorio. La
misura della quantità di luce visibile passante attraverso la buccia, correlata in modo significativo
con i tannini e gli antociani, consente di gestire al meglio la qualità fenolica delle uve rosse, di
costruire rapidamente curve di maturazione e di confrontare direttamente in campo tutte le pratiche
di gestione della vite, anche su piccole parcelle. A titolo di esempio si riportano alcuni rilievi svolti
in regione presso i campi sperimentali dei VCR di Rauscedo.
37
Maturità fenolica Franconia
270
260
PMI
250
240
230
220
210
200
VCR 242
VCR 244
VCR 22
VCR 21
VCR 21
VCR 22
VCR 242
VCR 244
cloni
I valori del nuovo indice di maturità fenolica PMI variano tra 150 e 300, in questo range sono
comprese tutte le varietà, le sensibilità analitiche inoltre consentono di stimare anche piccole
variazioni di polifenoli nella buccia. Nelle figure sono riportati valori di diversi cloni di Franconia
analizzati nella stessa data. Queste informazioni potranno essere utilizzate per definire in funzione
delle zone viticole il clone più adatto. Considerando la mole di dati ottenuta nella ricerca si ritiene
che il nuovo sistema di misura di campo possa essere utilizzato per migliorare a basso costo la
gestione della qualità delle uve.
Interventi in macerazione
Le esperienze realizzate presso numerose realtà enologiche hanno consentito di utilizzare lo
stesso sistema già descritto per il controllo delle uve in vigneto anche per il monitoraggio della
macerazione. Facendo assorbire il mosto/vino in macerazione su una specifica carta assorbente è
possibile misurare la quantità di luce passante ed ottenere un indice PMI su vino; tale informazione
è risultata correlata in modo significativo ai polifenoli del vino e consente pertanto di monitorare le
uve rosse in macerazione al fine di definire il momento ottimale di svinatura, anche in questo caso
si riducono notevolmente i carichi analitici di laboratorio e si ottengono informazioni in tempo reale
per la gestione dei vinificatori. E’ da precisare che la gestione ottimale della macerazione e della
svinatura consentono di preservare al meglio la qualità dell’uva e di trasferirla nel futuro vino.
Nella figura si riporta un esempio di controllo rapido della macerazione con la misura rapida
dell’indice PMI. Sono state inoltre effettuate esperienze tecnologiche di macerazione mettendo a
38
confronto su scala industriale alcune variabili, in particolare l’enzimaggio, l’inertizzazione del
processo, l’impiego di tannini come antiossidanti, la dinamicità del processo, il tempo. Le
esperienze principali sono state realizzate presso la Cantina Rauscedo ed hanno consentito di
trarre alcune interessanti considerazioni. Per le uve bianche non si sono ottenuti incrementi di
feccia, i polifenoli instabili sono risultati gestibili nelle successive fasi di lavorazione. La dinamicità
del processo ottenuta con vinificatori specifici consente di evitare l’enzimaggio esogeno, inoltre
l’inertizzazione della fase prefermentativa con CO2 consente di ridurre le quantità di anidride
solforosa in vinificazione. Le valutazioni sensoriali dei vini ottenuti hanno confermato la validità dei
procedimenti applicati, in particolare quelli in grado di ridurre l’impiego di anidride solforosa e di
enzimi macerativi. E’ stato inoltre verificato che con l’impiego di vinificatori-maceratori
appositamente attrezzati si possono personalizzare le fasi di macerazione in funzione della qualità
dell’uva.
Esempio di valutazione sensoriale di prove tecnologiche di enzimaggio su pigiato di Sauvignon.
Risultano interessanti gli incrementi degli aromi fruttati e floreali con l’impiego di enzimi ad attività
ß-glicosidasica a fine fermentazione.
Altre esperienze sono state effettuate su uve rosse mettendo a confronto tecniche in grado di
preservare il patrimonio fenolico e tannico dei vini. Anche in questo caso sono state fatte
esperienze su scala industriale ed i principali risultati ottenuti hanno dimostrato la possibilità di
gestire la macerazione in funzione della qualità fenolica delle uve rosse. La dinamicità del
processo consente inoltre di sostituire l’enzimaggio esogeno, inoltre l’impiego di un gradiente di
temperatura fino a 35 °C e l’inertizzazione dei primi due giorni di macerazione consentono di
preservare e stabilizzare gli antociani e di ridurre in modo significativo la quantità di anidride
solforosa dei vini.
Impego della tecnologia ad ultrasuoni in vinificazione
39
Al fine di introdurre tecnologie a basso impatto nella filiera enologica è stato sperimentato il
trattamento ad ultrasuoni alla frequenza di 20 KHz per la gestione di alcune fasi di vinificazione, in
particolare la macerazione e la lisi del lievito. Le esperienze si sono svolte in laboratorio e su scala
di prototipo in cantina. I risultati sono stati incoraggianti ed hanno dimostrato che con un
trattamento di 3 minuti sul prodotto si ottengono risultati tecnicamente interessanti.
Nella macerazione delle uve è stato verificato che 3 minuti di trattamento del pigiato possono
sostituire 3-5 giorni di macerazione nei vinificatori, con notevoli vantaggi economici nella gestione
dei grandi volumi delle cantine. Nella figura si riportano i dati ottenuti su diverse varietà, risulta
evidente il significativo effetto degli ultrasuoni nell’estrazione dei polifenoli totali utilizzando come
riferimenti analitici le estrazioni con tampone tartarico e con metanolo acidificato.
Abs 280nm (Increase %)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Abs 280nm (Increase %)
Model Wine
MetOH acid
3' 90% 5' 90% 3' 90% 5' 90% 3' 90% 5' 90% 3' 90% 5' 90% 3' 90% 5' 90% 3' 90% 5' 90% 3' 90% 5' 90% 3' 90% 5' 90% 3' 90% 5' 90%
Carmenere
16/09/2010
Pinot Nero
20/09/2010
Nebbiolo
22/09/2010
Uva Rara
27/09/2010
Sangiovese
28/09/2010
Samples
Petit Verdot
04/10/2010
Merlot
07/10/2010
Barbera
12/10/2010
Montepulciano
12/10/2010
Un’altra esperienza ha riguardato invece il trattamento delle fecce di fermentazione. I risultati
hanno permesso di verificare la validità del trattamento di alcuni minuti che potrebbe ridurre
notevolmente (anche di qualche mese) la sosta dei vini sulle fecce, con notevole vantaggio
Soluble proteins (mg/L BSA)
economico in produzione.
de
20000
d
de
f
f
RS
E
fe
16000
12000
8000
bc
bc
b
US
RS
E
bc
bc
US
RS
bc
c
a
4000
0
RS
t zero
10 days
E
30 days
US
RS
E
3 months
Samples at different times
40
US
US
7 months
Relativamente alle prove sulle fecce fini, il trattamento si è dimostrato efficace comportando un
aumento dei colloidi solubili, rispetto al campione di riferimento, che dipende sia dal tempo che
dalla % di amplitudine; estrazione che è risulta significativa anche per tempi brevi e % intermedie
di amplitudine.
Le valutazioni effettuate attraverso HPLC-gel permeation sulla variazione della frazione colloidale,
hanno confermato l’effetto degli ultrasuoni nei brevi trattamenti di 3-5 minuti.
Le prove svolte su diverse varietà di uva mostrano come, con pochi minuti di trattamento a diverse
frequenze, si possa conseguire un miglioramento dell’estrazione delle sostanze polifenoliche, ed in
termini di tempo, una progressiva riduzione fino al 30% della durata della macerazione classica. In
termini pratici questo rappresenta una ottimizzazione della tecnologia di macerazione e, quindi,
una migliore gestione della vinificazione delle uve rosse. Inoltre, considerati i brevissimi tempi di
trattamento, è ipotizzabile un pretrattamento in continuo del pigiato di uve rosse prima del
caricamento del vinificatore.
Il trattamento sulle fecce di fermentazione, provocando la disorganizzazione della cellula di lievito
e facilitando la fuoriuscita del particolato cellulare, favorisce la lisi dei lieviti, con rapida liberazione
dei colloidi, polisaccaridi e mannoproteine, e possibile riduzione dei tempi di affinamento dei vini
sulle fecce fini.
Studi per l’impiego minimo e ragionato di coadiuvanti e additivi
Una parte della ricerca è stata dedicata allo studio di tecniche per la riduzione della quantità di
coadiuvanti esogeni ed un loro uso ragionato.
Sono state applicate tecniche di analisi non usuali per il controllo qualità dei coadiuvanti, in
particolare la misura della carica elettrica superficiale e l’analisi del diametro idrocolloidale di
macromolecole e particelle. Per quanto riguarda in particolare i tannini enologici sono stati
effettuati controlli anche del potere antiossidante al fine di ottimizzare l’impiego di questi
coadiuvanti enologici, spesso usati in quantità eccessive che possono precludere la qualità finale
del vino.
Nella figura sono riportati i rilievi del potere
antiossidante di alcuni tannini commerciali, i
risultati evidenziano enormi differenze che
confermano l’importanza della scelta del
giusto tannino in funzione di specifiche
esigenze,
come
antiossidante
ad
esempio
diretto
l’effetto
utilizzabile
nell’elaborazione di uve rosse e bianche.
41
Al fine di ridurre e/o ottimizzare l’impiego dei coadiuvanti esogeni, degli additivi e più in generale di
ottimizzare la vinificazione sono stati applicati alcuni test per la verifica della stabilità proteica dei
vini bianchi. Tra questi il test Protocheck (messo a punto dall’Università di Udine) consente di
valutare in tempi rapidi l’eventuale instabilità proteica di un vino e quindi di definire in modo molto
preciso l’intensità dell’eventuale trattamento di stabilità proteica. In sostanza tale procedura
consentirà di ridurre significativamente l’impiego di bentonite, tradizionalmente utilizzata per la
stabilizzazione proteica ma che inevitabilmente adsorbe sostanze aromatiche caratterizzanti dei
vini bianchi.
Come studio più generale è stata fatta una ricerca sulla stabilità colloidale dei vini sempre utile al
fine di verificare il limite tra stabiltà/instabilità consentendo di ottimizzare le varie fasi di
vinificazione
e
stabilzzazione
nel
massimo
rispetto
della
qualità
sensoriale
dei
vini.
Nella figura si riportano i valori di torbidità di campioni simil-vino aggiunti di diverse macromolecole
autorizzate per il trattamento dei vini. I valori di torbidità variano tra i prodotti e in funzione del
tempo, a conferma della complessità del sistema colloidale dei vini che può passare nel tempo da
una situazione di stabilità ad una di instabilità con rischi di precipitazioni in bottiglia.
Turbidity (NTU)
Turbidity (NTU)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
mixed 30 days
mixed 45 days
Le esperienze realizzate hanno consentito di ottenere informazioni sicuramente utilizzabili per
ottimizzare le tecniche di stabilizzazione e ridurre l’impiego di coadiuvanti esogeni che potrebbero,
se mal gestiti, compromettere la qualità organolettica del vino. Tali esperienze hanno anche
permesso di verificare il significativo adsorbimento di sostanze aromatiche da parte dei
coadiuvanti, pertanto diventa di primaria importanza la ricerca della situazione di stabilità colloidale
che, se si tramuta in precipitazione comporta la perdita anche di una parte del patrimonio
aromatico.
42
Conclusioni
Dalle ricerche effettuate in questi due anni sono emersi alcuni interessanti risultati potenzialmente
applicabili all’enologia regionale.
In particolare risulta verosimile una migliore gestione della qualità dell’uva in vigneto con la
possibilità di individuare il momento ottimale di raccolta, la macerazione delle uve bianche e rosse
può essere gestita in funzione della qualità nota dell’uva, con possibilità di personalizzare il
processo e di ridurre l’impiego di coadiuvanti esogeni e di anidride solforosa.
E’ stata verificata la possibilità di utilizzare la tecnologia ad ultrasuoni in macerazione e nella lisi
del lievito, inoltre gli studi sullo stato colloidale potrebbero contribuire all’impiego minimo di
coadiuvanti e additivi allo scopo di preservare al meglio la qualità dell’uva e trasferirla
integralmente nel vino.
PUBBLICAZIONI
1. Study of the ultrasound effects on yeast lees lysis in winemaking. Cacciola V., Ferran
Batllò I., Ferraretto P., Vincenzi S., Celotti E, 2013. Eur Food Res Technol, 236:(2) 311317.
2. Ultrasound application in winemaking: grape maceration and yeast lysis. Ferraretto P.,
Cacciola V., Ferran Batllò I., Celotti E., 2013. Italian Iournal of Food Science, 25 (2), 160168.
3. Ricerca delle condizioni di stabilità colloidale dei vini: il ruolo delle interazioni tra tannini e
polisaccaridi. 2013. Ferraretto P., Cacciola V., Ebeler S.E., Celotti E. Infowine, 6/2, 1-17.
4. Sistema rapido di cantina per il monitoraggio della macerazione delle uve rosse, 2012.
Celotti E., Infowine, 7/3, 1-10.
5. Esperienze industriali di macerazione dinamica soffice su uve bianche. 2013. Celotti E.,
Cacciola V., Ferraretto P., Todeschini G., Vitenda 2013, 264-265.
43
U.O. Biologia vegetale
Colture cellulari “in vitro” e approcci molecolari per studiare l’accumulo di antociani nella
vite
Elisa Petrussa1, Carlo Peresson1, Alberto Bertolini1, Sonia Patui1, Enrico Braidot1, Marco Zancani1,
Vladimir Repka2, Klemen Lisjak3, Andreja Vanzo3, Lorena Butinar4, Paolo Sivilotti4, Angelo
Vianello1.
1 University of Udine, Dept. DISA, Udine, Italy
2 Research Institute of Viticulture and Enology, Plant Production Research Center Piešťany,
Bratislava, Slovak Republic
3 Kmetijski Inštitut Slovenje, Lubljana, Slovenia
4 University of Nova Gorica, Wine Research Centre, Slovenia
INTRODUZIONE
Tramite la dieta sono assorbiti composti di elevato valore nutrizionale, essenziali per la nostra
sopravvivenza, perché il nostro metabolismo non è in grado di effettuarne la sintesi. L’uva e i suoi
derivati agro-alimentari costituiscono una delle fonti più ricche di flavonoidi, metaboliti con funzioni
antiossidanti e antitumorali, nonché cruciali nella formazione delle proprietà organolettiche del
vino. Per tali motivi l’accumulo di flavonoidi nelle bacche e la loro successiva biodisponibilità per il
consumatore è divenuto uno dei caratteri qualitativi discriminanti delle uve. Appare dunque
essenziale determinare quali siano i meccanismi enzimatici e i relativi processi fisiologici che
portano all’accumulo di tali composti. La vite rappresenta una pianta modello per queste indagini,
in quanto è una coltura ad alto contenuto di flavonoidi, a larghissima diffusione e di rilevante
interesse economico.
Il presente studio si è posto tre obiettivi: 1) la messa a punto di un sistema di allevamento in vitro
per colture cellulari di vite quale indispensabile strumento per analizzare i meccanismi di accumulo
dei flavonoidi; 2) l’individuazione, con metodi immunochimica, di alcuni degli enzimi coinvolti nel
trasporto cellulare attivo e successivo accumulo di flavonoidi/antociani nei tegumenti della bacca
d’uva; 3) definire una correlazione tra la concentrazione dei pigmenti e il grado di espressione dei
trasportatori evidenziati in bacche di viti sottoposte a differenti pratiche agronomiche.
MATERIALI E METODI
Piano sperimentale e trattamenti. Nell’annata 2012 è stata condotta una sperimentazione in un
vigneto di Terrano allevato a Guyot monolaterale nella zona di Dutovlje (Karst, Slovenia) con
l’obiettivo di ridurre la produzione e ottenere così un aumento della componente polifenolica delle
44
uve. Le tesi a confronto sono state: UN, controllo non defogliato e non diradato; PFLR,
defogliazione in pre-fioritura (eliminando 5-6 foglie per tralcio); CT, diradamento dei grappoli
all’invaiatura (lasciando 1 grappolo/germoglio).
Colture cellulari.
Il materiale vegetale è costituito da colture cellulari stabilizzate di Vitis vinifera L., cv. Limberger. Le
cellule sono state allevate in terreno solido contenente citochinine e auxine, e trasferite ogni 23
giorni (Repka et al., 2000). Le sospensioni cellulari liquide sono state successivamente ottenute
attraverso il trasferimento di porzioni di callo selezionate per un alto contenuto in antociani (cellule
rosse) a confronto con porzioni che non presentavano tale accumulo (cellule bianche). Tali
sospensioni sono state allevate in una camera di coltura dotata di agitazione orbitale a 110 rpm e a
una temperatura di 27°C, in presenza di cicli di 12 ore di luce. Da tale materiale è stata isolata la
frazione microsomale, utilizzata per la corsa elettroforetica (SDS-PAGE) e successiva analisi
immunologica tramite Western blot (Braidot et al., 2008), con anticorpi anti-bilitranslocasi (antiBTL) di mammifero, reattivo contro il peptide EFTYQLTSSPTC, e anti-glutatione-S-transferasi
(anti-GST) di Triticum aestivum. La reazione immunologica è stata misurata mediante saggio
colorimetrico della fosfatasi alcalina.
Estrazione delle proteine e delle antocianine totali da buccia d’uva.
Sono stati scelti 5-6 grappoli da tre viti diverse di cv Terrano (repliche biologiche randomizzate) per
ciascuna tesi, alla fase di piena maturazione della bacca (28/09/2012). Le bucce sono state
polverizzate in azoto liquido e utilizzate sia per l’estrazione delle antocianine libere (5 g di peso
fresco per ogni campione), sia per l’estrazione delle proteine totali (3 g di peso fresco per ogni
campione).
La proteina totale è stata estratta secondo i metodi modificati di Conlon & Salter (2007) e Song e
coll. (2006), mediante tampone alcalino caldo e successiva precipitazione in acetone acidificato.
Le antocianine totali sono state estratte da tegumenti in metanolo a 4°C, con rapporto
bucce/solvente 1:4 (p:v). L’estrazione è stata condotta per 3 ore al buio e a temperatura ambiente.
Gli estratti sono stati quindi centrifugati a 3000×g a 4°C. I precipitati sono stati nuovamente
sottoposti a estrazione e centrifugati. Entrambi i surnatanti sono stati riuniti e insufflati con azoto,
conservati al buio e a -20°C.
Analisi immunochimica del trasportatore di flavonoidi.
Per il test immunochimico mediante saggio ELISA, sono stati saggiati 5 µg totali di proteina in
micropiastra, incubati con differenti anticorpi primari: anti- BTL di mammifero; anti-GST di Triticum
aestivum; anti-sintaxina 51 (anti-SYP51) di Arabidopsis thaliana. La reazione immunologica è stata
valutata mediante saggio colorimetrico della fosfatasi alcalina.
45
Analisi cromatografica delle antocianine libere mediante HPLC.
Aliquote ottenute da estratti metanolici di tegumenti di bacche di uva sono state portate a secco a
bassa pressione e temperature inferiore ai 40°C. I campioni sono stati ricostituiti nella fase eluente
dell’analisi cromatografica, filtrati con un filtro da 0.22 μm in PVDF e immediatamente analizzati.
Per la caratterizzazione e quantificazione delle antocianine è stato utilizzato un cromatografo
Agilent 1100 HPLC abbinato a un DAD, connesso a una ChemStation Agilent NDS. La
separazione è stata effettuata utilizzando una colonna C18 abbinata a una pre-colonna C18. La
fase mobile era composta un solvente A (0.3% acido perclorico) e da un solvente B (100%
metanolo). La separazione è stata condotta per 50 minuti a 35°C. Le condizioni di eluizione
prevedevano un gradiente lineare con una miscela iniziale di 28.5% B, incrementata fino al 51% B
dopo 42 minuti, al 68.5% di B in 3 minuti, proseguendo fino al 100% di B in 2 minuti, mantenuto
per i successivi 3 minuti. La velocità di flusso è stata di 0.55 ml/minuto e il volume iniettato di 10 µl.
Gli spettri UV-Vis sono stati registrati nell’intervallo da 200 fino a 700 nm, con lettura a 520 nm.
RISULTATI E DISCUSSIONE
È stata effettuata un’analisi immunochimica su proteine totali estratte dai tegumenti di bacca della
cv Terrano, allo scopo di rilevare il grado di espressione di alcuni traslocatori di flavonoidi in
risposta a due diverse pratiche agronomiche. Tali proteine, associate a un trasporto attivo, sono
state determinate per evidenziarne una potenziale correlazione con la quantità di antociani
presenti nella bacca, a seguito del diradamento del grappolo (CT) e dell’asportazione in prefioritura
di una consistente porzione dell’apparato fogliare (PFLR), rispetto a un controllo (UN).
La determinazione è stata condotta con il metodo ELISA, utilizzando per la reazione anticorpi
ottenuti, rispettivamente, contro una proteina simile alla bilitranslocasi di mammifero (BTL-like), la
glutatione-S-transferasi (GST) e la sintaxina (Syp51), proteina appartenente alla famiglia SNARE.
Come mostrato nella Fig. 1 (pannello A) entrambi i trattamenti agronomici (PFLR e CT) si sono
dimostrati efficaci nell’indurre un significativo aumento del contenuto di antocianine totali nei
tegumenti delle bacche rispetto al controllo (UN). Tale modificazione non ha avuto però effetto sul
grado di espressione dei traslocatori, la cui presenza è stata, anzi, considerevolmente ridotta dalla
rimozione di una parte dell’apparato fotosintetico, trattamento che ha probabilmente fortemente
alterato i rapporti trofici delle piante pregiudicando la biosintesi proteica (Fig. 1, pannello B).
46
3.0
10000
2.5
8000
ELISA test [A.U.]
Anthocyanin [mg/kg]
BTL-like
GST
Syp51
B
A
6000
4000
2000
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
UN
PFLR
UN
CT
PFLR
CT
Fig. 1. Effetto di pratiche agronomiche sul contenuto di antociani (pannello A) e sull’espressione di
tre trasportatori degli antociani (pannello B)
È stata effettuata un’analisi immunochimica su proteine totali estratte dai tegumenti di bacca della
cv Terrano, allo scopo di rilevare il grado di espressione di alcuni traslocatori di flavonoidi in
risposta a due diverse pratiche agronomiche. Tali proteine, associate a un trasporto attivo, sono
state determinate per evidenziarne una potenziale correlazione con la quantità di antociani
presenti nella bacca, a seguito del diradamento del grappolo (CT) e dell’asportazione in prefioritura
di una consistente porzione dell’apparato fogliare (PFLR), rispetto a un controllo (UN).
La determinazione è stata condotta con il metodo ELISA, utilizzando per la reazione anticorpi
ottenuti, rispettivamente, contro una proteina simile alla bilitranslocasi di mammifero (BTL-like), la
glutatione-S-transferasi (GST) e la sintaxina (Syp51), proteina appartenente alla famiglia SNARE.
Come mostrato nella Fig. 1 (pannello A) entrambi i trattamenti agronomici (PFLR e CT) si sono
dimostrati efficaci nell’indurre un significativo aumento del contenuto di antocianine totali nei
tegumenti delle bacche rispetto al controllo (UN). Tale modificazione non ha avuto però effetto sul
grado di espressione dei traslocatori, la cui presenza è stata, anzi, considerevolmente ridotta dalla
rimozione di una parte dell’apparato fotosintetico, trattamento che ha probabilmente fortemente
alterato i rapporti trofici delle piante pregiudicando la biosintesi proteica (Fig. 1, pannello B).
D’altra parte, l’assenza di relazione tra l’accumulo di pigmenti e l’induzione della sintesi di
traslocatori può essere spiegata con il coinvolgimento di numerose proteine che partecipano al
processo di trasporto attivo e che, dunque, permettono di riequilibrare e ridistribuire su più enzimi il
maggior carico di metaboliti. Inoltre, soprattutto nelle fasi terminali di maturazione, il processo di
trasporto attivo energeticamente dispendioso è ipotizzabile sia sostituito da fenomeni di diffusione
passiva e successiva precipitazione degli antociani all’interno del vacuolo.
I due tipi di colture cellulari ottenuti sono stati confrontati mediante analisi cromatografica per
misurare il contenuto di antociani (Fig. 2). La determinazione, tramite HPLC effettuata su estratti
alcolici delle due linee cellulari (Fig. 2 pannello A) ha evidenziato una presenza quasi
esclusivamente nelle colture rosse di due antocianine pure (cianidina-glicoside e malvidinaglicoside) o sostituite con cumarato, mentre le colture bianche non mostravano pigmenti in quantità
47
apprezzabile. In parallelo, un’analisi immunochimica (Western blot), effettuata sulle frazioni
microsomali ottenute da tali colture cellulari, rilevava la presenza in entrambe le linee di due GST e
di BTL-like (Fig. 2, pannello B). Tali risultati supportano l’ipotesi che anche in colture cellulari in
vitro siano presenti proteine trasportatrici analoghe a quelle riscontrate nei tegumenti di bacca.
L’analisi non ha però evidenziato una differente espressione degli enzimi in base alla
pigmentazione delle cellule, confermando l’assenza di una correlazione tra la quantità di antociani
presenti e la concentrazione dei traslocatori. Il sistema delle colture in vitro costituisce pertanto uno
strumento promettente per studiare i meccanismi di accumulo degli antociani nelle cellule vegetali.
Inoltre il loro impiego potrà consentire di effettuare trattamenti ormonali o con fattori ambientali per
comprendere nel dettaglio come tali agenti modulino e inducano la biosintesi di metaboliti
secondari quali sono i polifenoli.
Fig. 2. Profilo cromatografico degli antociani presenti nelle colture cellulari di vite (pannello A) e
analisi immuno-chimica delle proteine GST e BTL-like in cellule di vite (pannello B).
48
LETTERATURA CITATA
Repka V., Kubíková J., Fisherová I. (2000). Immunodetection of PR-1-like proteins in grapevine
leaves infected with Oidium tuckerii and in elicited suspension cell cultures. Vitis, 39:123–127.
Braidot E., Petrussa E., Bertolini A., Peresson C., Ermacora P., Loi N., Terdoslavich M.,
Passamonti S., Macri F., Vianello A. (2008). Evidence for a putative flavonoid translocator similar
to mammalian bilitranslocase in grape berries (Vitis vinifera L.) during ripening. Planta 228:203–
213.
Conlon H.E., Salter M.G. (2007). Plant protein extraction. Meth. Mol. Biol. 362:379–383.
Song J., Braun G., Bevis E., Doncaster K. (2006). A simple protocol for protein extraction of
recalcitrant fruit tissues suitable for 2-DE and MS analysis. Electrophoresis 27:3144–3151.
RINGRAZIAMENTI
Il presente lavoro è stato finanziato dal Fondo di Sviluppo Regionale Europeo, nell’ambito del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007–2013 (progetti TRANS2CARE e
AGROTUR) e dal programma GISVI della L.R. 26 (2011) art. 17.
49
U.O. scienze della vita UNITS
Anticorpi monoclonali anti-bilitranslocasi: sviluppo e applicazioni in biologia animale e
vegetale
Tramer F., Passamonti S.
Dipartimento Scienze della Vita – Università degli Studi di Trieste
Introduzione
La bilitranslocasi è un trasportatore di anioni organici presente sia nelle cellule dell’epitelio
assorbente del tratto gastrointestinale [1] sia in quelle di organi escretori come fegato e reni [2,3].
Tale proteina oltre a trasportare bilirubina in modo specifico, è coinvolta nel trasporto di molte altre
molecole come, per esempio, gli antociani [4, 5].E’ stato infatti dimostrato come gli antociani
dell’uva, sia gli agliconi che i loro derivati mono- e di-glicosidici, siano capaci di inibire il
meccanismo di trasporto svolto dalla bilitranslocasi [4]. Nella cellula vegetale, tali molecole
vengono sintetizzate nel citoplasma e successivamente immagazzinate nel vacuolo attraverso dei
meccanismi non ancora ben caratterizzati.
Studi compiuti su campioni di origine vegetale utilizzando anticorpi policlonali anti-bilitranslocasi
hanno dimostrato la presenza di un omologo di questa proteina anche nelle cellule vegetali come
nel petalo di garofano (Dianthus caryophyllus L.) [6] e nell’uva rossa (Vitis vitifera L. )[7]. Nel chicco
d’uva è stata identificata nel tonoplasto e nell’interfaccia tra la membrana plasmatica e la parete
cellulare sia della buccia che della polpa con un’espressione crescente nei diversi stadi maturativi.
Si è osservato l’aumento dell’espressione della bilitranslocasi durante la maturazione della bacca,
indicando che l’espressione di questa proteina è coordinata con l’intera via metabolica di biosintesi
degli antociani.
I composti polifenolici, di cui gli antociani fanno parte, costituiscono uno dei parametri di qualità del
vino, grazie al loro contributo nel determinare alcune caratteristiche organolettiche come il colore,
l’astringenza e l’aroma. La presenza di polifenoli nell’uva è influenzata anche dalle condizioni di
maturazione del grappolo ed è noto da anni che il vino rappresenta la fonte principale di flavonoidi
nella dieta [8].
Nell’ambito del progetto è stato nostro compito sviluppare e caratterizzare anticorpi monoclonali
capaci di riconoscere specificamente la sequenza della BTL, ma anche adatti per essere utilizzati
in campioni freschi, sia di origine vegetale che animale, dove fosse possibile valutare
quantitativamente la funzione di trasporto della proteina. Perciò la collaborazione con il gruppo del
Prof. Vianello dell’Università di Udine è stata continua ed intensa.
50
Materiali e Metodi
Produzione di anticorpi monoclonali anti- BTL
Tre topi femmine del ceppo BALB/c sono stati immunizzati con 15 μg di “multi-antigen peptide”
corrispondente alla sequenza amminoacidica 65-75 della BTL coniugata con l’emocianina (keyhole
limpet hemocyanin -KLH). Gli inoculi sono stati successivamente ripetuti dopo 2, 4 e 9 settimane. Il
siero dei topi immunizzati è stato utilizzato per valutare il titolo anticorpale (test ELISA, vedi di
seguito) e solamente gli animali con un titolo apprezzabile sono stati sacrificati per l’espianto della
milza. Attraverso l’utilizzo della tecnologia d’ibridazione è stata attuata la fusione dei linfociti della
milza con le cellule di mieloma di topo NS1. La selezione degli ibridomi esprimenti gli anticorpi è
stata effettuata in terreno HAT (ipoxantina, aminopterina e timidina) e successivamente, quelli
capaci di esprimere anticorpi dalla specificità desiderata valutata tramite test ELISA (vedi di
seguito).
Test ELISA (enzyme-liked immunosorbent assay): vaglio dei sieri e del surnatante degli
ibridomi attraverso
Per la valutare la presenza degli anticorpi specifici nel siero dei topi e nel terreno di crescita degli
ibridomi è stata utilizzata una quantità nota di antigene (50 μL peptide 65-75 (3μg/mL) per ogni
pozzetto) in 50m tampone carbonato/bicarbonato, pH 9.6. La presenza del complesso specifico tra
antigene ed anticorpo (incubazione o/n a 4°C) è stata valutata utilizzando un anticorpo secondario
anti-mouse coniugato con la perossidasi. La presenza di tale enzima, in presenza di un opportuno
substrato (ABTS), permette di rivelare e quantificare spettrofotometricamente (405 nm) la
presenza dell’anticorpo di interesse.
Purificazione degli anticorpi monoclonali
Allo scopo di poter ottenere una frazione di anticorpi specifica e sufficientemente concentrata, gli
anticopri monoclonali sono stati purificati attraverso cromatografia liquida (FLPC) utilizzando una
colonna HiTrap IgM (o IgG) Purification HP (GE Healthcare).
Caratterizzazione dell’anticorpo
Dal vaglio degli ibridomi sono stati individuati alcuni cloni positivi dai quali per selezioni successive
ne sono stati scelti due con caratteristiche migliori. Uno di questi è stato utilizzato per valutarne
l’attività attraverso diversi approcci sperimentali: inibizione specifica dell’attività di trasporto,
western blot, citofluorimetria di flusso (FACS), immunocitochimica, elettroforesi bidimensionale.
Risultati e discussione
Il primo e più importante dato riguarda la possibilità di utilizzare gli anticorpi monoclonali
51
selezionati per saggi di inibizione dell’attività di trasporto, in quanto questa metodica indica in
modo univoco e altamente specifico la presenza della bilitraslocasi nel campione biologico. Tale
test prevede l’inibizione del trasporto elettrogenico della bromosulfoftaleina (BSP) in vescicole di
plasmamembrana di fegato di ratto. L ’inibizione si è dimostrata dipendente sia dal tempo di
incubazione sia dalla concentrazione di anticorpo utilizzata (costante di inibizione di secondo
ordine, k =0.01±0.00 min-1 ml μg-1; r2=0.99). Inoltre, per evidenziare il legame dell’anticorpo con
l’epitopo legante la bilirubina, quale quello utilizzato nell’immunizzazione dei topi, sono stati
effettuati dei saggi di inibizione del trasporto in presenza di concentrazioni crescenti di bilirubina (050 nM). Tali dati hanno dimostrato come la presenza di questa molecole causi una minore
inibizione da parte dell’anticorpo a causa della competizione per il medesimo sito di legame della
bilirubina (costante di dissociazione del complesso bilirubina-BTL, Kd = 2.67±0.38 nM).
I dati di western blot, fatti utilizzando diverse frazioni purificate di tessuti di ratto, come atteso,
hanno confermato il riconoscimento, da parte dell’anticorpo, di una banda a 37 kDa. Dati ottenuti in
esperimenti di immunocitochimica e successivamente confermati da esperimenti di citofluorimetria
di flusso hanno evidenziato, come l’anticorpo prodotto riconosca un antigene a livello di membrana
plasmatica in diverse linee cellulari umane.
L’analisi bidimensionale è stata eseguita su frazioni di fegato di ratto accoppiata al western blot.
Tale metodica è stata utilizzata allo scopo di identificare in modo univoco la proteina d’interesse
all’interno del campione. Gli spot proteici identificati dall’anticorpo sono stati inviati all’analisi di
spettrometria di massa e si stanno aspettando i risultati.
Tutti i dati ottenuti confermano che l’anticorpo selezionato grazie alle sue caratteristiche risulta un
valido strumento nella ricerca. Innanzitutto l’anticorpo ha mostrato la peculiare caratteristica di
inibire la funzionalità di trasporto in frazioni purificate, in cellule nonché in colture organotipiche;
inoltre è capace di riconoscere la proteina in campioni costituiti da crescente complessità
morfologica sia in forma denaturata che nativa. L’importanza di poter utilizzare l’anticorpo, come
strumento sperimentale nello studio della bilitranslocasi, risulta tanto più fondamentale in
considerazione del fatto che tale proteina viene codificata da un trascritto anti-senso che ne
impedisce lo studio attraverso le normali tecniche di biologia molecolare. L’utilizzo degli anticorpi
perciò, risulta al momento l’unico approccio possibile. La produzione di anticorpi monoclonali ne
assicura una produzione costante dal punto di vista quantitativo e soprattutto qualitativo [9].
Bibliografia
[1] Passamonti et al. (2009) Current Drug Metabolism, 10, 369-394
[2] Baldini G et al. (1986) Biochim Biophys Acta, 856, 1-10
[3] Nicolin V et al. (2005) J mol Histol 36, 45-50;
52
[4] Passamonti S et al. (2002) BBRC 296, 631-636
[5] Passamonti et al. (2003) FEBS Lett 544, 210-213
[6] Passamonti et al (2005) FEBS J, 272, 3282-3296
[7] Braidot E et al. Planta 228, 203-213
[8] Cheynier, V. et al. (2006), in Flavonoids: chemistry, biochemistry and applications 2006 pp.
263-318
[9] Montiac S. et al., Radiol Oncol 2013; 47(2): 128-137
53