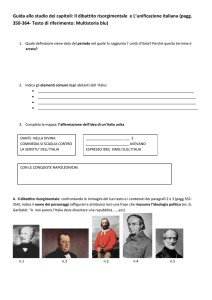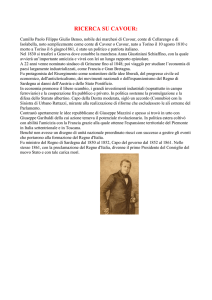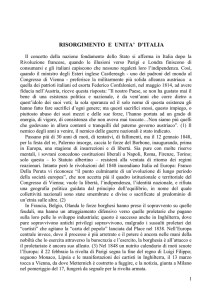I . T . I . L .S . “ F R ANC E S C O G I O RD A NI ” C AS E R T A
NUMERO 2/2011
DIRITTO DI PAROLA
INNO di MAMELI
*******
Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Uniamoci, amiamoci,
l'Unione, e l'amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Dall'Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla,
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò
IL CANTO DEGLI ITALIANI
L'inno nazionale è senz'altro
una delle cose che distingue
maggiormente i cittadini di
una nazione. E' quindi motivo
di grande orgoglio per gli abitanti di un paese cantare l'inno
alla propria patria, che va ben
oltre le parole e la musica che
le accompagna: ogni inno ha
infatti il suo significato e la
sua storia. Abbiamo tutti visto
ciò che è riuscito a fare Benigni a Sanremo, raccontando i
fondamenti storici del "Canto
degli italiani", che oggi conosciamo come Inno di Mameli.
Goffedro Mameli, giovanissimo poeta e, soprattutto, patriota genovese, compose
nell'autunno del 1847 i versi
del futuro inno italiano. Scelse
di non adattare le parole a musiche già esistenti e affidò
quindi la composizione
dell'accompagnamento musicale a Michele Novaro, altro
patriota genovese e compositore. Quest'ultimo è senza dubbio poco conosciuto, ma dobbiamo ringraziare lui per la
musica orecchiabile che è riuscito a comporre e che ha portato l'inno di Mameli ad essere
così apprezzato, sia allora che
o
g
g
i
.
La grande diffusione di questo
straordinario brano si ebbe già
pochi giorni dopo la sua prima
presentazione, a Genova, in occasione della festa del centenario
della cacciata degli austriaci. L'opera creata da questi due grandi
uomini piacque così tanto da divenire vera e propria colonna
sonora delle Cinque Giornate di
Milano, cantata a squarciagola
dagli insorti. Gli inni patriottici
rappresentavano il mezzo più
facile per trasmettere alle persone
gli ideali risorgimentali, e in pochi si sarebbero aspettati che tali
cori avessero aiutato a rendere
possibile l'unità d'Italia, che il 17
marzo di quest'anno, come tutti
sanno, ha compiuto 150 anni.
In più di un'occasione, dopo la
grande diffusione dell'inno, le
autorità cercarono di abolirlo, o
almeno di censurarlo, dal momento che era considerato fin
troppo eversivo; ma nessun
tentativo riuscì. Purtroppo,
ancor prima che i Mille intonassero in segno di vittoria il
canto da lui scritto, Mameli
morì, per una grave infezione
ad una ferita non particolarmente grave procuratasi durante i moti rivoluzionari di
Roma, a soli 22 anni.
L'inno di Mameli divenne
ufficialmente l'inno nazionale
italiano solo nel 1946, quasi
cento anni dopo la sua composizione, e andò a sostituire il
precedente, la Marcia Reale di
Giuseppe Gabetti, scritta sotto
richiesta di Carlo Alberto e
divenuta inno italiano l'anno
in cui il paese divenne ufficialmente unito, nel 1861.
Non tutti sanno, inoltre, che il
testo che viene cantato abitualmente durante le cerimonie internazionali, politiche o
sportive non è quello integrale, ma solo una piccola parte
dell'originale, ben più ampio
e, se vogliamo, complesso.
A distanza di più di 150 anni
dalla sua creazione, l'Inno di
Mameli rimane, e si spera
rimarrà, uno dei segni distintivi di quello che è stato e sarà
il nostro Paese
Donato Riello
Pa g in a 2
NUMERO 2/2011
L’amor di patria, oggi
Dopo 150 anni, la Repubblica italiana ha
istituito per il 17 marzo 2011 una festa nazionale
per
celebrare
l’anniversario
dell’Unità, un valore sacro per il quale molti
patrioti hanno dato la vita, credendo fino in
fondo a un ideale che si prospettava fonte di
forza per una Nazione che voleva e doveva
essere unita ma, soprattutto, libera dalle
dominazioni e dagli invasori che opprimevano la popolazione. È la stessa voglia di libertà che spinse giovani come Garibaldi a lanciarsi in una campagna disperata con una
parola d’ordine ben precisa: Patria, che ridesta emozioni, che Mameli riversò nel suo
inno nato per onorare la nostra Nazione.
Purtroppo sono poche le persone che, al
giorno d’oggi, ricordano la nostra origine e
sorge spontanea, a questo punto, una domanda: cosa ci è rimasto oggi di questi
ideali? La risposta, per quanto dura e secca
possa sembrare, è una: nulla, “tabula rasa”;
per un popolo, difatti, abituato a vivere in
una Nazione già unita, con tutti i suoi pregi
e, ancor di più, con l’enorme mole dei suoi
difetti, l’importanza di un valore come
l’amor di patria è ridotta quasi ai minimi
termini, e le sempre più disastrose situazioni di questo Paese non aiutano di certo a
ridestare tali ideali.
L’Italia, ormai, è diventata lo zimbello
d’Europa a causa di politici scellerati e di
una corruzione di fondo. Ora, il mio punto di
vista non vuole essere un affronto alla politica, ma è la semplice opinione di un adolescente che ritiene questa festa non solo
un’occasione di lode per quanto i nostri
patrioti hanno realizzato, ma anche un momento di riflessione che ci spinga a pensare
quanto lunga e impervia sia ancora la strada
da percorrere.
Poiché la sola Unità servirà a ben poco, se
non riusciremo a migliorare la condizione di
una Nazione bellissima ma ancora non del
tutto unita.
Francesco D’Alessio
E se…
Oggi, 4 febbraio 2511, è
stata un’ altra brutta giornata. Di questi tempi,dalle
nostre parti, ormai non ci
sono più belle giornate. Infatti, noi del sud siamo stati
completamente dimenticati
dal resto della p enisola ,
siamo un paese del terzo
mondo, pieno di povertà ,
criminalità e, soprattutto ,
spazzatura.
Le cose sono peggiorate due
secoli fa,quando l’Italia è
stata divisa in Repubblica
del Nord, e Repubblica del
Sud. Le cose vanno di male
in peggio, e vorrei fare
qualcosa
per
cambiarle,
perch é ormai vedo solo terrore davanti a me, ed essendo adolescente, non riesco
ad immaginare un futuro da
adulto.
Mentre penso questo, mi
viene un’idea: nella mia
vecchia scuola, ormai chiusa ed abbandonata (come
tutte le scuole del Sud), è
custodita una macchina del
tempo. Se riesco a ritrovarla forse, ca mbiando il passato, potrò cambiare in meglio il presente. Mi incammino subito in direzione
della scuola, sca valco il
muro che la circonda, e mi
dirigo nel laboratorio. La
macchina del tempo si trova
proprio in fondo alla stanza, piena di polvere mai
usata. Tanto tempo prima
era una macchina bellissima, di prima classe, di quelle che c’erano solo al Nord .
Con gli occhi che mi lu cci-
cano salgo sulla ma cchina ,
scelgo la destinazione e
parto.
Dopo qualche secondo mi
ritrovo
catapultato
nel
1860! Non mi semb ra vero .
Per strada ci sono ca valli e
non auto volanti, è tutto più
pulito e naturale, ci son o
ancora i prati fioriti e la
gente è tutta per la strada, e
non chiusa in ca sa. Vorrei
tanto stare lì a divertirmi e
a godermi la natura, ma no n
posso! Il destino d ell’ Italia
è nelle mie mani! E mancano
solo
pochi
giorni
all’unificazione della penisola!
Tornato
in me, cerco u n
cavallo. Ne tro vo uno bello
grande e p restante e, salitovi in groppa, parto subito
per la Sicilia. Dopo ore ed
ore di viaggio e di ricerch e
estenuanti, intravedo
da
lontano un gruppo di uomini, tutti vestiti con camicie
rosse. Mi avvicino a loro e
chiedo di Giuseppe Ga ribaldi. Loro all’inizio sono diffidenti, mi vedono come una
persona strana e inquietante
da come sono vestito.
Ma, proprio mentre stiamo
discutendo, dalla folla esce
il mitico Garibaldi. Il mio
cuore batte forte alla vista
di un personaggio simile.
Lui mi fissa sosp ettoso, poi
mi chied e cosa voglio da lui
e chi mi ha mandato. Contemporaneamente impugna
la sua spada affilata nella
mano destra. Io allora lo
chiamo in disparte e gli rac-
conto da dove vengo. Poi gli
spiego della situazione tragica del 2511, e gli dico
che, p er cambiare questo
tragico destino, c’è bisogno
di lui, il grande condottiero
italiano. Garibaldi, ovviamente, all’inizio scoppia a
ridere, non credendo alle
mie parole. Allora mi vien e
un’ idea: tiro fuori dal mio
zaino una torcia, la accendo, e lui rimane mera vigliato da tale tecnologia, che
sicuramente non è d ella su a
epoca.
Inizia perciò a capire ch e
forse io dico la verità e, co n
aria imperiosa, mi chied e
cosa avrebbe potuto fare. Io
gli dico che c’è solo un modo per non far sprofondare
il Sud nella povertà e nel
terrore: Garibaldi non dovrà fermarsi a Teano e siglare l’accordo con Vittorio
Emanuele, bensì dovrà proseguire nel cammino e conquistare quasi tutta la penisola, nonostante le annessioni.
Ovviamente, sa rebbe stata
un’ impresa troppo difficoltosa per le tecnologie di
quel tempo e, quindi, lui
non accetta. Allora, mentre
stiamo cadendo nello sconforto, mi ricordo ch e, nel
mio zaino, deve trovarsi un’
arma sp eciale, che ho portato per sicurezza con me
quando sono uscito dalla
mia abitazione e mi sono
recato a scuola. Così, tiro
fuori dal mio zaino una pistola laser K 350, inventata
di Raffaele Imperioso
nel 2400, in grado di ridurre in brandelli centinaia di
uomini in un solo secondo!
Lui, eccitato anche dal fatto
di poter usare un’arma così
potente, accetta senza p ensarci troppo. Allora, ordin a
ai suoi cosa fare. I ragazzi
si incamminano, tutti pieni
di carica e adrenalina. Dopo molti mesi di dure lotte,
Garibaldi riesce a conquistare quasi tutta l’Italia
grazie alla mia a rma, e diventa il re d’Italia. Sceglie
come capitale Napoli e crea
università, opere pubbliche,
banche e molte altre cose
che rendono il Sud un centro finanziario e di cultura.
Ormai, la mia missione è
compiuta e, salutato il mio
amico Giuseppe, salgo sulla
macchina del tempo e faccio
ritorno a casa. All’arrivo
non credo ai miei occhi. La
mia città è diventata un posto fantastico ! C’è molta
gente per le strade, i parchi sono aperti, e non c’è u n
briciolo di spazzatura. Davvero un sogno che si avvera .
Allora, stupito, faccio un
giro in città e, dopo, mi incammino felice in un parco.
Con grande stupore, ved o
una statua grandissima ch e
mi raffigura. Allora, piango
dall’emozione, e mi a vvicin o
con fierezza e orgoglio. Alla
base della statua si legge:
“Onore al misterioso ragazzo venuto dal futuro. A lui
sono dovuti tutti i privilegi
e le ricch ezze che abbiamo”.
D I R I TT O D I P A R O L A
Pa g in a 3
UNA VOCE FUORI DAL CORO
Quest’anno ricorre il 150°
anniversario
dell’Unità
d’Italia, celebrato ufficialmente il 17 marzo scorso.
Che l’Italia sia uno stato
“unito” da 150 anni è noto a
tutti; tuttavia, mi chiedo se
questa Unità sia vera o solo
frutto di una forte immaginazione collettiva. L’Italia
“unita”, nel vero senso della
parola, esiste o è paragonabile ad altre creature mitologiche presenti nei testi epici?
Partendo da episodi recenti,
non possiamo ignorare la
polemica e il dibattito creati
dai nostri politici sul festeggiamento dell’evento; siamo
tutti a conoscenza dei dubbi
e dei tentennamenti che ha
avuto
il
governo
sull’assegnazione del giorno
di festa. Assegnarla o non
assegnarla? Perché un governo che cerca a tutti i costi il
federalismo dovrebbe festeggiare l’Unità? Non è,
tuttavia, questa la domanda
che ci interessa; la domanda
è un’altra: “Perché dovremmo effettivamente festeggiare tale ricorrenza?”. La rivolgo soprattutto a noi meridionali che, quasi tutti i giorni, veniamo letteralmente
derisi dai nostri stessi connazionali: “Perché dovremmo
festeggiare un’Unità che, alla
fine, esiste solo sopra un
foglio di carta? Non ha senso, a mio parere, celebrare
l’Unità finché essa rimane
solo una parola in cui non
tutti gli italiani credono.
La spiegazione a tutte queste
domande è una sola: l’Italia
non esiste come stato unito,
perché noi Italiani al suo
interno non siamo uniti; siamo stolti e non ci rendiamo
conto dell’importanza degli
uni per gli altri; i nostri fratelli settentrionali ci disprezzano, ci considerano una banda
di
delinquenti,
di
“terroni”, tanto per dirlo con
parole ben note a tutti. Forse
noi adesso non ce ne rendiamo conto, ma effettivamente le diversità tra le due
“Italie” sono davvero tante
da far sì che ci si accetti non
senza titubanze; in fondo,
noi Italiani siamo uniti da soli
150 anni, per tutti gli anni
precedenti siamo sempre
stati divisi, sempre sudditi di
monarchie, regni, principati
o imperi diversi.
Come sono stati diversi i regimi che ci hanno governati,
così anche i tipi di cultura e
di evoluzione seguiti sono
stati e sono tuttora differenti.
La storia del Sud Italia, purtroppo, è sempre stata segnata da regimi abituati a
sfruttarci il più possibile. Le
innovazioni, mentre nelle
altre regioni erano già tante,
da noi erano solo una chimera. La situazione, con il pas-
sare del tempo, è migliorata
ma, purtroppo, i nostri fratelli settentrionali non se ne
rendono conto; non abbastanza, almeno, da capire
che senza di noi l’Italia
(quella ipoteticamente unita)
finirebbe per crollare. Per
quanto sia doloroso dirlo, a
mio parere l’Italia non è affatto cambiata dai tempi
dell’unificazione, con l’unica
differenza che adesso gode
dell’attributo “unita”, anche
se, nella realtà dei fatti, non
lo è.
Gli Italiani del settentrione
non riescono ancora ad apprezzare l’importanza del
meridione, anzi ci disprezzano a tal punto da volere la
separazione, lasciandoci in
preda a noi stessi; sempre
senza rendersi conto di candidare tutti –noi e loroall’autodistruzione. Il federalismo fiscale è quello che
vuole il Nord; è una palese
dimostrazione di come non
siamo un popolo unito e,
purtroppo, la celebrazione
dell’Unità d’Italia non ha
senso, se non quello di far
riposare per un giorno tutti i
lavoratori.
D’altronde, noi Italiani non
incarniamo affatto lo spirito
di unità a partire da chi ci
comanda che, a mio avviso,
non ha minimamente a cuore le sorti del Paese perché,
se così fosse, farebbe qualco-
sa per migliorarlo e non cercherebbe di separarlo; invece, il politico di oggi è interessato unicamente al proprio tornaconto e non alle
effettive condizioni del Paese. La vera Unità, purtroppo,
è andata persa; il profondo
significato dell’Unità sta tutto in quei decenni che la seguirono, quando i politici
erano intenzionati a plasmare dal nulla lo Stato appena
creato.
Sarà perché i politici moderni
non hanno visto i propri genitori versare il sangue sul
suolo del nostro Paese; sarà
perché nessuno di noi riesce
minimamente ad immaginare
cos’eravamo
prima
dell’unificazione; sarà perché
quella settentrionale e quella
meridionale
sono
due
“Italie” troppo diverse per
poter convivere in un solo
Stato. Sta di fatto che ognuna delle due “Italie” ha bisogno dell’altra per sopravvivere, come due gemelli siamesi
che, legati per la vita, se separati finiscono per morire
entrambi: Come la morte di
uno sovviene poche ore dopo la morte dell’altro, così le
due “Italie” rischiano di andare incontro alla medesima
sorte.
Alessandro Pascarella
Pa g in a 4
NUMERO 2/2011
Quel che resta del Risorgimento
1
Grande era la confusione all’indomani del 17 marzo 1861, dopo la proclamazione dell’unità d’Italia, al termine di un processo
lungo e tortuoso durato decenni e lastricato di morte e sofferenze, di cui nelle scorse settimane, tra mille polemiche e distinguo,
si è festeggiato il 150o. Ma altrettanto diffusa, nei settori borghesi ed intellettuali, era la speranza che qualcosa di importante stesse accadendo. A guardarsi indietro oggi, per molti versi si è trattato di un’occasione perduta. L’unificazione non è riuscita a plasmare un popolo e un’idea di nazione, almeno nel senso compiuto del termine, è vero. Ha tuttavia ottenuto risultati inimmaginabili soltanto pochi anni prima, provvedendo per esempio ad eliminare una pletora di stati, piccoli e grandi, governati sulla base di
una concezione ed una pratica paternalistica del potere e contribuendo in maniera decisiva ad un primo inserimento dell’Italia
nel sistema di stati europei. Ha inoltre
innescato –pur tra i tanti limiti giustamente denunciati, analizzati e documentati da una folta schiera di studiosi, politici ed intellettuali di vario orientamento- la spinta ad uno sviluppo
economico in senso capitalistico,
all’emancipazione di intere classi sociali, all’inserimento del Mezzogiorno
in circuiti dai quali le varie dinastie
succedutesi, segnatamente quella borbonica, l’avevano tenuto fuori per secoli. Senza considerare che, sempre al
Risorgimento e all’Unificazione, si
deve la presa di Porta Pia del 20 settembre 1870, che mise fine ad un regime tirannico ed oscurantista, quale
quello del “Papa Re”, che oggi nessun
Concordato o ingerenza potrà più restaurare nelle sue manifestazioni statuali.
Certo, il Mezzogiorno fu invaso
dall’esercito piemontese e trattato, per molti anni, come terra di conquista. Ma neppure il fenomeno del “brigantaggio”, fomentato in modo pressoché sistematico dai ceti agrari più retrivi e dai sostenitori del decaduto regime borbonico –pur assumendo in
determinate aree e momenti i tratti di una vera e propria rivolta sociale e sollevando problematiche verso le quali nessuno prima
e dopo di allora riuscì a prestare adeguata attenzione ricercando soluzioni, se non quelle di natura repressivo/militare- può essere
accomunato sul piano storico ad un movimento di liberazione, una sorta di Resistenza ante litteram, come invece vorrebbero i
soliti revisionisti.
Intendiamoci: una corrente anti-risorgimentale c’è sempre stata, a partire dal Risorgimento stesso. Ma nessuno, prima d’oggi,
aveva messo in discussione l’Unità in quanto tale, il carattere positivo dell’esistenza dello stato nazionale. Le ricorrenti polemiche anti-unitarie dei leghisti nostrani –i quali non perdono occasione di dimostrare quanto poco o nulla sanno della storia del
paese che governano- si appuntano populisticamente sull’idea di un Sud che drenerebbe a tutto spiano le risorse prodotte dal
Nord. Abituati a sfoggiare i simboli di una “Padania” che esiste solo nella loro mente, a bere acqua del Po, a considerare la bandiera nazionale meno di uno straccio, a bruciare pubblicamente l’immagine di Garibaldi definendolo “l’eroe degli immondi”, a
denigrare con ogni mezzo Giuseppe Mazzini o –che piaccia oppure no- colui che probabilmente rimane il più grande statista
italiano: Cavour, a ridicolizzare –ed è un dato di fatto che esula dalla retorica d’occasione- gli sforzi di tanti italiani sconosciuti
che in quell’idea ci hanno creduto fino a realizzarla anche a costo della vita, non sembrano rendersi conto che non è possibile
governare un paese contro la sua storia, bella o brutta che sia. Come ben sanno i tedeschi, tanto per fare un esempio.
Osservava opportunamente Angelo d’Orsi, sulle pagine de Il manifesto (6 maggio 2010), che “a costoro bisognerebbe innanzitutto ricordare che lo squilibrio tra le due aree, al di là delle situazioni storiche pregresse, è stato favorito da un processo di industrializzazione che si è localizzato nelle regioni settentrionali, a scapito del Mezzogiorno; e ribadire che quel Sud fu ed è tuttora
un mercato essenziale per le imprese produttrici del Nord; e infine, rammentare che i protagonisti di quel terzo moto unitario (il
secondo è stata la lotta di liberazione nazionale contro il nazifascismo, del '43-45), ossia gli immigrati meridionali a Torino, Milano e nelle altre aree industriali, resero possibile la fortuna delle imprese (e degli imprenditori) ivi collocate. E se nel Risorgimento e nella Resistenza, l'opera dei meridionali fu limitata -ma non irrilevante- nelle migrazioni Sud/Nord degli anni
Cinquanta/Sessanta, sono stati i meridionali poveri a fornire il «materiale umano» per le industrie del Nord, dopo aver costituito
carne da macello, accanto ai poveri del resto d'Italia, nei due conflitti mondiali e nelle altre guerre fasciste”.
Ecco, partendo da tali considerazioni e nella convinzione che, comunque sia andata, tutto il processo di unificazione resta un
fondamentale punto di non ritorno nella storia del nostro paese, vorrei provare a rievocarne brevemente le fasi storiche e a delinearne i nodi più significativi.
D I R I TT O D I P A R O L A
Pa g in a 5
2
Con l’armistizio di Villafranca (11 luglio 1859) e la conferenza di Zurigo del mese successivo, che di fatto archiviavano la seconda guerra di Indipendenza, il processo di unificazione faticosamente avviato da Cavour sembrò arenarsi di fronte agli interessi delle grandi potenze europee (Prussia in testa) e all’acquiescenza di Vittorio Emanuele II, contro la quale lo stesso Cavour si
vide costretto a rassegnare polemicamente le dimissioni da primo ministro. Ma è anche vero, per dirla con Giorgio Candeloro,
che esso costituì l’ultimo tentativo degli Stati stranieri di mettere mano all’assetto politico italiano senza consultare gli italiani
A sbloccare la situazione, contro ogni previsione, provvidero i movimenti popolari che, in tutta l’Italia centrale, dopo l’uscita di
scena degli austriaci, impedirono con pubbliche manifestazioni il ritorno o, comunque, la permanenza dei vecchi sovrani. Questi
movimenti, il più delle volte spontanei, si avvalsero dell’apporto massiccio dei moderati e di quello minoritario dei democratici
(mazziniani e non) che, ancora una volta, si rivelarono una forza complementare al moderatismo e, soprattutto, in grado di giungere là dove i tradizionali canali diplomatici non potevano. D’altronde, lo stesso Mazzini, condannato a morte in Piemonte, aveva deciso di rinunciare alla pregiudiziale repubblicana se Vittorio Emanuele si fosse posto a capo del movimento che –a suo avviso- bisognava estendere anche allo Stato Pontificio ed al Regno delle Due Sicilie. Ma il suo tentativo non aveva avuto esito
positivo, costringendolo a trovare rifugio in Svizzera. Il 16 gennaio 1860, ritornato a capo del governo piemontese, Cavour poteva così gestire una situazione diplomatica alquanto ammorbidita rispetto all’anno precedente. E, dietro la cessione di Nizza e
della Savoia, riusciva ad ottenere il consenso francese all’annessione (attraverso plebisciti) di Toscana, Emilia e Ducati Centrali.
I preparativi si svolsero con celerità, allertando i governi provvisori e la rete prefettizia da poco istituita. Infatti, il vero pericolo
non erano i risultati, visto che tutti –democratici compresi- si mostravano favorevoli. In più, la domanda agli elettori veniva posta in modo volutamente capzioso, in modo da orientare drasticamente la scelta verso l’annessione: bisognava cioè scegliere se
entrare a far parte di una monarchia costituzionale guidata da Vittorio Emanuele II oppure di un misterioso “regno separato” di
cui nessuno, al momento, sapeva indicarne peculiarità e guida. Il rischio concreto, quello che preoccupava Cavour ed i suoi sostenitori, era invece l’astensionismo, soprattutto nelle campagne, dove le masse erano ancora escluse dal movimento patriottico,
monopolizzato in massima parte da ristrette élite intellettuali e borghesi. Nonostante la propaganda contraria di parroci reazionari
e sanfedisti, queste non avrebbero mai osato battersi contro le annessioni ma, con un massiccio astensionismo, ne avrebbero inficiato la portata di fronte alla diplomazia europea.
Si corse ai ripari nell’unico modo possibile, ordinando ai prefetti di imporre ai fattori di stanare con ogni mezzo i contadini, uno
per uno, con una “caccia all’uomo”, e di portarli in massa a votare per l’annessione. Si trattò di una vera e propria mobilitazione
di massa, realizzata con metodi totalitari, come attestarono anche i risultati, considerato che all’epoca la base elettorale era costituita da una bassissima percentuale della popolazione. In Toscana votò circa il 75% della popolazione (370mila a favore e
20mila contro), mentre in Emilia si andò oltre l’80% (430mila a favore, circa 1.500 contro). Era una vittoria di Cavour, certo, ma
solo sul piano aritmetico e diplomatico. I metodi adoperati dimostravano, al di là di ogni dubbio, che le masse italiane, storicamente ostili all’idea di “nazione”, incontravano grosse difficoltà perfino ad accettarla. E l’Italia cominciava a nascere con il sopruso di una minoranza su una maggioranza pressoché assente, che non avendo collaborato si sentiva estranea, finanche ostile.
Comunque, la situazione appariva ora piuttosto chiara: dopo le annessioni, gli spazi diplomatici finalizzati ad ottenere
l’unificazione della penisola si erano ormai completamente esauriti. L’unica strada obiettivamente percorribile rimaneva quella
insurrezionale indicata da Mazzini. Ma un governo moderato quale quello piemontese, sotto lo sguardo attento delle diplomazie
europee –pronte a cogliere e punire il minimo errore- non poteva farsene carico. Ecco perciò che l’azione cominciò a passare
dalle mani dei moderati a quelle dei democratici.
3
Il Mezzogiorno d’Italia, sotto il dominio borbonico, viveva una crisi profonda ed insolubile. Da decenni, la storiografia si è divisa sulla profondità e sulle peculiarità di questa crisi. Di certo, la morte del sovrano Ferdinando II e la salita al trono del giovane
ed impreparato figlio Francesco II (22 maggio 1859) non avevano contribuirono a migliorare le cose. Le stesse masse contadine
–su cui i Borbone avevano potuto costantemente far leva- si mostravano indifferenti, se non addirittura ostili nei loro confronti.
A ciò si aggiungevano le spinte autonomistiche della Sicilia, mai tramontate del tutto, vera spina nel fianco per ogni tentativo di
sopravvivenza del Regno, e l’isolamento sul piano internazionale. Tuttavia, l’opposizione interna (moderata e non) appariva
anch’essa debole e pertanto la situazione –col contributo di paesi come la Francia e la Russia, timorosi di veder sbloccare il secolare l’equilibrio di quell’area strategica- si trascinava senza alcuna via di uscita.
Fino ad allora, molte rivolte scoppiate in Sicilia erano state duramente represse dall’esercito borbonico. E il grande merito dei
democratici fu quello di intuire che l’isola costituiva il vero punto debole del regime borbonico e che, quindi, era proprio lì che
bisognava concentrare i propri sforzi. I preparativi per una spedizione con lo scopo di liberarla si svolsero a Genova, sotto lo
sguardo attento di Garibaldi, senza che le autorità piemontesi facessero nulla per ostacolarli. In proposito, si è molto discusso
intorno alla conoscenza di tali preparativi da parte del re e di Cavour. Ma sembra che solo il primo fosse informato della cosa ed
in grado di prevenirla. Cavour –acerrimo nemico di Garibaldi e sempre critico verso il suo stesso sovrano- pur informato, non
aveva in quei frangenti la forza di opporsi e di arrestare Garibaldi, perché politicamente indebolito dalla questione di Nizza e
della Savoia con la Francia di Napoleone III.
Pa g in a 6
NUMERO 2/2011
In pochi giorni, si raccolsero poco più di un migliaio di volontari, quasi tutti provenienti
–contrariamente a quanto oggi
sostenuto a gran voce dalla vulgata leghista- dalle regioni settentrionali, segnatamente dal bergamasco. Essi partirono nella notte
tra il 5 ed il 6 maggio 1860 da Quarto, presso Genova, a bordo di due navi: il Piemonte ed il Lombardo, proprietà dell’armatore
Rubattino. Erano male equipaggiati ed abbigliati in modi fantasiosi considerata la situazione. Sicché, furono costretti a fare scalo
a Talamone, in Toscana, dove il comandante del fortino acconsentì a rifornirli di un piccolo quantitativo di armi e di indumenti,
comprese –pare- le famose camicie rosse.
Lo sbarco vero e proprio avvenne a Marsala, l’11 maggio, ed il primo scontro con le forze borboniche a Calatafimi, il 15. Da
quel momento fino alla liberazione di Palermo (6 giugno), si assistette ad un susseguirsi di successi che, col concorso di molta
fortuna, esaltarono le capacità militari e la popolarità di Garibaldi, il cui esercito non aveva affatto accresciuto i suoi effettivi –
come comunemente si crede- in seguito all’arruolamento massiccio dei contadini e dei picciotti, animati in realtà da semplici
sentimenti antiborbonici ed in attesa dell’esito dello scontro per accodarsi al vincitore, ma per il concorso esterno degli stessi
democratici di altre regioni, successivamente rafforzato da volontari di estrazione artigiana e borghese provenienti dalle città
siciliane. Dopo avere istituito un governo provvisorio, sotto la guida di Francesco Crispi, fu stroncata a Milazzo, il 20 giugno,
l’ultima resistenza borbonica. Tranne Messina, tutta la Sicilia era stata liberata, sebbene non fossero mancati episodi oscuri ed
ambigui che macchiarono indelebilmente la popolarità dell’epopea garibaldina, evidenziandone i limiti.
Benché sulla lealtà monarchica dell’ “eroe dei due mondi” non ci fossero dubbi, Cavour cominciò seriamente ad allarmarsi -di
fronte alla crisi dell’esercito e della leadership borbonica e al pubblico auspicio del fronte democratico che, all’indirizzo moderato fino ad allora prevalso nell’Italia centro-settentrionale, si contrapponesse, nel Mezzogiorno, l’istituzione di un’assemblea nazionale costituente- avviando in tutta fretta contatti per un’immediata annessione delle Sicilia che svuotasse la portata rivoluzionaria dell’avanzata garibaldina. Dal canto suo, il re di Napoli –consigliato da Vittorio Emanuele e da Cavour, speranzosi di vedere realizzato un regno dell’Italia centro-settentrionale a guida sabauda ed uno del Sud a guida borbonica- tentò di arginare la
crisi rimettendo precipitosamente in vigore la costituzione del 1848, ristrutturando la complessa macchina statale, e nominando
un governo di ispirazione liberale. Ma senza risultati, anzi. Pochi mesi dopo, il 6 settembre, fu costretto ad abbandonare Napoli
con tutto il suo seguito, rifugiandosi nella fortezza di Gaeta.
Il giorno successivo i garibaldini entravano in città, accolti dall’entusiasmo dei napoletani. A quel punto, i maggiori esponenti
del Partito d’Azione accorsero a Napoli da ogni angolo d’Italia nel tentativo di trovare una linea comune per il prosieguo
dell’avanzata. C’erano Saffi e Saliceti; Alberto Mario e sua moglie Jessie White, suffragetta inglese. Reduce dalla galera, Nicotera e, dal 19 ottobre, lo stesso Mazzini. C’erano perfino due guru del federalismo: Ferrari e Cattaneo, quest’ultimo (citatissimo
dalla Lega, che ama indicarlo come il campione dell’attuale “federalismo”, in realtà tra i più convinti sostenitori dell’unità italiana) invitato dallo stesso Garibaldi in qualità di consulente.
4
L’1 ottobre l’esercito borbonico affrontò nell’ultima battaglia quello garibaldino, nei pressi di Caiazzo, lungo il fiume Volturno.
Fu una sconfitta che aprì di fatto le porte del Sud ai liberatori. Cavour, che aveva in precedenza cercato con ogni mezzo di impedire l’avanzata garibaldina dalla Sicilia verso il continente, si era alla fine dovuto arrendere. “Se domani entrassi in lotta con
Garibaldi –scriveva a Nigra, suo ambasciatore a Parigi- è probabile che avrei dalla mia la maggioranza dei vecchi diplomatici,
ma l’opinione pubblica europea sarebbe contro di me, e con piena ragione perché Garibaldi ha reso all’Italia i più grandi servigi
che un uomo potesse renderle: ha dato agl’italiani fiducia in se stessi e ha dimostrato all’Europa ch’essi sanno battersi e morire
per riconquistarsi una patria”. Erano le parole sincere di un uomo che sapeva riconoscere i meriti dell’avversario, ma anche di un
grande statista pronto ad accettare la realtà, anche se poco gradevole.
A questo punto, anziché opporsi al corso degli eventi, diventava per lui essenziale controllarli, evitando il rischio di un intervento di truppe straniere, secondo il cosiddetto “principio di ingerenza” a suo tempo stabilito dalla Santa Alleanza. D’accordo con
Napoleone III, inviò l’esercito ad occupare le Marche e l’Umbria, immediatamente annesse, sconfiggendo a Castelfidardo (18
settembre) le truppe pontificie accorse a sbarrargli il passo. Il 3 ottobre Garibaldi si incontrò con Vittorio Emanuele II nei pressi
di Teano in un’atmosfera fredda ed informale, sbrigativa, al limite della scortesia (soprattutto da parte del sovrano sabaudo),
lontana anni luce dalla plastica rappresentazione tramandata dalla retorica risorgimentale, mentre a Torino la Camera dei Deputati approvava un disegno di legge che prevedeva l’accettazione senza riserve, da parte del governo, dell’annessione attraverso
plebisciti di tutte le altre regioni italiane.
Era l’effettiva liquidazione dell’impresa dei Mille e il passaggio dei poteri alla monarchia sabauda. Una eventuale svolta democratica al Sud –già in origine difficile- diventava ora davvero improbabile in ragione dell’atteggiamento della borghesia moderata, favorevole all’immediata annessione, mentre la delusione contadina –abilmente manovrata di ceti più retrivi- cominciava già
a manifestarsi con le prime forme di rivolta che preludevano al “brigantaggio”.
Il 21 ottobre furono annesse al Piemonte le Due Sicilie. Partecipò al voto, come in Toscana e in Emilia, un’altissima percentuale di iscritti alle liste: l’80% nelle province continentali (1.300.000 i sì e 10mila i no) e il 75% in Sicilia (430mila i sì e
circa 700 i no), anche se sui metodi utilizzati è meglio non soffermarsi. Il 4 e 5 novembre toccò all’Umbria e alle Marche,
con esiti simili. A Napoli, la luogotenenza fu assunta da due rappresentanti del governo piemontese, Farini e Montezemolo.
Le truppe garibaldine, che il generale aveva via via trasformato in un vero esercito i cui ufficiali –in seguito confluiti
nell’esercito sabaudo con ottimi risultati- si erano quasi tutti formati nell’unica efficiente scuola di guerra: la guerra stessa,
fu ufficialmente sciolto. Il Parlamento, riunitosi per la prima volta a Torino il 18 febbraio 1861, ratificò il 17 marzo successivo l’unificazione, proclamando il Regno d’Italia.
D I R I TT O D I P A R O L A
Pa g in a 7
La sua base sociale risultava costituita dall’alleanza tra la borghesia progressista dell’Italia settentrionale ed il blocco agrario
conservatore del Mezzogiorno. Il re d’Italia, tra molte polemiche, continuava a chiamarsi Vittorio Emanuele II per chiarire definitivamente che lo stato unitario era il frutto non di una rivoluzione, ma di una politica di annessione pazientemente perseguita
dal Piemonte.
L’unificazione era stata conseguita sulla base della convergenza di molte casualità, ma con il concorso di tutte le forze politiche:
moderate, radicali, democratiche, socialiste. Il contrasto generatosi dall’incontro-scontro di queste correnti vide prevalere le forze moderate, che avevano gestito autorevolmente e con estrema decisione le ultime fasi del Risorgimento, sfruttando
all’occorrenza l’azione svolta dalle altre forze, quella democratica in particolare.
Si crearono, pertanto, le condizioni perché la vecchia aristocrazia ormai imborghesita e la grande borghesia prendessero nelle
mani la direzione del paese, orientandone scelte e prospettive. Questo blocco moderato (la futura Destra storica), rispetto a quello democratico, mostrava maggiore compattezza di classe, dal Nord al Sud del paese, ed autorevole sostegno (Napoleone III su
tutti). Tuttavia, le resistenze che incontrò, allora come in seguito, furono notevoli (Chiesa, masse contadine, piccola borghesia).
Il che la costrinse ad accettare il compromesso con le forze sociali più arretrate, in particolar modo con la borghesia agraria
dell’Italia meridionale, cui garantì continuità di dominio sulle masse contadine, ricevendone in cambio appoggio nella realizzazione del programma politico.
Si abbandonò il progetto di autonomia regionale, preferendogli l’accentramento politico-amministrativo e alla convocazione di
un’assemblea costituente –avanzata dai democratici- fu preferita l’adozione dello Statuto Albertino, concesso dal re di Sardegna
nel 1848, che offriva ampio margine di autonomia nei confronti del Parlamento. Il nuovo stato italiano fu dotato di un ordinamento già adottato nel Regno di Sardegna, improntato al modello amministrativo napoleonico, che assicurava il rigido controllo
del governo, per mezzo dei prefetti, su tutta la vita locale, dando vita al cosiddetto fenomeno della “piemontesizzazione”. Il partito democratico, vera forza alternativa del Risorgimento, aveva perso la preziosa occasione di allearsi con le masse contadine,
che rimasero in tal modo escluse dal processo risorgimentale.
Ciro Rocco
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
1954 – D. Mack Smith, Cavour e Garibaldi nel 1860, Einaudi
1956-68 – G. Candeloro, Storia
dell’Italia moderna, voll. I – V, Feltrinelli
1960 – M. L. Salvadori, Il mito del buongoverno, Einaudi
1962 – W. Maturi, Interpretazioni del
Risorgimento, Einaudi
1962 - P. Pieri, Storia militare del Risorgimento, Einaudi
1963 – R. Romeo, Dal Piemonte sabaudo
all’Italia liberale, Laterza
1964 - F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Feltrinelli
1969 - A. Lepre, Storia del Mezzogiorno
nel Risorgimento, Editori Riuniti
1972 – F. Cusin, Antistoria d’Italia. Mondadori
1979 – A. Galante Garrone – F. Della
Peruta, La stampa italiana del Risorgimento, Laterza,
1984 – R. Romeo, Vita di Cavour, Laterza
1993 – D. Mack Smith, Mazzini, Rizzoli
2002 – S. Lupo, Il grande brigantaggio.
Interpretazione e memoria di una guerra
civile, in “Storia d’Italia – Annali”, vol.
XVIII, Einaudi
2004 – A. M. Banti, Il Risorgimento italiano
Pa g in a 8
NUMERO 2/2011
I contrasti della diversità
Al mondo, per quanto si possa cercare, è impossibile trovare una persona esattamente uguale ad un’altra e questo, per alcuni aspetti, è un bene. Proviamo ad immaginare solo per un istante un mondo in cui le persone siano tutte uguali, con le stesse idee, stessa personalità,
stesso modo di pensare... sarebbe la monotonia più totale dalla quale possiamo fuggire tornando al mondo reale,
con le mille differenze che esso presenta, dalle religioni
alle culture.
Così come un tifoso fa della propria squadra del cuore la
migliore di tutte, allo stesso modo l’uomo fa con la propria etnia, ed è così da tempo. Il fenomeno del razzismo
è infatti un fenomeno radicato nella società, un problema
impossibile da nascondere o ignorare. Parlando di razzismo, non si deve solo pensare ad un razzismo estremo
(quanti hanno pensato ad Hitler?), ma anche a quello
presente nella vita di ogni giorno e, quindi, non solo rivolto alle persone culturalmente o fisicamente diverse, ma
anche quello diretto, volontariamente o meno, verso i
disabili, per citare un caso, che vede questi ultimi spesso
abbandonati senza un aiuto. Il nostro modo di fare ed il
disprezzo di alcune persone verso questi soggetti richiama alla mente un comportamento ben più estremo ed
ignobile, il progetto nazista T4.
I nazisti vedevano nei diversamente abili dei “parassiti”
per la società che, non potendo servire lo stato, lo indebolivano. Erano per questo una piaga da eliminare, atteggiamento giustificato dall’idea di velocizzare la selezione naturale di Darwin, una sorta di legge della
giungla nella quale il più debole è destinato a soccombere. Il razzismo è dunque generato da questa diversità, che si manifesta anche nelle idee degli individui, basti pensare agli innumerevoli dibattiti
sull’eutanasia e sul significato di “vita” sul quale ognuno di noi esprime un parere diverso rifacendosi spesso alla propria cultura, al proprio credo, alla propria vita vissuta.
In definitiva, si può leggere la
diversità come una medaglia
con una duplice faccia: rende il
mondo vario e non standardizzato, ma genera contrasti, divergenze, fobie e spesso anche guerre.
Come affrontare dunque la
questione? Sicuramente con
maturità, spogliandosi di ogni
egocentrismo, abbandonando
l’idea di un “pensiero assoluto
e corretto” e di una “verità universale” di cui ognuno si crede
depositario, aprendosi a nuove
idee, a nuovi usi e costumi, ad
una “nuova tolleranza”.
Clemente Finocchiaro
D I R I TT O D I P A R O L A
Se non ora, quando?
‘Se non ora, quando?’. Così è stata chiamata la manifestazione avvenuta domenica 13 febbraio a Caserta, in
piazza Dante, dove alcune centinaia di donne e uomini
si sono riuniti per difendere la dignità delle donne di
fronte a questa società corrotta, dove apparire vale
più che essere.
Hanno partecipato alla manifestazione anche le rappresentanti dell’Associazione Spazio Donna ONLUS. A
spiegare le ragioni che hanno portato Spazio Donna a
partecipare alla manifestazione è la vicepresidente
Adele Grassito; “Ancora una volta il genere femminile
non è considerato una categoria sociale, ma solo un
prodotto di cui usare ed abusare nelle immagini comunicative e mediatiche”.
Anche l'Unione degli Studenti Caserta ha partecipato
per ribadire nuovamente che questo Paese, dove gli
organi di informazione e di cultura sono praticamente
monocratici, a parte quelle poche voci che resistono,
non è quello vogliamo, cioè un'Italia dove possa nascere un'altra idea di Paese, un'altra idea di rapporto tra
i sessi attraverso la rivendicazione di diritti fondamentali come istruzione e lavoro.
Ma il problema non è per quelle donne che ormai hanno
un posto nella società, ma per coloro che si sentono
sconfitte già in partenza. Da un lato ci sono le ragazze con un lavoro precario, dall’altro quelle che invece
guadagnano migliaia di euro vendendo il loro corpo.
Con queste ed altre testimonianze si voleva dimostrare che l’Italia è nata anche grazie alle donne, donne
che hanno lavorato duramente e hanno conquistato i
loro diritti.
E’ perciò giusto che le nuove generazioni siano informate e capiscano che vale più una donna che, dopo
anni di sacrifici, ha raggiunto i suoi obiettivi, creandosi uno spazio all’interno della società, diventando un
esempio per molti, senza dover ringraziare nessuno,
piuttosto che ragazze immagine che mostrano corpi
perfetti, con i quali è possibile ottenere tutto.
La manifestazione si è conclusa con dei balli popolari,
dove tutti hanno partecipato ballando o tenendo il ritmo con le mani. Inoltre era stato allestito un tabellone dove chiunque poteva scrivere il proprio pensiero
(la maggior parte dei quali era di protesta contro il
governo).
Quello che resta fare ora è aspettare che questo grido di protesta arrivi al destinatario e qualcosa migliori!
Lucia Fascia
Pa g in a 9
Manifestazione del “Giordani”
per la Festa della Donna
Il Dirigente Scolastico Prof.Francesco Villari
Oggi la festa della donna è celebrata in molte nazioni per
ricordare le lotte del passato, ma con il tempo quella che era
in origine una giornata di lotta dal forte e duro significato
politico, è andata lentamente attenuando i suoi toni di battaglia sociale per acquisire quelli di una festosa ricorrenza,
sempre più caratterizzata da connotati di carattere commerciale, con regali ad hoc e feste nei ristoranti e nei locali,
spesso rigorosamente vietate agli uomini.
Ma la commemorazione di tale evento viene largamente
rispettata e celebrata ogni anno presso la nostra scuola con
una manifestazione pubblica. Infatti, il nostro istituto organizza annualmente uno spettacolo centrato appunto sulla
festa della donna e che riceve il pieno sostegno dal nostro
Dirigente Scolastico, prof. Francesco Villari. Questo spettacolo, dal titolo “Effetto Donna”, è diretto interamente
da un ex-professore del nostro istituto, Pasquale De Marco,
che dirige un laboratorio musicale cui partecipano sia allievi
che ancora frequentano il nostro istituto sia studenti già
diplomati.
Lo spettacolo, tenutosi il 9 marzo 2011 presso l’Auditorium
di via Ceccano, ha visto partecipare molti nostri allievi che si
sono esibiti in piccoli balletti, canzoni inerenti al mondo della donna. Come ospite speciale, è stata accolta l’autrice del
libro ”Donne,cancelli delitti”, Liliana De Cristofaro. Il libro,
straordinariamente coinvolgente, raccoglie le testimonianze
di dieci detenute che l’autrice ha incontrato nel corso della
sua trentennale carriera lavorativa. L’autrice riesce a sublimare, con la sua prosa raffinata e scorrevole, i ricordi delle
protagoniste, stemperando le asprezze di episodi cruentie
inquadrandoli in una cornice di profonda umanità.
Lo spettacolo, come altre manifestazioni che il nostro istituto promuove, ha ottenuto particolare successo, valorizzando
questa festa che, in molte parti del mondo, sta perdendo la
propria importanza.
Alessandro Altruda, Michele Bosco, Michele Sanfelice
Pa g in a 10
LIBERTE', EGALITE', FRATERNITE'
"Una dittatura tra le più feroci al mondo, con a capo il monarca assoluto
Mubarak, tenta di reprimere la rivolta di un popolo che lotta per la democrazia. Non servirà a nulla sparare sulla folla, chiudere ogni tipo di comunicazione, rassicurare gli alleati. Quando il profumo della libertà si diffonde, nulla può fermarlo. E i giovani lo sanno"; con queste parole di Gianfranco Mingione si riassume la situazione estremamente complicata che
ha vissuto nei mesi scorsi l' Egitto.
Non è la prima volta, ma probabilmente non sarà nemmeno l' ultima, visto
che la storia è testimone di altri celebri scontri dove i popoli oppressi
hanno sacrificato vita ed ideali per sè e per il prossimo. E' il caso della
rivoluzione francese, le cui idee rivoluzionarono il mondo e che fornì il
modello a tutti i movimenti rivoluzionari successivi, come anche quello
russo del 1905.
La rivolta francese prima e quella sovietica poi hanno sicuramente diversi
punti in comune con
l' attualissima rivolta egiziana; infatti, come Mubarak, tiranno egiziano, anche Francia e Russia erano mal governate da
monarchi assoluti circondati da pochi privilegiati, oppressori fino all'estremo di popoli ormai ridotti in miseria. In Francia, causa della rivolta fu
principalmente il peso fiscale che opprimeva le masse popolari. Questo
non fece altro che inasprire il popolo e la borghesia. Il famoso "terzo stato" aspettava solo l'occasione per esplodere e rivendicare la propria libertà e i propri diritti. Con la presa della Bastiglia cominciarono dieci anni
di sangue che si conclusero con un bilancio spaventoso di morti, ma con
una nazione finalmente unita e libera e con il monarca Luigi XVI finalmente fuori gioco.
Analogamente, in Russia, al popolo era ancora imposto il culto della figura
dello zar padrone e semidio di ogni uomo o possedimento nell’immenso
territorio "di tutte le Russie". Anche qui la fragilità e la debolezza
dell'organizzazione politica e militare, unite ad una crisi economica senza
fine, finirono con l'esasperare la maggioranza della popolazione. L'apice
dello scontro si ebbe nel 1905 quando le truppe zariste risposero violentemente ad alcune manifestazioni pacifiste nella famosa e triste
"domenica di sangue".
Ed è proprio vero che la storia si ripete perché anche il dittatore Mubarak ha ordinato ai suoi uomini di aprire il fuoco sulla folla manifestante
che non chiedeva altro che riforme economiche adeguate, libertà religiosa e magari le dimissioni del presidente dittatore. Invece no, è nato solo
un lungo scontro conclusosi con la fuga del dittatore.
Illuminanti sono infatti le parole di John F. Kennedy: "Coloro che rendono
impossibili le rivoluzioni pacifiche fanno sì che diventino inevitabili quelle
violente". Questa rivoluzione è però solo nella fase iniziale. Occorre ora
ricostruire il paese, evitando il pericolo dell’estremismo islamico. Il solo
augurio che si può fare è che il mondo aiuti a risolvere questa situazione
il glorioso popolo delle piramidi, sancendo finalmente quei principi sanciti
per prima dalla Francia, ma che dovrebbero appartenere a tutti: LIBERTE', EGALITE', FRATERNITE'.
Vincenzo Avallone, Maria Pappadia, Maura Pontoriero
NUMERO 2/2011
Sulle necessità
E’ nella necessità di spezzare
i giorni, le ore, i minuti e gli attimi,
ucciderti mano a mano, scioglierti
e vederti rinascere sempre
ove risiede la mia incoerenza
per cui insisto e brucio,
rendo brandelli la vita
affinché il tuo sorriso
riaffiori come un sole,
un arco la cui freccia
rabbrividisce ogni alba,
ogni ora, ogni giorno
la mia necessità
di doverti pensare.
E così ti ritrovo,
riapro il libro dei miei ricordi
e sudo, forse piango
ma non demordo, sogno,
non demordo e sogno
così appari, sospiri i tuoi
- sì, eccomi, baciami ma rimango triste, non rinnego
nulla, non cancello il mio infinito,
non dubito della tua presenza
resto qui a dipingerti
come solo noi sappiamo fare
per sempre ti aspetto,
da qui non mi muovo.
Nando Taccogna
D I R I TT O D I P A R O L A
Pa g in a 11
Il testo di Daniel Pennac si presenta in maniera scorrevole
e piacevole alla lettura, coinvolgendo il lettore ed invitandolo a costanti riflessioni riguardo il suo passato (o presente) da studente ed il rapporto con i propri professori. Il
libro è diviso in due parti. La prima che racconta per sommi capi del suo periodo da “somaro”, illustrando quello
che era il suo pensiero sulla vita e sulla società in cui viveva. La seconda parte, invece, affronta il momento di passaggio tra il suo periodo da “somaro” a quello da professore, e la ricerca delle ragioni della sua passata ignoranza.
L'abilità dell'autore, secondo me, è stata quella di riuscire
a mettere in risalto molteplici aspetti riguardanti il rapporto
che c'è tra l'alunno “somaro” e i propri docenti i quali, nonostante l'enorme bisogno di aiuto nello studio da parte dei
propri allievi meno abili, preferiscono spesso catalogare
semplicemente l'alunno come “somaro” e dedicarsi con
impegno a coloro che sono già capaci. Pennac analizza
inoltre tutte le varie cause, scolastiche e sociali, dell'ignoranza dei ragazzi al giorno d'oggi, e ne spiega le ragioni
alla fine del libro.
Raffaele Cataletti
e
CONTRO
PRO
La scuola è uno dei pochi argomenti sempre importanti che non vengono mai chiusi nel dimenticatoio. Daniel Pennac, nel libro “Diario di scuola”, parla della
sua vita scolastica e scrive un romanzo molto diverso
dal solito, che pare in certe occasioni più un saggio, in
cui parla del cammino che ha compiuto per divenire
professore e scrittore.
Pennac era un somaro e, pur dando un'idea abbastanza
chiara di come lui era riuscito a cambiare e di come si
impegnava con alunni che si comportavano come lui
da somaro, il libro pubblicato da Feltrinelli non soddisfa il lettore, o almeno il sottoscritto. Nell'intero romanzo, l'autore pizzica tanti argomenti che si ricollegano, alcuni più altri meno, alla scuola e ai suoi problemi, ma proseguendo la lettura ciò comincia a diventare molto fuorviante e dispersivo, andando addirittura a toccare il marketing e le pubblicità, quando
forse il problema è ben più circoscritto di quel che fa
intendere l'autore. Sembra quasi che Pennac abbia voluto inserire tutto ciò che gli veniva in mente e fosse
collegato direttamente o indirettamente all'ambito scolastico: il tutto per arrivare a un numero di pagine soddisfacente (250 circa).
L'unico punto in cui lo scrittore è riuscito ad essere
sintetico e a trasmettere pienamente la sua idea riguardo il ruolo del professore nel recupero somaro, è nelle
ultime due pagine, davvero eccezionali per qualità
comunicativa, senza perdersi in giri di parole o termini
complessi che potrebbero trasmettere una immagine
leggermente narcisistica dell'autore.
Insomma, “Diario di scuola” non è sicuramente un
brutto libro, ma chi cerca una lettura che può cambiare
il suo modo di vedere la scuola, o almeno alterarlo, ne
rimarrà secondo me fortemente deluso.
Donato Riello
I . T . I . L .S . “ F R ANC E S C O G I O RD A NI ” C AS E R T A
Dirigente Scolastico:
Prof. Francesco Villari
Redazione:
Prof. G. De Tata,
Prof. C. Rocco,
Alunni dell’ Istituto
Per contatti e collaborazioni:
tel. 0823327359 Fax
0823325655
E-mail: [email protected]
Editor:
[email protected]
SIAMO SU INTERNET !
www.giordanicaserta.it
The Social Network
******
“The Social Network” è un film diretto dal regista David Fincher, il cui obiettivo forse è quello di far notare come il successo possa portare ad essere soli, mettendo in evidenza proprio la figura di Mark Zuckerberg, il
creatore di un social network così famoso che però si ritrova ad essere
solo.
Mark Zuckerberg è uno di quei classici “nerd” con molte difficoltà a socializzare, che considera come nemici coloro che riescono ad integrarsi meglio di lui, come ad esempio il suo migliore amico. Nel film, Mark viene
lasciato dalla sua ragazza, che invece tanto ammirava gli atleti della sua
università, ovvero quella di Harvard. Mark viene rifiutato dai club più importanti dell’università e riesce a mettersi in vista solo grazie ad un programma ideato da lui che è in grado di recuperare le foto di tutte le ragazze delle università di quell’area allo scopo di votare la più bella. Riesce nel
suo intento, facendo saltare la rete dell’università e dovendo pagare una
multa. Ma non passa inosservato. Infatti gli viene proposto di partecipare
alla creazione di un social network proprio da alcuni canottieri
dell’università, che però non aiuterà mai e, anzi, prenderà spunto dalla
loro idea per dar vita al moderno Facebook.
Ma inizia subito la battaglia legale contro Mark per quell’idea che, poco
tempo dopo, avrebbe fruttato milioni e milioni di dollari. La storia viene
descritta con vari flashback che nascono durante le discussioni legali tra
Mark, il suo migliore amico e gli atleti a cui rubò l’idea, e tra i rispettivi
avvocati. Questa storia, quindi, rappresenta una sorta di rivincita da parte
dei “nerd”, che sono quasi inabili a socializzare, contro coloro che invece
sono ben integrati.
Jesse Eisenberg riesce bene nel suo intento di mostrare questa inabilità
nel socializzare da parte del personaggio di Mark Zuckerberg, che rende
straordinariamente inespressivo e anonimo. Inoltre, questo film riesce a
riportare senza clamore un dato di fatto della vita moderna, ovvero che
molti di noi, oggi, danno alla vita in rete la stessa importanza che ha quella
reale.
Fabrizio Zoleo