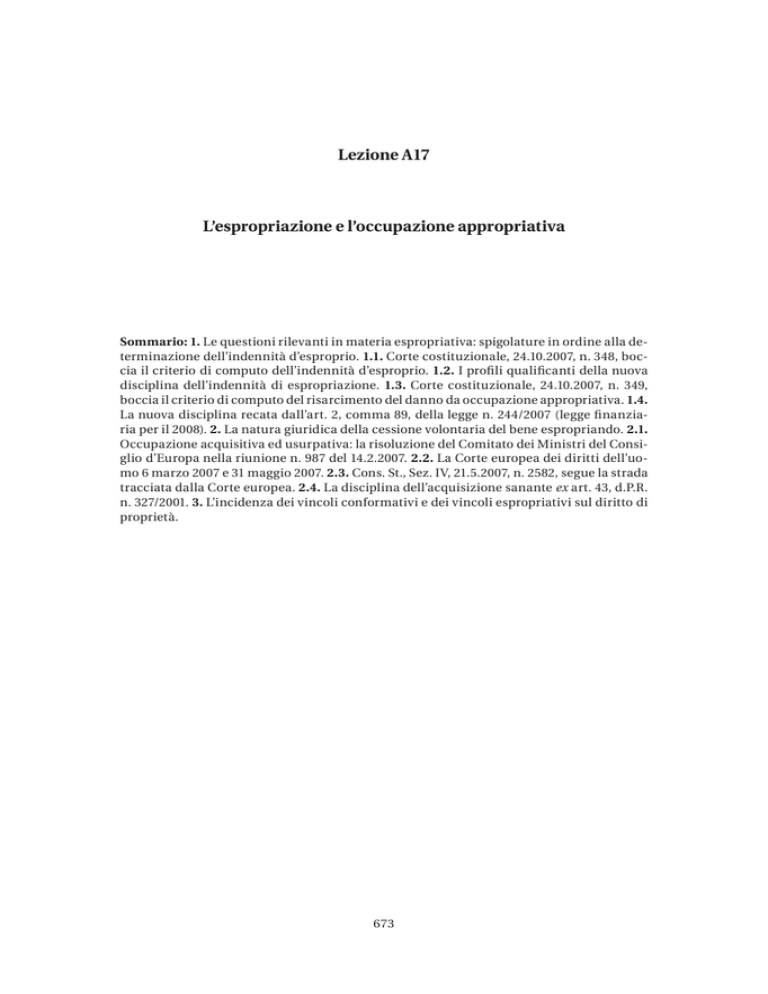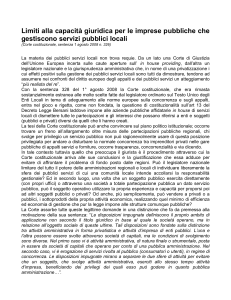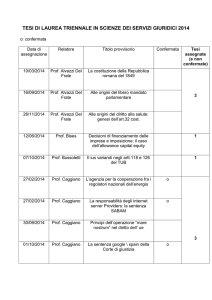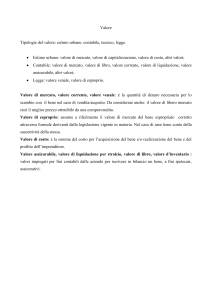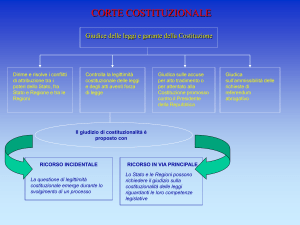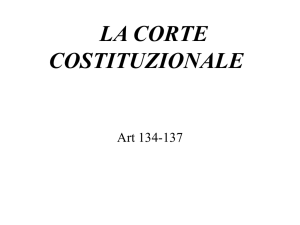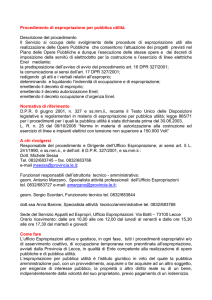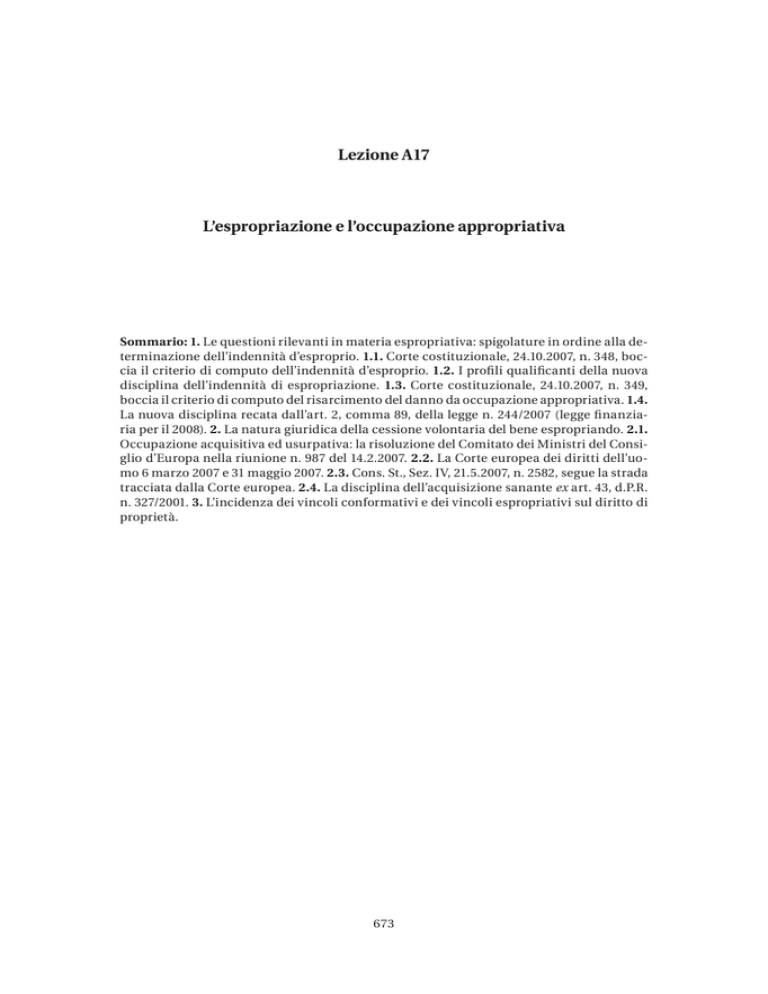
Lezione A17
L’espropriazione e l’occupazione appropriativa
Sommario: 1. Le questioni rilevanti in materia espropriativa: spigolature in ordine alla determinazione dell’indennità d’esproprio. 1.1. Corte costituzionale, 24.10.2007, n. 348, boccia il criterio di computo dell’indennità d’esproprio. 1.2. I profi li qualificanti della nuova
disciplina dell’indennità di espropriazione. 1.3. Corte costituzionale, 24.10.2007, n. 349,
boccia il criterio di computo del risarcimento del danno da occupazione appropriativa. 1.4.
La nuova disciplina recata dall’art. 2, comma 89, della legge n. 244/2007 (legge fi nanziaria per il 2008). 2. La natura giuridica della cessione volontaria del bene espropriando. 2.1.
Occupazione acquisitiva ed usurpativa: la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella riunione n. 987 del 14.2.2007. 2.2. La Corte europea dei diritti dell’uomo 6 marzo 2007 e 31 maggio 2007. 2.3. Cons. St., Sez. IV, 21.5.2007, n. 2582, segue la strada
tracciata dalla Corte europea. 2.4. La disciplina dell’acquisizione sanante ex art. 43, d.P.R.
n. 327/2001. 3. L’incidenza dei vincoli conformativi e dei vincoli espropriativi sul diritto di
proprietà.
673
L’espropriazione e l’occupazione appropriativa
1. Le questioni rilevanti in materia espropriativa: la Corte costituzionale interviene in ordine alla determinazione dell’indennità d’esproprio
In materia espropriativa, rinviando per i profili processuali alla lezione 15,
le questioni di maggiore interesse attengono: 1) alla determinazione dell’indennità d’esproprio; 2) alla natura giuridica della cessione volontaria; 3) all’istituto dell’occupazione nelle sue varie forme; 4) alla disciplina dell’acquisizione
sanante ex art. 43, d.P.R. n. 327/2001.
Nel caso in cui l’amministrazione non corrisponda l’indennità d’esproprio
l’espropriato non può presentare istanza all’amministrazione per poter utilizzare il rimedio di cui all’art. 21 bis, l. TAR, atteso che trattandosi di una relazione di diritto-obbligo, non concerne un atto autoritativo della P.A. la cui cognizione è pertanto sottratta alla giurisdizione del G.A., essendo affidata a quella
del G.O. (sul tema cfr. di recente Cons. St., Sez. IV, 16.11.2007, n. 5834).
Quanto alla determinazione dell’indennità d’esproprio si segnala che il criterio di liquidazione dell’indennità di esproprio è stato criticato dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 29 marzo 2006 (Scordino c. Italia), per non offrire al proprietario un indennizzo pari al valore venale del bene in assenza di ragioni che possano giustificare una minore indennità. Con
ordinanze rese in data 29 maggio e 19 ottobre 2006, invece, la Suprema Corte
ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 5 bis del d.l. 11.7.1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella l. 8.8.1992, n. 359, ritenendo che “la norma
è oggetto di censura nella parte in cui, ai fini della determinazione dell’indennità
di espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla
media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l’applicazione ai giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore della l. n. 359
del 1992”. Inoltre, la Corte di Cassazione, n. 11887/2006, ha sollevato questione
di costituzionalità in ordine al parametro indennitario utilizzato per il ristoro
in caso di occupazione appropriativa, affermando che: “In tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, non è manifestamente infondata,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis, comma 7 bis, della legge
n. 359 del 1992, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., anche alla luce
dell’art. 6 e dell’art. 1 del I prot. add. della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, disponendo l’applicabilità ai
giudizi in corso delle regole di determinazione dell’indennità di espropriazione in
esso contenute, ed assicurando un trattamento indennitario lesivo del diritto di
proprietà, viola i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.”
Alle citate ordinanze di rimessione risponde la Corte costituzionale con
due distinte pronunce esaminate nei paragrafi che seguono.
1.1. Corte costituzionale, 24.10.2007, n. 348, boccia il criterio di computo dell’indennità d’esproprio
La sentenza della Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348, in dispensa 17), esamina la conformità del meccanismo previsto dall’art. 5 bis del d.l.
674
Lezione A17
11.7.1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella l. 8.8.1992, n. 359, con le
norme della CEDU attraverso i parametri costituzionali dell’art. 111 (principio del giusto processo) e 117 Cost. (principio del rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato). La Consulta dapprima reitera il proprio orientamento in ordine all’impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare la
norma interna contrastante con la CEDU, in quanto quest’ultime non si traducono in una limitazione della sovranità nazionale, ma in quanto norme internazionali pattizie vincolano lo Stato, senza essere in grado, come invece,
quelle comunitarie di produrre effetti diretti nell’ordinamento interno. In questo senso depone, da ultimo, la riscrittura dell’art. 117 Cost., che distingue infatti, in modo significativo, i vincoli derivanti dall’“ordinamento comunitario”
da quelli riconducibili agli “obblighi internazionali”. La differenza tra le due situazioni è a livello sistematico in quanto mentre con l’adesione ai Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più ampio, di natura
sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite
dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. La Convenzione CEDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati
contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale
– pur con le caratteristiche peculiari che saranno esaminate più avanti – da cui
derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne degli Stati membri.
Venendo alla questione centrale relativa al contrasto tra il citato art. 5 bis
e l’art. 1 del primo Protocollo della CEDU, in relazione al parametro dell’art.
117, comma 1, Cost., il giudice rimettente evidenzia come il mutamento rappresentato dalla l. Cost. 3/2001, imponga al Giudice delle leggi di rivedere la
propria posizione circa la conformità a Costituzione della norma scrutinata.
La Corte, premesso che le norme della CEDU si pongono quali norme interposte rispetto al precetto costituzionale che alle stesse rinvia, rammenta come
nelle precedenti decisioni con le quali ha verificato la legittimità a Costituzione dell’art. 5 bis, ha fissato alcuni principi guida in omaggio ai quali “l’indennizzo assicurato all’espropriato dall’art. 42, comma terzo, Cost., se non deve
costituire una integrale riparazione della perdita subita – in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l’interesse generale che l’espropriazione mira a
realizzare – non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente
simbolica ma deve rappresentare un serio ristoro. Perché ciò possa realizzarsi,
occorre far riferimento, per la determinazione dell’indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la
congruità del ristoro spettante all’espropriato ed evitare che esso sia meramente
apparente o irrisorio rispetto al valore del bene”. La Corte in questo modo indica come il criterio adeguato debba essere stabilito anche in ragione del con-
675
L’espropriazione e l’occupazione appropriativa
testo storico, istituzionale e giuridico esistente al momento del giudizio. Né
il criterio del valore venale (pur rimasto in vigore dal 1983 al 1992), né alcuno
dei criteri “mediati” prescelti dal legislatore possono avere i caratteri dell’assolutezza e della defi nitività. Si impongono pertanto due distinti approfondimenti: a) l’incidenza del mutato quadro normativo sulla compatibilità della
norma censurata con la tutela del diritto di proprietà; b) il legame tra la contingente situazione storica (economica e fi nanziaria) esistente al momento della
sentenza n. 283 del 1993 e l’esito del giudizio di legittimità costituzionale sulla stessa norma.
Quanto al primo step la Consulta prende atto che la Corte europea con
la decisione del 29 marzo 2006 ha fissato alcuni principi generali: a) un atto della autorità pubblica, che incide sul diritto di proprietà, deve realizzare
un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui (punto 93); b) nel controllare il rispetto di questo equilibrio, la Corte riconosce allo Stato “un ampio margine di apprezzamento”, tanto per scegliere le modalità di attuazione,
quanto per giudicare se le loro conseguenze trovano legittimazione, nell’interesse generale, dalla necessità di raggiungere l’obiettivo della legge che sta alla base dell’espropriazione (punto 94); c) l’indennizzo non è legittimo, se non
consiste in una somma che si ponga “in rapporto ragionevole con il valore del
bene”; se da una parte la mancanza totale di indennizzo è giustificabile solo
in circostanze eccezionali, dall’altra non è sempre garantita dalla CEDU una
riparazione integrale (punto 95); d) in caso di “espropriazione isolata”, pur se
a fi ni di pubblica utilità, solo una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene (punto 96); e) “obiettivi legittimi di utilità pubblica, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o
di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo” (punto 97). Rispetto ai criteri indicati dalla Corte europea per
commisurare l’indennità la Consulta individua solo un contrasto con il proprio orientamento espresso nella sentenza 283/1993, che avallava un criterio
di indennizzo prossimo al 50 per cento del valore venale del bene, con l’ulteriore possibile decurtazione del 40%. Si tratta di un contrasto solo apparente
secondo la Consulta perché va relativizzata rispetto al periodo temporale nel
quale la pronuncia veniva emessa, durante il quale il Paese attraversava una
grave congiuntura economica.
Posto che l’art. 5 bis è stato travasato nell’art. 37, d.P.R. n. 327/2001, e che
non si può ravvisare la stessa crisi economica congiunturale ecco allora che la
norma censurata – la quale prevede un’indennità oscillante, nella pratica, tra
il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene – non supera il controllo di costituzionalità in rapporto al “ragionevole legame” con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il “serio ristoro” richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa
Corte. La suddetta indennità è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che la pur ridotta somma spettante ai proprietari viene ulteriormente falci-
676
Lezione A17
diata dall’imposizione fiscale, la quale – come rileva il rimettente – si attesta su
valori di circa il 20 per cento. Il legittimo sacrificio che può essere imposto in
nome dell’interesse pubblico non può giungere sino alla pratica vanificazione dell’oggetto del diritto di proprietà.
Ciò non comporta un obbligo per il legislatore di corrispondere in ogni caso un’indennità di esproprio pari al valore venale del bene, potendo quest’ultimo prevedere un ammontare inferiore in ragione della qualità dei fi ni pubblici da realizzare.
1.2. I profili qualificanti della nuova disciplina dell’indennità di espropriazione
La nuova disciplina dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili contenuta nell’art. 2, commi 89 e 90, della legge fi nanziaria per il 2008 (l.
24.12.2007, n. 244) è stata emanata per colmare la lacuna aperta dalla Corte costituzionale (sentenza 348/2007, in dispensa 17), la quale, a sua volta, è
stata chiamata, nell’apparente disinteresse del legislatore e del Governo (che
pure aveva l’obbligo di intervenire tempestivamente ai sensi dell’art. unico l.
9.1.2006, n. 12, dopo la sentenza della Grande Chambre della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo – in seguito CEDU – nel noto caso “Scordino I”), a porre rimedio alla “violazione di sistema” dell’art. 1 del primo protocollo aggiunto della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo generata dall’art. 5 bis, l. 359/1992
e quindi dall’art. 37 del TU delle espropriazioni, che ha portato “a regime” il criterio di determinazione dell’indennizzo espropriativo fino ad allora operante
in via provvisoria, fi no ad una riforma organica dell’istituto.
I punti qualificanti della nuova disciplina dell’indennità per le aree edificabili sono così riassumibili:
– l’indennità è rapportata al valore venale, con riduzione del 25% “quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale”;
– è mantenuto il sistema premiale in caso di cessione volontaria, trasformando la non decurtazione del 40% prevista dall’art. 5 bis (e 37 TU) nella maggiorazione del 10%;
– si conferma che tale bonus è dovuto anche quando la cessione bonaria
non viene conclusa per insufficienza dell’offerta dell’espropriante (inferiore
agli 8/10 dell’indennità stimata congrua);
– applicabilità retroattiva “a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo
che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile”.
Le questioni che si pongono attengono essenzialmente:
a) alla coerenza complessiva del regime delle indennità espropriative, secondo le varie modalità di determinazione previste dal TU (si evidenzia, come si cercherà di dimostrare a seguire, un nuovo serio profi lo di incostituzionalità);
b) ai casi in cui è applicabile la reductio del 25%;
677
L’espropriazione e l’occupazione appropriativa
c) al regime delle cd. “indennità aggiuntive”;
d) all’ambito di incidenza oggettiva della disciplina e all’idoneità a superare il contenzioso pendente innanzi alla CEDU;
e) ai prevedibili effetti sull’erario.
Quanto al criterio da utilizzare per le controversie pendenti al tempo
dell’intervento della Corte costituzionale e prima dell’entrata in vigore della
disciplina contenuta nella fi nanziaria per il 2008, Cass., Sez. un., 14.1.2008, n.
599: “Con riguardo ai giudizi di determinazione dell’indennità di esproprio pendenti in cassazione alla data di pubblicazione della sentenza n. 348/2007 della
Corte Costituzionale, in attesa di una nuova normativa, trova applicazione il criterio del valore venale, non potendo comunque la misura dell’indennità superare
quella effettuata dal giudice del merito qualora la sentenza sia stata impugnata
dalla sola amministrazione espropriante.”
1.3. Corte costituzionale, 24.10.2007, n. 349, boccia il criterio di computo del risarcimento del danno da occupazione appropriativa
La sentenza della Corte costituzionale, 24.10.2007, n. 349, in dispensa 2, si
occupa di valutare la conformità a Costituzione del criterio di commisurazione del risarcimento del danno da occupazione appropriativa. La norma denunciata dal giudice rimettente violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in
quanto si porrebbe in contrasto con le norme internazionali convenzionali
e, anzitutto, con l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, nell’interpretazione offertane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Secondo le indicazioni della Corte europea è compito del legislatore trovare il giusto equilibrio
tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze imperative
di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. Ma nel caso di occupazione appropriativa la stessa Corte ha indicato come la previsione di un criterio
di commisurazione del risarcimento appena superiore a quello per l’indennità
d’esproprio si ponga in contrasto con la CEDU.
“La temporaneità del criterio di computo stabilito dalla norma censurata,
le congiunturali esigenze finanziarie che la sorreggono e l’astratta ammissibilità di una regola risarcitoria non ispirata al principio della integralità della riparazione del danno non costituiscono elementi sufficienti a far ritenere che, nel
quadro dei princìpi costituzionali, la disposizione censurata realizzi un ragionevole componimento degli interessi a confronto, tale da contrastare utilmente
la rilevanza della normativa CEDU. Questa è coerente con l’esigenza di garantire la legalità dell’azione amministrativa ed il principio di responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato. Per converso, alla luce delle conferenti norme costituzionali, principalmente dell’art. 42, non si può fare a meno di
concludere che il giusto equilibrio tra interesse pubblico ed interesse privato non
può ritenersi soddisfatto da una disciplina che permette alla pubblica amministrazione di acquisire un bene in difformità dallo schema legale e di conservare
l’opera pubblica realizzata, senza che almeno il danno cagionato, corrisponden-
678
Lezione A17
te al valore di mercato del bene, sia integralmente risarcito. In conclusione, l’art. 5
bis, comma 7 bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 359 del 1992, introdotto dall’art. 3, comma 65, della legge n. 662 del
1996, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al
valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali
sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l’art.
117, primo comma, della Costituzione.”
1.4. La nuova disciplina recata dall’art. 2, comma 89, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008)
La sentenza n. 349, in dispensa 2, diversamente dalla precedente sentenza
n. 348, in dispensa 17, non poneva problemi di disciplina transitoria.
La sentenza n. 349, in dispensa 2, ha infatti esaminato la compatibilità
dell’in sé dell’istituto, anche alla luce delle norme Convenzionali, ma solo la
congruità, ritenuta inadeguata, della disciplina di liquidazione del danno. La
risposta sul quid della disciplina applicabile scaturisce immediatamente dal
dispositivo della sentenza impugnata, che dichiarando illegittima la norma
derogatoria ai principi generali in materia di liquidazione del fatto illecito, ripristina automaticamente i principi generali della responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 ss., in particolare 2056 c.c.).
Nella motivazione della sentenza, poi, si trovano ampie considerazioni sulla necessità che il danno nell’occupazione appropriativa sia commisurato all’effettivo pregiudizio, cui conduce una valutazione di equo bilanciamento tra
l’ammissibilità di un modo di acquisto della proprietà per fatto illecito, e l’interesse del proprietario ad una rifusione superiore all’indennità in modo apprezzabilmente significativo: il che non può che coincidere, anche in base alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, con il valore venale.
Ne deriva quindi la non necessità della disciplina legislativa di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale che l’art. 2, comma 89, della legge
244/2007 (legge fi nanziaria per il 2008) ha invece dettato a tambur battente statuendo, alla lettera e, che nel corpo dell’articolo 55 del TU espr., il comma 1 è
sostituito dal seguente:
“Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità,
in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”.
La norma, oltre che inutile per le ragioni esposte, rischia di ingenenare
dubbi e perplessità che costringono a taluni sforzi ermeneutici.
Per un verso il riferimento ai suoli edificabili può porre il dubbio che il principio della risarcibilità integrale del danno concerna solo l’occupazione appropriativa maturata con riguardo a tale aree e non anche a quelle agricole,
edificate e, più in generale, non edificabili. Il dilemma è da risolvere in senso
679
L’espropriazione e l’occupazione appropriativa
estensivo, posto che la disciplina degli artt. 2043, 2056, 1223 c.c. sancisce, in assenza di deroghe che non sono più ravvisabili, il principio della riparazione integrale valevole per ogni illecito aquiliano quale è da reputarsi in via generale
la cd. accessione invertita. La disciplina dell’indennnità di esproprio e la normativa sul risarcimento del danno da occupazione appropriativa, però, (nuovo
testo degli artt. 37, comma 1 e 55 del TU espr.) prevedono entrambe un ristoro
pari al valore venale del bene così equiparando le conseguenze di un provvedimento legittimo e di una condotta illecita e, per l’effetto, facendo venire meno
ogni deterrenza verso un fenomeno patologico destinato a permanere anche in
futuro in quanto sostanzialmente preservato dall’art. 43 TU espr. pur se sotto
l’ombrello del provvedimento formale di esproprio in sanatoria.
Il problema è accentuato dalla considerazione che lo stesso art. 2, comma
89, nel riscrivere il comma 2 dell’art. 37 cit., stabilisce che “nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto
non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10 per cento”. Ne consegue
che, in caso di cessione volontaria convenuta (o impossibilitata dalla non congrua offerta dell’amministrazione), spetterà al privato una somma superiore al
valore venale del bene. Si dà la stura, in tal guisa, ad un’asimmetria alla rovescia, e cioè ad un trattamento più favorevole alla vittima del comportamento
legittimo della P.A. concretatosi nella cessione volontaria, che otterrà il valore
venale incrementato del 10%, rispetto alla vittima dell’occupazione illecita che
dovrà accontentarsi del solo valore venale del bene. È quasi intuitivo l’effetto
deterrente alla rovescia che una simile stortura normativa produrrà rispetto al
fenomeno dell’occupazione sine titulo.
Non poche perplessità provoca anche il richiamo al valore venale del bene come parametro per la commisurazione del danno. Mentre infatti detto richiamo appare pertinente con riguardo all’indennizzo da provvedimento di
esproprio, ove si ristora il pregiudizio per la perdita della proprietà cagionato
da un atto, non altrettanto può dirsi per il pregiudizio cagionato da un comportamento fattuale illecito per il quale vale il principio generale, ex art. 1223 c.c.,
dell’integrale risarcimento dei danni cagionati non da un atto in sé preso ma
da una condotta che si protrae nel tempo.
Se si esamina allora il pregiudizio complessivamente cagionato dal comportamento occupativo sfociato nell’occupazione appropriativa è evidente allora in primo luogo che il valore venale del bene copre solo il pregiudizio dominicale per la perdita della proprietà non già il vulnus inferto per via della
privazione illecita del possesso per il torno di tempo antecedente alla maturazione dell’accessione invertita. Tale pregiudizio andrà allora risarcito a parte.
Si deve quindi interpretare l’art. 2, comma 89, lett. e, nel senso che pone riparo solo al pregiudzio da perdita della proprietà e non anche al danno possessorio anteriore.
Si deve poi osservare che anche il danno da perdita della proprietà non è
uguale per tutti al valore venale del bene. Posto infatti che, come insegnato
680
Lezione A17
dalla teoria differenziale dello Jhering, il danno non è subito dalla res (come
nella teoria cd. reale) ma dal soggetto danneggiato, è ben possibile che il proprietario spogliato dimostri, grazie alle note interferenzialità e propagazioni
positive tra i vari elementi del patrimonio, che il valore soggettivo del suo bene
è superiore al valore del bene e che, quindi, in relazione alle sue specifiche possibilità di realizzo ed utilizzo, il pregiudizio valichi il tetto del valore di mercato del bene. Non è un caso che in modo più prudente l’art. 43 del TU espr., con
riguardo alla cd. espropriazione in sanatoria, consapevole che un danno da
comportamento non è mai rigidamente conchiudibile in una formula normativa astratta ed atomistica legata al valore del bene in sé, preveda in modo più
generico il risarcimento dei danni. A tale incongruenza si può ovviare in via interpretativa, con il ritenere che il nuovo testo dell’art. 55 del TU espr. sancisca,
coerentemente con la ratio del rinvio al parametro del valore venale del bene
da parte della Corte Europea e della Corte Costituzionale, la base minima legalmente garantita, salva la prova dei maggiori danni. Se la lettera della norma fosse invece reputata insuperabile, si dovrebbe battere la via della riforma
di legge o della censura di incostituzionalità avverso un criterio di quantificazione irragionevolmente astratto e restrittivo.
Viene poi da chiedersi se ai danni economici ai quali allude il nuovo art. 55
del TU espr. siano cumulabili quelli non patrimoniali ex art. 2059 c.c., ove sia
ravvisabile l’estremo dell’incisione del valore fondamentale della persona nella lettura ormai patrocinata, in tema di danni non patrimoniali, dalla Cassazione a far tempo dal 2003.
Più in radice si deve attendere che la Corte Europea, e quella Costituzionale
di rimando, siano chiamati a fronteggiare il problema dell’an, ossia della compatibilità in sé, con la Convenzione Europea, dell’occupazione appropriativa
e dell’espropriazione in sanatoria ex art 43, tu espr., istituti entrambi che (pur
se nel secondo caso con la copertura formale di un provvedimento sanante) si
concretano in un’acquisizione della proprietà da parte della P.A. in conseguenza di un fatto illecito.
2. La natura giuridica della cessione volontaria del bene espropriando
La natura giuridica della cessione volontaria è da sempre stata oggetto di
discussione esistendo due contrapposte posizioni: quella di chi la qualifica alla stregua di una compravendita rispetto alla quale l’esistenza di un procedimento amministrativo viene confi nata nell’area dei motivi, in quanto tali irrilevante. Con ciò che ne consegue in termini di disciplina, perché alla cessione
sarebbero applicabili istituti tipicamente privatistici quali la rescissione, la risoluzione, la nullità, l’annullamento. Una tesi di segno opposto, invece, configura la cessione come un contratto di diritto pubblico ovvero un accordo che
si pone quale alternativa consensuale all’utilizzo di un potere unilaterale della
P.A. La platea dei sostenitori di quest’ultima tesi è arricchita dalla recente sentenza della Cassazione del 27.6.2006, n. 5390, che indica alcuni criteri distin-
681
L’espropriazione e l’occupazione appropriativa
tivi per sceverare l’ipotesi in cui si sia di fronte ad una compravendita da quella in cui ci si trovo di fronte ad una cessione volontaria: “La cessione volontaria
costituisce un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell’ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata, ma non esclude
che un bene immobile possa essere trasferito all’ente pubblico a mezzo di un contratto di compravendita, del tutto assoggettato alla disciplina privatistica, sicché,
onde distinguere se in pratica ci si sia avvalsi dell’uno o dell’altro strumento contrattuale, anche ai fini dell’applicabilità di istituti connessi alla procedura pubblicistica dell’espropriazione, quali la determinazione dell’indennizzo secondo i
canoni legali, e la retrocessione del bene ove l’opera pubblica non sia stata realizzata, va tenuto conto che la pendenza del procedimento espropriativo può dirsi
esistente non per il semplice fatto della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera realizzanda, occorrendo anche che sia stato avviato il sub-procedimento di determinazione indennitaria, e sia stata formulata l’offerta amministrativa dell’indennità, solo in presenza della quale il proprietario può valutare la convenienza
della cessione.”
2.1. Occupazione acquisitiva ed usurpativa: la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella riunione n. 987 del 14.2.2007. La Risoluzione del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella riunione n. 987 del 14.2.2007
A partire da due note pronunce del 2000 (Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia, e Carbonara e Ventura c. Italia) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ripetutamente bacchettato lo Stato italiano, rilevando la contrarietà dell’occupazione illegittima nelle due forme sopra esaminate rispetto all’art. 1 del primo
Protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il punto
di contrasto individuato dalla Corte europea concerne nelle prime sentenze la
mancanza di un fondamento normativo dell’istituto: si contesta che il privato
possa perdere la proprietà del bene in virtù di un comportamento dell’amministrazione che non segua un procedimento definito in anticipo da una norma.
L’elevato numero di condanne subite dallo Stato italiano spinge il legislatore
ad introdurre il meccanismo dell’art. 43, d.P.R. 327/2001 (sul quale vedi infra
par. 2.4), per fornire un fondamento normativo, in armonia con le richieste della Corte europea. Sennonché la critica della Corte europea nelle sentenze più
recenti si radicalizza, ponendo in discussione lo stesso art. 43, nella misura in
cui ritiene incompatibile con il rispetto del citato art. 1, che la deprivation of
possession possa essere il frutto di un atto illecito, che oltre a dare atto di una
carenza di moralità della P.A., risulta sprovvisto di una chiara definizione normativa e soggetto ad oscillazioni giurisprudenziali, che aggravano la lesione
dell’interessato. L’elevato numero di condanne subite dall’Italia, con le quali la
Corte ribadisce: “che la privazione di un terreno in forza del meccanismo dell’occupazione acquisitiva viola in quanto tale il diritto dell’espropriato al rispetto
dei propri beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1.” (Corte euro-
682
Lezione A17
pea dei diritti dell’uomo, 21.9.2006; 5.10.2006; 2.11.2006; 16.11.2006; 14.12.2006),
inoltre afferma che: “Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce che la privazione di un terreno in forza del meccanismo dell’occupazione acquisitiva viola in
quanto tale il diritto dell’espropriato al rispetto dei propri beni, di cui all’articolo
1 del Protocollo addizionale n. 1. A tal proposito, si precisa come la dichiarazione da parte delle giurisdizioni interne dell’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la perdita del terreno, non pregiudichi in quanto tale
la possibilità per la CEDU di accertare detta violazione.” (Corte europea dei diritti dell’uomo, 21.9.2006), sino a giungere a condannare l’Italia sia nella veste
di amministrazione per l’occupazione appropriativa che nella veste di giurisdizione per l’eccessiva durata del processo: “Con la presente sentenza, la CEDU ribadisce che la privazione di un terreno in forza del meccanismo dell’occupazione acquisitiva viola in quanto tale il diritto dell’espropriato al rispetto dei
propri beni, di cui all’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1. Inoltre, nel ricorso in esame la Corte riscontra altresì una violazione del diritto ad una durata ragionevole del processo innanzi le giurisdizioni nazionali.”, fa sorgere un caso in
seno al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che spinge lo stesso organo ad adottare in data 14 febbraio 2007 una risoluzione interinale sul tema
della cd. espropriazione indiretta. Il punto centrale della risoluzione verte attorno all’idea che l’espropriazione indiretta rappresenta in Italia una violazione strutturale o di sistema, alla stessa stregua di quella sull’eccessiva durata dei processi, che necessita di un meccanismo riparatorio interno, atteso che
il numero elevato di procedure pendenti dinanzi alla Corte europea ha trasformato quest’ultima in un quarto grado di giudizio. L’invito forte contenuto nella
citata risoluzione è nel senso che l’Italia dovrebbe assicurare la restituito in integrum del bene illegittimamente occupato a favore del proprietario con il definitivo ripudio delle coordinate tracciate dalle Sezioni unite nella sentenza n.
1463/1983 e l’abbandono di ogni questione inerente la prescrizione quinquennale; fatta salva la possibilità del privato di abdicare al diritto di proprietà per
ottenere il risarcimento.
2.2. La Corte europea dei diritti dell’uomo 6 marzo 2007 e 31 maggio 2007
Il giudice di Strasburgo con la sentenza del 6 marzo 2007 (cd. Scordino
3) pone l’accento su tre tematiche, chiarendo ulteriormente il contrasto tra lo
Stato italiano e la convenzione. In particolare, evidenzia: 1) la natura strutturale della violazione riferibile all’Italia; 2) la necessità che l’Italia individui
strumenti di carattere generale ed individuale per elidere gli effetti della violazione; 3) le conseguenze patrimoniali della reiterata violazione del diritto
di proprietà e del pregiudizio derivante dall’assenza di strumenti giurisdizionali efficaci nell’ordinamento nazionale. Quanto al primo aspetto la Corte individua nell’espropriazione indiretta una forma di violazione strutturale
della Convenzione da parte dell’Italia che rischia, per il carattere seriale delle
controversie che origina, di mettere a repentaglio il funzionamento della stes-
683
L’espropriazione e l’occupazione appropriativa
sa Corte. In ragione di ciò il giudice di Strasburgo sollecita l’adozione da parte dell’Italia di misure fi nanziarie e organizzative in grado di contrastare il fenomeno. Tra queste il non disporre l’occupazione del bene tutte le volte in cui
non c’è certezza che saranno rispettate le regole del procedimento espropriativo o non siano state previste misure finanziarie adeguate per assicurare idonee e tempestivi indennizzi a favore dei proprietari. La Corte, inoltre caldeggia
l’inasprimento di misure sanzionatorie a carico degli amministratori che concorrono a causare il fenomeno.
Sotto il secondo profi lo, la Corte rilancia il ruolo della restituito in integrum, quale strada maestra della tutela del proprietario, che può essere surrogata dal risarcimento per equivalente del valore venale del bene solo nel caso di
accertamento in concreto di un ostacolo che renda impossibile la restituzione.
L’ultimo punto esaminato dai giudici di Strasburgo attiene la quantificazione del danno, rispetto alla quale il giudice di Strasburgo muove dall’idea
che l’espropriazione indiretta realizzi la violazione di un diritto umano. Il carattere intrinsecamente illecito della condotta della P.A. si ripercuote sui criteri di determinazione del danno, sicché al proprietario deve essere accordato
un ristoro patrimoniale, che non può prescindere dal valore aggiunto acquisito dal fondo per effetto della realizzazione del manufatto al di sopra di esso da
parte dell’occupante abusivo. Sicché nella fattispecie la Corte ha accordato al
proprietario un indennizzo pari al valore del suolo decurtato delle somme ottenute sulla base della liquidazione effettuata dal giudice italiano, aumentato per la rivalutazione, in più è stato conteggiato il plusvalore apportato dalla
costruzione dell’edificio. Elemento quest’ultimo che ha fatto schizzare in alto
l’ammontare dell’indennizzo.
La sentenza del 31 maggio 2007, si segnala, invece, per l’avallo che la Corte
rende ad un possibile strumento risolutivo delle controversie in questione, per
altro dalla stessa Corte caldeggiato. Infatti, il giudice di Strasburgo nella fattispecie radia il ricorso dal ruolo prendendo atto del regolamento amichevole
concluso tra le parti successivamente alla sentenza in cui si è constatata l’avvenuta violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1, così riconoscendo che la quantificazione del danno ben può essere rimesso all’accordo delle parti attraverso uno strumento deflativo del contenzioso dinanzi alla Corte.
2.3. Cons. St., Sez. IV, 21.5.2007, n. 2582, segue la strada tracciata dalla Corte
europea
Con la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 21.5.2007, n. 2582, i giudici di Palazzo Spada, inoltre, rimettono in discussione il consolidato principio
secondo cui anche in assenza di un atto di natura ablatoria l’Amministrazione
acquista a titolo originario la proprietà dell’area altrui, quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un’opera pubblica, in attuazione della dichiarazione della pubblica utilità; quest’impostazione viene considerata non più condivisibile per due ragioni:
684
Lezione A17
– non è conforme ai principi della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in particolare con l’art. 1 del
protocollo n. 1, secondo cui “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto
dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di
utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del
diritto internazionale”, rispetto al quale la Corte europea dei diritti dell’uomo
ha più volte dichiarato la non conformità del quadro ordinamentale italiano
con riferimento in particolare all’occupazione acquisitiva: ex multis Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia e Carbonara e Ventura c. Italia, 30.5.2000; Scordino c. Italia, 27.3.2003, 15.7.2004, 29.7.2004; 17.5.2005; Sciarrotta e altri c. Italia,
12.1.2006; De Sciscio c. Italia, 20.4.2006; Gianni e altri c. Italia, 30.3.2006; Giannazza c. Italia, 5.10.2006);
– l’ordinamento prevede un unico rimedio per evitare la restituzione
dell’area, che è quello disciplinato dall’art. 43 d.P.R. 327/01 – TU espropriazioni –,
consistente nell’adozione, previa valutazione degli interessi in conflitto, dell’atto
di acquisizione (cd. acquisizione sanante) al patrimonio indisponibile della P.A.
dell’immobile che sia stato modificato per scopi di interesse pubblico (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento dei danni): in assenza
di ciò l’amministrazione procedente non può addurre l’intervenuta realizzazione dell’opera quale causa di impossibilità oggettiva e, quindi, quale impedimento alla restituzione, perdurando il diritto di proprietà in capo al privato e sussistendo un illecito permanente dell’amministrazione che utilizza il fondo altrui e
che, dunque, ha l’obbligo di restituirlo e di risarcire il danno cagionato.
In pratica, “a parte l’applicabilità della disciplina civile sull’usucapione (per
la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all’Amministrazione il diritto di
proprietà pur in assenza dell’atto di natura ablatoria), l’art. 43 testualmente preclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge. L’Amministrazione può divenire proprietaria:
– o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico (con il
decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando);
– oppure, quando vi è una patologia e il bene è stato “modificato in assenza
del valido ed efficace provvedimento”, quando è emesso il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 43”.
Per la formulazione di medesime considerazioni si veda anche, recentemente, TAR Veneto, Sez. I, 14.5.2007, Sez. I, n. 1462.
Corollario esplicitato dal Consiglio di Stato è che il termine quinquennale
condizionante la pretesa risarcitoria non decorre dalla trasformazione irreversibile dell’area o dalla realizzazione dell’opera.
2.4. La disciplina dell’acquisizione sanante ex art. 43, d.P.R. n. 327/2001
La stessa disciplina dell’acquisizione sanante e quella contenuta nell’art.
1, comma 1216 ss., l. n. 296/2006, sul diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni responsabili di violazioni della convenzione europea
685
L’espropriazione e l’occupazione appropriativa
dei diritti dell’uomo, introdotta dal legislatore per fronteggiare le critiche piovute da Strasburgo pare non raggiungere un livello consono al parametro di
tutela richiesto dalla Corte europea. I punti di contrasto tra il meccanismo disciplinato dall’art. 43 e la posizione della Corte sono due: il primo di carattere
strutturale; il secondo di carattere funzionale.
Quanto al primo la Corte con sentenza 17 maggio 2005 e 15 novembre 2005
ha ritenuto che la norma in questione non ha un sostrato legittimo in quanto
sorge sulle ceneri di un comportamento illecito della P.A., quindi viola la Convenzione nella misura in cui non istituisce un procedimento legittimo e chiaro
attraverso il quale il proprietario può essere privato del suo diritto, ma si limita
a sanare un comportamento illecito serbato dalla P.A.
Quanto al secondo profi lo, la Corte con la sentenza 6 marzo 2007 pone uno
standard di ristoro monetario che tiene conto anche del plusvalore derivante
dal costo della costruzione sul suolo occupato, che non trova riscontro nel parametro utilizzato dall’art. 43.
Sulla natura giuridica dell’art. 43, poi va segnalata la sentenza del Consiglio
di Stato, Sez. IV, 16.11.2007, n. 5830, secondo la quale: “L’art. 43 d.P.R. n. 327/2001
presuppone, per la sua applicazione, la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e di un illecito permanente dell’Amministrazione che si è a suo tempo impossessata del fondo altrui senza concludere tempestivamente il procedimento
di esproprio, anche se è stata realizzata l’opera pubblica o di interesse pubblico.
Con tale norma il legislatore delegato ha consapevolmente introdotto nel sistema
“norme di chiusura”, non solo per attribuire all’Amministrazione il potere di dare
‘a regime’ una soluzione al caso concreto quando gli atti del procedimento divengano inefficaci per decorso del tempo o siano annullati dal giudice amministrativo, ma anche per rimuovere il precedente contrasto sussistente tra la prassi interna (amministrativa e giudiziaria) e la Convenzione Europea, così attribuendo
all’Amministrazione una “legale via d’uscita” per gli illeciti già verificatisi. Il testo
e la ratio dell’art. 43, dunque, non consentono di ritenere sussistente un termine
quinquennale, decorrente dalla trasformazione irreversibile dell’area o dalla realizzazione dell’opera, decorso il quale si verificherebbe la prescrizione della pretesa risarcitoria. Al contrario, l’art. 43 ribadisce il principio per il quale, nel caso di
mancata conclusione del procedimento espropriativo e quando vi è una occupazione sine titulo (imputabile all’Amministrazione che abbia occupato l’area, anche se poi questa è stata concessa ad altri), vi è un illecito e l’autore ha l’obbligo di
disporre la restituzione del suolo e di risarcire il danno cagionato medio tempore, salvi i rapporti interni tra l’autore dell’illecito e i suoi beneficiari e salvo il potere ex art. 43 di fare venire meno l’obbligo di restituzione ab extra, con l’atto di
acquisizione del bene.”
In ogni caso il rimedio dell’art. 43 potrà essere utilizzato dall’amministrazione solo per acquisire la titolarità dell’area, sempre che non gli sia stata, ad
esempio, riconosciuta con sentenza passata in giudicato, atteso che la norma
in questione rappresenta un istituto utilizzato per adeguarsi alle indicazioni
provenienti dalla CEDU, ma non ha forza tale da incidere sul principio dell’irretrattabilità del giudicato (Cons. St., Sez. IV, 4.2.2008 n. 303, in dispensa 17).
686
Lezione A17
3. L’incidenza dei vincoli conformativi e dei vincoli espropriativi sul diritto
di proprietà
È noto che l’attività di pianificazione, per il perseguimento del fi ne cui è
preordinata – l’ordinato e razionale assetto del territorio – possa incidere su diritti assoluti, come quello di proprietà, costituzionalmente tutelato dall’art. 42
Cost., fi no a svuotarlo di contenuto.
L’ampiezza di tale potestà può essere verificata esaminando la portata e le
differenze tra i vincoli cd. conformativi e quelli cd. espropriativi: mentre i primi, prescrivendo limiti volumetrici e caratteristiche costruttive in relazione alle diverse zone in cui viene suddiviso il territorio comunale (cd. zonizzazione), condizionano l’edificabilità; i vincoli localizzativi, in quanto preordinati
all’espropriazione delle aree per la realizzazione delle opere pubbliche oggetto
di localizzazione, comportano una totale inedificabilità. A questi ultimi sono
assimilati i vincoli che, pur non importando il trasferimento coattivo del bene,
incidono comunque sul godimento di esso tanto da rendere il bene inutilizzabile in rapporto alla sua naturale destinazione, ovvero determinando il venir
meno del suo valore di scambio.
A questa distinzione corrisponde quella tra zonizzazione e localizzazione:
la prima trova la sua codificazione nella previsione di cui al n. 2 dell’art. 7 della
legge urbanistica n. 1150/42 (“la divisione in zone del territorio, con precisazione
di quelle destinate all’espansione dell’aggregato urbano, ed i caratteri e vincoli di
zona da osservare nell’edificazione”), la seconda nelle previsioni di cui ai n. 3-4
del medesimo articolo (“le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servitù; le aree da riservare a sede della cassa comunale e della
casa del fascio, alla costruzione di scuole e di chiese e ad opere ed impianti d’interesse pubblico in generale”).
Come è stato recentemente affermato dalla Cassazione civile, Sez. I,
7.2.2006, n. 2612, “il carattere conformativo dei vincoli di piano non discende
dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi, in particolare configurandosi tale carattere ove tali vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di
una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con
un’opera pubblica; di contro, se il vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la
proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere qualificato come
preordinato alla relativa espropriazione”.
I vincoli conformativi rientrano nello schema della funzionalizzazione-limitazione dei beni di proprietà privata previsto dall’art. 42, comma 2, Cost. e,
come tali, non sono indennizzabili e sono a tempo indeterminato, non soggetti dunque al limite temporale di efficacia di cinque anni sancito dall’art. 2 della
687
L’espropriazione e l’occupazione appropriativa
legge 1187/68, valevole invece per i vincoli espropriativi, per i quali, proprio per
la loro natura, si pone come ineludibile l’alternativa tra termine di durata massima dell’efficacia del vincolo e previsione di indennizzo.
Sul punto rileva la sentenza della Corte costituzionale 20.5.1999, n. 179,
che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17.8.1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo
comma, della legge 19.11.1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150), nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo” (la Corte ha ribadito gli
stessi principi con le sentenze 18.4.2001, n. 411 e 9.5.2003, n. 148).
Secondo la Corte i vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione, se
superano la durata determinata dal legislatore (cinque anni), possono essere di per sé reiterati, in quanto il potere dell’amministrazione di pianificare il
territorio non può estinguersi per effetto della mera scadenza della durata dei
vincoli; tuttavia, la reiterazione di siffatti vincoli è ammissibile solo nel rispetto di due condizioni:
– la decisione di reiterare i vincoli scaduti deve essere congruamente motivata in relazione alle effettive esigenze urbanistiche;
– occorre prevedere un indennizzo.
Precisa la Corte che i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale e che devono essere indennizzati in caso di reiterazione sono:
– quelli preordinati all’espropriazione, ovvero che hanno carattere sostanzialmente espropriativo, nel senso di comportare come effetto pratico
uno svuotamento, di rilevante entità ed incisività, del contenuto della proprietà stessa, mediante imposizione, immediatamente operativa, di vincoli a titolo
particolare su beni determinati, comportanti inedificabilità assoluta, qualora
non siano stati discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale;
– quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non
si compia l’esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale
esproprio con l’approvazione dei piani urbanistici esecutivi;
– quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell’ambito dell’art. 42
Cost.
La Corte, dunque, evidenzia il carattere patologico di una indefi nita reiterazione dei vincoli espropriativi, in assenza di una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte
di piano, tanto più dettagliata e concreta quante più volte venga ripetuta la reiterazione del vincolo.
Ma anche nell’ipotesi di vincoli legittimamente reiterati, quindi, una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea (di franchigia da
ogni indennizzo) il permanere del vincolo non può essere dissociato, in alternativa all’espropriazione, dalla previsione di un indennizzo.
688
Lezione A17
La Corte, peraltro, ha cura di precisare che non sono inquadrabili negli
schemi dell’espropriazione, dei vincoli indennizzabili e dei termini di durata i vincoli:
– riguardanti i beni immobili aventi valore paesaggistico-ambientale,
nonché quelli sottoposti a regimi speciali, in virtù delle loro intrinseche caratteristiche (beni di interesse storico-artistico, beni sottoposti a vincolo idrogeologico, ecc.);
– quelli conformativi, che comportano dunque limiti edificatori, non ablatori, posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione e programmazione urbanistica e relative norme tecniche, quali i limiti di altezza, di
cubatura o di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto in relazione a talune opere pubbliche, i diversi indici generali di fabbricabilità ovvero i limiti e rapporti previsti per zone territoriali omogenee e simili;
– quelli che importano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non
comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene; ciò può essere il risultato di una scelta di
politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di
dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come
tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata – pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad esempio, parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi
per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie, ecc.).
Sul tema cfr. TAR Lazio, Sez. II bis, 11.1.2008, n 151, in dispensa 17.
Quest’ultima categoria di vincoli esclusi dallo schema ablatorio-espropriativo è stata richiamata più volte dalla giurisprudenza, che vi ha ricondotto quei
vincoli che, ancorché reiterati, destinano aree a vocazione edificatoria realizzabile anche da privati, come, ad esempio, l’edilizia scolastica (TAR Emilia-Romagna, Bologna, 13.10.2003, n. 2022; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 3.7.2002,
n. 656), la realizzazione di impianti sportivi (TAR Lecce, Sez. I, 6.2.2007, n. 319;
TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 25.1.2005, n. 343), di un centro polifunzionale
per lo sviluppo sociale e culturale (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 20.6.2002,
n. 3628), di una struttura sanitaria-assistenziale (TAR Campania, Napoli, Sez.
IV, 18.3.2004, n. 3021).
Il Cons. St., Ad. plen., 24.5.2007, n. 7, ha fornito le seguenti precisazioni:
– in sede di pianificazione, l’esercizio del potere di reiterazione di un vincolo a contenuto espropriativo, può ritenersi legittimamente esercitato soltanto nel caso in cui la P.A. abbia preventivamente svolto una idonea istruttoria ed abbia adeguatamente motivato la propria scelta, in misura idonea ad
escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti e/o
provvedimenti, dimostrando di perseguire, effettivamente ed esclusivamente, un pubblico interesse;
– l’adeguatezza della motivazione della reiterazione di un vincolo a contenuto espropriativo va valutata tenendo conto, tra le altre, delle seguenti circo-
689
L’espropriazione e l’occupazione appropriativa
stanze: a) se la reiterazione riguardi o meno una pluralità di aree, nell’ambito
della adozione di una variante generale o comunque riguardante una consistente parte del territorio comunale; b) se la reiterazione riguardi soltanto una parte delle aree già incise dai vincoli decaduti, mentre per l’altra parte non è disposta la reiterazione, perché ulteriori terreni sono individuati per
il rispetto degli standard; c) se la reiterazione sia stata disposta per la prima
volta sull’area in questione;
– con riferimento alla circostanza sub a), occorre distinguere l’ipotesi in cui
la reiterazione del vincolo riguardi un’area ben specificata (per realizzare una
singola opera pubblica o per soddisfare i prescritti standard sui servizi pubblici o sul verde pubblico), da quella in cui la reiterazione riguardi una pluralità
di aree per una consistente parte del territorio comunale, a seguito della decadenza di uno strumento urbanistico generale che abbia disposto una molteplicità di vincoli preordinati all’esproprio. Infatti, quando sono reiterati “in blocco” i vincoli decaduti già riguardanti una pluralità di aree, la sussistenza di un
attuale specifico interesse pubblico risulta dalla perdurante constatata insufficienza delle aree destinate a standard (indispensabili per la vivibilità degli abitati), mentre l’assenza di un intento vessatorio si evince dalla parità di trattamento che hanno tutti i destinatari dei precedenti vincoli decaduti;
– con riferimento alla circostanza sub b), costituisce illegittimo esercizio
del potere della P.A. l’ipotesi in cui, a seguito della decadenza “in blocco” dei
vincoli complessivamente previsti dallo strumento urbanistico generale, l’Autorità ne reiteri solo alcuni, individuando altre aree per soddisfare gli standard,
in assenza di una adeguata istruttoria o motivazione. Tali scelte, infatti, devono fondarsi su una motivazione da cui emergano le relative ragioni di interesse
pubblico, poiché avvantaggiano chi non è più coinvolto nelle determinazioni
di reperimento degli standard, a scapito di chi lo diventa, pur non essendo stato destinatario di un precedente vincolo preordinato all’esproprio;
– con riferimento alla circostanza sub c), può ritenersi giustificato il richiamo alle originarie valutazioni, quando vi è una prima reiterazione, ma – quando il rinnovato vincolo sia a sua volta decaduto – l’autorità urbanistica deve
procedere con una ponderata valutazione degli interessi coinvolti, esponendo
le ragioni, riguardanti il rispetto degli standard, le esigenze della spesa, specifici accadimenti riguardanti le precedenti fasi procedimentali, che inducano
ad escludere profi li di eccesso di potere e ad ammettere l’attuale sussistenza
dell’interesse pubblico;
– gli atti dei procedimenti di adozione e di approvazione di uno strumento urbanistico generale, comportanti la reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, non devono necessariamente prevedere, a pena di illegittimità, la spettanza di un indennizzo in favore del proprietario delle aree
interessate dallo stesso vincolo. In sede di adozione di una variante allo strumento urbanistico l’amministrazione, infatti, non può impegnare somme di
cui non è certa la spettanza in ordine all’an e al quantum, sia perché potrebbe non seguire l’approvazione regionale, sia perché la quantificazione richiede
complessi accertamenti su elementi di fatto che solo il proprietario può rappre-
690
Lezione A17
sentare al termine del procedimento di pianificazione. I profi li attinenti al pagamento dell’indennizzo non rilevano, dunque, per la verifica della legittimità del procedimento, ma attengono a questioni di carattere patrimoniale (che
presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione), devolute
peraltro alla cognizione della giurisdizione civile.
La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha ripetutamente chiarito che
in capo al proprietario inciso dalla reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo non è ravvisabile alcun affidamento speciale, considerato che l’area era già soggetta a vincolo, con la conseguenza che non è comunque configurabile una aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria
in relazione ad una precedente determinazione dell’Amministrazione, ma solo un’aspettativa generica ad una reformatio in melius analoga a quella di ogni
altro proprietario che aspira ad una utilizzazione più proficua dell’immobile (cfr., Cons. St., Sez. IV, 10.12.2003 n. 8146; Ad. plen., 22.12.1999 n. 24). Il che
esclude un obbligo speciale di motivazione, essendo sufficiente, per la prova
della persistenza ed attualità delle esigenze urbanistiche sottese alla reiterazione del vincolo, la motivazione generale enucleabile dai principi guida dello
strumento urbanistico generale (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 25.7.2001 n.
4077; 20.3.2001 n. 1679).
L’Adunanza plenaria richiama, a sostegno delle proprie tesi, il dato normativo di riferimento, attualmente rappresentato dal d.P.R. 8.6.2001, n. 381 – TU
espropriazioni – dal quale si ricava che:
– la reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, finalizzato ad uno
specifico intervento, debba essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, con connesso onere di una motivazione specifica, perché si va ad incidere su una posizione determinata (art. 11);
– quando invece si tratti di una qualsiasi altra reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, anche se disposti “in blocco” o per una consistente parte del territorio comunale, pur se non è richiesto l’avviso di avvio del procedimento (per il richiamo operato dall’art. 9, comma 6, alle disposizioni sulla
adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici), rilevano i principi previsti dall’art. 9, comma 4, che attribuisce rilievo decisivo alle “esigenze di
soddisfacimento degli standard” (in connessione all’art. 9, TU edilizia, d.P.R. n.
380 del 2001);
– a seguito della reiterazione, il proprietario può attivare un procedimento
amministrativo nel corso del quale egli ha l’onere di provare “l’entità del danno
effettivamente prodotto”, quale presupposto processuale necessario per poter
agire giudizialmente (art.39).
691
Dispensa A17
L’espropriazione e l’occupazione appropriativa
INDICE
1. La Corte costituzionale boccia il criterio di computo dell’indennità di esproprio
a. Corte cost., 24.10.2007, n. 348
2. L’ambito di applicazione dell’art. 43, TU espropriazioni
a. Cons. St., Sez. IV, 4.2.2008, n. 303
3. La decadenza quinquennale dei vincoli urbanistici
a. TAR Lazio, Sez. II bis, 11.1.2008, n. 151
693
Dispensa A17
1. La Corte costituzionale boccia il criterio di computo dell’indennità di esproprio
a. Corte cost., 24.10.2007, n. 348
È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11.7.1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8.8.1992, n. 359.
Ai sensi dell’art. 27 della legge 11.3.1953, n. 87, è costituzionalmente illegittimo, in via
consequenziale, l’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8.6.2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
(Omissis)
1. – Con tre distinte ordinanze la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis del decreto-legge 11.7.1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della fi nanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge
8.8.1992, n. 359, per violazione dell’art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione,
in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), fi rmata a Roma il 4 novembre 1950, cui è stata data esecuzione con la legge 4.8.1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali fi rmata a Roma il 4 novembre
1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, fi rmato a Parigi il 20 marzo
1952), ed all’art. 1 del primo Protocollo della Convenzione stessa, fi rmato a Parigi il 20
marzo 1952, nonché dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai citati artt. 6 CEDU
e 1 del primo Protocollo.
La norma è oggetto di censura nella parte in cui, ai fi ni della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli edificabili, prevede il criterio di calcolo fondato sulla
media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l’applicazione ai giudizi in corso alla data dell’entrata in vigore della legge n. 359 del 1992.
2. – I giudizi, per l’identità dell’oggetto e dei parametri costituzionali evocati, possono essere riuniti e decisi con la medesima sentenza.
3. – Preliminarmente, occorre valutare la ricostruzione, prospettata dalla parte privata A.C., dei rapporti tra sistema CEDU, obblighi derivanti dalle asserite violazioni
strutturali accertate con sentenze defi nitive della Corte europea e giudici nazionali.
3.1. – Secondo la suddetta parte privata, il contrasto, ove accertato, tra norme interne e sistema CEDU dovrebbe essere risolto con la disapplicazione delle prime da parte del giudice comune. Viene richiamato, in proposito, il Protocollo n. 11 della Convenzione EDU, reso esecutivo in Italia con la legge 28.8.1997, n. 296 (Ratifica ed esecuzione
del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l’11 maggio 1994). L’art. 34 di tale Protocollo prevede la possibilità di ricorsi individuali diretti alla Corte europea da parte dei cittadini degli Stati
contraenti, mentre, con l’art. 46, gli stessi Stati si impegnano a conformarsi alle sentenze defi nitive della Corte nelle controversie delle quali sono parti.
Sono parimenti invocate la Risoluzione 1226 (2000) dell’Assemblea Parlamentare
del Consiglio d’Europa, con la quale le Alte Parti contraenti sono invitate ad adottare le
misure necessarie per dare esecuzione alle sentenze defi nitive della Corte di Strasburgo, la Risoluzione Res(2004)3 del 12 maggio 2004 del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa, relativa alle sentenze che accertano un problema strutturale sottostante alla
violazione, la Raccomandazione Rec(2004)5, di pari data, del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa, relativa alla verifica di conformità dei progetti di legge, delle leggi
694
Dispensa A17
vigenti e della prassi amministrativa agli standard stabiliti dalla Convenzione, nonché
la Raccomandazione Rec(2004)6, di pari data, con cui il Comitato dei Ministri ha ribadito che gli Stati contraenti, a seguito delle sentenze della Corte che individuano carenze
di carattere strutturale o generale dell’ordinamento normativo o delle prassi nazionali
applicative, sono tenuti a rivedere l’efficacia dei rimedi interni esistenti e, se necessario,
ad instaurare validi rimedi, al fi ne di evitare che la Corte venga adita per casi ripetitivi.
3.2. – La prospettata ricostruzione funge da premessa alla richiesta, avanzata dalla
predetta parte privata, che la questione sia dichiarata inammissibile, posto che i giudici
comuni avrebbero il dovere di disapplicare le norme interne che la Corte europea abbia
ritenuto essere causa di violazione strutturale della Convenzione.
3.3. – L’eccezione di inammissibilità non può essere accolta.
Questa Corte ha chiarito come le norme comunitarie “debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di ricezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della
Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione eguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari” (sentenze n. 183 del 1973 e
n. 170 del 1984). Il fondamento costituzionale di tale efficacia diretta è stato individuato
nell’art. 11 Cost., nella parte in cui consente le limitazioni della sovranità nazionale necessarie per promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.
Il riferito indirizzo giurisprudenziale non riguarda le norme CEDU, giacché questa
Corte aveva escluso, già prima di sancire la diretta applicabilità delle norme comunitarie nell’ordinamento interno, che potesse venire in considerazione, a proposito delle prime, l’art. 11 Cost. “non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale” (sentenza n. 188 del
1980). La distinzione tra le norme CEDU e le norme comunitarie deve essere ribadita
nel presente procedimento nei termini stabiliti dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte, nel senso che le prime, pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e
valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme
interne in eventuale contrasto.
L’art. 117, primo comma, Cost., nel testo introdotto nel 2001 con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha confermato il precitato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte. La disposizione costituzionale ora richiamata distingue infatti, in modo significativo, i vincoli derivanti dall’“ordinamento comunitario” da
quelli riconducibili agli “obblighi internazionali”.
Si tratta di una differenza non soltanto terminologica, ma anche sostanziale.
Con l’adesione ai Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e
non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale – pur con le caratteristiche peculiari che saranno esaminate più avanti – da cui derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più
vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio,
per tutte le autorità interne degli Stati membri.
695
Dispensa A17
Correttamente il giudice a quo ha escluso di poter risolvere il dedotto contrasto della norma censurata con una norma CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo,
procedendo egli stesso a disapplicare la norma interna asseritamente non compatibile
con la seconda. Le Risoluzioni e Raccomandazioni citate dalla parte interveniente si indirizzano agli Stati contraenti e non possono né vincolare questa Corte, né dare fondamento alla tesi della diretta applicabilità delle norme CEDU ai rapporti giuridici interni.
3.4. – Si condivide anche l’esclusione – argomentata nelle ordinanze di rimessione –
delle norme CEDU, in quanto norme pattizie, dall’ambito di operatività dell’art. 10, primo comma, Cost., in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte sul punto.
La citata disposizione costituzionale, con l’espressione “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l’adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell’ordinamento giuridico italiano. Le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali
o multilaterali, esulano pertanto dalla portata normativa del suddetto art. 10. Di questa categoria fa parte la CEDU, con la conseguente “impossibilità di assumere le relative
norme quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole (sentenza
n. 188 del 1980), ovvero come norme interposte ex art. 10 della Costituzione” (ordinanza
n. 143 del 1993; conformi, ex plurimis, sentenze n. 153 del 1987, n. 168 del 1994, n. 288 del
1997, n. 32 del 1999, ed ordinanza n. 464 del 2005).
4. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis del decreto-legge n. 333
del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., è fondata.
4.1. – La questione, così come proposta dal giudice rimettente, si incentra sul presunto contrasto tra la norma censurata e l’art. 1 del primo Protocollo della CEDU, quale
interpretato dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, in quanto i criteri di calcolo per
determinare l’indennizzo dovuto ai proprietari di aree edificabili espropriate per motivi
di pubblico interesse condurrebbero alla corresponsione di somme non congruamente
proporzionate al valore dei beni oggetto di ablazione.
Il parametro evocato negli atti introduttivi del presente giudizio è l’art. 117, primo
comma, Cost., nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Il giudice rimettente ricorda infatti che la stessa norma ora censurata è già stata oggetto di scrutinio di costituzionalità
da parte di questa Corte, che ha rigettato la questione di legittimità costituzionale, allora proposta in relazione agli artt. 3, 24, 42, 53, 71, 72, 113 e 117 Cost. (sentenza n. 283 del
1993). La sentenza citata è stata successivamente confermata da altre pronunce di questa Corte del medesimo tenore. Il rimettente non chiede oggi alla Corte costituzionale di
modificare la propria consolidata giurisprudenza nella materia de qua, ma mette in rilievo che il testo riformato dell’art. 117, primo comma, Cost., renderebbe necessaria una
nuova valutazione della norma censurata in relazione a questo parametro, non esistente
nel periodo in cui la pregressa giurisprudenza costituzionale si è formata.
4.2. – Impostata in tal modo la questione da parte del rimettente, è in primo luogo
necessario riconsiderare la posizione e il ruolo delle norme della CEDU, allo scopo di verificare, alla luce della nuova disposizione costituzionale, la loro incidenza sull’ordinamento giuridico italiano.
L’art. 117, primo comma, Cost. condiziona l’esercizio della potestà legislativa dello
Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente
rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo. Prima della sua introduzione, l’inserimento delle norme internazionali pattizie nel sistema delle
fonti del diritto italiano era tradizionalmente affidato, dalla dottrina prevalente e dalla stessa Corte costituzionale, alla legge di adattamento, avente normalmente rango di
696
Dispensa A17
legge ordinaria e quindi potenzialmente modificabile da altre leggi ordinarie successive. Da tale collocazione derivava, come naturale corollario, che le stesse norme non potevano essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 188 del 1980, n. 315 del 1990, n. 388 del 1999).
4.3. – Rimanevano notevoli margini di incertezza, dovuti alla difficile individuazione del rango delle norme CEDU, che da una parte si muovevano nell’ambito della tutela
dei diritti fondamentali delle persone, e quindi integravano l’attuazione di valori e principi fondamentali protetti dalla stessa Costituzione italiana, ma dall’altra mantenevano
la veste formale di semplici fonti di grado primario. Anche a voler escludere che il legislatore potesse modificarle o abrogarle a piacimento, in quanto fonti atipiche (secondo
quanto affermato nella sentenza n. 10 del 1993 di questa Corte, non seguita tuttavia da
altre pronunce dello stesso tenore), restava il problema degli effetti giuridici di una possibile disparità di contenuto tra le stesse ed una norma legislativa posteriore.
Tale situazione di incertezza ha spinto alcuni giudici comuni a disapplicare direttamente le norme legislative in contrasto con quelle CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo. S’è fatta strada in talune pronunce dei giudici di merito, ma anche in
parte della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, sentenza n. 6672 del 1998; Cass.,
sezioni unite, sentenza n. 28507 del 2005), l’idea che la specifica antinomia possa essere eliminata con i normali criteri di composizione in sistema delle fonti del diritto. In altre parole, si è creduto di poter trarre da un asserito carattere sovraordinato della fonte
CEDU la conseguenza che la norma interna successiva, modificativa o abrogativa di una
norma prodotta da tale fonte, fosse inefficace, per la maggior forza passiva della stessa
fonte CEDU, e che tale inefficacia potesse essere la base giustificativa della sua non applicazione da parte del giudice comune.
Oggi questa Corte è chiamata a fare chiarezza su tale problematica normativa e istituzionale, avente rilevanti risvolti pratici nella prassi quotidiana degli operatori del diritto. Oltre alle considerazioni che sono state svolte nel paragrafo 3.3 (per più ampi svolgimenti si rinvia alla sentenza n. 349 del 2007), si deve aggiungere che il nuovo testo
dell’art. 117, primo comma, Cost, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza
di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall’altra attrae le
stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale.
Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l’asserita incompatibilità tra le
due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi.
Ogni argomentazione atta ad introdurre nella pratica, anche in modo indiretto, una
sorta di “adattamento automatico”, sul modello dell’art. 10, primo comma, Cost., si pone comunque in contrasto con il sistema delineato dalla Costituzione italiana – di cui s’è
detto al paragrafo 3.4 – e più volte ribadito da questa Corte, secondo cui l’effetto previsto
nella citata norma costituzionale non riguarda le norme pattizie (ex plurimis, sentenze
n. 32 del 1960, n. 323 del 1989, n. 15 del 1996).
4.4. – Escluso che l’art. 117, primo comma, Cost., nel nuovo testo, possa essere ritenuto una mera riproduzione in altra forma di norme costituzionali preesistenti (in particolare gli artt. 10 e 11), si deve pure escludere che lo stesso sia da considerarsi operante
soltanto nell’ambito dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. L’utilizzazione del criterio interpretativo sistematico, isolato dagli altri e soprattutto in contrasto con lo stesso enunciato normativo, non è sufficiente a circoscrivere l’effetto condizionante degli obblighi
internazionali, rispetto alla legislazione statale, soltanto al sistema dei rapporti con la
697
Dispensa A17
potestà legislativa regionale. Il dovere di rispettare gli obblighi internazionali incide
globalmente e univocamente sul contenuto della legge statale; la validità di quest’ultima non può mutare a seconda che la si consideri ai fi ni della delimitazione delle sfere di
competenza legislativa di Stato e Regioni o che invece la si prenda in esame nella sua potenzialità normativa generale. La legge – e le norme in essa contenute – è sempre la stessa e deve ricevere un’interpretazione uniforme, nei limiti in cui gli strumenti istituzionali predisposti per l’applicazione del diritto consentono di raggiungere tale obiettivo.
Del resto, anche se si restringesse la portata normativa dell’art. 117, primo comma,
Cost. esclusivamente all’interno del sistema dei rapporti tra potestà legislativa statale e
regionale configurato dal titolo V della parte seconda della Costituzione, non si potrebbe
negare che esso vale comunque a vincolare la potestà legislativa dello Stato sia nelle materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo, di competenza esclusiva statale, sia in quelle indicate dal terzo comma, di competenza concorrente. Poiché, dopo la
riforma del titolo V, lo Stato possiede competenza legislativa esclusiva o concorrente soltanto nelle materie elencate dal secondo e dal terzo comma, rimanendo ricomprese tutte
le altre nella competenza residuale delle Regioni, l’operatività del primo comma dell’art.
117, anche se considerata solo all’interno del titolo V, si estenderebbe ad ogni tipo di potestà legislativa, statale o regionale che sia, indipendentemente dalla sua collocazione.
4.5. – La struttura della norma costituzionale, rispetto alla quale è stata sollevata la
presente questione, si presenta simile a quella di altre norme costituzionali, che sviluppano la loro concreta operatività solo se poste in stretto collegamento con altre norme,
di rango sub-costituzionale, destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad
enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere.
Le norme necessarie a tale scopo sono di rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria. A prescindere dall’utilizzazione, per indicare tale
tipo di norme, dell’espressione “fonti interposte”, ricorrente in dottrina ed in una nutrita
serie di pronunce di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 101 del 1989, n. 85 del 1990, n.
4 del 2000, n. 533 del 2002, n. 108 del 2005, n. 12 del 2006, n. 269 del 2007), ma di cui viene
talvolta contestata l’idoneità a designare una categoria unitaria, si deve riconoscere che
il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost. diventa concretamente operativo solo se vengono determinati quali siano gli “obblighi internazionali” che vincolano
la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Nel caso specifico sottoposto alla valutazione di questa Corte, il parametro viene integrato e reso operativo dalle norme della
CEDU, la cui funzione è quindi di concretizzare nella fattispecie la consistenza degli obblighi internazionali dello Stato.
4.6. – La CEDU presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica
peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell’uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa. Difatti l’art. 32, paragrafo 1, stabilisce: “La competenza della Corte si
estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47”.
Poiché le norme giuridiche vivono nell’interpretazione che ne danno gli operatori
del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall’art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con
la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione
alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita
per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato
italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno ri-
698
Dispensa A17
conosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia.
4.7. – Quanto detto sinora non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si
tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre
ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione.
La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle
concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali (ex plurimis, sentenze n. 183 del 1973, n.
170 del 1984, n. 168 del 1991, n. 73 del 2001, n. 454 del 2006) o dei principi supremi (ex plurimis, sentenze n. 30 e n. 31 del 1971, n. 12 e n. 195 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977,
n. 16 del 1978, n. 16 e n. 18 del 1982, n. 203 del 1989), ma debba estendersi ad ogni profi lo
di contrasto tra le “norme interposte” e quelle costituzionali.
L’esigenza che le norme che integrano il parametro di costituzionalità siano esse
stesse conformi alla Costituzione è assoluta e inderogabile, per evitare il paradosso che
una norma legislativa venga dichiarata incostituzionale in base ad un’altra norma subcostituzionale, a sua volta in contrasto con la Costituzione. In occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne, occorre verificare congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e precisamente
la compatibilità della norma interposta con la Costituzione e la legittimità della norma
censurata rispetto alla stessa norma interposta.
Nell’ipotesi di una norma interposta che risulti in contrasto con una norma costituzionale, questa Corte ha il dovere di dichiarare l’inidoneità della stessa ad integrare
il parametro, provvedendo, nei modi rituali, ad espungerla dall’ordinamento giuridico italiano.
Poiché, come chiarito sopra, le norme della CEDU vivono nell’interpretazione che
delle stesse viene data dalla Corte europea, la verifica di compatibilità costituzionale
deve riguardare la norma come prodotto dell’interpretazione, non la disposizione in sé
e per sé considerata. Si deve peraltro escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fi ni del controllo di costituzionalità delle
leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il
vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione.
In sintesi, la completa operatività delle norme interposte deve superare il vaglio della loro compatibilità con l’ordinamento costituzionale italiano, che non può essere modificato da fonti esterne, specie se queste non derivano da organizzazioni internazionali rispetto alle quali siano state accettate limitazioni di sovranità come quelle previste
dall’art. 11 della Costituzione.
5. – Alla luce dei principi metodologici illustrati sino a questo punto, lo scrutinio di
legittimità costituzionale chiesto dalla Corte rimettente deve essere condotto in modo
da verificare: a) se effettivamente vi sia contrasto non risolvibile in via interpretativa tra
la norma censurata e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea ed assunte come fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all’art. 117, primo
comma, Cost.; b) se le norme della CEDU invocate come integrazione del parametro,
nell’interpretazione ad esse data dalla medesima Corte, siano compatibili con l’ordinamento costituzionale italiano.
5.1. – L’art. 5 bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, prescrive, al primo comma, i criteri di calcolo dell’indennità di
699
Dispensa A17
espropriazione per pubblica utilità delle aree edificabili, che consistono nell’applicazione dell’art. 13, terzo comma, della legge 15.1.1885, n. 2892 (Risanamento della città di Napoli), “sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell’ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con d.P.R. 22.12.1986, n. 917”. L’importo così determinato è ridotto del 40 per
cento. Il secondo comma aggiunge che, in caso di cessione volontaria del bene da parte
dell’espropriato, non si applica la riduzione di cui sopra.
La norma censurata è stata oggetto di questione di legittimità costituzionale, defi nita con la sentenza n. 283 del 1993.
Nel dichiarare non fondata la questione, questa Corte ha richiamato la sua pregressa giurisprudenza, consolidatasi negli anni, sul concetto di “serio ristoro”, particolarmente illustrato nella sentenza n. 5 del 1980. Quest’ultima pronuncia ha stabilito che
“l’indennizzo assicurato all’espropriato dall’art. 42, comma terzo, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione della perdita subita – in quanto occorre coordinare il
diritto del privato con l’interesse generale che l’espropriazione mira a realizzare – non
può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica ma deve rappresentare un serio ristoro. Perché ciò possa realizzarsi, occorre far riferimento, per la
determinazione dell’indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche
essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge.
Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all’espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene”.
Il principio del serio ristoro è violato, secondo tale pronuncia, quando, “per la determinazione dell’indennità, non si considerino le caratteristiche del bene da espropriare
ma si adotti un diverso criterio che prescinda dal valore di esso”.
5.2. – L’effetto della sentenza da ultimo richiamata (e della successiva n. 223 del
1983) è stato quello di rendere nuovamente applicabile il criterio del valore venale, quale
previsto dall’art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) sino all’introduzione, nel 1992, della norma censurata.
A proposito di quest’ultima, la Corte, con la già ricordata sentenza n. 283 del 1993,
ha confermato il principio del serio ristoro, precisando che, da una parte, l’art. 42 Cost.
“non garantisce all’espropriato il diritto ad un’indennità esattamente commisurata al
valore venale del bene e, dall’altra, l’indennità stessa non può essere (in negativo) meramente simbolica od irrisoria, ma deve essere (in positivo) congrua, seria, adeguata”.
Posto che, in conformità all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, deve essere esclusa “una valutazione del tutto astratta in quanto sganciata dalle caratteristiche essenziali del bene ablato”, questa Corte ha ritenuto ammissibili criteri “mediati”,
lasciando alla discrezionalità del legislatore l’individuazione dei parametri concorrenti con quello del valore venale. La Corte stessa ha tenuto a precisare che la “mediazione tra l’interesse generale sotteso all’espropriazione e l’interesse privato, espresso dalla proprietà privata, non può fissarsi in un indefettibile e rigido criterio quantitativo,
ma risente sia del contesto complessivo in cui storicamente si colloca, sia dello specifico che connota il procedimento espropriativo, non essendo il legislatore vincolato ad
individuare un unico criterio di determinazione dell’indennità, valido in ogni fattispecie espropriativa”.
Come emerge chiaramente dalla citata pronuncia, questa Corte, accanto al criterio
del serio ristoro – che esclude la pura e semplice identificazione dell’indennità espropriativa con il valore venale del bene – ha pure riconosciuto la relatività sincronica e diacronica dei criteri di determinazione adottabili dal legislatore. In altri termini, l’adeguatezza dei criteri di calcolo deve essere valutata nel contesto storico, istituzionale e giuridico
esistente al momento del giudizio. Né il criterio del valore venale (pur rimasto in vigo-
700
Dispensa A17
re dal 1983 al 1992), né alcuno dei criteri “mediati” prescelti dal legislatore possono avere i caratteri dell’assolutezza e della defi nitività. La loro collocazione nel sistema e la loro compatibilità con i parametri costituzionali subiscono variazioni legate al decorso del
tempo o al mutamento del contesto istituzionale e normativo, che non possono restare
senza conseguenze nello scrutinio di costituzionalità della norma che li contiene.
La Corte ha concluso affermando: “anche un contesto complessivo che risulti caratterizzato da una sfavorevole congiuntura economica – che il legislatore mira a contrastare con un’ampia manovra economico-fi nanziaria – può conferire un diverso peso ai
confl iggenti interessi oggetto del bilanciamento legislativo. Questa essenziale relatività dei valori in giuoco impone una verifica settoriale e legata al contesto di riferimento
nel momento in cui si pone il raffronto tra il risultato del bilanciamento operato dal legislatore con la scelta di un determinato criterio “mediato” ed il canone di adeguatezza
dell’indennità ex art. 42, comma 3, della Costituzione”.
5.3. – La Corte rimettente ha posto in evidenza proprio la relatività delle valutazioni,
che richiede di verificare nel tempo e nello spazio normativo il punto di equilibrio tra i
contrastanti interessi costituzionalmente protetti. Si impongono pertanto due distinti
approfondimenti: a) l’incidenza del mutato quadro normativo sulla compatibilità della
norma censurata con la tutela del diritto di proprietà; b) il legame tra la contingente situazione storica (economica e fi nanziaria) esistente al momento della sentenza n. 283
del 1993 e l’esito del giudizio di legittimità costituzionale sulla stessa norma.
5.4. – Sul primo punto, si deve rilevare che l’art. 1 del primo Protocollo della CEDU
è stato oggetto di una progressiva focalizzazione interpretativa da parte della Corte di
Strasburgo, che ha attribuito alla disposizione un contenuto ed una portata ritenuti dalla stessa Corte incompatibili con la disciplina italiana dell’indennità di espropriazione.
In esito ad una lunga evoluzione giurisprudenziale, la Grande Chambre, con la decisione del 29 marzo 2006, nella causa Scordino contro Italia, ha fissato alcuni principi
generali: a) un atto della autorità pubblica, che incide sul diritto di proprietà, deve realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della
salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui (punto 93); b) nel controllare il rispetto di questo equilibrio, la Corte riconosce allo Stato “un ampio margine di apprezzamento”, tanto per scegliere le modalità di attuazione, quanto per giudicare se le loro
conseguenze trovano legittimazione, nell’interesse generale, dalla necessità di raggiungere l’obiettivo della legge che sta alla base dell’espropriazione (punto 94); c) l’indennizzo non è legittimo, se non consiste in una somma che si ponga “in rapporto ragionevole
con il valore del bene”; se da una parte la mancanza totale di indennizzo è giustificabile
solo in circostanze eccezionali, dall’altra non è sempre garantita dalla CEDU una riparazione integrale (punto 95); d) in caso di “espropriazione isolata”, pur se a fi ni di pubblica utilità, solo una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene (punto 96); e) “obiettivi legittimi di utilità pubblica, come quelli
perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un
indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo” (punto 97).
Poiché i criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione previsti dalla legge italiana porterebbero alla corresponsione, in tutti i casi, di una somma largamente inferiore
al valore di mercato (o venale), la Corte europea ha dichiarato che l’Italia ha il dovere di
porre fi ne ad una violazione sistematica e strutturale dell’art. 1 del primo Protocollo della CEDU, anche allo scopo di evitare ulteriori condanne dello Stato italiano in un numero rilevante di controversie seriali pendenti davanti alla Corte medesima.
5.5. – Per stabilire se e in quale misura la suddetta pronuncia della Corte europea incide nell’ordinamento giuridico italiano, occorre esaminare analiticamente il criterio di
calcolo dell’indennità di espropriazione previsto dalla norma censurata.
701
Dispensa A17
L’indennità dovuta al proprietario espropriato, secondo la citata norma, è pari alla
media del valore venale del bene e del reddito dominicale rivalutato riferito all’ultimo
decennio, con un’ulteriore sottrazione del 40 per cento dalla cifra così ottenuta.
Si deve, in primo luogo, osservare che è stato modificato l’originario criterio previsto
dalla legge n. 2892 del 1885, che, essendo mirata al risanamento di una grande città, prevedeva coerentemente il ricorso, ai fi ni della media, alla somma risultante dai “fitti coacervati” dell’ultimo decennio. C’era l’evidente e dichiarata finalità di indennizzare i proprietari di fabbricati ricadenti nell’area urbana, tenendo conto che gli stessi erano per lo
più degradati, ma densamente abitati da inquilini che pagavano alti canoni di locazione. Si intendeva, in tal modo, indennizzare i proprietari per il venir meno di un reddito
concreto costituito dai fitti che gli stessi percepivano. L’indennizzo così calcolato poteva
essere anche più alto del valore venale del bene in sé e per sé considerato.
La sostituzione dei fitti coacervati con il reddito dominicale ha spostato verso il
basso l’indennità rispetto a quella prevista dalla legge per il risanamento di Napoli, con
il risultato pratico che, nella generalità dei casi, la somma ottenuta in base alla media
prevista dalla legge è di circa il 50 per cento del valore venale del bene. A ciò si aggiunge l’ulteriore decurtazione del 40 per cento, evitabile solo con la cessione volontaria del
bene.
5.6. – Sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte
europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l’indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato. V’è pure
concordanza di principio – al di là delle diverse espressioni linguistiche impiegate – sulla non coincidenza necessaria tra valore di mercato e indennità espropriativa, alla luce del sacrificio che può essere imposto ai proprietari di aree edificabili in vista del raggiungimento di fi ni di pubblica utilità.
Rispetto alla pregressa giurisprudenza di questa Corte, si deve rilevare un apparente contrasto tra le sentenze di rigetto (principalmente la n. 283 del 1993) sulle questioni riguardanti la norma oggi nuovamente censurata e la netta presa di posizione della
Corte di Strasburgo circa l’incompatibilità dei criteri di computo previsti in tale norma
e l’art. 1 del primo Protocollo della CEDU.
In realtà, come rilevato, questa Corte – nel dichiarare non fondata la questione relativa all’art. 5 bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 359 del 1992 – ha posto in rilievo il carattere transitorio di tale disciplina, giustificata dalla grave congiuntura economica che il Paese stava attraversando ed ha precisato
– come s’è ricordato al paragrafo 5.2 – che la valutazione sull’adeguatezza dell’indennità deve essere condotta in termini relativi, avendo riguardo al quadro storico-economico ed al contesto istituzionale.
Sotto il primo profi lo, si deve notare che il criterio dichiaratamente provvisorio previsto dalla norma censurata è divenuto oggi defi nitivo, ad opera dell’art. 37 del d.P.R.
8.6.2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità) – non censurato ratione temporis dal giudice rimettente –, che contiene una norma identica, conformemente, del resto, alla sua natura di
atto normativo compilativo. È venuta meno, in tal modo, una delle condizioni che avevano indotto questa Corte a ritenere la norma censurata non incompatibile con la Costituzione. Né si può ritenere che una “sfavorevole congiuntura economica” possa andare
avanti all’infi nito, conferendo sine die alla legislazione una condizione di eccezionalità
che, se troppo prolungata nel tempo, perde tale natura ed entra in contraddizione con la
sua stessa premessa. Se problemi rilevanti di equilibrio della fi nanza pubblica permangono anche al giorno d’oggi – e non si prevede che potranno essere defi nitivamente risolti nel breve periodo – essi non hanno il carattere straordinario ed acuto della situazio-
702
Dispensa A17
ne dei conti pubblici verificatasi nel 1992, che indusse Parlamento e Governo ad adottare
misure di salvataggio drastiche e successivamente non replicate.
Un’indennità “congrua, seria ed adeguata” (come precisato dalla sentenza n. 283 del
1993) non può adottare il valore di mercato del bene come mero punto di partenza per
calcoli successivi che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato, concepiti
in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per attingere risultati marcatamente lontani da essa. Mentre il reddito dominicale mantiene un sia pur flebile legame con il valore di mercato (con il risultato pratico però di dimezzare, il più delle volte,
l’indennità), l’ulteriore detrazione del 40 per cento è priva di qualsiasi riferimento, non
puramente aritmetico, al valore del bene. D’altronde tale decurtazione viene esclusa in
caso di cessione volontaria e quindi risulta essere non un criterio, per quanto “mediato”,
di valutazione del bene, ma l’effetto di un comportamento dell’espropriato.
5.7. – Da quanto sinora detto si deve trarre la conclusione che la norma censurata –
la quale prevede un’indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene – non supera il controllo di costituzionalità in rapporto al “ragionevole legame” con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo e coerente, del resto, con il “serio ristoro” richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte. La suddetta indennità è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che
la pur ridotta somma spettante ai proprietari viene ulteriormente falcidiata dall’imposizione fiscale, la quale – come rileva il rimettente – si attesta su valori di circa il 20 per
cento. Il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell’interesse pubblico non
può giungere sino alla pratica vanificazione dell’oggetto del diritto di proprietà.
Non emergono, sulla base delle considerazioni fi n qui svolte, profi li di incompatibilità tra l’art. 1 del primo Protocollo della CEDU, quale interpretato dalla Corte di Strasburgo, e l’ordinamento costituzionale italiano, con particolare riferimento all’art. 42 Cost.
Si deve tuttavia riaffermare che il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato. L’art. 42
Cost. prescrive alla legge di riconoscere e garantire il diritto di proprietà, ma ne mette in
risalto la “funzione sociale”. Quest’ultima deve essere posta dal legislatore e dagli interpreti in stretta relazione all’art. 2 Cost., che richiede a tutti i cittadini l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Livelli troppo elevati di spesa per
l’espropriazione di aree edificabili destinate ad essere utilizzate per fi ni di pubblico interesse potrebbero pregiudicare la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti dalla
Costituzione (salute, istruzione, casa, tra gli altri) e potrebbero essere di freno eccessivo
alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per un più efficiente esercizio dell’iniziativa economica privata.
Valuterà il legislatore se l’equilibrio tra l’interesse individuale dei proprietari e la
funzione sociale della proprietà debba essere fi sso e uniforme, oppure, in conformità all’orientamento della Corte europea, debba essere realizzato in modo differenziato, in rapporto alla qualità dei fi ni di utilità pubblica perseguiti. Certamente non sono assimilabili singoli espropri per fi nalità limitate a piani di esproprio volti a rendere
possibili interventi programmati di riforma economica o migliori condizioni di giustizia sociale. Infatti, l’eccessivo livello della spesa per espropriazioni renderebbe impossibili o troppo onerose iniziative di questo tipo; tale effetto non deriverebbe invece da
una riparazione, ancorché più consistente, per gli “espropri isolati”, di cui parla la Corte di Strasburgo.
Esiste la possibilità di arrivare ad un giusto mezzo, che possa rientrare in quel “margine di apprezzamento”, all’interno del quale è legittimo, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che il singolo Stato si discosti dagli standard previsti in
703
Dispensa A17
via generale dalle norme CEDU, così come interpretate dalle decisioni della stessa Corte. Ciò è conforme peraltro a quella “relatività dei valori” affermata, come ricordato sopra, dalla Corte costituzionale italiana. Criteri di calcolo fissi e indifferenziati rischiano
di trattare allo stesso modo situazioni diverse, rispetto alle quali il bilanciamento deve
essere operato dal legislatore avuto riguardo alla portata sociale delle fi nalità pubbliche
che si vogliono perseguire, pur sempre defi nite e classificate dalla legge in via generale.
È inoltre evidente che i criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal
valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori.
6. – La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., rende superflua ogni valutazione sul dedotto
contrasto con l’art. 111 Cost., in rapporto all’applicabilità della stessa norma ai giudizi in
corso al momento della sua entrata in vigore, poiché, ai sensi dell’art. 30, terzo comma,
della legge 11.3.1953, n. 87, essa non potrà avere più applicazione dal giorno successivo
alla pubblicazione delle presente sentenza.
7. – Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dei commi 1 e 2 dell’art. 37 del d.P.R. n. 327 del
2001, che contengono norme identiche a quelle dichiarate in contrasto con la Costituzione dalla presente sentenza.
(Omissis)
2. L’ambito di applicazione dell’art. 43, TU espropriazioni
a. Cons. St., Sez. IV, 4.2.2008, n. 303
L’art. 43 del testo unico sugli espropri non si applica quando l’Amministrazione già risulti titolare dell’area (nella specie, in base ad una sentenza del giudice civile che abbia espressamente ravvisato tale titolarità, con una statuizione inequivocabile su cui è formato il giudicato). Invero la norma trae fondamento dalla giurisprudenza della Corte europea per i
diritti dell’uomo, secondo la quale la perdita del diritto di proprietà non può avvenire in assenza di un idoneo titolo previsto dalle legge. Tuttavia l’art. 32, paragrafo 1, della CEDU impone soltanto l’adeguamento della legislazione nazionale alle norme in essa contenute, nel
significato loro attribuito dalla Corte, ma non pregiudica le controversie irretrattabilmente definite dai giudicati nazionali. Di conseguenza il principio dell’irretrattabilità del giudicato non può ritenersi travolto dalle norme della Convenzione, derivandone altrimenti
un’inammissibile contrasto con l’art. 111 della Costituzione.
(Omissis)
Il riferimento che precede riguarda l’invocata applicazione, sotto vari profi li, della
c. d. acquisizione sanante di cui all’art. 43 del d.P.R. 8.6.2001 n. 327 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) del quale questa Sezione si è di recente occupata nella sentenza n. 2582/2007, effettuando le seguenti affermazioni.
a) la norma è conforme ai principi della Convenzione dei diritti dell’uomo, che hanno diretta rilevanza nell’ordinamento interno e per i quali non è consentito privare un
soggetto della proprietà in assenza di un idoneo titolo previsto per legge, procedendo alla espropriazione indiretta o sostanziale;
704
Dispensa A17
b) la norma è stata emessa dal legislatore per consentire all’Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto;
c) il testo e la ratio dell’art. 43 impongono di ritenere che esso non possa riferirsi a
tutti i casi di occupazioni sine titulo e quindi anche a tutti quelli già verificatisi alla data di entrata in vigore del testo unico l’art. 43, non sussistendo la possibilità di opporre
la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria decorrente dalla trasformazione
irreversibile dell’area o dalla realizzazione dell’opera.
I principi desumibili dall’art. 43 non risultano tuttavia applicabili nel presente giudizio, anche se l’appellante, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha ottenuto
nel 1987 l’annullamento del decreto di espropriazione del Presidente della Regione Lazio n. 6 del 1982.
Ed invero con atto notificato in data 17 marzo 1989, l’appellante ha chiesto al Tribunale di Viterbo, sul presupposto dell’illegittimità della procedura espropriativa portata
avanti dall’I.A.C.P. nei suoi riguardi, la corresponsione dei danni in misura pari al controvalore venale dell’immobile sul presupposto che l’area era divenuta di proprietà pubblica per effetto di quel fenomeno che oggi viene definito come “espropriazione acquisitiva” nonché dell’indennizzo per il periodo di occupazione legittima.
Svoltisi i tre gradi di giudizio dinanzi al giudice ordinario entrambe le domande sono state respinte (con sentenza della Corte d’appello, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11300 del 1996), per intervenuta prescrizione quinquennale.
Tale giudicato ha espressamente constatato che a suo tempo l’appellante ha perso
la proprietà dell’area oggetto della (illegittima) procedura espropriativa, poiché egli ha
agito innanzi al giudice civile per ottenere il risarcimento per equivalente, sul presupposto – tanto pacifico da essere dedotto da tutte le parti e comunque espressamente statuito dalla Corte d’appello – che da tempo l’Amministrazione era divenuta proprietaria
dell’area.
Si è pertanto in presenza di una fattispecie del tutto diversa da quella decisa dalla
Sezione con la decisione n. 5830 del 2007 (in cui un precedente giudicato civile aveva riguardato una domanda risarcitoria non rivolta ad ottenere il controvalore della res e unicamente basata – per petitum e causa petendi – sulla deduzione per cui l’Amministrazione si era immessa sine titolo nel possesso).
Ciò chiarito, la Sezione ritiene che l’art. 43 del testo unico non si applica quando
l’Amministrazione già risulti titolare dell’area (nella specie, in base ad una sentenza del
giudice civile che abbia espressamente ravvisato tale titolarità, con una statuizione inequivocabile su cui è formato il giudicato).
Come è noto l’irretrattabilità del giudicato, principio cardine del nostro ordinamento, discende dal principio generalissimo della certezza dei rapporti giuridici, e per esso
la norma di legge successiva non può influire sul giudicato anche quando quest’ultima
abbia natura interpretativa (Cass., Sez. lav., 10.4.1993, n. 3939). Natura che, peraltro, non
si può certamente riconoscere all’art. 43.
Come esposto nella sentenza di questa Sezione in precedenza riassunta, la norma
in questione è, invero, norma che trae ragione, in relazione alle procedure di esproprio
previste dall’ordinamento italiano, dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti
dell’uomo, in tema di tutela del diritto di proprietà affermata nella CEDU (art. 1 del primo Prot. Add.), secondo la quale la sua perdita non può avvenire in assenza di un idoneo
titolo previsto dalle legge.
Non emerge però da tale insegnamento, imponendo l’art. 32, par. 1, della CEDU, soltanto l’adeguamento della legislazione nazionale alle norme in essa contenute, nel significato loro attribuito dalla Corte, che lo Stato Italiano avrebbe dovuto adeguarsi fi no
a comprendere anche le controversie irretrattabilmente defi nite dai giudicati naziona-
705
Dispensa A17
li, piuttosto che circoscrivere l’intervento legislativo solo a quelle tutt’ora pendenti anche se risalenti.
Simile estensione invero esula dall’obbligatorio alveo disciplinare della Convenzione, per ricadere tutta nella potestà del legislatore nazionale (fatti salvi i profi li di legittimità costituzionale) al quale, da questa sede, può essere solo segnalata la questione.
Approfondendo quest’ultimo aspetto, non può, invero, trascurarsi di rilevare che
due recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno focalizzato il rapporto tra norma
interna, norma della Convenzione, e Carta Costituzionale, sottolineando che tale rapporto si atteggia in termini diversi da quelli che caratterizzano il rapporto tra norma comunitaria e norma interna.
In quest’ultimo caso, l’immediata applicabilità della norma comunitaria si esprime
con tale forza da travolgere persino il giudicato interno formatosi ex art. 2909 c.c., in violazione della norma comunitaria (Corte di Giustizia, grande sezione, sentenza 18.7.2007,
causa C-119/05).
Diversamente, i principi fondamentali della CEDU, pur imponendosi alla norma interna, per la forza che ad essi deriva dall’art. 117 della Costituzione, nel testo introdotto
con la recente modifica del Titolo quinto, in quanto affidati a “norme interposte”, possono essere recepiti dal giudice interno ove siano, a loro volta, come interpretati dalla Corte di Strasburgo, conformi alla nostra Carta Costituzionale (cfr. sentenze Corte Costituzionale del 24.10.2007, n. 348 e n. 349).
Applicando tali insegnamenti nella fattispecie in esame, ne discende che il principio dell’irretrattabilità del giudicato, la cui copertura costituzionale è senza dubbio affidata all’art. 111 della nostra Carta, non può ritenersi travolto dalle norme della
Convenzione, derivandone altrimenti un’inammissibile contrasto con la Costituzione stessa.
Non possono quindi in questa sede essere riesaminate (in rapporto ai principi affermati dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) le statuizioni del giudice civile secondo le quali l’Amministrazione sin dagli anni Ottanta è divenuta proprietaria
dell’area, mentre si è nel frattempo prescritta la pretesa risarcitoria volta ad ottenere il
suo controvalore.
In tale ambito di considerazione non è del resto irrilevante osservare che la salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici è principio operante non soltanto nell’ordinamento interno ma anche in quello internazionale.
Quest’ultimo rilievo offre lo spunto per ulteriormente rilevare che il vincolo del giudicato civile è stato portato dall’appellante al vaglio della Corte europea, deducendo il
contrasto con l’art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione, rendendosi conto che
l’intervento del giudice sopranazionale era l’unico mezzo per rimuoverne gli effetti.
Sennonché tale iniziativa non è stata coltivata con successo, essendo stata defi nita
con la pronuncia del 14 dicembre 2001 della Corte, che ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.
Ne discende che anche in ragione di tale esito non è sindacabile in questa sede il giudicato formatosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11300 del 1996.
Ricostruita nei termini che precedono la portata applicativa dell’art. 43 del TU delle espropriazioni, ne consegue che debbono essere respinti tutti i profi li di illegittimità
per violazione di legge che parte appellante sotto varie angolazioni propone, inserendoli trasversalmente in quasi tutte le censure articolate.
E ciò vale anche per la dedotta illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di acquisizione delle aree rivolta all’amministrazione, già condivisibilmente ritenuta improponibile dal giudice di primo grado, per violazione della norma di rito di cui
all’art. 21 bis, legge n. 1034/1971 (introdotto dall’art. 2, legge n. 205/2000).
706
Dispensa A17
Rimangono, conseguentemente, da esaminare il motivo n. 2 dell’atto d’appello, riguardante la declaratoria di nullità degli atti della procedura espropriativa “a monte”
del decreto di esproprio annullato con il d.P.R. 1.10.1987, ed il motivo n. 6, riguardante la
domanda sussidiaria di arricchimento senza causa.
Al riguardo la Sezione non può che confermare le valutazioni del giudice di primo
grado, correttamente volte ad evidenziare la completa assenze delle condizioni per la
proposizione dell’azione.
Con la sola aggiunta, in relazione all’azione di nullità, che essa è divenuta proponibile
con la novella introdotta con l’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, aggiunto dall’art.
14, l. 11.2.2005, n. 15, richiedendosi la presenza di specifici vizi che nel procedimento
espropriativo de quo non si sono certamente verificati, ed in relazione all’azione d’arricchimento, che nella fattispecie non è intervenuto il formale riconoscimento dell’utilità,
parziale o totale dell’opera da parte della P.A. (Cass. civ. Sez. II, 11.2.2002, n. 1884).
(Omissis)
3. La decadenza quinquennale dei vincoli urbanistici
a. TAR Lazio, Sez. II bis, 11.1.2008, n. 151
In materia edilizia, il principio della decadenza quinquennale ex art. 2 l. n. 1187/1968
si applica soltanto ai vincoli di piano regolatore che incidono su beni determinati, assoggettandoli ad espropriazione o ad inedificabilità, e che svuotano il contenuto del diritto di
proprietà. Infatti, soltanto tali vincoli incidono sul godimento del bene tanto da renderlo
inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale o da diminuirne il valore di scambio.
(Omissis)
La censura è infondata alla stregua di quanto già in precedenza precisato dalla Sezione in fattispecie analoghe (cfr. TAR Lazio, Sez. II bis, n. 2607/07; 2604/07; 2605/07).
Il Tribunale ha già precisato che “numerose decisioni dei giudici amministrativi
hanno univocamente statuito, con orientamento consolidato ribadito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 20.5.1999, che i vincoli di piano regolatore ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187, sono soltanto quelli che incidono su beni
determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che ne
comportano l’inedificabilità e, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà
incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il valore di scambio
(cfr. TAR Lazio, Sez. II, 11.10.2005, n. 8286; id., 14.9.2005, n. 7002; TAR Toscana, Sez. III,
14.9.2004, n. 3767; Cons. St., Sez. IV, 14.2.2005, n. 432; id., 10.8.2004, n. 5490; id., 22.6.2004,
n. 4426; id., 24.2.2004, n. 745).
…”Si rileva, in ogni caso, che la previsione di uno strumento urbanistico che subordina l’attività edificatoria alla preventiva formazione di un piano attuativo, non integra
gli estremi del vincolo espropriativo, in quanto non impedisce in modo assoluto l’edificazione e non svuota quindi di ogni contenuto il relativo diritto di proprietà. Conseguentemente tale previsione non è soggetta alla decadenza di cui all’art. 2 della legge n.
1187 del 1968 (cfr. Cons. St., Sez. IV, 25.8.2003, n. 4812)”.
Nella fattispecie, poi non poteva sussistere alcun vincolo di inedificabilità assoluta
atteso che lo stesso P.R.G. consentiva anche l’intervento diretto, sebbene con un indice
707
Dispensa A17
di edificabilità ridotto: deve ritenersi pertanto che detto vincolo costituisse esclusivamente espressione della potestà conformativa propria della pianificazione urbanistica
e come tale non fosse soggetto a decadenza.
Ne consegue, che non essendo decaduto il vincolo, doveva ritenersi applicabile la
previsione dell’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. del 1979, e che quindi l’indice di fabbricabilità da utilizzarsi per la zona in questione avrebbe dovuto essere quello ridotto e pari a
2.00 mc/mq, e non quello previsto dalla tabella A, utilizzabile esclusivamente nel caso
di edificazione in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi.
(Omissis)
708