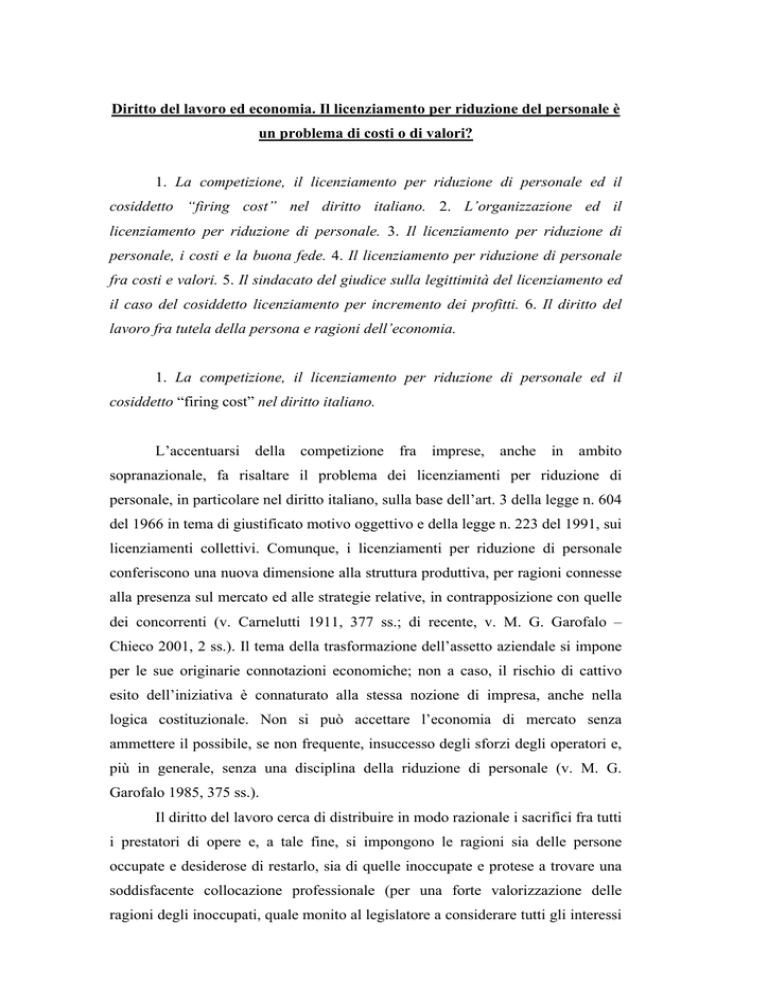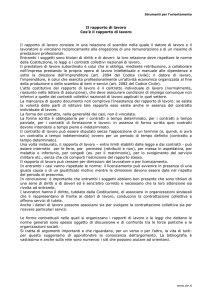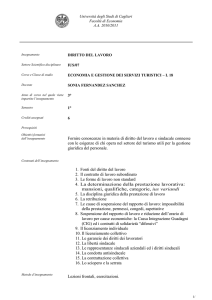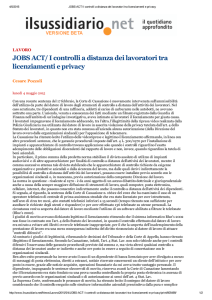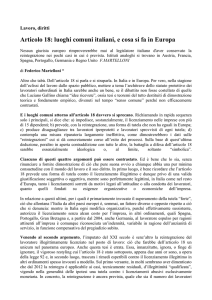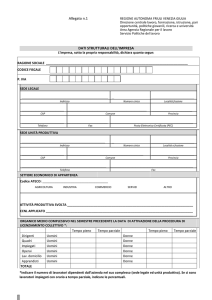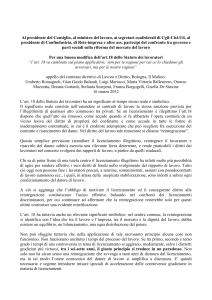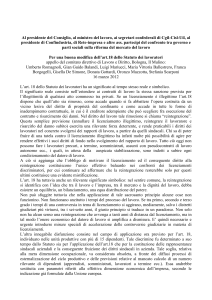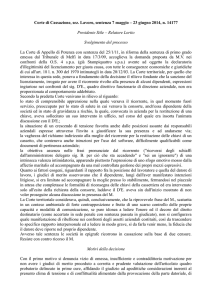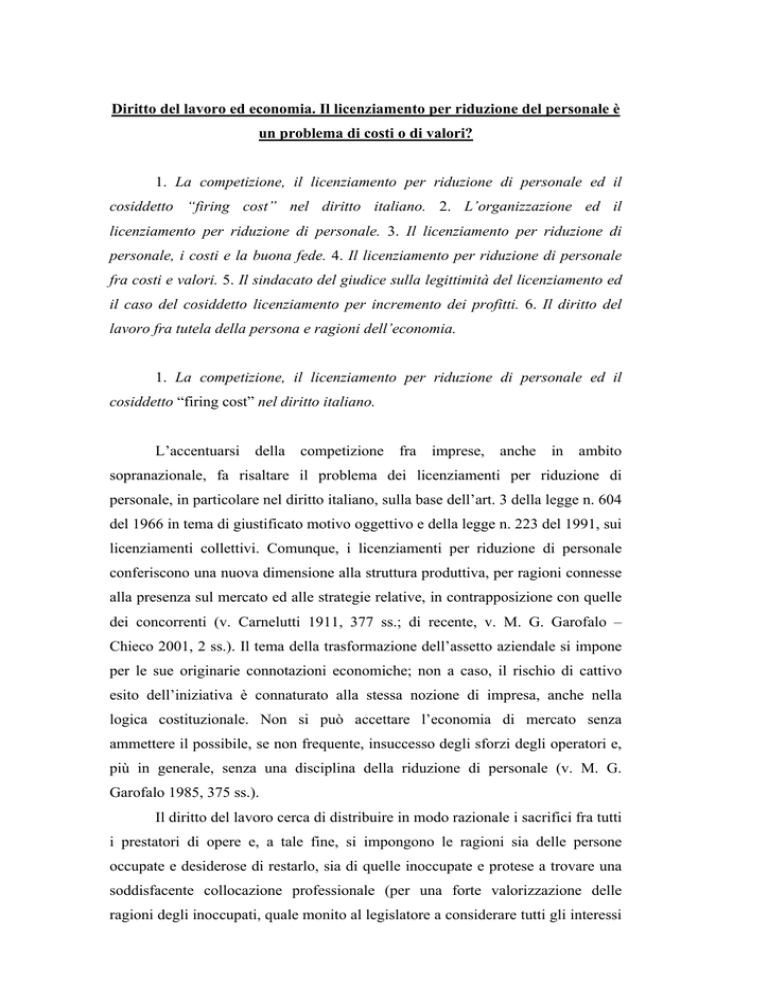
Diritto del lavoro ed economia. Il licenziamento per riduzione del personale è
un problema di costi o di valori?
1. La competizione, il licenziamento per riduzione di personale ed il
cosiddetto “firing cost” nel diritto italiano. 2. L’organizzazione ed il
licenziamento per riduzione di personale. 3. Il licenziamento per riduzione di
personale, i costi e la buona fede. 4. Il licenziamento per riduzione di personale
fra costi e valori. 5. Il sindacato del giudice sulla legittimità del licenziamento ed
il caso del cosiddetto licenziamento per incremento dei profitti. 6. Il diritto del
lavoro fra tutela della persona e ragioni dell’economia.
1. La competizione, il licenziamento per riduzione di personale ed il
cosiddetto “firing cost” nel diritto italiano.
L’accentuarsi della competizione fra imprese, anche in ambito
sopranazionale, fa risaltare il problema dei licenziamenti per riduzione di
personale, in particolare nel diritto italiano, sulla base dell’art. 3 della legge n. 604
del 1966 in tema di giustificato motivo oggettivo e della legge n. 223 del 1991, sui
licenziamenti collettivi. Comunque, i licenziamenti per riduzione di personale
conferiscono una nuova dimensione alla struttura produttiva, per ragioni connesse
alla presenza sul mercato ed alle strategie relative, in contrapposizione con quelle
dei concorrenti (v. Carnelutti 1911, 377 ss.; di recente, v. M. G. Garofalo –
Chieco 2001, 2 ss.). Il tema della trasformazione dell’assetto aziendale si impone
per le sue originarie connotazioni economiche; non a caso, il rischio di cattivo
esito dell’iniziativa è connaturato alla stessa nozione di impresa, anche nella
logica costituzionale. Non si può accettare l’economia di mercato senza
ammettere il possibile, se non frequente, insuccesso degli sforzi degli operatori e,
più in generale, senza una disciplina della riduzione di personale (v. M. G.
Garofalo 1985, 375 ss.).
Il diritto del lavoro cerca di distribuire in modo razionale i sacrifici fra tutti
i prestatori di opere e, a tale fine, si impongono le ragioni sia delle persone
occupate e desiderose di restarlo, sia di quelle inoccupate e protese a trovare una
soddisfacente collocazione professionale (per una forte valorizzazione delle
ragioni degli inoccupati, quale monito al legislatore a considerare tutti gli interessi
coinvolti dal diritto del lavoro, v. P. Ichino 1996, 37 ss.; A. Ichino – P. Ichino
1994, 487 ss.). Per la complessiva conciliazione di tali interessi possono essere
immaginate molte soluzioni, con vari, plausibili modelli. Però, in una economia
capitalistica, il concetto di riduzione di personale è imposto alla stessa legge dalla
struttura del sistema economico e, al limite, trova spiegazione nei criteri
costituzionali (v. Napoli 1996, 281 ss.; De Simone 2002, 25 ss.).
Il ruolo del diritto del lavoro non è secondario rispetto alle più articolate
dinamiche del mercato ed alle decisioni dei suoi protagonisti. Infatti, in un
contesto di frenetica competizione, l’esistenza delle imprese e le loro possibilità di
azione sono influenzate dalla disciplina della riduzione di personale (v. Del Punta
1998, 703 ss.). Questa dialettica non può essere sciolta in nome di astratte
contrapposizioni fra mercato e tutela del lavoro, poiché spetta al diritto positivo
definire un modello di licenziamento, per comporre le esigenze diverse.
Di recente, nell’ordinamento italiano, l’intera questione è stata considerata
in termini di determinazione del costo di licenziamento. Si dubita della
ragionevolezza della “imposizione all’imprenditore della prosecuzione di un
rapporto di lavoro in perdita; per quanto limitata questa sia, sarebbe incompatibile
con la regola costituzionale che esclude la possibilità di imposizione di obblighi
assistenziali a un soggetto privato” (v. P. Ichino 2002, 475 ss.). Si dice: “l’unica
risposta a questa obiezione che io sia riuscito a trovare consiste nel contenuto
assicurativo del rapporto di lavoro subordinato” (v. P. Ichino 2002, 475 ss.; cfr.
anche Stolfa 2004, 627 ss.). Non è quello il punto, ammesso che il rapporto abbia
una simile natura; in realtà, non si può parlare né di un rapporto in perdita, né di
uno in utile, pena cadere in una inaccettabile mercificazione (invece, v. Grandi
1997, 557 ss.) ed in forzature sulla valutazione dell’apporto individuale.
Il lavoratore ed il suo contributo produttivo non sono né in utile, né in
perdita e simili nozioni non possono essere riferite alla prestazione, poiché, in tale
ambito, non hanno alcun significato. Mentre questi concetti descrivono
l’andamento dell’impresa, non è possibile riportarli alla condizione di ciascun
dipendente, il quale è parte del disegno organizzativo, ma, come collaboratore,
non è “in perdita”. Affinché possa stabilire l’assetto dell’impresa, utilizzando la
categoria conoscitiva dell’organizzazione, il datore di lavoro deve mettere in
relazione il destino del dipendente con quello del complesso aziendale. Pertanto,
l’estinzione di un rapporto presuppone un ragionamento inerente all’intera
2
struttura e, così, non esiste il problema della prosecuzione di un “rapporto in
perdita”. Il punto è stabilire quale controllo abbia il giudice sulla decisione di
licenziare.
Si osserva che “la distinzione tra damnun vitandum e lucrum captandum
non ha alcun significato, se riferita ai profitti o perdite derivanti alle imprese dai
singoli rapporti”, così che “il criterio di valutazione del singolo licenziamento non
può (...) essere quello del saldo attivo o passivo del bilancio aziendale
complessivamente inteso” (v. Ichino 2002, 478 ss.). Però, tale affermazione
implica che si possa stabilire nell’ambito del singolo rapporto l’esistenza di un
“saldo attivo o passivo”, mentre ciò non è persuasivo. La prestazione non è
suscettibile di una valutazione aziendale, se essa non è collegata con il contesto
dell’organizzazione.
Si afferma che la conservazione di un lavoratore “inutile” comporterebbe
un “costo – opportunità” e “la sopravvivenza dell’impresa dipende (...) proprio
dalla sua capacità di individuare costantemente i costi – opportunità e perseguire
le opzioni che ne riducono al minimo l’entità” (v. P. Ichino 2002, 478 ss.).
Tuttavia, non ogni condotta che migliora l’efficienza è legittima, anche a volere
ammettere che si possa stabilire se l’apporto individuale sia un “costo inutile”. In
nessun modo l’ordinamento postula che il criterio di soluzione dei conflitti in
tema di licenziamenti per riduzione di personale sia dato dalla valorizzazione
massima dell’efficienza.
Poi, si riconosce che occorre verificare “la sincerità della dichiarazione
dell’imprenditore circa la perdita attesa” (v. Ichino 2002, 496 ss.) e, a tale fine, il
giudice dovrebbe stabilire il cosiddetto “firing cost”, vale a dire liquidare un
importo da versare al prestatore di opere, a fronte del sacrificio richiesto e quale
corrispettivo del vantaggio ottenuto con la riduzione dell’organico. L’idea
potrebbe essere di grande risalto se fosse modificata l’attuale disciplina
processuale, ma, allo stato, resta solo una provocazione. Si dice che, “quando
possano escludersi i motivi illeciti, il giudice nel corso del tentativo di
conciliazione indica quella che egli ritiene essere la soglia, ovvero la perdita (o
«copertura assicurativa») massima che può essere imposta all’impresa; se
l’imprenditore è disposto a pagare altrettanto al lavoratore, questo significa che la
perdita da lui attesa è superiore e che quindi il licenziamento è giustificato” (v.
Ichino 2002, 496 ss.).
3
Nessun giudice può quantificare il cosiddetto “firing cost”. Se la decisione
di assumere impedisce che il datore di lavoro possa licenziare a sua discrezione,
allora la soluzione non spetta agli strumenti processuali, ma al controllo analitico
del motivo giustificativo. Libero di perseguire il suo progetto soggettivo di
coordinamento dei fattori della produzione, il datore di lavoro incontra un
sindacato del giudice basato su parametri di socialità. Ciò accade in qualunque
ordinamento nazionale ed il problema è di stabilire come quello italiano
componga il conflitto. Se si deve cercare il limite entro il quale “l’impresa deve
farsi carico della prosecuzione del rapporto anche in perdita” (v. Ichino 2002, 477
ss.), per un verso non si può riflettere sul singolo rapporto, ma si deve guardare
all’intera azienda e, per altro verso, non basta un ragionamento sui costi, ma se ne
uno impone sui comportamenti e, quindi, sui valori espressi dai protagonisti
dell’azione economica.
L’impresa è proiettata al miglioramento dell’efficienza, come è tipico di
una economia di capitalismo maturo, con le sue crescenti tensioni concorrenziali.
Se mai, vi è da chiarire come, a fronte dei limiti imposti dal diritto del lavoro,
l’impresa possa rafforzare la sua posizione sul mercato. Il giudice deve
considerare l’intera evoluzione aziendale, perché “la distinzione tra «scelta
sottostante», di cui si pretende l’insindacabilità, e scelta (sindacabile) di licenziare
un determinato lavoratore è (...) contraddetta dagli orientamenti giurisprudenziali
(...) concernenti l’obbligo del repechage, o l’applicazione di un criterio
ragionevole nella scelta del lavoratore da licenziare: quando il giudice valuta la
possibilità (...) dello spostamento di un lavoratore da una posizione all’altra in
seno all’azienda (...), egli interviene proprio sull’organizzazione” (v. M. T.
Carinci 2006, 117 ss.).
Il controllo sulla decisione non riguarda il “costo” ed il relativo “utile”, se
non altro perché, pure avendo un costo, il rapporto è utile solo se inserito in un più
articolato contesto aziendale, nelle sue dinamiche e nelle sue prospettive. Se si
passa dalla sorte del dipendente all’organizzazione si può spiegare perché abbia
luogo il licenziamento. Se si stabilisce il suo motivo ci si può poi chiedere quali
regole presiedano alla sua legittimità e, cioè, come il diritto italiano componga il
conflitto, nella distribuzione dei sacrifici. Prima di domandarsi come abbia luogo
questa valutazione dei comportamenti, occorre verificare che cosa sia
l’organizzazione.
4
2. L’organizzazione ed il licenziamento per riduzione di personale.
Nonostante, a più riprese, si neghi il possibile sindacato del giudice sulla
cosiddetta discrezionalità dell’impresa e, quindi, sull’opportunità delle sue scelte,
in tema di licenziamenti per riduzione di personale è ristretto lo spazio non invaso
dall’intervento del giudice (v. Napoli 1980, 153 ss.). Infatti, il datore di lavoro
deve dimostrare le ragioni alla base della sua opzione e queste devono essere reali
e, quindi, oggetto di prova. Inoltre, deve essere impossibile il recupero
dell’attività del lavoratore seppure in mansioni differenti, con un prevalere
dell’interesse alla prosecuzione del rapporto su quello alla variazione dell’assetto
aziendale.
Il punto di fondo è capire come il potere unilaterale del datore di lavoro
possa riguardare la riduzione di personale e come le decisioni sulla sorte
dell’azienda possano interferire con la sorte dei dipendenti. Infatti, la crisi o, in
generale, le difficoltà dell’impresa si impongono come premessa ad un atto di
licenziamento sia nei recessi collettivi, sia in quelli individuali (v. Napoli 1980, 17
ss., per il quale “«giustificato motivo» è un’espressione sintetica idonea a
designare quei fatti al verificarsi dei quali l’esercizio del potere di recesso è
conforme al modello di riferimento fissato dalla legge”, in dichiarata
contrapposizione a Prosperetti 1967, 141 ss.).
Il problema organizzativo è oggetto di un giudizio, sintetico e critico.
Infatti, il concetto di questione organizzativa può essere scisso in due versanti.
Alcuni fatti non sono mai considerati dubbi e sono ritenuti pacifici sia
dall’impresa, sia dal lavoratore e dalle sue rappresentanze. Il contesto generale, la
situazione di mercato, le risultanze dei bilanci sono una sorta di sfondo ad analisi
più delicate, e su tali temi si registra spesso un diffuso consenso. A dire il vero,
questa concordanza di vedute può essere talora il frutto di una certa ingenuità
delle associazioni sindacali e dei prestatori di opere o, all’opposto, di abili
strategie aziendali di comunicazione.
Nonostante i numerosi obblighi di informazione fissati sia nei testi
normativi, sia nei contratti collettivi, la consapevolezza sulla situazione
dell’impresa è talora più apparente che reale e, in specie in strutture complesse e
con rilevanti ramificazioni territoriali, la percezione sull’effettivo andamento
5
economico può essere fuorviata da consapevoli sforzi del datore di lavoro volti a
fornire di sé e dei suoi obbiettivi una immagine apposita, non sempre fedele.
Tuttavia, di rado il conflitto sulla legittimità del licenziamento si spinge
fino alla contestazione dei giudizi, di natura descrittiva, che, con affermazioni
sintetiche, delineano il problema di fondo il quale, poi, conduce al recesso. Le
tensioni sono maggiori quando si passa dallo sfondo alla specifica questione in
discussione. Anche in tale ottica più ristretta (e più significativa per il sindacato
del giudice), la valutazione dell’organizzazione e dei suoi problemi resta oggetto
della conoscenza, con una descrizione più puntuale della struttura e delle ragioni
della riduzione del personale. Se dalla crisi si deduce l’esistenza di una
produzione eccessiva o se dalla competizione internazionale si ricava
l’opportunità di un potenziamento tecnologico, con l’uso di macchinari più
moderni, non si pone alcun “nesso di causalità” e, oltre tutto, non si passa ancora
sul terreno della decisione. Si rimane nell’area di dominio della conoscenza, se
mai con il transito da affermazioni descrittive (o come tali percepite) ad altre con
un più intenso contenuto critico e, quindi, più discutibili (sulla contrapposizione
fra conoscenza critica e storica, v. Pugliatti 1957, 225 ss.; Meloncelli 1983, 59
ss.).
Il giudizio tipico del processo intellettivo passa dalla semplice
ricostruzione del fatto alla sua critica (v. Carnelutti 1951, 364 ss.; Giampiccolo
1959, 143 ss.). Ciò vale in particolare qualora oggetto della conoscenza sia lo
stato dell’azienda, perché l’informazione si sofferma su più elementi connessi in
un intreccio, cioè la descrizione della struttura, la valutazione dello stato del
mercato, la verifica delle potenzialità tecnologiche, la riflessione sui bisogni dei
clienti, le ipotesi sulle scelte dei competitori e sui condizionamenti dati dalle
discipline di settore, l’interrogarsi sulle dinamiche macroeconomiche presenti e
future.
L’organizzazione è un metodo di valutazione delle situazioni. In quanto
chiave di comprensione di ciò che succede in azienda, l’organizzazione non è in
natura rerum e non è neppure regolata in modo diretto dal diritto positivo, ma è la
strada della razionale rielaborazione e dell’inquadramento degli eventi incidenti
sulla decisione di licenziare. In sostanza, l’organizzazione è prima di tutto nei
piani
dell’imprenditore;
proprio
perché
il
licenziamento
provoca
una
trasformazione dell’assetto produttivo, l’organizzazione non consiste solo nella
6
descrizione statica, ma nell’analisi critica funzionale al cambiamento. In fondo,
nella categoria dell’organizzazione si concentrano sia la sistemazione dei fatti
sottoposti a giudizi descrittivi, sia una prognosi, volta a prevedere lo svilupparsi
del mercato, dell’attività, della concorrenza.
Si resta nell’ambito della conoscenza, ma questa riguarda una realtà in
modificazione, da comprendere nelle sue trasformazioni. Nella sua interazione
con gli altri protagonisti del contesto economico, l’azienda può essere valutata
solo se si fa ricorso al concetto di organizzazione. Esso collega in un approccio
unitario tutti i fatti che afferiscono all’andamento dell’impresa ed alla posizione
dei prestatori di opere (v. Persiani 1966, 35 ss.; Marazza 2002, 145 ss.; sul nesso
fra l’organizzazione aziendale e le obbligazioni del prestatore di opere, v.
Mengoni 1965, 498 ss.).
L’organizzazione è un meccanismo concettuale di inquadramento delle
riflessioni dell’imprenditore, il quale, nel suo dialogo con la realtà, ha molteplici
impulsi, sull’attività dei suoi collaboratori, sulla natura dei prodotti, sui
comportamenti dei competitori, sull’evolversi del mercato, sui risultati
patrimoniali, sulle rivendicazioni sindacali, sull’andamento della legislazione di
settore, su molti altri aspetti che condizionano l’iniziativa economica, in una
società di capitalismo maturo. Tali profili devono essere collegati in un disegno
unitario, perché dall’intrecciarsi delle analisi e dei programmi provenga una
considerazione conclusiva (sull’impatto della competizione sul rapporto di lavoro,
v. Persiani 2000, 5 ss.).
L’organizzazione non è oggettiva, perché il disegno dell’azienda è nella
mente, cioè nel giudizio critico dell’imprenditore, se non si vuole spacciare per
reale un piano solo pensato e corretto di momento in momento, con adattamenti,
variazioni, innovazioni, indotti dalle modificazioni del contesto e dal
sopraggiungere di ulteriori stimoli. Quanto più sono rapide l’evoluzione della
società e quella di ciascuna azienda, tanto più si svela la natura soggettiva del
progetto, con aggiornamenti costanti, perché sia possibile reggere le sfide
provocate dalle decisioni non meno frenetiche dei concorrenti. A fronte di una
serrata competizione, la quale determina una protratta tensione verso maggiori
livelli di efficienza (reale o solo sperata), l’organizzazione è il nesso razionale fra
i diversi fattori della produzione o, se si vuole, fra le articolazioni dell’azienda.
Tuttavia, la categoria dell’organizzazione deve essere riportata alla conoscenza,
7
come criterio di spiegazione di un mutevole progetto, in affinamento progressivo
ed in relazione dialettica con gli impulsi che, a loro volta, arrivano senza
interruzione.
Con le sue analisi, l’impresa trae a sintesi notizie disorganiche. Così si
enuncia il problema che conduce alla riduzione del personale. In particolare, tale
ragionamento sfrutta la categoria dell’organizzazione, la quale mette in
connessione quanto si apprende sul presente rispetto alle prospettive del mercato.
L’intensità delle trasformazioni e la loro celerità rendono sempre più sfuggente
quella organizzazione alla quale, invece, si vorrebbe dare una sostanza oggettiva.
Se mai, una simile idea sarebbe stata allettante nel passato, quando l’immagine
dell’azienda era improntata alla stabilità ed alla solidità, più che alla ricerca della
massima duttilità, nell’inseguire le sfide del mercato.
Il rapporto di lavoro non può comprendere un impegno dell’imprenditore a
conservare un determinato assetto della struttura da lui creata. Quindi, per
organizzazione non si può intendere lo status quo, cioè il modello consolidato di
interrelazione fra i vari dipendenti, escluso dall’oggetto delle reciproche
obbligazioni. Infatti, il diritto del lavoro non garantisce un assetto dell’azienda,
ma si sofferma se mai sulle posizioni soggettive dei prestatori di opere e sui poteri
dell’imprenditore, in un contesto dinamico.
Non si possono fare coincidere la tutela dei lavoratori e la conservazione;
invece, occorre accettare, se non incoraggiare il dinamismo. Titolare dei poteri
riconosciuti per legge e fondati sul contratto, il datore di lavoro non trova né nella
legge, né nella contrattazione collettiva, né nell’accordo individuale il fondamento
del suo disegno di collegamento razionale fra i fattori della produzione (v.
Mancini 1957, 23 ss.), proprio perché questo disegno è un programma soggettivo,
oltre tutto in costante evoluzione. Tale progetto viene prima del diritto e, poi, è
realizzato con l’esercizio dei poteri e con l’osservanza dei limiti fondati dal diritto
del lavoro. Proprio per questo, il programma nel quale consiste l’organizzazione
rientra nel mero dominio della conoscenza, ma ha precisa rilevanza giuridica. Il
punto è stabilire quale sia tale rilevanza giuridica e, dunque, come sia disegnato il
potere del datore di lavoro. Tuttavia, la rilevanza dell’organizzazione non la rende
oggetto del contratto, né di una disciplina specifica.
3. Il licenziamento per riduzione di personale, i costi e la buona fede.
8
Di fronte all’allegazione di un motivo di recesso, il giudice deve muovere
nel suo sindacato da due prospettive concomitanti, chiedendosi in primo luogo se
quello addotto sia il motivo effettivo e poi se, con i margini di opinabilità tipici di
decisioni che facciano seguito a complessi e discutibili giudizi sintetici, il datore
di lavoro abbia allegato quel quid novi che è il necessario presupposto di un
legittimo licenziamento. Poiché il vero motivo resta chiuso nella psiche del
titolare del potere e, comunque, di chi abbia adottato l’atto, il controllo
sull’effettività del motivo indicato presuppone una analisi di verosimiglianza del
ragionamento (valutativo e decisorio) enunciato a fronte dell’impugnazione del
prestatore di opere. Quindi, il giudice deve partire dallo stato di fatto, per stabilire
il reale intendimento, per quanto esso si esponga alla cognizione altrui.
Dimostrato il sussistere del quid novi e, di conseguenza, chiarite la
credibilità del motivo addotto e la veridicità delle situazioni indicate a sostegno, il
motivo è giustificato qualora lo scopo sia il frutto coerente di un equilibrato
apprezzamento (a prescindere dalla sua esattezza) e l’intera condotta sia conforme
a buona fede. Si chiede “che il datore di lavoro non solo usi dei propri poteri
conformemente alla lettera delle disposizioni legislative o contrattuali, ma
parimenti ne rispetti, per così dire, lo spirito” (v. Ferrante 2004, 40 ss.).
Il giudice deve verificare la complessiva buona fede dell’impresa. Per
tradizione, il vincolo al recesso è visto nell’inevitabilità, quindi nella razionalità
della decisione, nella capacità di motivare il collegamento fra la causa (cioè, il
problema organizzativo) e l’effetto (dunque, il licenziamento). Tale impianto
argomentativo non è persuasivo ed il canone di valutazione del carattere
“giustificato” del motivo si deve situare su un altro piano, diverso dalla
ragionevolezza. In difetto, il giudice diventerebbe arbitro dei destini
dell’organizzazione
e
questa
sarebbe
esaminata
dall’esterno
secondo
apprezzamenti inconciliabili con la natura opinabile delle indagini e delle
decisioni connesse. Si renderebbe oggettiva una organizzazione che, all’opposto, è
strumento di spiegazione concettuale del progetto dell’impresa, si coinvolgerebbe
di fatto il lavoratore nella realizzazione di un piano cui è estraneo e si
giudicherebbe soccombente il suo interesse a fronte di una analisi su strategie
formulate dall’impresa stessa.
9
L’organizzazione non ha alcuna consistenza autonoma e non vi è un suo
interesse che si aggiunga o si distingua da quello dell’imprenditore, oltre tutto
nella posizione di governare con libertà le sue scelte ed il quale, quindi, può
rivedere, aggiornare e trasformare le sue strategie. L’organizzazione è solo nei
progetti dell’impresa e non ha sue ragioni diverse da quelle del datore di lavoro.
Quindi, la razionalità intesa (come spesso accade) quale coerenza con l’interesse
dell’organizzazione non può dirimere l’aspro conflitto fra datore di lavoro e
dipendente. La libertà di iniziativa economica deve trovare un altro
contemperamento e questo non può essere reperito in un sindacato del giudice che
discrimini a seconda della bontà della scelta.
All’impresa si chiede correttezza, quindi prevedibilità delle decisioni. Esse
devono rispondere ad un progetto non episodico o sorto in modo apodittico o
casuale. Il giudice non deve valutare il singolo problema, ma la vita dell’azienda,
per capire se il licenziamento corrisponda ad un impulso momentaneo od abbia
fondamenti più solidi. Poiché non si può entrare nell’intimo dell’organizzazione,
confinata fuori dalla sfera di controllo dei prestatori di opere e del giudice, il
datore di lavoro deve avere un contegno omogeneo, operare secondo gli stessi
schemi in contesti simili, enunciare in modo preciso le sue determinazioni,
ponderarle ed affrontare con lo stesso approccio situazioni paragonabili. Pertanto,
non si può valutare la razionalità, ma, al contrario, si deve guardare all’uso di un
metodo equilibrato.
Il controllo è di correttezza e, quindi, di conformità a parametri di
trasparenza, di prevedibilità, di puntuale spiegazione delle ragioni dell’atto, di
rispetto e di considerazione effettiva per le esigenze del lavoratore. Accantonato il
sindacato diretto sulla razionalità, si deve considerare il potere nelle modalità di
esercizio. Il punto di partenza è la motivazione, che l’impresa deve esternare e la
quale condiziona le successive valutazioni del giudice. Fermo l’obbligo di
enunciare e di provare il motivo, questo non deve essere esaminato rispetto alle
necessità dell’organizzazione, ma, se è ritenuto quello effettivo, deve essere
riguardato alla luce del complessivo contegno dell’impresa, della sua presenza sul
mercato, del suo modello di iniziativa nel lungo o, almeno, nel medio periodo.
Non si può inseguire una astratta idea di buona organizzazione
dimenticando gli interessi sostanziali; né si possono considerare misurabili i
“costi”, quando l’organizzazione è il semplice riflesso del mutevole progetto del
10
datore di lavoro. Poco importa il miglioramento dell’efficienza in sé (ammesso
che ciò possa essere stabilito con sicurezza) qualora l’espulsione di chi abbia
competenze superate non sia collegata ad una complessiva condotta leale. Una
simile impostazione potrebbe essere tacciata di indeterminatezza, di mancanza di
criteri direttivi, di scarsa precisione. Peraltro, le stesse osservazioni dovrebbero
essere rivolte alle tesi tradizionali. Solo la convinzione (infondata) dell’oggettività
dell’organizzazione dà un preteso fondamento alla ricerca del problema strutturale
quale presupposto del licenziamento.
La considerazione del comportamento dell’impresa dal punto di vista della
correttezza non provoca alcun rinvio a parametri generici. Del resto, il sindacato
di correttezza è da sempre patrimonio del nostro ordinamento. La verifica del
giudice non può riguardare la necessità della riduzione di personale, ma si deve
soffermare sulla buona fede. In sostanza, una analisi di coerenza organizzativa
deve essere sostituita da una di compatibilità sociale dell’iniziativa del datore di
lavoro. In questa logica si iscrive il noto tema del ripescaggio; sarebbe singolare
addossare all’impresa l’onere di spiegare in quale altro “posto” sarebbe stato
possibile inserire il lavoratore. Per un verso, questo ragionamento si basa sulla
pretesa rilevanza del “posto” quale oggettiva particella dell’organizzazione, con
uno schema poco persuasivo. Per altro verso, non si vede perché il recesso
intimato debba costringere ad un potenziamento dell’azienda in un altro settore,
con un incremento nel numero dei dipendenti impegnati.
Sebbene siano da escludere qualsiasi “funzionalizzazione” dell’attività e,
quindi, uno sforzo creativo del giudice, fuori dalle previsioni legali, queste ultime
devono essere ricostruite in sintonia con la direttiva costituzionale. Ciò permette
di vedere nella buona fede la “specifica lealtà che si impone fra due individui
legati da un vincolo di natura particolare” (v. Cattaneo 1971, 613 ss.), poiché tale
concezione non preclude di ripensare al canone di lealtà in sintonia con le
indicazioni costituzionali. Ne deriva uno spettro di doveri che circoscrivono
l’esercizio del potere e comportano vincoli in positivo. Le varie componenti
ricomprese nella buona fede permettono un incisivo sindacato del giudice, attento
al comportamento per controllare il motivo e la sua coerenza sociale.
In primo luogo, l’idea della lealtà insita nella buona fede consente di
verificare la prevedibilità del licenziamento. Esso non può essere improvviso e
deve essere preceduto da quelle avvisaglie indice di uno sforzo serio di
11
riflessione. Proprio perché questa è categoria della conoscenza, la ricognizione del
datore di lavoro sullo stato dell’impresa e sulle sue prospettive deve essere
percepibile e postula l’approfondimento dei temi significativi. Impregiudicati il
progetto dell’impresa e, di conseguenza, le sue opzioni, la decisione di recedere
deve seguire ad una complessiva valutazione. Poiché la scelta è comunque
traumatica, con il sacrificio estremo dell’interesse del lavoratore, essa deve essere
il frutto di un comportamento proporzionato.
Tali osservazioni non implicano un invito all’attendismo o al ritardo,
poiché, anzi, alcune crisi inducono alla massima celerità. Non ci si deve chiedere
quanto tempo il datore di lavoro debba ponderare prima di licenziare e come ciò
debba avere luogo. Fra l’altro, ciascuna impresa ha suoi percorsi decisionali, in
sintonia con le sue dimensioni, le sue forme di presenza sul mercato, il
collegamento fra il vertice e gli altri collaboratori, i metodi di comunicazione
interna, la circolazione dell’informazione.
Peraltro, il licenziamento deve essere adottato in modo leale. I
comportamenti preparatori possono comprendere verifiche sui metodi di lavoro,
consultazioni sindacali (anche qualora non siano obbligatorie), l’emanazione di
studi circostanziati, colloqui con i lavoratori; spetta al giudice una analisi
empirica, senza che questi si debba lasciare condizionare da impostazioni
precostituite, ma con la piena accettazione di diverse modalità di azione, purché
leali. Tuttavia, in quanto decisione fondata per sua natura su una ricognizione di
fatti, il licenziamento non può essere improvviso e, se mai, deve essere la coerente
conclusione di un ragionamento.
Peraltro, in ossequio ad un fondamentale criterio di lealtà, le avvisaglie del
recesso devono essere comprese per tempo; non vi possono essere una crisi che
sfugga per intero ai prestatori di opere, né una riorganizzazione a loro ignota, né
modificazioni tecnologiche delle quali non siano edotti. In sostanza, lo scopo non
può essere sorprendente, poiché ciò contrasterebbe con il carattere dell’obbiettivo
perseguito e con il suo rivolgersi al destino economico dell’impresa. Questa può
proseguire la sua vita, ma, nella prassi, il cambiamento deve essere percepito.
Quindi, oltre a stabilire se il motivo enucleato sia quello effettivo, il
giudice deve chiarire se la decisione sia stata adottata in modo leale. Mentre un
abile difensore può sempre costruire a posteriori un persuasivo problema
organizzativo ragionando a ritroso, la lealtà deve emergere dagli specifici
12
comportamenti, oggetto di prova diretta. Mentre il controllo sulla bontà della
decisione sposta la riflessione all’interno del progetto del datore di lavoro e segue
la sua descrizione dei problemi, spesso immaginata per la giustificazione della
determinazione assunta, la lealtà mette l’accento su fatti storici che qualificano la
genesi della decisione. Sotto questo profilo, il motivo non è sottoposto ad un
sindacato nel merito, ma per il percorso seguìto. Pertanto, se si utilizza il criterio
di lealtà fino alle sue naturali conseguenze, di fronte al giudice si espone non una
organizzazione comunque confinata in una conoscenza opinabile, ma un rapporto,
con gli eventi che caratterizzano la sua evoluzione.
4. Il licenziamento per riduzione di personale fra costi e valori.
L’elaborazione del motivo di recesso deve essere l’esito di una condotta
complessiva rispettosa delle ragioni del lavoratore e, se lo scopo in sé sfugge al
sindacato del giudice, invece il comportamento dell’impresa soggiace alla sua
cognizione, poiché il giudice stesso si deve occupare del “farsi” della
determinazione, non con riguardo al contenuto, ma alla formazione della volontà.
Qualora la riduzione di personale trovi le sue premesse in una crisi dell’apparato
produttivo od in una svolta tecnologica, è agevole spiegare i prodromi di tali
eventi, che, per loro natura, non possono essere improvvisi e, se mai, riportano a
situazioni note. Ciò non significa invitare l’impresa alla lentezza, poiché la lealtà
si può combinare con la massima celerità. Peraltro, chi è parte di una struttura
deve capire quale sia il destino suo, dei colleghi e dell’organismo intero. Se tale
trasparenza non è garantita, non si rispetta il criterio di buona fede. Quindi, il
sindacato del giudice passa dall’atto in sé all’esercizio del potere e, pertanto, al
comportamento.
Poi, il principio di buona fede implica quello di autoresponsabilità sociale.
Poiché la scelta di assumere è libera, il licenziamento non corrisponde a criteri
solidaristici qualora l’estinzione del rapporto rimedi ad un mero errore strategico
del datore di lavoro. Salvo il caso di una crisi aziendale, che comporta il sacrificio
della pretesa del dipendente, questi deve vedere prevalere le sue ragioni qualora il
recesso sia solo il frutto del pentimento dell’impresa per la sua assunzione.
L’autoresponsabilità sociale impedisce di eliminare le conseguenze
sfavorevoli di una decisione libera dell’impresa ai danni del prestatore di opere.
13
Tale linea di confine non può essere tracciata con una valutazione di costi, ma
deve essere definita con una considerazione dei comportamenti alla stregua di
parametri assiologici, sia pure codificati, come quelli del principio di buona fede.
Infatti, per lo stato di soggezione economica del prestatore di opere, la
responsabilità connessa alla scelta di assumere ricade per intero nella sfera
dell’impresa. Pertanto, in relazione ad un eventuale, successivo licenziamento, si
può parlare di autoresponsabilità sociale in quanto il soggetto deve riparare da sé
(e non a pregiudizio del lavoratore) alle conseguenze dannose dell’originaria
assunzione.
Il riconoscimento della libertà del datore di lavoro nel progettare e nel
realizzare la sua organizzazione non lascia disarmato il prestatore di opere,
perché, a fronte della libertà di stipulare il contratto individuale, opera una
autoresponsabilità che contempera la libertà di iniziativa economica con esigenze
di socialità. Non a caso, il sussistere del giustificato motivo oggettivo presuppone
un quid novi. Se esso manca e se le condizioni sono le stesse del momento della
stipulazione del contratto individuale, allora l’impresa non può pretendere di
cambiare il suo pensiero ed estinguere il rapporto creato per sua scelta. Ad
esempio, la giurisprudenza ricorda il noto tema dei cosiddetti licenziamenti
tecnologici, quindi dovuti al ricorso a moderne risorse.
A tale riguardo, non emergono soverchi problemi a proposito
dell’osservanza del principio di lealtà; infatti, il cambiare delle tecniche
presuppone una modificazione stabile e percepibile, ed è agevole riconoscere le
implicazioni sull’attività di tutti i dipendenti. Poiché, nel caso di recessi per
l’ammodernamento tecnologico, il quid novi è di ovvia consistenza materiale ed è
il risultato di una variazione degli impianti, non è in discussione la trasparenza del
recesso, che fa seguito non solo ad una valutazione su un evento certo, ma ad un
ragionevole periodo di ponderazione.
Si dice che il giudice dovrebbe stabilire il nesso di causalità fra
l’innovazione ed il recesso, e così si intende che il licenziamento deve riguardare
solo dipendenti la cui attività sia stata coinvolta nell’articolazione interna
sottoposta alla modificazione tecnologica. Se mai, emerge un problema di
effettività del motivo addotto. Infatti, l’eterogeneità fra le mansioni eseguite e
l’innovazione tecnica rende irrilevante il motivo enunciato, poiché, a tacere di
14
ogni altra considerazione, esso non può essere ritenuto quello vero, a seguito di un
esame in concreto.
In sostanza, non occorre fare ricorso a nozioni ambigue, come quella del
nesso di causalità, per dimostrare che il motivo deve attenere ai lavoratori
interessati alla trasformazione tecnica. Se mai, si deve controllare che, con
repentine modificazioni dei compiti assegnati non spiegabili altrimenti, il datore
di lavoro non abbia creato in modo artefatto i presupposti per il licenziamento. Sul
diverso piano della componente solidaristica del principio di buona fede, il
ragionamento diventa più articolato. Non è nemmeno il caso di insistere sulla
centralità delle trasformazioni tecnologiche e sulla corrispondente competizione
serrata, basata in primo luogo sull’aggiornamento del patrimonio tecnico.
Pertanto, sarebbe singolare se il criterio di solidarietà impedisse di migliorare il
livello tecnico dell’azienda. Simili innovazioni comportano spesso la riduzione
del personale, come conseguenza dell’economia capitalistica moderna, al limite
con la riqualificazione delle competenze dei dipendenti rimasti.
Anzi, se si guarda al futuro dell’azienda nel medio periodo e si accantona
l’approccio un po’ miope per il quale la tutela dei lavoratori coinciderebbe con la
conservazione dell’assetto preesistente, con una sorta di generale timore per
qualsiasi cambiamento, gli stessi dipendenti dovrebbero accettare non i recessi,
ma almeno le svolte tecnologiche come parte inevitabile del loro destino
professionale. Se questi eventi pongono gravi difficoltà alle persone allontanate,
essi riservano ragionevoli prospettive agli altri, per la corrispondente revisione
dell’azienda, che vuole rimanere nel mercato, senza cedimenti di fronte ai
competitori.
Quindi, se il motivo di recesso deve essere esaminato alla stregua della
buona fede, i licenziamenti tecnologici sono leciti e, anzi, restano strumento
doloroso, ma ragionevole, poiché migliorano l’efficienza, visto il nesso costante
fra acquisizioni tecnologiche, competizione ed attività produttiva, come è tipico di
una società di capitalismo maturo. Pertanto, se il datore di lavoro può innalzare il
livello tecnico della sua struttura, a fronte di questa constatazione il giudice si
deve arrestare.
Nonostante vi sia un netto divario concettuale fra il concepire il
licenziamento per riduzione di personale come un problema di costi e non una
questione di valori in conflitto, da considerare alla stregua del parametro di buona
15
fede, nell’ipotesi delle trasformazione tecnologiche le conclusioni non divergono
sulla base delle differenti tesi. Infatti, sono comunque necessari i licenziamenti.
Lo stesso non si può dire in altre ipotesi, in primo luogo qualora il datore di lavoro
voglia allontanare un dipendente assunto sulla base di una scelta sbagliata e
chiamato ad espletare una attività rivelatasi un inutile appesantimento. In tale
contesto, più frequente di quanto si possa pensare, se il licenziamento è un
problema di costi, esso è legittimo, se si esaminano i valori, si deve giungere alla
conclusione opposta.
5. Il sindacato del giudice sulla legittimità del licenziamento ed il caso del
cosiddetto licenziamento per incremento dei profitti.
Di solito, la giurisprudenza attribuisce scarsa tutela al lavoratore coinvolto
in processi di riorganizzazione che migliorino l’efficienza senza l’incombere della
crisi, per la sola volontà di aumentare i profitti. Se l’intera riflessione della
giurisprudenza ha luogo all’interno dello schema organizzativo, hanno minima
influenza gli obbiettivi ultimi del recesso ed all’impresa basta identificare un
preteso problema collegato alla soppressione del “posto”, se mai mettendo in luce
l’impossibilità del ripescaggio. Proprio in queste situazioni le tesi abituali
mostrano le loro più evidenti difficoltà; l’idea dell’organizzazione non può
mettere a raffronto le ragioni del datore di lavoro e quelle dei prestatori di opere,
perché
l’interesse
dell’organizzazione
coincide
sempre
con
quello
dell’imprenditore e, se questo è egoistico e, comunque, indirizzato al solo
aumento dei guadagni, il recesso è lo stesso giustificato. In sostanza, l’uso della
categoria dell’organizzazione comporta il riferimento ad un sistema di giudizio di
carattere egoistico, e non solidaristico.
Se il fine dell’impresa è ricostruito nella sua complessità, appunto come
obbiettivo ultimo dell’iniziativa, si può distinguere quando il licenziamento sia
preordinato a ridurre od eliminare uno stato di crisi o, all’opposto, quando si
voglia selezionare il personale per incrementare il margine economico. In
entrambi i casi si cerca di rimediare ad una precedente scelta errata o superata,
poiché l’assunzione del collaboratore era superflua o tale si è rivelata, anche se a
distanza di tempo.
16
Però, il motivo non è giustificato in quanto l’errore iniziale o, almeno, la
sopravvenuta inadeguatezza della decisione di assumere devono fare gravare le
conseguenze negative sull’autore, che ha creato il costo – opportunità (v. Ichino
2002, 496 ss.). Il licenziamento non risponde al principio di autoresponsabilità
sociale se l’eliminazione del costo – opportunità è compiuta dall’autore dell’errore
a scapito del dipendente, proprio perché chi sbaglia è vincolato alle sue
determinazioni in nome di criteri di socialità, che limitano il potere di recesso. Il
valore solidaristico prevale su quello del miglioramento dell’efficienza, perché il
diritto del lavoro deve contemperare gli interessi in conflitto e l’errore non può
essere superato in nome del semplice aumento del guadagno, ai danni del
prestatore di opere. Se così fosse, il diritto del lavoro non realizzerebbe la sua
funzione tipica.
Differente è il tentativo dell’impresa di rimediare ad una condizione
patrimoniale avviata sulla pericolosa china del dissesto. In queste ipotesi, viene in
risalto la salvezza dell’intera impresa e, quindi, non l’inesistente interesse
dell’organizzazione, ma le vere e note aspettative degli altri lavoratori occupati e,
al limite, di quelli inoccupati, per i quali la scomparsa dell’azienda eliminerebbe
una futura occasione di collocazione professionale. Invece, qualora il recesso
ambisca al mero ripristino di una astratta efficienza, la piena libertà negoziale
nell’assumere determina una corrispondente autoresponsabilità sociale. Se la
decisione di stipulare si è rivelata inadeguata, le implicazioni gravano sullo stesso
imprenditore.
Non si dica che questa concezione provocherebbe una scarsa capacità di
competizione ed una pericolosa stasi. Se la differenza fra il lecito e l’illecito grava
sul motivo di licenziamento e se questo è da qualificare alla stregua della buona
fede, è illegittimo addebitare al collaboratore l’esito negativo di una assunzione
rivelatasi inopportuna, e nessuna responsabilità vi è per il prestatore di opere, non
solo per la sua debolezza sociale, ma perché l’organizzazione è il disegno
opinabile ed insindacabile del datore di lavoro. Non vi può essere alcuna
riprovazione per l’impresa che abbia assunto in eccesso; però, in tali condizioni,
se non è a rischio il persistere stesso dell’azienda, il rapporto può essere risolto
solo in via consensuale, se mai con opportune forme di incentivazione. Infatti, fra
i due interessi in conflitto deve prevalere quello del lavoratore, e non quello
dell’impresa, che ha comunque creato il problema, aumentando l’organico.
17
Tale impostazione non disincentiva le assunzioni. Se mai si volesse
utilizzare l’istituto dei recessi quale strumento di intervento sul mercato del lavoro
(e tale argomento meriterebbe una apposita considerazione, qui sovrabbondante;
v. F. Carinci 2003, 35 ss.; Liebman 2002b, 378 ss.; Liso 2002, 169 ss.), non si
dovrebbe comunque considerare il regime di validità sostanziale dell’atto, ma, al
limite, quello sanzionatorio. Il licenziamento non è giustificato se mira al
semplice incremento del profitto.
L’idea consueta del giustificato motivo quale portato dell’organizzazione
vuole in larga misura aiutare l’impresa proprio in queste situazioni. Invece, non si
può allontanare senza spesa chi sia stato assunto per una opzione superata dagli
eventi, peraltro fuori dalla crisi. Infatti, il preteso interesse dell’organizzazione
non può occultare le ragioni profonde del licenziamento, che sono anche le più
semplici. Un recesso per la salvezza dell’azienda ed uno per l’incremento del
guadagno sono spesso accostati. Invece, le due fattispecie devono essere
contrapposte, e l’una è legittima, l’altro no.
6. Il diritto del lavoro fra tutela della persona e ragioni dell’economia.
Il problema del sindacato sul motivo di licenziamento per riduzione di
personale si inserisce in un più delicato confronto fra le ragioni del diritto del
lavoro e quelle dell’economia, secondo linee di studio proprie del dibattito recente
(v. Del Punta 2001, 4 ss.; Loi 1999, 547 ss.), non sempre con esiti persuasivi. In
realtà, la crisi del diritto del lavoro trova spiegazione più nella trasformazione
delle modalità organizzative aziendali che nell’obsolescenza teorica degli schemi
tradizionali. Il cambiare dell’azienda e dei suoi metodi può imporre una revisione
anche profonda del sistema di regolazione, ma tali variazioni dipendono da una
causa esterna, quindi dalle trasformazioni della società e dei comportamenti dei
protagonisti. In tale orizzonte, è opinabile parlare di crisi del diritto del lavoro,
come se le sue allegate difficoltà si collegassero a fattori interni. In fondo, come
ricorda Graziano, il diritto postula sempre un incontro fra le idee del legislatore (e,
comunque, delle disposizioni positive) e le condotte umane regolate, i “mores”, i
quali devono trovare una sintesi accettabile con l’impostazione giuridica, salvo
assistere al loro finale, inevitabile prevalere.
18
Nella fase storica attuale, non si percepisce un ripensamento sui
fondamenti del diritto del lavoro, ma, se mai, un suo spiazzamento progressivo
(valutato in modo diverso quanto all’ampiezza ed all’intensità) ad opera dei
”mores” degli imprenditori. Pertanto, le tensioni nella sintesi fra diritto ed
economia trovano la loro motivazione nelle modificazioni subìte dalle tecniche di
produzione.
Troppo spesso si levano toni da “autocritica” sugli obbiettivi e sulla
struttura degli istituti del diritto del lavoro, mentre, all’opposto, con maggiore
senso storico, si dovrebbe ridefinire la regolazione affinché essa sia resa più
adatta, se del caso, alle strategie delle imprese. A dire il vero, queste difficoltà
riguardano nello specifico alcune impostazioni, in particolare quelle che vogliono
rendere il diritto del lavoro un metodo di condizionamento delle iniziative
imprenditoriali.
Non è mancata la tentazione di trasformare i vincoli opposti al datore di
lavoro per la protezione del prestatore di opere in strumenti di limitazione del
potere dell’impresa, con la corrispondente costruzione di un contropotere delle
associazioni sindacali e del giudice, che condividerebbero la responsabilità
dell’esercizio della libertà di iniziativa economica. Tali analisi si sono concentrate
proprio nella ricostruzione del recesso per riduzione di personale, in ordine al
quale si cerca spesso di spingere la valutazione del giudice fino all’intima essenza
dell’organizzazione, come se il giudice potesse stabilire se l’estinzione dell’uno o
dell’altro rapporto corrisponda all’interesse dell’organizzazione stessa. Questa
interpretazione non può essere condivisa, perché, a tacere di altro, confonde la
sfera della conoscenza con quella della volontà.
Lo scopo del diritto del lavoro non è di rendere ragionevoli le strategie
imprenditoriali, ma di porre vincoli a presidio di prevalenti interessi del prestatore
di opere. Ciò non toglie nulla alla natura contrattuale del rapporto e al fatto che
sull’accordo si basano il potere direttivo e la stessa subordinazione (v. Simitis
2001, 61 ss.). Peraltro, i fini aziendali non sono né oggetto del contratto, né
condizionati dalla subordinazione, né, ancora, resi razionali dal diritto del lavoro.
In particolare, in tema di riduzione del personale, il sindacato del giudice non
deve stabilire quando sia ragionevole licenziare, ma se il comportamento
dell’impresa sia coerente con parametri di correttezza.
19
Ne
derivano
due
conclusioni
correlate.
In
primo
luogo,
un
ridimensionamento delle funzioni del diritto del lavoro rende più agevole una
sintesi delle sue ragioni con quelle dell’economia; l’intervento dall’esterno sui
poteri del datore di lavoro comporta la rinuncia ad una razionalizzazione delle
prassi presenti nella vita dell’azienda e, soprattutto, lascia l’impresa arbitra del
suo destino, come deve essere in una moderna economia di mercato, condizionata
da una piena competizione a livello sopranazionale. Di fronte alle sue sfide, il
potere è del datore di lavoro, come accade per la responsabilità relativa, e né
l’uno, né l’altro possono essere condivisi con i soggetti collettivi o con il giudice.
Altro è impedire che l’imprenditore possa nuocere con le sue scelte a valori
prevalenti e per questo tutelati. Però, a tale fine, la discussione si sposta sulla
buona fede nell’intimazione del licenziamento, non sulla razionalità (v. Oppo
2001, 421 ss.).
In secondo luogo, se si ridimensionano le funzioni attribuite al diritto del
lavoro, questo le può perseguire in modo più agevole. Se rinuncia ad essere
strumento di riconduzione a razionalità delle iniziative dei datori di lavoro e si
arresta alla soglia dello spazio di decisione libera dell’impresa, esercitando in
pieno il suo compito di impedire i comportamenti in mala fede, il diritto del
lavoro subisce in grado inferiore l’effetto delle trasformazioni costanti della
società, proprio perché è contenuta l’interferenza fra il sistema giuridico e quello
economico
ed
il
primo
riguarda
il
secondo
dall’esterno.
Questo
ridimensionamento delle ambizioni del diritto del lavoro non implica una
riduzione dell’effettività delle sue previsioni; anzi, la valutazione in termini di
buona fede (e non di razionalità) delle decisioni dovrebbe consentire una
distinzione più agevole dei comportamenti riprovevoli da quelli accettabili, e
dovrebbe facilitare il sindacato del giudice, con esiti più prevedibili. Il diritto del
lavoro non considera la costruzione delle strategie aziendali, ma ne esamina le
conseguenze.
A. Accornero (1999), L’ultimo tabù. Lavorare con meno vincoli e più
responsabilità, Roma - Bari;
P. G. Alleva (2000), I licenziamenti collettivi in prospettiva europea, in
Lav. giur., 608 ss.;
M. V. Ballestrero (1975), I licenziamenti, Milano;
20
S. Brun (2002), Giustificato motivo oggettivo di licenziamento e sindacato
giudiziale, in Quad. dir. lav. e rel. ind., n. 26, 134 ss.;
F. Carinci (2003), Discutendo intorno all’art. 18 dello Statuto dei
lavoratori, in Riv. it. dir. lav., I, 35 ss.;
F. Carinci (2007), Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal
ponte, in Aa. Vv., Il lavoro subordinato, a cura di F. Carinci, tm. I, Il diritto
sindacale, coordinato da G. Proia, Torino, XIV ss.;
M. T. Carinci (2006), Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di
lavoro subordinato, Padova;
F. Carnelutti (1911), Del licenziamento nella locazione d’opere a tempo
indeterminato, in Riv. dir. comm., I, 377 ss.;
F. Carnelutti (1951), Teoria generale del diritto, ed. III, Roma;
G. Cattaneo (1971), Buona fede obbiettiva abuso del diritto, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 613 ss.;
R. Del Punta (1998), Disciplina del licenziamento e nuovi modelli
organizzativi delle imprese, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 703 ss.;
R. Del Punta (2001), L’economia e le ragioni del diritto del lavoro, in
Giorn. dir. lav. e rel. ind., 5 ss.;
R. Del Punta (2002), Il diritto del lavoro tra valori e storicità, in Lav. dir.,
351 ss.;
G. De Simone (2002), Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
l’instabile equilibrio tra le ragioni dell’impresa e i diritti dei lavoratori, in Quad.
dir. lav. e rel. ind., n. 26, 25 ss.;
V. Ferrante (2004), Potere e autotutela nel contratto di lavoro
subordinato. Eccezione di inadempimento, rifiuto di obbedienza, azione diretta
individuale, Torino;
M. G. Garofalo (1985), L’influenza dei valori costituzionali sull’evoluzione
del diritto sindacale negli USA, in Aa. Vv., L’influenza dei valori costituzionali
sui sistemi giuridici contemporanei, a cura di Pizzorusso - Varano, Milano, tm. I,
375 ss.;
M. G. Garofalo – P. Chieco (2001), Licenziamenti collettivi e diritto
europeo, in Aa. Vv., I licenziamenti per riduzione di personale in Europa, a cura
di B. Veneziani – U. Carabelli, Bari, 2 ss.;
G. Giampiccolo (1959), La dichiarazione recettizia, Milano;
21
M. Grandi (1997), “Il lavoro non è una merce”. Una formula da
rimeditare, in Lav. e dir., 557 ss.;
A. Ichino - P. Ichino (1994), A chi serve il diritto del lavoro?, in Riv. it.
dir. lav., I, 487 ss.;
A. Ichino – P. Ichino – M. Polo, L’influenza delle condizioni del mercato
del lavoro regionale sulle decisioni dei giudici in materia di licenziamento, in Riv.
it. dir. lav., I, 19 ss.;
P. Ichino (1996), Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro
maggiorenne, Milano;
P. Ichino (1999), Appunti sul licenziamento per giustificato motivo
oggettivo di licenziamento, in Riv. it. dir. lav., III, 3 ss.;
P. Ichino (2002), Sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di
licenziamento, in Riv. it. dir. lav., I, 475 ss.;
A. Javillier (1996), Recenti orientamenti della Cassazione francese in tema
di licenziamento per motivi economici, in Dir. rel. ind., 153 ss.;
S. Liebman (2002a), Il sistema dei rimedi nella disciplina dei licenziamenti
individuali, in Quad. dir. lav. e rel. ind., n. 26, 37 ss.;
S. Liebman (2002b), La disciplina del licenziamento, in Dir. rel. ind., 378
ss.;
F. Liso (2002), Appunti sulla riforma della disciplina dei licenziamenti, in
Riv. it. dir. lav., I, 169 ss.;
G. Loi (1999), L’analisi economica del diritto e il diritto del lavoro, in
Giorn. dir. lav. e rel. ind., 547 ss.;
G. F. Mancini (1957), La responsabilità contrattuale del prestatore di
lavoro, Milano;
M. Marazza (2002), Saggio sull’organizzazione del lavoro, Padova;
A. Meloncelli (1983), L’informazione amministrativa, Rimini;
L. Mengoni (1965), Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in Aa. Vv., Il
contratto di lavoro nel diritto dei Paesi membri della Ceca, Lussemburgo, 1965,
498 ss.;
M. Napoli (1980), La stabilità reale del rapporto di lavoro, Milano;
M. Napoli (1996), Flessibilità e tutela contro i licenziamenti, in Questioni
di diritto del lavoro (1992 - 1996), Torino, 281 ss.;
22
L. Nogler (2007), La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del
bilanciamento tra i “principi” costituzionali, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 593 ss.;
G. Oppo (2001), Impresa e mercato, in Riv. dir. civ., 421 ss.;
M. Persiani (1966), Contratto di lavoro e organizzazione, Padova;
M. Persiani (2000), Diritto del lavoro e autorità dal punto di vista
giuridico, in Arg. dir. lav., 5 ss.;
U. Prosperetti (1967), Il recesso dal contratto di lavoro ed il principio del
giustificato motivo, in Aa. Vv., Giusta causa e giustificati motivi nei licenziamenti
individuali, Atti del Convegno di Firenze, Milano, 141 ss.;
S. Pugliatti (1957), La trascrizione. La pubblicità in generale, Milano;
S. Simitis (2001), Diritto privato e diseguaglianza sociale: il caso del
rapporto di lavoro, in Giorn. dir. lav. e rel. ind., 61 ss.;
C. Spinelli (1996), Il licenziamento per motivi economici in Francia:
profili legislativi e giurisprudenziali, in Dir. rel. ind., 121 ss.;
F. Stolfa (2004), Giustificato motivo oggettivo di licenziamento: i primi
frutti di un dialogo tra giurisprudenza e dottrina, nota a Trib. Palermo 10
dicembre 2003, in Riv. it. dir. lav., II, 627 ss.;
C. Zoli (2008), I licenziamenti per ragioni organizzative: unicità della
causale e sindacato giudiziale, in Arg. dir. lav., 31 ss..
23