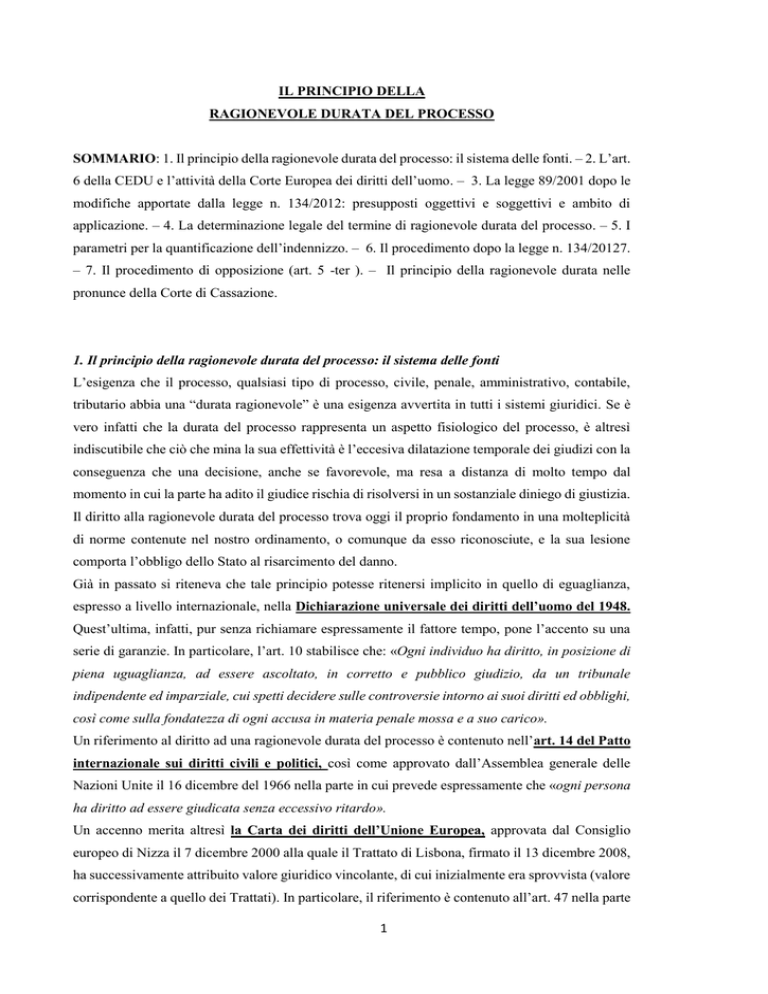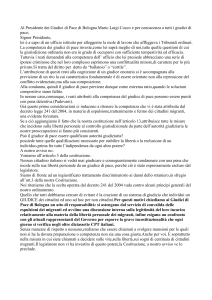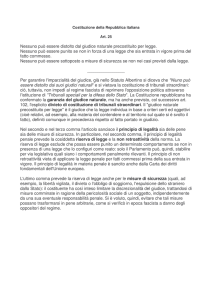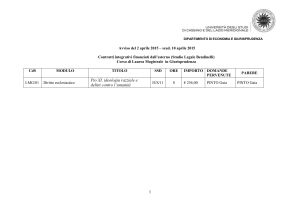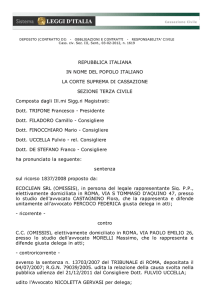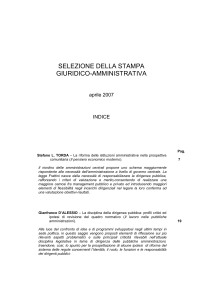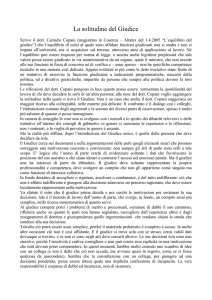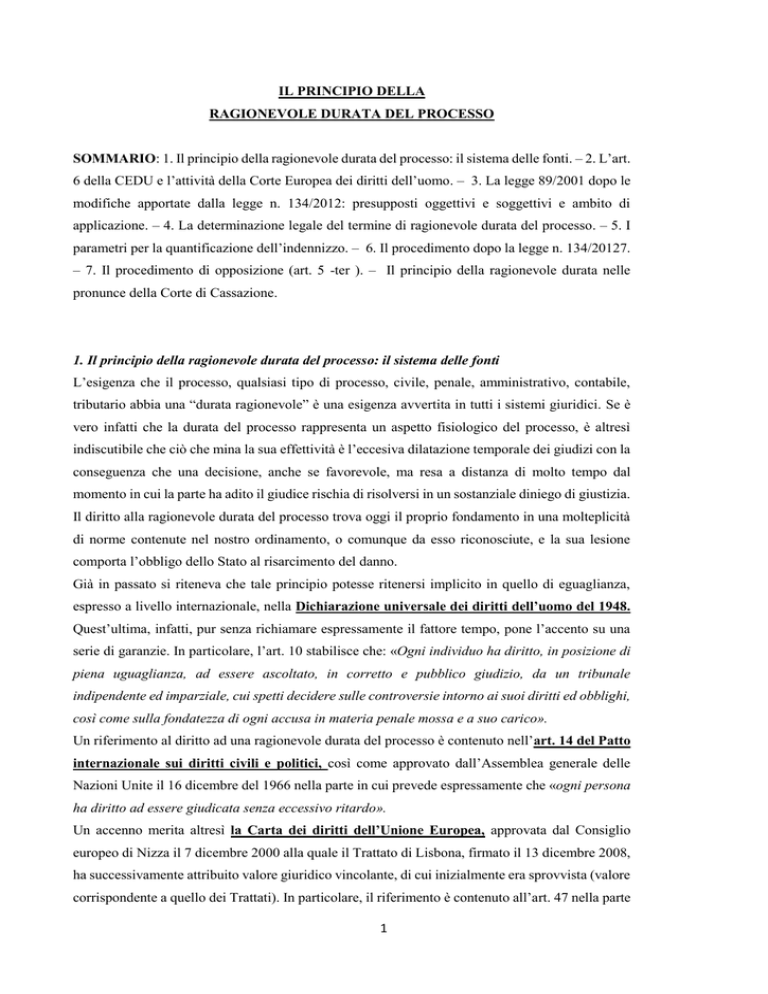
IL PRINCIPIO DELLA
RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
SOMMARIO: 1. Il principio della ragionevole durata del processo: il sistema delle fonti. – 2. L’art.
6 della CEDU e l’attività della Corte Europea dei diritti dell’uomo. – 3. La legge 89/2001 dopo le
modifiche apportate dalla legge n. 134/2012: presupposti oggettivi e soggettivi e ambito di
applicazione. – 4. La determinazione legale del termine di ragionevole durata del processo. – 5. I
parametri per la quantificazione dell’indennizzo. – 6. Il procedimento dopo la legge n. 134/20127.
– 7. Il procedimento di opposizione (art. 5 -ter ). – Il principio della ragionevole durata nelle
pronunce della Corte di Cassazione.
1. Il principio della ragionevole durata del processo: il sistema delle fonti
L’esigenza che il processo, qualsiasi tipo di processo, civile, penale, amministrativo, contabile,
tributario abbia una “durata ragionevole” è una esigenza avvertita in tutti i sistemi giuridici. Se è
vero infatti che la durata del processo rappresenta un aspetto fisiologico del processo, è altresì
indiscutibile che ciò che mina la sua effettività è l’eccesiva dilatazione temporale dei giudizi con la
conseguenza che una decisione, anche se favorevole, ma resa a distanza di molto tempo dal
momento in cui la parte ha adito il giudice rischia di risolversi in un sostanziale diniego di giustizia.
Il diritto alla ragionevole durata del processo trova oggi il proprio fondamento in una molteplicità
di norme contenute nel nostro ordinamento, o comunque da esso riconosciute, e la sua lesione
comporta l’obbligo dello Stato al risarcimento del danno.
Già in passato si riteneva che tale principio potesse ritenersi implicito in quello di eguaglianza,
espresso a livello internazionale, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.
Quest’ultima, infatti, pur senza richiamare espressamente il fattore tempo, pone l’accento su una
serie di garanzie. In particolare, l’art. 10 stabilisce che: «Ogni individuo ha diritto, in posizione di
piena uguaglianza, ad essere ascoltato, in corretto e pubblico giudizio, da un tribunale
indipendente ed imparziale, cui spetti decidere sulle controversie intorno ai suoi diritti ed obblighi,
così come sulla fondatezza di ogni accusa in materia penale mossa e a suo carico».
Un riferimento al diritto ad una ragionevole durata del processo è contenuto nell’art. 14 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici, così come approvato dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 16 dicembre del 1966 nella parte in cui prevede espressamente che «ogni persona
ha diritto ad essere giudicata senza eccessivo ritardo».
Un accenno merita altresì la Carta dei diritti dell’Unione Europea, approvata dal Consiglio
europeo di Nizza il 7 dicembre 2000 alla quale il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2008,
ha successivamente attribuito valore giuridico vincolante, di cui inizialmente era sprovvista (valore
corrispondente a quello dei Trattati). In particolare, il riferimento è contenuto all’art. 47 nella parte
1
in cui sancisce «il diritto di ogni individuo a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente ed imparziale,
precostituito per legge».
Ma la disposizione indubbiamente più importante e, con la quale, per la prima volta è stato
regolamentato il principio della ragionevole durata è quella contenuta nell’art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali siglata a Roma nel 1950 e ratificata
dall’Italia con la legge del 1955. A mente della norma richiamata «Ogni persona ha diritto di farsi
ascoltare, in corretto e pubblico giudizio, da un giudice imparziale ed indipendente, costituito per
legge, cui spetti decidere in tempo ragionevole, sulle controversie intorno ai suoi diritti ed obblighi
di carattere civile, cosi come sul fondamento di ogni accusa mossa a suo carico».
Per completare il quadro delle disposizioni che espressamente fanno riferimento alla durata del
processo ed alla necessità che tale durata sia contenuta in tempi ragionevoli, è doveroso richiamare
la Costituzione italiana. Il pensiero corre all’art. 111 Cost., così come modificato dalla legge
costituzionale del 23 novembre 1999, il quale oggi dispone al suo primo comma che «la
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». A mente poi del novellato
2° comma «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti
a un giudice terzo e imparziale».
L’art. 111 Cost. canonizza il principio del giusto processo ed esplicita i valori ai quali deve ispirarsi
il giusto processo, alcuni direttamente discendenti dal principio di uguaglianza, vale a dire la
circostanza da un lato che il processo deve essere gestito da un giudice che sia in posizione di
terzietà rispetto agli interessi in gioco e dall’altro che in esso deve essere riconosciuta alle parti una
parità di ruoli, sia con riferimento al rapporto tra di loro sia nel rapporto tra di loro ed il giudice.
Immediatamente dopo l’enunciazione di tali valori, l’ultima parte del 2º comma dell’art. 111 Cost.
aggiunge l’affermazione per cui «la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo».
Pertanto, a seguito di tali modifiche il principio in esame è entrato a pieno titolo nella nostra Carta.
Ciò non significa che, prima degli interventi apportati dalla legge del 1999, la nostra Costituzione
non contenesse i principi di cui all’art. 6 della Convenzione. Difatti, non vi è dubbio che il novellato
art. 111 enunciando espressamente il principio della ragionevole durata del processo non ha fatto
altro che ribadire l’immanenza costituzionale di un principio già desumibile dall’art. 24 Cost. tenuto
conto che lo Stato è chiamato non solo ad approntare la tutela giurisdizionale ma, altresì, a fare in
modo che questa sia effettiva nel fermo convincimento che la tutela giurisdizionale è effettiva solo
se la distensione temporale del procedimento (e quindi lo iato esistente tra il momento della
proposizione domanda e quello della decisone) viene contenuta nei limiti strettamente necessari ad
assicurare una decisione conforme a giustizia.
2
2. L’art. 6 della CEDU e l’attività della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
La lettura dei lavori che hanno portato alla novellazione dell’art. 111 Cost. dimostra come, nella
redazione della citata disposizione, il legislatore abbia tenuto bene a mente l’art. 6 della
Convenzione.
Questo, tuttavia, non significa che le due disposizioni sia perfettamente coincidenti avendo,
viceversa, una differente portata.
Orbene, l’art. 111 Cost.,
pur recependo un principio già sancito dall’art. 6 della ridetta
Convenzione, oltre che desumibile dall’art. 24 Cost., ha comunque una portata innovativa, avendo
elevato a rango istituzionale il principio della ragionevole durata del processo. A ben vedere, però,
il citato art. 111 non si rivolge ai singoli cittadini, ai quali non viene riconosciuto un diritto
soggettivo da far valere nei confronti dello Stato alla ragionevole durata del proprio procedimento,
bensì ha come diretto destinatario sia il legislatore, imponendogli di produrre una normativa idonea
a consentire il celere svolgimento dei processi sia i giudici della Consulta ai quali attribuisce il
potere di dichiarare incostituzionali tutte quelle disposizione da cui conseguano tempi processuali
eccessivamente lunghi. Ma, come meglio sarà analizzato successivamente, è norma che si rivolge
altresì al giudice chiamato ad interpretare le norme del nostro sistema processuale.
Diversa, viceversa, è l’ottica dell’art. 6 della Convenzione ove il diritto alla ragionevole durata del
processo è concepito come garanzia soggettiva, nel senso che da esso discende il riconoscimento
in capo a ciascun cittadino degli stati firmatari della Convenzione un vero e proprio diritto
soggettivo alla ragionevole durata del processo. Difatti, accanto al riconoscimento del diritto
all'equo processo la CEDU garantisce un sistema di tutela per il singolo, il quale, in caso di
violazione dell'art. 6 (o di ogni altra disposizione CEDU) potrà presentare ricorso alla Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo per ottenere una equa riparazione (art. 41 della CEDU). La possibilità
di adire la Corte di Strasburgo è però subordinata, ai sensi dell’art. 35 CEDU, ad una condizione di
procedibilità, ovvero il previo esaurimento delle vie interne di ricorso (c.d. principio di
sussidiarietà). È evidente, allora, che Convenzione obbliga direttamente ciascun Stato firmatario
non solo a rispettare le norme in essa contenute ma altresì ad assicurare nell’ordinamento interno
di ciascuno Stato l’effettivo godimento, attuazione e la tutela di tali diritti attraverso la
predisposizione di rimedi efficaci, accessibili ed adeguati rimedi che, con particolare riferimento al
tema in oggetto, garantiscono un processo che abbia una durata ragionevole.
L'Italia ratifica la CEDU nel 1955 e, inserendola nell'ordinamento a livello di legge ordinaria, l’ha
posta quasi nel dimenticatoio. L'inerzia del legislatore innanzi all'obbligo di risultato imposto con
la ratifica della CEDU di adottare rimedi interni efficaci, accessibili ed adeguati affinché il sistema
giudiziario renda giustizia in tempi ragionevoli ha, pertanto, determinato come conseguenza una
enorme mole di ricorsi presentati a Strasburgo contro lo Stato Italiano per violazione della
ragionevole durata. Questo, infatti, l’unico rimedio rimesso al cittadino per denunziare la violazione
dell’art. 6 della citata convenzione, stante l’inesistenza di un rimedio interno giurisdizionale che
3
consentisse al singolo cittadino di far valere la violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo direttamente innanzi al giudice nazionale. Di qui, dunque, a partire dagli anni 80 (ma la
situazione si è aggravata ulteriormente negli anni 90) una valanga di condanne inflitte dalla Corte
europea di Strasburgo contro lo stato italiano per eccesiva lentezza dei processi italiani. In
particolare, con le quattro decisioni del 1999 (caso Bottazzi, Ferrari, di Mauro, e A.P.), la Corte
Europea ha inflitto un duro colpo all’Italia; stante da un lato la perdurante inadempienza dello Stato
italiano a munirsi di un rimedio interno per lamentare la violazione dell’art. 6 e, dall’altro,
l’accumulazione delle violazioni constate, i giudici di Strasburgo sono giunti ad affermare
l’esistenza nel nostro ordinamento di una prassi incompatibile con la convenzione. Tale asserzione,
sotto il profilo processuale, si è tradotta oltre che in una forma di presunzione di colpevolezza dello
Stato italiano, anche in una inversione dell’onere della prova a carico dello stato convenuto che, a
partire da quel momento, avrebbe dovuto dimostrare che non si versava in una situazione
riconducibile alla patologia della pratica incompatibile.
Una svolta nella giurisprudenza della Corte Europea è rappresentata dalla decisione del 26 ottobre
del 2000 sull’affaire Kudla c. Polonia nella quale la Corte, onde evitare di essere sommersa dai
ricorsi e di vedere paralizzata la propria attività, ha rimarcato l’obbligo di ciascuno stato di
predisporre al suo interno uno specifico rimedio di carattere giurisdizionale per denunciare
l’eccesiva durata dei processi, in ossequio al principio di cui all’art. 13 della Convenzione con la
conseguenza che, solo dopo all’infruttuoso esperimento dei mezzi interni, come disposto dall’art.
35 della Convenzione, la parte interessata avrebbe potuto adire la Corte.
La decisione esaminata ha rivestito un ruolo decisivo rappresentando un invito all’Italia di
prevedere un mezzo di ricorso per lamentare la violazione dell’art. 6 Cedu sotto il profilo
dell’eccesiva durata dei processi.
A fronte delle reiterate condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo inflitte all’Italia
per l’irragionevole durata del processo, lo stato italiano è stato costretto ad intervenire varando la
legge 24 marzo del 2001, n. 89 rubricata «Previsione di equa riparazione per violazione del termine
ragionevole del processo» (altrimenti nota come legge Pinto dal nome del senatore che l’ha
proposta) contenente misure acceleratorie ma, invero, solo riparatorie contro l’irragionevole durata
dei processi.
È bene chiarire subito un aspetto al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci: la legge Pinto
non ha risolto tutti i problemi connessi all’irragionevole durata del processo. Anzi, sotto alcuni
profili, ne ha addirittura aggiunti ulteriori.
Da molti definita «disciplina tampone», non vi è dubbio che, con la sua emanazione, il legislatore
è intervenuto su uno soltanto dei problemi attinenti all’eccesiva durata del processo, ossia porre un
argine ai ricorsi italiani alla Corte di Strasburgo, così deflazionando il contenzioso accumulatosi
dinnanzi a quest’ultima. Viceversa, la legge in esame non ha inciso né sulla struttura né sui tempi
del processo, limitandosi ad introdurre un rimedio che, tramite la riparazione, tamponasse agli
4
effetti discorsivi provocati da un sistema processuale evidentemente incapace di garantire la
ragionevole durata del processo.
Trattasi, dunque, di un rimedio di tipo esclusivamente indennitario, inidoneo perciò come tale ad
incidere ex ante sull’organizzazione del sistema giustizia, assicurando il rispetto della durata
ragionevole del processo secondo i dettami della CEDU.
Viceversa, in un’ottica preventiva non esiste attualmente alcun strumento che, in maniera definitiva
e radicale, riesca a fare sì che i processi si svolgano in tempi molto rapidi nonostante sia
indiscutibile che la migliore soluzione in termini assoluti è, in tutti i campi, la prevenzione. Tanto
a differenza di quanto avviene in altri Stati quali l’Austria, la Croazia, la Spagna, la Polonia la
Slovacchia che hanno affrontato in modo adeguato la problematica in esame cercando di combinare
i due tipi di soluzione, così coordinando misure acceleratorie con strumenti prettamente riparatori.
In termini analoghi si è espressa la stessa Corte Europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera,
Scordino c. Italia del 29 marzo 2006) la quale, a più riprese, ha evidenziato che «il miglior rimedio
in assoluto è la prevenzione” e non il risarcimento dei danni, che può indurre a provocare
deliberatamente ulteriori ritardi per conseguire non più una vittoria (ipotetica) nel processo, ma
un titolo (certo) per richiedere il risarcimento per il ritardo».
Il punto è che la l. Pinto, proprio per il fatto che opera soltanto a posteriori, non è ex se in grado di
garantire la risoluzione dell’annoso problema del rispetto del délai raisonnable e – aspetto più grave
– non è probabilmente neppure idonea a realizzare un giusto equilibrio tra l’interesse generale e la
salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo: la qual cosa rappresenta invero un fattore
senz’altro ostativo ad una declinazione dell’effettività della tutela giurisdizionale in termini di
adeguatezza, svuotando, di fatto, il diritto attribuito.
Per di più, la l. Pinto si è mostrata incapace anche sotto l’ulteriore e connesso profilo di arginare il
proliferare dei ricorsi a Strasburgo dovuti alla mancata effettività del c.d. rimedio interno.
Ed infatti, se in primo momento i giudici di Strasburgo avevano considerato la legge Pinto idonea
ad introdurre un rimedio effettivo a disposizione di chi si riteneva vittima di un processo
eccessivamente lungo per ottenere una equa riparazione ben presto però l’ottimismo della Corte
ha subito una forte diminuzione in quanto la maggior parte dei giudici italiani nel decidere le cause
relative agli indennizzi da corrispondere non si uniformava ai principi della Corte di Strasburgo. E
così a pochi casi di sintonia si sono susseguite molte decisioni in contrasto con gli orientamenti di
detti giudici. Ma è stata soprattutto la Corte di Cassazione a creare un vero e proprio braccio di
ferro con la Corte di Strasburgo negando più volte la diretta applicabilità e prevalenza della
giurisprudenza della Corte Europea DI Strasburgo .
L’esistenza di tale giurisprudenza ha quindi indotto la Corte Europea ad un ripensamento dubitando
che il meccanismo introdotto dalla legge pinto avesse le caratteristiche dell’effettività ed efficacia.
Eclatante in questo senso è la sentenza Scordino c. Italia (decisione n. 36813/97 del 27 marzo
2003) che ha dichiarato ricevibile il ricorso Scordino c. Italia anche sotto il profilo attinente alla
5
irragionevole durata del processo nonostante che i ricorrenti avessero omesso di impugnare il
decreto innanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, sotto il profilo del previo esperimento delle
vie di ricorso interno da parte dei ricorrenti, la Corte Europea di Strasburgo, dopo aver ribadito che
la ragione d’essere della regola del previo sta nel principio di sussidiarietà della giurisdizione
internazionale (in base al quale gli stati possono essere chiamati a rispondere dei loro atti dinanzi
ad un organismo internazionale solo dopo aver avuto la possibilità di rimediare essi stessi alla
presunta violazione), ha chiarito che tale regola non ha carattere assoluto e che il rimedio nazionale
deve essere sufficientemente certo e deve mantenere un notevole gradi di accessibilità ed effettività.
E quindi i ricorrenti possono considerarsi esonerati dall’onere di preventivo esperimento se i loro
reclami sono destinati all’insuccesso in quanto esiste all’interno dello stato una costante
giurisprudenza loro sfavorevole.
Sempre in quella occasione la Corte Europea di Strasburgo ha evidenziato che non è sufficiente che
le autorità nazionali abbiano riconosciuto esplicitamente (o in sostanza) la violazione della
convenzione ma è necessario che la vittima abbia ottenuto una riparazione adeguata per il
pregiudizio sofferto, con la conseguenza che solo quando queste due condizioni sono soddisfatte la
natura sussidiaria del meccanismo di protezione della Convenzione impedisce l’esame da parte
della Corte.
Ancora, la Corte Europea è stata costretta a intervenire nuovamente per stigmatizzare
l'irragionevole durata del tempo necessario alle vittime per ottenere concretamente il versamento
delle somme loro riconosciute al termine del procedimento ex l. Pinto.
Oggi infatti si assiste al fenomeno della cd. «Pinto sulla Pinto», cioè alla richiesta di risarcimento
per il ritardo nella definizione non solo della prima causa, ma anche della causa sul ritardo, in una
logica che ingenera abusi processuali.
Ne è prova il fatto che le relazione che inaugurano gli ultimi anni giudiziari rilevano come ulteriore
motivo di crisi del sistema giustizia il costo economico derivante dal risarcimento dei danni per
l’eccessiva durata dei processi, definito di recente dal Presidente della Repubblica «abnorme» e
«intollerabile».
L’ incremento dei costi derivanti dalla cd. Legge - Pinto continua ad essere esponenziale e
allarmante: peraltro, nella maggior parte dei casi, lo Stato non è in grado di adempiere al debito
derivante dai provvedimenti di condanna delle varie Corti d’Appello, con la conseguente che cresce
il numero delle procedure di pignoramento presso il Ministero della Giustizia.
E così, al fine di risolvere taluni dei problemi originati dalla previgente disciplina, il legislatore è
intervenuto nel 2012 con la l. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle domande proposte a partire
dall’11 settembre 2012), con la quale, accogliendo i suggerimenti della dottrina, ha in buona parte
riscritto la normativa contenuta nella l. 89/2001, risolvendo, seppure solo in parte, taluni problemi
originati dal sistema previgente.
6
3. La legge 89/2001 dopo le modifiche apportate dalla legge n. 134/2012: presupposti oggettivi e
soggettivi e ambito di applicazione
Innanzitutto, il decreto sviluppo ha lasciato immutati i presupposti per richiedere l’equa
riparazione: espressamente richiamati nell’art. 2 rubricato “Diritto all'equa riparazione”. La logica
cui si impronta la riforma è la medesima che aveva pervaso la l. 89/2001: introdurre un filtro ai
ricorsi diretti alla Corte di Strasburgo, al duplice scopo di dare attuazione all’obbligo di ciascuno
degli Stati membri di apprestare, ex art. 13 CEDU, un rimedio interno contro la violazione di uno
dei diritti fondamentali contemplati dalla Convenzione e di deflazionare il contenzioso dinanzi alla
Corte stessa che, a causa dell’elevato numero di ricorsi italiani pendenti, correva il serio rischio di
ingolfarsi.
La domanda di equa riparazione resta quindi proponibile alla presenza di due presupposti:
1) l’irragionevole durata del processo: sotto tale profilo, il legislatore italiano mostra di dare
rilevanza esclusivamente alla violazione dell’art. 6 della Convenzione, non menzionando né le altre
situazioni tutelate dalla CEDU né peraltro l’art. 111 Cost. In definitiva, il legislatore se da un lato
riconosce il diritto di ciascun soggetto alla ragionevole durata del processo, dall’altro lato, rimarca
l’obbligo dello Stato di organizzare il sistema giudiziario in modo tale da assicurare una durata
ragionevole dei procedimenti. Trattasi, in altri termini, di una obbligazione di risultato, nel senso
che lo Stato si riconosce responsabile avanti a chiunque delle disfunzioni della macchina giustizia
nel suo complesso per ciò che concerne la durata del processi, a prescindere da specifiche violazioni
del dovere di diligenza del singolo magistrato.
Orbene, con riferimento a tale presupposto, il primo problema affrontato in dottrina come in
giurisprudenza è stato quello attinente alla natura del rimedio in esame. In particolare, ci si chiesti
se il diritto alla riparazione dei danni riconosciuto dalla legge Pinto possa essere ricondotto nella
figura del diritto al risarcimento del danno per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. o, se
viceversa, debba ricomprendersi nella diversa figura dell’indennizzo da attività illecita tenuto
conto l’operatività di tal diritto si ricollega alla durata non ragionevole del processo a prescindere
da una condotta dolosa o colposa del giudice o di suoi ausiliari o di altra autorità.
Al riguardo, la dottrina dominante, sostenuta da una parte della giurisprudenza (cfr., in particolare,
Cass. 8 agosto 2002, n. 11987), discostandosi dall’orientamento adottato al livello europeo dalla
Corte di Strasburgo, è dell’avviso che i richiami contenuti nella stessa legge all’«equità» nonché al
«limite delle risorse disponibili», oltre che l’ utilizzo dell’espressione «indennizzo» confermino la
natura indennitaria della riparazione. Secondo tale orientamento è pertanto esclusa una integrale
riparazione dei pregiudizi conseguenti all’eccesiva durata del processo, mirando il rimedio in esame
unicamente a fornire una equa riparazione. Difatti, l’equa riparazione nasce dal protrarsi oltre una
durata ragionevole della attività giudiziaria che per effetto di tale lentezza non si trasforma in
attività illecita, attribuendo viceversa soltanto il diritto in capo al soggetto leso di ottenere una equa
riparazione.
7
2) esistenza di un danno, patrimoniale (che, secondo le tradizionali regole probatorie dettate
dall’art. 2967 c.c. deve essere provato dall’istante) e non patrimoniale. Prima dell’intervento delle
sezioni unite nel 2004, fortemente dibattuta è stata la querelle attinente alla prova del danno non
patrimoniale, essendo controverso se il predetto potesse considerarsi in re ipsa. Orbene, almeno
inizialmente, la Corte di Cassazione, discostandosi dalla consolidata giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, richiedeva la prova del danno non patrimoniale, sia nella sua quantificazione che nella
sua esistenza, in quanto «il diritto alla ragionevole durata del processo non era considerato un diritto
fondamentale della persona direttamente tutelato da norme costituzionali ma trovava la sa fonte a
livello di legge ordinaria» (Cass. 8 agosto 2002, n. 11987).
Detto contrasto giurisprudenziale è stato superato con l’intervento delle Sezioni unite che, con
quattro sentenze gemelle, hanno ricomposto le divergenze della giurisprudenza nazionale rispetto
a quella europea, dando così nuova linfa al rimedio interno (Cass. 26 gennaio 2004 n. 1338, 1339,
1340, 1341)
Ritornando sui loro passi e correggendo il loro precedente orientamento, i giudici nazionali hanno
precisato che il danno non patrimoniale «è una conseguenza presunta della violazione della
ragionevole durata del processo e che quindi esso non necessita di alcun sostegno probatorio
relativo al singolo caso ed il giudice deve ritenerlo sussistere ogniqualvolta non ricorrano nel caso
concreto le circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato
subito dal ricorrente».
La novella del 2012 non ha intaccato altresì l’ambito di applicazione di questo rimedio.
Sicché, anche all’indomani di detto intervento, il rimedio in esame continua a trovare applicazione
con riferimento a tutte le controversie di cui all’art. 6 della Convenzione che a sua volta riconosce
il diritto del singolo ad ottenere che la causa sia decisa entro un termine ragionevole in relazione
alle controversie che vertano sia sui diritti ed obblighi di natura civile (anche qualora sia interessata
la pubblica amministrazione) sia sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi
confronti, facendo così chiaro riferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale.
Tra le controversie non di competenza del giudice ordinario che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha più volte riconosciuto come di carattere civile, e che quindi rientrano ugualmente
nell’ambito di applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, vi sono controversie che il nostro
ordinamento attribuisce alla giurisdizione del giudice speciale amministrativo. In particolare, la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto natura civile ai procedimenti dinanzi al giudice
amministrativo perché essi possono costituire il presupposto per agire dinanzi alla giurisdizione
ordinaria civile per il risarcimento dei danni. Ma, addirittura, ha esteso l’applicabilità dell’art. 6
della Convenzione (e quindi indirettamente della legge Pinto) anche ai procedimenti dinanzi ai
giudici amministrativi italiani ove si faccia questione di interessi legittimi. Ciò che conta, per i
giudici di Strasburgo, è lo sviluppo di una lite, seria e rilevante, contro l’amministrazione, con cui
si lamenti la lesione dell’affidamento del soggetto privato sulla possibilità di veder riconosciuto un
8
proprio diritto. Si precisa che con legge n. 133/2008, "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria", è stata prevista come condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione,
l’istanza di prelievo: trattasi di un atto di parte che il difensore presenta per segnalare la presenza
di un fatto sopravvenuto che renda necessario decidere urgentemente il ricorso. L'istanza è
effettuata al presidente del T.A.R o della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato il quale
decide discrezionalmente sul suo accoglimento. Per quel che attiene ai procedimenti tributari, il
diritto all’equa riparazione in materia di procedimenti tributari può trovare applicazione
limitatamente alle controversie attribuite al giudice tributario riferibili alla materia civile nel senso
che riguardano pretese che non investono la determinazione del tributo, ma aspetti consequenziali
(ad esempio, un credito di imposta non contestato) o alla materia penale, intesa in senso ampio,
come comprensiva delle controversie relative all’applicazione di sanzioni tributarie, se
commutabili in misure detentive ovvero se, per la loro gravità, siano assimilabili sotto il profilo
dell’afflittività ad una sanzione penale (Cass. 15 luglio 2008, n. 19367).
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di pronunciarsi anche sulla durata dei
processi in materia pensionistica attribuiti alla giurisdizione della Corte dei conti. E poiché non è
sorta incertezza circa la loro sottoposizione alla regola dell’art. 6, par. 1, della Convenzione, non
c’è dubbio che essi, in forza del richiamo operato dall’art. 2, 1° comma, rientrino nell’ambito di
applicazione della legge n. 89/2001. L’eccessiva durata può venire ipotizzata pure relativamente ai
procedimenti dinanzi ai giudici della Consulta, specie quando abbiano ad oggetto la verifica della
legittimità di una norma da applicare in altro procedimento dove è insorto il dubbio circa la sua
costituzionalità.
Viceversa, non si ritiene invece che possa dar luogo all’equa riparazione di cui alla legge Pinto
l’eccessiva durata del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso in questione
non ha infatti carattere contenzioso ma costituisce un rimedio straordinario di natura amministrativa
che può essere coltivato, a discrezione del ricorrente, in alternativa ai canali giurisdizionali. Infine,
la legge Pinto non si applica, ovviamente, all’arbitrato, che costituisce una alternativa, normalmente
veloce, alla giurisdizione statale. (Cass. 13/02/2014, n. 331; Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2014 n.
143).
Per quanto riguarda, invece, il profilo soggettivo, resta fermo che il diritto all’equa riparazione ex
art. 2 ss. l. 89/01 possa essere fatto valere solo dai soggetti (persone fisiche od enti collettivi che
siano) che abbiano assunto — e con riferimento al periodo di tempo in cui abbiano assunto — la
qualità di parte nel procedimento di cui si deduca la irragionevole durata (o, iure successionis, dagli
eredi in ragione della quota ereditaria)
4. La determinazione legale del termine di ragionevole durata del processo
9
Se dunque sono rimasti invariati i presupposti, la l. 134/2012 ha tuttavia apportato molteplici novità
sul piano della disciplina sostanziale muovendosi essenzialmente in tre direttrici:
1) la rigida determinazione legale del termine di ragionevole durata del processo;
2) i criteri per determinare l’effettiva violazione del délai raisonnable;
3) lo svolgimento del procedimento di equa riparazione.
Innanzitutto, il legislatore del 2012 ha fissato dettagliatamente i tempi di durata ragionevole del
giudizio, stabilendo all’art. 2, comma 2-bis, un lasso temporale entro il quale il termine di
ragionevole durata del processo ex art. 6, par. 1, CEDU può dirsi rispettato, termine differente a
seconda che a venire in rilievo sia il processo di cognizione, quello esecutivo oppure quello
fallimentare.
Difatti, in relazione al processo di cognizione, si considera ragionevole il termine che non eccede
la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di
legittimità (La norma nulla dispone circa la durata dell’eventuale giudizio di rinvio conseguente
alla cassazione della sentenza, ma, in linea con la giurisprudenza di Strasburgo, è ragionevole
ritenere che, in caso di rinvio, la durata per dirsi ragionevole non debba eccedere il biennio):
Oggi, dunque ci ritroviamo davanti ad una rigida fissazione del parametro temporale al di sotto
della quale non è possibile configurare una violazione dell’art. 6.
In altri termini, la formulazione della disposizione, nel fissare una soglia di durata ragione al di
sotto della quale non è possibile configurare una violazione dell’art. 6, impedisce ogni valutazione
della peculiarità della causa principale.
Quanto al procedimento di esecuzione forzata, cui deve ritenersi assimilabile il giudizio di
ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, la durata è fissata in tre anni, ovvero, in sei
nell’ipotesi di procedimento concorsuale. Anche a questo proposito, le «soglie» introdotte dal d.l.
83/12 appaiono eccessivamente rigide e non del tutto rispondenti agli orientamenti
giurisprudenziali formatisi nel vigore del testo originario della legge Pinto . Quanto al primo
aspetto, è indiscussa infatti l’esistenza di procedure esecutive (come, per es., quelle di sfratto per
morosità) per le quali non può considerarsi giustificata, in linea di principio, una durata triennale
(nel senso che, ai fini dell’applicabilità dell’istituto dell’equa riparazione di cui alla c.d. legge Pinto,
la durata ragionevole di un procedimento di esecuzione di sfratto per morosità relativo a un
immobile abitativo può valutarsi in mesi otto, v. App. Genova 14 giugno 2006); con riferimento,
invece, all’esecuzione di un provvedimento di rilascio per finita locazione, cfr. App. Trento 15
marzo 2005, nel senso che può considerarsi ragionevole un tempo di circa un anno, tenuto conto
della necessità di contemperare le contrapposte esigenze di proprietario e conduttore); quanto alle
procedure concorsuali, nel previgente assetto normativo, la Corte di cassazione ha individuato in
cinque anni la durata ragionevole di una procedura fallimentare di media complessità (elevabile a
sette anni nel caso in cui il procedimento risulti particolarmente complesso, in quanto comportante
un impegno particolare nell’accertamento del passivo, nella liquidazione dell’attivo e nella gestione
10
del contenzioso, in ragione dell’elevato numero dei soggetti falliti, della grande quantità dei
creditori, della natura delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, dalla proliferazione di
controversie giudiziarie innestatesi nella procedura fallimentare, dell’entità del patrimonio da
liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto.
Il comma 2 bis del novellato art. 2 l. 89/01 specifica poi, recependo quanto elaborato dalla
giurisprudenza sul punto, che (a seconda della forma prevista per la proposizione del giudizio), ai
fini del computo della durata, il processo presupposto «si considera iniziato con il deposito del
ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione». Quanto alla
procedura fallimentare, va tuttavia precisato che il dies a quo della durata, mentre per il fallito
coincide con la sentenza dichiarativa del fallimento, per i creditori insinuati al passivo è segnato
dalla proposizione della relativa domanda di insinuazione.
Per quel che riguarda il processo penale, stabilendo che esso «si considera iniziato con
l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando
l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari», la nuova
disciplina si discosta, ancorché solo in parte, dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità:
essa, infatti, esclude in radice dall’ambito di valutazione del giudice, ai fini della legge Pinto, la
durata delle indagini preliminari, laddove nel precedente assetto normativo, pur dovendosi di regola
far coincidere il dies a quo del processo penale con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del
pubblico ministero, la durata delle indagini preliminari veniva ritenuta computabile per l’indagato,
ogniqualvolta egli avesse avuto (e a partire dal momento in cui avesse avuto) concreta notizia della
pendenza del procedimento nei suoi confronti (con conseguente applicabilità, in tal caso, della l.
89/01 anche nell’ipotesi di procedimento concluso con un provvedimento di archiviazione).
Nuova, rispetto al panorama giurisprudenziale formatosi nell’applicazione del testo originario
della l. 89/01, risulta, nella sua assolutezza, anche la regola introdotta dal novellato comma 2 quater
dell’art. 2, secondo la quale, ai fini del computo della durata del processo presupposto, «non si tiene
conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a
decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa» .Sembra ovvio,
peraltro, che la stessa regola debba valere anche nel caso di interruzione del processo.
La disposizione che fissa i parametri aritmetici per la determinazione ragionevole o meno del
processo rappresenta tuttavia una norma di carattere generale che deve poi conciliarsi con quella
che è stata definita una clausola di chiusura inserita nel comma 2 ter a mente del quale «si considera
comunque rispettato il termine ragionevole di durata se il giudizio viene definito in modo
irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni».
Si coglie, così, una ulteriore novità della riforma, perché se nel sistema anteriore la domanda di
equa riparazione poteva proporsi anche in pendenza del procedimento che aveva originato la
(presunta) violazione del termine di ragionevole durata, attualmente la proponibilità di tale
domanda presuppone, viceversa, l’irretrattabilità della decisione: in questo senso depongono sia la
11
nuova formulazione dello stesso art. 4, che non prevede più (a differenza di quella originaria) la
possibilità di proporre la domanda di equa riparazione «durante la pendenza del procedimento …»
presupposto, sia le disposizioni in base alle quali il giudice deve tenere conto, sotto vari profili,
dell’esito del procedimento presupposto, sia ai fini del riconoscimento di un equo indennizzo
(comma 2 quinquies del novellato art. 2 l. cit.), sia, comunque, ai fini della sua determinazione in
concreto (art. 2 bis l. cit., aggiunto dal d.l. 83/12). La necessità di attendere la conclusione del
procedimento presupposto non espone, peraltro, a rischio di estinzione per prescrizione l’eventuale
diritto della parte all’equa riparazione per il danno subìto a causa della irragionevole durata del
procedimento cui abbia preso parte, atteso l’ormai consolidato orientamento della corte di
legittimità circa la impossibilità di far decorrere la prescrizione prima della scadenza del termine
semestrale di decadenza di cui all’art. 4 l. 89/01 (Tale orientamento ha trovato recentemente
conferma nella sentenza 2 ottobre 2012, n. 16783, resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite).
Tuttavia, un’interpretazione letterale di quest’ultima disposizione potrebbe condurre al risultato
paradossale di dover considerare rispettoso del principio della durata ragionevole anche un processo
svoltosi in unico grado che, pur non presentando elementi di complessità, si sia ingiustificatamente
protratto ben oltre il termine ordinario di tre anni (purché definito in modo irrevocabile nel volgere
di sei anni). In quest’ottica, appare senz’altro preferibile una sua interpretazione sistematica e
costituzionalmente orientata, che ne limiti il campo di applicazione alle ipotesi in cui il processo
presupposto si sia articolato in più gradi di merito e di legittimità.
Del resto, già prima delle recenti modifiche sia la giurisprudenza europea che quella di cassazione
erano ferme nel ritenere che la valutazione della ragionevolezza della durata di un processo va
effettuata con riferimento al giudizio nella sua interezza, senza cioè la possibilità di estrapolare da
esso sue singole fasi o gradi la cui durata abbia eventualmente superato i parametri elaborati dalla
corte di Strasburgo, se il processo sia stato comunque definito in un arco di tempo da reputarsi
ragionevole in base a tali parametri. Un diversa interpretazione sarebbe in contrasto con il
precedente comma che, al contrario, continua a prevedere termini specifici per i vari gradi di
giudizio (Cfr. Cass. 4 luglio 2011, n. 14534, cit.).
In altri termini, questa ultima disposizione recepisce formalmente l’indirizzo giurisprudenziale che
già prima dell’entrata in vigore delle anzidette modifiche stigmatizzava la frazionabilità del credito
all’indennizzo per il ritardo sottolineando la necessità di una valutazione globale ed unitaria del
processo articolato in più fasi, un orientamento che, in concreto escludeva quindi l’ammissibilità
di istanze dirette a richiedere una volta concluso il processo l’indennizzo per la durata eccesiva di
una sua singola fase nonostante il tempo complessivamente impiegato risultasse congruo rispetto
ai parametri perché compensato dalla rapidita delle fasi successive.
Ed appunto in questo senso si esprime la prima pronunzia di merito che risulta si sia occupata della
questione: v. App. Milano, decr. 11 dicembre 2012 inedita, ove si osserva che, considerate «le
conseguenze paradossali di un’acritica applicazione letterale del novellato art. 2, comma 2 ter, l.
12
cit., la norma va… interpretata, secondo una lettura costituzionalmente e convenzionalmente
orientata (oltre che coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla
questione con riferimento alla previgente disciplina in materia, che il legislatore della riforma
sembra avere inteso recepire), nel senso che: a) qualora il giudizio presupposto si sia articolato in
più gradi, non si può limitare la domanda né procedere a una valutazione frazionata di ciascun
grado, dovendosi invece operare una valutazione unitaria e complessiva dell’intero giudizio; b) la
mera violazione del termine di fase non lede il diritto della parte quando il termine ragionevole di
durata complessiva del giudizio (che, come si è detto, il legislatore ha oggi fissato in sei anni)
risulti comunque rispettato». Cass. civ., sez. VI, 06-11-2014, n. 23745. In tema di equa riparazione
per violazione del termine ragionevole del processo, l’art. 2, 2º comma ter, l. 24 marzo 2001 n. 89,
secondo cui detto termine si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo
irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una
valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai
processi che si esauriscono in unico grado.
Sul punto è altresì intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 36 del 2016, in
relazione al termine complessivo di sei anni, previsto dall’art. 2, comma 2-ter, ha precisato che il
termine di sei anni previsto da tale norma, e che si considera “comunque” ragionevole, esigerebbe
che
il
processo
si
sia
svolto
in
tre
gradi.
Con la anzidetta pronuncia, la Corte Costituzionale ha altresì affrontato il problema della ipotetica
applicabilità dell’art. 2, comma 2 bis, anche ai procedimenti previsti dalla legge n. 89 del 2001,
escludendone l’estensione trattandosi di giudizi articolati su due gradi di giudizio.
Nella sentenza, la Corte osserva che nella giurisprudenza europea è consolidato il principio
secondo cui “lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all’equa riparazione del danno
da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure
ordinarie”, con la conseguenza che l’art. 6 della CEDU, il cui significato si forma attraverso il
reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza europea sui casi di specie, “preclude al
legislatore nazionale, che abbia deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata
dei processi ai fini dell’equa riparazione, di consentire una durata complessiva del procedimento
regolato dalla legge n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti
civili di cognizione, anziché modellarla sul calco dei più brevi termini indicati dalla stessa Corte
di
Strasburgo
e
recepiti
dalla
giurisprudenza
nazionale”.
Ancora, in detta occasione, la Corte Costituzionale ha invece ritenuto non fondata l’ulteriore
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui determina in un
anno la ragionevole durata del giudizio di legittimità previsto dalla legge n. 89 del 2001, ritenendo
che il termine annuale scelto dal legislatore “è conforme alle indicazioni di massima provenienti
dalla Corte europea e recepite dalla giurisprudenza nazionale”, e rilevando altresì che “la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione concernente la durata del processo di
13
primo grado fa sì che la ragionevole durata complessiva di un procedimento regolato dalla legge
n. 89 del 2001, in concreto articolatosi su due gradi di giudizio, sia inferiore a quella stabilita per
gli altri procedimenti ordinari di cognizione, e comunque possa essere contenuta nel tetto di due
anni, in conformità agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost”.
Dunque, all’esito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui
si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001 ed alla luce
delle ulteriori precisazioni contenute nella citata sentenza della Corte Costituzionale, la ragionevole
durata del giudizio di equa riparazione dovrà ora essere ravvisata nel termine di un anno per l’unico
grado di merito ex lege Pinto e di un anno per il giudizio di Cassazione, così per un tempo di durata
complessiva di entrambi i gradi di giudizi non superiore a due anni.
La decisione di limitare la proponibilità del ricorso ex l. Pinto solo ad un momento successivo
all'intervenuta definizione del giudizio presupposto risponde all'esigenza di ridurre il carico delle
domande proposte alle Corti d'appello e di evitare altresì la possibilità per il medesimo ricorrente
di frazionare in più volte la propria pretesa, con evidente aggravio per le risorse statali destinate
all'equa riparazione. Nella stessa ottica si pongono anche altre disposizioni introdotte dal d.l. n. 83
del 2012 che, se da un lato snelliscono la procedura di decisione dei ricorsi, dall'altro prevedono
l'introduzione di alcuni paletti che ne rendono indubbiamente più difficile e onerosa la
proposizione .
Per quanto apprezzabile è l’intento del legislatore, la rigidità della previsione rischia di lasciare
scoperte situazioni particolarmente gravi e di porsi soprattutto rottura con lo standard seguito dalla
corte di Strasburgo.
Ed infatti, a poco meno di un anno dall’entrata in vigore, la Corte di Appello di Bari con
provvedimento del 18 marzo 2013, giudice, dott. Gaeta, ha sottoposto alla Corte costituzionale la
questione della legittimità del nuovo testo dell'art. 4 della l. Pinto, come risultante dalla sostituzione
operata dall'art. 55 comma 1, lett. d).
Secondo il giudice a quo il nuovo testo dell'art. 4 si porrebbe innanzitutto in contrasto con l'art. 3
Cost., in quanto l'indennizzo può essere oggi richiesto solamente da chi lamenti l'eccessiva durata
del processo presupposto che sia già terminato, mentre non può agire per l'equa riparazione chi
lamenti l'eccesiva durata di un processo che non si sia ancora concluso, malgrado tale durata sia già
irragionevole ai sensi della disciplina vigente. Giustamente la Corte d'appello evidenzia come in
questo secondo caso «la lesione del diritto alla ragionevole durata risulti ictu oculi più grave».
Secondo il giudice remittente risulterebbe altresì violato l'art. 111 Cost., in quanto il diritto ad agire
per l'equa riparazione costituirebbe ormai «una forma indiretta del diritto alla ragionevole durata
del processo presupposto».
Da ultimo, con l'ordinanza è stata altresì dedotta la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in
relazione all'art. 6, paragrafo 1 della CEDU, in quanto il rimedio costituito dalla l. Pinto, pur
essendo di tipo esclusivamente indennitario, risulta comunque valutato con favore dalla Corte EDU
14
purché lo stesso sia dotato del carattere dell'effettività e consenta la massima conformazione
possibile dei giudici nazionali alla CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo.
La questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale con sentenza del 25 febbraio 2014, n. 30.
Ebbene in questa decisione la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale sollevata per due ordini di ragioni.
In primo luogo la Corte rileva come l’attuale assetto normativo all’indomani delle modifiche
intervenute nel 2012 imponga comunque di attendere la conclusione del giudizio presupposto per
poter valutare sia l'an che il quantum dell'indennizzo richiesto dai ricorrenti.
Sotto questo primo profilo è necessario rilevare come gran parte delle condizioni ostative al
riconoscimento dell'equa riparazione, ovvero conformative dell'ammontare della stessa, non siano
in realtà ipotesi che inibiscano a livello europeo la presentazione del ricorso alla Corte EDU o,
comunque, il risarcimento “pieno” del danno da durata non ragionevole.
In secondo luogo, la Corte ritiene che comunque l'intervento additivo richiesto «non sarebbe a rime
obbligate in ragione della pluralità di soluzioni normative configurabili a tutela del principio della
ragionevole durata del processo».
Lascia invece perplessi, nel caso specifico, l'affermazione secondo cui l'intervento additivo
risulterebbe comunque precluso «in quanto vi sarebbero più soluzioni normative configurabili dal
legislatore per superare l'illegittimità accertata dalla Corte».
Invero, come evidenziato in dottrina, il superamento dell'incostituzionalità difficilmente potrà
avvenire tramite un intervento che non preveda, comunque, la possibilità per il ricorrente di agire
anche nell'ipotesi in cui il giudizio principale, pur essendo ancora in corso, abbia già superato il
limite della durata ragionevole.
In conclusione, la pronuncia sembra lasciare aperti troppi problemi rendendo assai concreto il
rischio che i cittadini italiani vittime di processi eccessivamente lunghi ma non ancora conclusi (e
non sono pochi ...), decidano di rivolgersi nuovamente alla Corte EDU lamentando la mancanza di
un rimedio interno efficace. Tale mancanza è oggi peraltro sancita esplicitamente proprio dalla
sentenza della Corte costituzionale qui esaminata, che riscontra il vulnus e lamenta la mancanza di
un rimedio effettivo.
Dopo aver definito “aritmicamente” i tempi di durata ragionevole del processo, l ’art. 2, comma 2
bis della Legge Pinto specifica altresì che il giudice, al fine di accertare la violazione, è tenuto ad
esaminare alcuni particolari elementi:
- la complessità del caso: come desumibile dall’elaborazione della giurisprudenza europea, la
complessità del caso deve essere valutata avuto riguardo sia i fatti della causa sia alle questioni di
diritto sollevate. Per quel che attiene queste ultime, occorre valutare quali e quante siano le
questioni giuridiche da trattare, la loro complessità, la novità e la mancanza di precedenti,
l’esistenza di un testo legislativo oscuro sulla base del quale si sono formati orientamenti
contrastanti, eccezioni preliminare eventualmente sollevate, la loro fondatezza e rilevanza la
15
necessità di un giudizio pregiudiziale della Corte Costituzionale o della Corte della giustizia delle
comunità europee.
Viceversa, con riferimento ai fatti oggetto della causa, è necessario vedere, ad esempio, quante
siano le parti concretamente coinvolte nel procedimento, se tutte la parti sono italiane, se si debba
procedere a notifiche all’estero con traduzione degli atti, se i fatti siano stati o no contestati.
Invero, almeno inizialmente, i giudici nazionali hanno enfatizzato il criterio delle «complessità del
caso», utilizzandolo quale salvacondotto per giustificare l’eccesiva durata del processo. A ben
vedere però, come chiarito in dottrina, esso non può essere elevato a parametro assoluto, dovendo
viceversa, in ogni caso, essere rapportato alle altre vicende processuali. Basti pensare alla richiesta
di un rinvio che se in un procedimento relativamente semplice può integrare gli estremi di una
condotta incompatibile con le esigenza della ragionevole durata del processo, in un procedimento
complicato può, viceversa, essere giustificato da esigenze di approfondimento: si pensi alle cause
di stato, di asilo, di famiglia, di separazione;
- l’oggetto del procedimento: il criterio relativo all’oggetto del procedimento è di nuovo conio,
essendo del tutto assente nella previgente disciplina, e fa evidentemente riferimento alla natura
della situazione sostanziale controversa. Il che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso
richiamare, anche ai fini di una più completa valutazione da parte del giudice nazionale, uno dei
criteri di maggiore rilevanza impiegati dalla Corte di Strasburgo nell’apprezzamento della
violazione del délai raisonnable, ossia il criterio della c.d. rilevanza della posta in gioco. Difatti, i
giudici europei, pur non offrendo una interpretazione univoca al riguardo, hanno evidenziato che,
nella valutazione della ragionevole durata del processo, entrino in gioco anche la peculiarità del
diritto azionato e l’importanza degli interessi in gioco. In linea generale, tale criterio è stato
utilizzato in tutti quei procedimenti aventi ad oggetto diritti personali ed inviolabili dell’individuo
(si pensi ai procedimenti riguardanti soggetti sieropositivi contaminati dal virus dell’hiv a seguito
di trasfusioni di sangue infetto), nonché nei giudizi riguardanti status personali (in materia di
filiazione) e nelle controversie in materia di diritto del lavoro. In tutti questi casi, l’estrema
particolarità e delicatezza della situazione giuridica tutelata impongono all’autorità di agire con
estrema diligenza ma soprattutto con estrema celerità.
Ancora, una altra tipologia di procedimento in cui si può ravvisare il criterio della posta in gioco
riguarda, ad esempio, la procedura fallimentare che rientra nell’ambito di applicazione della legge
Pinto.
Difatti, la dichiarazione di fallimento ha ripercussioni negative non solo sulla sfera personale del
fallito, il quale durante la procedura subisce una serie di restrizioni alla sua libertà ed ai suoi diritti,
ma anche per gli stessi creditori per ciò che attiene soprattutto alla quantificazione del danno subito
che è di natura prevalentemente patrimoniale.
-
il comportamento del giudicante nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a
concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione (art. 2, 2° comma, l. 89/2001).
16
Nell’accertare se via sia stata violazione del termine di durata ragionevole del processo, il giudice
dovrà altresì tenere conto del comportamento non soltanto del giudice ma di qualsiasi autorità
interessata dal processo, da quella amministrativa (capo dell’ufficio giudiziario, cancellerie) a
quella ausiliaria (consulenti tecnici, curatori) e politica (governo, quale rappresentante dello Stato
amministrazione qualora non appresti tutte le misure idonee ad adeguare il sistema giustizia alle
esigenze della collettività).
Dando uno sguardo veloce alla giurisprudenza di legittimità, emerge come in una molteplicità di
casi i giudici hanno valutato l’eccesiva durata del processo dando rilievo, ad esempio, a ripetuti e
non motivati rinvii delle udienze di trattazione e dell’udienza collegiale disposti a volte per periodi
superiori ad un anno. Ancora, si rivengono taluni casi in cui una riserva di decisione è stata sciolta
a distanza di ben tre anni.
Peraltro, in Cass. 10 gennaio 2005 n. 297, la Corte di Cassazione è giunta ad affermare che, ai fini
dell’accertamento della violazione della durata ragionevole del processo, il giudice è altresì tenuto
a considerare il periodo di durata del procedimento per la correzione dell’errore materiale della
sentenza, nonché quello per la risoluzione dell’incidente di legittimità costituzionale (Cass. 17
gennaio 2006, n. 789).
- Comportamento delle parti: in ordine a tale criterio, va detto che, sulla scorta di quanto precisato
dalla Corte europea di Strasburgo, la condotta del ricorrente e delle parti in generale deve essere
inevitabilmente valutata alla luce del principio di difesa nel senso che nessun addebito potrà essere
mosso alle parti che si siano avvalse di tutti gli strumenti previsti dalla legge al fine di esercitare
tale diritto. Ciò che, al contrario, diviene addebitabile è evidentemente un eccesivo abuso degli
strumenti previsti dal legislatore a garanzia del predetto diritto nonché un loro impiego con finalità
prettamente dilatorie. Si pensi, ad esempio, all’audizione di un testimone o l’effettuazione di perizie
e consulenze tecniche, richieste di rinvii, che se da un lato ovviamente rappresentano attività idonee
ad allungare eccessivamente i tempi del processo, dall’altro costituiscono altresì manifestazione del
diritto di difesa e quindi in tale caso non possono ovviamente essere ritenute contrarie al dovere di
diligenza.
Ma su questo aspetto e cioè sulla valutazione del comportamento delle parti è bene far riferimento
ad una ulteriore novità introdotta dalla riforma del 2012
Difatti, l’art. 2, comma 2-quinquies, l. 89/2001 individua determinate ipotesi che, laddove
dovessero concretamente verificarsi, fungono da impedimento all’inverarsi del diritto al
risarcimento del danno, patrimoniale o non, trattandosi di atteggiamenti processuali reputati
contrari al principio della ragionevole durata. In particolare, con riferimento ai giudizi civili:
- è stabilito che non si riconosce alcun indennizzo in favore della parte soccombente condannata
per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- nel caso di condanna alle spese a norma dell’art. 91, 1° comma, secondo periodo, c.p.c., ossia
quando, rifiutata nel corso del processo una proposta conciliativa, la parte, benché vittoriosa, sia
17
stata condannata al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della
proposta. La formulazione della disposizione appare alquanto discutibile, non comprendendosi per
quale ragione il rifiuto della proposta conciliativa possa di per sè ed in ogni caso testimoniare
l’assenza di ogni ansia e patema d’animo circa l’esito del processo a prescindere da ogni valutazione
sull’oggetto della controversia e sulle circostanze che hanno indotto la parte a rifiutare la proposta
stessa
- nel caso di cui all’art. 13, 1° comma, primo periodo, del d. l. 4 marzo 2010, n. 28, vale a dire in
caso in cui la parte nel corso del procedimento di mediazione rifiuti una proposta poi trasfusa in
sentenza;
- infine, in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata
dilatazione della durata del processo;
- con riferimento al processo penale, nell’ipotesi di il mancato deposito da parte dell’imputato
dell’istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento del
termine triennale (di durata ragionevole) di cui al precedente articolo. Disposizione questa che,
facendo carico all’imputato di assumere l’iniziativa per una celere celebrazione del processo,
finisce almeno in parte per elidere la disposizione di cui alla precedente lett. d) (in tema di
prescrizione del reato).
Dubbi sono sorti in ordine alla possibilità di estendere la legittimazione alla proposizione del
rimedio in esame in capo alla parte rimasta contumace nel processo presupposto.
Sulla questione è sorto un contrasto creatosi tra la seconda (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4474
P<residente Rovelli, Relatore Carratto) e la quinta sezione della Cassazione (24 aprile 2013, n.
10013) e risoltosi con Cass. sezioni unite 14 gennaio 2014 , n. 585 che ha accolto la tesi estensiva
estenso il diritto al risarcimento del danno anche in capo al soggetto rimasto contumace nel giudizio
presupposto.
Secondo le sezioni unite appare arbitrario escludere tale diritto in capo al soggetto rimasto
contumace non prevedendo nè l’art 6 nè l’art. 2 della lege Pinto alcuna limitazione in tal senso con
la conseguenza che la tutela è apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un
procedimento giurisdizionale tanto più che nella tradizione giuridica la contumacia è stata sempre
configurata come un atteggiamento pienamente legittimo preclusivo della assunzione della qualità
di parte ma ragione anzi di specifiche tutele. Contumacia che cmq non e indice univoco di
disinteresse all’esito della lite e conseguentemente della sua durata.
La decisione potrebbe lasciare apparentemente perplessi perché non è chiaro come posa il
contumace dolersi dell’eccesiva durata di un processo a quale non abbia partecipato. A ben vedere
però la statuizione si presenta convincente. Innanzitutto, il suddetto orientamento appare conforme
ai principi elaborati in materia da questa Corte sui rapporti fra diritto comunitario e diritto interno
(Sez. Un. 1338 e 1341 del 2004 e molte altre successive), secondo cui il giudice italiano deve
interpretare la L. n. 89 del 2001, in modo conforme a quella data dalla Corte Europea di Strasburgo
18
all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, vale a dire per come essa vive
nella giurisprudenza di detta Corte, dal momento che sia nelle disposizione internazionali che in
quelle interne non si inviene alcuna limitazione per il contumace che è pacificamente parte del
processo nei cui confronti la sentenza esplica i suoi effetti; quindi deve escludersi ogni
incompatibilità tra contumacia e il diritto all’equa riparazione da durata irragionevole del processo;
L’estensione della legittimazione anche in capo al contumace e poi conforme con le nuove modiche
apportate dal legislatore del 2012 dal momento che le ipotesi di esclusione a priori dell’indennizzo
risultano testualmente limitate all’abuso del processo: ed è pacifico (almeno de jure condito) che la
contumacia sia un’opzione del tutto neutra, scevra ex positivo jure di connotazioni negative, un
comportamento processuale legittimo nei cui confronti il nostro legislatore non ricollega se non in
casi eccezionali (cfr. art. 663 c.p.c. in tema di convalida di sfratto in caso di mancata comparizione
dell’intimato) conseguenze negative.
Tutt’al più, l’atteggiamento inerte della parte rimasta contumace potrebbe ridurre ai minimi il
patema d animo sofferto e cosi imporre la liquidazione di un indennizzo il più possibile contenuto,
ma non addirittura rappresentare elemento per escludere la sussistenza di detto diritto.
5. I parametri per la quantificazione dell’indennizzo
Rilevanti modifiche sono state apportate in tema di liquidazione e determinazione dell’indennizzo
traverso l’introduzione dell’art. 2 bis:
L’art. 2 bis novellata l. 89/01, confermando il principio che la tutela indennitaria assicurata dalla
c.d. legge Pinto va rapportata esclusivamente al lasso di tempo eccedente il termine ragionevole di
durata del processo fissa delle regole precise prevedendo che:
a) la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore ad euro 750
per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non
inferiore a euro 1.000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo
comporta un aggravamento del danno (30);
b) è possibile liquidare anche somme di importo notevolmente inferiore a quella di euro 1.000, e
segnatamente l’importo di euro 500 per ogni anno di ritardo, qualora ciò sia giustificato dalle
particolarità del caso, e in particolare in ipotesi di procedimenti dinanzi al giudice amministrativo
o al giudice contabile protrattisi per lunghi periodi in assenza di impulso sollecitatorio di parte o
nel caso di posta in gioco irrisoria.
In ogni caso, precisa l’art. 2 bis la misura dell’indennizzo non è affidata ad automatismi ma
comporta una valutazione del giudice operata sulla base di parametri che implicano la conclusione
del processo ed esplicitamente la considerazione del suo esito.
La norma in discorso specifica che, ai fini della determinazione dell’indennizzo, deve tenersi conto
dei seguenti elementi:
19
a) dell’«esito del processo» presupposto: il che significa che bisogna considerare non soltanto se
il ricorrente sia stato vittorioso o soccombente, ma, altresì, le modalità di definizione del processo
(per es., se questo si sia concluso con la cancellazione e l’estinzione della causa dal ruolo per
inattività delle parti; in caso di processo dinanzi al Tar, l’eventuale perenzione del ricorso);
b) del «comportamento del giudice e delle parti»: a questo riguardo vengono in rilievo l’eventuale
disinteresse dimostrato dalle parti per l’andamento della causa, così come le loro ripetute richieste
di differimento;
c) della «natura degli interessi coinvolti»: assume, quindi, a tal fine rilevanza il fatto che la
controversia riguardi, per es., diritti della persona, la materia della famiglia o dei minori, piuttosto
che interessi di carattere prettamente economico;
d) del «valore e… rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della
parte». L’ultimo comma dell’art. 2 bis prevede, peraltro, che, anche in deroga agli estremi
dell’anzidetta «forbice», «la misura dell’indennizzo… non può in ogni caso essere superiore al
valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice».
La norma, per come formulata, sembrerebbe precludere la possibilità di liquidare in una qualche
misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo, sia risultata intera-mente
soccombente.
Ed infatti, a pochi mesi dall’entrata in vigore, con ordinanza del 8 aprile 2013 la Corte di Appello
di Reggio Calabria ha rimesso alla Corte Costituzione questione di legittimità costituzionale del
comma 3 dell'art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 (la legge Pinto, per l'appunto) per contrasto
con gli artt. 3, 24 e 117 Cost.
Ebbene, in detta occasione, la Corte costituzionale ha sí negato l’illegittimità, facendo leva sulla
circostanza che la disposizione va intesa come riferita alle sole fattispecie nelle quali sia stata
accertata l’esistenza del diritto fatto valere in giudizio, dovendosi di contro escludere quei casi nei
quali il giudice accerti l’inesistenza del diritto dedotto. Sicché, con l’escamotage di una
interpretativa di rigetto, la Corte si è ritagliata, in realtà, uno spazio per la concessione di un’equa
riparazione anche nell’ipotesi della parte risultata soccombente, offrendo in definitiva una
interpretazione dell’art. 2-bis, 3° comma, coerente con la giurisprudenza della Corte Europea
consolidata nel ritenere che «la spettanza dell’equa soddisfazione per la lesione del diritto alla
durata ragionevole del processo» tocchi «a tutte le parti» e, dunque, anche a quella che sia risultata
soccombente.
6. Il procedimento dopo la legge n. 134/2012
La nuova disciplina introdotta dalla legge 134/2012 ha profondamente modificato l’architettura del
procedimento per l’equo indennizzo del danno da violazione della ragionevole durata del processo.
Per quel che attiene la competenza, la norma è rimasta invariata confermandosi che la domanda si
propone dinnanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi
20
dell’art. 111 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati
nel cui distretto è concluso o è estinto relativamente ai gradi di merito, ovvero pende il
procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
Nello specifico, la Corte di appello territorialmente competente è individuata attraverso una
apposita tabella elaborata secondo i criteri previsti per la competenza territoriale della
responsabilità dei magistrati ai sensi del citato art. 11. In sostanza, del giudizio di equa riparazione
non se ne occupa la Corte di appello del distretto cui appartiene il Tribunale nel quale si è svolto il
processo bensì la corte di appello immediatamente contigua a livello territoriale.
La particolare competenza territoriale inderogabile trova la sua ratio nell’esigenza di assicurare
l’imparzialità dell’ufficio giudiziario chiamato a decidere su una domanda che potrebbe comunque
interessare un magistrato come, ad esempio, nel caso in cui la durata sia dipesa da ritardi imputabili
ai giudici.
Dubbi sono sorti in ordine all’applicabilità di tale disposizione alle domande di equa riparazione
relative a ritardi dei giudizi amministrativi, stante il difetto della “distribuzione distrettuale” di tali
organi. Al riguardo, si riteneva, almeno sino ad oggi, che in relazione ai giudizi amministrativi, la
domanda di equa riparazione dovesse essere proposta innanzi alla Corte di Appello del luogo in cui
è sorta o deve estinguersi l’obbligazione, con riferimento cioè al luogo in cui è stato celebrato il
giudizio, ovvero a quello dove va eseguita l’obbligazione, in applicazione della regola generale di
cui all’art. 25 c.p.c. Sul punto, però, sono intervenute le Sezioni unite che, con sentenza 16 marzo
2010 n. 6307, hanno rimeditato il precedente orientamento ritenendo che «la regola generale di cui
all’art. 3, comma 1, concerne anche i giudizi amministrativi e contabili, non rilevando il riferimento
contenuto nella norma ad un termine (distretto), proprio della distribuzione territoriale degli organi
della giurisdizione ordinaria». Di interesse è che secondo le Sezioni unite «il dilatarsi del
contenzioso innescato dalla legge Pinto, che fa ricadere sul bilancio dello Stato un onere sempre
più gravoso a causa del perdurante fenomeno della eccesiva durata del processo, rende a questo
punto ragionevole l’interpretazione qui accolta che i giudici ordinari che debbono deciderne non
siano prossimi a quelli speciali davanti ai quali il ritardo si manifesta».
In relazione poi a giudizi celebrati innanzi ai giudici ordinari, le Sezioni unite hanno inoltre ritenuto
che «occorre considerare in modo unitario il giudizio nel quale si è verificata la violazione,
individuando quale fattore rilevante della localizzazione, la sede del giudice di merito avanti al
quale il giudizio di merito è iniziato» (Cass., sez. un., 16 marzo 2010, n. 6306).
Immutate sono rimaste altresì le indicazioni riguardo all’amministrazione statale nei cui confronti
la domanda di equa riparazione deve essere proposta, con la conseguenza che la domanda va
proposta nei confronti del ministro della giustizia quando venga in rilievo l’eccessiva durata di un
procedimento svoltosi dinanzi a giudice ordinario, nei confronti del ministro della difesa quando si
tratti di procedimento del giudice militare, e negli altri casi, nei confronti del ministro
dell’economia e delle finanze, pena la inammissibilità della domanda ove proposta nei confronti di
21
amministrazione diversa da quella stabilita dall’art. 3 l. 89/01, non potendo trovare applicazione il
disposto dell’art. 4 l. 260/58 (v. Cass. 6 maggio 2011, n. 10010, Foro it., Rep. 2011, voce Diritti
politici e civili, n. 258; 1° aprile 2005, n. 6917, id., Rep. 2006, voce cit., n. 270)
Ciò che è cambiata è la struttura complessiva del procedimento e gli oneri di allegazione e di prova
incombenti al ricorrente.
In particolare, mentre in precedenza il ricorso per l’equa riparazione (contenente gli elementi di cui
all’art. 125 c.p.c.) veniva trattato e deciso in camera di consiglio dalla corte d’appello in
composizione collegiale, ai sensi degli art. 737 ss. c.p.c., previa instaurazione del contraddittorio
nei confronti del ministero competente, il procedimento ex l. 89/01 (art. 3 ss.), così come novellato
dall’art. 55 d.l. 83/12, è un procedimento con struttura bifasica a contradditorio eventuale,
modellato su quello di ingiunzione seppure con alcune differenze.
In particolare, guardando alla prima fase, secondo il novellato art. 3 la domanda è proposta con
ricorso al presidente della corte d'appello, competente ex art. 11 c.p.p. con l'applicazione dell'art.
125 c.p.c. (malgrado la norma non preveda più che il ricorso debba essere sottoscritto da un
difensore munito di mandato speciale si ritiene che sussista ancora l’obbligo del patrocinio del
difensore).
Il presidente designa un magistrato della corte per la trattazione della causa.
Mentre nel precedente assetto normativo, ai fini della proponibilità della domanda per equa
riparazione, si reputava sufficiente l’allegazione (e la dimostrazione) da parte del ricorrente dei dati
relativi alla sua posizione nel processo presupposto (data iniziale, data della sua definizione,
eventuale articolazione nei vari gradi), spettando poi al giudice (anche in coerenza con il modello
procedimentale, di cui agli art. 737 ss. c.p.c., prescelto dal legislatore) disporre, se del caso, anche
su istanza di parte, l’acquisizione di tutti o di alcuni degli atti e documenti del procedimento, al fine
di verificare la sussistenza di eventuali cause giustificative della durata del procedimento
presupposto; ora il 3° comma del novellato art. 3 l. 89/01 stabilisce che, unitamente il ricorso, deve
essere depositata copia autentica degli atti introduttivi, dei verbali di causa e del provvedimento
che ha definito il giudizio « ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili».
Trattasi di un vero e proprio deterrente abbastanza subdolo ai fini della proposizione della legge
Pinto dal momento che, una volta esclusa l’acquisizione di ufficio, il ricorrente parrebbe onerato
dal deposito dell’intero contenuto del fascicolo di causa, previsa estrazione peraltro non già della
copia semplice attinta dal fascicolo di ufficio ma di quella autenticata.
In analogia a quanto previsto nel procedimento monitorio è previsto, attraverso il richiamo ai primi
due commi dell'art. 640 c.p.c., che il giudice possa ordinare l'integrazione della documentazione,
pena il rigetto della domanda in caso di inottemperanza.
Il presidente o il magistrato da lui designato provvede nella forma del decreto motivato, da emettere
entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
22
Se la domanda è accolta, il decreto ingiuntivo emesso — che dovrà liquidare anche le spese del
procedimento — è provvisoriamente esecutivo.
In caso di rigetto e anche di accoglimento parziale, la domanda non può essere riproposta, ma è
possibile fare opposizione al collegio.
Trattasi di un'importante differenza rispetto alla disciplina del decreto ingiuntivo, dettata da
evidenti finalità deflattive.
Il nuovo art. 5 l. 89/01 stabilisce dettagliatamente gli adempimenti cui è tenuto il ricorrente nel caso
in cui la sua domanda sia stata accolta (anche solo in parte) dal presidente della corte d’appello (o
suo delegato): l’ingiunzione di pagamento dell’equo indennizzo diventa infatti inefficace (e ciò
irrimediabilmente, non potendo la domanda essere riproposta), qualora nel termine di trenta giorni
dal deposito in cancelleria del relativo decreto questo non venga notificato, unitamente al ricorso,
all’amministrazione intimata, la quale avrà, a sua volta, trenta giorni di tempo dalla notifica (il
termine è perentorio, e quindi a pena di decadenza) per proporre opposizione al decreto ingiuntivo
notificatole, mediante deposito di apposito ricorso nella cancelleria della stessa corte d’appello
(ricorso nel quale, applicandosi l’art. 125 c.p.c., devono essere esposte le ragioni dell’opposizione).
Nel caso di accoglimento parziale della domanda, peraltro, come si desume dal complesso degli
art. 5, 3° comma, e 3, 6° comma, il ricorrente avrà dinanzi a sé due possibilità : notificare (entro
trenta giorni) il decreto di pagamento emesso a suo favore, comportando tale comportamento
acquiescenza al provvedimento ottenuto, oppure proporre opposizione ai sensi dell’art. 5 ter (entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui il decreto stesso gli è stato comunicato).
In altri termini cioè la notificazione preclude al ricorrente la possibilità di fare opposizione nel caso
in cui ovviamente la domanda sia stata rigettata o accolta solo in parte , comportando acquiescenza
al decreto.
Il comma 4, infine, ripete la preesistente disposizione secondo cui «il decreto che accoglie la
domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale
avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti
pubblici comunque interessati dal procedimento».
7. Il procedimento di opposizione (art. 5 -ter )
Il nuovo art. 5-ter disciplina poi il procedimento di opposizione « contro il decreto che ha deciso
sulla domanda di equa riparazione».
L'opposizione va proposta, con ricorso, che presenti il contenuto minimo previsto dall'art. 125
c.p.c., che va depositato entro 30 giorni decorrenti, per il ricorrente, dalla comunicazione del
provvedimento in tutto o in parte negativo e, per l'amministrazione, nei cui confronti sia emessa
ingiunzione in caso di accoglimento della domanda, dalla sua notificazione a cura del ricorrente.
23
L'opposizione deve essere proposta sempre alla corte d'appello, che decide collegialmente, nelle
forme del procedimento camerale, senza la partecipazione del giudice che ha emesso il
provvedimento.
L'opposizione non sospende l'esecuzione, tuttavia il collegio, in presenza di gravi motivi, può
sospenderla con ordinanza non impugnabile.
Il decreto che decide sull'opposizione, da pronunciarsi nel termine (ordinatorio) di quattro mesi dal
deposito del ricorso, è immediatamente esecutivo ed è impugnabile per cassazione.
Infine, l'art. 5-quater prevede infine — con l'evidente finalità di reprimere abusi— che con il decreto
che provvede negativamente sulla domanda ovvero con il provvedimento che definisce
l'opposizione, il giudice possa condannare la parte al pagamento di una sanzione da versarsi alla
cassa delle ammende, ma ciò solo nel caso di domanda dichiarata inammissibile o manifestamente
infondata. (cfr. Cass. civ., sez. II, 31-10-2014, n. 23302: “ In tema di equa riparazione per
irragionevole durata del processo, la sanzione processuale di cui all’art. 5 quater l. 24 marzo 2001
n. 89, è applicabile non solo quando la domanda sia dichiarata manifestamente infondata, ma
anche quando la stessa sia inammissibile per colpa ascrivibile al ricorrente, come in ipotesi di
inosservanza del termine semestrale di proponibilità decorrente dal momento in cui la decisione
che conclude il procedimento è divenuta definitiva (nella specie, desumibile dalla piana
applicazione dell’art. 2, all. 3, cod. proc. amm., che ha sancito l’ultrattività della previgente
disciplina per la proposizione dell’appello ai soli termini «in corso all’entrata in vigore» del codice
del processo amministrativo”.
8. Le recenti modifiche apportate dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità
2016).
All’indomani dei risultati poco soddisfacenti ottenuti per effetto delle modifiche del 2012 (i tempi
del processo sono rimasti “irragionevoli” ed i costi pubblici sono ulteriormente lievitati), con la
legge n. 208 del 28 dicembre 2015, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla c.d. Legge Pinto
inserendo rilevanti novità, ispirate, almeno in linea di principio, alla finalità di “razionalizzare i
costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi” (così l’incipit
dell’art. 1, comma 777, della citata legge n. 208).
La novità indubbiamente più eclatante consiste nell’introduzione dei rimedi c.d. preventivi (art. 1
ter), che rendono la domanda di equa riparazione inammissibile se fatta valere da chi non abbia
esperito detti rimedi.
a) nel processo civile costituisce rimedio preventivo l’introduzione del giudizio nelle forme del
procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.; nelle cause introdotte con citazione costituisce altresì
rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma
dell’art. 183 bis c.p.c.; e, nelle cause nelle quali non si applica il rito sommario, ivi compreso il
24
giudizio di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di
trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
b) per il processo penale costituisce rimedio preventivo un’apposita istanza di accelerazione che
l’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma
2-bis (nuovo art. 1-ter comma 2); c) per il processo amministrativo costituisce rimedio preventivo
l’istanza di prelievo con la quale la parte segnala l’urgenza del ricorso, prevista dall’art. 71, comma
2, c.p.a., da presentare almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma
2-bis; d) per il processo contabile, pensionistico e di cassazione costituisce rimedio preventivo
un’istanza di accelerazione presentata, rispettivamente, almeno 6 e 2 mesi prima della scadenza del
termine di ragionevole durata (nuovo art. 1-ter commi 4, 5 e 6).
La scelta del legislatore di subordinare l’ammissibilità della domanda di ristoro all’esperimento dei
rimedi preventivi di cui al nuovo art. 1 ter, appare poco condivisibile.
Ora, in primo luogo, è pacifico che intanto le parti possono utilizzare il procedimento sommario di
cui all’art. 702 bis c.p.c. in quanto la controversia non necessiti di una “istruzione non sommaria”,
dovendo viceversa utilizzare il procedimento ordinario ex art. 163 ss. c.p.c.
Del pari, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario ai sensi del nuovo art. 183 bis c.p.c. presuppone che “valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria”, questa la si giudichi
semplice e di pronta soluzione, poiché se, al contrario, la controversia non è ne’ semplice ne’ di
pronta soluzione, il passaggio al rito sommario non è possibile, e la controversia deve essere trattata
e portata a termine con il rito ordinario.
Sicchè, come subito evidenziato in dottrina, volendo offrire una lettura costituzionalmente orientata
di tale norma, appare ragionevole interpretare il successivo art. 2 della nuova legge Pinto nel senso
che la domanda di equa riparazione è inammissibile se, pur sussistendo i presupposti della
cognizione sommaria, egualmente la parte non l’abbia utilizzata o richiesta nell’udienza ex art. 183
c.p.c.; al contrario, se il mancato rimedio preventivo è dipeso da complessità della causa, questo
non potrà essere impediente di una richiesta di equa riparazione, pena, altrimenti, la completa
irragionevolezza della norma.
La legge di Stabilità 2016 ha poi ridotto la soglia minima e massima entro cui potrà essere liquidato
l’indennizzo: il riformulato art. 2-bis, comma 1, ha infatti indicato nuovi parametri di liquidazione
dell’indennizzo fissando un range compreso tra 400 e 800 euro per anno o frazione di anno
superiore ai sei mesi di eccedenza sulla durata ragionevole del processo (in precedenza il range era
fissato tra 500 e 1500 euro), prevedendo tuttavia correttivi in aumento per i casi in cui il ritardo si
sia eccessivamente prolungato, potendo la somma liquidata essere in tali casi aumentata sino al 20
per cento per gli anni successivi al terzo e sino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo.
A sua volta, il nuovo comma 1-bis dell’art. 2-bis consente riduzioni sino al 20 per cento se le parti
del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento se le parti sono più di cinquanta,
25
mentre il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis prevede la diminuzione “fino a un terzo” della somma
liquidabile a titolo di indennizzo nei casi di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel
giudizio presupposto.
Le anzidette soglie appaiono tuttavia nettamente inferiori agli standard determinati dalla Corte di
Strasburgo, sicché cresce il rischio di un intervento della Corte europea ai sensi dell’art. 41 CEDU
per inadeguatezza del rimedio interno.
In sede di riforma, è stato altresì riscritto il vecchio comma dell’art. 2, comma 2-quinquies
(introdotto dal d.l. n. 83 del 2012), che, come detto, contemplava una serie di ipotesi in cui è escluso
in radice il diritto all’indennizzo. Ai sensi del nuovo art. 2, comma 2-quinquies, infatti, non è
riconosciuto alcun indennizzo alla parte condannata, ex art. 96 c.p.c., ai danni per lite temeraria nel
processo presupposto ed anche alla parte che, pur in assenza di tale condanna, risulti consapevole
dell’infondatezza “originaria o sopravvenuta” della sua posizione (lett. a), nonché nei casi di cui
all’art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. (lett. b) e all’art. 13, comma 1, primo periodo del d.lgs.
4 marzo 2010 n. 28 (lett. c); infine, l’indennizzo è escluso “in ogni altro caso di abuso dei poteri
processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento” (lett.
d).
Del tutto nuova è, invece, la disposizione di cui al nuovo comma 2 sexies dell’art. 2, il quale
inserisce una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo,
superabile dalla prova contraria, per i casi di prescrizione del reato di cui benefici l’imputato (lett.
a), di contumacia della parte (lett. b), di estinzione o perenzione del processo civile o
amministrativo (lett. c e lett. d), di proposizione di motivi aggiunti al ricorso amministrativo
mediante autonomo ricorso (lett. e), nonché di mancata richiesta di riunione ex art. 70 c.p.a. dei
ricorsi amministrativi connessi, proposti dalla stessa parte (lett. f); infine, la lettera g) della
medesima norma esclude fino, a prova contraria, l’indennizzo in caso di “irrisorietà della pretesa
o del valore della causa, valutata anche in relazione alla condizione personale della parte”.
Ancora, il nuovo comma 2-septies dell’art. 2, introduce poi una presunzione di insussistenza del
danno per la parte che, dall’eccessiva durata del processo, abbia ricevuto vantaggi patrimoniali
uguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo in astratto ad essa spettante.
Con riferimento al procedimento, il legislatore ha ritenuto opportuno modificare il criterio di
competenza sui ricorsi Pinto attribuendola ora al presidente della Corte d’Appello nel cui distretto
ha sede il giudice che si è occupato in primo grado del processo presupposto. Del pari, il nuovo 4°
comma dell’art. 3, esplicita l’incompatibilità del giudice del processo presupposto, di per sé già
desumibile dal sistema.
Nel nuovo assetto cambiano nettamente le modalità di pagamento dei decreti Pinto di condanna ora
disciplinate dal nuovo art. 5-sexies, che impone al creditore il rilascio di dichiarazione di
autocertificazione e sostitutiva di notorietà che attesti la mancata riscossione del dovuto e altri dati,
avente validità semestrale e rinnovabile a richiesta. L’amministrazione è così autorizzata a
26
richiedere al creditore di attestare un credito già accertato dal giudice, a pena di divieto dell’ordine
di pagamento in caso di dichiarazione mancante, irregolare o incompleta (comma 4°), e con
preclusione nelle more di ogni atto esecutivo (comma 7°).
Va infine precisato che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 introduce anche una disciplina
transitoria secondo cui nei processi che, alla data del 31 ottobre 2016, eccedano i termini
ragionevoli ovvero siano stati assunti in decisione non è necessario esperire i rimedi preventivi,
introdotti con la normativa in commento, ai fini dell’ammissibilità della domanda di equa
riparazione.
Di contro, in assenza di una specifica disposizione ed applicando i principi generali in materia di
successione delle leggi nel tempo, appare ragionevole ritenere che tutte le altre modifiche potranno
applicarsi ai procedimenti ex legge Pinto istaurati dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità
del 2016 (quindi, dopo il primo gennaio 2016).
8. Il principio della ragionevole durata nelle pronunce della Corte di Cassazione
Il principio della ragionevole durata del processo ha rappresentato un canone imprescindibile per
una lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano il processo civile.
Difatti, l’art. 111 Cost. è norma che si rivolge non solo al legislatore ma altresì al giudice che, in
qualità di interprete della norma processuale, è chiamato a prediligere tra le varie interpretazioni
possibili quella “più costituzionalmente orientata”. È evidente, quindi, che l’introduzione del
principio della ragionevole durata del processo ha imposto all’interprete un nuovo approccio
interpretativo avversante ogni inutile appesantimento della giudizio, al fine di giungere in tempi
celeri alla definizione della controversia
Sulla base di tale principio, in questi ultimi dieci anni, la Corte di Cassazione è intervenuta con una
serie di pronunce dirette a fornire una lettura costituzionalmente orientate della norme del codice
di procedura civile.
Un primo filone di pronunce è certamente quello in materia di sospensione del giudizio. Non vi
è dubbio, infatti, che se il canone della ragionevole durata del processo impone di giungere alla
definizione del processo in tempi celere, l’istituto della sospensione debba essere formalmente
delimitato nella sua operatività, in quanto istituto contrario alla natura del processo e tale da incidere
sull’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost.
In questa ottica, dunque, a seguito della novellazione dell’art. 111 Cost. ed alla luce dei principi del
giusto processo e della ragionevole durata del processo, la Corte di Cassazione, a partire dalla
sentenza, sez. un. 1º ottobre 2003, n. 14670, ha inaugurato quel filone giurisprudenziale teso da
un lato a limitare l’operatività della sospensione del processo (attraverso l’espulsione dal sistema
delle ipotesi di sospensione discrezionale) e dall’altro ad ampliare i controlli avverso i
provvedimenti dichiarativi della sospensione, così attribuendo all’interessato un rimedio immediato
per contestare la correttezza del provvedimento di sospensione.
27
In quest’ultimo filone si inserisce la sentenza, sez. un. del 2008, n. 21931 con la quale, sia pure
attraverso una lettura un po’ forzata dell’art. 46 (che esclude l’applicabilità dell’art. 42 e, quindi
delle norme sul regolamento di competenza, nei procedimenti dinnanzi al giudice di pace), la Corte
Suprema di Cassazione ha esteso il regolamento di competenza anche avverso i provvedimenti del
giudice di pace dichiarativi della sospensione, cosi garantendo alla parte lesa uno strumento idoneo
ad assicurare la sollecita ripresa delle attività processuali ed impedendo la lesione del diritto alla
ragionevole durata del processo.
In altre ipotesi, viceversa, il richiamo alla ragionevole durata del processo ha rappresentato
l’occasione per rivedere orientamenti più risalenti ed ormai ritenuti non più costituzionalmente
orientati. Balza subito all’attenzione, la copiosa giurisprudenza in materia di notificazioni, di
impugnazioni e di termini.
In particolare, con sentenza, sez. un., 15 dicembre 2008, n. 29290, la Corte di Cassazione ha
statuito che la notificazione dell’atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per
più parti, mediante consegna di una sola copia (o comunque di un numero inferiore) è valida ed
efficace, dovendosi, al contrario, superare il vecchio orientamento che imponeva, in caso di
consegna di una sola copia, «la rinnovazione della notificazione …… mero formalismo non
imposto dalla norma ed in contrasto con le esigenze di effettività e semplificazione che impongono
di privilegiare le interpretazioni coerenti con l’esigenza di rendere giustizia in tempi celeri e
ragionevole, in virtù della generale applicazione del principio della ragionevole durata del
processo».
Rileva poi la sent., sez. un., 3 novembre 2008, n. 26373 con la quale la Suprema Corte partendo
dal presupposto che «il rispetto del fondamentale diritto a una durata ragionevole del processo
impone, in concreto, al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una
sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio
di energie processuali», ha sancito il principio secondo cui nel processo in cui vi sia una pluralità
di soggetti che hanno diritto a ricevere la notifica dell’impugnazione, non può non ritenersi
superflua e, quindi, da evitare, al fine di definire con maggior celerità il giudizio, la concessione di
un termine per la notifica dell’impugnazione alla parte totalmente vittoriosa nei cui confronti sia
stata omessa, quando il giudice ritiene di dover dichiarare l’inammissibilità o l’improcedibilità
dell’impugnazione.
Il principio della ragionevole durata del processo ha altresì rappresentato il canone ispiratore delle
disposizioni nelle quali si scandiscono i tempi del processo.
Innanzitutto, ritroviamo nella giurisprudenza della Corte di cassazione enunciazioni di carattere
generale intese essenzialmente a far emergere come il sistema delle preclusioni, letto alla luce del
principio della ragionevole durata del processo, soddisfi una esigenza di carattere generale. In
particolare, in Cass., sez un., 15 dicembre 2008, n. 29290 la Cassazione sottolinea l’importanza
28
del dovere di collaborazione anche in capo alle parti affinché nel processo sia tempestivamente
circoscritti i fatti effettivamente controversi.
Destano sicuramente più interesse quelle pronunce che si occupano in modo specifico degli aspetti
problematici alle preclusioni istruttorie. Al riguardo, è d’obbligo menzionare due importanti filoni
giurisprudenziali.
In particolare, si segnala Cass. sez. un., 20 aprile 2003, n. 8203 e n. 8202. Con tale pronuncia, le
sezioni unite, risolvendo definitivamente il contrasto relativo ai limiti di ammissibilità di nuove
prove in appello, giunge ad affermare che «il regime di preclusioni in appello riguarda sia le prove
costituende sia le prove precostituite (i documenti)», soluzione questa in linea con il principio della
durata ragionevole del processo che impone di eliminare ogni inutile prolungamento delle attività
processuali.
Ancora, Cass. 28 luglio 2007, n. 15787, nella quale la Corte, nell’affrontare il problema dei limiti
ai poteri istruttori del terzo interveniente, afferma che l’intervento del terzo è ammesso sino alla
udienza di precisazione delle conclusioni, quand’anche sia ispirato il termine di cui all’art. 183 ma,
in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 268 c.p.c. il terzo non può compiere atti che
sono ormai preclusi alle altre parti e quindi gli è preclusa ogni attività di allegazione e di prova.
Questa, dunque, una interpretazione della norma che la corte ritiene in linea con i principi del giusto
processo «considerato che un processo giusto è anche un processo celere in seno al quale non siano
consentite manovre dilatorie o vicende funzionali volte a prolungare immotivatamente i tempi di
celebrazione».
In molte altre ipotesi, la Corte di cassazione, motivando in punto di principi costituzionali e in
particolar modo invocando il principio della ragionevole durata del processo, è giunta a conclusioni
in contrasto con il tenore letterale della norma. Si inseriscono in questo filone giurisprudenziale
due recenti sentenze.
In particolare, Cass. 9 ottobre 2008 n. 24883 (seguita da Cass. 30 ottobre 2008, n. 2601)con la
quale la suprema Corte, in netto contrasto con la lettera dell’art. 37 c.p.c. , ha statuito che il difetto
di giurisdizione può essere eccepito dalle parti o rilevato di ufficio dal giudice solo sino a quando
la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado, altrimenti la questione di giurisdizione resta
assorbita dalla mancata impugnazione della sentenza.
Ancora una volta, le conclusioni cui perviene la Cassazione trovano il loro sostegno principale
proprio nel principio della ragionevole durata del processo. In altri termini, le sezioni unite, facendo
leva su detto principio, ritengono che proprio a seguito del suo avvento nel sistema costituzionale,
il principio di economia processuale non può non produrre i suoi effetti anche in relazione ai tempi
concessi per il consolidamento della giurisdizione. La riduzione degli spazi applicativi dell’art. 37
c.p.c. è simmetrica alla portata espansiva del nuovo dettato costituzionale.
Attraverso una sentenza molto elaborata la Cassazione disapplica l’art. 37 c.p.c. affermando che
esso «non realizza un corretto bilanciamento dei valori costituzionali e produce una ingiustificata
29
violazione del principio della ragionevole durata del processo e dell’effettività della tutela, in
quanto comporta la regressione del processo allo stato iniziale, la vanificazione di due pronunce di
merito e l’allontanamento sine die di una valida pronuncia nel merito».
Qualche eccesso nel calcare la mano sul canone della ragionevole durata del processo, quale
principio ispiratore per una lettura costituzionalmente orientate delle norme processuali, emerge
anche in Cass., 23 febbraio 2010, n. 4309. Disapplicando totalmente l’art. 269 c.p.c., in materia
di chiamata in causa del terzo tempestivamente proposta dal convenuto (che, come è noto, non è
soggetta ad autorizzazione da parte del giudice, dovendo quest’ultimo, previa richiesta, fissare entro
cinque giorni, la data della nuova udienza), la Cassazione, in virtù del principio della ragionevole
durata del processo che impone al giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di
ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, ha statuito che «il provvedimento del giudice di
fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel processo chiesta
tempestivamente dal convenuto ai sensi dell’art. 269 c.p.c., al di fuori delle ipotesi di litisconsorte
necessario, è discrezionale, potendo il giudice rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la
costituzione del terzo per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del
processo».
È evidente allora come il metodo utilizzato dalla Cassazione, almeno in queste ultime due pronunce,
non può essere condiviso.
E difatti se è vero che l’art. 111 Cost. è una norma costituzionale programmatica che impone al
legislatore di dettare leggi finalizzate ad accelerare i tempi del processo, questo però non significa
che il giudice possa utilizzare il parametro della ragionevole durata del processo per riscrivere le
norme del codice di procedura civile, specie quando il precetto della norma (v. art. 37 c.p.c., art.
269 c.p.c.) è chiaro ed è espressione fedele e coerente di un giudizio di valore del legislatore di
senso diametralmente opposto.
In questo caso, il giudice non può stravolgere il contenuto della norma processuale. Tanto perché i
giudizi di valore legislativo possono essere disattesi nel nostro ordinamento solo attraverso
l’intervento dello stesso legislatore o rimettendo la questione di legittimità costituzionale
direttamente dinnanzi alla Corte costituzionale. In caso contrario, come sostenuto in dottrina, «ne
deriverebbe una violazione palese anche del principio della legalità e lo stesso codice di procedura
civile non servirebbe più a nulla. In questa ottica, dunque, il principio della ragionevole durata del
processo costituirebbe non solo la perdita della preconoscenza delle regole processuali, tenuto
conto che il cittadino deve conoscere le modalità in cui viene e deve essere esercitata la funzione
giurisdizionale ma dall’altro conto il giudice acquisirebbe un potere assoluto di determinazione
delle modalità di svolgimento del rito in deroga al principio di legalità».
Ad ultimo, l’art. 111 Cost. è una norma che si rivolge al legislatore il quale per dare effettiva
attuazione al principio di ragionevole durata dovrebbe operare da un lato sugli aspetti
organizzativi e strutturali (assicurando un rapporto adeguato tra il numero complessivo delle
30
controversie ed il numero dei magistrato togati ed onorari addetti alla loro trattazione,
aumentandola la competenza dei giudici di pace, revisione delle circoscrizioni) e dall’altro sul
piano strettamente processuale, approntando normative idonee a garantire il celere svolgimento
dei processi.
Dobbiamo tuttavia constatare che, se è vero che negli ultimi dieci anni non c’è stata legge di riforma
del processo civile nella quale il legislatore non abbia affermato quale sua fonte ispiratrice
l’esigenza di attuare una giustizia più celere ed efficace (v. da ultimo, la recente riforma del
processo civile attuata con legge n. 69/2009 finalizzata a contenere i tempi del processo), nulla è
stato fatto in riferimento alla modernizzazione e al rafforzamento degli apparati e degli strumenti
organizzativi.
Tanto a differenza di quanto accaduto negli altri paesi esteri (si pensi alla Spagna ed al Portogallo)
che, anziché risolvere il problema della ragionevole durata del processo solo attraverso
l’introduzione di una norma ad hoc a ristoro dei danni derivanti dalla violazione dell’art. 6 della
convenzione, hanno altresì privilegiato l’intervento strutturale teso alla accelerazione complessiva
dei tempi del processo ed al rafforzamento delle garanzie interne e dell’apparato giudiziario.
Una conclusione quest’ultima condivisa anche dalla Corte Europea di Strasburgo che ha
sottolineato come “il miglior rimedio in assoluto è la prevenzione” e non il risarcimento dei danni,
che può indurre a provocare deliberatamente ulteriori ritardi per conseguire non più una vittoria
(ipotetica) nel processo, ma un titolo (certo) per richiedere il risarcimento per il ritardo (Grande
Camera, Scordino c. Italia del 29 marzo 2006) .
31