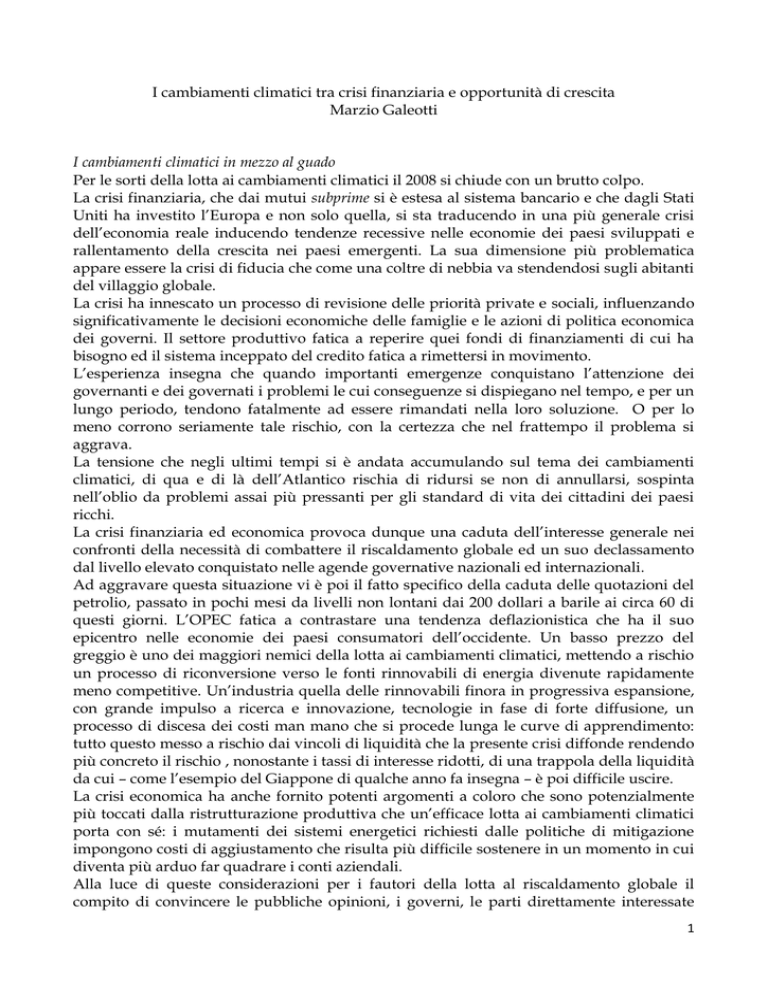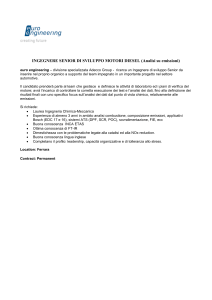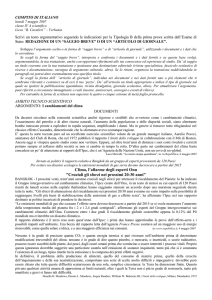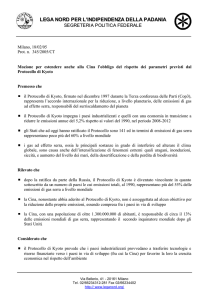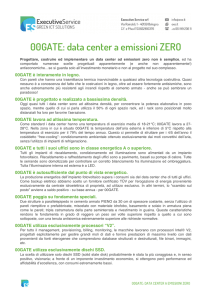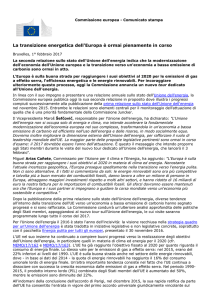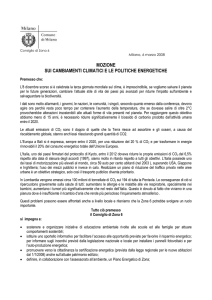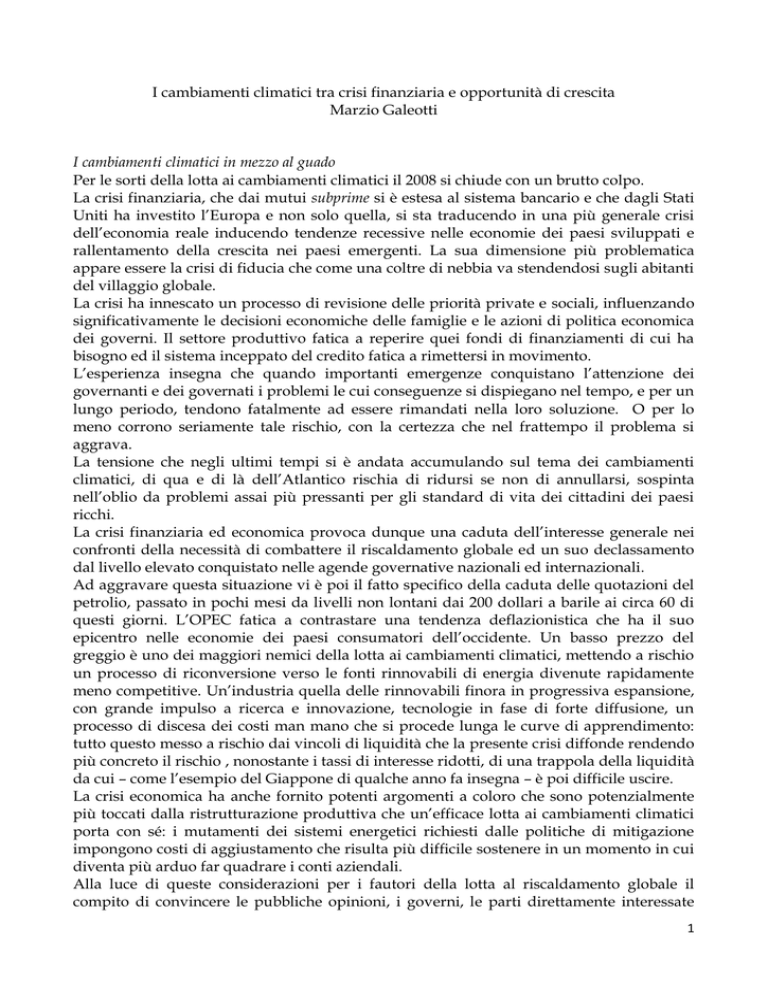
I cambiamenti climatici tra crisi finanziaria e opportunità di crescita
Marzio Galeotti
I cambiamenti climatici in mezzo al guado
Per le sorti della lotta ai cambiamenti climatici il 2008 si chiude con un brutto colpo.
La crisi finanziaria, che dai mutui subprime si è estesa al sistema bancario e che dagli Stati
Uniti ha investito l’Europa e non solo quella, si sta traducendo in una più generale crisi
dell’economia reale inducendo tendenze recessive nelle economie dei paesi sviluppati e
rallentamento della crescita nei paesi emergenti. La sua dimensione più problematica
appare essere la crisi di fiducia che come una coltre di nebbia va stendendosi sugli abitanti
del villaggio globale.
La crisi ha innescato un processo di revisione delle priorità private e sociali, influenzando
significativamente le decisioni economiche delle famiglie e le azioni di politica economica
dei governi. Il settore produttivo fatica a reperire quei fondi di finanziamenti di cui ha
bisogno ed il sistema inceppato del credito fatica a rimettersi in movimento.
L’esperienza insegna che quando importanti emergenze conquistano l’attenzione dei
governanti e dei governati i problemi le cui conseguenze si dispiegano nel tempo, e per un
lungo periodo, tendono fatalmente ad essere rimandati nella loro soluzione. O per lo
meno corrono seriamente tale rischio, con la certezza che nel frattempo il problema si
aggrava.
La tensione che negli ultimi tempi si è andata accumulando sul tema dei cambiamenti
climatici, di qua e di là dell’Atlantico rischia di ridursi se non di annullarsi, sospinta
nell’oblio da problemi assai più pressanti per gli standard di vita dei cittadini dei paesi
ricchi.
La crisi finanziaria ed economica provoca dunque una caduta dell’interesse generale nei
confronti della necessità di combattere il riscaldamento globale ed un suo declassamento
dal livello elevato conquistato nelle agende governative nazionali ed internazionali.
Ad aggravare questa situazione vi è poi il fatto specifico della caduta delle quotazioni del
petrolio, passato in pochi mesi da livelli non lontani dai 200 dollari a barile ai circa 60 di
questi giorni. L’OPEC fatica a contrastare una tendenza deflazionistica che ha il suo
epicentro nelle economie dei paesi consumatori dell’occidente. Un basso prezzo del
greggio è uno dei maggiori nemici della lotta ai cambiamenti climatici, mettendo a rischio
un processo di riconversione verso le fonti rinnovabili di energia divenute rapidamente
meno competitive. Un’industria quella delle rinnovabili finora in progressiva espansione,
con grande impulso a ricerca e innovazione, tecnologie in fase di forte diffusione, un
processo di discesa dei costi man mano che si procede lunga le curve di apprendimento:
tutto questo messo a rischio dai vincoli di liquidità che la presente crisi diffonde rendendo
più concreto il rischio , nonostante i tassi di interesse ridotti, di una trappola della liquidità
da cui – come l’esempio del Giappone di qualche anno fa insegna – è poi difficile uscire.
La crisi economica ha anche fornito potenti argomenti a coloro che sono potenzialmente
più toccati dalla ristrutturazione produttiva che un’efficace lotta ai cambiamenti climatici
porta con sé: i mutamenti dei sistemi energetici richiesti dalle politiche di mitigazione
impongono costi di aggiustamento che risulta più difficile sostenere in un momento in cui
diventa più arduo far quadrare i conti aziendali.
Alla luce di queste considerazioni per i fautori della lotta al riscaldamento globale il
compito di convincere le pubbliche opinioni, i governi, le parti direttamente interessate
1
che vi sono importanti benefici che le politiche di mitigazione sono in grado di generare e
che questi benefici superano i costi diventa ancora più arduo. Ma questo è precisamente il
compito che nell’immediato le forze riformiste si devono dare e perseguire con grande
convinzione.
Le difficoltà del negoziato
Con il Protocollo di Kyoto già operativo l’attenzione degli addetti ai lavori si è rivolta al
suo successore. Con la defezione degli Stati Uniti l’impatto di Kyoto sotto il profilo
quantitativo di riduzione delle emissioni è risibile. La riduzione del 5,2% rispetto al 1990
scende al 3% ed anche in questo caso non vi è certezza che tale obiettivo verrà centrato
entro la fine del primo periodo di commitment, il quinquennio già iniziato che si concluderà
il 31 dicembre 2012. Nonostante ciò, diversi paesi sono vincolati al rispetto degli obblighi
previsti dall’accordo. Secondo i dati più recenti sulle emissioni, l’Europa a 15 paesi (quelli
che avevano contratto l’impegno di Kyoto nel 1997 riconfermato l’anno dopo a
Lussemburgo) è in linea con gli obblighi dell’accordo, anche se al suo interno si segnalano
alcuni paesi – Italia, Spagna e Danimarca – che sono significativamente fuori linea. Altri
paesi, tra cui Canada e Giappone, si trovano al momento in difficoltà da questo punto di
vista. Anche se il Protocollo di Kyoto avrà scarse conseguenze sulle emissioni globali, esso
ha avuto un enorme significato politico, costituendo il primo storico passo concreto verso
la soluzione di un problema tra i più complessi e pervasivi che l’umanità ha conosciuto.
A fronte del Protocollo di Kyoto vi è l’evidenza presentata dal Fourth Assessment Report
dell’IPCC circa lo sforzo necessario per contenere l’aumento della temperatura media
globale entro i 2oC rispetto all’era preindustriale: si tratta di ridurre le emissioni per un
importo tra il 50% e l’85% rispetto al 2000 entro il 2050, le quali perciò dovrebbe
raggiungere il picco nel periodo 2000-2015.
Ecco così che grandi sono le aspettative circa il futuro accordo e l’architettura del nuovo
regime globale. Si tratta innanzi tutto di confermare l’asse portante dell’accordo, e cioè
l’assunzione di obblighi vincolanti circa la riduzione delle emissioni assolute di gas
climalteranti. Si tratta poi di confermare, eventualmente rafforzare i meccanismi di
flessibilità che hanno lo scopo di rendere meno oneroso per i paesi contraenti il
raggiungimento del proprio target. Si tratta soprattutto infine di stabilire i criteri di equità
nella distribuzione dell’impegno, a partire dall’assunzione o meno di obblighi di riduzione
delle emissioni da parte dei paesi in via di sviluppo.
Tecnicamente il futuro regime dovrebbe scaturire dal Protocollo di Kyoto, la cui struttura è
definita teoricamente per un periodo infinito di tempo. Ai sensi dell’articolo 3.9 i paesi che
hanno ratificato il Protocollo, i cosiddetti MOP (members of parties), sono obbligati secondo
il diritto internazionale a negoziare nuovi targets per i periodi di commitment 2013-2017,
2018-2022 e così via. Gli sforzi verso il futuro accordo si articolano attualmente su tre
livelli: il Kyoto Protocol Review process (Articolo 9 del protocollo), l’Ad-Hoc Working Group
(AWG-KP) che discute dei nuovi targets per i paesi Annex 1 (Article 3.9 del protocollo) and
il Dialog on Long-Term Cooperative Action (AWG-LCA) che coinvolge i paesi come gli USA
che non hanno ratificato il Protocollo di Kyoto ma che hanno firmato la Convenzione
Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC).
Mentre i riflettori si vanno accendendo su Copenaghen, dove nel 2009 si svolgerà la
COP15 (il Protocollo di Kyoto fu firmato al COP3) e dove secondo le speranze di molti
dovrebbe essere raggiunto l’accordo sul nuovo regime che apra la strada alle negoziazioni
ed al processo di ratifica da concludersi entro la fine del 2012 (l’Italia sarà presidente di
2
turno del G8), appare chiaro che l’accordo deve soddisfare alcuni requisiti. Esso deve
essere profittevole per essere sottoscritto da ciascun paese: i benefici devono cioè per esso
superare i costi, così da essere preferibile all’assenza dello stesso. L’accordo deve però
anche essere sostenibile e per questo deve essere stabile nel tempo: non devono al
proposito esserci incentivi al free riding. In linea di principio uno schema di trasferimenti
(finanziari, di tecnologie, o altro) da alcuni paesi ad altri o ai potenziali free riders può
soddisfare i requisti menzionati. Sfortunatamente, tanto più alti i benefici tanto più elevati
gli incentivi al free riding che non possono essere compensati da opportuni trasferimenti.
Di fatto il cuore del problema è rappresentato dall’esigenza di coinvolgere i grandi
emettitori tra i paesi in via di sviluppo, i paesi del BRIC più Sud Africa: per volume di
emissioni totali prodotte è necessario che questi paesi assumano degli obblighi di
riduzione, per stadio di crescita economica e per livelli di emissione pro capite è
oggettivamente difficile pretendere da essi obblighi analoghi a quelli dei paesi sviluppati.
Su questo punto il negoziato è rimasto finora bloccato, con da un lato i paesi interessati
che non ci sentono sull’assunzione di obblighi e dall’altro gli Stati Uniti d’America che per
tutto il mandato del presidente Bush si sono ostinatamente rifiutati di assumersi le
responsabilità che competono al paese con maggiori emissioni pro capite al mondo. Ma,
almeno per quanto riguarda questo paese, il vento sta cambiando.
La “speranza” americana
Nel presidente-eletto Obama i sostenitori della lotta ai cambiamenti climatici ripongono
consistenti speranze. Uno dei punti qualificanti del suo programma elettorale è
l’investimento in fonti pulite di energia – più di 150 miliardi di dollari in tecnologie
energetiche verdi nell’arco di dieci anni – al fine di ridurre la dipendenza statunitense dal
carbonio. La nuova amministrazione intende varare un programma federale secondo cui il
25% di elettricità dovrà provenire da fonti rinnovabili entro il 2025. Obama intende anche
varare una legislazione che renda tutti i nuovi edifici carbon free entro il 2030. Una delle più
importanti novità che il presidente eletto intende introdurre è un sistema federale di capand-trade, analogo al mercato europeo dei permessi al fine di ridurre le emissioni di
anidride carbonica dell’80% entro il 2050.
La crisi finanziaria potrebbe rendere nell’immediato difficile far passare in congresso un
programma così ambizioso, stante l’impossibilità per la maggioranza democratica di
bloccare l’eventuale ostruzionismo. Ma Obama dispone di diversi poteri di iniziativa nel
campo delle energie pulite, compresa l’imposizione di nuovi standard di efficienza nel
settore dei trasporti, che possono essere esercitati nel breve termine.
E in direzione opposta a quella del suo predecessore Obama potrebbe usare I suoi poteri
esecutivi per ordinare, senza bisogno di approvazione da parte del congresso, all’agenzia
federale per l’ambiente – l’Environmental Protection Agency – di regolamentare le emissioni
di gas serra nel quadro del Clean Air Act.
Appare dunque comprensibile come, date queste premesse, molti si attendano
un’inversione di rotta nell’atteggiamento degli Stati Uniti al tavolo del negoziato
internazionale, soprattutto in vista dell’appuntamento di Copenaghen.
Un appuntamento al quale l’Unione Europea intende presentarsi forte dell’approvazione
di un pacchetto di misure di riduzione delle emissioni domestiche con l’obiettivo di
condizionare il negoziato globale verso un esito favorevole alla lotta al riscaldamento.
La “presunzione” europea
3
Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha approvato la nuova strategia europea, denominata
“Una politica integrata del clima e dell’energia”. Ribadendo l’obiettivo strategico di
limitare l’aumento della temperatura media globale a 20C al di sopra del livello preindustriale, la decisione adottata prevedeva l’assunzione unilaterale di tre obiettivi
vincolanti per l’intera Unione, caratterizzati da un ricorrente numero “magico”, il 20.
Entro il 2020 l’Unione Europea si impegna a ridurre le emissioni di gas-serra del 20 per
cento rispetto al 1990, a portare la quota di fonti rinnovabili di energia sul totale
consumato al 20 per cento e di elevare l’efficienza energetica (rapporto consumi di energia
su Pil) al 20 per cento. La strategia è divenuta successivamente nota come pacchetto “2020-20”. L’UE faceva in realtà di più: essa ha assunto l’impegno a portare la riduzione delle
emissioni al 30% nel caso di accordo internazionale che impegni allo stesso modo paesi
sviluppati come gli USA e i paesi in via di sviluppo, questi secondo le proprie capacità.
Entro il 2050 le riduzione diventerebbero del 60% e dell’80% rispettivamente.
Gli obiettivi della politica energetica europea che il pacchetto 20-20-20 si prefigge non
riguardano tuttavia solo i cambiamenti climatici, ma anche la sicurezza energetica e un
mercato interno competitivo dell’energia. Sotto questo profilo va osservato che in linea di
principio la lotta ai cambiamenti climatici si fa anche solo con il primo dei tre obiettivi,
quello della riduzione delle emissioni. Gli altri due elementi servono evidentemente anche
altre finalità non meno importanti che l’UE intende perseguire: mantenere la leadership
politica e la propria influenza nel contesto delle nuove potenze mondiali, acquisire una
leadership tecnologica (nucleare in Francia, solare in Germania, cattura e sequestro del
carbonio…), ridurre della dipendenza energetica dall’estero e dalle fonti fossili attraverso
la ricerca, sviluppo e adozione di nuove tecnologie energetiche e la creazione di una nuova
industria a esse collegata, cui infine aggiungere la sincera preoccupazione ed il buon
esempio, con un occhio agli impatti dei cambiamenti climatici nel continente europeo
(ondate di calore, agricoltura, uragani e precipitazioni piovose e nevose…),
Naturalmente l’assunzione di un impegno globale europeo si traduce necessariamente
nell’assunzione di obblighi per ciascuno Stato membro. Dopo quasi un anno di analisi di
impatto, a gennaio 2008 la Commissione presenta un pacchetto di proposte costituito da
una serie di direttive, le più importanti ai fini presenti sono due sulla riduzione delle
emissioni e una sulle fonti rinnovabili. L’elemento centrale della strategia europea, la sua
spina dorsale, resta l’ETS, il mercato dello scambio dei permessi attivato nel 2005 ed
entrato nella sua seconda fase, quella 2008-2012. Lo strumento, previsto dal Protocollo di
Kyoto, consente agli attori soggetti a controllo delle proprie emissioni di raggiungere il
target con la maggiore flessibilità, e cioè con i costi più bassi possibile. Se sono virtuosi
potranno vendere la differenza positiva tra il proprio obiettivo e le proprie emissioni,
ottenendo un guadagno; se non sono virtuosi, con emissioni superiori al proprio target,
potranno acquistare permessi sul mercato a un prezzo che avranno giudicato inferiore a
quello che avrebbero dovuto pagare per ridurre le proprie emissioni “in casa”. Entrambi
gli attori, che offrono e che domandano, hanno in questo caso la possibilità di scegliere tra
modificare il proprio livello di emissioni in relazione al target ovvero compravendere la
differenza sul mercato sotto forma di permessi. Si tratta dunque di una soluzione costoefficiente, rispetto all’alternativa dell’obbligo secco (con sanzioni per le inadempienze) per
ciascuno di soddisfare il proprio obiettivo. Cruciale in questa situazione è la distribuzione
degli impegni ai singoli attori, in modo che sia compatibile con il target complessivo
europeo. Le proposte di direttiva della Commissione contengono perciò una declinazione
a livello di Stati membri degli obblighi loro imposti compatibili con l’obiettivo del 20 per
4
cento. La proposta di burden sharing deve anzitutto assicurare che, dati e simulazioni alla
mano, la compatibilità sia assicurata, e vuole inoltre valutare quali siano i costi e i benefici
dell’intera strategia, nonché quelli per i singoli Stati con la ripartizione degli oneri
ipotizzata.
Anche per le rinnovabili è previsto un analogo meccanismo di flessibilità, rappresentato
dalla possibilità di acquistare e vendere titoli su un nuovo mercato, quello delle garanzie
d’origine, simile ai certificati verdi nazionali, nel caso in cui la propria quota di energie
rinnovabili fosse inferiore (o superiore) al proprio target nazionale. Un altro meccanismo
di flessibilità che, come il precedente, svolge la funzione di permettere ai singoli di non
soddisfare “fisicamente” il proprio target, senza però violare quello europeo.
I costi in termini di Pil per l’Unione e per i singoli Stati membri dell’intera strategia sono il
risultato di una lunga e complessa serie di simulazioni che si basano sul confronto tra il
baseline scenario, lo scenario di riferimento al 2020, con altri in cui si attuano le direttive
proposte, e che come tali costituiscono gli scenari “vincolati” o di policy. Quelli considerati
variano tra loro per diversi aspetti, ma soprattutto per il diverso grado di operatività dei
meccanismi di flessibilità. Ed è sui costi dei vari scenari che è andata in onda una disputa
che ha visto protagonista il governo italiano affiancato da quello di una serie di paesi
dell’Europa orientale, Polonia in primis.
Costi, sempre costi, solo costi
Era da tempo che non si assisteva a uno scontro così deciso tra il governo italiano e la
Commissione europea come quello in atto sul cosiddetto pacchetto clima. Così come è
stata posta dai nostri rappresentanti, e ripresa e amplificata dalla stampa, sembra essere
una questione di numeri. In realtà non è così, è una questione politica.
Spesso diversi scenari sono simulati per vedere il grado di variabilità delle stime ottenute
– in questo caso i costi – rispetto a quelle centrali scelte come le più ragionevoli, realistiche
o preferibili. Lo scenario su cui la Commissione europea ha basato le sue valutazioni è
quello che prevede l’operatività dei vari meccanismi di flessibilità, in particolare lo
scambio di garanzie di origine sulle rinnovabili e la possibilità (limitata) di accreditare alle
imprese europee le minori emissioni associate a progetti e impianti che esse realizzassero
nei paesi in via di sviluppo: si tratta dei cosiddetti CDM previsti dal Trattato di Kyoto.
Questo ricorso, ancora una volta, può essere per il singolo attore meno oneroso delle
opzioni alternative di cui dispone per raggiungere il proprio target. I costi di questa
strategia che sfrutta la flessibilità variano tra lo 0,45% e lo 0,60% del Pil europeo e tra lo
0,51% e lo 0,66% del PIL italiano. Il Governo nazionale ha invece sostenuto che per noi
sono pari al doppio, l’1,14 per cento del Pil, ossia 181,5 miliardi di euro cumulativamente
ovvero 18,2 miliardi in media d’anno. La soluzione del contrasto sta nello scenario preso a
riferimento, in quanto l’Italia ha selezionato quello privo di qualsiasi meccanismo di
flessibilità per rinnovabili e CDM. Non vi sono numeri inventati, fasulli o più veri. Vi sono
solo numeri, corrispondenti a diverse ipotesi di scenario, ognuno associato a modalità di
implementazione delle stesse direttive. Nessuna ipotesi mette in discussione l’impianto di
fondo e i principi del pacchetto 20-20-20, ma guarda semplicemente all’impatto sui costi
complessivi della presenza o meno, e in diversi gradi, dei meccanismi di flessibilità
previsti. È dunque singolare che il governo italiano, liberista sulla carta, vada a selezionare
a sostegno delle proprie tesi proprio quello scenario che non prevede, anzi nega, un ruolo
ai mercati e alla flessibilità.
5
L’ottica distorta dell’Italia
Non vi è dunque uno scenario giusto né uno sbagliato; ve ne sono diversi e
ragionevolmente la Commissione europea ha selezionato quello che fa un favore agli Stati
membri in quanto porta a minimizzare per essi i costi delle direttive proposte. Questo
appare essere stato ben compreso dagli altri importanti paesi dell’Unione – Germania,
Francia, Spagna – atteso che quest’ultima ha addirittura un costo stimato superiore al
nostro ed atteso che la crisi finanziaria riguarda tutti quanti e non solo noi.
Il presidente di turno Sarkozy vuole chiudere entro dicembre con una decisione definitiva
e ha messo in chiaro che l’arma del veto minacciato dal nostro primo ministro è spuntata,
in quanto inefficace. I numeri assumono allora il valore di una scusa per cercare di
prendere tempo e cercare di ottenere condizioni più vantaggiose nella ripartizione degli
oneri tra paesi membri. Siamo in compagnia di otto paesi dell’Europa dell’Est, unico tra i
fondatori ad adottare una posizione di scontro e chiusura con la Commissione e gli altri
stati membri che contano. Non è una bella cosa. La partita poteva essere giocata meglio e
si doveva tenere presente che tutti i nostri partner hanno visto il comportamento da cicala
delle emissioni che l’Italia, governi di centrosinistra o di centrodestra, ha tenuto finora e
che ci colloca ampiamente fuori rotta rispetto all’appuntamento di Kyoto.
La Confindustria è andata sostenendo che il pacchetto europeo avrebbe conseguenze fatali per la
nostra industria, provocando perdita di occupazione, di competitività e delocalizzazione
all’estero di molte attività produttive. Le misure sarebbero inique in quanto l’industria
italiana è tra le più efficienti sotto il profilo energetico, mentre finirebbe per dovere
sostenere una quota dei costi totali superiore alla quota del PIL nazionale su quello
europeo. Queste argomentazioni non appaiono decisive: un’elevata efficienza energetica
non implica sconti sullo sforzo di riduzione delle emissioni che sono cresciute
proporzionalmente di più rispetto al 1990 di quelle di altri paesi europei. Più in generale
non si può non riconoscere che svolte nella politica energetica e del clima di questo tipo, la
cui importanza e necessità è da tutti riconosciuta, comportano aggiustamenti
nell’economia che riguardano anche i settori produttivi. L’industria delle rinnovabili
fiorisce, le industrie energivore soffrono: riallocazioni sono dolorose ma necessarie.
L’esigenza è allora quella di favorirle attutendo per quanto possibile i costi
dell’aggiustamento. Ma le proposte di direttiva, con l’assegnazione gratuita, almeno
all’inizio, dei permessi di emissione , la possibilità di opting-out per le piccole imprese dal
mercato delle emissioni, fino alla discussa possibilità di imporre border tax adjustments (cioè
dazi all’import) per le produzioni più a rischio di perdita di competitività, svolgono
esattamente quella funzione. Altri dubbi, quali quello sull’efficacia del mercato dei
certificati delle emissioni e delle GO, sono in realtà inconsistenti in quanto svilirebbero
l’intera impostazione del pacchetto UE fondato, come visto, su un meccanismo di sostegno
degli obiettivi che metta in concorrenza i soggetti virtuosi rispetto ai ritardatari dando a
questi ultimi la possibilità di rimediare attraverso la negoziazione delle quote d’obbligo a
livello europeo. Lo scambio dovrebbe incentivare gli investimenti anche alla luce di
poterne esportare la realizzazione negli altri paesi UE. Sarebbe anche un’opportunità per
avere vantaggi di prima mossa in paesi non UE che decideranno successivamente di
promuovere le tecnologie per la riduzione delle emissioni o la produzione di energie
rinnovabili. Infine, mercati diversi da quelli europei sia in dimensione sia in termini di
disponibilità dei servizi energetici per l’intera popolazione potrebbero essere interessati ad
acquistare tecnologie per la fornitura energetica.
6
L’Italia è, all’interno di una corretta interpretazione dei dati e delle finalità del pacchetto
clima, un paese che può avere ampi benefici e ricadute positive anche alla luce del proprio
tessuto industriale. L’importante è guardare avanti alle opportunità offerte dalla nascita di
nuovi mercati e dall’innovazione tecnologica e non rimanere vincolati alla difesa di uno
status quo che a lungo andare non paga e svilisce lo stesso significato di crescita
economica.
Italia: “a great leap forward”?
Più in generale, infine, i numeri da tutti citati enfatizzano i costi, ma non tengono
adeguato conto dei benefici. Quale è l’entità dei danni dei cambiamenti climatici evitati
dalle direttive se dovessero entrare in vigore? Quale è l’entità dei cosiddetti co-benefici
rappresentati da guadagni occupazionali netti, da proventi connessi all’innovazione
tecnologica? Quale il costo di interventi alternativi come tasse sul carbonio, quali i benefici
in termini di minori emissioni di altri inquinanti connessi al pacchetto? Quale il risparmio
di spesa sui combustibili fossili e quale il beneficio per la nostra bilancia commerciale?
Il Consiglio Europeo dopo l’incontro del 15 e 16 ottobre di Bruxelles ha confermato nelle
conclusioni la propria determinazione a tener fede agli impegni concordati nel marzo 2007
e nel marzo 2008, con l’obiettivo di giungere ad un accordo complessivo entro la fine
dell’anno. Se non si arriverà ad una soluzione condivisa è probabile, secondo alcuni
osservatori, che nel caso in cui l'Italia insistesse nel suo ostruzionismo, l'Europa alla fine
andrà avanti senza il nostro paese. Un'occasione persa, se come sembra Germania, Regno
Unito, Francia e Spagna (un paese molto lontano dall’obiettivo di Kyoto), accettando
questa sfida nel campo dell’innovazione, sono invece consapevoli che ne potranno
ottenere notevoli benefici anche per l’economia. A tal proposito, secondo le stime del
Politecnico di Milano e dell'Anev con interventi decisi nei settori dell'efficienza energetica
e delle fonti rinnovabili si possono creare in Italia almeno 120.000 nuovi posti di lavoro.
Queste considerazioni ci riportano alla crisi finanziaria ed economica che stiamo
attraversando. E’ lecito sulla base di quanto detto finora chiedersi se questa crisi, destinata
come tutte prima o poi a finire, non costituisca un’occasione propizia per iniziare la
transizione verso un’economia a basso tenore di carbonio. La sfida è, nel momento in cui i
governi si trovano ad intervenire a sostegno del sistema produttivo e dei bilanci familiari,
quella di legare gli interventi all’ambiente così da innescare quell’effetto moltiplicativo
che, attraverso il rilancio dell’industria dell’energia pulita, degli interventi sull’efficienza
energetica, la spinta all’innovazione tecnologica amica dell’ambiente, ci faccia uscire dalle
secche della recessione e dall’equilibrio di sottoccupazione. A livello di
occupazione puntare sulle aziende “verdi” sarebbe molto più conveniente che non
rattoppare i buchi delle compagnie finanziarie: secondo un rapporto pubblicato dal Center
for American Progress investendo 100 miliardi di dollari in rinnovabili e risparmio
energetico si creerebbero 2 milioni di posti di lavoro, molti dei quali in settori duramente
colpiti dalla crisi, come l’edilizia. Con lo stesso denaro investito nei servizi finanziari,
invece, i posti sarebbero circa la metà. Un investimento nell’industria verde delle
dimensioni del buco creato a Wall Street potrebbe favorire una crescita ancora più grande,
eliminando praticamente la disoccupazione e incrementando significativamente i redditi
della classe media. Una nuova multimiliardaria economia verde potrebbe rimettere in
piedi non solo l’America ma anche Wall Streeet. I benefici indiretti poi sarebbero molti
più vasti, prevenendo una minaccia finanziaria anche più grande di quella attuale: il
riscaldamento globale. Come ci ricordano per esempio le stime del famoso Rapporto Stern
7
i costi dovuti agli effetti del global warming (aumento delle malattie, alluvioni, siccità,
ecc.) oscillerebbero tra il 5 e il 20% del prodotto interno lordo mondiale: per i soli Stati
Uniti una botta da 3,8 milioni di miliardi ogni anno. A questo va aggiunto il vantaggio di
iniziare una graduale uscita dalla dipendenza dalle fonti fossili e dai loro elevati prezzi.
E come potrebbe inserirsi il nostro paese in questo New Deal Sostenibile? A fine ottobre,
dopo ore di intensa discussione nella House of Commons i membri del parlamento
britannico hanno approvato a larghissima maggioranza il Climate Change Bill che comporta
l’assunzione dell’obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra per almeno l’80% entro
il 2050. Il provvedimento è stato inoltrato alla House of Lords per diventare definitivamente
legge del Regno Unito.
Agli inizi di novembre il governo finlandese ha approvato una strategia di lungo termine
per l’energia e il clima che prevede la riduzione delle emissioni, il taglio ai consumi di
energia e una spinta all’uso delle fonti rinnovabili. Il comunicato del governo afferma che
“la strategia mostra chiaramente che gli obiettivi del pacchetto clima dell’Unione europea
per la Finlandia non possono essere raggiunti senza nuove, significative azioni di politica
climatica ed energetica”.
Quanto all’Italia, la disputa sul pacchetto europeo e la posizione di estremo svantaggio
circa il livello di emissioni rispetto agli obblighi assunti pongono con forza la necessità di
prendere il toro per le corna, varando – accanto alla strategia nucleare che in ogni caso
potrà tornare utile non prima del 2018-2025 – una organica strategia fatta da coerenti
politiche e misure che sappiano coniugare la gradualità che la crisi attuale comanda con la
severità che gli impegni richiedono. Una strategia di leapfrogging: un disegno ambizioso
che consentirebbe al nostro paese di passare da ultimo a uno dei primi della classe.
E se è vero che il mondo non finisce nel 2020, come notano i fautori del ritorono al nuclare,
è anche vero che la caratteristica principale che caratterizza la vita e le abitudini degli
esseri umani, le decisioni dei governi, la struttura dei sistemi economici in generale e dei
sistemi energetici in particolare è la path dependance, l’inerzia, la persistenza che
difficilmente renderà indipendenti le sorti della lotta al clima nella seconda metà del
secolo da ciò che è stato deciso e che è stato non deciso nelle prossime decadi.
Marzio Galeotti
Consiglio d’indirizzo di Glocus
Università degli studi di Milano, IEFE-Bocconi, redazione lavoce.info
8