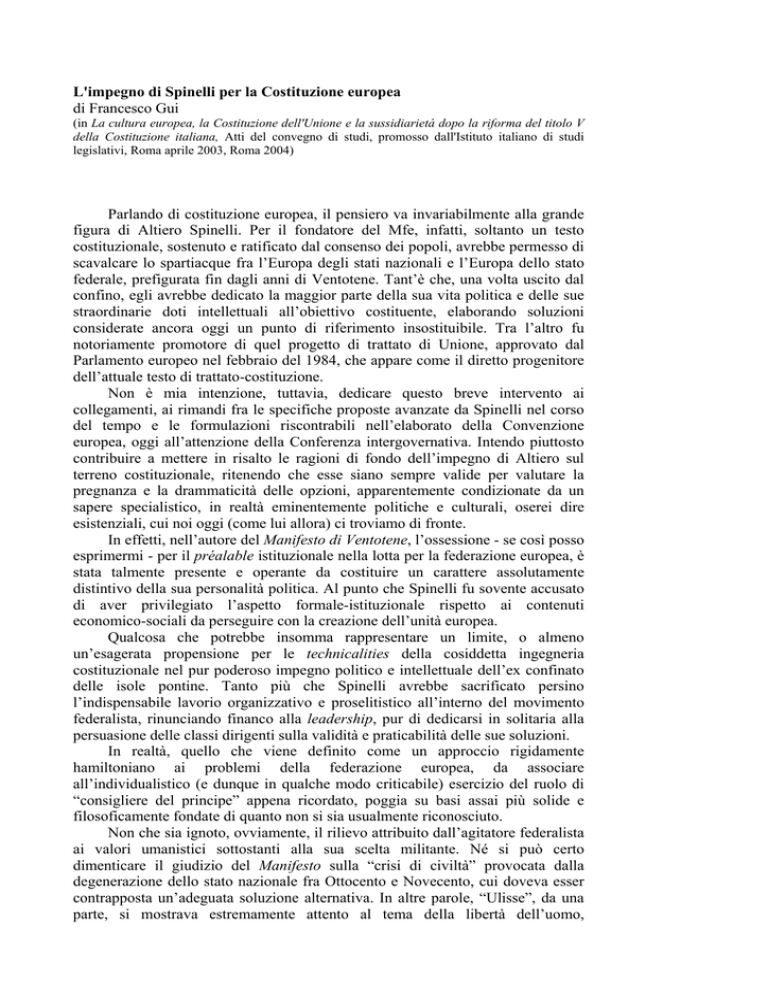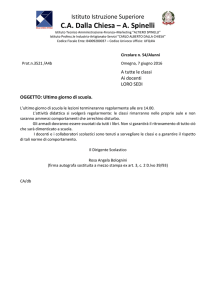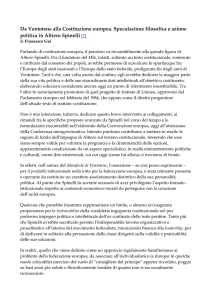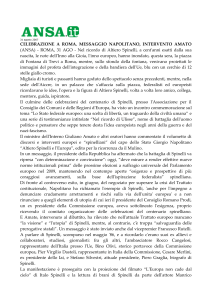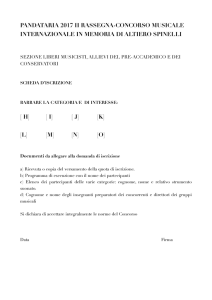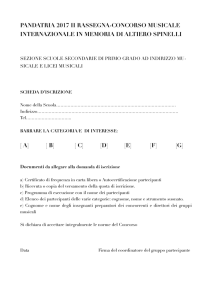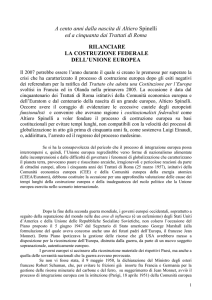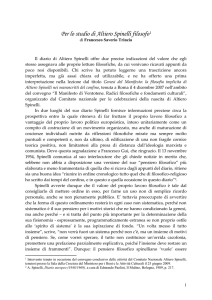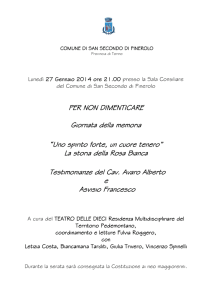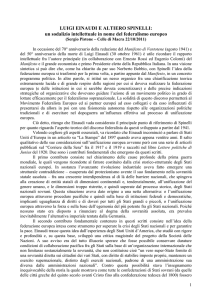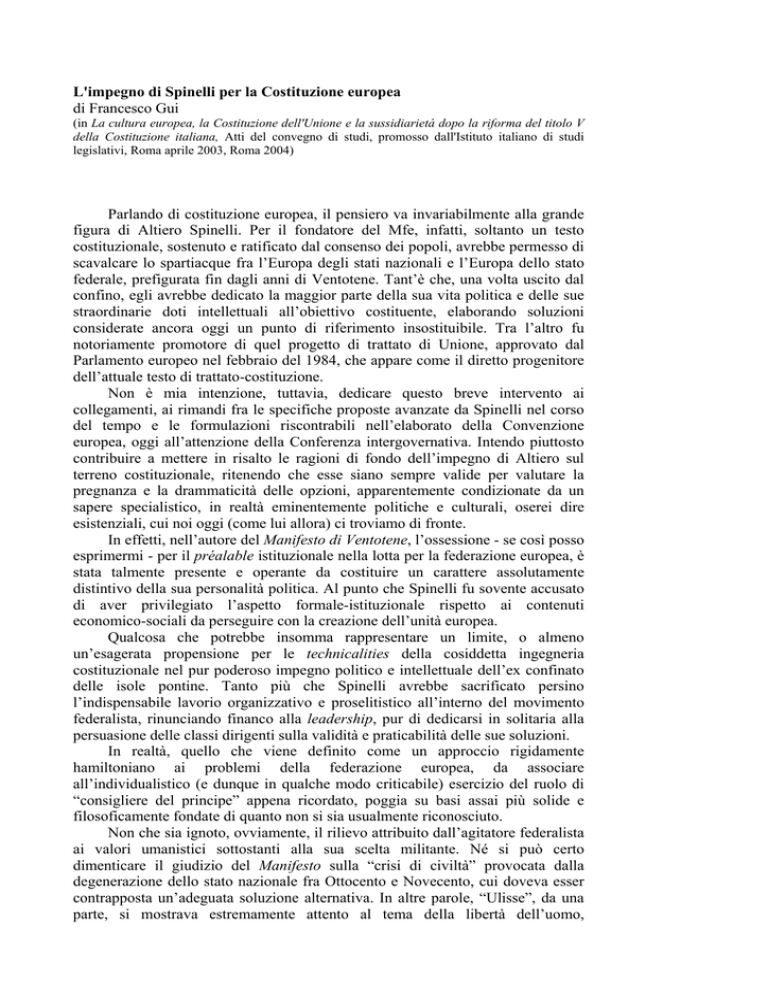
L'impegno di Spinelli per la Costituzione europea
di Francesco Gui
(in La cultura europea, la Costituzione dell'Unione e la sussidiarietà dopo la riforma del titolo V
della Costituzione italiana, Atti del convegno di studi, promosso dall'Istituto italiano di studi
legislativi, Roma aprile 2003, Roma 2004)
Parlando di costituzione europea, il pensiero va invariabilmente alla grande
figura di Altiero Spinelli. Per il fondatore del Mfe, infatti, soltanto un testo
costituzionale, sostenuto e ratificato dal consenso dei popoli, avrebbe permesso di
scavalcare lo spartiacque fra l’Europa degli stati nazionali e l’Europa dello stato
federale, prefigurata fin dagli anni di Ventotene. Tant’è che, una volta uscito dal
confino, egli avrebbe dedicato la maggior parte della sua vita politica e delle sue
straordinarie doti intellettuali all’obiettivo costituente, elaborando soluzioni
considerate ancora oggi un punto di riferimento insostituibile. Tra l’altro fu
notoriamente promotore di quel progetto di trattato di Unione, approvato dal
Parlamento europeo nel febbraio del 1984, che appare come il diretto progenitore
dell’attuale testo di trattato-costituzione.
Non è mia intenzione, tuttavia, dedicare questo breve intervento ai
collegamenti, ai rimandi fra le specifiche proposte avanzate da Spinelli nel corso
del tempo e le formulazioni riscontrabili nell’elaborato della Convenzione
europea, oggi all’attenzione della Conferenza intergovernativa. Intendo piuttosto
contribuire a mettere in risalto le ragioni di fondo dell’impegno di Altiero sul
terreno costituzionale, ritenendo che esse siano sempre valide per valutare la
pregnanza e la drammaticità delle opzioni, apparentemente condizionate da un
sapere specialistico, in realtà eminentemente politiche e culturali, oserei dire
esistenziali, cui noi oggi (come lui allora) ci troviamo di fronte.
In effetti, nell’autore del Manifesto di Ventotene, l’ossessione - se così posso
esprimermi - per il préalable istituzionale nella lotta per la federazione europea, è
stata talmente presente e operante da costituire un carattere assolutamente
distintivo della sua personalità politica. Al punto che Spinelli fu sovente accusato
di aver privilegiato l’aspetto formale-istituzionale rispetto ai contenuti
economico-sociali da perseguire con la creazione dell’unità europea.
Qualcosa che potrebbe insomma rappresentare un limite, o almeno
un’esagerata propensione per le technicalities della cosiddetta ingegneria
costituzionale nel pur poderoso impegno politico e intellettuale dell’ex confinato
delle isole pontine. Tanto più che Spinelli avrebbe sacrificato persino
l’indispensabile lavorio organizzativo e proselitistico all’interno del movimento
federalista, rinunciando financo alla leadership, pur di dedicarsi in solitaria alla
persuasione delle classi dirigenti sulla validità e praticabilità delle sue soluzioni.
In realtà, quello che viene definito come un approccio rigidamente
hamiltoniano ai problemi della federazione europea, da associare
all’individualistico (e dunque in qualche modo criticabile) esercizio del ruolo di
“consigliere del principe” appena ricordato, poggia su basi assai più solide e
filosoficamente fondate di quanto non si sia usualmente riconosciuto.
Non che sia ignoto, ovviamente, il rilievo attribuito dall’agitatore federalista
ai valori umanistici sottostanti alla sua scelta militante. Né si può certo
dimenticare il giudizio del Manifesto sulla “crisi di civiltà” provocata dalla
degenerazione dello stato nazionale fra Ottocento e Novecento, cui doveva esser
contrapposta un’adeguata soluzione alternativa. In altre parole, “Ulisse”, da una
parte, si mostrava estremamente attento al tema della libertà dell’uomo,
significativamente definito dal Manifesto “autonomo centro di vita”. Dall’altra,
era perfettamente consapevole della grandiosità delle forze in gioco e della
complessità dei fattori che concorrono alla creazione delle forme politico-culturali
della vita internazionale, nonché alle loro possibili trasformazioni. Tuttavia
Altiero stesso sembrerebbe aver steso un velo, tanto nell’attività politica che negli
scritti del dopoguerra, sul legame diretto sussistente fra l’elaborazione
intellettuale antecedente e la concretezza delle soluzioni proposte a classi dirigenti
e popoli.
Ciò malgrado, nella costante istituzionale spinelliana, è bene ribadirlo, il
fondamento teorico, sia di tipo filosofico, sia derivante da una riflessione storica
di lungo periodo, risulta assai più profondo, più “drammatico”, più radicalmente
motivato, nonché molto più intrecciato di quanto non si creda con l’apparente
tecnicismo, o con la sapienza vagamente manipolatoria (frutto di astuzia e di
sperimentata esperienza) riscontrabili in progetti di costituzione come quello da
lui elaborato, tanto per tornare al punto, attraverso l’ormai celebre Club del
Coccodrillo.
Per rendersene conto, è indispensabile rivolgere l’attenzione ad un periodo
molto lontano e decisamente oscuro della storia di Spinelli. Il periodo, intendo,
precedente alla redazione (assieme a Ernesto Rossi) del Manifesto di Ventotene,
durante il quale il giovane detenuto comunista, trovandosi rinchiuso nelle carceri,
e dunque con l’esperienza del confino ancora di là da venire, iniziò quel radicale
ripensamento delle concezioni marxiste che lo avrebbe condotto alla scelta
federalista. Si trattò di una lunga traversata nel deserto, nel corso della quale egli
sottopose ad una critica serrata buona parte delle ideologie e delle teorie del suo
tempo, dalle filosofiche alle economiche, finendo per riemergere da quella
dantesca visitazione delle profondità dello spirito con una mirabile chiarezza di
idee, unita ad una non meno determinata volontà di azione.
Peraltro, prima di addentrarmi in medias res, voglio nuovamente
sottolineare che il pur succinto approfondimento che intendo qui proporre, lungi
dal costituire un esercizio accademico o filologico, può risultare formativo per
venire intellettualmente alle prese con l’attuale fase della storia europea e con i
suoi problemi, ivi compreso, ovviamente, il tema costituente. Ai nostri giorni,
infatti, il vecchio continente, se per un verso ha recuperato unità e libertà rispetto
all’epoca della guerra fredda, dall’altro, essendo venuta meno buona parte delle
impalcature di sostegno allestite dalle due superpotenze, si trova esposto ai più
diversi rischi e pericoli, interni quanto esterni. Esso ha ripreso insomma a
navigare in mari quasi altrettanto aperti e forse non meno impegnativi di quelli
che si trovò a solcare nella prima metà del Novecento, con tutte le alee che ne
derivano.
Non a caso, recentemente, proprio nel nostro Paese, sono ricomparsi non
impalpabili inebriamenti del sentimento nazionale, i quali potrebbero pur risultare
felicemente temperati dalla propensione al rafforzamento dei legami con le
democrazie anglosassoni, ove non ci trovassimo nella disorientante contingenza di
constatare che, proprio attorno ai vertici di quelle stesse democrazie, la
statunitense in particolare, risulta in atto una singolare rivalutazione – leggere
Kagan per credere – delle logiche di potenza dell’Europa hobbesiana d’altri
tempi. Per sovrapprezzo, da quegli stessi ambienti, che si immaginerebbero intenti
soltanto all’esercizio pratico del potere, o tutt’al più all’elaborazione strategica
della politica, emana una ripulsa esplicita e professata della filosofia kantiana,
intesa come fondamento delle teorie del federalismo e della pace perpetua.
Di conseguenza non possiamo negare di trovarci di fronte ad un intenso
ripensamento, apparentemente teorico, ma dai riflessi estremamente concreti (e
dagli esiti alquanto degenerativi), dei principi della convivenza internazionale e
dei rapporti fra i popoli a cui eravamo stati abituati nel dopoguerra. Pertanto ci
troviamo sollecitati ad attrezzarci nel modo più conveniente, proprio a partire dal
piano delle idee prima di giungere alle soluzioni politico-istituzionali, per
fronteggiare la nuova temperie del nostro tempo. Ed è a mio avviso altamente
significativo – ma posso dirlo solo di passaggio – che a determinare tale temperie
concorra anche la perpetuazione nel Medio Oriente di quelle logiche, apertamente
avversate da Spinelli, dello stato nazionale superiorem non recognoscens, da cui
potrebbe discendere una nuova “crisi di civiltà” su scala mondiale.
Precisamente per queste ragioni, una presa d’atto della profondità e delle
ramificazioni delle radici intellettuali sottostanti al concretissimo federalismo di
Spinelli può aiutarci a tenerci all’altezza delle esigenti domande del presente. Del
resto, era sua salda convinzione, espressa in appendice a uno scritto di Rossi del
’42 che “le idee valgono sempre solo come direttive di effettiva operosità, tolta la
quale restano ombre tutte equivalenti tra di loro, e che con un leggero giuoco di
concetti possono convertirsi l’una nell’altra, integrarsi a piacere, e divenire
sempre più belle e seducenti…” (P. Graglia, Machiavelli nel secolo XX, pp. 1534). Idee dunque e attuazioni insieme.
Riprendendo la discesa nella preistoria interiore spinelliana, è abbastanza
noto che il ventenne prigioniero, entrato in carcere da militante comunista allevato
(seppur con incipienti dubbi) alla scuola di Gramsci, si avviò verso una precoce
emancipazione dal “dogma” marxista attraverso l’intensa lettura delle opere di
Croce, da cui assorbì la storicistica religione della libertà. Così almeno narra
Altiero stesso, anche se appare piuttosto probabile che il recupero di concezioni
liberali non venisse tutto dal suo sacco. Benché egli asserisca infatti di esser stato
nutrito di socialismo fin dalla più tenera età ad opera del padre, risulta
indubitabile l’interferenza di concetti riconducibili alla figura di Umberto Ricci,
zio materno legato al Salandra e piuttosto famoso economista di scuola liberale
classica, presto divenuto oppositore del fascismo.
Non è certo questa la sede per approfondire tale legame familiare, piuttosto
sottaciuto da Spinelli. Ma non si direbbe lecito dubitare dell’influenza duratura
esercitata dallo zio sulla personalità intellettuale del nipote, specialmente in tema
di concezioni economiche, arricchite di assai istruttive dipendenze dalla scuola
inglese e di influssi dell’antiprotezionismo meridionalistico, ambedue riscontrabili
nel retroterra del Manifesto. In ogni caso, tornando a Croce, non molto tempo è
passato da quando, nel corso di una ricerca presso l’Istituto Gramsci, la laureanda
Andreina Borgh reperì un fascicolo di lettere risalenti al periodo della detenzione
nel carcere di Viterbo e stranamente ignorate dalla storiografia vicina al Pci. Fra
quei fogli compariva la prova che l’appena venticinquenne Spinelli era giunto a
raccomandare al Partito comunista d’Italia una missione piuttosto sorprendente.
Quella cioè di dedicarsi a: sconfiggere il fascismo nel nome della libertà e non
della dittatura del proletariato, intensificare i legami con il movimento operaio
europeo, ammonire i compagni russi sulle tendenze pesantemente autocratiche
emerse al loro interno (Critica liberale, settembre 2001).
Nell’occasione, correvano gli inizi del ’32, i compagni di detenzione
percepirono abbastanza correttamente l’influsso del filosofo di Pescasseroli sul
corso dei pensieri del pur tenace (e fedele al partito) militante romano dalle
spiccate attitudini intellettuali. Peccato per loro, tuttavia, che l’evoluzione di quei
medesimi pensieri, contrariamente alle aspettative di rientro nei ranghi, non fosse
in realtà ancora terminata. E in effetti l’attenzione di Altiero verso il problema
della libertà lo avrebbe condotto abbastanza rapidamente a prendere le distanze
dallo storicismo crociano stesso, in quanto ritenuto una versione edulcorata, ma
comunque sempre deterministica, dell’idealismo hegeliano, oltre che della sua
deriva materialistica di stampo marxista.
In pratica, nel volgere di un quinquennio per noi piuttosto imperscrutabile,
data la perdita (salvo poche cose) dei manoscritti lasciati nel carcere di
Civitavecchia, l’emancipazione del futuro leader federalista dall’eredità
dell’idealismo sarebbe giunta a compimento. Per averne conferma, al di là delle
annotazioni riscontrabili nella suggestiva, quanto tarda autobiografia di “Ulisse”,
vale la pena di consultare innanzitutto i saggi inediti del periodo ventotenese,
pubblicati da Piero Graglia. In modo speciale, un passo del settembre ’41 mi pare
indicativo di come Spinelli fosse giunto a superare arditamente ambedue i due
pensatori che avevano conquistato le menti e i cuori dell’intellighentia italiana (e
che avrebbero continuato a tenerla avvinta anche nei decenni postbellici).
Scriveva Altiero, ancora fresco della scrittura del Manifesto, a un sedicente amico
“trotzkista”:
Qual è oggi il compito dei rivoluzionari? (Con questa parola intendo indicare coloro che vogliono
agire per risolvere in modo radicale i problemi di vita e di morte della nostra civiltà.) Bisogna dire
purtroppo che sinora i rivoluzionari italiani sono sotto un’influenza nefasta che impedisce loro di
elaborare in modo adeguato il compito che dovrebbero assolvere, e che li tiene pericolosamente
prigionieri di orientamenti tradizionali effettivamente sorpassati… Essa si compendia nei due
nomi di Marx e Croce. L’influenza marxista tende a fare accettare come dato originario la
divisione in classi, facendo trascurare l’esame del problema che l’ha generata, e di tutti gli effettivi
problemi che si pongono nell’attualità. L’influenza crociana tende a far accettare come dato
originario il formalistico, pomposo e fervoroso orientamento etico-politico, svalutando l’esame dei
concreti problemi politici, che scompaiono in quell’orientamento come le vacche di schellinghiana
ed hegeliana memoria nell’oscurità della notte. Questi due pensatori hanno finito in Italia per
completarsi a vicenda, fornendo il primo il contenuto e il secondo la forma della coscienza
politica, e cospirando insieme per tenerla chiusa nel vago e nel vecchio [corsivi miei]. (P. Graglia,
Machiavelli, p. 103).
Come si può notare, il nostro Pantagruel (questo il nomignolo dell’epoca,
ampiamente rivelatore di una personalità fin troppo debordante) aveva preso a
considerare obsoleti Marx e Croce proprio perché intendeva affrontare, anzi,
risolvere nel modo più efficace i problemi cruciali della sua epoca. Il che non
voleva dire accantonare il pensiero pensante dei due “nefasti”, bensì superarlo
sulla base di una nuova sintesi, in grado di conciliare più produttivamente il rigore
del raziocinio e quello dell’azione. Per questo egli si era immerso in quella lunga
peregrinazione cognitiva nei meandri della filosofia e lungo il corso della storia
che ne aveva fatto – parole sue - non soltanto un “cittadino del mondo”, ma un
“cittadino dei secoli” (P. Graglia, Machiavelli…, p. 163).
Per quanto attiene a Marx, che, come accennato, era stato sottoposto a
critica per primo, non è qui il caso di approfondire l’argomento, se non
sottolineando ulteriormente quell’accusa rivolta al pensatore tedesco di aver
ipostatizzato la divisione in classi della società. In effetti, Marx, benché ammirato,
gli appariva mitologico nelle formulazioni filosofiche e ormai superato dalla
scienza economica in tema di analisi dei meccanismi capitalistici. Ma soprattutto
quello che Spinelli non accettava – e qui sta il punto di maggiore interesse - era il
metodo di valutazione delle dinamiche sociali. Un qualcosa, in altre parole, che
aveva a che fare con la precisione dell’uso dell’intelletto. A suo avviso, infatti, la
divisione in classi non costituiva la “divisione reale e fondamentale della società”,
dal momento che l’errore di Marx e dei marxisti, una sorta di risorgente
“realismo” filosofico d’altri tempi, era di “partire da distinzioni accettate come
valide in sé, per poi determinare quali sono e quali debbono essere i problemi”.
Ma ragionando in quel modo:
si ritrovano così solo quei problemi che inconsciamente si erano già presupposti quando si erano
ammesse quelle distinzioni. L’impostazione va rovesciata. Bisogna determinare i problemi
generati dallo sviluppo della civiltà, e in conseguenza stabilire come si dispongono le forze sociali
(P. Graglia, Machiavelli…, p. 163).
Quanto a Croce, il suo superamento era avvenuto sull’onda della medesima
ricerca di chiarezza intellettuale. Per seguirne gli sviluppi, sono fortunatamente a
nostra disposizione alcuni scritti filosofici di Altiero degli anni del confino a
Ponza e a Ventotene, da tempo affidati all’archivio fiorentino delle Comunità, ma
rimasti tuttora trascurati e sostanzialmente inediti, fatta salva la mia intenzione di
pubblicarli, almeno parzialmente, il prima possibile. Tra i fitti ghirigori della
grafia penitenziaria spinelliana, tenacemente decrittata dai grandi occhi scuri della
laureanda Raffaella Cambise, abruzzese come i genitori di Altiero, si percepisce
tutta l’originalità e l’indipendenza intellettuale di colui che ebbe l’ardire di fare
della federazione europea il traguardo più rivoluzionario, quanto politicamente
realistico della storia contemporanea, oltre che lo scopo della sua vita successiva.
Alcune interessanti notazioni emergono in realtà già nelle lettere inviate da
Civitavecchia, nella primavera del ’36, al fratello Cerilo, per curarne in qualche
modo la formazione. Il particolare più stimolante è che Altiero, rispetto a Croce,
mostrava caso mai di preferire Gentile, quasi quasi prevenendo, verrebbe da dire
un po’ superficialmente, l’assai più tarda rivalutazione operata da Gennaro Sasso.
Osservava lo scrivente che “la semplicità di esposizione” di Croce era
riconducibile “alle sue grandi capacità di scrittore, ma molto più è dovuta al fatto
che egli sorvola sui problemi più difficili, e, col non trattarli, fa sembrare a prima
vista che non esistono”. Viceversa, Gentile gli appariva un “pensatore più
tormentato, e perciò il suo stesso stile… più contorto”. Però Altiero mostrava di
preferirlo. Certo, proseguiva, Gentile aveva “un’idea inadeguata dei momenti
soggettivo ed oggettivo costituenti la realtà”, cosa su cui il recluso si era a lungo
affaticato, elaborando soluzioni a suo avviso più avanzate, che aveva affidato ad
appunti inviati al fratello. Comunque, aggiungeva, “la correzione non deve far
cadere il concetto vivo gentiliano, che afferma essere il processo conoscitivo non
processo collaterale, o sia pure coronatore ma pur sempre parziale del processo
complessivo di autoformazione umana, ma che è questo stesso. Imparare,
conoscere è formarsi, agire”. (Lettera a Cerilo, da Civitavecchia, del 5 aprile ’36).
Unità dunque del conoscere e dell’agire, malgrado i limiti accennati
dell’impostazione gentiliana, cui Altiero riteneva appunto di aver riparato con le
sue riflessioni. Sotto questo profilo, uno scritto di poco successivo, sempre
indirizzato Cerilo e dedicato ai “due libri più importanti di Gentile per la
comprensione del suo pensiero… La teoria dello spirito come atto puro e il
Sistema di Logica”, risulta istruttivo. Annotava il fratello maggiore:
Nella Logica Gentile esamina nei suoi puri termini il problema del rapporto fra soggetto ed
oggetto, e, nei miei appunti io l’ho seguito sullo stesso campo logico per mostrare la deficienza
che c’è sotto il suo apparente rigore di ragionamento. Egli si atteggia infatti alla parte del
pensatore che ha portato la filosofia fino al punto in cui non plus ultra. E molti lo riconoscono per
tale. In realtà G. non ha cercato e non ha trovato che la formulazione più povera e più astratta del
concetto di spirito. Il pensiero – egli dice - è l’atto del pensare. L’atto del pensare si oggettiva, o
realizza, in un pensato, ma poiché il pensato è quello che è, determinato, finito, incapace di divenir
altro, il pensante, cioè l’atto, non si riconosce in quello, che è sì suo figlio ma suo figlio morto.
Perciò passa oltre a pensare ulteriormente senza acquietarsi mai. Questa sua analisi, che ti ho
riassunta in quattro righe, è il succo di tutto il pensiero gentiliano. Una volta raggiunto, l’ha
rimasticato in mille modi, e nella sua genericità essa può servire a tutti gli scopi, alti e bassi. Non è
certo un pensiero sbagliato questo suo, ma è incompleto.
Per parte sua Altiero riteneva di essersi spinto più avanti di Gentile, senza
peraltro negare la positività del punto di partenza di questi, ossia del rifiuto del
positivismo che aveva egemonizzato il pensiero ottocentesco:
Esso [il pensiero gentiliano] è sorto colla rinascita filosofica antipositivistica del primo decennio
di questo secolo ed ha affermato che l’essenza della realtà è il pensiero – concepito come azione.
Ma è restato alla semplice fase di reazione, e non si è sforzato di stabilire che la realtà – naturale e
storica – non è pensiero semplicemente perché è compresa dal soggetto pensante, ma che è tale in
sé stessa; non è cioè affatto quel morto ed inerte “pensato” che G. crede. (Lettera a Cerilo, da
Civitavecchia, del 4 maggio 1936).
Altiero peraltro aggiungeva che Gentile, “essendosi fermato al momento
soggettivo”, restava prigioniero - sintetizzo io - del formalismo dei moti dello
spirito, tipico dell’idealismo, in cui tutti “i gatti diventano bigi [e] qualunque cosa
accada egli l’approva; e quando accade il contrario fa lo stesso, e dice che ne è
stato il precursore”.
Il punto centrale, da evincere dal testo spinelliano e confermato in altri suoi
scritti del periodo, stava comunque nel fatto che la realtà, naturale e storica, non
era solo pensata dal soggetto pensante, e dunque inerte in sé, ma pensiero in se
stessa. E alle obiezioni del fratello, rimasto alquanto frastornato, replicava di lì a
poco così:
Circa quelle due proposizioni su Gentile che non ti son parse chiare. Per G. il “pensato”, l’oggetto
del pensiero, non ha una sua vita interna, un processo di autoformazione. Esso viene formato dai
“pensanti” e resta lì inerte, uguale a se stesso. Ora io dicevo che la realtà (la realtà oggettiva =
l’oggetto del pensiero) non è pensiero semplicemente in questo senso voluto da G., non è
sottomessa al semplice principio di logica formale di essere uguale a sé stessa di non contraddirsi;
ma è pensiero (= attività) essa stessa, è cioè un processo di formazione (= sottoposto al principio
dialettico di negazione di sé stessa, di contraddizione), ed è insieme un divenire oggettivo. (Lettera
a Cerilo, da Civitavecchia, del 1 giugno 1936).
L’attenzione al rapporto fra soggetto pensante e oggetto pensato si ritrova
riproposta in un lungo saggio, scritto a Ponza, nel maggio del ’38, e intitolato
“Rileggendo La filosofia dello spirito di Croce”. Non è certo qui la sede per darne
un resoconto completo, tuttavia può essere enucleato un passo sinteticamente
riassuntivo della critica a Croce, pur nell’apprezzamento per il suolo svolto da
don Benedetto nel ravvivamento dello spirito filosofico. Scriveva Spinelli:
Per C. l’identificazione fra storia e filosofia tenta di compiersi mediante la riduzione della seconda
alla prima, cioè cercandosi di determinare un elemento rappresentativo nella filosofia. Il tentativo
non riesce perché l’elemento rappresentativo è sempre, nel quadro filosofico, un quid negativo, ed
esistente solo come negato. Alla filosofia resta così solo l’analisi o definizione del momento
astratto della sintesi a priori. Onde una logica formale, analisi di forme vuote extrastoriche che si
riempiranno di infiniti contenuti storici, restando quelle tuttavia indifferenti a tutti questi.
L’identificazione di filosofia e storia deve invece compiersi in modo tale che scompaia il
formalismo della filosofia e la sua indifferenza al contenuto storico. La filosofia deve veramente
essere risposta a problemi, e perciò contenere come elemento costitutivo, conservato oltre che
negato il problema. Le categorie non debbono essere imposte dalla filosofia alla storia
autocraticamente, ma sorgere dall’interno stesso della storia, del problema. Solo così sarà possibile
attingere l’universalità (non extrastorica, non formale).
Se invece si resta sul terreno della definizione analitica e non della produzione dialettica del
concetto, si ha un bel protestare contro il concetto “statico” del sistema filosofico (ma quale
sistema più statico di questo di C.?); in realtà si crea un sistema statico, e se lo dichiara semplice
“sistemazione”storica, ciò è estrinseca affermazione del filosofo conscio della caducità del suo
sistema, e non cosa che balzi dal sistema stesso.
Un sistema che voglia veramente essere una sistemazione storica, deve avere l’elemento di
storicità come elemento costitutivo della stessa sistemazione.
Un’ulteriore precisazione, unita alla promessa, peraltro solo embrionalmente
attuata, di spingersi oltre i traguardi raggiunti dai maggiori filosofi italiani,
giungeva sempre nello stesso saggio, al paragrafo IX, intitolato “Pratica e teoria”.
In breve, si trattava dell’addio definitivo a Croce e Gentile, nel nome di un
soggetto particolarmente caro a Spinelli, nel nome di Prometeo, dell’individuo
che entra in lotta, non in sintonia, con “lo spirito universale” per trasformarlo
grazie al lavorio della sua coscienza:
Finché si resta sul gradino della coscienza produttiva (il soggetto che fa l’oggetto) non c’è che una
distinzione: quella fra il produrre ed il prodotto, come ha fatto Gentile, il quale ha perciò avuto il
merito di portare al punto estremo l’elaborazione del concetto di coscienza produttiva.
Perché sul nostro orizzonte sorgano teoria e pratica bisogna procedere oltre. Solo quando avremo
visto apparire il soggetto particolare, l’autocoscienza individuale che si è staccata dal flusso
originario della coscienza, e non la capisce più, ed è in lotta con essa, solo allora teoria e pratica
avranno un senso, poiché saranno il modo con cui l’individuo (che non è una manifestazione del
tutto bensì la negazione del tutto, non è “la situazione storica dello spirito universale” (della
coscienza), bensì il distacco violento da quello spirito universale), il modo, dico, con cui
l’individuo cerca di riunirsi al tutto. Ma così ci si apre tutto un orizzonte di ricerche filosofiche che
C. e, aggiungo, Gentile, non sospettano nemmeno.
La necessità di spingersi su simili orizzonti si ritrova anche nelle
“Osservazioni circa l'esaurirsi della filosofia contemporanea italiana”, del ’39, in
cui il giovane apprendista filosofo, nel constatare il limite dello storicismo e dello
spiritualismo, collocava il problema filosofico del suo tempo non già “nell'analisi
più o meno speculativa dell'intelletto, ma [nel ricercare la] genesi dell'intelletto
stesso, cioè in una ricerca fenomenologica”.
Nell’intelletto stava insomma l’oggetto dell’attenzione del sedicente
rivoluzionario federalista, il quale scriveva in una “Nota” buttata giù fra
novembre ’39 e gennaio ’40:
Chiameremo intelletto quest’attività giudicatrice, intendendolo nel più ampio senso
dell’autoaffermazione dell’io il quale realizza il suo mondo. Sarà bene metter definitivamente da
parte la questione se si tratti di teoria o di pratica. Abbiamo infatti qui contemplazione del mondo
fatto da noi, cioè teoria e pratica insieme.
Stavano qui, dunque, cioè nell’intelletto inteso come autoaffermazione
dell’io che realizza il suo mondo, nell’imbricazione di teoria e pratica, gli aspetti
essenziali della forma mentis – peraltro, direi, assolutamente immanentistica - con
cui Spinelli si apprestava a scrivere di lì a poco il Manifesto. Il quale Manifesto
consisteva, appunto, in quanto risultato delle meditazioni filosofiche del suo
autore, non già nella formalistica profezia che alla “crisi di civiltà” del suo tempo
lo spirito avrebbe fatto indefettibilmente seguire una nuova affermazione della
libertà. E non si riduceva nemmeno, ovviamente, ad una tecnicistica formulazione
di soluzioni istituzionali per l’Europa postbellica. Esso nasceva dalla convinzione
acquisita che la storia non fosse deterministicamente condizionata, che ogni sua
evoluzione fosse il risultato, non necessariamente scontato, di un’analisi e di un
atto volitivo dell’intelletto, dell’io, si è detto, che realizza il suo mondo. Tale
evoluzione consisteva infatti non in uno svolgimento, ma in un’innovazione non
prevedibile a priori, cioè in una reale creazione e scoperta, le cui determinazioni
ed attuazioni spettavano al medesimo io dell’intelletto.
Visto sotto questa luce, il Manifesto assume, mi pare, una valenza ancor più
generale di quanto non sia il pur eccezionale atto fondativo di una corrente
politica destinata ad avere un ruolo forse fondamentale nella nostra epoca. Esso si
proponeva come la via d’uscita per una civiltà in crisi, quella dello stato
nazionale, giunta ad un punto morto apparentemente insuperabile. Nel contesto,
una non immodesta concezione di se stesso convinceva Spinelli di aver
individuato la soluzione - sintetizzabile nel passaggio alla società dello stato
federale - come esito di un affannoso periodo di lotta contro “lo spirito
universale” in cui l’individuo, cioè lui stesso, aveva finito per riunirsi, da
vincitore, a quello spirito medesimo. Tutt’altra drammaticità di movenze, ad ogni
buon conto, rispetto al fiducioso abbandono alla “situazione storica dello spirito
universale” che avrebbe portato al superamento della crisi di civiltà.
Sì, perché nel mondo interiore di Spinelli la vittoria non consisteva
semplicemente nella superiorità potenziale di una concezione sull’altra, bensì nel
suo successo pratico e reale, nella sua affermazione sulla comunità degli uomini.
Pensiero e azione dovevano coincidere, verum e factum erano tenuti
vichianamente a convergere. Tant’è che “Ulisse”, come si deduce dalla prima
pagina del suo Diario, curato da Paolini, non si affidava neanche al rassicurante
formalismo della morale kantiana, dal momento che in lui l’ansia di aver visto (e
fatto) giusto prevaleva su quella, più benpensante, di muoversi a fin di bene,
avvenisse che può. Solo il successo era indice della grazia, il resto caducità.
Ora, è chiaro che simili concezioni, ispirate almeno in lui ad un’impietosa (e
pertanto onesta) ricerca del vero, avrebbero potuto sicuramente prestarsi, e
Spinelli ne era consapevole, a pericolose derive solipsistiche e superomistiche, in
cui il massimo bene e il massimo male avrebbero potuto confondersi. Difatti
l’ambizione del recluso a proporsi niccianamente come “legislatore del futuro” lo
avrebbe portato spesso a confrontarsi con la vertigine. Tuttavia l’io spinelliano
non pretendeva di essere unico, né che il mondo si esaurisse in un singolo campo
di attività, la politica. Pertanto il corso dei suoi pensieri lo portò ad un
attaccamento tenace alla “civiltà della personalità”, non alla “civiltà di massa”, al
vagheggiamento dello stato federale come comunità di individui, non di stati. Al
punto che proprio attorno a questi temi si verificò il dissenso con Colorni,
dissociatosi almeno in parte dalla redazione del Manifesto.
Colorni, infatti, dando prova della consapevolezza estrema con cui i
confinati di Ventotene guardavano alla “crisi di civiltà” prodotta dallo stato
nazionale, mostrava di accettare, pur di scongiurare una prossima guerra
mondiale, la prospettiva di uno stato comunista esteso dalla Russia alla Germania
e destinato a consentire nel tempo, e nella pace, la resurrezione dell’Europa.
Spinelli e Rossi, invece, si rivolgevano al mondo anglosassone e al federalismo
americano, come tutori, appunto, della “civiltà della personalità”. E non si può
negare che avessero visto meglio e giusto (P. Graglia, Machiavelli…, pp. 203-18,
268).
In ogni caso, Spinelli, privilegiata che ebbe la funzione dell’intelletto,
nonché postulata la coincidenza fra verità pensata e realtà fattuale, si sarebbe
dedicato da allora in poi a sperimentare, a mettere alla prova, per così dire, nel
vivo della lotta politica e dell’evoluzione storica i risultati raggiunti con le sue
precedenti meditazioni carcerarie. La sua vita successiva, quasi avesse rimosso
quella precedente, angustamente vissuta tra pagliericcio e bugliolo, ma in realtà
passata a fantasticare lungo i secoli e nell’infinità delle idee, consistette nella
tenace trasformazione in atti concreti, vincenti, segnati dalla “grazia”, ma spesso
anche minimi e minuti, di quel suo superamento filosofico dell’idealismo e dello
storicismo, a cui di fatto imputava di non aver saputo impedire la crisi dell’intera
civiltà occidentale.
Sotto questo profilo, lo strumento principe per la trasformazione del pensato
in agito gli appariva precisamente l’evento costituente, costituzionale, attraverso
cui la salvezza, il progresso della civiltà sarebbero stati assicurati. La qual cosa,
peraltro, se fosse stata vera, e dunque realizzabile, doveva apparire convincente
anche alle classi dirigenti democratiche europee, che l’uomo si sforzava di
persuadere con il suo metodo individualistico, proprio per dimostrare a se stesso
la prerogativa dell’intelletto e dell’io solitario di essere in grado di imporsi agli
altri, ricongiungendosi così con lo spirito universale.
E se il pensato non poteva essere qualcosa di caduco e di inerte, ma un
“processo di formazione”, allora anche lo strumento istituzionale, destinato a dare
la forma, il quadro di espansione della nuova civiltà, assumeva ben altre valenze e
ben altre potenzialità di quanto potesse apparire a prima vista. Asseriva infatti
Spinelli, difendendo il suo Manifesto nel corso dei dibattiti del ’42:
Il punto di vista federalista sembra a prima vista un semplice progetto di sistemazione giuridica
del diritto internazionale europeo. Pare che pure accogliendolo si possano mantenere in altri campi
della politica le vedute solite. Ma non appena lo si applica ad ogni singolo problema si vede che
questo si modifica radicalmente non solo nella sua soluzione, ma nella sua stessa impostazione.
Poiché c’è sempre una notevole differenza tra l’esser disposto a modificare le proprie vedute
abitudinarie ed il modificarle effettivamente, ogni nuova indagine fatta da quel punto di vista
implica uno sforzo ed una pena.
Ogni volta è un nuovo legame col passato che si spezza, ogni volta è un irriverente
maneggiamento di forze storiche che sinora ci avevano in qualche modo sorretto e che d’ora
innanzi intendiamo esser noi a sorreggere. Ci vuole un certo coraggio. (P. Graglia, Machiavelli…,
p. 136).
Questo è esattamente il punto. La costituzione europea non è soltanto uno
strumento giuridico. E non è nemmeno materiale inerte. Per maneggiarlo ci vuole
un certo coraggio. Un coraggio che spazia sui grandi orizzonti, ma conosce anche
la necessità di soffermarsi sui dettagli, forse anche sulle technicalities, pur di
adeguare il pensiero alla realtà:
Una battaglia non si vince solo studiando le regole della strategia in generale, ma decidendo ad un
certo momento di occupare quel colle, questo ponte, e portando poi le operazioni innanzi, a
seconda che lo si sia o no occupato. Siano benvenuti quelli che comprendono, poiché sono il sale
della terra, ma più benvenuti ancora siano coloro che si rimboccano le maniche, e con semplicità si
mettono al lavoro. Si sono nutriti del sale e l’hanno convertito in carne. (P. Graglia,
Machiavelli…, p. 127).
Il problema, naturalmente, è possedere la determinazione per provarsi a
ragionare in questo modo. Ed anche per credere che l’uomo non sia affidato a
forze superiori, ma arbitro del suo destino. Senza voler far proprio in ogni
dettaglio il pensiero di Altiero, il lascito che ci ha lasciato è più imponente e al
tempo stesso più impegnativo di quel che molti sospettano. Comporta un impegno
pratico, ma anche il compito di liberarsi faticosamente di molte mitologie del
passato, per giungere ad una precisione di giudizio scomoda, eppure il più
possibile rispondente alle esigenze fondamentali della propria civiltà:
Il pensiero politico non può uscire dalle strettoie attuali con una impossibile restaurazione dei
mistici valori crollati, ma proseguendo inflessibile lungo il cinico cammino di vedere le cose come
veramente sono. (P. Graglia, Machiavelli…, p. 169).
Per giungere a questi traguardi rigorosi, eppure, lo sappiamo, tutt’altro che
cinici nel sentimento, nelle intenzioni e nelle prospettive, Spinelli aveva compiuto
un percorso interminabile, non privo di innamoramenti irrazionali e di errori, ma
ormai era sicuro di essere giunto in porto, anche a costo, si è detto, di non voltarsi
più indietro. Ma chi volesse farlo per lui può ripercorrere la lettera inedita alle
sorelle, dell’agosto ’42. Vi è descritto l’itinerario di chi, per raggiungere la sua
verità, aveva osato separarsi dallo Spirito universale, crociano o marxiano che
fosse.