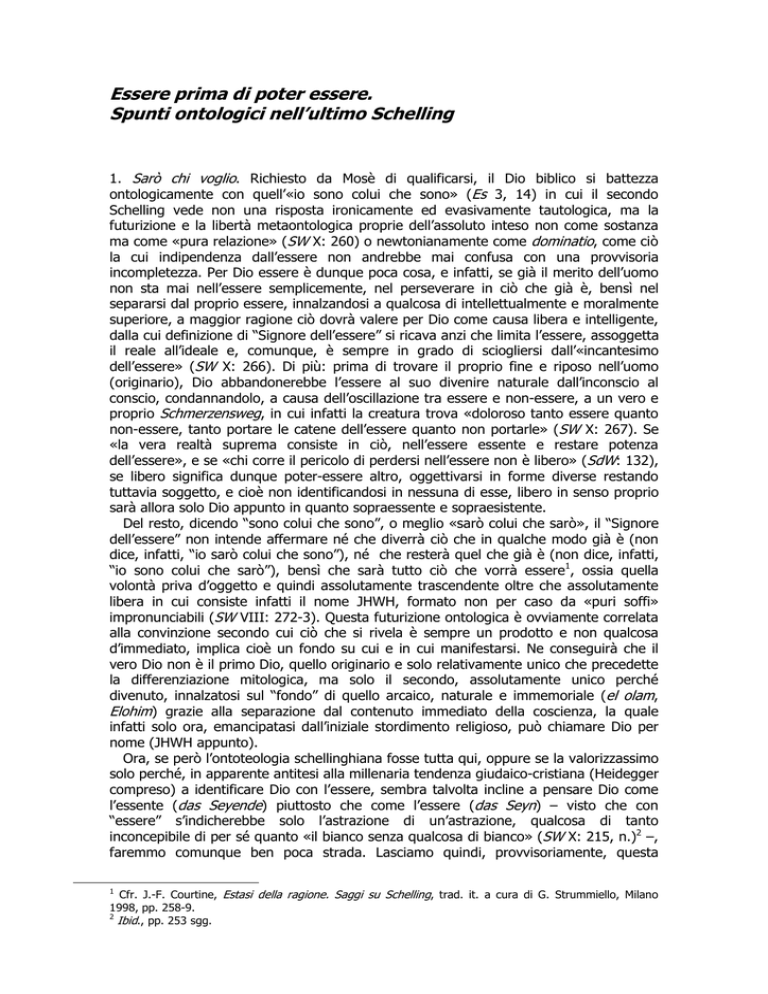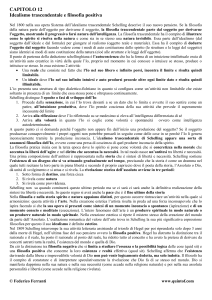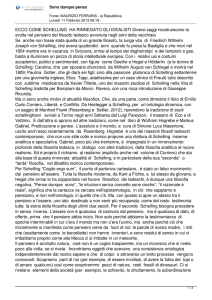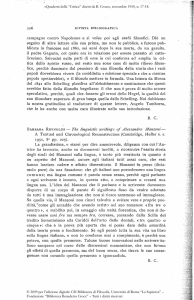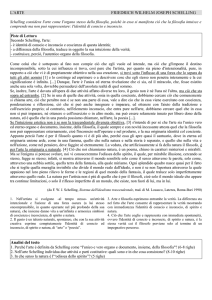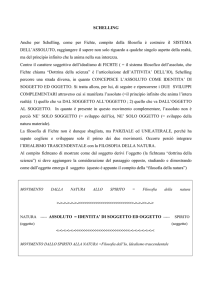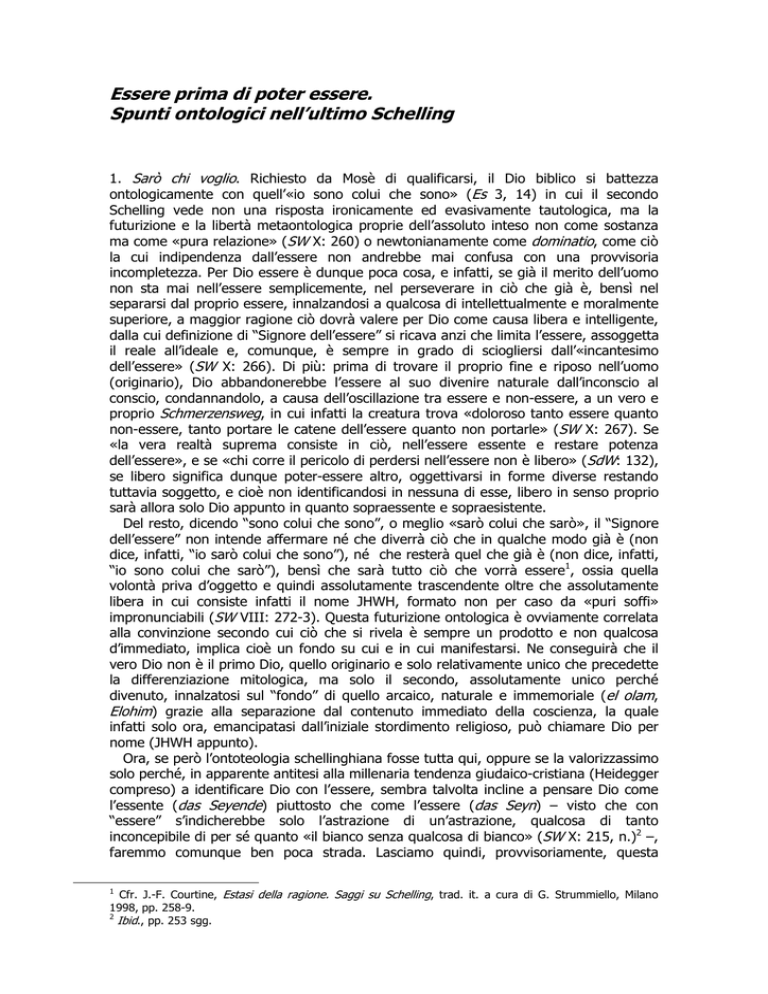
Essere prima di poter essere.
Spunti ontologici nell’ultimo Schelling
1. Sarò chi voglio. Richiesto da Mosè di qualificarsi, il Dio biblico si battezza
ontologicamente con quell’«io sono colui che sono» (Es 3, 14) in cui il secondo
Schelling vede non una risposta ironicamente ed evasivamente tautologica, ma la
futurizione e la libertà metaontologica proprie dell’assoluto inteso non come sostanza
ma come «pura relazione» (SW X: 260) o newtonianamente come dominatio, come ciò
la cui indipendenza dall’essere non andrebbe mai confusa con una provvisoria
incompletezza. Per Dio essere è dunque poca cosa, e infatti, se già il merito dell’uomo
non sta mai nell’essere semplicemente, nel perseverare in ciò che già è, bensì nel
separarsi dal proprio essere, innalzandosi a qualcosa di intellettualmente e moralmente
superiore, a maggior ragione ciò dovrà valere per Dio come causa libera e intelligente,
dalla cui definizione di “Signore dell’essere” si ricava anzi che limita l’essere, assoggetta
il reale all’ideale e, comunque, è sempre in grado di sciogliersi dall’«incantesimo
dell’essere» (SW X: 266). Di più: prima di trovare il proprio fine e riposo nell’uomo
(originario), Dio abbandonerebbe l’essere al suo divenire naturale dall’inconscio al
conscio, condannandolo, a causa dell’oscillazione tra essere e non-essere, a un vero e
proprio Schmerzensweg, in cui infatti la creatura trova «doloroso tanto essere quanto
non-essere, tanto portare le catene dell’essere quanto non portarle» (SW X: 267). Se
«la vera realtà suprema consiste in ciò, nell’essere essente e restare potenza
dell’essere», e se «chi corre il pericolo di perdersi nell’essere non è libero» (SdW: 132),
se libero significa dunque poter-essere altro, oggettivarsi in forme diverse restando
tuttavia soggetto, e cioè non identificandosi in nessuna di esse, libero in senso proprio
sarà allora solo Dio appunto in quanto sopraessente e sopraesistente.
Del resto, dicendo “sono colui che sono”, o meglio «sarò colui che sarò», il “Signore
dell’essere” non intende affermare né che diverrà ciò che in qualche modo già è (non
dice, infatti, “io sarò colui che sono”), né che resterà quel che già è (non dice, infatti,
“io sono colui che sarò”), bensì che sarà tutto ciò che vorrà essere1, ossia quella
volontà priva d’oggetto e quindi assolutamente trascendente oltre che assolutamente
libera in cui consiste infatti il nome JHWH, formato non per caso da «puri soffi»
impronunciabili (SW VIII: 272-3). Questa futurizione ontologica è ovviamente correlata
alla convinzione secondo cui ciò che si rivela è sempre un prodotto e non qualcosa
d’immediato, implica cioè un fondo su cui e in cui manifestarsi. Ne conseguirà che il
vero Dio non è il primo Dio, quello originario e solo relativamente unico che precedette
la differenziazione mitologica, ma solo il secondo, assolutamente unico perché
divenuto, innalzatosi sul “fondo” di quello arcaico, naturale e immemoriale (el olam,
Elohim) grazie alla separazione dal contenuto immediato della coscienza, la quale
infatti solo ora, emancipatasi dall’iniziale stordimento religioso, può chiamare Dio per
nome (JHWH appunto).
Ora, se però l’ontoteologia schellinghiana fosse tutta qui, oppure se la valorizzassimo
solo perché, in apparente antitesi alla millenaria tendenza giudaico-cristiana (Heidegger
compreso) a identificare Dio con l’essere, sembra talvolta incline a pensare Dio come
l’essente (das Seyende) piuttosto che come l’essere (das Seyn) – visto che con
“essere” s’indicherebbe solo l’astrazione di un’astrazione, qualcosa di tanto
inconcepibile di per sé quanto «il bianco senza qualcosa di bianco» (SW X: 215, n.)2 –,
faremmo comunque ben poca strada. Lasciamo quindi, provvisoriamente, questa
1
Cfr. J.-F. Courtine, Estasi della ragione. Saggi su Schelling, trad. it. a cura di G. Strummiello, Milano
1998, pp. 258-9.
2
Ibid., pp. 253 sgg.
rapida anticipazione di alcuni dei temi ontoteologici di Schelling, che possiamo fin da
ora reputare fondati su tacite ipostatizzazioni e spregiudicati usi linguistici, ambiguità
semantiche e interferenze assiologiche eticamente e antropologicamente connotate,
per partire da capo, vale a dire da una più complessiva discussione del suo ruolo nella
storia dell’ontologia.
2. La verità: non dentro ma fuori. Per mitigare la legittima sorpresa suscitata
dall’inserimento di Schelling tra gli ontologi di rango non basterà certo rammentare la
sua costante critica intuizionistica al logicismo, converrà sottolineare piuttosto quella
drammatica apertura del vecchio filosofo alla realtà che, com’è noto, generò fin troppe
aspettative tra gli antihegeliani e gli hegeliani di sinistra (Kierkegaard, Bakunin ed
Engels su tutti), i quali si attendevano da colui che si auspicava una filosofia efficace in
quanto aderente alla realtà un’analisi critica dello Stato e della Chiesa e non certo una
filosofia del mito e della rivelazione, i quali inoltre, come Kierkegaard ammette,
gioivano al solo sentir nominata la parola “realtà” e ben presto si scoprirono delusi se
non ideologicamente truffati. Si tratta del passaggio dalla dottrina della scienza alla
scienza vera e propria, ossia dal mero movimento del concetto, caratteristico di quella
filosofia che ora definisce “negativa” (filosofia, in certo qual modo ancora
trascendentale, del “che cosa”) e in cui arruola ogni altra filosofia (compresa la
propria), alla filosofia “positiva” intesa come filosofia del “che”, come quell’esperienza
“superiore” della realtà – un aggettivo da cui dipende ovviamente ogni eventuale
applicabilità di tale dottrina in un ambito fenomenologico extrateologico – che fu solo
incoativamente presente nella giovanile filosofia della natura3, e secondo la quale «ogni
oggetto [dovrebbe] venir spiegato a partire da se stesso», in modo «che possano
essere trovate e scoperte con e in esso tutte le ragioni genetiche del suo divenire e
nascere» (SW XII: 671), in modo, detto altrimenti, che ogni svolgimento (che sia delle
figure naturali o di quelle mitologiche) si mostri indipendente dal volere e dal pensare
dell’umanità. Che si voglia definire “storica” o “positiva” o magari “empiristica” la sua
ultima filosofia, quel che è chiaro è che essa tematizza una forza attiva responsabile
dell’intero movimento ontologico, ancorché irrimediabilmente anteriore, se non del
tutto opposta, alla ragione, promuovendo un “empirismo filosofico” secondo cui il
filosofo, lungi dall’avere benefici dalla ritrazione interioristica e/o trascendentale, pensa
solo in seguito alla diretta intuizione di ciò che veramente esiste, anzi solo se
abbandona il proprio luogo e si pone fuori di sé, se si desoggettivizza in una condizione
di non-sapere in cui convergono istanze non meno realistiche che mistiche.
Nulla di strano, allora, nel fatto che Schelling dia il benservito all’ontologia e alla
metafisica scolastica (quella di Wolff, per capirci), declassata a disordinata e
incompleta «raccolta di definizioni» che, scimmiottando il «metodo geometrico», crede
di «possedere quei concetti di per sé e indipendentemente dagli oggetti»,
inconsapevole del fatto che «per la vera scienza, per la scienza che incomincia dal
principio, gli oggetti [devono] essere tanto a priori quanto i loro concetti» (SW X: 63).
Le spetterebbe tutt’al più un’utilità meramente propedeutica, per il fatto che, come
«filosofia meramente ragionante, razional-soggettiva», essa «concede nello stesso
tempo una certa libertà di pensiero e di uso dell’intelletto, la quale potrebbe avere un
effetto tanto più benefico, in quanto questa maniera di filosofare è la sola conforme e
adatta alla grande maggioranza delle persone» (SW X: 71), meritandosi peraltro
giustamente, come anodina filosofia di senso comune, il severo disprezzo delle filosofie
successive, più personali e scientificamente avvertite. Un’occasione in più per Schelling
per denunciare l’insufficienza di ogni sistema che riduca «tutto a meri rapporti razionali
ed esclude libertà e personalità», che ci ammannisca «un sapere in cui il pensiero non
si eleva mai al di sopra di sé e progredisce unicamente all’interno di se stesso, laddove
3
Che sarebbe allora una parte della filosofia positiva, poi integrata dal passaggio alla processualità «anche
nel mondo spirituale o storico» (GpP 1832/3: 467).
noi esigiamo di elevarci al di sopra del pensiero, per essere liberati dal tormento del
pensiero da ciò che è superiore al pensiero» (SW X; 168-9). Il che significa che, non
diversamente dall’uomo comune, anche il professionista del pensiero ravvisa nel
pensiero (astratto) un autentico tormento, «uno stato rarissimo, passeggero, anzi uno
stato innaturale» (SW X: 10), da cui converrebbe allontanarsi quanto prima, tanto più
che «ciò di cui l’uomo ha bisogno non è di porsi dentro se stesso, ma di porsi fuori di
sé» (SW IX: 229-30).
3. Può un idealista avere un’ontologia? Che la verità sia all’esterno e non all’interno del
soggetto è considerazione che non può però valere per il primo Schelling, il cui rifiuto
trascendentalista del dogmatismo che fa dell’essere qualcosa di originario e il
conseguente movimento dal sapere (massimamente dall’autocoscienza) come
condizione di possibilità all’essere lo inducono, da un lato, a respingere ogni presunta
oggettualità dell’io assoluto, cioè dell’incondizionato principio della materia e del
pensiero, e dall’altro a identificarlo però con l’essere, perché, se «tutto ciò che è (nel
senso proprio della parola è), è solo in virtù della direzione a se stesso» (SW I: 369),
ossia identità autoriferita, sarà “essere” (Sein) solo l’io inobbiettivabile, in quanto è
l’assoluto esser-posto datosi a se stesso nell’intuizione intellettuale, e non certo il
mondo fenomenico, condizionato e non diretto a se stesso, dotato soltanto di
“esistenza” (Dasein) e quindi poco al di sopra del singolo fenomeno, che non ha se non
“realtà effettiva” (Wirklichkeit).
Questa prima differenziazione ontologica va però incontro a una prima revisione nel
momento in cui al principio dell’io subentra quello di uno spirito (Geist) che diviene
incessantemente. L’ “azione” si rivela qui ontologicamente superiore alla “cosa”, nel
senso che, poiché «qualsiasi riempimento dello spazio è solo un grado dell’attività, e
ogni cosa soltanto un grado determinato di attività con il quale lo spazio viene
riempito» (SW III: 375), una modificazione di un’attività variamente limitata, al mondo
oggettuale non spetterà che una realtà derivata e meramente conferita4. Se c’è un
essere in senso proprio, questo non sarà allora «nient’altro che una continua-efficace
attività della natura, che è estinta nei suoi prodotti» (SW III: 13), un «essere
eternamente in lotta e mai essente» (SW IX: 27), rispetto al quale l’essere come
permanenza non è se non illusione (il che spiega anche il perché del miracolo dell’arte
come unica sensibilizzazione possibile dell’essere come assoluto inoggettivabile).
Ma nel volgere di pochi anni, nella cosiddetta filosofia dell’identità, l’essere assoluto,
inteso come“identità assoluta”, ridiventa un immutabile estraneo a qualsiasi divenire, in
perfetta corrispondenza con una ragione desoggettivizzata e assurta a modalità con cui
l’identità assoluta conosce se stessa. Ne consegue che ogni ente sarà identità assoluta
se assolutamente considerato (nella sua essenza), ma unicamente un conoscere
dell’identità assoluta se relativamente considerato (nella sua forma). Di più: non
essendo altro che una mera differenza quantitava di soggettivo e oggettivo all’interno
di un Indifferenzpunkt, un elemento di una serie causal-temporale condannata alla
cattiva infinità perché costituita da elementi “finiti all’infinito”, svincolati dall’assoluto e
che solo per un’illusione prospettica risultano ontologicamente causa ed effetto di altro
da sé, il singolo ente non avrebbe a rigore neppure un vero essere. Ne risulta che,
mentre sul piano dell’archetipo si ha un autentico collasso delle categorie ontologiche
(le idee valgono infatti qui come universa e come dèi mitologici, caratterizzate dalla
coincidenza di particolare e universale, essere e significato, possibile e reale), su quello
ectipo le cose finite sono bensì ma, siccome il fondamento del loro essere va visto in
una “caduta” dall’infinito, più propriamente non-sono se paragonate al vero essere
dell’idea: un po’ come le macchie solari – l’esempio è di Schelling –, che sono il nonvisto, un non-reale (un po’ come i fatti negativi dell’odierna ontologia) percettivamente
positivizzato solo in rapporto alla visione della luce solare. Se questa è un’ontologia, è
4
Cfr. H. Zeltner, Schelling, Stuttgart 1954, p. 284.
allora un’ontologia in cui il mondo della finitezza e la temporalità in certo qual modo
svaniscono, non essendo se non l’esito della difettività dello sguardo umano.
Ben diversamente significativa è l’ontologia presupposta da quell’orientamento che, a
partire dallo scritto sulla libertà del 1809, desemplifica l’essere per personificarlo,
ravvisandovi l’unità dell’essere come esistenza o realtà e dell’essere che, come Grund
del primo, è relativamente non-esistente nel suo carattere di mera potenzialità – un
non esistente o fondamento che, mentre Dio possiede perfettamente, resta in certo
qual modo esterno agli esseri finiti e può pervertirsi in forza autonoma5. In questa
prima articolazione della dottrina delle (tre) potenze misuriamo il transito dalla filosofia
della natura, ove le potenze sono solo i diversi gradi di esplicitazione fenomenica di
un’unica forza, alla cosiddetta “filosofia delle età del mondo”’, in cui si spiega come,
nello svilupparsi del “passato” della personalità divina, i princìpi siano alternativamente
non-essenti (in potenza) e essenti (in atto) fino a generare né «un vero sopra né un
vero sotto […] bensì soltanto una ruota incessante, un moto rotatorio che non si
estingue mai» (SW VIII: 264), ossia quel particolare essere che, in analogia con la
(böhmiana) Rad der Geburt, per la sua perenne instabilità non è davvero mai se non
quando l’intervento non necessitato della quarta potenza (dell’apotenziale
sovraessente, che “decide” di automanifestarsi) sostituisce al vuoto moto rotatorio un
accadere dotato di un vero principio e di una vera fine veri.
Pur senza indulgere nel birignao tipico dei commenti che intendono emulare
l’“abissalità” del filosofo di Leonberg, è indiscutibile che già questa sommaria incursione
nei temi della cosiddetta “filosofia della libertà” suscita un problema ineludibile. Quale
spazio ontologico resta a una filosofia che strappa al reale ogni sostanzialità e
permanenza, che, quasi fosse la “biografia” a posteriori della causa suprema, riduce
ogni cosa a un divenire teogonico tanto libero da essere infondato? Intendiamoci: se
l’ontoteologia schellinghiana è inutilizzabile, lo è a causa non dei contenuti specifici
della filosofia positiva (mtologia, rivelazione), i quali non di rado appaiono anzi
semplicemente due ambiti di prova, ancorché euristicamente rilevanti nella loro relativa
estraneità alla filosofia razionale, del nuovo metodo scientifico, bensì del suo più
complessivo impegno teologico ad assorbire l’intera realtà nella sua causa assoluta. Il
che non toglie che sia pur sempre possibile valorizzare in modo relativamente
autonomo da questo vincolo l’impegno antisolipsistico e antilogicistico con cui Schelling
cerca, per dirla con le sue parole, una filosofia che non «sostituisce [più] alla
connessione reale la mera filigrana del concetto» (SW XII: 672), che segue l’oggetto
nel suo autosviluppo e muove dall’esperienza, o addirittura entra «nell’esperienza
stessa e diventa, per così dire, tutt’uno con essa» (SW XIII: 128), in modo che sia
l’oggetto stesso a spiegare se stesso.
4. Verso un’ontologia deflazionistica. Come si è detto e come ancor meglio si vedrà,
per Schelling non c’è tutto, ovviamente solo nel senso eminente di “essere” e secondo
una differenziazione assiologica tanto fondamentale quanto problematica. È dunque
un’ontologia deflazionistica a guidarlo, pur se con motivazioni diverse, sia nella fase
trascendental-idealistica e dell’identità sia in quella dell’empirismo filosofico. Eppure
non sarebbe difficile ricavare dalla già menzionata distinzione tra una filosofia che
dimentica l’esistente concreto per ciò che può essere, e una filosofia che invece si
rivolge all’essere quale liberamente e fattualmente si è dato e si dà, la prova
dell’esemplare conversione all’empirismo di un idealista già da molto tempo
insoddisfatto dell’amputazione fichtiana della realtà, e infatti voltosi, a differenza del
suo primo “maestro”, a due concreti come la natura e l’arte, intesi come
5
Cfr. M. Vetö, Le fondement selon Schelling, Paris 1977 e T. Griffero, Grund ed Existenz. Classicità e melanconia alla
luce della «teoria dei princìpi» di Schelling, in C. Tatasciore (a cura di), Dalla materia alla coscienza. Studi su
Schelling in ricordo di G. Semerari, Milano 2000, in particolare pp. 253-259.
concretizzazione “positiva”, rispettivamente, dello spirito universale e del genio6. Non si
può tuttavia passare sotto silenzio che dietro ai rimproveri mossi nel 1806 alla visione
fichtiana della natura, che puntando tutto sulla sua moralizzazione sarebbe
unilateralmente economico-teleologica7 e quindi incapace di vedervi quella “ragione
diffusa” che, estranea alla conoscenza discorsivo-sintetica, è garante viceversa
dell’identificazione del conoscere con il vivere8, vi è un realismo del tutto particolare.
Infatti, se è vero che, giusta la ripresa della plotiniana prosopopea della natura,
l’«ammutolire del discorso davanti alla vita è l’operazione suprema che la filosofia deve
compiere», dato che «l’evidenza è riconducibile a una sorta di apparire interno della
natura a se stessa, dell’essere all’essere e ogni parola aggiunta la distrugge»9, è pur
vero che dietro all’esordio del duraturo ideale dell’automanifestarsi del positivo in un
corrispondente «”occhio interno” che coincide con la vita e la genesi»10 e che è il
sapere assoluto (filosofico), troviamo non solo la sfiducia naturalistica di Hume11 e poi
anche di Jacobi verso la ragione argomentante, ma anche una sorta di empirismo
dell’assoluto sfociante nella teodicea ovviamente del tutto estraneo all’empirismo.
Quando leggiamo affermazioni indubbiamente realistiche come le seguenti – «la vera
filosofia deve parlare di ciò che esiste, ossia della natura reale, della natura che è» (SW
VII: 30); «essere è verità e verità è essere. Ciò che il filosofo pensa e di cui parla deve
essere, perché dev’essere vero. Ciò che non è, non è vero» (ibid.) –, non dobbiamo
mai dimenticare che l’oggetto della filosofia reale non è qui solo la realtà sensibile, ma
anche e a maggior ragione Dio stesso come garante dell’esistenza del mondo e della
ragione che vi è “diffusa”. Visti questi precedenti, se ne conclude che anche il tardo
realismo schellinghiano trova nell’empiria il suo punto d’avvio e l’explicandum ma,
diversamente dal positivismo, non certo la sua fonte; che perviene induttivamente
all’essere muovendo dall’ente reale-finito, ma assumendo quest’ultimo solo come il
prius logico in vista dell’acquisizione del prius reale.
Ma se la svolta empiristica è quanto meno controversa, indubbia è invece quella
ontologica, dato che qui è la filosofia stessa come scienza dei princìpi a essere definita
la «scienza dell’ente» e a essere considerata la sola risposta possibile alla domanda
antropologica sul “perché esista qualcosa anziché il nulla”. Durante tutto il
quarantennio di pressoché totale silenzio editoriale Schelling nutre appunto l’ambizione
di costruire una scienza i cui princìpi siano quelli non del pensiero ma dell’essere12,
senza che ciò implichi una regressione alla metafisica prekantiana, ma anzi capitalizzi
proprio la contraddittoria concezione che induce Kant a pensare alla cosa in sé ora
come a una x indipendente dalla conoscenza, ora come a un qualcosa che non può non
esistere visto che causa l’impressione sensibile. Incapace di aprirsi all’esperienza di un
“che” irriducibile alla ragione e condizionata dall’errore (estremizzato dall’ex-amico
Hegel) di confondere negativo e positivo, tutta la filosofia precedente sarebbe stata
6
Solo la mancata comprensione di questo costante e pressoché esclusivo interesse per la positività – che si tratti di arte,
di natura o di rivelazione religiosa – spiega l’interpretazione di J. Schmidt, Die Geschichte des Genie-Gedankens in der
deutschen Literatur, Philosophie und Politik, 1750-1945, I, Darmstadt 1988, p. 396, in termini di “feticizzazione”
dell’interesse schellinghiano per l’opera anziché per la produttività artistica.
«Il fondamento di qualsiasi mediocrità spirituale è appunto l’assenza di quell’intuizione grazie a cui la natura ci appare
vivente per se stessa […] poiché ogni potere risanante risiede solo nella natura. Solo questa è il vero antidoto
all’astrazione» (SW VII: 19).
7
8
Cfr. F. Moiso, Unità e identità nel tardo Fichte, in V. Melchiorre (a cura di), L’uno e i molti, Milano 1990, pp. 371404.
9
Ibid., pp. 378-379.
10
Ibid., p. 382.
11
Cfr. F. Moiso, Vita natura libertà. Schelling (1795-1809), Milano 1990, p. 16: «è all’ineludibilità dell’alternativa
humiana [tra scetticismo e realismo; NdA] in un discorso filosofico identificante verità e connessione vivente che
probabilmente occorre far risalire tratti cospicui dell’ “empirismo” e della “positività” presenti in tutta la filosofia di
Schelling».
12
Così A. Franz, Philosophische Religion. Eine Auseinandersetzung mit den Grundlegungsproblemen der
Spätphilosophie F. W. J. Schellings, Amsterdam-Atlanta 1992, p. 87.
solo “negativa”, mentre la sfida sarebbe quella di conquistare «non […] il mero essere
[ma] l’essere che è o esiste» (SW X: 215), di aggirare trascendentalismo e
naturalizzazione empirica13 individuando proprio in Dio il ricercato principio dell’essere,
in assenza del quale nulla sarebbe quel che è (né il pensiero né l’essere) e nella
coscienza del quale, che lo voglia o no, l’uomo è sempre immerso, essendo per natura
l’essere-che-pone-Dio, colui che non tanto ha quanto è coscienza del divino. La “nuova
religione” auspicata da Schelling e dalla sua cerchia fin dall’epoca del Systemprogramm
si declina ora nella forma di una “religione filosofica” che – detto in estrema sintesi –
da un lato indaghi il modo in cui il pensiero giunge al principio (divino), dall’altro
muovendo proprio da questo principio mostri in che senso la religione mitologica e
quella rivelata non siano se non una progressiva manifestazione del divino.
5. Il fallimento (annunciato) della filosofia “negativa”. «Il migliore svolgimento di una
vita consacrata alla filosofia potrebbe consistere nel partire con Platone e finire con
Aristotele» (SW XI: 380). Così, citando nell’incompiuta Darlegung der reinrationalen
Philosophie le proprie «stelle polari» (SW XI: 391), Schelling universalizza il proprio
percorso dalla poesia filosofica alla scienza, reinterpretata extrafilologicamente in una
prospettiva platonizzante (perché «non si comprende Aristotele se ci si ferma a lui»;
SW XI: 382) e comunque ontologicamente valorizzata in antitesi al soggettivismo
raziocinante post-cartesiano e alla kantiana “regolatività” anti-metafisica. Sintetizzando
in certo qual modo il metodo dialettico di ascesa all’assoluto (Platone) e la portata
ontologica del principio assoluto (Aristotele), egli vede legittimato il metodo induttivo
con cui la filosofia puramente razionale – tra l’altro paradossalmente costretta, a
differenza di ogni altra scienza (dotata di un proprio oggetto specifico), a indagare un
oggetto impossibile, vale a dire quell’ente in generale che (nominalisticamente) non
esiste né è esprimibile, presentandosi piuttosto sempre solo come l’attributo di
qualcosa d’altro –, escludendo sperimentalmente varie ipotesi, giunge a mettere in luce
il processo che pone capo all’ente, e cioè i princìpi o potenze che costituiscono l’entità
dell’ente e che non a torto sono stati paragonati per struttura e funzione alle
espressioni sortali14.
La filosofia negativa è quindi certamente un’ontologia, ma un’ontologia ancora
totalmente condizionata dal pensiero. Seppur fondamentale, l’esperienza testimonia qui
infatti non che cosa sia reale e che cosa non lo sia, ma soltanto che cosa sia possibile o
meno nel pensiero, non tanto quindi l’essere reale quanto «le possibilità che bisogna
necessariamente pensare» (SW XI: 304) rispetto all’ente, compresa quella «sensazione
(Gefühl) che non ci permette di attribuire a queste possibilità una collocazione diversa
da quella dichiarata» (SW XI: 304) e che, come principio di non-contraddizione,
costituisce la «legge di tutto l’ente» (SW XI: 305), intelligibile non meno che sensibile.
Non diversamente, l’ente universale nella cui acquisizione si concludono le trecento
pagine schellinghiane di questo “torso” non è che «il tutto, che si produce con
necessità nel pensiero» e perciò «solo nell’idea, non realmente» (SW XI: 313),
qualcosa di ben diverso dall’assoluto come puro atto impensabile spettante alla filosofia
positiva. L’esito della filosofia puramente razionale non sarebbe dunque altro che l’idea
della realtà, la possibilità di Dio e del mondo quale la si deve pensare quando si astrae
dal “che” e ci si rivolge unicamente al “che cosa”. Pur non limitata all’ente quanto la
matematica e libera di indagare «la sostanza nel senso più alto della parola» (SW XI:
377), proprio come la matematica la filosofia negativa non andrebbe oltre il possibile
essere-così di una cosa, che è del tutto indipendente dall’esistenza della cosa, e si
dimostrerebbe altresì estranea, in quanto scienza (aristotelicamente) solo
13
Cfr. H. J. Sandkühler in F. W. J. Schelling, Das Tagebuch 1848, hg. von H. J. Sandkühler, Hamburg
1990, pp. LV sg.
14
Cfr. T. Buchheim, Eins von Allem. Die Selbstbescheidung des Idealismus in Schellings Spätphilosophie,
Hamburg 1992, p. 36, n. 24.
dell’universale, all’individualità e quindi anche al principio assoluto, più disponibile al
sentimento, infatti, che al concetto.
Nonostante questo fallimento programmatico rispetto alla realtà della scienza
puramente razionale, varrà la pena cercare di capire che cosa non possiamo non
pensare quando pensiamo l’esistente. Quali siano cioè – in estrema sintesi ed evitando
tutte le prevedibili complicazioni enfatizzate dalla ricerca – le potenze, ossia i principi
costitutivi (scoperti dal pensiero) dell’ente in generale e quindi anche di Dio, nella
misura in cui anch’egli «compie in sé il movimento del venire alla presenza che è
proprio di ogni ente intramondano»15. Posto che l’esistente sia A, la prima potenza 1)
non sarà che puro poter-essere (-A), il primum cogitabile16 e il puro soggetto
dell’essere (ma nel senso di mera sup-positio, di Grund o base di una potenza
superiore), che Schelling interpreta come un volere originario ancora inattivo, come un
sostrato infondato-indeterminato quanto lo era l’apeiron pitagorico-platonico e quindi
come causa solo quantitativo-materiale che di per sé è come nulla17. Ma perché l’ente
si delinei occorre che si aggiungano 2) una seconda potenza [+A nel senso di -(-A)
ovviamente], che agisca come causa qualitativo-formale su quel sostrato delimitandone
l’informità e quindi oltrepassandolo (e per Schelling l’essenza stessa dell’ente è di
oltrepassarsi), nonché la terza 3), ossia il soggetto-oggetto (±A), che non è affatto la
loro somma, ma ciò che, essendo uno e medesimo in entrambe e portando così alla
costituzione dell’«inesauribile molteplicità di forme del puro ente» (SW XI: 391), vale
come causa finale, come quell’ente in virtù di se stesso («il poter-essere essente come
tale»; SW XIII: 235) che “deve” essere. Rappresentando la «materia dell’ente, cioè
dell’universale» (SW XI: 291), queste tre potenze (-A, +A, ±A, ma anche poter-essere,
necessità-di-essere, dover-essere) – in cui Hartmann vedrà riassunte le articolazioni
rispettivamente
platonica
(indeterminato,
determinato,
autodeterminantesi),
aristotelica (causa materiale, formale, finale)18 e hegeliana (esser-in-sé, esser-fuori-disé, esser-presso-di-sé) – cooperano come quegli dèi etruschi che nascono e decadono
solo insieme, sono ciò attraverso cui il pensiero fa sorgere processualmente l’ente (ma,
ricordiamolo ancora, non nella realtà), però solo se postula anche una quarta causa
(efficiente), che nel garantire la cooperazione delle precedenti non va intesa come un
quarto elemento, bensì come qualcosa (A°) che eccede tale processo e rientra in un
ordine totalmente diverso, non afferendo semplicemente all’ente, né identificandosi con
Dio (pena la sua retrocessione a causa immanente tra le altre). Schelling vi vedrà
piuttosto l’anima, ossia quell’elemento divino-immateriale che, come anima prima del
mondo e poi dei singoli enti, conferisce l’essere a tutti i concreta, cioè alle idee quali
produzioni del «pensiero necessario» (SW XI: 411).
6. Scienza dell’esperienza: dal quid al quod. Schelling è senz’altro convinto di poter
rivoluzionare col proprio appello all’esperienza la storia della filosofia, superando anche
l’idealismo, il cui indubbio merito sarebbe stato quello di indagare il fondamento
dell’esistenza degli oggetti e non solo di cercarne i predicati appropriati alla maniera
della metafisica prekantiana, ma il cui limite fu quello di non poter andare oltre la
conoscenza razionale a priori di che cosa è o può essere, ossia di quell’essenza delle
15
J.-F. Courtine, Estasi della ragione, cit., p. 191.
«La prima cosa che devo pensare è senza alcun dubbio il soggetto dell’esistenza, il quale non è ancora
l’ente, bensì solo il principio dell’essere, il suo primo punto d’attrazione» (SW X: 303). Questo primum
cogitabile non è tanto il primo oggetto del pensiero quanto il suo primo ingrediente, un indeterminato a
cui il pensiero si rifiuta però di anteporre qualcosa (SW XI: 302), perché se il pensiero non cominciasse
appunto con una sottrazione (steresis), con un’assenza di determinazioni (che non equivale a un nulla
bensì a un puro poter-essere), ma con una determinazione, non sarebbe neppure pensiero. Cfr. T.
Buchheim, Eins von Allem, cit., pp. 118 sgg.
17
Cfr. J.-F. Courtine, Estasi della ragione, cit., p. 184.
18
Cfr. N. Hartmann, La filosofia dell’idealismo tedesco, trad. it. di B. Bianco, a cura di V. Verra, Milano
1972, p. 160, che però identifica erroneamente +A con la causa efficiente.
16
cose (quid) che rimarrebbe immutata anche se quella cosa non esistesse affatto nel
mondo. Sottolineando con forza da un lato il fatto che si ottengono così solo enti
apparenti, la cui esistenza si esaurisce nell’essenza (nel concetto), si perviene cioè a
una scienza della ragione che equivale a un «completo deserto di ogni essere» (SW
XIII: 76) e che appare pertanto legittima, rivelandosi un’indispensabile via d’accesso
alla filosofia positiva19, solo quando non finge (come in Hegel) di essere altro da ciò
che è, spacciando un movimento solo logico per un movimento oggettivo, e dall’altro
che è solo l’esperienza a insegnarci che qualcosa esiste davvero (il quod), che
un’ontologia positiva concerne unicamente fatti che nella loro accidentalità
spaziotemporale sono concettualmente inanticipabili, egli vuole in conclusione
dimostrare proprio su di sé la tesi secondo cui la filosofia tedesca avrebbe introiettato
l’istanza empiristica, senza mai diventare però empirismo. Paradossalmente, la filosofia
negativa è allora una scienza riuscita solo quando fallisce, quando, sfociando nel
«costante rovesciamento della ragione» (SW XIII: 152), si dichiara incapace di
qualsiasi conoscenza reale e si esaurisce nel rinviare alla filosofia positiva, un po’ come
accadeva nel culti eleusini ai “piccoli Misteri”, il cui senso ultimo era di rinviare ai
“grandi Misteri” successivi. Giunta a un uno che, pur essente, non cessa di essere fonte
dell’essere, che è insieme semplice e molteplice nella sua qualità di perfetta spiritualità,
la filosofia razionale può ben arrestarsi, perché ora si rovescia e perde l’ipoteticità che
necessariamente le veniva dal supporre che si dia (sorga) un essere o un ente. In altri
termini: quanto fin qui era il prius, e cioè la dialettica delle potenze che ci ha condotti
allo spirito, appare ora come il posterius, da cui si può prescindere avendo avuto un
valore solo strumentale, laddove lo spirito è ora il prius rispetto alle potenze.
Ma è il momento di vagliare con maggiore attenzione l’impegno ontologico della
“filosofia positiva”, intesa come quella Denkform che, parzialmente anticipata nella
speculazione giovanile dalla tesi dell’irriducibilità dell’organismo alle categorie
meccanicistiche e più generalmente dal primato assegnato all’intuizione (intellettuale o
della ragione), antepone il reale esperito alla mera ipoteticità del pensiero, il positivo al
negativo, pur ammettendo di dovervi passare, così come Dante sale al cielo solo
attraverso l’inferno. Siccome il fatto reale che esperiamo prima di poterci chiederci che
cosa essa sia, la cui esistenza ci precede per quanto presto vi arriviamo (si pensi a
quando sentiamo chiaramente che qualcosa in noi non va, pur senza minimamente
conoscere la patologia responsabile e addirittura se si tratti di una patologia)20, non
potrà essere, in quanto azione, che un rivelarsi, dato che «rivelarsi è agire, così come
ogni agire è un rivelarsi» (SW VIII: 306), allora la positività della filosofia consisterà
proprio nella capacità di vedere nella realtà il frutto di una libera azione irriducibile alla
ragione e alla necessità.
A Schelling interessa sapere – e non solo pensare – niente di meno che l’origine di
tutte le cose. Solo un sapere più che pensante, sintetico e non tautologico (com’è
invece nella filosofia negativa, condannata in certo qual senso a trattare oggetti
virtuali)21, può dunque placare la domanda ontologica, riconducendo l’ente non tanto a
un’ubiqua razionalità conoscibile a priori, quanto a una decisione libera dell’assoluto, il
cui opposto è quindi sempre possibile, un po’ come apprendiamo la volontà di un uomo
esclusivamente da ciò che effettivamente fa. Volta alla dimostrazione a posteriori del
fondamento volontaristico dell’essere attuale, dell’«assoluta, trascendente ed
esuberante libertà» (SW XIII: 256) con cui lo spirito si manifesta integralmente
(secondo l’organicistica identità di parte e tutto) in ciascuna forma ontologica, senza
peraltro mai arrestarvisi, la filosofia positiva deve tutto al fallimento di quella solo
razionale e alla silenziosa ignoranza, alla quasi braminica «assoluta inspirazione del
19
«Quanto più il negativo veniva formulato in maniera pura, tanto più fortemente doveva elevarsi dinanzi
a esso il positivo» (SW XIII: 86).
20
Cfr. T. Buchheim, Eins von Allem, cit., pp. 17-18.
21
Ibid., p. 68.
pensiero» (SW XIII: 252) che secondo Schelling ne sarebbe la logica conclusione. Ma
l’afasia estatica non è qui l’unico rischio, giacché questa ontoteologia, radicata nella
libertà sovraempirica e nella volontà automotivante secondo la tesi che «l’essere
originario è il volere e non c’è altro essere che il volere» (SdW: 169, ma cfr. anche SW
VII: 350), finisce per legittimare anche delle quanto meno discutibili (volontaristiche)
scorciatoie metodiche, su tutte l’illusione che sia possibile aggirare i limiti del cosiddetto
“empirismo regressivo” assegnando a una non meglio precisata “volontà filosofica”22,
affine per extraconcettualità all’altrettanto necessario “sentimento artistico” e
“scientifico” per la totalità, la capacità di risalire dalla realtà esperibile non solo al Dio
che si relaziona creazionisticamente-logicamente al mondo ma al Dio assolutamente
libero. Un punto di partenza volontaristico che, tra l’altro, non è che un’ipotesi euristica
in attesa di una dimostrazione progressiva, e quindi a rigore infinita, da parte della
filosofia positiva non tanto di un principio ontologico astratto – l’astrazione nel vivo
dell’esperienza equivalendo per Schelling a una svalutazione23 ––, bensì di una
“persona” (divina) di cui esperiamo l’estrinsecazione solo a cose fatte. Le difficoltà non
riguardano allora solo la filosofia negativa, al cui approccio a priori della realtà sensibile
sfugge necessariamente una realtà pura irriducibilmente anteriore, ma anche quella
positiva, che, se deduce a priori il mondo dal principio, è però condannata nella sua
non dogmaticità a rincorrere asintoticamente la dimostrazione a posteriori di tale
principio, visto che «il regno della realtà non è compiuto, ma è qualcosa che va
continuamente incontro al proprio compimento» (SW XIII: 131).
7. Quale esperienza? A prescindere ora dalla controversa questione circa l’eventuale
autonomo movimento della filosofia positiva (scienza suprema, descendens), che se
per un verso sembra infatti necessariamente introdotta dalla (dallo scacco della)
negativa (scienza prima, ascendens), per l’altro, muovendo dal volere, pare poter
«incominciare puramente di per sé, anche solo con la semplice affermazione: io voglio
ciò che è sopra l’essere, che non è il semplice ente, ma qualcosa di più che questo, è il
signore dell’essere», in altri termini avere «un inizio assoluto e certo di se stesso» (SW
XIII: 93) dal momento che «non esige alcuna fondazione, la cui natura esclude anzi
ogni fondazione» (SW XIII: 161) –, una cosa è certa, ed è che questa “positività”
necessita di un’indagine ulteriore.
Schelling parla talvolta anche di “filosofia storica”, intendendo con ciò di certo non a)
una filosofia che tragga il proprio sapere dalla materia storica nel senso generico della
parola, ma neppure b) una filosofia della storia nel senso tradizionale o, peggio ancora,
c) una filosofia che si risolva in storia della filosofia. Pensa piuttosto a una filosofia
tanto concreta quanto la storia, non per caso reputata superiore alla politica, perché
«mentre in questa si tratta in gran parte dell’impotente “che cosa”, la storia si occupa
del reale compimento, dell’onnidisponente “che”» (Plitt III: 223), a una filosofia, nella
fattispecie, che valorizzi il cristianesimo anzitutto come religione orientata a ciò che
Cristo ha “fatto” più che detto, per poi tematizzare quella storia superiore-divina
(ierostoria) che ha ben poco a che vedere con la storiografia e in cui a contare è
l’evento tanto inanticipabile da suscitare meraviglia (e proprio nell’inanticipabilità
teorica fin da giovane Schelling aveva individuato la specificità della storia) e
incomprensione razionale24. Una precisazione s’impone: “filosofia cristiana” non
equivale qui, come molti critici credono, a “filosofia religiosa” o, peggio ancora, a
22
24
«Il primo concetto in filosofia può essere solo oggetto di un volere. Solo in questo modo essa può
essere “una scienza che inizia assolutamente dal principio”» (GpP: 396).
23
«Persino il termine “uomo”, se lo adoperiamo per ciò che per noi è la cosa suprema e più cara, può
risultare offensivo. Nessuno di noi vuole essere definito mediante una categoria puramente generale, e ha
ben diritto che ciò non accada» (GpP:465).
Cfr. F. Moiso, Temporalità e filosofia positiva in Schelling, «Annuario filosofico», 6 (1990), p. 323: «Il Cristianesimo
appare infatti oggetto e autorità perché esso è per la filosofia anzitutto storia, tempo, successione, che la ragione non
può darsi da sé».
“filosofia rivelata”, giacché essa, quanto meno nelle intenzioni, non fa della rivelazione,
che pure molto avrebbe insegnato alla filosofia, un presupposto storico esterno e tanto
meno una verità inconcussa – pena la fine della filosofia come «scienza prodotta in
modo totalmente libero» (SW XIII: 139), la cui stessa esistenza, d’altronde, dimostra
con chiarezza l’insufficienza della fede –––, ma un oggetto da comprendere in maniera
autonoma e indipendente, anche se, non diversamente dalla natura e dalla storia, al di
fuori della logica.
Per lo più Schelling parla però di “scienza dell’esperienza”, solo che con esperienza
non intende affatto a) la certezza del mondo sensibile, ossia né l’esperimento, che da
sempre ritiene governato e reso possibile solo dalla teoria (cfr. ad es. SW V: 341), né
quella «autorità dell’esperienza comune, che ci assicura dell’esistenza e della natura
delle cose sensibili, così come della nostra propria esistenza esteriore e interiore, e
delle sue determinazioni sia costanti sia mutevoli» (SW XI: 261) – autorità,
quest’ultima, che insieme a quella dei princìpi universali e della ragione costituisce la
fonte della metafisica scolastica, e ciò perché l’esperienza del reale attuale, ad esempio
del corporeo, va preliminarmente distinta, per quanto apparentemente ognuno vi si
sottometta ciecamente, da ciò che, per sua natura e in modo eminente, è esperienza
reale solo nella misura in cui implica anche il sovrasensibile. Né intende b) il grado
immediatamente superiore al sensismo rappresentato dall’empirismo mistico
(teosofismo), il quale, enfatizzando il bisogno di un’esperienza diretta del
sovrasensibile, porrebbe in effetti la medesima esigenza sentita dalla filosofia positiva
(e si sa quanto Schelling abbia mutuato da Böhme e da Oetinger), ma in un modo
immediato-intuitivo che non ha nulla di metodico e quindi di scientifico, che,
pretendendo di saltare il “negativo”, «muore infine di una inevitabile consunzione
spirituale» (SW X: 176). E ovviamente non ha in mente neppure c) l’esperienza che si
consuma nel pensiero, e che tutt’al più impronta l’ambito logico-negativo della scienza,
ancorché talvolta sia costretto a riconoscere che, citando l’esempio del principio di non
contraddizione, «occorre pensare realmente per fare esperienza del fatto che non si
può pensare il contraddittorio» (SW XI: 326).
Talvolta con “empirismo” Schelling sembra pensare perfino a una scienza del
significato interiore delle cose. Se “fatti” possono dirsi in senso generale anche gli
oggetti specifici delle varie scienze, il fatto “vero” sarà però «sempre qualcosa di
interiore» (SW X: 227), ad esempio in una battaglia lo «spirito del generale» e in un
libro ciò che il lettore vi comprende; qualcosa che si acquista grazie all’esperienza, non
esclusa quella che si ottiene ripercorrendo “sperimentalmente” la successione tutt’altro
che casuale dei sistemi filosofici. Ma non è proprio tale successione, paradossalmente,
a sancire la vittoria del soggettivo sull’oggettivo, e quindi dell’epistemologia
sull’ontologia, dato che il viceversa renderebbe impossibile la scienza stessa? Non del
tutto, perché anche la graduale soggettivazione dell’oggettivo, il “fatto” cioè che B
diventi A, senza cessare del tutto di essere B, in virtù dell’azione limitante di un
principio superiore (ideale, maschile) su un altro principio illimitato (reale, femminile),
presuppone a giudizio di Schelling pur sempre l’oggetto e quindi non invalida i diritti
dell’ontologia. Non li invalida il trascendentalismo, giacché «il soggetto conoscente ha
necessariamente come suo presupposto l’oggetto conoscibile» (SW X: 229), e in fondo
il conoscente non è meno un “ente” di quanto lo sia il conosciuto, e neppure il
dualismo cartesiano, che infatti, mentre infrange con la de-ontologizzazione della
corporeità il tacito accordo di senso comune che secondo Schelling lega il filosofo al
suo pubblico e gli prescrive di spiegare il mondo senza amputazioni idealisticamente
condizionate, non fa altro che trasferire l’intero peso ontologico sul soggetto, dovendo
in ultima analisi confessare di non poter «sfuggire all’essere, che intendev[a] evitare e
per così dire aggirare (come un nemico)» (SW X: 233). Ma l’ammissione di un mondo
ontologicamente autonomo non va oltre. Benché il soggetto e l’oggetto “siano”, ossia
vedano limitata la loro originaria illimitatezza da «un principio opposto all’essere e che,
proprio per questo, lo limita» (SW X: 236), benché proprio per questo l’intelligenza del
soggetto abbia una corrispondenza nell’intelletto oggettivo deposto nelle cose, il
conoscibile non può certo per Schelling dirsi esistente nel senso alto ed eminente con
cui lo si dice del conoscente, al quale infatti si rapporta anzi come un relativo nonessere. Significativo è comunque che l’idealismo appaia qui redento dal suo tradizionale
nichilismo ontologico, il condizionamento soggettivo dell’oggetto non inficiando affatto
la realtà ontologica dell’oggetto, perché anzi «la cosa con queste determinazioni
soggettive è appunto la vera cosa, giacché se le sottraggono tali determinazioni, essa
non è più in generale una cosa» (SW X: 240).
Facendo dell’esperienza della realtà in senso proprio qualcosa che è altro sia dalla
banale empiria sia dal pensiero – ma come convive quest’esigenza con ricorrente
ammissione che «ogni essere presente nell’esperienza ha in sé delle determinazioni
logiche dell’intelletto, senza le quali esso non sarebbe rappresentabile» (SW XIII: 127)?
–, Schelling pensa a un prius assoluto e non solo relativo (quale sarebbe la potenza,
destinata a trapassare nell’essere), oltre che assolutamente trascendente in quanto da
nulla costretto a produrre l’essere reale; un prius che non nel suo cominciamento
assoluto (assolutamente al di là dell’esperienza), ma certamente nella successione
condizionata unicamente dal suo volere potrebbe essere dimostrato empiricamente (a
posteriori), dal momento che, a differenza della verità logica, a comprovare questa
volontà sarebbero unicamente le sue conseguenze “fattuali”. Pensa cioè a
un’esperienza che provi la «divinità di quel prius – che esso è Dio e, dunque, che Dio
esiste» (SW XIII: 129), e che, dimostrando che «anche il prius stesso esiste proprio nel
modo in cui l’abbiamo compreso, cioè che Dio esiste» (ibid.), lasci essere il prius come
prius, conoscendolo «a partire da ciò che a esso segue, ma non in modo tale che
questo seguente preceda» (ibid.), dove evidentemente “a posteriori” significa soltanto
per posterius. Non possiamo però nasconderci la problematicità dell’inferenza
schellinghiana, secondo cui «se il necessariamente esistente è Dio, allora abbiamo
questa e quest’altra conseguenza – quel che vogliamo dire è che a, b, c, ecc. diventano
allora possibili; ora, secondo la nostra esperienza a, b, c, ecc. esistono però realmente
e quindi – conclusione necessaria – il necessariamente esistente è realmente Dio» (SW
XIII: 169; corsivo nostro). È sempre antipatico infierire sulle sviste logiche del passato,
ma sia chiaro, per limitare i danni di questa evidente fallacia25 dell’affermazione della
conseguente (se p allora q, ma q quindi p), non basta certo enfatizzare il fatto che
Schelling parli solo di “possibilità” delle conseguenze o pensi a dei fatti biblici che
dimostrerebbero l’agire divino perché, come la divinità presupposta, eccedenti la sfera
concettuale26. Comunque sia, solo a questo punto è chiara l’intenzione teoretica
schellinghiana. In sintesi: se la filosofia negativa è empirismo a priori e quindi non vero
empirismo, quella positiva è, in quanto apriorismo empirico, il vero e proprio
empirismo, vale a dire a) scienza a priori rispetto al mondo e b) scienza a posteriori
rispetto a Dio, perché, attraverso un argomento ontologico invertito, essa procede non
dall’essenza all’esistenza ma dall’esistenza (infondata e infondabile) di Dio alla sua
essenza o idea, trasformando così l’assolutamente trascendente, paradossalmente
scoperto nell’estasi della ragione, nell’assolutamente «immanente (ossia, fatto
contenuto della ragione)» (SW XIII: 170), portandolo al pensiero e, solo così,
rendendolo veramente Dio.
8. L’essere prima del poter-essere. Così suonano le formule messe in circolazione da
Schelling. Sarà meglio lasciarle perdere, per precisare piuttosto come la filosofia non
sia solo, genericamente, ontologia, come il suo oggetto, che è l’unica tra le scienze a
non trarre dall’esperienza, da altre scienze superiori o magari dal caso, non sia tanto
25
P. C. Hayner, Reason and existence. Schelling’s philosophy of history, Leiden 1967, pp. 105, 171.
Cfr. T. Buchheim, Eins von Allem, cit., pp. 22-23; A. White, Schelling. An introduction to the system of
freedom, New Haven/London 1983, p. 166.
26
l’ente stesso, quanto «l’ente in modo totale […], non potenza, bensì tutto atto, pura
realtà effettiva» (SW XIII: 149); in altri termini ciò che, diversamente da quanto a
causa della composizione di potenza e atto è solo parzialmente conoscibile, è
totalmente conoscibile, oltre che totalmente degno di conoscibilità, in quanto
totalmente ente, ossia atto puro, privo di non-essere. Il supremo, a cui anche se solo
nel concetto perviene la filosofia negativa, è dunque l’atto puro o «potenza-di-essere
rovesciata» (SW XIII: 156), in cui, lungi dall’esserci un passaggio dalla potenza all’atto,
la potenza è il posterius e l’atto il prius. Per dirla con Schelling: «se dunque egli esiste,
può essere l’esistente solo in, e per così dire, prima di se stesso, cioè prima della sua
divinità» (SW XIII: 158), prima del suo e a maggior ragione di ogni altro concetto. Di
questo actus purissimus o realtà tanto originaria da essere priva di potenzialità
precedenti, di questo essere incondizionatamente necessario, tanto anteriore a ogni
essere e pensiero da echeggiare il kantiano «abisso della ragione umana» (KrV, B 641)
– ma non identificabile con l’oggetto specifico del mistico, che non s’accontenta affatto
del “che”, ma «vuole conoscere estaticamente anche il che-cosa» (SW XIII: 163; nota)
–, non è possibile predicare l’essere in senso attributivo, perché «l’esistenza, che in
ogni altra cosa appare come l’accidentale, è qui l’essenza. Il quod si trova qui al posto
del quid» (SW XIII: 162). E neppure è possibile averne un’“idea”, ovviamente se
pensiamo all’idea nel senso della potenzialità (filosofia negativa) e non all’«idea
rovesciata, l’idea in cui la ragione è posta fuori di sé» (SW XIII: 162-3) che caratterizza
la filosofia positiva. Si tratta di partire non dal concetto, ma «dal meramente esistente
in cui null’altro sia pensato che appunto il meramente esistente […] per vedere se da
esso si può giungere alla divinità» (SW XIII: 158), provare cioè la divinità di ciò che,
essendo il puramente e necessariamente esistente, è anche l’indubitabile, dal momento
che dubbio è solo ciò che è potenza o è scaturito dalla potenza d’essere e quindi
costantemente in pericolo di non essere, in breve risalire dall’atto (essere) a priori alla
sua potenza (essenza) come divinità. Non stupisce allora che il pensiero e la ragione,
per natura circoscritti al possibile, ammutoliscano al cospetto del puramente esistente
e si scoprano del tutto secondari rispetto all’essere: perché nel suo sviluppo privo di
libertà, il pensiero «non sa nulla di una decisione, di un’azione o perfino di un atto»
(SW XIII: 173), perché «non per il fatto che si dà un pensare, infatti, si dà un essere,
ma perché c’è un essere, si dà un pensare» (SW XIII: 162), il quale altrimenti
rischierebbe la stasi, dato che «ciò che una volta ha avuto inizio nel semplice pensiero
può anche solo procedere nel semplice pensiero e non arrivare mai più in là dell’idea»
(SW XIII: 162).
Si arriverebbe dunque alla realtà effettiva solo muovendo dalla realtà effettiva
anteriore a ogni possibilità. Ma una realtà anteriore a ogni possibilità non è qualcosa di
incomprensibile? Certamente è incomprensibile se la si vuole afferrare col concetto
(pena il ridurlo da necessario a possibile) e domandandosi se possa esistere e quale sia
la sua essenza (visto che qui il “che-cosa” segue il “che”), ossia con un pensiero che si
pretende anteriore all’essere – ma per Schelling l’inizio del pensiero non è mai a sua
volta un pensiero bensì una realtà in atto –, mentre è perfettamente immaginabile (e
d’altronde attestata nella tradizione aristotelico-tomista) se se ne vede l’analogia con
quegli atti quotidiani che, secondo Schelling, diciamo originali in quanto non derivano
da un concetto precedente e ne inferiamo la possibilità solo a partire dalla loro realtà
attuale. Suggestivo, ma assai discutibile sia per la sua verosimile dipendenza dalla
logomachia estetica della genialità, sia perché l’individuazione del potenziale pare qui
successiva solo per difetto epistemico e non per una sua qualche intrinseca
posteriorità, l’esempio non doveva bastare nemmeno a Schelling se, per ovviare al
legittimo sospetto che il principio come puro atto, non scaturendo dal superamento
della potenza, ne conservi tutta l’accidentalità, sente il bisogno di reintrodurre
nell’immemoriale (e immobile) atto puro un contrasto capace di sottrarlo «alla sua
cieca eternità, all’eternità del semplice esistere, per giungere all’eternità dell’essere
essenziale (Wesen), all’eternità dell’idea» (SW XIV: 342). Provocandolo e offrendogli
qualcosa da volere, questo contrasto lo avvia alla condizione di “Signore” tanto di ciò
che ancora non esiste, quanto dell’essere originario che evidentemente non
padroneggiava, lo trasforma da essere necessario solo in atto – e pertanto sempre
passibile di tornare a essere mera possibilità sotto l’azione del sopravveniente – in
«essere necessariamente necessario, […] natura necessaria» (SW XIV: 348). Che vi si
veda il condizionamento razionalistico a ricondurre l’assolutamente accidentale al
necessario o una necessità non rafforzata «ma indebolita, cioè […] una necessità
doppiamente accidentale»27, questo cavilloso raddoppiamento della necessità non
esprime se non il fatto che Dio è la libertà di oltrepassare il proprio essere cieco e
immemoriale, rendendolo liberamente voluto. Peccato che alla legittima domanda circa
il motivo per cui egli vorrebbe superare e poi ricostituire il proprio essere necessario
attraverso il mondo (già, perché «tra quel superamento e questa ricostituzione sta il
mondo nella sua interezza») (SW XIV: 352-3), non si trova di meglio che rispondere
chiamando in causa la felicità con cui egli crea, e non per se stesso, con cui non ha
propriamente niente a che fare essendo a priori certo di sé, ma per qualcosa d’altro:
un’idea che, se segnala vistosamente come l’attivismo moderno viva della
stigmatizzazione dell’improduttivo motore immobile aristotelico («di certo non può
esserci nulla di più penoso che pensare incessantemente solo se stesso e quindi a se
stesso») (SW XIV: 352), nondimeno suona evasiva se non fideisticamente
condizionata.
9. L’esistenza ineludibile. È ovvio che si tratta di una condanna senz’appello della
tradizionale prova ontologica. In verità, oscillando nella sua analisi tra il rifiuto di ciò
che in essa degrada Dio a oggetto, unificando semplicemente l’ideale e il reale
precedentemente disgiunti dalla riflessione, e il desiderio di darne una
reinterpretazione nel senso dell’identità intuita di essenza ed esistenza, Schelling
giunge revocare la necessità del passaggio dal pensiero all’esistenza, fondandovi la
distinzione stessa tra negativo e positivo28, solo nel momento in cui si vede spinto al
“positivo” dalla crescente insoddisfazione per un Dio concepito come aseitas
razionalmente risolvibile e accoglie senza riserve l’avvertenza kantiana a non vedere
necessariamente implicata l’esistenza nell’ideale trascendentale (cui non può non
giungere la ragione spinta dal contingente al necessario), a considerare l’esistenza non
come mero predicato (logico) bensì come posizione, acquisizione sintetica (KrV: B 620
sgg., ma anche KdU §76, nota). Solo a questo punto gli appare chiaro che la prova
cartesiana dimostra non che Dio esiste, ma solo che, se esiste, allora esiste
necessariamente. Ciò che invece si tratta di dimostrare è non che Dio esiste, ma che
l’esistente è Dio, il che induce Schelling in un certo senso a partire sia dai fenomeni29
sia da un quod che, per la sua esenzione dal quid, medusizza la ragione, esigendo,
quale conseguenza della meraviglia che si prova «dinanzi all’essere che tutto domina»
(SW XIII: 165), l’idea «fuori della ragione» o «idea rovesciata» (SW XIII: 171, 162) del
puramente esistente, detto altrimenti un autentico “salto”, che, come non ha nulla di
mistico implicando pur sempre un’estasi della ragione, sancisce la bancarotta non di
qualsiasi ontologia, ma solo di quella formale.
Al centro dell’ontologia dell’ultimo Schelling, pur tra mille sfumature e revisioni,
troviamo in ultima analisi l’idea che a meravigliare, anzi a medusizzare, sia non la
ragione ma il puramente esistente, aconcettuale e quindi irriconducibile al possibile e
con ciò alla razionalizzazione logica, ciò che, in altri termini, «è subito reale, comincia
con l’essere» (SW XIV: 338) e si impone alla ragione giunta necessariamente in ritardo.
27
C. Ciancio, La libertà di Dio nell’ultimo Schelling, in C. Tatasciore (a cura di), Dalla materia alla
coscienza. Studi su Schelling in ricordo di Giuseppe Semerari, Milano 2000, p. 383.
28
Cfr. X. Tilliette, Attualità di Schelling, a cura di N. De Sanctis, Milano 1972, p. 107.
29
Ibid., p. 111.
Un’idea, quella della trascendenza dell’essere sul pensiero, che può ben essere
indipendente da precisi presupposti teologici, visto che ad attestarla basta in fondo
l’esperienza quotidiana dell’irriducibilità della sfera reale a quella logica. Ora, se nello
spiegarla un filosofo cristiano come Schelling non può ovviamente prescindere
dall’ipotesi creazionista e dalla tentazione di ricondurre il regno del possibile alla
ragione divina, ciò non significa affatto che un’“ontologia della libertà” debba
necessariamente sfociare in quella retorica abissale e tragicista che nell’estatica
“possessione” ontologica della coscienza ravvisa «un volto sfingeo e misterioso, che
folgora e soggioga il pensiero con lo scorcio di segrete e insondabili profondità»30. A
patto naturalmente che con la «convertibilità di essere e libertà»31 non si pensi
necessariamente Dio bensì il mondo reale, e che la non-necessità di tale mondo non
sia necessariamente spiegata come l’esito di un’azione personale, a patto, per dirla in
breve, che la meontologia, che sempre accompagna l’ontologia, non si traduca
automaticamente in un discorso fideistico ed extrascientifico.
Ma, per restare a Schelling, la cosa più intrigante è forse il fatto che proprio il suo
quasi ossessivo tentativo di rimuovere il possibile e lo status inevitabilmente
contingente sia dell’esistente sia della razionalità (se il mondo è logico, lo è per
Schelling infatti solo perché fu gettato nel logico), riveli ex contrario il ruolo
assolutamente centrale svolto nella sua filosofia complessiva dalla nozione di
possibilità, non da ultimo nel suo legame intrinseco con quella di materia. Si vedano le
acute riflessioni – che non è qui ovviamente possibile esaminare in dettaglio –
sull’ambiguità immanente al poter-essere, che esiste solo quando ignora se stessa,
proprio «come certe qualità umane, che sussistono a loro volta solo nel non sapere di
se stesse» (SW XIII: 225), e diventa fatalmente l’opposto in seguito
all’autoconsapevolezza, sulla sua estraneità alla scienza nonché sul suo essere,
rappresentando il nulla indispensabile all’attrazione dell’ente, la fonte di ogni
insoddisfazione e perciò sempre qualcosa di “sinistro”. Ma si pensi, soprattutto,
all’insufficiente distinzione tra le varie accezioni di possibilità (logica, materiale, reale) e
tematizzazione del carattere squisitamente mentale del possibile. Nell’osservare che la
realtà, essendo l’esito di una decisione, avrebbe pur sempre potuto essere altra da ciò
che è, se non addirittura del tutto diversa, Schelling non sembra avvertire come
problematico il fatto – peraltro correttamente segnalato laddove, escludendo che la
materia sia tale originariamente, vi vede unicamente la retroproiezione della realtà
effettiva – che l’individuazione di possibilità non esistenti, non attualizzate, dipende
solo dal pensiero, più precisamente dalla possibilità di immaginarle e darne una
descrizione linguisticamente consistente, che non è, detto altrimenti, se non una
variabile dipendente e parassitaria dalla realtà, l’esito di una valutazione differenziale
del reale, introdotta ex post nel reale per dotarlo di una provenienza e quindi anche di
un passato. Posto, allora, che lo stato ontologico del possibile sia fondamentalmente
mind-dependent32, non tanto uno stato del mondo quanto un carattere della realtà
stessa (a essa successivo), non ricadrà l’intera filosofia positiva, nella sua struttura
ontoteologica, nella sfera di quella negativa perché solo raziocinante? Rischia così
Schelling di confermare, suo malgrado, l’ipotesi secondo cui la sola ontologia possibile
è quella negativa, oppure pone le basi per una metafisica o ontologia riunificata nel
segno di una riedizione della teoria delle potenze? Una domanda che intenzionalmente
lasciamo aperta e la cui risposta necessita di un ulteriore, ma qui impossibile,
approfondimento dell’ontologia modale dell’ultimo Schelling.
30
L. Pareyson, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Torino 1995, p. 406.
Ibid. p. 21.
32
Cfr. N. Rescher, The ontology of the possibile, in M. J. Loux (ed.), The possible and the actual. Readings
in the metaphysics of modality, Ithaca-London 1979, pp. 166-181, e più ampiamente Id., A theory of
possibility, Oxford 1975.
31
2) Il vincolo tradizionale che sembra legare il possibile al pensabile non sembra creare
problemi a Schelling
Ma: possibile nel senso logico a) che la sua affermazione non implica contraddizioni,
che nulla esclude e quindi è uguale in linea di principio a ogni cosa, comportando però
la diversità da sé e quindi rendendo obliquo il riferimento. Fin qui abbiamo la possibilità
unicamente come funzione finzionale di un mondo. Ma la possibilità, non più solo logica
ma materiale bA ciò s’aggiunga la possibilità c) reale, nella sua duplice caratteristica di
possibilità che un certo reale sia o agisca in un certo modo e di possibilità
(controfattuale) che il reale sia altro da quello che è.
3) Ma il possibile non costituisce affatto un regno ontologico accanto a quello della
realtà, trovandosi a rigore solo nel pensiero.
Sigle
GgP = Grundlegung der positiven Philosophie. Münchner Vorlesung (1832-33), Hg. von H. Fuhrmans,
Torino 1972.
SdW = System der Weltalter. Münchener Vorlesung 1827/28 in einer Nachschrift von Ernst von Lasaulx,
hg. und eing. Von S. Peetz, Frankfurt a. M. 1990.
SW = Sämmtliche Werke, hg. von K. F. A. Schelling, Stuttgart 1856-61.
La prima potenza in cui al pensiero si presenta l’essente privo di fondamento è la
potentia existendi, il cui passaggio all’essere non è affatto necessario nel senso
costrittivo del termine ma dipendente dalla sua naturale volontà di compierlo; la
seconda potenza dell’essente è il dover-essere, che fa sì che non si tratti di un cieco
essere ma di un essente nella sua compiutezza
Il che però significa che l’Uno, duplice nella sua unità, padroneggia se stesso in quanto
il se stesso che è potenza d’essere viene limitato dal se stesso che è il puramente
esistente.
SW II 44-45: un Dio in cui l’idea preceda l’atto è un Dio che non può creare; vale
semmai che da Dio scaturiscono contemporaneamente gli oggetti reali e le loro idee
(reale contemporaneamente alla conformità allo scopo): idee contemporanee al reale.
Nel delineare come l’aspirazione a una vita saggia implichi la credenza nella presenza
della saggezza anche nella vita, Schelling sottolinea esplicitamente che il soggetto
conoscente deve presupporre anche nell’oggetto della sua conoscenza una certa
conoscenza, che dunque il reale possiede una sua razionalità immanente, ma subito
dopo declina questa corrispondenza tra conosciuto e conoscente nei termini
trascendentalistici secondo cui l’oggetto porterebbe in sé «la forma e l’impronta del
conoscente»il presupposto di una realtà e di un divenire dotati di saggezza è
indispensabile a chi voglia ordinare la propria vita saggiamente (XIII: 203).
detto altrimenti una «scienza del pensiero necessario, che inizia da se stesso e in sé
progredisce, ma nel contempo si realizza immediatamente nell’esperienza» che si può
considerare l’«unica vera ontologia» (SW XIII: 111).
Ma una rettifica positiva della filosofia negativa non potrebbe limitarsi semplicemente
ad esigere che quanto la ragione concepisce come meramente possibile, senza peraltro
poterne provare da sé l’esistenza presente (l’esistenza di questa o quella cosa), venga
poi legittimato nella sua realtà attuale dal mondo sensibile, dalla «fede» nella sua
autorità? Vediamo. Ricevendo una impressione, noi ci rappresentiamo anzitutto
l’esistenza di qualcosa in generale, il quod, e solo in un secondo tempo pensiamo il suo
quid, ossia che cosa sia l’oggetto della nostra rappresentazione
Del resto, a rigore l’empirismo non esclude affatto il sovrasensibile, giacché è evidente
che, ad esempio, l’intelligenza agente, pur essendo conoscibile solo a posteriori e
quindi empiricamente, non è come tale propriamente accessibile al senso, è cioè un
sovrasensibile conoscibile sensibilmente (attraverso i suoi atti), qualcosa di
propriamente inaccessibile al senso, ma non certo come ciò che lo è attualmente e che
però non eccede il circolo dell’esperienza possibile. Tutto sta a capire come senso ed
esperienza non coincidano e come la causa dell’esperibile non sia necessariamente
l’astratto inesperibile. Se si dà esperienza solo dove vi siano deliberazione e azione
(laddove ciò che pone il puro pensare è privo di vera libertà), si tratta di valutare se
possa darsi un empirismo metafisico.
Riflettiamo: anche se gli si può attribuire una sorta di eternità secondaria rispetto a Dio
quale Herr des Seins, a cui è coeterno essendo necessario porlo insieme a Dio
(appunto di per sé impensabile senza rapporto con l’essere), l’essere è però tanto
assiologicamente quanto (paradossalmente) ontologicamente dotato di un essere
proprio, distinto e ovviamente inferiore a quello di Dio. È vero che è solo se Dio è, e
tuttavia prima di ogni determinazione, che necessariamente viene da Dio, è pur
sempre qualcosa, quanto meno «un vero nulla», materia capace delle tre
determinazioni suddette ma di per se stessa priva di esse e perciò «puro gioco della
libertà divina» (SW X: 275). Ma questa tesi è solo un passaggio, bisognoso di rettifica
in quanto ancora ammette qualcosa che (concettualmente?, tradizionalmente?) è a
rigore inammissibile, e cioè che la causa suprema abbia ancora qualcosa fuori di sé
(anche se non extra bensì praeter), abbia cioè un presupposto, il quale viceversa
sparisce se si ammette che abbiamo Dio soltanto e che è Dio stesso, mediante il solo
suo volere, a manifestarsi ora come 1) illimitato (essere cieco), ora come 2) limitato
(ciò che nega quell’essere cieco), infine come 3) ciò che è posto come spirito. Dio è
l’atto, l’unità che passa nell’intero processo. Ma anche quello di «causa assoluta», pur
essendo per noi il solo concetto possibile di Dio (come creatore e signore delle cose),
non è affatto il suo concetto supremo, implicando una relazione verso qualcosa che è
almeno possibile; la sua assoluta indipendenza è meglio espressa dal concetto di
«sostanza» che ha in sé, volendolo, la potenza di essere l’illimitato (B), di essere ciò
che nega B, ecc. I princìpi prima «scoperti mediante un’analisi empirica» (SW X: 280)
si tramutano ora in potenze immanenti a Dio, dalle quali peraltro dobbiamo a rigore
prescindere se vogliamo pensare Dio non in relazione ma nella sua solo volontà, o
meglio dobbiamo concepirle come potenze non sostanziali (ne verrebbe per lui una
necessità di agire) bensì in tutto e per tutto dipendenti solo dalla sua volontà, come
potenze che non esistono in lui già come potenze ma che vengono poste in essere,
anche solo come potenze, solo dalla sua volontà («egli soltanto le rende potenze, esse
non lo sono») (SW X: 286), e perciò sono sue determinazioni immanenti. Né l’essere
come eterno correlato né le potenze come possibilità che si offrono a Dio resistono
all’analisi schellinghiana e al suo voler restar (filosoficamente) fedele all’idea di una
creazione assolutamente libera e senza presupposti, di una creazione (ex nihilo) non
preceduta neppure da un non-esistente inteso come me on, da una semplice potenza
(interna o esterna a Dio che sia), che a sua volta deriva dal vero nulla (ouk on). Ma
qui, dovendo spiegare come Dio sia il prius delle potenze stesse e quindi il prius
assoluto, l’empirismo lascia già il posto al sovraempirico. Se ne ricava che empirismo
equivale a indagine regressiva sino a Dio??
“speculare” significa per Schelling cercare una possibilità grazie a cui la scienza
raggiunge uno scopo mediante ipotesi in attesa di conferma, il che non rende affatto
ipotetica l’intera filosofia positiva, che dimostrando la realtà di tutto ciò che consegue a
quella ipotesi, toglie appunto a questa ipotesi stessa ogni ipoteticità (SW XIV: 346)
Se potenza d’essere e essere attuale sono accomunate dal possibile (il secondo infatti
presuppone in permanenza quella potenza d’essere che dell’essere che ora ha è la
negazione), differenziandosi così decisamente dal puramente esistente,