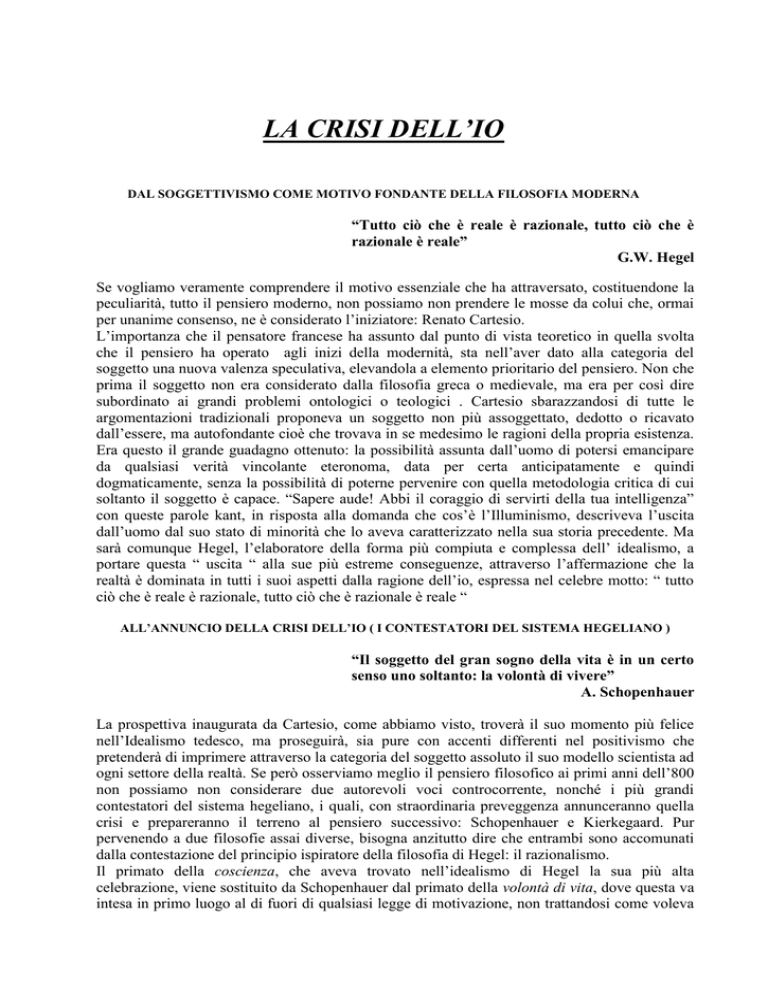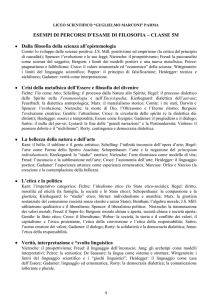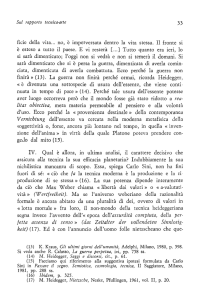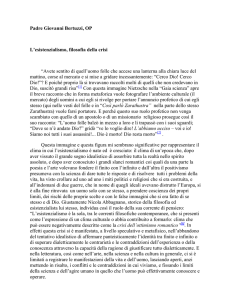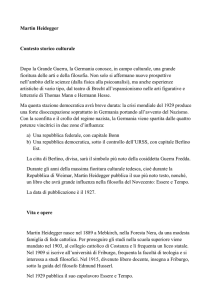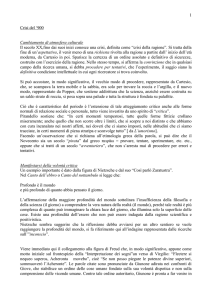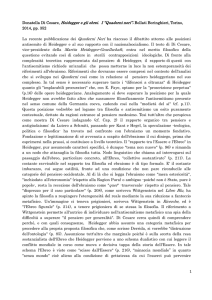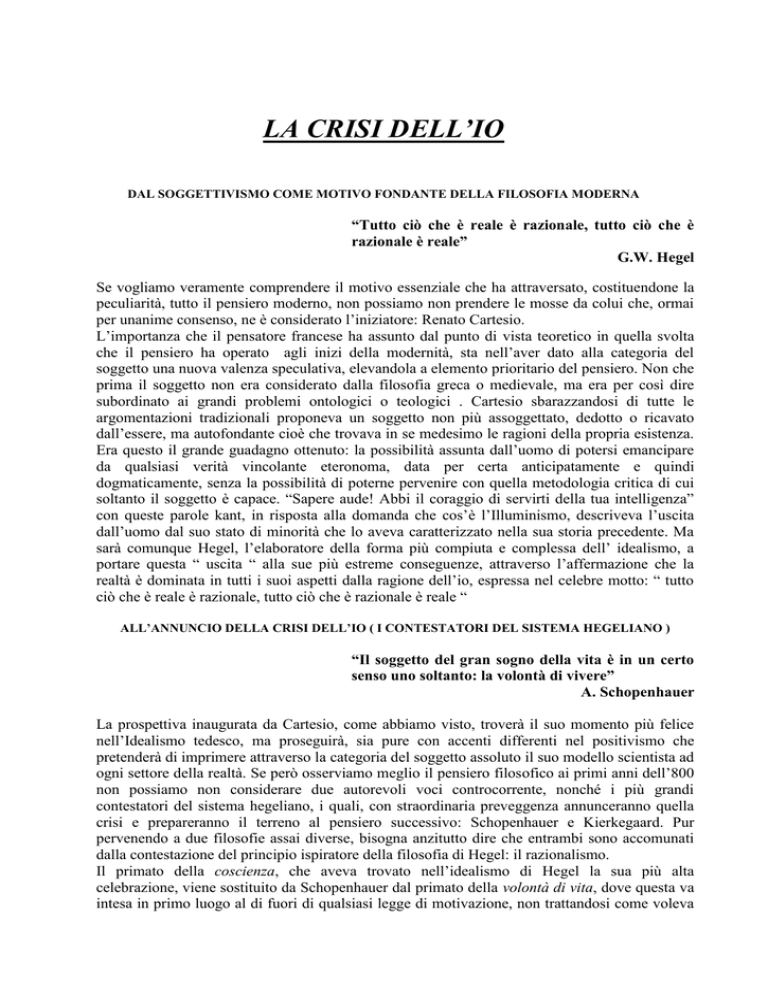
LA CRISI DELL’IO
DAL SOGGETTIVISMO COME MOTIVO FONDANTE DELLA FILOSOFIA MODERNA
“Tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è
razionale è reale”
G.W. Hegel
Se vogliamo veramente comprendere il motivo essenziale che ha attraversato, costituendone la
peculiarità, tutto il pensiero moderno, non possiamo non prendere le mosse da colui che, ormai
per unanime consenso, ne è considerato l’iniziatore: Renato Cartesio.
L’importanza che il pensatore francese ha assunto dal punto di vista teoretico in quella svolta
che il pensiero ha operato agli inizi della modernità, sta nell’aver dato alla categoria del
soggetto una nuova valenza speculativa, elevandola a elemento prioritario del pensiero. Non che
prima il soggetto non era considerato dalla filosofia greca o medievale, ma era per così dire
subordinato ai grandi problemi ontologici o teologici . Cartesio sbarazzandosi di tutte le
argomentazioni tradizionali proponeva un soggetto non più assoggettato, dedotto o ricavato
dall’essere, ma autofondante cioè che trovava in se medesimo le ragioni della propria esistenza.
Era questo il grande guadagno ottenuto: la possibilità assunta dall’uomo di potersi emancipare
da qualsiasi verità vincolante eteronoma, data per certa anticipatamente e quindi
dogmaticamente, senza la possibilità di poterne pervenire con quella metodologia critica di cui
soltanto il soggetto è capace. “Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza”
con queste parole kant, in risposta alla domanda che cos’è l’Illuminismo, descriveva l’uscita
dall’uomo dal suo stato di minorità che lo aveva caratterizzato nella sua storia precedente. Ma
sarà comunque Hegel, l’elaboratore della forma più compiuta e complessa dell’ idealismo, a
portare questa “ uscita “ alla sue più estreme conseguenze, attraverso l’affermazione che la
realtà è dominata in tutti i suoi aspetti dalla ragione dell’io, espressa nel celebre motto: “ tutto
ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale “
ALL’ANNUNCIO DELLA CRISI DELL’IO ( I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO )
“Il soggetto del gran sogno della vita è in un certo
senso uno soltanto: la volontà di vivere”
A. Schopenhauer
La prospettiva inaugurata da Cartesio, come abbiamo visto, troverà il suo momento più felice
nell’Idealismo tedesco, ma proseguirà, sia pure con accenti differenti nel positivismo che
pretenderà di imprimere attraverso la categoria del soggetto assoluto il suo modello scientista ad
ogni settore della realtà. Se però osserviamo meglio il pensiero filosofico ai primi anni dell’800
non possiamo non considerare due autorevoli voci controcorrente, nonché i più grandi
contestatori del sistema hegeliano, i quali, con straordinaria preveggenza annunceranno quella
crisi e prepareranno il terreno al pensiero successivo: Schopenhauer e Kierkegaard. Pur
pervenendo a due filosofie assai diverse, bisogna anzitutto dire che entrambi sono accomunati
dalla contestazione del principio ispiratore della filosofia di Hegel: il razionalismo.
Il primato della coscienza, che aveva trovato nell’idealismo di Hegel la sua più alta
celebrazione, viene sostituito da Schopenhauer dal primato della volontà di vita, dove questa va
intesa in primo luogo al di fuori di qualsiasi legge di motivazione, non trattandosi come voleva
l’idealismo di un prodotto della coscienza, ma caratterizzata da una cieca irrazionalità portatrice
di dolore e distruzione. Non quindi la conoscenza e poi la volontà, ma la conoscenza come esito
della volontà, quell’”immotivata volontà di esistere” a cui l’uomo occidentale ha sempre voluto
sottrarsi. La filosofia della coscienza, che Platone ha inaugurato con il concetto di anima e che
Cartesio ha ribadito col primato del cogito, subirà con Schopenhauer il primo momento di
precarietà e inconsistenza, in cui la realizzazione dell’individuo risulterà estremamente
problematica essendo mossa passivamente da quel principio metafisico cieco e irrazionale che è
la volontà; con la conseguente perdita del libero agire del soggetto umano che diviene così il
deterministico prodotto delle pulsioni e dei bisogni naturali in cui si palesa la volontà e non
potendo più fare affidamento su una ragione universale garante di tutto e di tutti. L’influsso di
questo pensiero sulla cultura a lui successiva è stato molto grande, merita comunque di essere
segnalato quello su Nietzsche, ( di cui più avanti tratteremo ).
Pur partendo dalle medesime critiche al pensiero di Hegel (dando sempre per scontato che esso
rappresenti il punto conclusivo del secolare sviluppo della filosofia razionalistica), ben diverso
si presenta il pensiero di Kierkegaard. La distanza che prende da Schopenhauer può essere
focalizzata nel fatto che mentre quest’ultimo partiva dalla concezione di un individuo
assoggettato ad un principio infinito, in Kierkegaard, al contrario, l’individuo è pensato nella
sua valenza irrimpiazzabile e come il più adeguato punto di vista a partire dal quale è possibile
affrontare tutti i problemi della filosofia. Si capisce che allora l’attacco all’ hegelismo è ancora
più radicale, essendo quest’ultimo il tentativo estremo di spiegare la realtà attraverso un ordine
sistematico, totalitario, chiuso, e quindi incapace di pensare l’assoluta singolarità dell’esistente,
intesa come processo sempre aperto alla possibilità. Il capovolgimento della metodologia
hegeliana porterà Kierkegaard ad una riflessione profonda sul singolo individuo, riflessione
posta a partire da una categoria che gioca un ruolo cruciale nel suo pensiero, quella
dell’esistenza. L’Esistenza dell’uomo in senso etimologico vuol dire infatti “esser fuori “, fuori
dai modelli sistematici e astratti della ragione universale che pretende di riassorbire
l’individuale nell’universale, e quindi inserito in una dinamica di illimitate possibilità in cui
ogni volta è chiamato a rispondere. Di qui la sua indecisione, la sua instabilità di fronte alle
alternative possibili, che proprio perché caratterizzate da quella alta dose di “ non necessità “
traducono la sua libertà di agire in un insormontabile sentimento di angoscia, quel puro
sentimento della possibilità che lo ribalta in un orizzonte di radicale “finitezza”. Questa nuova
prospettiva è ancora maggiormente illuminata da un’altra tematica centrale del suo pensiero,
quella dell’esperienza religiosa. Adamo in un primo momento, come si è soliti ricordare, viveva
in uno situazione di completa innocenza caratterizzato da uno stato di ignoranza, come è potuto
pervenire successivamente alla coscienza di sé? Non sicuramente secondo un passaggio logico,
bensì con un taglio netto, con una rottura, che è il peccato originale. Solo il peccato, il pesante
stato di angoscia che esso produce ha portato Adamo a comprendere il suo essere individuo, il
suo essere finito di fronte alla figura infinita di Dio. Questo senso di essere colpevoli è la pietra
di paragone più pertinente per poter pervenire a se stessi, che porterà Kierkegaard ad affermare
la correlatività tra il “singolo “ e la “ fede “ come unico accesso per poter pensare un’ esistenza
“ autentica “.
NIETZSCHE E FREUD: LA CRISI DELL’IO COME MANIFESTAZIONE EPOCALE DEL PENSIERO
“ Io conosco la mia sorte. Si legherà un giorno al
mio nome il ricordo di una crisi, come non ce ne fu
un’altra simile sulla terra.”
F.Nietzsche
Abbiamo prima messo in evidenza l’influsso che Schopenhauer ha esercitato sul pensiero di
Nietzsche perché esso rappresenta un nodo davvero rilevante all’inizio del suo pensiero. È lo stesso
Nietzsche leggendo “il mondo come volontà e rappresentazione” a riconoscere il suo debito,
scriverà infatti più tardi: << avevo davanti a me uno specchio nel quale vidi il mondo, la vita e il
mio stesso animo >>. Il punto di partenza è quindi il medesimo: l’io è un derivato di quelle pulsioni
che a null’altro tendono che all’immotivata volontà di esistere. La condizione dell’uomo, quindi,
lungi dal costituirsi attraverso idee equilibrate e trasparenti, versa in una situazione di incertezza
legata agli istinti, in pieno accordo con la natura, con tutta quella dose di caos che gli è propria. La
sua critica a quel lungo processo di razionalizzazione operato dal pensiero occidentale raggiungerà
tuttavia una più profonda consapevolezza che non negli altri autori sopra trattati, facendo di
Nietzsche un punto di riferimento ineludibile per tutta la filosofia del novecento. Il suo merito va
ricercato anzitutto nel suo disincanto che gli ha permesso di smascherare e di decostruire tutto quel
pensiero che a partire da Socrate, ma più esplicitamente da Platone, ha creduto di poter pervenire
alla verità attraverso la postulazione di un mondo ideale, trascendente, in sé, che in quanto mondo
vero è sovraordinato al mondo sensibile e di cui il soggetto umano è l’esclusivo interprete;
teorizzazione questa che inevitabilmente viene a cadere man mano che l’uomo riesce a prendere
consapevolezza della propria condizione. Questa condizione troverà nel suo pensiero la sua più
seria esplicitazione, ed è lo stesso Nietzsche a dircelo quando pensava se stesso come: << il primo
perfetto nichilista d’Europa >>. Ma che cos’è propriamente il nichilismo? È ancora lo stesso
Nietzsche a dircelo: << Nichilismo: manca il fine; la risposta al perché?; che cosa significa
nichilismo?- che i valori supremi si svalutano >>. Il lungo sogno del razionalismo occidentale viene
dunque a finire, poiché presto il mondo ideale si rivelerà illusorio, irraggiungibile, e quindi
inevitabilmente inconsistente; che cosa rimane a questo punto se non l’uomo solo di fronte a se
stesso? ma dire questo non significa anche dire che da questo momento in poi l’uomo non potendo
più contare su nessuna consolante garanzia trascendente ( qualunque essa sia: il Bene, Dio, l’Io
assoluto ecc., ) è inevitabilmente consegnato alla più estrema precarietà? Nietzsche sa bene l’alta
dose di rischio che caratterizza l’uomo contemporaneo, ciò nonostante, e in questo sta il suo grande
congedo da Schopenhauer, non vuole concedersi l’annullamento dello spirito umano nel nulla che
sarebbe l’etichetta di un nichilismo passivo, bensì in una presa di posizione teorizzata nella figura
del superuomo, unico vero interprete di una situazione epocale irrimediabilmente avviata. In un
celebre frammento dell’87 chiedendosi: << quali uomini saranno allora i più forti? >> risponde:
<< i più moderati, quelli che non hanno bisogno di principi e di fede estrema, quelli che non solo
ammettono, ma anche amano una buona parte di caso, di assurdità, quelli che sanno pensare,
riguardo all’uomo, con una notevole riduzione del suo valore senza diventare perciò piccoli e
deboli. >>. Solo ammettendo la sua debolezza la sua non stabilità, solo così l’uomo potrà far fronte,
sia pure per piccoli passi, a quella situazione precaria e di radicale crisi, sigillo autentico della
nostra epoca. Strettamente connessa alla tematica del nichilismo è da considerare quella dell’eterno
ritorno che Nietzshe tratta in perfetta coerenza con lo svilupparsi delle sue tesi; se infatti la nostra
epoca si rivela come l’emergere della mancanza di senso che tutto investe, dove vanno a finire
quelle categorie di fine di progresso tanto care sia alla concezione Cristiana della storia che allo
storicismo di matrice Hegeliana? È chiaro, a questo punto, che anche esse inconsistenti prodotti di
una insensata volontà, che mirerebbe piuttosto alla costruzione di questi illusori ideali per garantire
la propria conservazione, si perdono nel nulla. Non esiste, dunque, nessuna razionalità garante
dell’azione umana, nessuna provvidenza, nessun progresso, solo l’eterno ritorno delle cose e dei
fatti, secondo una legge ciclica di un mondo soltanto teso ad accettare se stesso e di ripetersi, non
essendo diretto verso nessun fine. Al di là di ogni giudizio di valore che le varie interpretazioni gli
hanno attribuito, resta il fatto dell’insistente riemergere, anche in epoca recente, di questo pensiero
che ha duramente segnato il nostro tempo.
Pur provenendo da una diversa formazione intellettuale è illuminante sottolineare come anche
Freud, pur non avendolo letto, perviene alle stesse conclusioni di Nietzsche; indice di una crisi
ormai affermatasi in tutti i campi. È Freud ad imprimere all’uomo la terza grande umiliazione
storica. Dopo la prima, quella “cosmologica”, che gli è stata inflitta da Copernico, quando lo ha
tolto, togliendovi la Terra, dal centro dell’universo e la seconda, quella “biologica”, da Darwin, che
lo ha fatto discendere dalla schiera degli animali, adesso è proprio Freud ad inferiorizzarlo,
scoprendo che le sue azioni non derivano da una libera scelta, ma sono il prodotto delle passioni e
pulsioni inconsce. Il duro colpo, se si osserva bene, è indirizzato soprattutto a quella concezione
cristiana, ma anche ad ogni forma di morale che nutriva una profonda fiducia su un concetto di
anima unitaria e razionalmente controllabile. Il profondo scandalo e lo scarso interesse che essa
suscitò è dunque da ricercare in questo. Ad avviso di Freud esisterebbe una regione, all’interno
della nostra mente, chiamata Es, che si sottrae drasticamente al mondo della coscienza. Sbagliare,
sognare, dimenticarsi e ogni genere di nevrosi troverebbero la loro spiegazione causale in pulsioni
respinte e in desideri rimossi dell’inconscio, ma non cancellate. Il fatto è che anche il primo stadio
della nostra vita, cioè il periodo infantile, sarebbe caratterizzato da una serie di istinti e di pulsioni,
che sono in primo luogo di natura sessuale, e che queste attraverso un processo di razionalizzazione
morale verrebbero censurate, ma non per questo assolutamente neutralizzate. Questo principio
biologico-sessuale, lungi dal perdere la sua rilevanza attraverso quel processo di censura, troverebbe
manifestazione in quelle circostanze caratterizzate dalle più svariate patologie: nevrosi, lapsus, ecc,
consegnando l’anima umana ad una vera e propria frammentazione. È importante osservare come
attraverso l’esplicazione della teoria Freudiana veniva drammaticamente a cadere la portata
simbolica dell’infanzia intesa come età dell’innocenza e della purezza morale: il bambino, secondo
Freud e ben lungi da quell’essere morale che si era sempre creduto, anzi in lui, già dal primo giorno
di vita, sono in attività degli intensi bisogni sessuali che alla coscienza comune si mostrano in tutta
la loro più estrema perversità. Ecco come Freud chiarifica questo nodo centrale della sua teoria: <<
il bimbo concentra sulla persona della madre i suoi desideri sessuali e concepisce impulsi ostili
contro il padre, considerato come un rivale. Questa è anche, “mutatis mutandis”, l’attitudine della
bambina >>; i sentimenti che si formano in questo periodo non sono dunque caratterizzati
esclusivamente dall’affabilità e dalla tenerezza ma possono anche tramutarsi nell’odio più profondo,
formando quel “complesso” che è inevitabilmente condannato ad una rapida censura. Questo
particolare momento può essere efficacemente illuminato, secondo Freud, dal mito di Edipo, figlio
del re di Tebe, che nella tragedia greca uccide suo padre e prende in moglie la propria madre;
tenendo sempre presente di come le cose in realtà si articolano diversamente: nell’impossibilità di
soddisfare il suo desiderio, il bimbo si assoggetta a quel competitore , il genitore di cui è geloso, e
costui diviene il suo padrone interiore che nella figura di censore può far svanire la crisi edipica e
contemporaneamente far emergere il senso morale da seguire.
Dopo quanto detto è facile schematizzare la teoria dell’apparato psichico proposta da Freud.
Questo è composto dall’ “Es” che è la sorgente dell’energia biologico-sessuale, e quindi la sede
degli impulsi inconsci; dall’ “Ego” che è il rappresentante cosciente dell’ “Es”; ed infine dal
“Super-Ego” che, come abbiamo visto sopra, nasce come interiorizzazione dell’autorità familiare e
prosegue successivamente attraverso altre figure come per es.: educatori, insegnanti e modelli
ideali, traducendo il Super-Ego “paterno” in Super-Ego “sociale”. Si può comprendere ora che
L’Ego, punto di riferimento imprescindibile e prioritario del razionalismo occidentale, non gode di
nessuna posizione autonoma e privilegiata, ma in verità si trova continuamente a dover
commerciare tra le pulsioni aggressive dell’ “Es” e le proibizioni ( siano queste familiari o sociali )
morali del Super-Ego. In altri termini l’individuo è sottoposto a quella spinta biologico-sessuale che
è regolata da due principi: quello del piacere e quello della realtà. Attraverso il principio del piacere
queste pulsioni tendono a trovare un soddisfacimento immediato e totale, che però quel censore che
è il principio di realtà riesce ad incanalare per altre vie come la produzione artistica, la scienza ecc. ,
quelle vie che Freud chiama le vie della civiltà. Ma il momento più pericoloso per l’uomo subentra
quando le repressioni del principio di realtà sono cosi consistenti da impedire qualsiasi deviazione
sostitutiva, costringendolo nella più totale nevrosi che è ben sintetizzata dalle stesse parole di Freud:
“l’Io non è più padrone nemmeno in casa propria”.
MARTIN HEIDEGGER: L’ESISTENZA DELL’ “IO” INTESA COME “VIVERE PER LA MORTE”
Il lavoro filosofico dei pensatori sopra trattati non poteva rimanere nell’anticamera a lungo: tutto il
pensiero del novecento, infatti, scopri irrimediabilmente l’affermarsi in modo radicale di quella crisi
dell’io precedentemente non presa sul serio e quella vasta corrente filosofica contemporanea che si
affermerà dopo la I guerra mondiale sotto il nome di Esistenzialismo non poteva non prendere le
mosse dalla constatazione della grande crisi dell’Hegelismo come orizzonte epocale del pensiero.
Martin Heidegger, che di questa corrente è uno dei maggiori rappresentanti, cominciava la sua
opera che lo avrebbe reso noto al panorama filosofico, cioè Essere e Tempo, denunciando
l’inadeguatezza da parte della metafisica tradizionale di poter pervenire alla verità attraverso
l’identificazione della categoria dell’essere con quella della semplice presenza o per usare un
termine più tecnico con l’oggettività. Era questo, dunque, il problema da cui Heidegger prendeva le
mosse: quello dell’incomprensione da parte del pensiero del senso dell’essere in generale. Problema
che è importante sottolineare fin d’ora non era quello dei filosofi precedentemente trattati ma che
nonostante tutto lo condurrà ad esaminare una tematica tanto cara soprattutto a Kierkegaard: quella
dell’esistenza, della condizione umana, che Heidegger valuterà come il percorso più originario per
poter pervenire ad una comprensione dell’essere in generale. Se infatti la metafisica ha sempre
voluto presupporre un Ente ( Dio, il Soggetto Assoluto ecc. ) in forza del quale si poteva dare
ragione di ogni realtà era dunque opportuno in primo luogo sbarazzarsi di qualsiasi categoria data
per certa anticipatamente, e dunque partire da quella condizione umana più irriducibile alle
astrattezze dei concetti. Come lo stesso Heidegger ci dice in ogni problema è possibile distinguere:
1. ciò che si domanda, 2. ciò a cui si domanda, 3. ciò che si trova domandando, e in questo senso
c’è un cercato ( l’essere ), un ricercato ( il suo senso ) e un interrogato presso cui si cerca. Questo
interrogato non può però essere un ente qualsiasi, o per dirla con Heidegger una semplice presenza
oggettiva; gli enti infatti possono essere molti: vegetali, animali, cose ecc. ma solo l’uomo può
vantare un rango primario per fungere da interrogato, solo l’uomo proprio perché è l’unico ad essere
originariamente aperto alla comprensione dell’essere. Heidegger precisando questa cruciale
posizione dell’uomo dirà che dal granello di sabbia a Dio gli enti <<sono>> ma non <<esistono>>,
non sono aperti, cioè, a quella originaria manifestazione dell’essere. Dire questo, signica intendere
il termine ex-sistere nel suo senso etimologico, cioè come star fuori, oltrepassare la realtà
semplicemente-presente in direzione della possibilità, con tutto quello che questo termine implica.
La differenza radicale che separa il modo di essere dell’uomo da quello delle cose va ricercato dal
punto di partenza, i caratteri dell’uomo non saranno quindi l’insieme delle <<proprietà>> che
determinano la sua realtà poiché la sua natura è quella di poter essere, dunque quella di non avere
una natura o un’essenza. Giunti a questo punto si può capire benissimo che l’esistenza, come luogo
esclusivo dell’uomo, non può essere considerato come il luogo occasionale del problema del senso
dell’essere in generale, ma la condizione costitutiva della sua possibilità. In parole più semplici non
ci può essere problema dell’essere se non c’è l’esistenza. Heidegger chiama più propriamente la
situazione dell’uomo con il termine Da-sein , che può essere tradotto in italiano col termine esserci, dove appunto il ci sta ad indicare la situazione concreta dell’uomo intesa sempre in maniera
dinamica, come appunto temporalizzazione, che Heidegger chiamerà con il termine progetto.
Rapportarsi col mondo significherà allora in primo luogo progettare, l’uomo è nel mondo sempre
come ente che si rapporta alle proprie possibilità, e in questo senso incontra le cose inserendole in
un progetto, cioè assumendole come strumenti. In questo modo Heidegger riusciva a prendere
egregiamente congedo da quel modo abituale di vedere di un certo tipo di filosofia che concepiva
l’uomo come occhio puro e distaccato di un mondo totalmente <<oggettivo>>, cioè un mondo di
cose in sé che l’uomo aveva la facoltà di spiegare, mostrando che l’in sé delle cose altro non è che
un’operazione dell’uomo effettuata in vista di certi scopi, quindi una forma derivata
dall’utilizzabilità delle cose che resta la modalità originaria del loro darsi. Ma lo strumento non può
mai considerarsi isolato, esso è caratterizzato dal fatto che rimanda ad una totalità di strumenti
all’interno della quale si definisce; nel rimando sorge il significato. Essere-nel-mondo non significa
esclusivamente avere a che fare con una totalità di cose e strumenti , ma anche avere a che fare con
una totalità di significati. Se è dunque vero che essere-nel-mondo significa essere originariamente
aperti a una totalità di significati un altro tratto costitutivo dell’esser-ci sarà dunque la
comprensione; dove con questo termine non si deve intendere il classico rapporto tra soggetto
conoscente e oggetto conosciuto, ma quell’apertura al senso che viene prima di ogni significato
specifico e particolare. Da questo momento in poi può emergere in tutta la sua chiarezza una prima
conclusione che gioca un ruolo decisivo nel pensiero Heideggeriano: il fatto ,cioè, che ogni
situazione teorico-conoscitiva non sorge a partire da una condizione di autosufficienza del pensiero
stesso ( quindi da una priorità dell’Io, secondo il principio di un sapere assoluto ) come la filosofia
ha sempre ritenuto, ma a partire da una condizione che Heidegger chiama situazione affettiva (
gioia, dolore, noia, angoscia ecc. ) in cui l’uomo inequivocabilmente si trova, al di là di qualsiasi
verità formale, e che costituisce quella <<prensione>> più originaria da cui deriva la <<comprensione>> stessa del mondo. Procedendo per questa via il famoso Io puro di Kantiana memoria,
cioè una soggettività non contaminata dalla disposizione emotiva, veniva totalmente decostruito,
proprio perché la situazione affettiva non dipende dall’esserci ( che in questo caso è come se fosse
gettato ), ma siccome condiziona la comprensione del mondo ne consegue che il mondo è qualcosa
che sfugge nei suoi fondamenti. La finitezza umana, dopo Kierkegaard, emerge di nuovo con
Heidegger in tutta la sua drammaticità, e in tutta la sua opposizione all’Hegelismo che aveva
concepito l’uomo come un puro occhio sul mondo da nulla condizionato.
Il fatto che l’uomo si trovi gettato nel mondo porterà Heidegger ad analizzare altre due importanti
questioni: quella dell’esistenza inautentica e quella dell’esistenza autentica. La preliminare
comprensione che l’uomo effettuerà del mondo sarà determinata dalla modalità acritica e irriflessa
di comprenderlo che è esplicitamente indicata dal modo <<comune>> di vedere e giudicare le cose;
Heidegger chiama questo modo comune di vedere le cose col nome <<Si>> e con queste parole lo
illustra: << Ce la spassiamo e ci si diverte come ci si diverte ; leggiamo, vediamo e giudichiamo di
letteratura e di arte come si vede e si giudica. Ci teniamo lontani dalla “gran massa” come ci si tiene
lontani, troviamo “scandaloso” ciò che si trova scandaloso. Il Si, che non è un esserci determinato,
ma tutti ( non però come somma ) decreta il modo di essere della quotidianità >>. Si tratta in
termini più semplici di un’esistenza inautentica che sottostà all’assioma << la cosa sta così perché
così si dice >>, quella che si appresa dal modo << comune >> di considerare le cose in cui l’esserci,
venendo al mondo, s’è trovato. Per l’esserci “gettato nel mondo” la comprensione anonima del Si è
inevitabile, e questo conduce Heidegger ad affermare che << in essa e da essa >> si realizza ogni
comprensione genuina, ma poi aggiunge che essa rappresenta lo sfondo dal quale il progetto del
singolo ha bisogno di staccarsi. Staccandosi, l’esserci realizza un’esistenza autentica, nel senso che
fa un’esperienza << propria >> ( il termine autenticità tradotto in tedesco si dice Eigentlichkeit,
dove appunto l’aggettivo eigen vuole dire << proprio >> ) delle cose e, facendola, se ne appropria
rapportandosi direttamente ad esse. Questo rapportarsi Heidegger lo chiama << cura >>, che vuol
dire in primo luogo assumersi responsabilità di fronte alle cose, cioè di rispondere ad esse in modo
proprio. Assunta la modalità di progettare in modo proprio l’esserci, che è appunto poter-essere, si
imbatte in un’altra questione problematica: tutte le scelte del poter-essere sono in fondo tutte
equivalenti: posso scegliere di impegnare la mia vita allo studio, all’arte, al lavoro ecc. e alla fine
decidermi per una di esse finendo però sempre al livello del mondo e delle cose. C’è tuttavia una
possibilità diversa dalle altre a cui l’uomo non può sfuggire: si tratta della morte. Posso decidere di
non studiare di non mangiare ecc., ma non posso decidere di non morire, la morte come possibilità
permanente ci dice Heidegger è la possibilità che tutte le altre possibilità divengano impossibili; ma
è ancora più importante sottolineare il fatto che essa è la più propria e quindi la più autentica in
quanto tocca l’esser-ci nel suo stesso << Ci >>, mentre ogni altra possibilità si colloca all’interno
dell’essenza progettuale dell’esserci come suo di modo determinarsi. La morte in parole più
semplice è quella possibilità che coglie la mia singolarità, ossia il mio essere proprio, nel modo più
radicale poiché nessuno può fronteggiare la mia morte al mio posto. Come possibilità << più
autentica >> e << più propria >> lungi dal chiudere l’esserci, la morte può aprirlo alle sue
possibilità più autentiche se, invece di essere assunta come un fatto ineluttabile, viene anticipata
come ciò che possibilizza le possibilità, come ciò che le fa apparire veramente tali, per cui l’esserci,
invece di irrigidirsi in una delle sue possibilità, assume se stesso come un perenne poter-essere.
Solo la coscienza della nullità di ogni progetto, solo questo può far pervenire l’uomo alla sua
condizione più autentica e originaria, quella del suo essere per la morte, che lungi dal far irrigidire
l’uomo ai suoi progetti fonda la drammatica storicità e nullità della sua esistenza. È questo
potremmo dire il nocciolo teoretico forte della riflessione esistenzialistica di M. Heidegger,
nocciolo che per la complessità e profondità delle tematiche che esso implica non fa altro che
mettere in evidenza la maturità e l’ineludibilità che il problema della crisi dell’io ha assunto in
epoca contemporanea.
Bruno Caracciolo