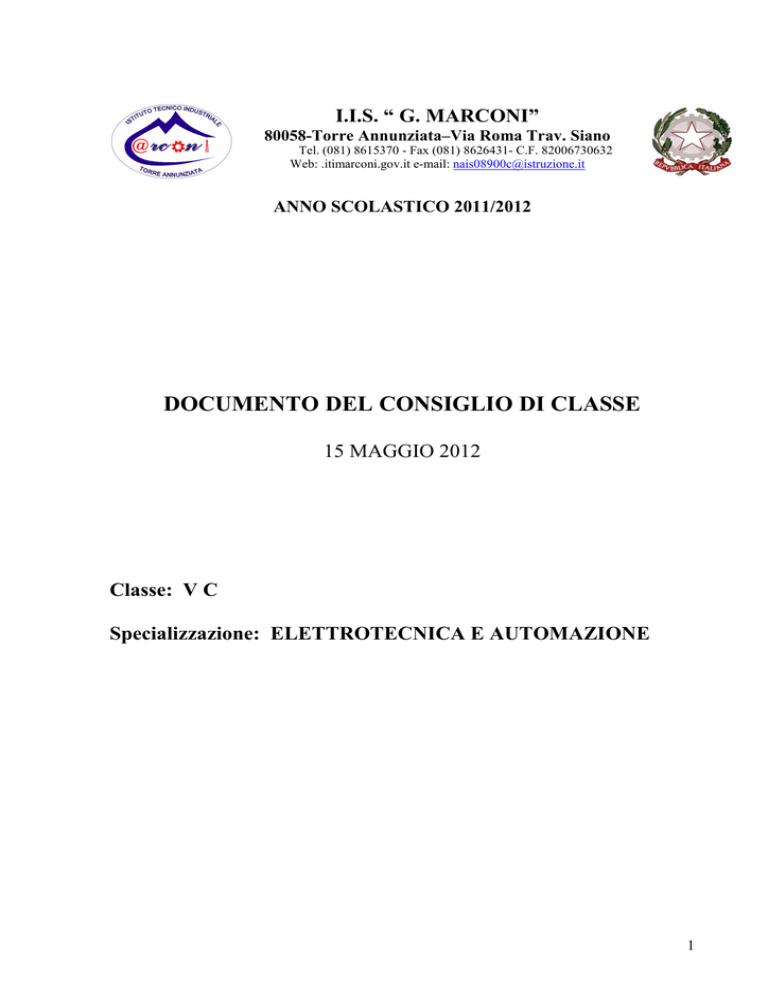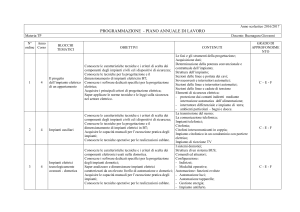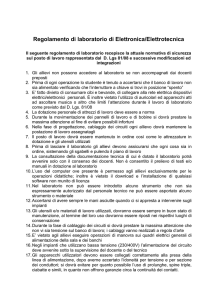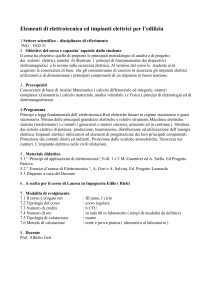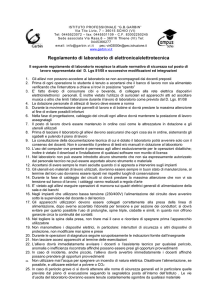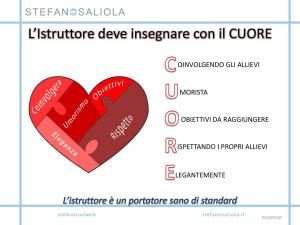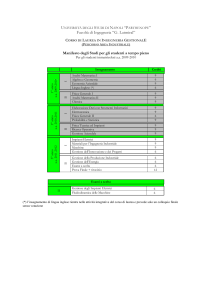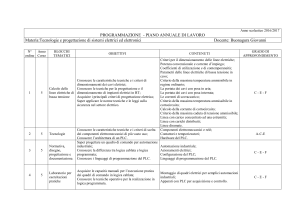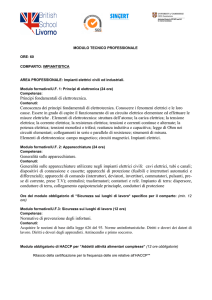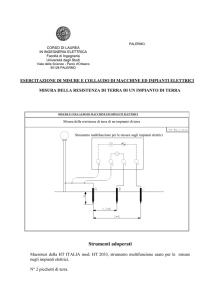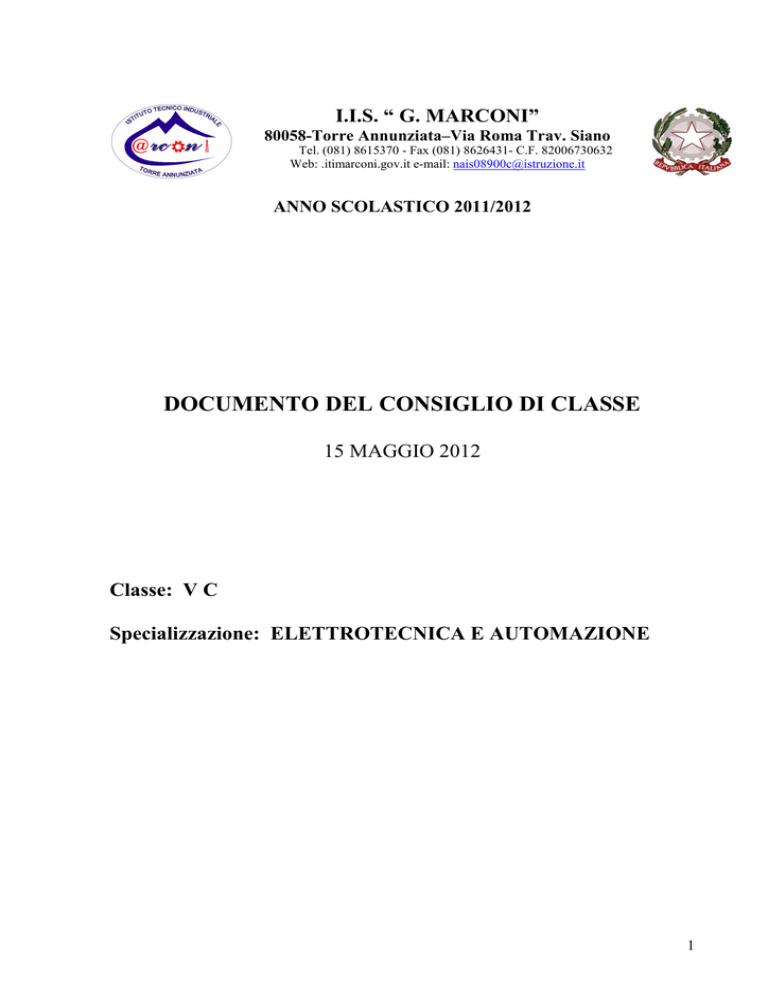
I.I.S. “ G. MARCONI”
80058-Torre Annunziata–Via Roma Trav. Siano
Tel. (081) 8615370 - Fax (081) 8626431- C.F. 82006730632
Web: .itimarconi.gov.it e-mail: [email protected]
ANNO SCOLASTICO 2011/2012
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
15 MAGGIO 2012
Classe: V C
Specializzazione: ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE
1
IL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINE
DOCENTI
1
Religione
Anna
Pesce
2
Italiano
Sceila
Miceli
3
Storia
Lucia
Paolillo
4
Inglese
Vittorio
Baggiano
5
Diritto
Paolo
Apuzzo
6
Matematica
Arturo
Narciso
7
Elettrotecnica
Ferdinando
Fusco
8
Impianti elettrici
Salvatore
Iaccarino
9
Tecnologie disegno e progettazione
Salvatore
Iaccarino
10
Sistemi automatici
Ferdinando
Fusco
11
Ed. Fisica
Gaetano
Sportiello
12
Laboratorio sistemi elettrici
Vincenzo N.
Aiello
13
Laboratorio elettrotecnica
Vincenzo N.
Aiello
14
Laboratorio T.D.P.
Vincenzo N.
Aiello
FIRMA
2
GLI ALLIEVI
COGNOME
NOME
MATRICOLA
DATA DI NASCITA
1
Acunzo
Antonio
12892
03/09/1993
2
Di Gennaro
Raffaele
12740
20/04/1992
3
Frezza
Raffaele
12827
02/03/1993
4
Mellone
Vincenzo Rosario
12854
07/02/1994
5
Mennella
Riccardo
1867
02/12/1991
6
Palomba
Rosario
12917
21/06/1993
7
Salvi
Pasquale
12855
12/08/1993
8
Simone
Giuseppe
12879
14/05/1993
9
Sito
Ciro
12880
09/09/1993
10
Veropalumbo
Salvatore
12882
24/07/1993
11
Vitiello
Dario
12895
26/12/1993
3
PROFILO DELL’INDIRIZZO
Obiettivo generale dell’indirizzo è quello di formare una figura professionale
capace di inserirsi in realtà produttive differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione,
sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro.
Le caratteristiche generali di tale figura sono:
•
versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;
•
ampio ventaglio di competenze nonché di capacità di orientamento di fronte a
nuovi problemi e di adattamento all’evoluzione professionale;
•
capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.
Il perito industriale per l'Elettrotecnica e Automazione, nell’ambito del proprio livello
operativo, va preparato a:
•
partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di
gruppo;
•
svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;
•
interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e
commerciali dell’azienda in cui opera;
•
aggiornare le proprie conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di
attività.
Il Perito Industriale per l’Elettrotecnica e Automazione deve, pertanto, essere in grado di:
•
analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;
•
analizzare le caratteristiche funzionali di sistemi, anche complessi, di generazione,
trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica;
•
partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche
complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi;
•
progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare
riferimento ai dispositivi per l’automazione;
•
progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi,
valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul
mercato;
•
descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi
progettati e scriverne il manuale d’uso;
4
•
comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in
lingua straniera;
•
conoscere e saper operare con i più comuni software utilizzati per la produzione di
fogli elettronici di lavoro (scrittura, fogli di calcolo ed elaborazione dati, disegno
tecnico).
Con riferimento alle più ampie finalità formative comuni a tutti gli Indirizzi, lo studente
dovrà altresì acquisire:
•
padronanza della lingua italiana, ovvero la capacità di produrre testi orali e scritti
corretti ed efficaci sul piano comunicativo, e di comprendere – analizzare testi di
varia natura non letterari e letterari;
•
competenza della lingua inglese che consenta di comprendere e produrre
correttamente semplici testi orali e scritti non solo di argomento tecnico ma anche
relativi a comuni situazioni comunicative conoscenza e consapevolezza critica
delle linee essenziali di evoluzione storica della civiltà contemporanea nei suoi
aspetti economici, sociali, politici, culturali, con particolare attenzione per le
espressioni letterarie.
PROFILO DELLA CLASSE
La 5C è una classe composta da 11 allievi, di cui dieci hanno frequentato insieme il
ciclo di studi gia dal terzo anno, mentre uno si è inserito nel gruppo classe all’inizio del
quinto anno, proveniente da un altro istituto tecnico situato nelle vicinanze.
La classe all’inizio del terzo anno si presentava abbastanza scolarizzata e con una
preparazione di base adeguata. Gli alunni, mostravano interesse per lo studio, attenzione in
classe, una certa regolarità nell’impegno. Inoltre, la classe non mancava di buone
individualità che si mettevano in mostra per motivazione ed interesse e che si rivelavano in
grado di fornire apporti personali, anche sul piano critico. Sul piano comportamentale gli
allievi hanno sempre mostrato correttezza sia nei rapporti interpersonali che in quelli con il
personale della scuola.
Questa caratterizzazione è rimasta immutata anche al quarto anno, anche se, il
modesto impegno nelle attività di studio pomeridiano, non ha consentito a tutti di
raggiungere livelli di preparazione adeguati alle rispettive capacità.
Nel corso di questo anno, la situazione non è stata molto diversa da quella degli
anni precedenti. Gli allievi si sono trovati comunque disorientati per il cambio di docenti e
5
quindi di metodologia didattica in discipline significative, quali: Elettrotecnica,
Matematica, Sistemi, Italiano e Storia.
Gradualmente, grazie ad una maggiore applicazione nello studio, ad una più seria e
reciproca disponibilità degli allievi e dei docenti e soprattutto grazie ad una proficua
interazione del gruppo dei più bravi, che ha continuato a fare da traino, si sono risolti
problemi di vario tipo, con una ricaduta decisamente positiva sulla didattica, sul processo
di apprendimento e sul profitto in generale.
Si può schematizzare il quadro generale con la delineazione di tre fasce:
•
la prima, formata dal gruppo di allievi che si sono distinti nell’arco del triennio per
capacità, serietà, assiduità allo studio di tutte le discipline conseguendo risultati più che
buoni.
•
la seconda, costituita da studenti capaci che, nonostante qualche problema di continuità
nello studio, hanno comunque conseguito risultati pienamente sufficienti, in virtù delle
buone capacità di recupero.
•
la terza, per fortuna esigua, formata da allievi per i quali l’apprendimento è risultato
difficoltoso a causa del modesto impegno.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
“OBIETTIVI TRASVERSALI”
Gli obiettivi trasversali perseguiti, sulla base dell’indirizzo e della specificità del
corso di studi sono:
•
Rendere più stretto il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, privilegiando i
risvolti operativi, anche collegati a diverse esperienze di lavoro.
•
Armonizzare le conoscenze specifiche acquisite nelle materie di indirizzo con la
formazione culturale di base, fondata sulle discipline umanistiche e linguistiche in
modo da contribuire a delineare un profilo professionale polivalente.
•
Comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio appropriato.
•
Partecipare al lavoro organizzato individuale e di gruppo.
“OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO”
Area linguistico – storico – letteraria
Conoscenza:
•
Conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi della letteratura italiana;
6
•
Conoscenza dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato la storia dell’
‘800 e del ‘900;
•
Conoscenza della struttura morfo – sintattica e lessicale della lingua straniera.
Competenze:
•
Competenze nell’uso della lingua italiana in relazione alla comprensione ed
alla produzione scritta e orale;
•
Competenze nell’effettuare inferenze in base alle diverse informazioni
contenute nei testi di lingua in relazione a quelle già conosciute .
Capacità:
•
Comunicative;
•
Di riflessione sulla lingua e sulla letteratura italiana;
•
Di analisi e contestualizzazione dei testi;
•
Di rielaborazione critica personale.
Area Tecnico Scientifica.
Conoscenze e competenze:
•
Partecipare con personale e responsabile contributo al lavoro organizzato e di
gruppo;
•
Svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;
•
Documentare e comunicare gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del
proprio lavoro;
•
Aggiornare le proprie conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di
attività.
Capacità:
•
Saper analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;
•
Saper analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di
generazione, conversione, trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica;
•
Saper progettare, realizzare e collaudare piccole parti di sistemi elettrici, con
particolare riferimento ai dispositivi per l’automazione;
•
Saper progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi,
valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul
mercato.
7
“LE METODOLOGIE APPLICATE”
Le metodologie applicate sono volte alla creazione di un clima di fiducia nelle
possibilità di riuscita e nella possibilità di contribuire al lavoro comune attraverso l’esperienza
ed il vissuto del singolo alunno.
Esse possono essere così elencate:
•
Valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali;
•
Motivazione alla partecipazione e allo studio;
•
Coinvolgimento dello studente attraverso la chiarezza degli obiettivi da
perseguire;
•
Utilizzazione delle lezioni frontali come momento preparatorio ad attività che
coinvolgono più direttamente lo studente;
•
Valorizzazione del lavoro di gruppo strutturato e guidato dal docente;
•
Utilizzazione del problem solving come strumento di apprendimento;
•
Valorizzazione della cooperazione come modalità di lavoro privilegiata.
Queste indicazioni hanno trovato concreta applicazione attraverso:
•
Lezioni frontali in cui gli alunni hanno raccolto appunti;
•
Lavori individuali e di gruppo basati sulla capacità di auto apprendimento e/o
di comunicazioni di conoscenze pregresse;
•
Metodo ripetitivo legato ad interrogazioni individuali e/o di gruppo;
•
Esercitazioni guidate sugli aspetti più propriamente professionali;
•
Commento ed analisi di testi attinenti alle diverse discipline.
“CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE”
I presupposti metodologici esposti in precedenza sono ovviamente stati incrociati con
i criteri di verifica e valutazione e con gli obiettivi assunti, alla fine di monitorare
costantemente l’andamento di lavoro didattico e l’apprendimento, con lo scopo di apportare i
necessari interventi di rettifica e di modulazione delle attività perseguendo criteri di
attendibilità, equità ed efficacia.
La verifica ha avuto come scopo:
•
Assumere informazioni sul rapporto insegnamento ed apprendimento;
•
Verificare l’adeguatezza dei metodi;
•
Verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici;
•
Pervenire alla classificazione degli alunni.
La verifica è avvenuta attraverso:
8
•
Interrogazioni individuali e di gruppo;
•
Soluzioni di problemi pratici attinenti alla professionalità da conseguire;
•
Lavori di ricerca e approfondimento delle varie materie;
•
Integrazione del lavoro comune attraverso esperienze professionali pregresse;
•
Somministrazione di test nelle singole discipline.
“TABELLA DI VALUTAZIONE”
LIVELLO VOTO
VALUTAZIONE
L’ALLIEVO E’ IN GRADO DI
INSUFFICIENTE -
Conoscere ma frammentariamente e/o
superficialmente i contenuti della
disciplina
Conoscere in maniera accettabile i
contenuti della disciplina
Conoscere e comprendere quanto
1
4-5
2
6
SUFFICIENTE
3
7
DISCRETO
4
8
BUONO
5
9 -10
OTTIMO
MEDIOCRE
appreso
Conoscere comprendere applicare e
analizzare quanto appreso
Conoscere comprendere applicare
analizzare e valutare quanto appreso
Per la valutazione delle prove d’italiano e della lingua straniera si è tenuto conto della:
•
Correttezza formale;
•
Rielaborazione personale;
•
Validità dei contenuti;
•
Rispondenza alla traccia.
Per quanto riguarda la valutazione della prova dell’area tecnico – scientifica si è tenuto
conto della:
•
Correttezza – completezza delle informazioni;
•
Esattezza del procedimento;
•
Correttezza dei contenuti;
•
Aderenza alla traccia.
Inoltre il consiglio ha posto un particolare accento sulla valutazione e valorizzazione dei
progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza.
9
“CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO”
Per l’attribuzione del credito scolastico si rimanda alla normativa e alle possibili bande
di oscillazione che essa prevede, partendo dalla media dei voti conseguiti ed integrandoli con
elementi quali la frequenza, la partecipazione attiva, l’interesse e l’impegno.
Per gli alunni dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di classe procederà
all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla seguente
Tabella A allegata al DM 42 del 22-05-2007 e dai criteri stabiliti nel P.O.F.
MEDIA VOTI
CREDITO SCOLATICO PUNTI
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10
V ANNO
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, è espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media
M dei voti:
- l'assiduità della frequenza scolastica.
- l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari
ed integrative.
- eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei
voti.
Agli alunni che, in sede di scrutinio finale, presentano una media maggiore o uguale alla metà
dell’intervallo di appartenenza (ad esempio 6,5- 6,6 ; 8,6….) e contestualmente un numero di
assenze minore o uguale a 25, un numero di assenze di massa non superiore a 7, viene
attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza.
All’alunno che presenta una media inferiore alla metà della fascia di appartenenza (ad
esempio 6,4….) viene attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza se:
a) il numero delle assenze è minore o uguale a 25
b) il numero delle assenze di massa non è superiore a 5
c) ha partecipato ad un progetto extracurricolare interno all’istituto o esterno purché coerente
con l’indirizzo di studi ( credito formativo)
10
d) ha conseguito una certificazione riconosciuta (certificazioni per la lingua straniera
certificazioni informatiche)
N.B. il punteggio massimo viene attribuito in presenza degli indicatori di cui alle lettere a-b-c
( D può essere in sostituzione di C )
Calcolo del Credito Formativo:
Sono valutate esperienze formative che l’alunno ha maturato al di fuori della normale attività
scolastica. Tali esperienze devono essere coerenti con il corso di studio, debitamente
documentate e valutate dal consiglio di Classe.
Ad ogni esperienza, ritenuta valida dal consiglio di Classe è attribuito un punteggio di 0,25
che si somma alla media dei voti riportata dallo studente, per il calcolo del credito scolastico.
“ATTIVITÀ DIDATTICHE”
•
Attività curricolari
(vedi contenuti per le singole discipline)
•
Attività integrative del triennio
Attività
Argomento / destinazione
Anno
N°
partecipanti
Concorso
Vivere il mare
III
10/11
trattazione di una soluzione tecnica per
l’ottenimento di energia pulita
Concorso
Sicurezza sul lavoro
III
10/11
Concorso
Progetto energia:
III
10/11
III
10/11
approfondimento di particolari problematiche
energetiche
Concorso
Playenergy:
trattazione di problematiche energetiche
Open day
Accoglienza e preparazione relativa
III
10/11
Corso
Controllori a Logica Programmabile
IV
8/11
Visita di istruzione
Visita agli stabilimenti della Schneider
IV
10/11
IV
10/11
IV
10/11
Electric di Casavatore (NA)
Visita di istruzione
Visita all’impianto idroelettrico di Presenzano
(CE) e dell’oasi “Le Mortine”
Corso
I.G.S.
Impresa alternativa
11
Open day
Accoglienza e preparazione relativa
IV
10/11
PON- C2
Marconi Tour
V
8/11
Corso
Impianti fotovoltaici
V
5/11
Open day
Accoglienza e preparazione relativa
V
11/11
Meeting
Incontro delle scuole sul territorio presso
V
11/11
l’Istituto Mazzarello
Competizione
Competizione I.G.S. tra classi quinte
V
11/11
Corso
Corso sulla preparazione sulla stesura di un
V
8/11
curriculum vitae e colloquio per il mondo del
lavoro
Corso
Ecdl
V
2/11
Corso
Ecdl-CAD
V
2/11
Corso
“Patti chiari” patrocinato dal Banco di Napoli
V
11/11
Visita di istruzione
Young meeting a Casalvelino (SA)
V
9/11
•
Attività di recupero
Le attività di recupero sono state svolte da ciascun docente in ambito curricolare
•
Testi verifiche effettuate
Gli elaborati degli allievi sono a disposizione per essere visionati
“TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA”
In linea con lo spirito dell’Esame di stato, sulla scorta dell’esperienza maturate ed
in base alle indicazioni del Ministero, il Consiglio di classe ha erogato alla classe tre
simulazioni di terza prova.
Per meglio abituare gli studenti all’effettuazione della prova d’esame, per la
valutazione della stessa si è fatto riferimento alla valutazioni previste dall’Esame di stato.
I testi delle prove e le relative griglie di valutazione sono riportati in allegato al
presente documento.
12
“CONTENUTI E OBIETTIVI PER LE DIVERSE DISCIPLINE”
RELIGIONE
Durante l'anno scolastico abbiamo parlato delle principali religioni soffermandoci in
particolare sui tre monoteismi evidenziando il cattolicesimo data l'influenza che ha avuto nella
cultura e nel patrimonio storico italiano. Abbiamo sviluppato in modo dignitoso le varie
religioni del mondo per la costruzione di una società pluralista ed empatica, capace di sentire
e accettare l'altro. Non abbiamo trascurato tematiche a confronto più vicine alla sensibilità dei
giovani che hanno arricchito gli alunni da un punto di vista etico e morale, favorendo un
ampliamento della conoscenza e un approfondimento critico.
Ci siamo avvalsi di fotocopie di alcuni testi che trattavano argomenti scelti dagli alunni e
abbiamo sviluppato gli stessi attraverso dibattiti e lezioni frontali, approfondendo tali
argomenti talvolta con visioni di film.
CONTENUTI
•
Alle origini delle religioni
•
Le principali religioni nel mondo
•
Il Cristianesimo
•
Il Cattolicesimo
•
L'Islamismo
•
L'Ebraismo
•
L'Induismo
•
Il Buddismo
•
Le religioni cinesi
•
Il dialogo tra le religioni
•
Nuovi movimenti religiosi e gruppi di origine cristiana
TEMATICHE A CONFRONTO
•
Ambiente e rispetto del creato
•
Divorzio
•
Donna
•
Eutanasia
•
Guerra e pace
•
Male e sofferenza
•
Omosessualità
13
•
Sessualità
•
Pena di morte
•
Stranieri e migranti
•
Suicidio
•
Trapianti
14
ITALIANO
Nonostante la classe sia stata assegnata all’insegnante solo in quest’ultimo anno in corso, sin
dall’inizio si è instaurato con gli studenti un dialogo educativo aperto e proficuo. Le lezioni,
per lo più frontali, hanno sempre fornito occasione di discussione e di confronto.
Lo studio degli autori e delle correnti letterarie è sempre stato proposto attraverso la lettura e
l’analisi dei testi e l’interazione con il contesto storico e culturale.
Durante l’anno scolastico sono state proposte prove scritte comprendenti le diverse tipologie
di produzione testuale: analisi di testi letterari, saggi brevi, articoli di giornale, temi storici o
argomentativi.
Tutte le verifiche sono state valutate e discusse in classe, con l’intento di fornire indicazioni
mirate al superamento dei singoli problemi.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Hanno acquisito una competenza organizzativa nella comunicazione orale o scritta che
permette una gestione della stessa con personalità e coerenza;
una competenza comunicativa che permette di servirsi della lingua italiana in modo
sufficientemente adeguato al contesto di riferimento;
sanno fare collegamenti interdisciplinari;
sanno usare il testo e integrare le conoscenze dello stesso con altre fonti.
Conoscono sufficientemente gli argomenti di Letteratura italiana analizzati durante l’anno.
METODOLOGIE, STRUMENTI DIDATTICI E MATERIALI
E’ stata privilegiata la lettura, l’analisi del testo e la contestualizzazione dei contenuti
inserendo la trattazione degli argomenti in una dimensione multidisciplinare.
Le lezioni frontali e partecipative, le esercitazioni e le discussioni sono state di rinforzo
all’acquisizione delle tecniche di decodifica di analisi dei testi letterari.
VERIFICHE
Le prove di verifica sono state scritte e orali. Le tipologie di prove scritte sono state codificate
secondo modelli il più possibile simili a quelle delle prove scritte dell’Esame di Stato: analisi
testuale e prove di scrittura documentata (saggio breve su tematiche culturali, scientifiche,
storiche e letterarie).
Le verifiche orali sono state strutturate sotto forma di colloqui per verificare la padronanza
linguistica ed espressiva degli alunni.
15
Per la valutazione sommativa, ulteriore criterio di giudizio è stata l’osservazione
dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse e dell’assiduità mostrati dagli alunni nel
corso dell’anno scolastico.
CONTENUTI
•
Il positivismo, nuovo indirizzo di pensiero;
•
La reazione al tardo romanticismo;
•
Il romanzo naturalista e verista;
•
Giovanni Verga;
•
La poesia tra ottocento e novecento;
•
la lirica italiana tra ottocento e novecento;
•
Giovanni Pascoli;
•
Gabriele D’Annunzio;
•
La poesia tra le due guerre;
•
Giuseppe ungaretti;
•
Salvatore Quasimodo;
•
Eugenio Montale;
•
Luigi Pirandello;
•
La narrativa del ventennio fascista;
•
La letteratura del secondo dopoguerra;
16
STORIA
Nonostante la docente sia stata assegnata al’insegnamento della Storia solo nell’ultimo anno
in corso, sin dall’inizio si è instaurato con gli studenti un dialogo educativo aperto e proficuo.
Lo svolgimento del programma è stato regolare e conforme, nella sostanza, alle ipotesi di
lavoro formulate all’inizio dell’anno scolastico. Al fine di favorire la maturazione della
coscienza storica da parte degli studenti, gli avvenimenti più rilevanti sono stati trattati e
approfonditi con letture di documenti.
La classe nella sua globalità ha mostrato attenzione e interesse per gli argomenti trattati, con
riferimenti alle problematiche attuali attraverso i percorsi di cittadinanza e costituzione.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
Acquisizione dei contenuti basilari per ogni unità didattica: complessivamente raggiunto.
Capacità di relazionare in modo appropriato sugli argomenti, di saper operare collegamenti fra
momenti della storia del ‘900 e fra le discipline diverse: parzialmente raggiunto. Acquisizione
di un linguaggio appropriato e dei termini specifici: parzialmente raggiunto. Capacità di
operare collegamenti riferiti a tempo e spazio e di analizzare la realtà contemporanea
rapportandola al processo storico: parzialmente raggiunto.
CONTENUTI
•
L’unificazione italiana
•
L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica
•
La seconda rivoluzione industriale
•
La società di massa
•
L’età giolittiana
•
La prima guerra mondiale
•
La rivoluzione russa
•
Il primo dopoguerra
•
L’Italia tra le due guerre: il fascismo
•
Il mondo verso la guerra
•
La seconda guerra mondiale
Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione
•
Le origini della guerra fredda
•
La distensione
•
Gli anni di piombo.
17
INGLESE
Gli allievi sono apparsi nel complesso particolarmente attenti ed interessati alle attività
proposte, profondendo un impegno accettabile, costante e positivo. La maggior parte di
essi ha una preparazione da sufficiente a discreta mentre in un paio di casi si evidenziano
difficoltà dovute a lacune pregresse a cui, in qualche caso, si aggiungono superficialità e
mancanza di volontà e di applicazione.
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
La maggior parte degli allievi possiede un accettabile bagaglio lessicale che permette loro
di esprimere bisogni comunicativi diversificati in base ad un determinato contesto e di
comunicare in ambiti a loro familiari, di interesse personale o più generale o su argomenti
a loro noti e relativi al settore di specializzazione. In qualche caso, il bagaglio lessicale è
esiguo.
La maggior parte degli allievi conosce un buon numero di funzioni comunicative ed
espressioni che li mettono in grado di comunicare informazioni di tipo personale, familiare
e quotidiano, e di esprimersi su argomenti più generali o riguardanti l’indirizzo di studio.
Per alcuni allievi tale repertorio è limitato.
La maggior parte degli allievi conosce le strutture grammaticali apprese precedentemente e
quelle proposte nel corso del quinto anno. Alcuni evidenziano incertezze o lacune.
Nel complesso gli allievi conoscono il contenuto delle varie letture e dei brani tecnici
trattati in classe
ABILITA’ DI COMPRENSIONE
Comprensione orale (Listening):
La maggior parte degli allievi è in grado di comprendere una varietà di messaggi orali
finalizzati a scopi diversi, di carattere familiare, generale e specifico del settore
professionale di specializzazione, cogliendone argomento, situazione, informazioni
principali, specifiche e di supporto. Alcuni allievi evidenziano incertezze.
Comprensione scritta (Reading):
Gli allievi nel complesso sono in grado di comprendere testi scritti di vario tipo, anche
relativi ad argomenti e problemi attinenti al settore di specializzazione, identificandone
senso globale ed informazioni principali e specifiche; non tutti sono in grado di operare
inferenze.
18
ABILITA’ DI PRODUZIONE
Interazione e produzione orale (Speaking):
Un gruppo di allievi è in grado di comunicare su argomenti di carattere familiare, generale
e di carattere tecnico noti in modo adeguato dal punto di vista comunicativo e linguistico;
un altro gruppo comunica sugli stessi argomenti in modo semplice e comprensibile, pur se
con errori; alcuni allievi rivelano incertezze o difficoltà.
.
Produzione scritta (Writing)
La maggior parte degli allievi è in grado di produrre testi scritti di carattere generale e
specifico del settore professionale coesi e coerenti, usando un codice nel complesso
appropriato. Alcuni evidenziano difficoltà morfosintattiche.
CONTENUTI
•
The Generation of Current
•
DC and AC Circuits
•
The Principles of Magnetism and Electromagnetism
•
Rectifiers
•
Converters
•
Switches
•
Relays
•
Commutators
•
Conductors, Insulators, Semiconductors and Superconductors
•
Electric Motors and DC Generators
•
Motor Starters
•
CAD and CAM Systems
STRUTTURE GRAMMATICALI
•
Present Simple for Habits
•
Present Progressive
•
Present Progressive as a Future Form
•
To Be Going To
•
Will/Shall
•
Simple Past
•
Past Progressive
•
Present Perfect
19
•
Duration Form – For/Since – Present Perfect Simple and Progressive
READINGS
•
Comic Stories:
•
No saucers here
•
The Fog that Couldn’t Lift
Nel mese di maggio saranno svolte altre letture inerenti al programma tecnico relative
all’energia solare.
METODI
Per raggiungere gli obiettivi prefissati è stato adottata la lezione con attività in cui le abilità
linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà
dell’allievo. Attraverso tali attività l’allievo è stato guidato a formulare messaggi che
assolvessero a precisi obiettivi di comunicazione ed a percepire quindi la lingua straniera
come strumento, non come fine immediato di apprendimento. L’attività orale è stata
favorita tramite una serie di attività comunicative in coppia o in gruppo, in cui sono state
privilegiate l’efficacia della comunicazione e la fluenza del discorso.
Per lo sviluppo delle abilità di scrittura si sono affiancate attività manipolative guidate ad
attività di tipo più libero. La formulazione della regola è avvenuta solo dopo che essa era
stata generalizzata sulla base del materiale linguistico esercitato.
STRUMENTI
Fondamentale è stato l’uso del libro di testo da cui sono state tratti tutti gli argomenti
relativi al programma svolto.
VERIFICA E VALUTAZIONESTRUMNITRUMENTI
Le verifiche formative sono state effettuate in itinere con sistematicità e tutte le attività
svolte in classe sono state utili a raccogliere dati atti ad accertare il livello di
apprendimento degli allievi e l’efficacia dell’azione didattica. Le verifiche sommative,
funzionali alla classificazione degli allievi, hanno avuto la cadenza regolare di due
verifiche orali. Esse sono state effettuate secondo forme di accertamento già sperimentate
in fase di esercitazione e sono state di vario tipo, in base ad obiettivi e abilità che si
intendeva verificare. Sono state inoltre effettuate due simulazioni in preparazione della
terza prova d’esame.
20
Per le verifiche orali sono state utilizzate domande flash, interventi durante la normale
attività didattica, interrogazione breve e interrogazione lunga.
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto della fluenza del discorso, della
pronuncia, della chiarezza e precisione dell’informazione, più che dell’accuratezza
formale. La valutazione di fine periodo, oltre che dei risultati effettivamente conseguiti
nelle verifiche sommative svolte in itinere, ha tenuto conto dell’impegno, della
partecipazione, dell’interesse e del progresso di ogni singolo allievo rispetto alla situazione
di partenza, senza mai prescindere, tuttavia, dal raggiungimento degli obiettivi minimi
prefissati.
21
DIRITTO ED ECONOMIA
La classe si è mostrata fin dall’inizio disciplinata e disponibile all’impegno e al dialogo
educativo. Alcuni alunni hanno partecipato con vivo interesse alle lezioni mostrando
maggiore autonomia nel lavoro e maggiore capacità nell’interpretare un testo ed
estrapolare le maggiori informazioni .Altri si sono mostrati meno autonomi perché non
dotati di un metodo di studio organico e sistematico. Per questi ultimi si è reso necessario
soffermarsi e riprendere gli argomenti più volte, usando strategie diverse di volta in volta
adattate a seconda dei risultati ottenuti al fine di raggiungere gli obiettivi minimi.
Complessivamente è stata realizzata una didattica attiva. Si è cercato di analizzare,
applicare e rielaborare le conoscenze acquisite effettuando gli opportuni collegamenti ed
impiegando correttamente la terminologia giuridica, Sono state ,a tal fine, effettuate lezioni
frontali e dialogiche e confronto di opinioni. In conclusione la classe ha raggiunto un
livello di conoscenza soddisfacente ed un ottima predisposizione al rapporto umano.
CONTENUTI
•
Introduzione materia Diritto
•
Ordinamento giuridico
•
Ordinamento costituzionale
•
L’impresa
•
Le società
•
Le procedure concorsuali
•
Introduzione materia economia
•
Beni e servizi economici
•
Il mercato e le sue classificazioni
•
I cicli di produzione
•
L’inflazione
OBIETTIVI CONSEGUITI
CONOSCENZE
conoscere le varie tipologie di imprenditori e di impresa;
conoscere le varie tipologie di società presenti nel nostro ordinamento e la particolare
disciplina alla quale sono sottoposte;
conoscere pregi e difetti dei vari sistemi economici;
conoscere i concetti di prodotto e reddito nazionale;
22
conoscere le caratteristiche delle varie forme di mercato e le loro differenze;
COMPETENZE
Essere in grado di riconoscere i vari istituti studiati classificandone caratteri ed elementi;
CAPACITA’
Saper analizzare, applicare e rielaborare le conoscenze acquisite effettuando gli opportuni
collegamenti ed impiegando correttamente la terminologia giuridica.
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni
MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI
Libro di testo e appunti forniti dal docente.
TIPOLOGIA VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Colloqui orali, prove scritte(test).
La valutazione ha considerato la conoscenza dei contenuti, l’organizzazione logica e la
capacità di sintesi, la qualità espositiva e il corretto uso del linguaggio giuridico
23
ELETTROTECNICA
All’inizio dell’anno scolastico è stato svolto un necessario lavoro di recupero, svolto in
itinere, per riprendere i concetti del precedente anno scolastico (reti elettriche in regime
alternato trifase).
Circuiti elettrici trifase in regime alternato sinusoidale
U.D.
OBIETTIVI
CONTENUTI
Sistemi trifase
Conoscere la costituzione e i
metodi di risoluzione dei circuiti
elettrici trifase.
Sistemi elettrici trifase
simmetrici ed equilibrati.
Carichi trifase con collegamento
a stella e triangolo.
Rifasamento.
Trasformatori monofasi
U.D.
OBIETTIVI
CONTENUTI
Trasformatori
monofase
Conoscere i trasformatori monofasi Principio di funzionamento del
e la loro utilizzazione nei circuiti
trasformatori
elettrici.
Trasformatore monofase reale
Determinazione dei parametri
del circuito equivalente
Perdite e rendimento
Parallelo dei trasformatori
monofasi
Trasformatori trifasi
U.D.
OBIETTIVI
CONTENUTI
Trasformatori
trifase
Conoscere le caratteristiche dei
trasformatori trifasi e saper
scegliere quello adatto in relazione
al tipo di impiego.
Principio di funzionamento del
trasformatore trifase
Funzionamento a vuoto ed in
corto circuito
Perdite e rendimento
Parallelo dei trasformatori trifasi
La macchina asincrona
U.D.
OBIETTIVI
CONTENUTI
Motore asincrono
Conoscere il principio di
funzionamento della macchina e le
grandezze che la caratterizzano.
Aspetti costruttivi
Campo magnetico rotante
Circuito equivalente del motore
asincrono
Coppia motrice e caratteristica
meccanica
Curve caratteristiche del motore
Avviamento e regolazione di
velocità
24
Cenni sulle macchina a corrente continua
(da svolgere presumibilmente entro la fine dell’anno)
U.D.
OBIETTIVI
CONTENUTI
Motore a corrente
continua
Conoscere il principio di
funzionamento della macchina e le
grandezze che la caratterizzano.
Aspetti costruttivi
Principio di funzionamento
Caratteristica esterna
Generatore a
corrente continua
Principio di funzionamento
Caratteristica meccanica
Regolazione di velocità
Esercitazioni pratiche
Verifica di un’induttanza campione.
Misura di potenza attiva e reattiva in c.a. monofase.
Misura di potenza trifase con inserzione ARON
Prova pratica sul principio di funzionamento del trasformatore con utilizzo di trasformatore
didattico.
Prova a vuoto di un trasformatore monofase.
Prova in corto circuito di un trasformatore monofase.
Prova a vuoto su M.A.T.
METODOLOGIE APPLICATE
Lezione frontale.
Gruppi di lavoro.
Attività di recupero in itinere.
Studio a casa su: libro di testo, appunti presi durante la lezione e fotocopie fornite dal
docente.
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di Testo.
Appunti dettati in aula e fotocopie.
Apparecchiature di laboratorio.
Software per simulazioni.
25
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Prove scritte.
Interrogazione.
Prove di laboratorio.
LA VALUTAZIONE
La valutazione finale ha tenuto conto di:
progressione nell’apprendimento.
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
capacità di organizzare il lavoro, di esprimere e comunicare i risultati.
partecipazione, impegno e interesse mostrato nello studio della disciplina.
26
SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI
Si è riscontrata eterogeneità degli studenti per quanto riguarda la preparazione , la
predisposizione, la capacità di apprendimento poiché molti presentano lacune di base di
tipo concettuale.
Difficoltà si sono riscontrate nella trattazione teorica di alcuni argomenti erano richieste
basi matematiche più robuste di quelle possedute dalla maggior parte degli allievi, e ogni
singolo argomento è stato scisso nelle sue nozioni di base. Nel complesso gli allievi hanno
permesso di lavorare in un contesto normale, permettendo un discreto rapporto educativo
sia dal punto di vista umano che didattico.
La trasformata di Laplace
Obiettivi
Contenuti
• Conoscere la trasformata
• Risoluz. di circuiti
di Laplace e la sua
elettrici con la L [f(t)]
applicazione al calcolo delle
evoluzioni di un sistema
differenziale lineare ed
invariante
Attività didattica
• lezioni frontali;
• esercizi
Sistemi deterministici
Obiettivi
Contenuti
Attività didattica
• Saper analizzare la
risposta temporale dei
sistemi lineari e invarianti
sottoposti a diversi segnali
di prova
• Sistemi del 2° ordine
• Parametri di un
sistema temporale
• lezioni frontali;
• esercizi
Obiettivi
Contenuti
Attività didattica
Utilizzare l’amplificatore
operazionale nelle diverse
configurazione
invertente
non invertente
sommatore
• lezioni frontali;
• Simulazione in
laboratorio
• Simulazione in
laboratorio
Amplificatori operazionali
configurazioni.
differenziale.
27
I sistemi di controllo a tempo continuo
Obiettivi
Contenuti
Attività didattica
• Acquisire i concetti
fondamentali della teoria
della regolazione con
riferimento allo studio della
risposta temporale dei
sistemi retroazionati e al
loro comportamento a
regime
• La risposta dei sistemi
retroazionati.
• Il comportamento a
regime dei sistemi
retroazionati.
• Rappresentazioni
grafiche.
• lezioni frontali;
• esercizi
La stabilità dei sistemi a tempo continuo
Obiettivi
Contenuti
Attività didattica
• Conoscere e saper
applicare i metodi basati
sull'analisi della F(s) per lo
studio della stabilità di un
sistema lineare nel dominio
della frequenza
La stabilità dei sistemi
dalla conoscenza della
F (s)
• lezioni frontali;
• esercizi
Obiettivi
Contenuti
Attività didattica
• acquisire specifiche
conoscenze sui moderni
dispositivi in grado di
rilevare le grandezze fisiche
da controllare.
• Sensori e
Trasduttori
• Parametri dei
trasduttori.
• Classificazione dei
trasduttori.
• lezioni frontali;
• Prove di
laboratorio
Obiettivi
Contenuti
Attività didattica
• Conoscere gli elementi un
costituenti il sistema di
controllo dei motori in c.c.
• sistema di controllo di
un motore in c.c. in
catena aperta.
• Lezioni frontali
• Prove di
laboratorio
Sensori e trasduttori
Controllo motore in c.c.
28
Esercitazioni pratiche
. Prova su motore D.C.: caratteristica esterna V-n.
. Prova su trasduttore “dinamo tachimetrica”
. Prova su trasduttore “cella di carico”
. Prova su trasduttore di temperatura “PT100”
. Prove simulate su amplificatori operazionali:
configurazione invertente
non invertente
sommatore
differenziale.
. Prova su controllo in retroazione della velocità di un motore D.C.
. Prova su controllo della velocità di un motore D.C. , tecnica PWM con
integrato NE555
(da effettuarsi nele mese di maggio)
METODOLOGIE APPLICATE
Lezione frontale.
Gruppi di lavoro.
Attività di recupero in itinere.
Studio a casa su: libro di testo, appunti presi durante la lezione e fotocopie fornite dal
docente.
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
Libro di Testo.
Appunti dettati in aula e fotocopie.
Apparecchiature di laboratorio.
Software per simulazioni.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Prove scritte.
Interrogazione.
LA VALUTAZIONE
La valutazione finale ha tenuto conto di:
progressione nell’apprendimento.
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
capacità di organizzare il lavoro, di esprimere e comunicare i risultati.
partecipazione, impegno e interesse mostrato nello studio della disciplina.
29
IMPIANTI ELETTRICI
METODO D’INSEGNAMENTO
La metodologia dell’insegnamento in classe si è basata principalmente sulla lezione dialogata
che consente di avere un confronto immediato con le concezioni spontanee degli allievi.
Il gruppo classe è stato più volte sollecitato a discutere e a intervenire, minimizzando i modi
convenzionali di “fare scuola” , come la lezione per ascolto, il completamento di schede e le
interrogazioni alla cattedra. Si è cercato di attivare il cosiddetto “apprendimento per
scoperta”, collocando di fatto l’allievo al centro del processo educativo. Si è privilegiato l’uso
di una terminologia facilmente comprensibile, sempre però nel rispetto del linguaggio
specifico della materia.
Gli argomenti relativi al programma sono stati trattati limitando quanto più possibile l’aspetto
teorico, esaltandone invece l’aspetto pratico e le applicazioni dirette.
Ove possibile, la trattazione teorica è stata integrata da esercitazioni pratiche effettuate con
l’ausilio dei software di progettazione disponibili nell’istituto e/o forniti dalle case costruttrici
di materiale elettrico.
Il programma è stato svolto in stretto raccordo con i docenti delle materie affini ( “
ELETTROTECNICA”, “SISTEMI ED AUTOMAZIONE”). Ciò allo scopo di consentire agli
allievi di acquisire una conoscenza organica dell’elettrotecnica e delle applicazioni ad essa
direttamente collegate.
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il grado di apprendimento degli allievi è stato accertato periodicamente sia mediante prove
orali che mediante l’effettuazione di test scritti. I relativi criteri di valutazione sono stati quelli
relativi alla programmazione della classe. Sono state tenute in considerazione e fatte emergere
tutte le attitudini ( teoriche, pratiche, linguistiche, terminologiche ) tali da consentire una
valutazione globale delle conoscenze acquisite.
CONTENUTI ED OBIETTIVI RAGGIUNTI
Pericolosità della corrente elettrica
Obiettivi:
conoscenza dei rischi legati all’interazione con elementi in tensione
Contenuti:
Percezione della corrente elettrica
Effetti fisiopatologici
30
Limiti di pericolosità della corrente
Resistenza elettrica del corpo umano
Limiti di pericolosità della tensione
Collegamento a terra degli impianti elettrici e protezione nei confronti dei contatti
diretti ed indiretti
Obiettivi:
essere in grado di realizzare sistemi di protezione nei confronti di contatti diretti ed indiretti
Contenuti:
Generalità e definizioni
La dispersione a terra della corrente
Tensione di contatto e di passo
L’impianto di terra
Esecuzione dell’impianto di terra
Elementi dell’impianto di terra
Prescrizioni in merito all’impianto di terra
Struttura e caratteristiche elettriche dei dispersori
Collegamento di dispersori
Interruttore differenziale
Generalità e funzionamento
Classificazione dei differenziali
Considerazioni sull’utilizzo
Coordinamento dell’interruttore differenziale con l’impianto di terra
Caratteristiche di protezione nei sistemi TT,TN, IT
Protezione dai contatti diretti
Protezione totale
Isolamento delle parti attive
Protezione con involucri e barriere
Protezione parziale
Protezione dalle sovracorrenti
Obiettivi:
essere in grado di realizzare efficaci sistemi di protezione nei confronti delle sovracorrenti di
impianto
Contenuti:
31
Caratteristiche delle sovracorrenti in un impianto
Arco elettrico e sue modalita di estinzione
Determinazione della corrente di cortocircuito
Classificazione dei relè
Relè termico di massima corrente
Rele elettromagnetico di massima corrente
Protezione magnetotermica
Tipi di interruttore
Caratteristiche funzionali degli interruttori
Interruttori automatici di bassa tensione
Fusibili e loro caratteristica di intervento
Protezione delle condutture elettriche contro sovraccarico e cortocircuito
Protezione in serie ( backup )
Selettività nelle protezioni
Sezionamento e comando degli impianti utilizzatori
Obiettivi:
essere in grado di realizzare efficaci sistemi di comando degli impianti elettrici
Contenuti:
Caratteristiche dei dispositivi di sezionamento e comando
Criteri di scelta dei sezionatori
Criteri di scelta dei contattori
Sezionamento
Interruzione per manutenzione non elettrica
Comando ed arresto di emergenza
Comando funzionale
Rifasamento degli impianti industriali
Obiettivi:
essere in grado di dimensionare correttamente un impianto di rifasamento
Contenuti:
Generalità, motivi e vantaggi del rifasamento
Tipo di rifasamento
Metodi di dimensionamento dell’impianto di rifasamento
Tipologia di condensatori di rifasamento
32
Dispositivi di protezione e manovra
Requisiti di sicurezza
Cabine di trasformazione MT/BT
Obiettivi:
essere in grado di dimensionare un sistema di trasformazione MT/bt
Contenuti:
Generalità
Schema elettrico di cabina per la distribuzione pubblica dell’energia elettrica. Scelta delle
apparecchiature
Schema elettrico di cabina privata di proprietà dell’utente. Scelta delle apparecchiature
Scelta, dimensionamento e collegamento dei trasformatori
Struttura costruttiva di una cabina MT/bt
Gruppo misure
Sistemi di distribuzione a media e bassa tensione
Obiettivi:
conoscere le caratteristiche dei sistemi di distribuzione MT e bt
Contenuti:
Sistemi di distribuzione in media tensione
Distribuzione pubblica
Sistemi di distribuzione in bassa tensione
Realizzazioni costruttive per la distribuzione in bassa tensione
Quadri elettrici per bassa tensione
Quadri elettrici per media tensione
Cenni alla produzione dell’energia elettrica
Obiettivi:
conoscere le caratteristiche dei sistemi di produzione dell’energia
Contenuti:
fonti primarie di energia
produzione e consumi
centrali idroelettriche
centrali termoelettriche
centrali nucleotermoelettriche
33
centrali fotovoltaiche
centrali eoliche
Esempi di impianti elettrici in bassa tensione
Obiettivi:
saper dimensionare un impianto elettrico per attività del terziario
Contenuti:
Impianto elettrico in attività turistico-ricettive
Impianto elettrico in strutture scolastiche
Impianto elettrico in strutture industriali
34
TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE
Gli argomenti che sono stati sviluppati si discostano sensibilmente da quelli suggeriti nei
programmi ministeriali. Questa scelta è stata dettata dall’esigenza di formare gli allievi in
maniera da prepararli alle problematiche che si troveranno ad affrontare nel momento in cui si
inseriranno nel mondo del lavoro. Infatti, a parere degli scriventi, gli attuali programmi
ministeriali, ( peraltro oggetto di prossima revisione nel contesto della riforma in atto ), non
permettono una preparazione attualizzata nel settore caratterizzante l’indirizzo di studi. E ciò
è dovuto alla rapida evoluzione che si è manifestata negli ultimi anni nel settore degli
impianti elettrici e nell’automazione. Evoluzione che, ad oggi, non è stata accompagnata da
un’altrettanto rapido adeguamento dei programmi di insegnamento.
Al quinto anno di corso sono state illustrate le caratteristiche salienti degli impianti industriali,
con particolare riferimento a quelli con gestione automatizzata a PLC. Ampio risalto è stato
dato all’aspetto della sicurezza elettrica.
METODO D’INSEGNAMENTO
La metodologia dell’insegnamento in classe si è basata principalmente sulla lezione dialogata
che consente di avere un confronto immediato con le concezioni spontanee degli allievi.
Il gruppo classe è stato più volte sollecitato a discutere e a intervenire, minimizzando i modi
convenzionali di “fare scuola” , come la lezione per ascolto, il completamento di schede e le
interrogazioni alla cattedra. Si è cercato di attivare il cosiddetto “apprendimento per
scoperta”, collocando di fatto l’allievo al centro del processo educativo. Si è privilegiato l’uso
di una terminologia facilmente comprensibile, sempre però nel rispetto del linguaggio
specifico della materia.
Gli argomenti relativi al programma sono stati trattati limitando quanto più possibile l’aspetto
teorico, esaltandone invece l’aspetto pratico e le applicazioni dirette.
La trattazione teorica è stata accompagnata da esercitazioni di laboratorio consistenti nella
realizzazione di piccoli schemi di automazione.
Il programma è stato svolto in stretto raccordo con i docenti delle materie affini ( “
ELETTROTECNICA”, “SISTEMI ED AUTOMAZIONE”,). Ciò allo scopo di consentire agli
allievi di acquisire una conoscenza organica dell’elettrotecnica e delle applicazioni ad essa
direttamente collegate
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il grado di apprendimento degli allievi è stato accertato periodicamente sia mediante prove
orali che mediante l’effettuazione di test scritti e prove pratiche. I relativi criteri di valutazione
35
sono stati quelli relativi alla programmazione della classe. Sono state tenute in considerazione
e fatte emergere tutte le attitudini ( teoriche, pratiche, linguistiche, terminologiche ) tali da
consentire una valutazione globale delle conoscenze acquisite.
CONTENUTI ED OBIETTIVI RAGGIUNTI
Automazione civile
Obiettivi:
essere in grado di comprendere le parti principali di un sistema di gestione domotica. Saper
progettare l’impianto di gestione demotica per ambienti adibiti a civile abitazione.
Contenuti:
Generalità
Normalizzazione
Applicazione e funzioni dei sistemi bus
Il sistema instabus EIB
Il sistema KNX
Apparecchi e componenti bus
Automazione Industriale
Confronto tra automazione civile ed automazione industriale
Il cablaggio strutturato:
Obiettivi:
Conoscere sia dal punto di vista costruttivo che funzionale, saper scegliere ed utilizzare le
apparecchiature maggiormente diffuse per la realizzazione di impianti e reti di cablaggio
strutturato per edifici del terziario
contenuti
struttura di una rete di cablaggio strutturato
prestazioni di una rete di cablaggio strutturato
realizzazione di cablaggio strutturato per un’immobile adibito a scuola
Apparecchiature di comando, segnalazione e protezione degli impianti industriali
obiettivi:
Conoscere sia dal punto di vista costruttivo che funzionale, saper scegliere ed utilizzare le
apparecchiature elettromeccaniche maggiormente diffuse per la realizzazione di telecontrolli
su macchine elettriche, impianti ed apparati di tipo industriale
36
contenuti:
Contattori, caratteristiche funzionali, costruttive e criteri di scelta.
Apparecchi ausiliari.
Relè.
Temporizzatori.
Pulsanti.
Lampade di segnalazione.
Interruttori di finecorsa.
Regolatori di livello.
Interruttori di prossimità.
Fotocellule
Apparecchi di protezione
Relè termici.
Relè elettromagnetici.
Relè magnetotermici.
Caratteristiche di intervento dei relè.
Fusibili.
Coordinamento delle protezioni.
Azionamenti elettrici
Obiettivi:
Comprensione teorica e realizzazione pratica di alcuni importanti impianti elettrici industriali.
Saper interpretare e produrre correttamente gli schemi elettrici ad essi relativi.
Contenuti:
Generalità sugli azionamenti industriali.
Azionamenti a velocità non regolata: avviamenti diretti di motori asincroni trifasi.
Teleavviamento diretto di un motore asincrono trifase.
Teleinversione di marcia di un motore asincrono trifase.
Telecommutazione temporizzata di un motore asincrono trifase.
Avviamento stella triangolo di un motore asincrono trifase
Elementi di automazione e controllore logico programmabile (PLC)
Obiettivi:
Acquisire i concetti di base sui comandi automatici e sull’informatica industriale. Conoscere,
sia dal punto di vista dell’architettura che da quello della programmazione, attraverso i
37
linguaggi più noti, i controllori a logica programmabile. Saper convertire lo schema di un
automatismo da logica cablata a programmabile (e viceversa).
Contenuti:
Automazione e comandi automatici.
Logica cablata e logica programmabile
Tecnologie utilizzate nei processi automatici.
Il controllore logico programmabile (PLC). Principio di funzionamento.
Hardware dei PLC. Memorie.
La programmazione dei PLC.
Caratteristiche tecniche di alcuni tipi di PLC.
Esempi di Applicazione dei PLC agli impianti industriali e confronto con i corrispondenti
impianti in logica cablata.
Applicazione nella gestione di un impianto di un edificio civile
38
EDUCAZIONE FISICA
SITUAZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI
Gli obiettivi programmati e illustrati all’inizio dell’anno scolastico hanno suscitato interesse
ed entusiasmo, costituendo una base solida intorno alla quale tutti si sono posti con buone
intenzioni.
La classe ha evidenziato partecipazione attiva, metodo di studio organizzato, impegno tenace.
Gli alunni hanno profuso energie pratiche e mentali, conseguendo risultati positivi
specialmente nei giochi presportivi e sportivi.
L’itinerario didattico è stato percorso con regolare equilibrio e gli obiettivi raggiunti in
termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati rilevanti se si considera la situazione
di partenza.
Il lavoro proposto è stato svolto, nel complesso, con uniformità e costante unità metodologica
basata prevalentemente su lezioni frontali, lavori di gruppo e interventi individualizzati.
Il comportamento dei ragazzi verso i compagni ei docenti è stato sempre corretto,
evidenziando un buon grado di collaborazione, socializzazione e agonismo controllato.
39
MATEMATICA
La classe è risultata abbastanza interessata e collaborativa, ma non sempre ha profuso il
necessario impegno, soprattutto nel lavoro domestico.
Alcuni alunni hanno evidenziato difficoltà di apprendimento, anche a causa di lacune su
alcuni argomenti basilari della disciplina; carenze tra l'altro già evidenziate nel corso degli
anni precedenti, sostenute con attività di recupero, e puntualmente riemerse.
Alcuni elementi di spicco hanno trascinato positivamente il resto della classe.
Nel corso dell'anno scolastico si sono registrati miglioramenti continui che, in definitiva,
hanno consentito alla maggior parte della classe il raggiungimento di livelli soddisfacenti,
buoni o ottimi in pochi casi.
La programmazione didattica è stata in linea di massima rispettata. Lo studio delle funzioni si
è concentrato in particolare sulle quelle razionali, intere e fratte, esponenziali e logaritmiche.
I teoremi fondamentali dell'Analisi matematica sono stati definiti e studiati eventualmente
nei loro aspetti grafici, tralasciandone le dimostrazioni.
CONTENUTI
Insiemi numerici
Intervalli
Intorni
Funzioni
Dominio di una funzione
Limite finito di una funzione in un valore finito
Limite destro e sinistro
Limite finito di una funzione all’infinito
Asintoti orizzontali
Limite infinito di una funzione in un valore finito
Asintoti verticali
Limite infinito di una funzione all’infinito
Teorema dell’unicità del Limite ( senza DIM )
Teorema del confronto ( primo teorema senza DIM )
Funzione continua in un punto
Teoremi sul calcolo dei limiti
Forme indeterminate 0/0 – inf/inf
Punti di discontinuità
Definizione di Rapporto Incrementale in un punto
Significato geometrico del R.I.
Definizione di derivata
Definizione di funzione derivabile in un punto
Significato geometrico della derivata
Definizione di punto stazionario
Derivate fondamentali
Teoremi sul calcolo delle derivate
Teorema di Rolle ( senza DIM )
40
Teorema di Langrange ( valor medio – senza DIM )
Funzioni crescenti e decrescenti
Teorema di De L’Hospital
Definizioni di massimo e minimo relativo
Definizione di punto di flesso
Teoremi sui massimi e minimi relativi
Concavità di una curva
Punti di flesso
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui
Studio di una funzione
STRUMENTI
E’ stato usato il libro di testo ed altro materiale utile come dispense e fotocopie di esercizi
da svolgere.
VERIFICHE
Le verifiche sono state eseguite periodicamente sia orali che scritte. Quelle scritte sono
state il compito tradizionale e prove analoghe alla terza prova d’esame.
VALUTAZIONE
La valutazione ha tenuto conto delle abilità raggiunte, del loro impegno e della
partecipazione mostrata nell’arco dell’anno.
41
ALLEGATI
1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO
2. SIMULAZIONI DELLE TERZE PROVE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO
42
ALLEGATO 1
PRIMA PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO
Tipologia: "Analisi testuale"
INDICATORI
DESCRITTORI
padronanza e uso della lingua
Correttezza ortografica [CO]
15/15
a)buona
2
b)sufficiente (errori di ortografia non gravi)
1,5
c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
0/1
Correttezza sintattica [CS]
a) buona
2
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
1,5
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
0/1
Correttezza lessicale [CL]
conoscenza dello argomento e
del contesto di
riferimento
capacità
logicocritiche ed espressive
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
3
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
2
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
0/1
Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]
a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della loro funzione comunicativa
2,5
b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali
2
c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo
1,5
d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali
0/1
Comprensione del testo [O]
a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive
2,5
b) sufficiente comprensione del brano
2–1,5
c) comprende superficialmente il significato del testo
0/1
Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]
a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di riferimenti culturali e
approfondimenti personali
3
b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace
2,5-2
c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione
1,5
d) scarsi spunti critici
0/1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO IN
QUINDICESIMI
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0-3
INSUFFICIENTE
4-7
MEDIOCRE
8-9
SUFFICIENTE / Più CHE SUFF.
10
DISCRETO / Più CHE DISCRETO
11-12
BUONO /DISTINTO
13 - 14
OTTIMO
15
43
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO
Tipologia : "Articolo di giornale"
INDICATORI
DESCRITTORI
padronanza e uso della lingua
Correttezza ortografica [CO]
15/15
a)buona
2
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
1,5
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
0/1
Correttezza sintattica [CS]
a) buona
2
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
1,5
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
0/1
Correttezza lessicale [CL]
conoscenza dello argomento e del
contesto di riferimento
Capacità logico-critiche ed espressive
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
3
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
2
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
0/1
Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica [S]
a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e gli usi giornalistici
(cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al pubblico e all’occasione)
2
b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…)
1,5
c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…)
1
d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico
0
Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata
3
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico
2
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi
1
d) ignora i dati forniti dai documenti
0
Capacità di riflessione e sintesi [A]
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati
3
b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace
2,5-2
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico
1,5
d) scarsi spunti critici / non analizza i dati avendoli ignorati
0/1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0-3
INSUFFICIENTE
4-7
MEDIOCRE
8-9
SUFFICIENTE
10
DISCRETO / Più CHE DISCRETO
11-12
BUONO /DISTINTO
13- 4
OTTIMO
15
44
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO
Tipologia : "Saggio breve"
INDICATORI
DESCRITTORI
padronanza e uso della lingua
Correttezza ortografica [CO]
15/15
a)buona
2
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
1,5
c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
0/1
Correttezza sintattica [CS]
a) buona
2
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
1,5
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
0/1
Correttezza lessicale [CL]
conoscenza dello argomento e
del contesto di riferimento
Capacità logico-critiche ed
espressive
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
3
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
2
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
0/1
Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]
a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la redazione di un saggio
breve
2,5
b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio breve
2
c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio breve
1,5
d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve
0/1
Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata
2,5
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico
2–1,5
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi
1
d) ignora i dati forniti dai documenti
0
Capacità di riflessione e sintesi [A]
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati
3
b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace
2,5-2
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico
1,5
d) scarsi spunti critici // non analizza i dati avendoli ignorati
0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0-3
INSUFFICIENTE
4-7
MEDIOCRE
8-9
SUFFICIENTE
10
DISCRETO / Più CHE DISCRETO
11-12
BUONO /DISTINTO
13-14
OTTIMO
15
45
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO
Tipologia : "Tema storico"
INDICATORI
DESCRITTORI
padronanza e uso della
lingua
Correttezza ortografica [CO]
15/15
a) buona
2
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
1,5
c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
0/1
Correttezza sintattica [CS]
a) buona
2
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
1,5
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
0/1
Correttezza lessicale [CL]
conoscenza
dell'argomento e del
contesto di riferimento
Capacità logico-critiche
ed espressive
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
3
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
2
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
0/1
Conoscenza degli eventi storici [S]
a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie)
2,5
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)
2
c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze)
1,5
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate
0/1
Organizzazione della struttura del tema [O]
a) Il tema è organicamente strutturato
2,5
b) il tema è sufficientemente organizzato
2–1,5
c) il tema è solo parzialmente organizzato
0/1
Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]
a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali
3
b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti
2,5 -2
c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o l’interpretazione del
libro di testo)
1,5
d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi
0/1
ALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0/3
INSUFFICIENTE
4-7
MEDIOCRE
8-9
SUFFICIENTE
10
DISCRETO / PIU’ CHE DISCRETO
11-12
BUONO / DISTINTO
13-14
OTTIMO
15
46
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO
Tipologia : "Tema di attualità"
INDICATORI
DESCRITTORI
padronanza e uso della
lingua
Correttezza ortografica [CO]]
15/15
a)buona
2
b)sufficiente (errori di ortografia non gravi)
1,5
c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
0/1
Correttezza sintattica [CS]
a) buona
2
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
1,5
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
0/1
Correttezza lessicale [CL]
conoscenza
dell'argomento e del
contesto di riferimento
Capacità logico-critiche
ed espressive
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
3
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
2
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
0/1
Sviluppo dei quesiti della traccia [S]
a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti)
2,5
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)
2
c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve)
1,5
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate
0/1
Organizzazione della struttura del tema [O]
a) Il tema è organicamente strutturato
2,5
b) il tema è sufficientemente strutturato
2–1,5
c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti)
0/1
Capacità di approfondimento e di riflessione [A]
a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate
3
b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica
2,5-2
c) sufficiente capacità di riflessione/critica
1,5
d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica
0/1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0-3
INSUFFICIENTE
4-7
MEDIOCRE
8-9
SUFFICIENTE / Più CHE SUFF.
10
DISCRETO / Più CHE DISCRETO
11-12
BUONO /DISTINTO
13-14
OTTIMO
15
47
SECONDA PROVA SCRITTA
Parametri
Linguaggio tecnico e
rappresentazione grafica.
Contenuto e organizzazione
generale.
Comprensione ed elaborazione,
giudizi, idee, soluzioni adeguate
e consapevolezza.
Completezza dello svolgimento.
Livelli di partenza
Rivela padronanza della tecnica di settore, che
usa in modo dettagliato , approfondito e
pertinente.
La rappresentazione grafica è abbastanza
corretta e appropriata.
La rappresentazione grafica presenta varie
improprietà, utilizza raramente una tecnica
appropriata.
Tratta in modo organico i vari argomenti
facendo opportuni collegamenti e mostrando
conoscenze approfondite.
Mostra conoscenze adeguate all’argomento e le
utilizza con coerenza e puntualità.
Comprende i dati proposti e li utilizza con
coerenza e puntualità.
Conosce parzialmente l’argomento e non
evidenzia una esauriente comprensione.
A. presenti.
Punti
4
Punti
3
2
6
5
4
3
2
B. presenti in modo parziale.
1
A. in modo completo.
3
B. in modo parziale.
2
C. in modo parziale ma non corretto.
1
Totale
48
ORALE
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Indicatori
Padronanza della
lingua
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
Capacità di
collegare le
conoscenze
Capacità di
discutere gli
argomenti
Capacità di
approfondire gli
argomenti
0 - 12
13 -21
22
23 -28
29 -34
35
Scarsa
Incerta
Accettabile
Sicura
Specifica
Ricercata
Scarsa
Limitata
Accettabile
Adeguata
significativa
Documentata
Scarsa
approssimativa
Accettabile
appropriata
Ampia
Dettagliata
Scarsa
Ripetitivo o
meccanico
Accettabile
Appropriata
Ampia
Arguta
Scarsa
Limitata
Accettabile
Articolata
Ampia
Originale
49
ALLEGATO 2
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
I.T.I.S.
G. MARCONI
via Roma trav. Siano – Torre Annunziata (NA)
I SIMULAZIONE
TERZA PROVA D’ESAME
ANNO SCOLASTICO: 2011
/ 2012
ALUNNO: …………………………………………..
CLASSE: V
TIPOLOGIA:
SEZIONE: C
B + C ( B quesiti risposta singola, C quesiti risposta multipla)
n° 9 tipologia B, n° 20 tipologia C.
MATERIE COINVOLTE:
•
IMPIANTI ELETTRICI (3 quesiti tipologia B)
•
TECNOLOGIE ELETTRICHE, DISEGNO E PROGETTAZIONE (3 quesiti tipologia B),
•
INGLESE (3 quesiti tipologia B),
•
MATEMATICA (10 quesiti tipologia C),
•
SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI (10 quesiti tipologia C).
Norme sulla prova:
• per la tipologia B i candidati devono rispondere esclusivamente nei sei righi predisposti;
• per la tipologia C solo una delle risposte risulta corretta;
•
tempo previsto per la prova:
Data
………………………….
2 ore.
Firma dell’alunno
………………………….
50
IMPIANTI ELETTRICI
1) Cosa rappresenta il potere di interruzione di un interruttore magnetotermico, ed in base a quali parametri della
rete elettrica va scelto.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Come si effettua la selettività differenziale verticale tra piu’ dispositivi?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Differenze costruttive e di impiego tra un sezionatore, un contattore ed un interruttore automatico
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
51
TECNOLOGIE ELETTRICHE, DISEGNO E PROGETTAZIONE
1) Controllore a Logica Programmata: quando è conveniente l’utilizzo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Illustrare come si realizza l’interblocco elettrico in una teleinversione di velocità di un mat. Chiarendo anche il
motivo per il quale viene implementato.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3)Illustrare l’architettura di una rete lan realizzabile all’interno di un edificio scolastico
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
52
INGLESE
1)
GIVE AN APPROPRIATE DEFINITION OF DC CURRENT
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2)
DESCRIBE THE FREQUENCY OF AN ALTERNATING CURRENT
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3)
WHY IS ALTERNATING CURRENT MORE WIDELY USED THAN DC CURRENT?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
53
MATEMATICA
54
MATEMATICA
55
SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI
1) Quale dei seguenti bipoli non è lineare? :
A. l’elemento resistivo
B. l’elemento induttivo
C. il diodo
D. l’elemento capacitivo
2) Quale dei seguenti sistemi, con ingresso x(t) ed uscita y(t) è lineare?
A. y(t) = 5·x(t)
B. y(t) = 2·(x(t))²
C. y(t) = √x(t)
D. y(t) = ln(x(t))
3) Dato un circuito R-L, il polo della corrispondente F.d.T. sarà del tipo:
A. puramente reale
B. puramente immaginario
C. nell’origine
D. nessuno dei precedenti
4) Un circuito R-C viene alimentato a tensione costante. Durante il transitorio che andamento nel
tempo avrà la tensione sul condensatore, tenuto conto che il circuito è inizialmente scarico?
A. un andamento costante
B. un andamento a rampa crescente
C. un andamento sinusoidale ad ampiezza crescente nel tempo
D. nessuno dei precedenti
5) Dato un sistema R-L-C inizialmente scarico con un fattore o coefficiente di smorzamento ξ = 0.1,
se alimentato a tensione costante durante il transitorio che andamento nel tempo avrà la tensione sul
condensatore?
A. un andamento costante a tratti
B. un andamento sinusoidale ad ampiezza crescente nel tempo
C. un andamento a rampa decrescente
D. un andamento alternato ad ampiezza decrescente nel tempo
56
SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI
6) In un trasduttore, quale tra le seguenti caratteristiche è di tipo dinamico?
A. sensibilità
B. precisione
C. risoluzione
D. tempo di risposta
7) La dinamo tachimetrica è un sensore di:
A. velocità
B. temperatura
C. pressione
D. peso
8) Data la funzione di trasferimento di un sistema, è possibile verificarne la stabilità asintotica
conoscendo i poli che dovranno soddisfare alla seguente condizione:
A. reali positivi e complessi coniugati a parte reale positiva
B. almeno un polo doppio nell’origine e tutti gli altri negativi
C. reali negativi e complessi coniugati a parte reale positiva
D. reali negativi e complessi coniugati a parte reale negativa
9) Quale delle seguenti affermazioni risulta vera:
A. la Funzione di trasf. F(Jω) = K / ( 1 + Jω · τ) è tipica di un blocco con un polo
B. la Funzione di trasf. F(Jω) = K / ( 1 + Jω · τ) è tipica di un blocco con uno zero
C. la Funzione di trasf. F(Jω) = Jω è tipica di un blocco con un polo nell’origine
D. la Funzione di trasf. F(Jω) = K è tipica di un blocco con uno zero nell’origine
10) Un condensatore di capacità 100µF è connesso ad un generatore di tensione E costante tramite un
resistore di 2kΩ. Dopo quanto tempo si potrà considerare carico il condensatore? :
A. in circa 1s
B. in circa 2ms
C. non si può rispondere perché non è noto il valore di E
D. il condensatore non si carica affatto
57
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA SIMULAZIONE
III PROVA D’ESAME
Punteggio massimo per disciplina: 15 punti.
Tipologia B
MATERIA
PERCORSO
VALUTATIVO
IMPIANTI (max 15)
1^
2^
3^
T. D. P. (max 15)
1^
2^
3^
INGLESE (max 15)
1^
2^
3^
Conoscenza degli argomenti
trattati
Capacità di argomentare e
costruire la risposta in modo
organico e corretto
Conoscenze del linguaggio
specifico, delle regole e delle
conoscenze
PARZIALE
TOTALE
Tipologia C
PERCORSO
VALUTATIVO
1
2
3
MATEMATICA
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
SISTEMI ELETTRICI
4
5
6
7
8
Risposta esatta
Risposta errata
Alcuna risposta
TOTALE
Per tipologia C, i punteggi sono così ripartiti:
•
•
•
0 : RISPOSTA ERRATA
0 : ALCUNA RISPOSTA
1,5 : RISPOSTA ESATTA
/ 75
TOTALE DELLA PROVA ……
CONVERSIONE VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI
58
9
10
Punteggio
max 80
Voto in
quindicesimi
1–5
1
6 - 10
2
11 - 15
3
16 – 20
4
21 – 25
5
26 – 30
6
31 – 35
7
36 – 40
8
41 – 45
9
46 – 50
10
51 – 55
11
56 – 60
12
61 – 65
13
66 – 70
14
71 – 75
15
VALUTAZIONE DELLA PROVA
……
/ 15
59
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
I.T.I.S.
G. MARCONI
via Roma trav. Siano – Torre Annunziata (NA)
II SIMULAZIONE
TERZA PROVA D’ESAME
ANNO SCOLASTICO: 2011
/ 2012
ALUNNO: …………………………………………..
CLASSE: V
TIPOLOGIA:
SEZIONE: C
B + C ( B quesiti risposta singola, C quesiti risposta multipla)
n° 9 tipologia B, n° 20 tipologia C.
MATERIE COINVOLTE:
•
IMPIANTI ELETTRICI (3 quesiti tipologia B)
•
TECNOLOGIE ELETTRICHE, DISEGNO E PROGETTAZIONE (3 quesiti tipologia B),
•
INGLESE (3 quesiti tipologia B),
•
MATEMATICA (10 quesiti tipologia C),
•
SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI (10 quesiti tipologia C).
Norme sulla prova:
• per la tipologia B i candidati devono rispondere esclusivamente nei sei righi predisposti;
• per la tipologia C solo una delle risposte risulta corretta; non sono ammesse due risposte o cancellature;
•
tempo previsto per la prova:
Data
………………………….
2 ore.
Firma dell’alunno
………………………….
60
IMPIANTI ELETTRICI
1) Illustrare il significato di backup tra dispositivi magnetotermici e chiarire la differenza con la
selettività verticale.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) Differenze costruttive e di impiego tra un sezionatore, un contattore ed un interruttore automatico
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3) Chiarire la differenza tra le correnti che si manifestano in relazione ad un guasto fase-pe nel caso
di impianti TT ed impianti TN
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
61
TECNOLOGIE ELETTRICHE, DISEGNO E PROGETTAZIONE
1) Illustrare le differenze dimensionali e strutturali tra le varie taglie di carpenterie per quadri
elettrici
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) Illustrare il significato di “categoria di impiego” di un contattore.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) Illustrare le differenze tra interblocco elettrico ed interblocco meccanico tra due contattori.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
62
INGLESE
1) DESCRIBE WHAT RELAYS ARE AND HOW THEY WORK
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) WHAT IS A COMMUTATOR SWITCH?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) THE SERIES-WOUND MOTOR IS THE SIMPLEST TYPE OF ELECTRIC MOTOR:
DESCRIBE HOW IT WORKS
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
63
MATEMATICA
64
MATEMATICA
SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI
65
SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI
1 Quale delle seguenti affermazioni risulta vera:
A. un sistema a catena aperta non commette mai errori
B. un sistema a catena aperta, in presenza di disturbo lo compensa interamente
C. un sistema retroazionato, in presenza di un disturbo lo compensa parzialmente
D. un sistema retroazionato non commette mai errori
2) Dato un circuito R-L, il polo della corrispondente F.d.T. sarà del tipo:
E. puramente reale
F. puramente immaginario
G. nell’origine
H. nessuno dei precedenti
3) Dato un sistema R-L-C inizialmente scarico con un fattore o coefficiente di smorzamento ξ = 1,1 se
alimentato a tensione costante durante il transitorio che andamento nel tempo avrà la tensione sul
condensatore?
E. un andamento costante a tratti
F. un andamento sinusoidale ad ampiezza crescente nel tempo
G. un andamento a rampa decrescente
H. un andamento aperiodico
4) In un trasduttore, quale tra le seguenti caratteristiche è di tipo dinamico?
E. campo di variazione dell’entrata
F. guadagno o costante di traduzione
G. risoluzione
H. costante di tempo
5) Nel sistema di regolazione della velocità di un motore in corrente continua in anello chiuso, quale
funzione assume la dinamo tachimetrica?
A. contribuisce a fornire potenza al motore
B. fornisce il segnale di reazione
C. fornisce l’alimentazione dei poli magnetici
D. fornisce il segnale di riferimento
66
SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI
6) Quale delle seguenti affermazioni risulta vera:
E. la Funzione di trasf. F(Jω) = K / ( 1 + Jω · τ) è tipica di un blocco con un polo
F. la Funzione di trasf. F(Jω) = K / ( 1 + Jω · τ) è tipica di un blocco con uno zero
G. la Funzione di trasf. F(Jω) = Jω è tipica di un blocco con un polo nell’origine
H. la Funzione di trasf. F(Jω) = K è tipica di un blocco con uno zero nell’origine
7) In un sistema retroazionato, il condizionatore di segnale, a valle del sensore, assume uno tra i
seguenti compiti:
A. riporta il segnale all’uscita del sistema
B. elabora il segnale proveniente dal sensore per renderlo confrontabile con un secondo segnale
C. funge da attuatore
D. raffredda il sensore
8) In un sistema di controllo, il generatore di riferimento serve per:
A. Genera la potenza necessaria al sistema di controllo
B. Amplificare un segnale.
C. Regolare il segnale di controllo del sistema.
D. Converte un segnale elettrico debole in uno di potenza.
9) In un sistema di controllo, un SCR opportunamente collegato ad altri componenti, assume il
compito di:
A. Generare la potenza necessaria al sistema di controllo.
B. Amplificare la potenza per il carico.
C. Carico.
D. Filtro passivo.
10) In un sistema di controllo, un amplificatore operazionale, una volta configurato, può svolgere solo
uno tra i seguenti compiti, quale?
A. Fornisce potenza al carico elettrico
B. Amplifica un segnale
C. Funge da attuatore
D. Raffredda il sensore
67
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA SIMULAZIONE
III PROVA D’ESAME
Punteggio massimo per disciplina: 15 punti.
Tipologia B
MATERIA
PERCORSO
VALUTATIVO
IMPIANTI (max 15)
1^
2^
3^
T. D. P. (max 15)
1^
2^
3^
INGLESE (max 15)
1^
2^
3^
Conoscenza degli argomenti
trattati
Capacità di argomentare e
costruire la risposta in modo
organico e corretto
Conoscenze del linguaggio
specifico, delle regole e delle
conoscenze
PARZIALE
TOTALE
Tipologia C
PERCORSO
VALUTATIVO
1
2
3
MATEMATICA
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
SISTEMI ELETTRICI
4
5
6
7
8
Risposta esatta
Risposta errata
Alcuna risposta
TOTALE
Per tipologia C, i punteggi sono così ripartiti:
•
•
•
0 : RISPOSTA ERRATA
0 : ALCUNA RISPOSTA
1,5 : RISPOSTA ESATTA
/ 75
TOTALE DELLA PROVA ……
CONVERSIONE VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI
68
9
10
Punteggio
max 80
Voto in
quindicesimi
1–5
1
6 - 10
2
11 - 15
3
16 – 20
4
21 – 25
5
26 – 30
6
31 – 35
7
36 – 40
8
41 – 45
9
46 – 50
10
51 – 55
11
56 – 60
12
61 – 65
13
66 – 70
14
71 – 75
15
VALUTAZIONE DELLA PROVA
……
/ 15
69