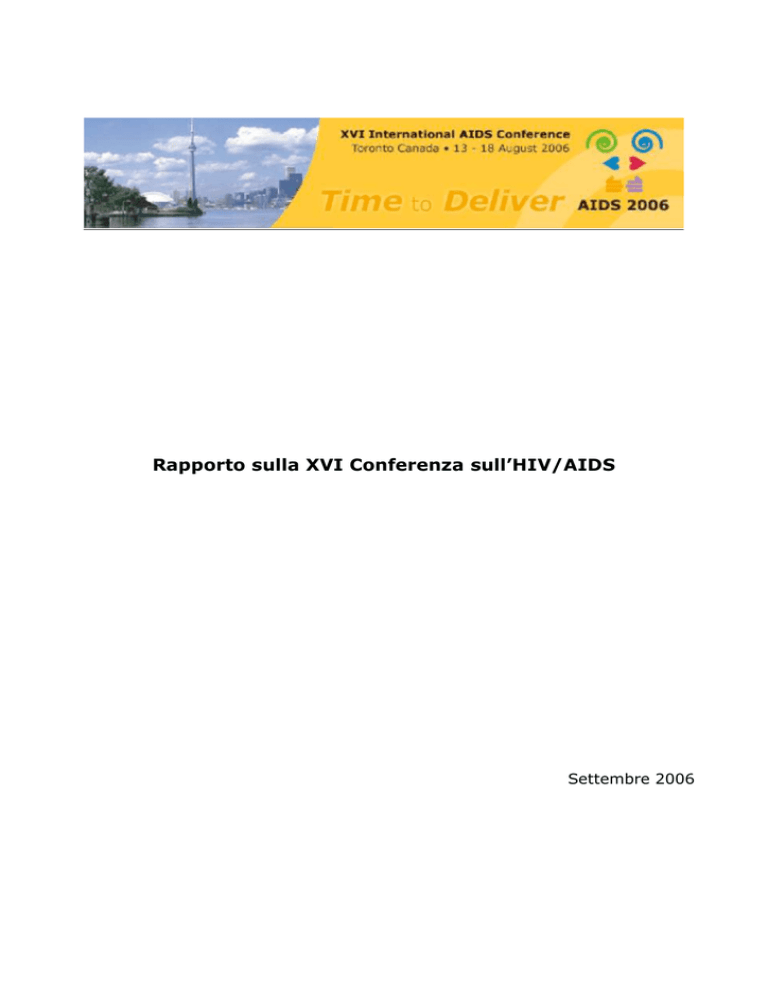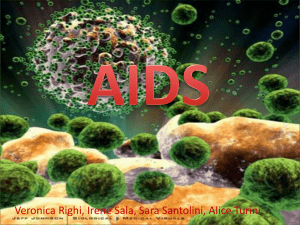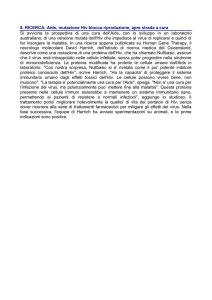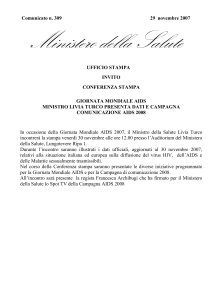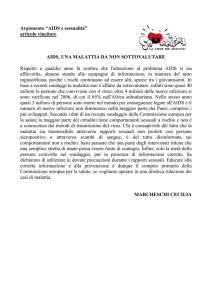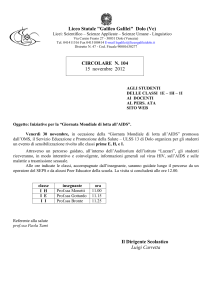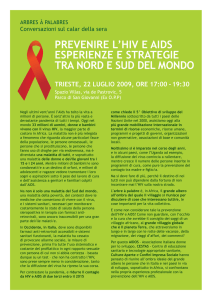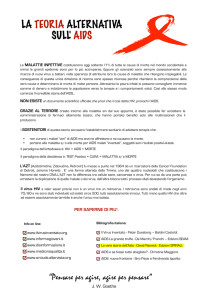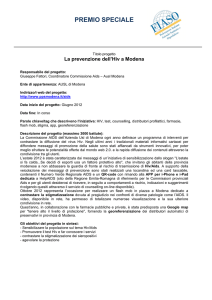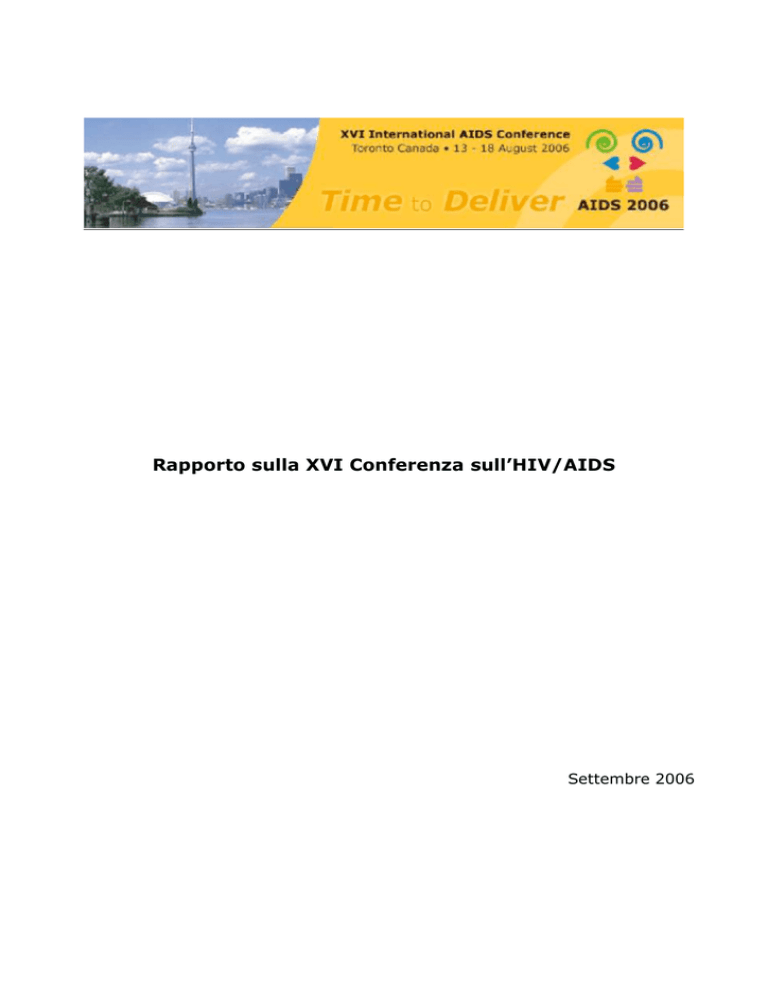
Rapporto sulla XVI Conferenza sull’HIV/AIDS
Settembre 2006
Introduzione
Alla conferenza internazionale sull’AIDS di Toronto hanno partecipato circa
25.000 - 30.000 delegati provenienti da paesi diversi, con esperienze e
formazioni differenti tutti accomunati dallo stesso obiettivo: condividere la
propria esperienza, ascoltare l’esperienza altrui, confrontarsi sulle questioni
principali legate alla lotta alla pandemia.
Lo slogan della Conferenza in inglese era “Time To Deliver” tradotto in francese
“Passer à l’action”.
Se la versione francese sottolinea come a quasi 25 anni dal primo caso
diagnosticato di AIDS ci sia l’urgenza dell’azione, quella inglese pone l’enfasi su
un’azione transitiva da un soggetto all’altro, un’azione che è dunque un generico
dare, consegnare, fornire. Uno slogan, quello inglese, dunque, più interessante
perché non solo presuppone un soggetto che agisce, ma anche un “qualcosa”,
oggetto dell’azione, un altro “qualcuno” destinatario dell’azione e un “come”, il
modo cioè con cui quel qualcosa giunge a quel qualcuno.
Mi soffermo su questi aspetti apparentemente formali e linguistici perché se è
vero che l’interrogarsi sul “chi”, “che cosa”, “a chi” e “come” dovrebbe essere alla
base delle riflessioni che precedono ogni azione e interazione umana, a Toronto
ho imparato che porsi questo interrogativo è a maggior ragione fondamentale
quando si parla di lotta all’AIDS.
Per molte patologie, in effetti, è facile individuare nel “chi” un dottore, nel “cosa”
un farmaco e nell’ “a chi” un paziente, ma per l’HIV/AIDS, malattia particolare e
complessa, non basta un dottore, non serve solo una pillola e non si tratta
semplicemente di un paziente. E in effetti, i programmi di lotta all’AIDS non si
basano semplicemente sul trattamento o terapia, ma anche sulla cura, o meglio
sul prendersi cura dell’individuo e sulla prevenzione e l’informazione. E ognuna
di queste tre macro aree: prevenzione, cura e trattamento sono dei grossi
contenitori in cui confluiscono e interagiscono aspetti e temi importanti, quali i
diversi contesti sociali economici e culturali, i diritti umani, le questioni di genere.
E anche se un approccio olistico richiede il doppio degli sforzi, tutti questi ambiti
non si possono considerare separatamente: ignorare la complicata interazione
che esiste tra tutti questi aspetti e che agisce su ogni singolo individuo che ha
contratto il virus rischia di vanificare gli sforzi compiuti finora e quelli che
saranno compiuti per sconfiggere la pandemia.
Eppure l’impressione generale di Toronto è che questa interazione non sia
considerata prioritaria. Le incoraggianti scoperte in campo scientifico fatte
recentemente sono state dibattute e analizzate da un punto di vista prettamente
scientifico e ben poco si è parlato della loro sostenibilità qualora la loro efficacia
venisse confermata.
Molti sono stati i membri di associazioni e gruppi di sieropositivi che hanno
partecipato alla conferenza, ma molto debole la loro voce che non è confluita in
un messaggio forte unitario da consegnare ai presenti.
Tra lo spazio sobrio delle sale conferenze e della “lezione frontale” e quello
colorato, vivace e rumoroso del global village fatto di stand e di “lezioni circolari”
sembrava esistesse non solo una separazione spaziale, ma anche in molti casi
un’impercettibile barriera culturale e sociale, fatta, a volte, di reciproca diffidenza
o sfiducia.
La mia impressione è che nel tentativo di evitare questo pericoloso scollamento,
un’organizzazione non-governativa come AMREF possa avere un ruolo davvero
cruciale.
AMREF è arrivata a Toronto con uno slogan semplice ma efficace: “Understand
Africa” e dietro questa frase da tradurre più con un imperativo che con un
infinito, c’è proprio quell’approccio multi-disciplinare al problema della diffusione
dell’HIV/AIDS in Africa che va dalla rimozione delle barriere culturali che
impediscono di sottoporsi spontaneamente al test dell’HIV, a programmi
finalizzati all’analisi di distribuzione sostenibile di antiretrovirali, da programmi di
formazione di guaritori tradizionali, agli studi sui microbicidi o sul ruolo
dell’herpes simplex nella trasmissione del virus. C’è inoltre la radicata e
indispensabile consapevolezza che una risposta alla pandemia in Africa basata sul
modello occidentale, che purtroppo molto spesso detta le linee guida dei grandi
donatori istituzionali, anche se ha portato ad ottimi risultati nei paesi
caratterizzati da sistemi sanitari efficienti come i nostri, in Africa appunto non
può funzionare.
L’Africa deve, infatti, considerare queste esperienze e rimodellarle adattandole al
contesto locale piuttosto che importare nozioni preconfezionate e durante questo
processo di revisione non può ignorare le comunità locali, poiché “finché le
persone non saranno coinvolte nel creare il proprio sistema sanitario,
continueremo ad asciugare il pavimento mentre il rubinetto continua a
gocciolare” (Miriam Were)
Cominciando dall’ABC
“We need to put the power to prevent HIV in the hands of women.” (Melinda
Gates)
Quando si parla di prevenzione dell’HIV/AIDS ci si riferisce spesso ad un modello
denominato ABC che si basa su tre principi: A come Abstinence; B come Be
Faithful, C come Condoms. Finora questo modello ha contribuito a ridurre
l’incidenza del virus ed è necessario espanderlo, ma presenta sicuramente dei
grossi limiti. Spesso quando si parla di esperienze di successo nella riduzione
dell’incidenza dell’HIV/AIDS attraverso il ricorso all’ABC si cita il caso
dell’Uganda, primo paese africano ad adottare questo modello. Ma a chi
considera la riduzione della prevalenza dei casi registrata nel paese come prova
dell’efficacia dell’ABC, viene contestato il fatto che si trascura l’alto numero di
decessi avvenuti nel passato e che l’attuale diminuzione di decessi dipende anche
dall’espansione dei programmi di accesso a terapie antiretrovirali e aggiungerei,
una oggettiva difficoltà nel fornire dati reali tenuto anche conto della difficile
situazione presente nel nord del paese.
Sui limiti dell’ABC considerata come unica forma di prevenzione all’Aids, ma
anche sui pericoli di una riduzione del modello da ABC ad un semplice AB, sono
spesso intervenuti diversi relatori presenti a Toronto: l’astinenza in molti contesti
africani non è una concreta opzione per le giovani donne così come l’essere fedeli
non le protegge dall’infedeltà che è più frequente tra gli uomini.
Anche l’uso del preservativo non è una scelta che la donna possa
autonomamente.
prendere
Oltre ai limiti dell’ABC molti dei relatori presenti a Toronto hanno lanciato
l’allarme circa una pericolosa tendenza ad escludere la distribuzione gratuita di
condoms nei programmi di prevenzione. Sotto accusa soprattutto il PEPFAR
(President's Emergency Plan for AIDS Relief) fondo di emergenza della Casa
Bianca creato per la lotta all’AIDS che finanzia diversi progetti in Africa ponendo
una serie di condizioni e restrizioni tra cui appunto: il divieto di utilizzare i fondi
per l’acquisto e distribuzione di preservativi, il divieto di realizzare programmi
che prevedano tra i beneficiari prostitute o tossico-dipendenti.
Alle accuse rivolte al programma da molti attivisti, i responsabili del PEPFAR
hanno sempre risposto sottolineando la trasparenza nell’uso delle risorse, la
capacità di coinvolgere le persone sieropositive nei propri programmi e il buon
sistema di monitoraggio e valutazione delle attività, ma soprattutto la libertà
altrui di integrare i programmi PEPFAR con altri programmi di prevenzione e
distribuzione dei condoms.
Eppure la situazione raccogliendo le informazioni dei vari relatori alla conferenza
sembra essere meno rassicurante: in Zambia il 95% dei nuovi programmi di
prevenzione sono solo su astinenza e fedeltà e alcune policy e strategie nazionali
omettono riferimenti espliciti a metodi di prevenzione contrari a quelli indicati dal
PEPFAR.
Il rischio maggiore, nel caso in cui tra i messaggi di prevenzione sparisca il
riferimento ai preservativi e restino solo fedeltà o astinenza, è che si arrivi ad
una vera e propria distorsione del messaggio e l’accrescimento dello stigma. “Se
agli adolescenti insegniamo che solo astinenza e fedeltà sono valori e strumenti
per difendersi dall’AIDS, cosa penseranno allora degli infermieri, insegnanti o
familiari infetti?”
Oltretutto a far pressione su programmi di prevenzione basati sull’astinenza e la
fedeltà sono molti leader religiosi: “Ancora oggi in Sud Africa la chiesa si
dimostra ipocrita ed ignora deliberatamente il tema della prevenzione attraverso
i preservativi” ha accusato Musa Nioko artista jazz e attivista africana e ha
aggiunto “ancora oggi le donne africane spesso rifiutano di partecipare a
programmi di prevenzione della trasmissione materno-fetale a causa dello
stigma. Bisogna garantire attraverso mirati programmi educativi e formativi
l’emporwement femminile, ma continuare a coinvolgere gli uomini che devono
assumersi le proprie responsabilità nel proteggere le proprie mogli e la propria
famiglia”.
A complicare ulteriormente il quadro c’è anche il fatto che, anche la posizione dei
leader religiosi pur appartenenti alla stessa confessione non è un’univoca.
Per stessa ammissione del reverendo sieropositivo Johannes Petrus Heath,
segretario generale di ANERELA (African Network of HIV-affected Religious
Leaders living with or personally Affected by HIV and AIDS) in Africa c’è stato un
sostanzioso aumento nella produzione di materiale informativo e di manuali sulla
prevenzione, ma non necessariamente questo fatto può essere considerato
positivo, perché spesso si tratta di insegnamento errato. In Uganda, ha aggiunto
l’80% dei pastori protestanti continua a pensare e predicare che l’HIV/AIDS sia
una punizione divina.
E’ questo, io credo un tema di estrema importanza, ma di difficilissima gestione.
Tra i leader religiosi, quello che più di tutti ha onestamente affrontato il tema
delle ragioni per cui le chiese o le mosche non hanno il coraggio di porsi a difesa
dei più deboli e in questo caso dei sieropositivi credo sia stato Farid Esack,
teologo mussulmano sudafricano che ha affermato:
“Rendere le persone sieropositive parte integrante del nostro lavoro significa
ammettere conse “terribili”. Significa affrontare tra gli altri il problema della
prostituzione e dell’omosessualità. E questi sono ambiti che ci terrorizza
considerare. Per molti di noi le nostre vite religiose si basano sul riconoscimento
e l’accrescimento del “potere religioso”. E gli interrogativi del potere sono: Come
possiamo controllare le gerarchie? Come possiamo controllare le comunità?
Addentrandoci invece in quegli ambiti si considerano al contrario realtà
difficilmente controllabili. E’ necessario quindi un radicale ripensamento dei
contenuti e dei messaggi delle nostre religioni”.
Complessivamente a Toronto è emersa la necessità di insistere ed espandere
programmi di prevenzione: gli antiretrovirali non sono la cura e non essendoci un
vaccino, ridurre il rischio di ulteriori contagi è attualmente l’unica arma a
disposizione per cercare di tenere sotto controllo la diffusione della pandemia.
Ma assodata la necessità di investire nella prevenzione è necessario chiarire che
cosa si intende con questo termine. L’HIV/AIDS è prevalentemente una malattia
a trasmissione sessuale e ogni essere umano è un essere sessuato: il sesso è un
aspetto naturale della vita umana. In Africa spesso la percentuale complessiva di
infezioni contratte da ragazze e giovani donne è doppia rispetto a quella dei
coetanei, questo dato riflette in maniera significativa la vulnerabilità sociale delle
donne dovute a sistemi strutturalmente ineguali, condizioni sociali ed economici
di indigenza in cui comunque si stabilisce un iniquo rapporto tra i generi,
ovunque nel mondo: ”women over represent the poorest” e tra vulnerabilità
femminile, AIDS e povertà esiste un rapporto di proporzionalità diretta.
Malgrado il carattere intuitivo di questa disparità nei rapporti uomo-donna, le
questioni di genere non sono adeguatamente considerate quando si parla di
prevenzione dell’aids.
Inutilmente la società civile ha chiesto lo scorso giugno a New York di esplicitarlo
nella Dichiarazione di UNGASS, e dietro questo rifiuto formale, c’è una
sostanziale mancanza di volontà politica. “E’ necessario mettere nelle mani delle
donne il potere di prevenire l’HIV”: resta da capire come farlo per garantire che
quel potere diventi reale.
Microbicidi
“The best way forward is the synergistic use of social, behavioural, biomedical
and barrier methods, which can only happen with community involvement and
leadership at all levels.” (Gita Ramjee)
Partendo da questa slide Gita Ramjee, scienziato dell’Unità di Ricerca sulla
prevenzione di Durban, (Sud Africa) ha illustrato il lavoro che la ricerca scientifica
sta compiendo nell’ambito dell’individuazione dei nuovi strumenti di prevenzione
e in particolare dei microbicidi.
I microbicidi sono: “molecole in sperimentazione che, in forma di gel, pomata, o
crema, applicati nella vagina o nel retto prima del rapporto sessuale, sarebbero
potenzialmente in grado di bloccare la trasmissione dell'HIV (ed eventualmente
di altri microrganismi sessualmente trasmissibili)”.
Si tratterebbe dunque di un’ulteriore strategia terapeutica preventiva che
potrebbe rappresentare non solo uno strumento efficace per tenere sottocontrollo
l’epidemia, ma anche per affidare tale controllo alle donne.
I primi risultati delle sperimentazioni attualmente in corso, alcune delle quali
proprio nei paesi in cui AMREF è presente (Kenya, Uganda, Sud Africa, Tanzania)
sembrerebbero molto incoraggianti, i primi dati dovrebbero essere disponibili
entro settembre 2007 e quindi divulgabili circa un anno dopo.
Confesso che ho seguito la presentazione condividendo l’entusiasmo per il lavoro
svolto e le opportunità che sembra dimostrare, ma nel corso della giornata la mia
perplessità è aumentata.
La prima considerazione da fare è temporale: per quanto il 2008 possa sembrare
vicino è necessario considerare che secondo le stime più recenti, ogni giorno
avvengono 11.200 nuove infezioni e si registrano circa 8.000 decessi: è giusto
investire sulla ricerca, ma è altrettanto fondamentale continuare a garantire
risorse per realizzare i programmi di prevenzione utilizzando gli strumenti finora
disponibile.
La seconda considerazione da fare è di natura etica. Secondo quanto affermato
dalla dott.ssa Ramjee, tra i microbicidi finora sperimentati si è intuito che quelli
più efficaci nell’inibire il virus siano quelli che contengono antiretrovirali. Lo
stesso problema si verifica anche quando si fa ricorso ad altri strumenti di
prevenzione come la PrEP (Pre-exposure prophylaxis) o la PEP (Post Exposure
prophylaxis)1. E abbastanza naturale chiedersi a questo punto se sia eticamente
accettabile sottoporre a trattamenti medici cronici individui sani per evitare il
contagio. Inoltre, come si può monitorare l’aderenza ai programmi e come
evitare abusi o usi impropri dei farmaci? Proprio su un tema così importante mi è
sembrato di percepire che le posizioni di scienziati e donatori (tra cui Bill e
Melinda Gates) da un lato e attivisti e società civili dall’altro, fossero piuttosto
discordanti e che Toronto non abbia rappresentato una vera opportunità di
confronto.
La terza considerazione è di natura politica. Posta l’efficacia delle nuove scoperte
scientifiche, come sarà possibile garantire che diventi uno strumento accessibile
per tutti?
Un quarto aspetto è stato preso in considerazione da Daraus nel suo discorso
tenuto durante il ricevimento di AMREF: “Il gel – ha spiegato Daraus- deve
essere conservato in frigorifero, come si può considerare allora che i microbicidi
siano uno strumento efficace di prevenzione per le donne che vivono nei tanti
villaggi africani in cui le case non hanno elettricità?”
Sarebbe stato bello che un dibattito su questi tutti aspetti si fosse tenuto dopo la
presentazione della dott.ssa Ramjee.
Ma aldilà dell’occasione mancata, resta comunque il fatto che se sarà confermata
l’efficacia di questi nuovi strumenti di prevenzione, se ne saranno ridotti gli effetti
collaterali e se ci sarà la volontà politica di renderli rapidamente accessibili alle
popolazioni più a rischio, si potrebbe assistere ad una vera e propria rivoluzione
nell’ambito della lotta all’HIV/AIDS.
Coinvolgere le comunità
“To deliver a response that can help people, we need qualified human resources,
we need genuine investment to strengthen the capacity of our communities. We
are part of the solutions, not only as target groups.” (Frika Chia Iskandar)
La prima Sessione Speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha
portato all’elaborazione di una Dichiarazione di impegno sulla lotta all’HIV/AIDS
1
“PREP, acronimo di Pre-exposure prophylaxis. La profilassi di pre-esposizione (preparazione) prevede l’assunzione
dei farmaci antiretrovirali per impedire l'infezione di HIV. Diversa è la profilassi post-esposizione (PEP) che prevede la
terapia antiretrovirale dopo ogni singola esposizione al virus.” (LILA)
sottoscritta da 189 paesi membri si è tenuta a New York nel 2001 2.
Lo scorso fine maggio sempre a New York si è tenuta una nuova sessione
speciale, momento di verifica su quanto fatto finora e su quegli impegni che è
necessario rinnovare o rivitalizzare per combattere la pandemia.
La dichiarazione del 2006 ha lasciato piuttosto insoddisfatti gli attivisti e la
società civile internazionale impegnata nella lotta all’AIDS, ma contiene in sé
un’affermazione importante: “ora abbiamo gli strumenti per far regredire la
pandemia e per evitare inutili perdite di milioni di vite umane”. L’obbligo di tutti
gli attori coinvolti nella lotta all’aids è quella di capire in che modo gli strumenti
finora a disposizione possano essere utilizzati in maniera efficace.
Tra i vari modi per rendere l’affermazione della dichiarazione reale, c’è
sicuramente il pieno coinvolgimento delle comunità a vari livelli nei programmi di
lotta all’HIV/AIDS.
Una delle prime presentazioni a cui ho assistito a Toronto è stata quella relativa
allo studio del ruolo del coinvolgimento comunitario come elemento chiave per il
successo di programmi di trattamento e cure.
Lo studio presentato dimostra come esista un rapporto diretto tra il sostegno
della comunità al paziente e la sua risposta alla terapia. Il ruolo che la comunità
può avere nel sostenere i pazienti affetti dal virus e migliorare la qualità della
loro vita è supportato da dati significativi: il numero delle cellule CD4 dei pazienti
che godono del sostegno comunitario aumenta più in fretta rispetto agli altri. E
coinvolgere le comunità significa considerare le risorse di cui dispone e
potenziarle con attività mirate.
I membri comunitari non sono semplici target di progetti di sensibilizzazione
realizzati per combattere lo stigma.
Nel discorso tenuto durante la cerimonia di apertura della conferenza, Frika Chia
Iskandar ha ben illustrato questo punto. E’ necessario ha detto: garantire
l’empowerment delle comunità che possono avere un ruolo fondamentale
nell’educazione, cura, sostegno trattamento e negli aspetti di prevenzione del
virus. Garantire un meccanismo di finanziamento che sia facilmente accessibile
dai membri delle comunità e guidato dai loro bisogni reali.
Frika Iskandar ha sottolineato inoltre che la gran parte dei fondi a disposizione
per la lotta all’AIDS non raggiungono le comunità è questo, io credo è purtroppo
un dato di fatto inaccettabile e intollerabile.
Particolarmente interessanti le sue considerazioni sullo stigma, apprezzate da
tutto lo staff di AMREF presente alla cerimonia.
Lo stigma e la discriminazione rimangono un problema ha detto che continua ad
impedire a molte persone di sottoporsi al test, o ad individui sieropositivi di
rivelare il proprio stato al proprio partner o alla comunità. Ma è innegabile, ha
detto che le persone e i politici discriminano i malati di aids da oltre 20 anni e
continueranno a farlo. E’ più utile quindi invece di promuovere programmi di
riduzione dello stigma imparare a conviverci, affrontarlo nell’unico modo
possibile: attraverso il reale, autentico coinvolgimento delle persone
sieropositive.
2
Durante la Conferenza di Toronto ho assistito al dibattito: “Accountability for Implementation of the UNGASS
HIV/AIDS Declaration of commitment. I miei commenti a questa sessione speciale sono sul sito di AMREF
http://www.amref.org/index.asp?PageID=460
Conclusione
I temi che ho cercato di sintetizzare in queste pagine non offrono ovviamente
una visione complessiva della conferenza di Toronto. E non solo per l’enorme
numero di incontri tenuti in contemporanea, che mi hanno costretto a scegliere a
priori cosa seguire, non solo perché tutto quello che ho scritto è ovviamente
filtrato dalla mia personale interpretazione, ma anche perché non è tutto quello
su cui ho sentito discutere, ho preso appunti o riflettuto durante l’intensissima
settimana di conferenza.
Ho scelto infatti, degli aspetti che credo interessino tutti noi di AMREF Italia.
AMREF in quanto organizzazione sanitaria africana è in prima linea nella lotta
all’AIDS. Sappiamo bene che il nostro compito è diverso rispetto a quello dei
nostri esperti che cercano in loco di combattere il virus, ma anche noi abbiamo il
dovere di informarci e soprattutto di agire impegnandoci attivamente in ambiti
specifici.
Abbiamo il compito di fare in modo che si mantenga “l’eccezionalità dell’AIDS
nella agenda politica” italiana ed europea e la reale volontà politica di combattere
il virus.
Si parla così tanto di AIDS che l’impressione che si potrebbe ricavare è che le
risorse destinate alla lotta contro la pandemia siano ingenti, addirittura
eccessive, ma purtroppo non è così.
Nel 2004 circa 273.000 persone sono morte a causa dello tsunami, la risposta da
parte della comunità internazionale ad un così devastante disastro naturale è
stata immediata: 10 miliardi di $ investiti nel post-tsunami, la stessa cifra era
stata stimata dalle Nazioni Unite come necessaria per il piano strategico di
ricostruzione del Sud-est asiatico.
Nello stesso anno i decessi per AIDS sono stati 14 volte quelli dovuti allo tsunami
e la previsione di UNAIDS circa le necessità finanziarie per combattere la
pandemia per il 2006-2007 è di circa 8 miliardi di $. E’ giusto quindi interrogarsi
su questioni etiche quali le motivazioni che hanno indotto la comunità
internazionale a rispondere in modo così diversa allo tsunami e all’AIDS e se
davvero esiste una rilevante differenza morale che possa giustificare le diverse
risposte.
L’eccezionalità dell’AIDS sembrava essere stata riconosciuta dalla comunità
internazionale nel 2001, quando è stato creato il Fondo Globale per la lotta
all’AIDS, tubercolosi e malaria, ma purtroppo non sono stati messi in piedi dei
sistemi come la creazione di fondi addizionali da parte dei donatori che
garantissero continuità ai programmi nel lungo termine.
Dobbiamo dunque impegnarci anche noi affinché le promesse fatte a livello
internazionali non restino inadempiute, ma dobbiamo anche impegnarci a fondo
nel monitorare la qualità di questi programmi e fare pressione affinché i fondi
raggiungano le comunità, altrimenti l’enorme divario esistente tra le
negoziazioni, i documenti e le dichiarazioni stipulate dalla comunità
internazionale da un lato e ciò che realmente accade sul campo dall’altro, rischia
di diventare sempre più incolmabile.
Alcuni paesi, tra cui la Francia, stanno sperimentando nuovi strumenti, quali ad
esempio la tassazione sui voli per trovare i fondi addizionali necessari per la lotta
all’HIV/AIDS. E’ compito della società civile italiana proporre soluzioni alternative
anche in Italia e monitorare il meccanismo di raccolta di queste risorse
provenienti da fonti diverse.
Dobbiamo dunque assumerci l’impegno di veicolare le istanze provenienti dal
basso e di tradurle in puntuali azioni di advocacy. A questo proposito vorrei citare
un esempio pratico discusso a Toronto relativo alla questione dei brevetti che
limitano la produzione di farmaci a basso costo.
La GlaxoSmithKline ha richiesto il brevetto sul Combivir, ovvero un farmaco nato
dalla combinazione di due farmaci da tempo conosciuti, AZT and 3TC che come
tali non sono più tutelati da brevetti, e una sostanza inattiva (tipo il diossido di
silicio, carbonato di calcio etc.) largamente utilizzati dall’industria farmaceutica.
Si tratta di un escamotage spesso usato e definito in gergo come un “evergreen”
ovvero un modo per estendere la durata del brevetto considerando nuovi,
farmaci che in realtà sono vecchi.
La società civile di India e Tailandia interessate a produrre i farmaci localmente si
sono attivate per spingere la Glaxo a rivedere la propria posizione.
Lo scorso marzo INP+ (Indian Network for People Living with HIV / AIDS) e MNP
Network of Positive People hanno avviato una campagna contro la Glaxo proprio
relativa al combivir. Nei primi giorni di agosto membri di associazioni di
sieropositivi tailandesi e indiani hanno organizzato dimostrazioni sotto le sedi
Glaxo rispettivamente di Bangkok e Bangalore. Il 9 agosto la Glaxo, in risposta
alla campagna condotta anche attraverso il coinvolgimento dei media, ha
annunciato che invierà una lettera aperta in cui annuncerà la revoca
dell’applicazione del brevetto in India e Tailandia. Quest’esempio mostra come
una generica proposta di boicottaggio o denuncia delle case farmaceutiche non
serva a nulla, ma al contrario di come sia importante il dialogo serrato con le
istituzioni: bisogna pensare ad azioni di advocacy mirate, fatte di richieste
puntuali, basate sull’evidenza e per le quali è necessario mettersi in rete e
sensibilizzare i media ed opinione pubblica.
Il prezzo dell’inazione politica è troppo alto da pagare: è questo il senso della
presentazione di Mark Heywood rappresentante di Treatment Action Campaign
and AIDS Law Project del Sud Africa. Una delle cose che è maggiormente
mancate a Toronto ha affermato è stata proprio la questione della leadership
politica. Senza una volontà politica non sarà possibile tradurre le scoperte
scientifiche che abbiamo sentito durante la conferenza in interventi di sanità
pubblica che potranno salvare milioni di vite umane.
Anch’io sono convinta che se anche un vaccino fosse oggi disponibile, questo non
necessariamente garantirebbe il successo alla lotta all’HIV/AIDS, altrimenti come
spiegarsi che in troppi paesi in via di sviluppo milioni di persone continuano a
morire di tubercolosi, nonostante la cura alla malattia esista.
Se è vero che “abbiamo i mezzi per combattere l’AIDS” e che “adesso è l’ora di
passare all’azione”, è nostro obbligo morale impegnarci affinché:
- siano fissati obiettivi precisi e realistici, basati sulle reali esigenze e sulle
possibili soluzioni individuate lavorando sul campo;
- si faccia pressione su tutti gli attori coinvolti nella lotta all’AIDS chiedendo
maggiore trasparenza nell’allocazione delle risorse e prove concrete dell’efficacia
del proprio intervento;
- si combatta la sistematica violazione dei diritti umani esercitata su tutte le
persone sieropositive a cui è negato l’accesso ai farmaci, nell’unico modo
possibile: impedendo che i privilegi di pochi continuino ad essere perseguiti a
discapito dell’interesse di molti.