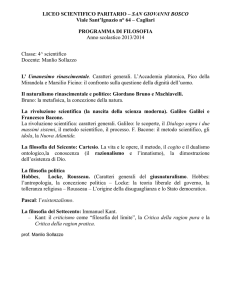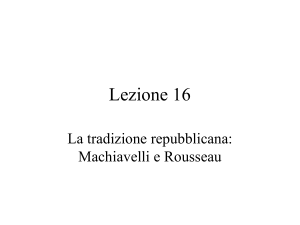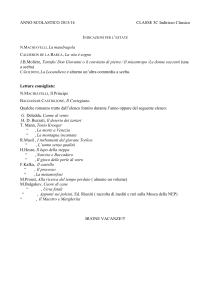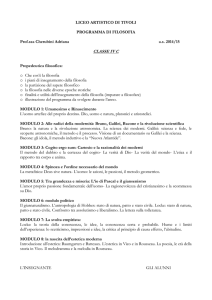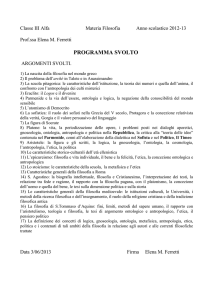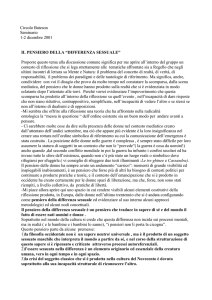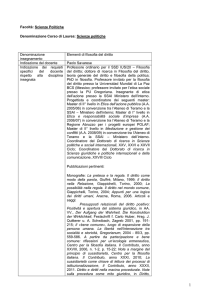ETICA, ONTOLOGIA, POLITICA:
LA NATURA UMANA E IL “DIO MORTALE”
(Roberto Gatti)
1. Premessa
Il filo conduttore di questo schema provvisorio di relazione consiste nella tesi che il tema del
rapporto tra ontologia, etica e politica consente di intercettare alcuni problemi cruciali della filosofia
politica moderna e di evidenziare altresì alcune interne tensioni e/o aporie che la caratterizzano.
Questa tesi è parte di un lavoro di ricerca più generale, in fase di svolgimento, il cui obiettivo è
mostrare la fragilità teoretica della ben nota idea schmittiana secondo cui solo con il moderno si
porrebbero le condizioni adeguate per l’intellegibilità del “politico”, la quale comporta
necessariamente, per Schmitt, il rigetto di ogni concezione idealistica dell’uomo e l’accettazione di
una visione «problematica» di esso, così come la troviamo emblematicamente consegnata nel
pensiero di Thomas Hobbes1.
Nel lavoro cui ho fatto riferimento si cerca di contestare questa idea mostrando come in alcuni
filosofi politici particolarmente significativi della modernità (tra i quali lo stesso Hobbes, Locke,
Rousseau, Kant) la intelligibilità filosofica del “politico” risulti tutt’altro che lineare e, anzi, approdi
-pur in modi e per strade diverse- ad uno scacco che consente con piena legittimità di definire la
modernità non come l’unico spazio storico entro il quale sarebbe possibile iniziare a pensare il
“politico” in modo coerente -individuandone per la prima volta le leggi proprie e la specifica
autonomia dalle altre sfere della convivenza-, ma anzi come un contesto segnato fondamentalmente
da una insuperata difficoltà di fondare il “politico” stesso2.
In questa relazione vorrei estrarre, per così dire, un segmento di questa ricerca, seguendolo fino
alle sue conseguenze ultime. Ciò con l’obiettivo non solo di far meglio risaltare i contorni delle
questioni sul tappeto, ma anche di sollecitare un confronto che (almeno così mi auguro) potrà
risultare tanto più serrato quanto più volutamente radicalizzate sono le conclusioni che cercherò di
argomentare.
E la conclusione principale risulta da quella che si potrebbe definire l’accettazione e al tempo
stesso il capovolgimento della convinzione di Hannah Arendt (che in parte ha offerto lo spunto per
la ricerca di cui ho detto), secondo la quale il moderno coincide con il tempo dell’impolitico o,
meglio, porta alle sue estreme conseguenze- raccogliendo e riformulando un’eredità che riceve da
Platone- la destrutturazione della politica come “azione comune basata sul discorso”. Tale modo di
vivere e concepire la politica caratterizzava, per la Arendt, l’esperienza pre-filosofica della polis,
C. Schmitt, Le categorie del “politico”, tr. it. a cura di G. Miglio-P. Schiera, Il Mulino, Bologna 2006.
Sia permesso rinviare a R. Gatti, Sul carattere impolitico del moderno: Hobbes, Locke, Rousseau, in Forme del bene
condiviso, a cura di Luigi Alici, Il Mulino, Bologna 2007.
1
2
1
quell’esperienza che declina quando la filosofia comincia a pretendere, con Platone, di far valere il
primato della Verità sull’agire, irrigidendo la ricchezza, la pluralità, l’imprevedibilità della prassi
entro l’imperialismo della theoria. Così -attraverso la riduzione della politica a mera attività
poietica- la filosofia di matrice platonica prepara anche le condizioni che porteranno all’avvento del
totalitarismo: «La separazione platonica di conoscere e fare è rimasta alla radice di tutte le teorie del
dominio che non siano mere giustificazioni di una irriducibile e irresponsabile volontà di potenza.
Mediante la pura forza della concettualizzazione e della chiarificazione filosofica, l’identificazione
platonica della conoscenza con il comando e il governo, e dell’azione con l’obbedienza e
l’esecuzione, dominò tutte le prime esperienze e distinzioni nell’ambito della sfera politica e
divenne vincolante per l’intera tradizione del pensiero politico»3. «Quanto duraturo sia stato il
successo del tentativo di trasformare l’agire in una modalità del ‘fare’ -continua la Arendt- è
agevolmente attestato dall’intera terminologia della teoria politica e del penseiro politico, che
rendono quasi impossibile discutere tali questioni senza usare la categoria dei mezzi e dei fini e
senza pensare in termini di strumentalità […]. La nostra è forse la prima generazione divenuta
pienamente consapevole delle conseguenze atroci che discendono da una linea di pensiero che
costringe ad ammettere che tutti i mezzi, purché siano efficaci, sono leciti e giustificati per
conseguire qualcosa definito come un fine»4.
La parte della lettura arendtiana che intendo assumere e proporre alla comune riflessione è
appunto quella che concerne il nesso tra la crisi della politica nella modernità e la genesi del
totalitarismo come una delle possibilità che tale crisi apre. La parte che intendo invece non
assumere concerne le radici profonde di questo processo.
Infatti per la Arendt la riflessione sulla politica, sulla sua crisi, sulle possibilità di una sua
rinascita entro le condizioni del mondo attuale, deve essere sganciata da ogni ipoteca ontologica e,
in particolare, da ogni riferimento all’idea di “natura umana” come fondamento della prassi 5. In
contrasto con questa posizione vorrei cercare di motivare invece la tesi che proprio il congedo variamente declinato nell’ambito della filosofia moderna- dalla categoria di “natura umana”
nell’accezione onto-teleologica che ha trovato la sua paradigmatica espressione in Aristotele
costituisce l’elemento determinante per intendere le aporie del “politico” moderno in quelle che
3
H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, tr. it. di S. Finzi, Introduzione di A. Dal Lago, Bompiani, Milano 1991 3,
p. 165.
4
Ivi, p. 168.
5
La Arendt definisce, in Vita activa, «insolubile» il «problema della natura umana», sia nel senso «psicologico
individuale», sia nel «senso filosofico generale»: «sarebbe come scavalcare la nostra ombra». Il punto cruciale della sua
argomentazione è la non oggettivabilità della natura propria di un essere, come l’uomo, a questo essere stesso. Se
possediamo «una natura o un’essenza, allora certamente soltanto un dio potrebbe conoscerla e definirla, e il primo
requisito sarebbe che egli fosse in grado di parlare di un ‘chi’ come se fosse un ‘che cosa’» (ivi, pp. 9-10).
2
sono da considerare alcune delle sue espressioni teoretiche più fortemente significative6. Inoltre
individuo qui il punto di avvio per giustificare l’ulteriore tesi che c’è almeno una linea, per nulla
secondaria e marginale, la quale consente di parlare di natura intrinsecamente totalitaria del
moderno, almeno per quanto concerne determinati suoi sviluppi (che poi non siano gli unici
sviluppi, ma possibilità storico-culturali da indagare ogni volta senza schemi preconcetti, è tanto
ovvio da non dover essere precisato, se non per forse esagerata precauzione).
Metodologicamente, questo abstract è strutturato a partire dalla convinzione che, quanto al tema
proposto, debbano procedere insieme il riferimento ad alcuni grandi classici della storia della
filosofia occidentale e la sintesi teoretica, che riguarda almeno due punti salienti, i quali possono
servire anche per articolare, se lo si ritiene opportuno, la discussione dell’abstract stesso:
a. Il primo potrebbe riguardare una valutazione della ricostruzione critica che viene qui di
seguito avanzata per quanto riguarda lo scacco cui va incontro, nella filosofia moderna, la
costituzione del “politico” inquadrata a partire dalla chiave interpretativa indicata nel titolo (“etica,
ontologia, politica”). E’ il punto che, anche in considerazione della linea di ricerca su cui sto
lavorando e quindi del campo tematico con il quale ho maggiore affinità, è stato maggiormente
approfondito nella relazione.
b. Il secondo potrebbe concernere la valutazione di alcune versioni salienti (anche se molto lungi
dall’essere esaustive) del rapporto tra i termini richiamati nel titolo colte in autori che mi sono parsi
degni di attenzione per il modo in cui hanno declinato questo rapporto nell’ambito della filosofia
contemporanea, cioè cercando di fare i conti in maniera non occasionale e marginale con il retaggio
del moderno così come l’ho sin qui stilizzato.
2. Il «futuro alle spalle»: i dilemmi della «genetica liberale»
Nel presentare il suo saggio Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer
liberalen Eugenik? (2001) Jürgen Habermas, dopo aver evidenziato che oggi «il fenomeno più
inquietante consiste nel venire meno del confine tra la natura che noi siamo e la dotazione organica
che noi ci diamo», suggerisce di impostare «l’attuale discussione sul bisogno di regolamentazione
dell’ingegneria genetica» a partire dalla domanda concernente il significato dell’ «indisponibilità
dei fondamenti genetici della nostra esistenza»7. Rifiutando la prospettiva che invita a pensare di
«moralizzare la natura umana» tornando a una «ri-sacralizzazione» di essa, invita a dirigere la
La multivocità semantica del termine “ontologia” induce subito a precisare che qui assumo appunto quale modello,
almeno in partenza, la concezione aristotelica e la svolgo in particolare in riferimento all’idea della natura umana come
essenza dotata intrinsecamente di un suo telos, che indica la raggiunta pienezza morale dell’uomo. In chiave politica
l’esplicitazione di questo concetto è notoriamente in La politica I, 2. Vedi comunque, per lo sviluppo di questo
concetto, infra.
7
J. Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, tr. it. di L Ceppa, Einaudi, Torino 2002,
p.25.
6
3
riflessione sui problemi della bioetica pensando la «‘moralizzazione’ della natura umana» come
«autoaffermazione di una certa auto comprensione etica del genere. Alludo -precisa- a quella
autocomprensione da cui dipende la possibilità di continuare a intenderci come gli autori indivisi
della nostra storia di vita, nonché di continuare a riconoscerci mutuamente come persone che
agiscono in maniera autonoma». Solo in questo modo il tentativo di porre un freno con mezzi
giuridici allo «strisciante affermarsi della genetica liberale […] sarebbe qualcosa di diverso
dall’espressione di una reazionaria resistenza antimodernistica». Infatti mirerebbe a sostenere in
maniera più ponderata l’autonomia del soggetto morale e sarebbe così del tutto coerente con il
mantenimento delle condizioni «proprie della autocomprensione pratica della modernità»8.
La reintroduzione di un apparato concettuale nel quale gioca un ruolo cruciale la categoria di
“natura umana” ha generato reazioni diverse, per lo più improntate a una notevole dose di
perplessità da parte dei rappresentanti di una tendenza che risulta certo molto variegata al suo
interno, ma che è ormai uniformemente attestata sull’idea che il congedo da questa categoria
costituisca e debba costituire un punto di non ritorno per una filosofia effettivamente critica.
Cosicché il senso dell’affermazione habermasiana secondo cui la modernità è chiamata, di fronte ai
problemi che si sono generati nel suo ambito, a riguadagnare una capacità autoriflessiva sovente
smarrita viene invertito nel suo senso: sarebbero insomma Habermas e quanti accolgono la sua
sollecitazione a rischiare di far cadere il potenziale emancipativo del moderno e ad avviarsi lungo
un ambiguo itinerario di ripensamento delle conquiste realizzate.
Si può prendere spunto dal dibattito sui problemi sollevati da Habermas e, in particolare, sul
riemergere di concetti, come quello di “natura umana” -da tempo classificato come decisamente
desueto e archiviato ormai come lascito di un venerando quanto antiquato apparato teorico- per
mettere alla prova un metodo di fare filosofia che implica il rifiuto di sganciare le questioni del
presente dal loro legame con la tradizione e che invece attesta la fecondità di ricollegare l’attualità
filosofica con quanto la tradizione ci tramanda. Instradarsi lungo questa via significa anche evitare
di pronunciare censure diventate spesso moneta corrente di una nuova forma di dogmatismo che dà
per scontato il carattere “superato” di importanti concetti e termini, senza più sentire il bisogno di
render ragione di tale conventio ad excludendum.
Ritengo sia giustificato sostenere che poco o nulla è dato comprendere della posta in gioco nel
dibattito richiamato se non si cerca di ricostruire, intorno al coro di proteste virulente e di
accettazioni entusiastiche suscitate via via dalle posizioni dell’ultimo Habermas, un filo adatto a
ritessere la continuità che lega alle loro spesso misconosciute origini le varie argomentazioni che si
contendono il consenso a proposito del rapporto tra natura, etica, politica, argomentazioni che
8
Ivi, p.28.
4
diventano particolarmente accese quando si affronta la questione dei «rischi di una genetica
liberale». Per dirlo in altro modo, rimane vero -usando i termini di Hannah Arendt- che almeno una
parte del nostro «futuro» ci sta sempre «alle spalle». Ma la consapevolezza di ciò pare scarsamente
diffusa nelle posizioni egemoni della filosofia politica attuale, incline a contrarre debiti
eccessivamente onerosi con i richiami dell’ “attualità”.
3. Natura umana e politica: un modello interpretativo
Il nesso che connette natura umana, etica e politica è vecchio quanto la vicenda della filosofia di
questa parte di mondo che chiamiamo Occidente; e quindi sarebbe uno sforzo presuntuoso e
destinato all’insuccesso cercare di tracciarne, in un così breve spazio, anche solo una concisa
mappa. Ciò non vuol dire però che sia impossibile tentare di intercettare, seguendo un metodo
fortemente selettivo (e quindi inevitabilmente carente), alcuni snodi cruciali che contraddistinguono
l’evolversi della riflessione filosofica intorno a questo problema. Ciò può essere fatto privilegiando
una linea di sviluppo che, pur da un’angolatura parziale, consente di focalizzare, per la sua
particolare radicalità quanto ai contenuti teoretici e all’impatto storico, un certo numero di
importanti problemi .
Alasdair MacIntyre fornisce, in questo percorso estremamente schematico, un punto di partenza
utile per impostare il discorso. Come egli scrive, lo «schema morale» che in forme e modi diversi
ha dominato gran parte del medioevo, fino a giungere alle soglie della modernità, è stato fornito da
Aristotele nell’Etica nicomachea ed ha una «struttura essenziale» che consente di interpretare anche
le questioni che sono oggetto di questo articolo. A fondamento dello schema aristotelico c’è un
«contrasto fondamentale fra l’uomo come è di fatto [..] e l’uomo come potrebbe essere se
realizzasse la sua natura essenziale». «Etica» indica quella scienza che «deve mettere gli uomini in
condizione di capire come effettuare il passaggio dal primo stato al secondo» e, così intesa, implica
«una qualche dottrina della potenza e dell’atto, una qualche dottrina dell’essenza dell’uomo e, in
primo luogo, una qualche dottrina del telos umano». La ragione ci insegna qual è il nostro fine e
come operare per realizzarlo, mentre i desideri e le emozioni vengono ordinate e indirizzate
mediante la formazione a quelle «abitudini di comportamento che l’etica prescrive»9.
Entro questo schema ciò che l’uomo può fare è riconducibile, in tutti i campi della sua attività
pratica, a un criterio che poggia su una concezione teleologica della natura e qui trova anche un
limite: il pericolo della hybris è evitabile se si tiene conto dei precetti etici desumibili dal telos
interno della natura dell’uomo. A questo proposito torna utile ricordare quanto osserva, tra gli altri,
Hans Jonas, e cioè che il termine «natura» designa in generale, per i Greci, quella dimensione del
9
A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, tr. it. di P. Capriolo, Feltrinelli, Milano 1988, p. 71.
5
«permanente» che argina le possibilità del «mutevole» edificabile dagli esseri umani. La
caratteristica di «immutabilità» attribuita alla natura ebbe tra le sue conseguenze che la filosofia
classica non considerò mai «l’incidenza sugli oggetti non umani […] un ambito di rilevanza etica»,
tale ambito essendo riservato ai rapporti diretti degli uomini tra di loro; e nessun greco pensò
neppure che «l’entità ‘uomo’» potesse essere considerata «nella sua essenza […] oggetto della
techne»10.
Das Prinzip Verantwortung (1979) di Jonas costituisce un testo emblematico per verificare la
consistenza (e i limiti) del progetto di recuperare una concezione teleologica della natura umana di
fronte ai problemi posti dall’evento assolutamente determinante che lo stesso Jonas individua nel
sopravvenire dell’idea, spesso tragicamente resa operativa dopo l’avvento della modernità, che la
natura, piuttosto che essere «immutabile», è invece «vulnerabile» attraverso la tecnica11. Non
interessa però qui il tentativo compiuto ne Il principio responsabilità, quanto saggiare per altra via
alcune implicazioni del nesso natura umana-etica-politica così come subentrano nel momento in cui
il paradigma classico comincia a perdere la sua influenza.
4. Un punto di partenza: Machiavelli
Un autore tanto importante quanto scarsamente considerato sotto questo profilo è Machiavelli. Si
potrebbe anzi arrivare a dire -mi pare senza eccedere- che, proprio leggendolo nella prospettiva dei
problemi che stiamo esaminando, il Segretario fiorentino offre elementi di portata filosofica
assolutamente rilevanti. E ciò avviene in un pensatore politico la cui appartenenza alla filosofia è da
sempre stata invece oggetto di dispute, molto spesso concluse, in modo non del tutto giustificato, a
sfavore di un’inclusione dell’autore del Principe e dei Discorsi sulla prima deca di Tito Livio tra i
filosofi politici degni di questo nome.
Machiavelli infatti traccia già, alle soglie della modernità, i due percorsi che condurranno alla
frattura con la precedente tradizione di matrice aristotelica, filtrata attraverso il fondamentale
apporto del pensiero di Tommaso e poi dell’Umanesimo. Pur essendo diversi, questi due percorsi
convivono -peraltro non senza contraddizioni- all’interno del suo pensiero12.
Il primo conduce alla radicale tecnicizzazione della politica e si basa sulla programmatica
esclusione di ogni intento normativo, riducendo così la riflessione sulle cose politiche ai
suggerimenti per conquistare e, soprattutto, per mantenere il potere. La dichiarazione più esplicita in
tale prospettiva è probabilmente quella contenuta nel §1 del cap. 15 de Il Principe: «sendo l’intento
H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, tr. it. di P. Rinaudo, a cura di P. P.Portinaro,
Einaudi, Torino 1979, p.8.
11
Ivi, p. 10 ss.
12
Riprendo qui, con numerose variazioni e integrazioni, alcuni spunti contenuti in R. Gatti, Filosofia politica, La
Scuola, Brescia 2007.
10
6
mio, scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare drieto alla verità
effettuale della cosa che alla immaginazione di essa […]; perché elli è tanto discosto da come si
vive a come di doverrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si doverrebbe
fare impara più presto la ruina che la preservazione sua»13.
Ma non è questa la via che vorrei seguire, in quanto l’altra, alla quale subito qui di seguito
accenno, mi pare molto più fertile nella prospettiva interpretativa che vorrei delineare. Infatti:
l’enfasi portata sulla «verità effettuale» in relazione alla politica e alla natura umana non è il
risultato di un gesto asettico. L’assumere, isolandolo, il “fatto” della natura dell’uomo come
originariamente acquisitiva14 e della politica come il luogo in cui questo “fatto” si manifesterebbe
attraverso la ricerca del potere da parte di chi ha volontà e doti per governare (oppure attraverso la
ricerca della protezione da parte di chi vuol godere semplicemente della sicurezza negli affari
privati15) implica l’introduzione di una frattura nel modello tripartito aristotelico così come
ricostruito da MacIntyre (la natura com’è, la natura come dovrebbe essere, i principi etici che
dovrebbero portare alla realizzazione di quest’ultima seguendone il finalismo interno). Infatti,
abbandonata ogni componente teleologica, resta solo in gioco, per quanto riguarda la concezione
dell’uomo, il primo termine, vale a dire la natura “com’è”. L’apparente neutralità dello sguardo
tipico dell’osservatore disincantato svela la sua componente per nulla neutrale, cioè l’inevitabile
opzione che lo sottende e che consiste nell’inchiodare l’immagine dell’essere umano ai suoi aspetti
servili, rendendoli gli unici aspetti che la caratterizzerebbero. Si delinea così un’antropologia
filosofica, pur non sistematicamente elaborata, che anticipa i tratti dell’homo homini lupus
hobbesiano e che fornisce l’orizzonte interpretativo necessario per comprendere il pensiero politico
machiavelliano. Essa caratterizza sia il Principe che i Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio,
quindi la teoria del «principato» non meno di quella della «repubblica»: «come ne è piena di
esempli ogni istoria, è necessario, a chi dispone una repubblica e ordina leggi in quella, presupporre
tutti gli uomini rei, e che li abbiano sempre a usare la malignità dello animo loro»16. La ragione è
che «la natura ha creato gli uomini in modo che possono desiderare ogni cosa e non possono
conseguire ogni cosa», da cui «nasce il variare della fortuna loro, perché, disiderando gli uomini
parte di avere più, parte temendo di non perdere lo acquistato, si viene alle inimicizie e alla
guerra»17. È il motivo per cui diventa del tutto plausibile la tesi secondo la quale «li òmini si
13
N. Machiavelli, Il Principe, a cura di M. Martelli, Corredo filologico di N. Marcelli, in Opere di Niccolò Machiavelli,
Ed. Salerno, Roma 2006, pp. 215-216.
14
Cfr. Ivi, p. 94.
15
Cfr. N. Machiavelli, Discorsi sulla prima deca di Tito Livio, a cura di F. Bausi, in Opere di Niccolò Machiavelli, cit.,
v.I/2, t. 1, p. 105.
16
Ivi, p. 30.
17
Ivi, p. 178.
7
debbono o vezzeggiare o spegnere»18. La politica sembra dover rimanere bloccata tra queste due
alternative, con ciò finendo per essere esclusa la via di una relazionalità sottratta alla paralizzante
forbice che si istituisce tra violenza e menzogna19.
C’è però da osservare che la preferenza, e anche la nostalgia, palesate ripetutamente da
Machiavelli nei Discorsi sulla prima deca di Tito Livio, per un governo «libero» e il suo
attaccamento ad esso -cioè a quella forma di reggimento politico di cui, a parere del Segretario
fiorentino, resta esempio paradigmatico la repubblica romana e rispetto al quale il «principato» è
solo uno strumento da attivare quando la «libertà» è stata travolta20- sono inconciliabili con questi
presupposti antropologici. Infatti il governo «libero» può essere costituito e mantenuto solo sulla
base dell’esercizio di quelle virtù che sembrano a tutti gli effetti impraticabili per uomini che
rispondano al resoconto machiavelliano. Machiavelli si sofferma ripetutamente sulla virtù degli
antichi romani, identificandola con il coraggio in guerra, con l’amore per la libertà, con
l’attaccamento al bene comune, con la capacità di curare allo stesso tempo i «privati e publici
commodi»21, con una pratica religiosa che non pone in conflitto, contrariamente a quanto accade nel
cristianesimo, il riferimento al divino e il successo mondano. Mancanza di corruzione, ostilità verso
l’ozio ed «equalità» sono altri fondamentali ingredienti dell’«antica bontà»22 e «la virtù che allora
regnava» viene contrapposta al «vizio che ora regna»23. I severi costumi erano fondamento della
conquiste militari, che dovettero meno alla «fortuna» di quanto abbiano dovuto alla «virtù»24.
Machiavelli definisce «meravigliosa cosa» sia la grandezza che si originò per Atene a seguito della
cacciata di Pisistrato, sia quella di Roma dopo che si fu liberata «da’suoi re»: «La ragione è facile a
intendere, perché non il bene particulare, ma il bene comune è quello che fa grande le città. E senza
dubio questo bene comune non è osservato se non nelle repubbliche»25. La virtù fa sì anche che si
possano «le ricchezze multiplicare in maggiore numero, e quelle che vengono dalla cultura e quelle
che vengono dalle arti», cioè dall’agricoltura e dalle attività artigianali26.
18
N. Machiavelli, Il Principe, cit., p. 79.
Si ricordi il libro XVII, cap. 2, del Principe: «perché delli òmini si può dire questo generalmente, che sieno ingrati,
volubili, simulatori, fuggitori de’ pericoli, cupidi di guadagno, e, mentre fai loro bene, sono tutti tua, òfferonti el sangue,
la roba, la vita, e’ figliuoli […], quando el bisogno è discosto, ma, quando ti si appressa, e’ si rivoltano. E quel principe
che si è tutto fondato in sulle parole loro, trovandosi nudo di altre preparazioni, rovina […]. E li òmini hanno meno
respetto ad offendere uno che si facci amare che uno che si facci temere, perché l’amore è tenuto da uno vinculo di
obligo, il quale, per essere li òmini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto, ma il timore è tenuto da una paura
di pena che non ti abbandona mai» (Il Principe, cit., p.228-231).
20
Sul punto mi limito a rinviare a G. Sasso, Niccolò Machiavelli. Storia del suo pensiero politico, Il Mulino, Bologna
1980, v.I, pp. 314 ss.
21
N. Machiavelli, Discorsi…, cit., p. 322.
22
Ivi, p. 263.
23
Ivi, p. 301.
24
Ivi, pp. 303-319.
25
Ivi, p. 313.
26
Ivi, p. 321.
19
8
Ci troviamo quindi di fronte, da un lato, alla permanenza di un catalogo di abiti virtuosi che
evidenzia un fondamentale aggancio con la tradizione classico-repubblicana e, dall’altro, a un
resoconto della natura umana che configge palesemente con i requisiti richiesti per la loro
realizzazione. Il debito teorico che così si crea è saldabile solo al prezzo di una brusca torsione che
viene fatta subire al rapporto tra natura umana e artificio politico: «gli uomini non operono mai
nulla bene se non per necessità; ma dove la elezione abonda, e che vi si può usare licenza, si
riempie subito ogni cosa di confusione e di disordine. Però si dice che la fame e la povertà fa gli
uomini industriosi, e le leggi gli fanno buoni»27. Il ruolo delle «leggi», dei «costumi», delle
«istituzioni» non è più quindi -a differenza di quanto accadeva nella tradizione aristotelica- di
rendere possibile che sia portato a compimento il fine interno dell’uomo, cioè la vita secondo
ragione e virtù. Diventa piuttosto quello di correggere, attraverso accorte strategie miranti a
utilizzare gli ineliminabili e dominanti moventi egoistici degli individui, gli effetti degli «appetiti
umani insaziabili»28. La forbice che si crea tra l’accettazione, da un lato, dell’immagine dell’uomo
come essere acquisitivo, egoistico, portato al conflitto, e la recezione, dall’altro, dei principi e delle
virtù su cui si basa la libertà repubblicana può essere chiusa -anche se con un’evidente
contraddizione interna- forzando e/o manipolando una natura i cui caratteri sono agli antipodi di ciò
che sarebbe da quei principi richiesto.
I riferimenti a tale strategia sono innumerevoli nei Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio29.
Machiavelli si sofferma, per esempio, sul ruolo delle pene e dei premi, rispettivamente per le cattive
e per le buone azioni pubbliche30; sottolinea con forza il ruolo delle leggi per tenere a freno «gli
appetiti»31; loda il ruolo dei censori32; sostiene che, a condizione di essere «regolato dalle leggi» e
«bene ordinato» da esse, un popolo può essere più savio e più costante di un principe33; insiste
infine sul ruolo dell’educazione che, nell’antica Roma, si ispirava a una religione la quale «non
beatificava se non uomini pieni di mondana gloria»34. A partire dall’«elezione del sito», cioè dalla
scelta del luogo ove edificare la Città, per arrivare all’«ordinazione delle leggi»35 nel loro
necessario e complesso rapporto con i «costumi», la politica diviene il problematico artificio
finalizzato a produrre libertà e virtù partendo da uomini «rei» e pronti in ogni momento «a usare la
malignità dello animo loro, qualunque volta ne abbiano libera occasione»36.
27
Ivi, p. 31.
Ivi, p. 300.
29
Cfr. ivi, p. 31; p. 110; pp. 112-113; pp. 132-135; pp. 234-236.
30
Cfr. Ivi, pp. 132-135.
31
Ivi, pp. 212-213.
32
Cfr. ivi, pp. 234-240.
33
Ivi, pp. 276-286.
34
Ivi, p. 318.
35
Ivi, p. 12.
36
Ivi, p. 30.
28
9
Il passaggio tra l’uomo qual è e l’uomo quale dovrebbe essere risulta attuabile, una volta negata
la teleologia interna della natura umana, solo attraverso un intervento esterno che conformi la natura
a dei fini morali palesemente controfattuali rispetto ai moventi che contraddistinguono le azioni di
ogni individuo. Allora si tratterà di agire su tali moventi, egoistici e acquisitivi, per utilizzarli in
modo che da essi si originino comportamenti che non sono virtuosi ma esteriormente conformi alla
virtù (è un altro degli aspetti del tema della politica come spazio dell’apparenza in Machiavelli).
Insistere su quest’ultimo punto non è privo di importanza. Infatti consente di sottolineare che
tutto quanto evidenziato sin qui non contrasta con l’affermazione, variamente formulata e
costantemente ripetuta da Machiavelli (basti rinviare al Proemio del libro I dei Discorsi), relativa
alla stabilità nel tempo de «li uomini», quella stabilità che dovrebbe permettere, ispirandosi alla
conoscenza della storia, di tentare l’«imitazione» degli «antiqui», indicati come «esempli» da
seguire, e purtroppo non seguiti. Contrasto, a mio avviso, non c’è perché questa stabilità va riferita,
come già accennato, ai moventi delle azioni, che però sono considerati come tali da poter essere
indirizzati secondo la volontà dei reggitori: ho riportato appena sopra alcuni esempi di questo modo
di agire auspicato da Machiavelli, un modo di agire che può ottenere, orientando sapientemente gli
«appetiti insaziabili» degli individui, condotte virtuose e altruistiche. Certo, l’accento posto su tale
elemento di relativa permanenza dell’agire umano mostra che in Machiavelli siamo ancora appena
agli esordi di una posizione di pensiero destinata a sviluppi ben più radicali. Ma ciò non toglie
l’importanza cruciale che l’autore dei Discorsi ricopre in questo percorso interno alla filosofia
politica moderna.
In sintesi, si può quindi sostenere che la fragilità dell’ideale repubblicano di Machiavelli sta nella
dicotomia che si viene a creare tra l’accoglimento degli ideali morali presenti nella tradizione
classica e la cancellazione dello sfondo antropologico che in quella tradizione li rendeva
giustificabili. Se il «principato» può accontentarsi di tenere gli uomini «frenati» attraverso la
«podestà» dello «stato regio», la «repubblica» o «stato popolare» deve invece predisporre
«ordinamenti» in grado di preservarli -una volta che siano stati opportunamente «corretti»- dagli
effetti indesiderabili delle inclinazioni (Discorsi)37 che li portano generalmente a essere «più proni
al male che al bene»38. Sicuramente così non si arriverà mai a formare individui intrinsecamente
buoni e virtuosi, ma al massimo esseri che agiscono in foro esterno come se fossero virtuosi: è la
metamorfosi che subisce, e non può non subire date le premesse antropologiche, l’ideale aristotelico
37
Cfr. Ivi, p. 117.
Ivi, p. 64. Cfr. L. Strauss, Pensieri su Machiavelli (1958), tr. it. di G. De Stefano, Giuffrè, Milano 1970 (specie cap.
IV).
38
10
della educazione alla buona vita39. Ed è anche una delle versioni che assume nella filosofia politica
moderna la separazione tra “interno” ed “esterno”, tra “coscienza” e “politica”.
Si può aggiungere un’ulteriore considerazione. In realtà principato e repubblica, al di là delle
loro ovvie differenze e prescindendo anche dalle circostanze storiche che possono rendere
preferibile il primo rispetto alla seconda (o viceversa), hanno in comune la scissione, già
chiaramente presente in Machiavelli e che verrà poi sistematizzata a livello filosofico da Hobbes,
tra natura e politica: mentre la prima dispone gli uomini al conflitto e all’insocievolezza, la seconda
deve creare le condizioni per un ordine che, dopo l’abbandono dell’idea dell’uomo come zoon
politikon (o, nella versione tomistica, animal sociale et politicum), non può che essere un ordine
artificiale, cioè un ordine “creato” e non “dato”.
Ciò che però è diverso in Hobbes e Machiavelli è il modo di affrontare e di risolvere questa
scissione. L’aspetto cruciale, in questo senso, è che in Machiavelli la stessa natura umana finisce
per essere intesa come insieme di proprietà sul quale, almeno fino a un certo punto e in una certa
misura, si può operare: il confine tra natura e arte si fa sottile, tende a essere sempre più incerto,
apre possibilità di manipolazione inedite; insomma la natura si presta appunto, con mani adatte, ad
essere «corretta», per usare il lessico machiavelliano.
Qui mi pare il punto su cui vale la pena di attirare l’attenzione. Machiavelli non elabora una
concezione sistematica della scienza politica, ma prefigura, sulla scorta di una rilettura critica ed
originale della tradizione classica e umanistica, una “tecnica”, un’arte della “prudenza” indirizzata
ad operare accortamente sui moventi che spingono l’uomo ad agire. Ciò nella convinzione che tali
moventi possono essere indirizzati verso i fini voluti dal legislatore e dai governanti, senza altro
limite che non sia quello della volontà dei detentori del potere. In tal modo inaugura un modo di
intendere il rapporto tra natura umana- scienza/tecnica - politica che avrà grande influenza in
alcune correnti e versioni della filosofia politica moderna. La scienza e la tecnica divengono gli
strumenti per manipolare una natura umana i cui confini si fanno sempre più nebulosi e incerti, fino
a scomparire del tutto e a fondersi con il “costume” e l’ “abitudine”.
Su questo aspetto e, in particolare, sul rapporto Machiavelli-Hobbes vorrei aggiungere comunque
qualche sintetica annotazione più avanti.
5. Un primo approdo: l’Illuminismo e l’onnipotenza dell’artificio
Non c’è modo in questo abstract di rendere ragione, scendendo nei particolari e prendendo in
esame tutti gli autori più significativi che sarebbe necessario considerare, degli sviluppi di tale
posizione di pensiero. Ci si deve limitare a indicare come, impostando così il rapporto tra natura
39
Cfr. Aristotele, Politica, tr. it. a cura di L. Laurenti, in Opere, v. IX, Laterza, Roma-Bari 1983, p. 249 (1332 a).
11
umana e politica, Machiavelli anticipi, tra l’altro, alcune tendenze tanto essenziali quanto poco
studiate del tardo illuminismo. L’idea dell’onnipotenza dell’artificio umano rispetto alla natura è,
già nel Segretario fiorentino, un’anticipazione illuministica o, per dir meglio, di alcune espressioni
dell’illuminismo; sotto questo profilo, passa in secondo piano tutto quanto distingue gli autori e i
contesti culturali che qui saranno pur brevemente esaminati.
Risulta istruttivo, in questa prospettiva, prenderne come esempio uno, certamente di primaria
importanza, cioè Claude-Adrien Helvétius. Recuperando una nota idea pascaliana, Helvétius
sostiene che la «natura» altro non è se non «abitudine»40; l’uomo è necessitato ad essere com’è
dall’ambiente che lo circonda, nel quale vanno compresi aspetti quali i fattori fisico-naturali,
l’educazione, la situazione sociale, le istituzioni politiche, le leggi, le forme di governo 41. In realtà il
comportamento virtuoso o vizioso non dipende da fattori innati e non costituisce l’espressione di un
finalismo interno della natura umana, ma è la conseguenza diretta delle condizioni fisiche, sociali,
economiche e soprattutto politiche in cui gli individui si vengono a trovare 42. In questo senso
l’adeguamento dei cittadini ai principi dell’«utilità pubblica» dipende esclusivamente dal tipo di
condizionamento cui sono sottoposti ad opera dei governanti e dall’indirizzo che il «legislatore»
riesce a dare alle passioni, sfruttandole sapientemente ai fini di essa. Scrive Helvétius: «sono le
passioni [...] che formano gli uomini. Gli studiosi di morale dovrebbero percepirlo e sapere che,
simile allo scultore il quale da un tronco d’albero foggia un dio o una semplice panca, il legislatore
forma a suo piacimento degli eroi, dei geni, e della gente virtuosa». È per questo che «tutto
l’impegno degli studiosi di morale consiste nel determinare l’uso che bisognerebbe fare delle
ricompense e delle punizioni, e i vantaggi che se ne potrebbero trarre per legare l’interesse
personale all’interesse generale [...]. Se i cittadini non potessero perseguire la loro felicità
particolare senza realizzare allo stesso tempo il bene pubblico, i soli malvagi resterebbero gli
insensati»43. L’esempio dell’antica repubblica romana continua, anche in Helvétius, ad avere valore
paradigmatico44: dimostra che è possibile riuscire a legare l’interesse personale a quello della
collettività, tanto da far sì che gli uomini siano «necessitati alla virtù». Ciò si può realizzare
attraverso un’attenta utilizzazione di leggi premiali e punitive, nonché mediante un accorto ricorso
C. A. Helvétius, De l’esprit (1758), in Id., Oeuvres complètes, Georg Olms, Hildesheim 1969 (rist. anast. dell’ed.
1795), v. III, pp. 121; 137-140; cfr. anche, sempre di Helvétius, De l’homme (1773, postumo), ivi, v. VII, p. 228.
41
Cfr. C. A. Helvétius , De l’homme, v. VII, pp. 216-233.
42
Cfr. C. A. Helvétius , De l’esprit, v. II, pp. 161-184 e pp. 236-251; v. III, pp. 87-99 e pp. 113-142; C. A. Helvétius ,
De l’homme, v. IX, pp. 14-; v. X, pp. 148-153; v. XI, pp. 131-160.
43
C. A. Helvétius , De L’esprit, v. III, pp. 96-97.
44
L’ideale di una repubblica di piccoli proprietari terrieri caratterizza De l’esprit, mentre nel postumo De l’homme la
preferenza va verso una forma di monarchia illuminata. Ma è una differenza che non incide a fondo su quanto in questo
articolo cerco succintamente di argomentare.
40
12
alla distribuzione di onori e privilegi da parte dallo Stato, uniti a un’educazione civile che deve
imprimere nei cittadini il principio del valore essenziale del «benessere pubblico».45.
La conseguenza in termini politici che si trae da quanto sin qui detto è che l’uomo risulta
modellabile all’infinito, purché si individuino i mezzi idonei ad ottenere i comportamenti
desiderabili dal punto di vista di una legislazione razionale suggerita dalla philosophie e tradotta in
pratica da un saggio reggitore. Lo strumento fondamentale è l’impiego dell’interesse personale, il
cui perseguimento non è frutto di una scelta, ma la manifestazione di un determinismo innato. In
quanto espressione di una necessità physique, è di per sé moralmente neutro, ma può diventare il
movente di azioni utili alla società nella misura in cui venga adeguatamente indirizzato, guidato e
manipolato.
Il modello di scienza che orienta il pensiero di Helvétius è sostanzialmente diverso dall’arte della
prudenza di Machiavelli. Tra le propaggini estreme dell’illuminismo, rappresentate da Helvétius e
da D’Holbach, e l’autore de Il Principe c’è infatti il pieno sviluppo della rivoluzione scientifica e
soprattutto c’è l’essenziale mediazione operata dalla «filosofia civile» di Hobbes, cioè il grande
tentativo di edificare una scienza politica esemplata sul paradigma della geometria e, quindi,
almeno nelle intenzioni, incontrovertibile: c’è insomma il giusnaturalismo moderno che, come è
stato correttamente evidenziato, trova la sua unità non tanto nei contenuti ma nel metodo, quello
appunto della scientia more geometrico demonstrata e applicata alla morale, al diritto e alla
politica46.
Eppure, se l’assunzione di questo modello di sapere scientifico e il materialismo meccanicistico
costituiscono dei legami evidenti con Hobbes, è difficile non cogliere o sottovalutare la differenza
essenziale. In Hobbes -che qui assumo come autore di riferimento tipico, non potendo neppure
accennare alle articolazioni e diversificazioni interne del diritto naturale moderno- la scienza
politica ha ancora a che fare con una natura umana dotata di proprietà che vengono concepite quali
condizioni intrascendibili per l’intelligibilità filosofica e per la costituzione stessa della Civitas. Il
fine è contenere gli effetti distruttivi delle passioni mediante il «timore della spada» esercitato da un
sovrano i cui diritti si estendono -come notoriamente Hobbes sottolinea nel cap. 18 del Leviathanfino al controllo preventivo degli scritti che i sudditi possono o non possono leggere, visto che dalle
opinioni che si formano leggendoli dipendono poi le loro azioni47. Ma, malgrado l’entità dei poteri
Cfr., per esempio, oltre i luoghi già ricordati, C. A. Helvétius, De l’esprit, cit., v. XI, pp. 131-136; pp. 155-159; pp.
139-146.
46
Cfr. N. Bobbio, Il giusnaturalismo, in Storia delle idee politiche, economiche, sociali, a cura di L. Firpo, UTET,
Torino, t.IV, v.1, 1980, pp.498-503.
47
T. Hobbes, Leviatano, tr. it. di A. Lupoli-M.V. Predaval-R. Rebecchi, a cura di A. Pacchi, Laterza, Roma-Bari 20017,
p.149.
45
13
che, sempre in questo capitolo, attribuisce al sovrano48, Hobbes non ha mai pensato alla scienza
politica come strumento per correggere la natura umana nel senso machiavelliano. E il perché è
evidente: pur rigettando la concezione aristotelica dell’uomo, egli mantiene infatti ferma l’idea che
una natura, in quanto tale, non si cambia, se è veramente tale.
È del tutto superfluo rammentare l’abissale distanza che separa la concezione teleologica della
natura umana di Aristotele dalla concezione materialistico-meccanicistica hobbesiana; pur
fondamentale, tale distanza non annulla però ciò che giustifica il fatto di collocarli dalla stessa parte
e di opporli alla linea di pensiero che va da Machiavelli a quelle versioni dell’illuminismo di cui
Helvétius è rappresentante emblematico (ma sulla stessa linea è D’Holbach, ed è anche Morelly, cui
accennerò più avanti).
Infatti, pur partendo da un impianto teoretico che è radicalmente diverso nei due casi, resta il
fatto che sia per Aristotele che per Hobbes la natura umana rappresenta, con i suoi caratteri e le sue
proprietà stabili ed invariabili, un dato immutabile e anche un limite di cui la riflessione filosofica e
l’azione politica non possono fare a meno di tener conto. Questo vale se consideriamo,
aristotelicamente, la natura umana in un’ottica finalistica chiaramente connotata in senso
ontologico, in modo che -per riprendere il lessico di MacIntyre- i «precetti etici» si configurano
come l’espressione dell’interna normatività della natura stessa e sono eseguibili previa adeguata
formazione del carattere e disciplina dei desideri; in questo contesto interpretativo la polis, il cui
scopo precipuo è proprio il perseguimento di tale formazione e di tale disciplina, costituisce lo
spazio che consente la massima realizzazione delle potenzialità umane nell’ambito della vita
pratica; è il luogo, per definizione, dell’eccellenza morale.
Ma vale anche se invertiamo lo schema nel modo in cui avviene in Hobbes: egli infrange, lo si è
già succintamente osservato più sopra, la continuità tra natura e politica tipica del modello
aristotelico e, offrendo un resoconto dell’uomo come essere per natura strutturalmente egoistico,
competitivo, conflittuale, deve pensare la politica come l’artificio che consente di creare mediante
un patto -quindi via convenzione- un ordine dotato della massima stabilità possibile, risolvendo così
il disordine della «condizione naturale dell’umanità» alla cui illustrazione è dedicato il cap. XIII del
Leviathan. Nell’opposizione che li separa quanto al modo di concepire la relazione tra natura e
politica, Aristotele e Hobbes non arriverebbero mai a congetturare -pur per diversi ed anche
profondamente divergenti ragioni- che il dato naturale sia passibile di manipolazione, cioè sia
plasmabile nelle sue connotazioni costitutive: diventi insomma una non-natura, una tabula rasa su
cui il filosofo e il legislatore possono operare senza limiti mediante l’arte dell’ «imitazione» che
trae i suoi ammaestramenti dalla storia o partendo dagli insegnamenti della science politique resa
48
Ivi, pp.145-154.
14
edotta dagli insegnamenti dei «grands physiciens» che hanno scoperto l’identità delle leggi
dell’universo fisico-materiale e di quello umano49. La posizione di pensiero che Machiavelli
comincia ad introdurre nella modernità oppone, alla paideia aristotelica e alla onnipervadente
vigilanza del sovrano hobbesiano, il progetto, ben altrimenti ambizioso, della “correzione della
natura”.
Nei Discorsi sulla prima deca di Tito Livio questa è l’unica premessa che permette di realizzare
l’ideale repubblicano in un autore che conserva la sua adesione agli ideali della virtù pubblica in
senso classico, ma fa propria una concezione dell’uomo controfattuale rispetto a quegli ideali. Mi
pare si possa trovare qui -detto per inciso e senza poter affrontare ovviamente in modo diretto e
compiuto il dibattito su questo tema- il vero e proprio punto di frattura tra il repubblicanesimo di
Machiavelli e quello di matrice aristotelica, quindi anche il motivo per cui non è filosoficamente
corretto il loro accostamento: non lo è per la tensione che si introduce, in modo particolarmente
evidente nei Discorsi, tra dimensione antropologica e dimensione morale. Il valore filosofico a mio
avviso rilevante di Machiavelli sta appunto nel fatto che, per eliminare tale tensione, egli deve
attribuire all’arte politica -alla politica non come semplice tecnica del potere, ma come tecnica del
dominio sulla natura umana- un compito che, in questo caso sì, diventa veramente prometeico e che
autorizza il richiamo ai versi dell’Antigone con cui Jonas apre il suo Principio responsabilità:
«Molte ha la vita forze
tremende; eppure più dell’uomo nulla,
vedi, è tremendo […].
Con ingegno che supera
sempre l’immaginabile, ad ogni arte
vigile, industre,
egli si volge al male
ora, ora al bene. Se le leggi osserva
C. A. Helvétius, De l’esprit, cit., v. III, p. 95. Se manteniamo sullo sfondo le categorie suggerite nel titolo di questo
abstract (ontologia, etica, politica), è evidente che, per quei filosofi politici della modernità che conservano un concetto
vincolante di “natura umana” (ed è chiaro che qui l’ambito di riferimento privilegiato è costituito dal giusnaturalismo
tra ‘600 e ‘700), il problema che si pone è diverso da quello cui ci troviamo di fronte esaminando quell’indirizzo, per
quanto variegato, che è al centro dello schema interpretativo proposto in queste pagine. Nel giusnaturalismo moderno la
relazione tra natura umana, etica e politica diventa infatti dilemmatica in virtù della circostanza per cui la frattura
rispetto alla tradizione aristotelico-tomistica (si pensi a un autore emblematico come Hobbes) non avviene passando per
il rigetto della categoria “natura umana”, ma assumendo questa categoria in una prospettiva che sostituisce al
fondamento onto-teleologico tradizionale un fondamento empiristico e pretende di dedurne more geometrico, cioè
secondo il modello della ragione scientifica moderna, le caratteristiche del giusto ordine politico. A questa deduzione,
che è deduzione del valore dal fatto nella sua determinazione meramente empirica, è perfettamente applicabile la critica
humeana (Trattato sulla natura umana, tr it. di A. Carlini, E. Lecaldano, E. Mistretta, Laterza, Roma-Bari 20026, Libro
III, pp. 480-503), che denuncia la fallacia del collegamento del dover essere dall’essere e che deve essere assunta come
la sconfessione definitiva del modello giusnaturalistico moderno. Ma applicabile questa critica non è se si parte da un
diverso concetto di natura, com’è appunto quello di matrice aristotelica, in cui la natura è già di sé dotata di una
normatività interma, ciò che non rende per nulla arbitrario e fallace il passaggio dalla natura al valore.
49
15
della sua terra e la fede giurata
agli dèi di sua gente, sé con la patria esalta;
un senza-patria
è chi s’accosta, per sua folle audacia, al male»50.
Hobbes, al confronto, è lontano dal tremendum (deinos), nell’accezione che possiamo mutuare
da Sofocle, e mantiene nella sua «filosofia civile» un senso del limite e della misura incomparabili
rispetto a Machiavelli51, in cui il potere assume un volto «demoniaco» non tanto e non solo per i
motivi che espone Gerard Ritter nel suo notissimo libro52, ma per il fondamentale obiettivo di
opporsi alla tradizione cristiana in un senso del tutto diverso da quello che Ritter intende53, cioè
mettendo in campo il progetto di ri-creare l’uomo secondo un modello di virtù che implica, da un
lato, il prendere l’uomo com’è e, dall’altro, di sottoporlo a un processo non di formazione nel senso
della paideia classica, ma di riplasmazione radicale che mira a fare dell’uomo quello che dovrebbe
essere, e che per natura non è .
6. Figure rivelative: il “legislatore”
Non può essere considerato un caso il riapparire, in alcune concezioni politiche cruciali
nell’ambito della modernità, proprio a partire da Machiavelli, della figura del «legislatore», che
aveva svolto una funzione importantissima nella filosofia politica classica.
Il punto, peraltro, non è semplicemente registrare il ritorno di tale figura, quanto piuttosto
sottolineare il mutamento radicale che investe il suo significato. Forse in questo caso l’autore che a
buon diritto può essere considerato emblematico, rimanendo ancora nell’ambito dell’illuminismo, è
Rousseau.
Fin dall’inizio del libro I del Contratto sociale viene posta l’essenziale premessa secondo cui è
necessario «prendere gli uomini come sono», cioè certamente capaci di ragione, ma anche passibili
di cadere preda delle passioni, come lo stesso Rousseau mostra a proposito della storia della specie
(Discours sur l’inégalité) e del laborioso processo di sviluppo dell’individuo singolo (Emile). Di
conseguenza va dato conto di come si possa ottenere da esseri fragili e fallibili l’adeguazione alla
Riprendo la tr. it. di G. Lombardo Radice, che è quella usata nell’ed. italiana del testo di Jonas (p.5)
Le letture in chiave liberale di Hobbes hanno forse troppo poco tenuto conto di questo aspetto, il quale invece
costituisce uno dei fattori di vicinanza maggiormente significativi tra Hobbes e il liberalismo; nelle varie teorie liberali
infatti, indipendentemente dalle differenze talora molto profonde che le connotano, è rinvenibile un’esemplare
tematizzazione dei limiti della politica.
52
Il «demoniaco» in Machiavelli si identifica, per Ritter, nel collocare per la prima volta, con estrema e radicale
consequenzialità, la «norma morale» nella prospettiva del «mero opportunismo» (Il volto demoniaco del potere, tr. it. di
E. Melandri, Il Mulino, Bologna 1971 3, p.16) e nell’indicare l’ «essenza della politica» nella «guerra totale che
assoggetta al rapporto amico-nemico ogni rispetto morale ed umano» (p.33, ma cfr. anche p.38).
53
L’opposizione, per Ritter, consisterebbe, in sostanza, nel rigetto del «diritto naturale cristiano», in cui vengono a
sintesi le «idee cristiane» (in cui peraltro la possibilità di «perdizione satanica» in cui incorre chi esercita il potere è ben
presente e già oscura in parte il quadro morale-razionale della classicità) e la «tarda filosofia antica» (ivi, p.23).
50
51
16
«volontà generale», la quale costituisce un «puro atto dell’intelligenza che ragiona, nel silenzio
delle passioni, su ciò che l’uomo può esigere dal suo simile e su ciò che il suo simile ha diritto di
esigere da lui»54. È evidente che, a tal fine, il contratto -cioè lo strumento essenziale al quale tutta la
tradizione giusnaturalistica moderna si rivolge (e si arresta) per dar conto della giustificazione
razionale e della costituzione dell’ordine politico- non può essere lo strumento idoneo.
Ricorrendo ad esso si può ottenere al massimo, come Rousseau argomenta, un «interesse» da
parte di ogni cittadino ad essere «giusto». Infatti, venendosi a costituire per effetto del patto un
«corpo» formato «solo dai singoli che lo compongono» (cioè l’assemblea sovrana in cui l’esercizio
della sovranità spetta al «popolo»), ne deriva che questo «tutto» (tout) non può avere «interessi
contrari» a quelli degli individui che ne sono parte, perché «è impossibile che il corpo voglia
nuocere a tutti i suoi membri». Inoltre, dato che il primo requisito della legge è la sua universalità per cui ognuno è sottoposto alle leggi che delibera riguardo a tutti gli altri-, «non può nuocere ad
alcuno di essi in particolare» senza nuocere a tutti55. Insomma, ciascuno ha interesse a deliberare
secondo giustizia poiché sa che sarà sottoposto alle leggi emanate dall’assemblea sovrana di cui egli
è membro. Ma -a parte i molti altri problemi che potrebbero essere sollevati in merito a questo
apparentemente persuasivo funzionamento del meccanismo a specchio della sovranità56- basti qui
osservare che lo stesso Rousseau riconosce come l’«interesse», da solo, sia un movente quanto mai
debole per l’obbligo politico57. D’altra parte, la giustizia perseguita per interesse significherebbe il
fallimento della società politica rispetto al suo obiettivo essenziale, che nel cap. 8 del libro I è
identificato con la realizzazione della «liberté morale».
È a questo punto che, quasi a segnare un nuovo e non poco problematico incipit del Contrat
social viene introdotta, nel capitolo 7 del libro II, la figura del «legislatore». Il suo ruolo è chiaro:
non deve solo «scoprire […] le migliori regole della società che convengono alle Nazioni»
(insomma fungere da potere costituente, compito per il quale il popolo al momento della sua nascita
non possiede sufficienti «lumi»), ma soprattutto deve riuscire a dénaturer gli uomini, cioè a formare
l’«homme civil». Questi, diversamente dall’«homme naturel», si comporta -secondo quanto
Rousseau scrive nell’Emile- non come «intero assoluto», ma come «unità frazionaria che dipende
dal denominatore e il cui valore sta nel suo rapporto con il tutto, che è il corpo sociale»58. La
corrispondenza tra l’Emile e il Contrat è in questo caso quasi letterale: «Colui che osa tentare
54
J.-J- Rousseau, Manuscrit de Genève, in Oeuvres complètes, a cura di B. Gagnebin-M. Raymond, Gallimard, Paris,
1959-1995, v. III, p.286.
55
J.-J. Rousseau, Du contrat social, in Oeuvres complètes, cit., v. III, pp. 362-363 e pp. 373-375; Cfr. anche la sintesi
in Emile, in Oeuvres complètes , v.IV, p.841.
56
Vedi le note di commento alla tr. it. del Contratto sociale, a cura di R. Gatti, Rizzoli, Milano 2005. Rinvio anche a
R.Gatti, L’enigma del male. Un’interpretazione di Rousseau, Studium, Roma 1997, pp.197-198, 215-220, 260-268.
57
Cfr, per esempio, J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie politique, in Oeuvres complètes, cit., v.III, pp.247-262;
Emile (Libro IV), in Oeuvres complètes , v.IV, pp.595ss, specie p.599.
58
J.-J. Rousseau, Emile, cit., p.249.
17
l’impresa di dare istituzioni a un popolo deve sentirsi in grado […] di trasformare ogni individuo
[corsivo mio] nella parte di un più grande tutto, da cui questo individuo riceva in qualche modo la
sua vita e il suo essere […]; di sostituire un’esistenza relazionale e morale a quella fisica e
indipendente che noi tutti abbiamo ricevuto dalla natura»59. Gli strumenti per realizzare questo
immane ma ineludibile obiettivo -in primo luogo i «costumi» (moeurs), l’educazione pubblica, le
leggi,
l’«amore per la patria»- richiamano palesemente il Machiavelli “repubblicano” e sono
esaminati da Rousseau in molti dei suoi scritti politici, a partire dal Discours sur l’économie
politique60 per finire con le Considérations sur le Gouvernement de Pologne61. Nel Contrat social si
trova invece solo un accenno a tale tema, là dove, dopo aver distinto, nel cap. 12 del libro II, i vari
tipi di leggi («politiche», «civili», «penali»), Rousseau aggiunge: «A questi tre tipi di leggi se ne
aggiunge un quarto, il più importante di tutti, che non si incide né nel marmo, né nel bronzo, bensì
nel cuore dei cittadini» e che «conserva un popolo nello spirito delle sue istituzioni e sostituisce in
maniera impercettibile la forza dell'abitudine a quella dell'autorità. Parlo dei costumi, delle
consuetudini e soprattutto dell'opinione, parte sconosciuta ai nostri politici, ma dalla quale dipende
il successo di tutte le altre»62.
Solo la difficile e lunga formazione dello «spirito pubblico» -iniziata dal «legislatore» ma che
sarà poi compito dei «magistrati» addetti a questo compito di condurre innanzi nella vita ordinaria
della società politica una volta superato la stato nascente- consente di chiudere il cerchio della
teoria repubblicana di Rousseau, che così mostra la sua continuità con quella di Machiavelli. Leggi,
costumi, ordinamenti, istituzioni, non sono mezzi per portare a compimento il fine interno della
natura umana, ma per piegare quest’ultima a un ideale di virtù civile che, in base alla sua
costituzione originaria, nessun uomo potrebbe mai realizzare. Anche in Rousseau -sebbene
nell’ambito di una concezione dell’uomo molto più articolata (e non certo priva di aporie) di quanto
non fosse quella di Machiavelli63- la scienza della legislazione fuoriesce dai suoi confini giuridicopolitici per investire il piano antropologico e diventa l’arte, quasi divina64, di dénaturer l’uomo,
cioè di sottrarlo alla sua natura originaria per conferirgliene un’altra che sia conforme alle esigenze
della virtù. Il rapporto tra antropologia ed etica è invertito rispetto al modello aristotelico: i principi
morali non sono più quelle azioni che conformano pratiche di vita nelle quali l’uomo raggiunge il
suo telos, ma diventano dei presupposti a cui è la natura a dover essere adeguata.
59
J.-J. Rousseau, Du contrat social, cit., pp.381-382.
Cfr. J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie politique, cit., pp.251-262
61
Cfr. J.-J. Rousseau, Considérations sur le Gouvernement de Pologne, in Oeuvres complètes, v.III, pp.956-971.
62
J.-J. Rousseau, Du contrat social, cit., p.394. Cfr. anche libro IV, cap.7.
63
Sia consentito rinviare, oltre che a R. Gatti, L’enigma del male, cit., anche a Id., Introduzione a J.-J. Rousseau, Il
contratto sociale, tr. it. cit.; inoltre Id., “L’impronta di ciò che è umano”. Saggi di filosofia, PLUS, Pisa 2006, cap.II
(consultabile anche in http://bfp.sp.unipi.it/hj05b/?viewPage=4); infine Id., Sul carattere impolitico del moderno:
Hobbes, Locke, Rousseau, in Forme del bene condiviso,cit.).
64
«Occorrerebbero degli Dei per dare leggi agli uomini» (J.-J. Rousseau, Du contrat social, cit., p.381).
60
18
L’alleanza tra etica, politica e scienza, cioè il punto focale del progetto illuministico, realizza
appunto tale obiettivo, ma lo realizza -da Rousseau a Hélvetius a D’Holbach a Morelly- in una
forma che dell’illuminismo propriamente inteso distorce il significato: la scienza non si unisce
all’etica e alla politica per un’opera di rischiaramento, quindi di abbattimento dei dogmi e di uscita
dell’uomo dalla minorità -secondo l’accezione cui Kant darà sistemazione sintetica in
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784)-, bensì per una finalità di cui, non del tutto a
torto, è stata denunciata l’essenza «totalitaria»65.
7. Un secondo approdo: Marx e la natura come storia
Il materialismo storico di Marx ed Engels, se per un verso si differenzia dal materialismo
illuministico, per l’altro porta alle estreme conseguenze, muovendo da un’interpretazione non più su
base naturalistica ma storico-sociale del materialismo, l’idea dell’uomo come «esistenza storica»66,
cioè come essere la cui natura è la storia, che qui intendo come l’insieme di quelle circostanze, di
quei contesti, di quei condizionamenti in cui gli esseri umani si trovano a vivere; e anche di quei
prodotti che essi creano con le loro attività (prodotti tra i quali, alla fine, arriva a essere compreso
l’uomo stesso). Troviamo chiaramente affermato, nell’Ideologia tedesca, che l’essere umano, con
tutte le sue facoltà -la coscienza, il linguaggio, il pensiero- è un «prodotto sociale» e che lo stesso
strutturarsi dei comportamenti, delle tendenze, delle inclinazioni, dipende strettamente dalla
situazione economica in cui l’uomo vive ed opera: «come gli individui esternano la loro vita, così
essi sono. Ciò che essi sono coincide dunque immediatamente con la loro produzione, tanto con ciò
che producono quanto col modo come producono. Ciò che gli individui sono dipende dunque dalle
condizioni materiali della loro produzione»67. Antonio Gramsci non farà altro che riprendere
fedelmente questa interpretazione quando scriverà che «la innovazione fondamentale introdotta
dalla filosofia della prassi nella scienza della politica e della storia è la dimostrazione che non esiste
una “natura umana” fissa e immutabile (concetto che deriva certo dal pensiero religioso e dalla
trascendenza) ma che la natura umana è l’insieme dei rapporti sociali storicamente determinati, cioè
un fatto storico»68.
Come viene messo in evidenza da Marx ne La questione ebraica in relazione alla società
borghese-capitalistica, se in essa dominano relazioni sociali basate sull’isolamento reciproco,
65
J. Talmon, Le origini della democrazia totalitaria, tr. it. M. L. Izzo Agnetti, Il Mulino, Bologna 1967. In realtà
Talmon semplifica molto, soprattutto riguardo a Rousseau, l’interpretazione degli autori che include tra i rappresentanti
della «democrazia totalitaria». Ho cercato, nei testi già ricordati supra, di offrire un quadro in cui si mettono a fuoco
alcuni tratti di queste interpretazioni, a mio avviso eccessivamente schematiche e riduttive.
66
Cfr. K. Löwith, Uomo e storia, in Critica dell’esistenza storica, trad. it. di A. Künkler Giavotto, Napoli, Morano,
1967, pp. 212 ss.
67
K. Marx-F. Engels, L’ideologia tedesca, tr. it. di F. Codino, Introduzione di C. Luporini, Editori Riuniti, Roma 2000 5,
p. 9.
68
A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, v. III, p. 1599.
19
sull’egoismo, sull’antagonismo, ciò dipende non dal fatto che queste sono disposizioni naturali
dell’individuo, ma dall’esistenza di condizioni materiali tali da determinare la nascita e lo sviluppo
dell’ «individualismo possessivo»69, il quale trova appunto un’emblematica espressione nella classe
borghese nascente. La critica portata dall’autore de Il capitale alle concezioni dell’uomo
giusnaturalistiche -matrici delle Dichiarazioni dei diritti dell’homme e del citoyen e delle
costituzioni redatte nel contesto delle rivoluzioni americana e francese- si basa proprio sulla
considerazione che in esse viene presentato come valido sub specie aeternitatis un resoconto
dell’uomo che in realtà risulta da una surrettizia ipostizzazione della condizione in cui questi si
trova nel modo di produzione capitalistico. Siamo di fronte dunque, in contrasto con ciò che
afferma la presunta science politique sei e settecentesca, non a una vera e propria scienza, ma a
«ideologie» della società mercantile e acquisitiva moderna.
Proprio la convinzione della costitutiva storicità di quella che in gran parte della tradizione
filosofica viene erroneamente definita “natura umana” -cioè l’idea secondo cui essa non è un
insieme di proprietà date a priori, ma un «prodotto sociale», un «fatto storico»- consente di
ipotizzare una situazione nella quale il superamento di strutture basate sulla proprietà privata, sullo
sfruttamento, sulla lotta di classe, creerà «uomini del tutto nuovi»70, in cui non incideranno più
quelle contraddizioni, quei limiti, quelle distorsioni, effetto di rapporti di produzione che hanno
generato, nelle società di classe, conflitto e ingiustizia.
Alcuni passi tratti da Marx, da Engels e da autori che riprenderanno questo aspetto del loro
pensiero hanno valore emblematico per render conto di questa idea dell’autocreazione dell’uomo.
Solo questa capacità di crearsi da sé può restituire, come Marx aveva affermato nei Manoscritti
economico-filosofici del 1844, l’essere umano alla sua «indipendenza», che è tale proprio nella
misura in cui questi, congedandosi per sempre dai miti della religione cristiana, non si consideri più
creato (quindi, per Marx, dipendente) da un altro71. L’idea di creazione e quella di natura umana
sono per Marx strettamente unite e vanno, quindi, nella loro stretta connessione, criticate,
demistificate e superate, sostituendole con l’unica vera posizione secondo cui «per l’uomo
Cfr. C. B. Macpherson, Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell’individualismo
2
possessivo da Hobbes a Locke,, tr. it di S. Brutti, Prefazione di A. Negri, I.S.E.D.I., Milano 1973
70
F. Engels, Principi del comunismo, tr. it. in K. Marx-F. Engels, Opere complete, v. VI, Editori Riuniti, Roma 1973, p.
373.
71
«Un ente si stima indipendente solo appena sta sui suoi piedi, e sta sui suoi piedi appena deve la propria esistenza a se
stesso. Un uomo che vive per grazia di un altro si considera un essere dipendente. Ma io vivo completamente per grazia
di un altro quando non gli sono debitore del mantenimento della mia vita, bensì anche quando è esso che ha creato la
mia vita, quando è la fonte della mia vita; e la mia vita ha necessariamente un tale fondamento fuori di sé quando essa
non è la mia propria creazione. La creazione è quindi una rappresentazione molto difficile da scacciare dalla coscienza
popolare. La sussistenza per opera propria della natura e dell’uomo le è inconcepibile, perché contraddice a tutte le
evidenze della vita pratica» (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, in Opere filosofiche giovanili, tr. it. a
cura di G. Della Volpe, Editori Riuniti, Roma 1977 4, p. 234).
69
20
socialista, tutta la cosiddetta storia universale non è che la generazione dell’uomo dal lavoro
umano»72.
Mi limito a riportare alcuni dei passi detti: «Nella società comunista, in cui ciascuno non ha una
sfera di attività esclusiva ma può perfezionarsi in qualsiasi ramo a piacere, la società regola la
produzione generale e appunto in tal modo mi rende possibile di fare oggi questa cosa, domani
quell’altra, la mattina andare a caccia, il pomeriggio pescare, la sera allevare bestiame, dopo pranzo
criticare, così come mi vien voglia; senza diventare né cacciatore, né pescatore, né pastore, né
critico»73. Diviene a portata di mano l’instaurazione di un regno della fratellanza universale: «In
una società eretta a sistema socialistico ognuno spiega le sue attitudini per giovare a se stesso, con
che egli giova ad un tempo a tutti. Oggi l’egoismo personale e il bene generale sono spesso termini
antitetici che si escludono, mentre nella nuova società, tolta codesta antitesi, l’egoismo personale e
il bene generale armonizzano e si fondono»74. L’abolizione di ogni male sociale è ormai un
obiettivo realizzabile: «I ladri spariranno, con lo sparire della proprietà privata, e ognuno potrà, con
un onesto lavoro, appagare, come tutti gli altri, facilmente e comodamente i propri bisogni. Non ci
saranno più «disoccupati e vagabondi», prodotto di una società che riposa sulla società privata […].
Omicidi perché se ne dovrebbero commettere? Nessuno può arricchire a spese di un altro, e
l’omicidio per odio o vendetta dipende sempre più o meno direttamente dalle presenti condizioni
sociali»75. E allora è naturale prospettare come perfettamente possibile una condizione futura in cui
gli uomini arriveranno a obbedire alle regole della convivenza spontaneamente e senza costrizione
di alcun tipo: «La necessità di osservare le regole semplici e fondamentali di ogni società umana
diventerà ben preso un costume»76.
E tutto ciò non è considerato un’utopia, perché la natura umana non ha caratteri propri già da
sempre definiti, ma è effetto del milieu storico, sociale, economico. L’illuminista Morelly aveva già
espresso nel modo forse più conciso l’idea di fondo sottesa alle concezioni fin qui illustrate:
«L’uomo è accidentalmente o condizionatamente malvagio. Tolte, pertanto, la condizione e le cause
della malvagità, che per la maggior parte non dipendono da lui, egli non potrà essere perverso, né
desiderare o continuare ad esserlo»77.
E anche in questo caso è la «scienza reale e positiva» di cui parla L’ideologia tedesca, cioè il
materialismo storico, a consentire l’«emancipazione umana» (Zur Judenfrage) mediante un’azione
72
Ivi, p. 235. Il secondo corsivo è mio.
K. Marx-F. Engels, L’ideologia tedesca, cit., p. 24 (cap. I).
74
A. Bebel, La donna nel passato, nel presente e nell’avvenire, tr. it. di V. Olivieri, Savelli, Roma 19732 (rist. anast.
della tr. it. del 1892), p. 340.
75
Ivi, p. 390.
2
76
V. I. Lenin, Stato e rivoluzione, tr. it. di V. Gerratana, Editori Riuniti, Roma 1970 , p. 179.
77
Morelly, Codice della natura (1755), tr. it. di E. Piscitelli, Einaudi, Torino 1975, p. 119.
73
21
rivoluzionaria che incida in radice sulle condizioni della esistenza storico-sociale dell’uomo,
facendolo transitare dal regno della necessità al regno della libertà.
Invero la posizione di Marx è forse più complessa di quelle esaminate in precedenza, poiché egli
fa affidamento più sulle trasformazioni economico-sociali che non sulle possibilità intrinseche alla
politica come fattore del cambiamento. Questo è del tutto coerente con la sua idea, contenuta ne La
questione ebraica e più volte ribadita, che l’«emancipazione politica» è solo un’emancipazione
parziale ed incompiuta dell’uomo, visto che non tocca l’essenza dei rapporti di produzione e gli
elementi strutturali della convivenza78. Pur tuttavia, anche Marx ha ripetutamente insistito sul ruolo
centrale che l’azione politica riveste nel passaggio verso il comunismo. Da un lato, infatti, la
rivoluzione, passaggio inevitabile nel cammino verso quest’ultimo, è un atto eminentemente
politico. Dall’altro, lo «Stato di transizione» che ne dovrebbe nascere, ultima forma storica di
«Stato politico», ricopre un ruolo centrale non solo per motivi organizzativi (promuovendo la
centralizzazione dei mezzi di produzione e difendendo le conquiste della rivoluzione contro le
residue opposizioni delle classi sfruttatrici sconfitte79), ma perché costituisce lo strumento di
preparazione ed educazione delle masse alla nuova società in via di edificazione80. È ben noto che
la teoria politica marxiana si caratterizza per l’idea dell’«estinzione dello Stato»; e però, a parere di
Marx, questo fine risulta raggiungibile solo a seguito di un temporaneo (ma non per questo meno
essenziale) rafforzamento del momento politico-statuale, caratteristico dello “Stato di transizione”.
Evidentemente, se così stanno le cose, la prassi politica -mediata dalla conoscenza vera che ha
superato le illusioni dell’ideologia e che consente uno sguardo non capovolto, ma corretto del
mondo- assume un vero e proprio ruolo salvifico. Si è potuto parlare, in questo senso, di
«messianismo politico», inteso come quella concezione il cui «punto di riferimento [...] è la ragione
e la volontà dell’uomo, e la sua aspirazione a raggiungere la felicità sulla terra attraverso una
trasformazione sociale. Il punto di riferimento è temporale, ma le aspirazioni sono assolute»81. Se si
riduce il male alle sue componenti puramente storico-sociali, considerandolo come contingente e
perciò estirpabile dal mondo, la politica arriva ad essere il mezzo più idoneo a rimuoverlo, poiché è
da essa che dipende, in primo luogo, il mutamento di quelle condizioni da cui il male stesso ha
tratto origine. La società corrotta e ingiusta diventa il vero soggetto di imputazione del male e, così
considerata, viene distinta dall’uomo “buono per natura” o, comunque, plasmabile secondo le
esigenze della virtù, ma ostacolato nell’esercizio delle sue potenzialità dall’esistenza di relazioni e
78
Cfr. K. Marx, Sulla questione ebraica, in B. Bauer, K. Marx, La questione ebraica, tr. it. a cura di M. Tomba,
ManifestoLibri, Roma 2004, pp. 179-186, 192-206.
79
Cfr. K. Marx-F. Engels, Manifesto del partito comunista, tr. it. di M. Monaldi, Introduzione di E. Hobsbawm,
Rizzoli, Milano 20043, pp. 111-117; V. I. Lenin, Stato e rivoluzione, cit., pp. 71-86, 103-115.
80
Su questo punto ha insistito particolarmente Antonio Gramsci (cfr., per esempio, Quaderni del carcere, cit., v. III, pp.
1560-1561, 1565-1566, 2314).
81
J. Talmon, Le origini..., cit., p. 19.
22
strutture sociali distorte, frutto di una vicenda storica concepita come deplorevole, ma correggibile,
«disavventura»82.
Nella misura in cui il fine della politica è così alto ed impegnativo, i detentori del potere devono
essere necessariamente dotati di tutti gli strumenti atti a raggiungerlo; non ha infatti senso porre
freni e condizionamenti alla loro azione, visto che la si ritiene basata su una conoscenza superiore (e
alla quale è perciò insensato e dannoso opporsi) delle leggi e dei fini della storia. Com’è stato
osservato, «la stessa idea di un sistema [...] dal quale sia stato eliminato ogni male e ogni infelicità è
totalitaria. La supposizione che un tale schema di cose è fattibile, e anzi inevitabile, è un invito per
un regime a proclamare che esso realizza questa perfezione, a esigere dai suoi cittadini
riconoscimento e sottomissione e a condannare l’opposizione come vizio o perversione»83.
Inoltre raggiungere la perfezione comporta sempre la necessità di una “guida” che interpreti il
vero interesse delle masse, considerate incapaci, senza un’illuminazione superiore, di pervenire a
un’adeguata coscienza dei loro compiti e degli obiettivi da raggiungere. In questa prospettiva la
figura del «legislatore» cui fanno ricorso Rousseau ed Helvétius84 non è sostanzialmente diversa,
quanto al suo significato, da quella del partito-avanguardia che ricorre nella tradizione marxistaleninista: soddisfano entrambi, legislatore e partito-guida, l’esigenza che il popolo sia condotto alla
convivenza buona e giusta, alla liberazione dal dispotismo e dall’oppressione di classe, per opera di
quell’uomo o di quelle minoranze che sole posseggono la verità e che sono in grado di tradurla in
un progetto di totale trasformazione della vita collettiva85.
8. Per ritessere il filo: le implicazioni totalitarie della «genetica liberale»
Il congedo dall’idea di “natura umana” porta inevitabilmente con sé conseguenze totalitarie? Un
interrogativo posto così svela, per il modo stesso in cui è presentato, la sua fragilità e si espone sin
troppo facilmente alla confutazione di essere, quanto meno, generico e anche fuorviante. Ma non è
in direzione di tale domanda che procede tutto quanto precede. Si è infatti detto, sin dall’inizio, che
l’obiettivo era semplicemente quello di seguire un itinerario tra i molti possibili lungo i quali ci è
dato di rivisitare le forme attraverso cui viene ripensato, nella modernità, rispetto al modello
classico-aristotelico, il rapporto tra natura umana, etica e politica. Quello che invece è legittimo
sottolineare è che, come spesso avviene, gli esiti radicali, e anche storicamente drammatici, di un
processo di pensiero -per quanto diversificato al suo interno, com’è quello qui ricostruito82
H. Gouhier, Filosofia e religione in Jean-Jacques Rousseau (1970), tr. it. di M. Garin, Laterza, Roma-Bari 1977, pp.
30-31.
83
J. Talmon, Le origini..., cit., p. 52.
84
Cfr. J.-J. Rousseau, Du contrat social, cit., pp.381-384; Helvétius, De l’esprit, v. II, pp. 65-66; 249-250; 263-264; v.
III, pp. 134-142.
85
Cfr. V. I. Lenin, Che fare?, tr. it di L. Gruppi, Roma 19703, specie, pp. 55, 62-63, 75, 137, 148-149; G. Lukàcs,
Storia e coscienza di classe, tr.it. di G. Piana, Sugar, Milano 1974.
23
permettono di portare alla luce in maniera più incisiva e netta alcuni elementi di cui sarebbe errato
non tenere il debito conto. Affermare che sarebbe arbitrario e teoreticamente debole stabilire una
sorta di nesso consequenziale tra eclissi del concetto di “natura umana” sul piano teoretico e
totalitarismo sul piano storico non equivale a dire che l’itinerario ricostruito in precedenza non
possa e non debba essere letto come l’invito a riflettere sulle potenzialità negative e anche
distruttive che possono essere contenute nel divorzio della filosofia politica dal concetto in
questione. Hannah Arendt ricordava, nell’ultimo capitolo della prima edizione del suo The Origins
of Totalitarianism (1951)86, che la caratteristica del totalitarismo consiste nel fatto che esso «non
mira alla trasformazione delle condizioni esterne dell’esistenza umana né al riassetto rivoluzionario
dell’ordinamento sociale, bensì alla trasformazione della natura umana che, così com’è, si oppone al
tale trasformazione». I lager sono stati i laboratori in cui si è sperimentato tale immane progetto.
Quindi è perfettamente conseguente concludere che nella logica totalitaria «non è in gioco la
sofferenza, di cui ce n’è stata sempre troppa sulla terra, né il numero delle vittime. È in gioco la
natura umana in quanto tale [corsivo mio]»87. E aggiungeva, in una forma che, oggi in particolare,
suona come ammonimento, che «le soluzioni totalitarie potrebbero sopravvivere alla caduta dei loro
regimi»88 .
La convinzione secondo cui elementi totalitari possano, pur dopo la fine dei regimi totalitari
nazista e comunista, continuare ad esistere o tornare a inquinare le democrazie che, almeno in una
parte del mondo, sono uscite vittoriose dalla lotta epocale sul totalitarismo non è certo tipica solo
della Arendt. La si ritrova, per esempio, com’è ben noto, in alcuni scritti fondamentali dei
francofortesi89. E, senza far necessariamente ricorso a pezze d’appoggio tratte dalla filosofia, basta
guardare la prassi in atto di alcuni governi democratici attuali. Certo è che il campo della bioetica,
da cui ero partito prendendo spunto da Habermas, è tra quelli in cui l’insidia della permanenza di
componenti totalitarie nelle società di inizio millennio è forse maggiormente evidente. Che una di
queste componenti consista, per riprendere proprio i termini di Habermas, nella convinzione
secondo cui l’uomo potrebbe e dovrebbe «‘cogestire l’evoluzione’ o addirittura ‘recitare la parte di
Dio’», mi pare affermazione difficilmente contestabile. La portata totalitaria di una
«autotrasformazione del genere»90 senza limiti e senza criteri di regolazione morali è inconfutabile.
Come inconfutabile è che questo «coktail esplosivo di darwinismo e liberismo che si era diffuso tra
Otto e Novecento all’ombra della pax britannica sembra oggi rinascere sotto il segno di un
Il cap. 13, “Ideologia e terrore”, sarà aggiunto nella II ed. (1958).
Sui problemi del concetto di “natura umana” nella Arendt vedi infra.
88
H. Arendt, Le origini del totalitarismo, tr. it. di A. Guadagnin, Introduzione di S. Forti, Comunità, Milano 1999, pp.
628-629.
89
Rinvio, per brevità, solo a M.Horkheimer-T.W.Adorno, La dialettica dell’illuminismo, tr. it. di R. Solmi,
Introduzione di C. Galli, Einaudi, Torino 1997, pp. 14, 32 ss., 92 ss., 160 ss.
90
J. Habermas, Il futuro della natura umana…, cit., p.24.
86
87
24
neoliberismo globalizzato»91, cioè in un tempo nel quale l’enfasi sovente acritica posta sull’
«autonomia privata del singolo» -intesa, per dirla con Charles Taylor, come il risultato della fusione
di «soggettivismo» e «relativismo» (Il disagio della modernità)- tende a far rifiutare come illiberale
ogni tentativo di porre confini morali di fronte «all’idea liberale per cui tutti i cittadini devono avere
la stessa chance di organizzare autonomamente la vita», arrivando anche a manipolarne i
presupposti biologici basilari e cercando, per questo, di incidere, senza ingombranti remore
normative, sulle condizioni di inizio, di fine, di qualità della vita92.
Qui si aprirebbe la questione cruciale, che però può essere solo accennata. Può per molti versi
ritenersi inaccettabile una posizione come quella di MacIntyre (o posizioni ad essa sostanzialmente
assimilabili), secondo la quale il congedo dal concetto onto-teleologico di natura umana di stampo
aristotelico porta inevitabilmente a conseguenze «nichilistiche» (tutti ricordiamo la sua secca
alternativa «Nietzsche o Aristotele»93). Così, forse in maniera più fertile, si potrebbe proporre di
avviare un ripensamento di questo concetto, dei suoi fondamenti e delle sue articolazioni possibili,
senza però abbandonarlo.
Se ci si colloca in questa seconda prospettiva, possono soccorrerci alcuni riferimenti che
rammento senza alcuna pretesa di esaustività, anzi come meri spunti per una “mappa”
semplicemente orientativa basata su modelli che delineano posizioni le quali, ovviamente,
avrebbero bisogno di ben maggiore approfondimento.
a) Il grado di maggiore continuità rispetto alla tradizione aristotelica, filtrata attraverso il
tomismo, è costituito, per utilizzare un esempio particolarmente pregnante, dalla riflessione di
Jacques Maritain, nella quale risulta centrale il recupero di quella tradizione come l’unica in grado
di salvaguardare dalla caduta nel nichilismo in etica e dalla fatale identificazione, che la modernità
introduce, tra “società politica” e sovranità statuale; è al termine estremo di questa identificazione
che si colloca, transitando per lo Stato etico hegeliano, l’esito totalitario del moderno, come
Maritain argomenta in L’uomo e lo Stato. Il fondamento onto-teleologico dell’etica garantisce,
attraverso la teoria della legge naturale, un’articolazione del diritto e della politica tale da evitare ciò
che il «positivismo» porta con sé inevitabilmente, vale a dire la relativizzazione del valore e di
conseguenza il decisionismo politico. La serrata polemica con Hans Kelsen, e più in generale, con
le variegate espressioni del non-cognitivismo etico ha proprio il fine di mostrare che contrariamente a quanto Kelsen e coloro che si muovono sulla sua scia ritengono- il «relativismo
filosofico», con il suo radicale e dogmatico rigetto della metafisica, non è l’unica via di
91
Ivi.
Ivi, p.27.
93
A. MacIntyre, Dopo la virtù, cit., pp. 135-147.
92
25
giustificazione possibile della democrazia94, ma esattamente il suo opposto. Relativismo etico e
totalitarismo si collocano su una stessa linea e il rifiuto dell’idea di “Verità” in etica, in diritto e in
politica, anziché essere la precondizione della libertà, costituisce la premessa per il suo
affondamento95. Il rinvio alla teoria della legge naturale -e quindi il recupero della nozione
tomistica di partecipatio e dell’analogia entis- consente il fondamento dei diritti dell’essere umano:
«Una filosofia positivista che riconosce solamente il Fatto [è] impotente a stabilire l’esistenza dei
diritti naturalmente posseduti dall’essere umano, anteriori e superiori alla legislazione scritta […].
Logicamente, la nozione di tali diritti non può apparire a quelle filosofie che come una
superstizione. Essa è valida e razionalmente sostenibile solo se ogni individuo esistente ha una
natura o un’essenza che è il luogo di necessità intelligibili e di verità necessarie, ossia se il regno
della natura inteso come costellazione di fatti e di avvenimenti racchiude e manifesta un regno della
natura inteso come universo di essenze, che trascende il fatto e l’avvenimento. In altri termini, non
vi sono diritti a meno che un certo ordine, che di fatto può essere violato, non sia inviolabilmente
richiesto da ciò che le cose sono nel loro esemplare intelligibile o nella loro essenza, o da ciò che la
natura dell’uomo è e da ciò in cui essa trova il proprio perfezionamento; ordine in virtù del quale
certe cose, come la vita, il lavoro, la libertà, sono dovute alla persona umana, che è un esistente
dotato di un’anima spirituale e del libero arbitrio»96. Intorno alla nozione di “persona” viene poi
elaborata, sia ne I diritti dell’uomo e la legge naturale che in Cristianesimo e democrazia, una
concezione della democrazia come regime che della persona consente di realizzare le proprietà
costitutive, cioè l’ «indipendenza», la «totalità» e l’ «apertura».
«Legiferare, e cioè determinare il contenuto dell’ordinamento sociale, non secondo ciò che obiettivamente è meglio
per gli individui soggetti all’ordinamento, ma secondo ciò che questi individui, o la loro maggioranza, crede,
giustamente o erroneamente, essere meglio per loro -questa conseguenza dei principi democratici di libertà ed
uguaglianza- trova una giustificazione solo se non v’è una risposta assoluta alla domanda su cosa sia il meglio, se non
esiste un bene assoluto. Permettere ad una maggioranza di uomini ignoranti di decidere, invece di riservare la decisione
all’unico uomo che, in virtù della sua origine o ispirazione divina, ha la conoscenza esclusiva del bene assoluto, non è il
metodo più assurdo se si crede che questa conoscenza è impossibile e che, perciò, nessun individuo singolo ha il diritto
di imporre la sua volontà agli altri. Che i giudizi di valore abbiano una validità soltanto relativa -principio basilare del
relativismo filosofico- implica che opposti giudizi di valore non siano esclusi né logicamente né moralmente. Uno dei
principi fondamentali della democrazia è che ognuno deve rispettare l’opinione politica degli altri, giacché tutti sono
uguali e liberi. Tolleranza, diritti della minoranza, libertà di parola e di pensiero, così caratteristici della democrazia,
non trovano posto in un sistema politico basato sulla credenza nei valori assoluti. Questa credenza porta
irresistibilmente -ed ha sempre portato- ad una posizione in cui colui che presume di possedere il segreto del bene
assoluto pretende di avere il diritto di imporre la sua opinione e anche la sua volontà agli altri, i quali, se non sono
d’accordo, sono in errore» (H.Kelsen, I fondamenti della democrazia, tr. it. in La democrazia, Il Mulino, Bologna
1981, pp.213-214).
95
«Se fosse vero che chiunque conosce o pretende conoscere la verità e la giustizia non può ammettere la possibilità di
un punto di vista diverso dal proprio ed è quindi tenuto ad imporre il proprio punto di vista vero agli altri con la
violenza, allora l’animale ragionevole sarebbe il più pericoloso di tutti gli animali. In realtà l’animale ragionevole è
tenuto, in virtù della sua natura, a cercare di condurre i propri compagni a partecipare di ciò che egli conosce o pretende
di conoscere come vero e come giusto, non con la coercizione, ma con mezzi razionali, e cioè la persuasione» (J.
Maritain, Tolleranza e verità, in Id. Il filosofo nella società, tr. it. a cura di A. Pavan, Morcelliana, Brescia 1976 p. 67).
96
J. Maritain, L’uomo e lo Stato, tr. it., Vita e pensiero, Milano 1982, pp. 112-113
94
26
c) Più volte e da più parti il recupero del concetto di “natura umana” è stato criticato e rifiutato
perché finirebbe per sacrificare inevitabilmente la dimensione della “pluralità” individuale e il
momento della libera soggettività97. Per quanto a questa obiezione si potrebbe forse rispondere
abbastanza convincentemente ricordando la dialettica, che Maritain istituisce e illustra con
chiarezza soprattutto ne La persona e il bene comune, tra «individuo» e «persona», non si può
comunque negare che almeno un uso non adeguatamente sorvegliato di tale concetto può facilmente
incorrere in tale esito.
Un’autrice che molto ha insistito su questo punto è senza dubbio Hannah Arendt, che qui prendo
come spunto per sondare un approccio filosofico che è senz’altro cruciale per il problema proposto
in questo abstract. L’esempio della Arendt è particolarmente significativo anche perché l’autrice di
Vita activa assume in pieno e direttamente la questione insita nella categoria “natura umana”, ma
mostra una singolare oscillazione nel suo uso. Infatti, come risulta dalla citazione riportata in
precedenza sul totalitarismo e tratta dall’edizione del 1951 del testo The Origins of Totalitarianism,
nella prima fase del suo pensiero vede la minaccia maggiore del totalitarismo proprio nel
presupposto che, a suo avviso, lo anima, vale a dire nella convinzione che sia necessario e possibile
trasformare la natura umana secondo un progetto ideologico che viola le condizioni elementari della
vita e del mondo umani e che quindi non può che dar luogo, come storicamente è accaduto, agli
esiti dell’orrore concentrazionario.
In questa interpretazione del fenomeno totalitario, come Eric Voegelin vide lucidamente, si
annidava però già un equivoco teoretico non certo di secondario rilievo. Nella recensione al testo
della Arendt Voegelin lo esplicita con palese durezza e decisione quando sottolinea i «difetti
teorici» di questo pur «eccellente libro». Riprendendo esattamente dalla Arendt la citazione che ho
riportato sopra, egli afferma di condividere la lettura della Arendt e in particolare la convinzione
che alla base dell’avvento del totalitarismo sia da individuare un «disagio spirituale», del quale
però, a suo avviso, la Arendt non coglie la profondità storica e filosofica: non si tratta del «crollo
istituzionale delle società nazionali e della crescita delle masse socialmente superflue», ma di un
processo di molto più lunga data, che parte dal «settarismo immanentista» dell’alto medioevo e
giunge alla contemporaneità attraverso i «movimenti gnostici di massa». Solo in questo orizzonte
molto più ampio i fenomeni registrati dalla Arendt assumono il loro pieno senso e possono essere
compresi in radice. E a questo punto Voegelin affonda il colpo: «La fede cristiana nella perfezione
trascendente raggiungibile con la grazia divina è stata convertita -e pervertita- nell’idea della
perfezione immanente ottenibile con un atto umano. E questa interpretazione del crollo spirituale e
intellettuale è seguita nel testo della Dottoressa Arendt dalla frase: ‘La natura umana come tale è in
97
Vedi, a mò di significativo esempio, l’esordio di Vita activa di Hannah Arendt e il cap. l sull’ “azione”.
27
gioco, e anche se sembra che questi esperimenti abbiano successo non nel cambiare l’uomo, ma
solo nel distruggerlo…non si dovrebbero dimenticare le necessarie limitazioni di un esperimento
che richiede un controllo globale per poter offrire dei risultati conclusivi’ […]. Quando ho letto
questa frase, non ho quasi creduto ai miei occhi. ‘Natura’ è un concetto filosofico: esso denota che
si identifica una cosa come una cosa di questo genere e non di un altro. Una ‘natura’ non può
essere cambiata o trasformata; un ‘cambiamento della natura’ è una contraddizione in termini; il
cercare di alterare la ‘natura’ di una cosa significa distruggere la cosa. Il concepire l’idea del
‘cambiare la natura’ dell’uomo (o di qualsiasi cosa) è un sintomo del collasso intellettuale della
civiltà occidentale. L’autrice infatti adotta l’ideologia immanentistica, assume un ‘atteggiamento
aperto’ riguardo le atrocità totalitarie, considera la questione del ‘cambiamento della natura’ come
una materia che va determinata con il principio della ‘prova e dell’errore’, e dal momento che la
‘prova’ non si è potuta ancora servire delle possibilità offerte dal laboratorio globale, la questione
resta per il momento in sospeso»98. Il «deragliamento teorico» della Arendt la porta quindi a
condividere, pur in modo inconsaputo (ma proprio per questo filosoficamente più grave) i
presupposti teorici di cui critica le conseguenze storiche, evidenziando «quanto terreno hanno in
comune i liberali e i totalitari»99.
In realtà il deragliamento è tutt’altro che casuale e, in fin dei conti, non siamo neppure di fronte
a un’aporia. Il termine «natura umana» è usato dalla Arendt, ne Le origini del totalitarismo, in
modo poco più che allusivo e retorico, come dimostra la prosecuzione della sua riflessione, in
questo caso consegnata soprattutto alle pagine di Vita activa, il cui titolo originale suona, com’è
noto, The human Condition. Qui, come è già stato rammentato all’inizio, viene svolta una critica
senza mezzi termini del concetto di natura umana, con una chiara sottolineatura del fatto che «la
condizione umana […] non coincide con la natura umana». Tant’è vero che «il più radicale
mutamento nella condizione umana che noi possiamo immaginare sarebbe un’emigrazione degli
uomini dalla terra in un altro pianeta. Un evento del genere, non più del tutto impossibile,
comporterebbe per l’uomo il dover vivere in condizioni create dall’uomo, radicalmente diverse da
quelle che gli offre la terra. In tal caso, né l’attività lavorativa, né l’operare, né l’azione, e neppure il
pensiero, così come lo conosciamo, avrebbero più alcun senso. Tuttavia anche questi ipotetici
emigranti sarebbero umani; ma la sola affermazione che potremmo fare circa la loro ‘natura’ è che
essi sarebbero pur sempre esseri condizionati, anche se in una condizione in buona parte
autodeterminata»100. Quindi comprendere il significato della vita umana nel mondo equivale a
98
E. Voegelin, Recensione a Le origini del totalitarismo di Hannah Arendt, tr. it. in Eric Voegelin: un interprete del
totalitarismo, a cura di G. Lami, Astra, Roma 1978, pp. 67-68.
99
Ivi, p.69.
100
H. Arendt, Vita activa, cit., p. 9.
28
svolgere una fenomenologia delle «condizioni dell’esistenza umana», cioè «vita, natalità e
mortalità, mondanità, pluralità e terra», le quali però «non potranno mai ‘spiegare’ che cosa noi
siamo o rispondere alla domanda ‘chi siamo noi?’ per la semplice ragione che non ci condizionano
in maniera assoluta»101. Il fulcro di questa posizione è nella coppia concettuale condizionamentoautodeterminazione, che non dicono necessariamente di una contrapposizione, ma indicano che
l’«analisi dei concetti» -cui la Arendt ha esplicitamente delimitato il suo progetto filosofico- deve di
volta in volta render conto di come gli uomini rispondono alle situazioni in cui si trovano, fermo
restando che questo non ci conduce né ci può condurre a una «spiegazione» e/o fondazione ultima,
ma a una comprensione dei modi in cui gli esseri umani abitano il mondo (o i mondi futuri
possibili). In un certo senso la posizione della Arendt è emblematica per illustrare un approccio di
tipo fenomenologico che rigetta ogni apertura al fondamento e recupera, nella sua concezione dall’
“azione”, il modello aristotelico della phronesis, ma sganciandolo dai presupposti onto-teleologici
che in Aristotele lo giustificavano. Si tratta di una direzione di pensiero tutt’altro che isolata
nell’ambito della “riabilitazione della filosofia pratica” nelle sue varie articolazioni, sulla quale,
come molti interpreti hanno rilevato, incombe l’onere (spesso non assolto) di dimostrare
esaurientemente come il modello fronetico applicato all’etica e alla politica possa reggersi
coerentemente prescindendo da quei presupposti. Com’è stato osservato in relazione al recupero del
modello della phronesis aristotelica nell’ambito del filone ermeneutico (entro il quale la Arendt ha
un ruolo evidentemente centrale), «nel riprendere le idee portanti della filosofia pratica aristotelica,
l’ermeneutica le ha scorporate dal quadro complessivo della metafisica e dell’ontologia aristotelica,
che essa non ritiene più condividibile». Ma proprio questa operazione di scorporamento fa
incombere il pericolo di uno scacco teoretico. Infatti la phronesis aristotelica era «un sapere relativo
ai mezzi atti a raggiungere un fine e non relativo al fine stesso (che è invece presupposto dalla
phronesis) [...]. In Aristotele la phronesis poteva garantire l’equilibrio tra l’efficacia dei mezzi e la
qualità morale dei fini, e quindi la riuscita dell’agire, perché era pensata nel quadro specifico
tracciato dalla scienza pratica e, più in generale, in quello dell’articolazione aristotelica del sapere.
Nell’ermeneutica, invece, la riabilitazione della phronesis rischia di fallire il suo scopo perché oggi
quest’ultima non dispone più di un quadro di riferimento analogo entro il quale poter collocarsi»102.
Quello che è stato definito il “neo-aristotelismo” della Arendt trova dunque il suo limite -ed è
ovviamente un limite essenziale anche in relazione al tema di questa mia proposta di discussionenella frattura che si realizza tra recupero del modello del sapere fronetico come forma della
discussione nello spazio pubblico, da un lato, e, dall’altro, congedo definitivo dalla sfondo
101
Ivi, p. 10.
F. Volpi, Tra Aristotele e Kant: orizzonti, prospettive e limiti del dibattito sulla “riabilitazione della filosofia
pratica”, in Teorie etiche contemporanee, a cura di C. A. Viano, Bollati Boringhieri, Milano 1984, pp. 146-147.
102
29
ontologico entro il quale in Aristotele trovava la sua collocazione il resoconto della prassi e
l’individuazione dei criteri direttivi della vita morale nel suo concreto svolgimento103.
c) Quanto, al di là dell’evidente differenza tra le due posizioni, c’è in comune relativamente al
problema che sottende l’itinerario speculativo di due filosofi, tanto distanti quanhto significativi per
il nostro tema, come la Arendt e Ricoeur? Il problema è ovviamente costituito dalla forte
propensione per un’indagine in termini fenomenologici ed ermeneutici dell’esistenza nelle sue varie
dimensioni. Tale propensione evidenzia, nella Arendt, il rigetto senza mezzi termini della
componente ontologica nel senso appena sopra ricordato (cioè nel senso che ipoteca negativemente
la coerenza della sua adozione del modello aristotelico della phronesis), mentre in Ricoeur fa
emergere, nei confronti della componente ontologica, un’accentuata prudenza che però non
conclude mai ad una chiusura nei confronti dell’ontologia, quanto piuttosto si condensa nello
sforzo, mai portato a conclusione, di delineare un’ontologia debole che lascia, alla fine, su questo
cruciale punto, il discorso in sospeso. Ricoeur riprende il concetto di “persona”, ma, a differenza di
quanto accade in Maritain, opera, sulla linea di Mounier, una sensibile problematizzazione di tale
concetto e lo rilegge alla luce delle categorie di «sproporzione», di «fragilità», di «fallibilità»,
quindi con una marcata accentuazione delle implicazioni connesse a un’insistita riflessione sulla
finitudine del soggetto umano, con tutte le ricadute che ciò implica nell’ordine della conoscenza
così come in quello della prassi. Dilemmatico diventa quindi lo sforzo di connettere la sfera dell’
«agire, in senso fenomenologico, e l’atto di essere sul piano ontologico»104. Com’è stato
evidenziato, «la via indiretta dell’ermeneutica ricoeuriana si presenta come il compito filosofico
forte di pensare la totalità e come la consapevolezza critica di non poterla esaurire con
l’ipostatizzazione di un atteggiamento o con l’assolutizzazione di un linguaggio»105. Il tema del
soggetto «non offre nessuna forma di accesso all’Essere assoluto ed eterno, sul piano della
Com’è stato osservato, la filosofia pratica conserva in Aristotele una relazione significativa con i contenuti di verità
della filosofia prima relativi alla determinazione delle caratteristiche costitutive essenziali della natura umana e alla
individuazione delle sue finalità, contenuti di verità che rappresentano l’orizzonte di riferimento entro cui deve essere
collocato il confronto dialettico sulla “vita buona” e che ne garantiscono la fondatezza. Il rapporto tra etica e metafisica,
pur non essendo pensabile, platonicamente, come relazione che permetta una sorta di deduzione rigida e meccanica
della prima dalla seconda (cfr. Aristotele, Etica Eudemia, VIII, 3, 1248b 7-1249b 25), è comunque un nesso che non
può essere reciso, nella misura in cui la riflessione sull’agire umano non può prescindere dalla conoscenza della physis e
del telos propri dell'uomo, che la filosofia prima evidenzia: «La phronesis non crea, ma scopre, l’ordinamento
teleologico dell’uomo verso il proprio fine, cioè verso il bene umano […], poiché questo ordinamento rientra nella
struttura generale della realtà, cioè nella physis, la quale in ultima analisi fa capo a Dio». D’altro canto «l’etica non si
subordina alla metafisica, cioè non deduce da questa le sue norme […], ma ne tiene conto per determinare più
esattamente in che consiste il bene dell’uomo» (E. Berti, La razionalità pratica tra scienza e filosofia, in Le vie della
ragione, Il Mulino, Bologna 1987, p.75).
104
D. Iannotta, L’alterità nel cuore dello stesso, Introduzione a P. Ricoeur, Sé come un altro, tr. it. di D. Iannotta, Jaca
Book, Milano 1993, p.83
105
D. Iannotta, L’alterità nel cuore dello stesso, introduzione a P. Ricoeur, Sé come un altro, tr. it., Jaca Book, Milano
1993, p. 68.
103
30
speculazione» ed evidenzia «un’assenza, più di una presenza»106. Certo non si stratta del rifiuto tout
court di percorrere il camino dell’ontologia, ma di una cautela teoretica che si concretizza in un
costante rinvio del progetto di sistematizzare tale dimensione e che, quando si misura su questo
piano, lo fa nei termini di un’ontologia debole, la cui cifra è consegnata alla cifra della finitudine,
della incommensurabilità tra «finito» e «infinito». Ne Il conflitto delle interpretazioni Ricoeur
scriveva: «Nella mia lotta contro lo strutturalismo mi sono sempre battuto […] contro l’idea di un
linguaggio che parlerebbe solo di se stesso […]. L’idea che il linguaggio è sempre su qualche cosa,
ecco, a mio avviso, l’esca ontologica del mio lavoro»107. Si potrebbe dire che l’ “esca” è rimasta,
almeno parzialmente, immersa nel’acqua e che questo ha ingenerato uno dei problemi cruciali del
pensiero ricoueriano, cioè quello consistente nella articolazione tra piano fenomenologico e piano
etico, in assenza di un’ontologia rigorosamente articolata. L’elemento etico finisce per prevalere,
ma, quanto alle sue basi, Ricoeur sembra aver contratto e mai saldato un debito fondativo che
ipoteca la tenuta della sua riflessione sulla prassi, anche in sede politica. La sporgenza dell’etico
rispetto all’ontologico crea, mi pare si possa dire, una sfasatura che proietta l’ontologia
nell’orizzonte di un compito da assolvere ma non assolto (o non assolvibile?), la configura insomma
come un sentiero interrotto. Il punto è se e come, dopo Ricoeur, per chi intenda muoversi sulla sua
linea, sia possibile riprendere questo sentiero108.
Che poi altri sentieri siano possibili è ovvio; basterebbe pensare alla critica radicale
dell’ontologia come filosofia della potenza carica di implicazioni totalizzanti e totalitarie così come
è presentata da Lévinas (quindi a una lettura del tema ontologia-etica-politica fortemente eccentrica
o, meglio, opposta rispetto a quella qui tratteggiata) e alla sua idea di identificazione, contro ogni
filosofia del Medesimo, di metafisica ed etica, declinate nell’orizzonte della “responsabilità” verso
l’altro. Ma, semplicemente, non è possibile (né utile) limitarsi a giustapporre modelli interpretativi.
Ho preferito, centrando in ultimo l’attenzione su Ricoeur, indicare una linea, che potrà essere
evidentemente anch’essa oggetto di discussione.
Roberto Gatti
D. Jervolino, Ricoeur. L’amore difficile, Studium, Roma 1995, p. 38.
A colloquio con Ricoeur. Appendice a O. Rossi, Introduzione alla filosofia di Paul Ricoeur. Dal mito al linguaggio,
Levante, Bari 1984, p. 169.
108
Cfr. Luca Alici, Il paradosso del potere. Paul Ricoeur tra etica e politica, Vita e Pensiero, Milano 2007, in
particolare pp. 20-23, 80-84, 131-137.
106
107
31
32