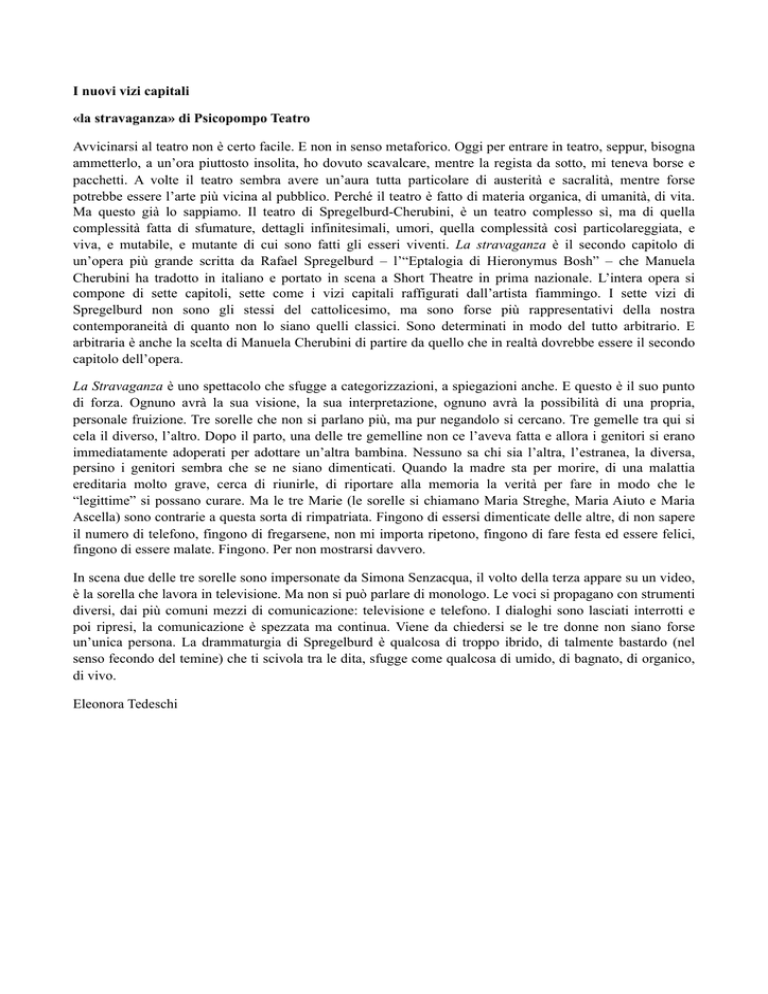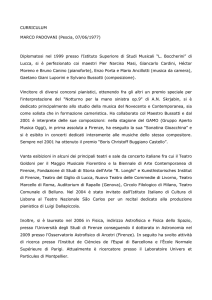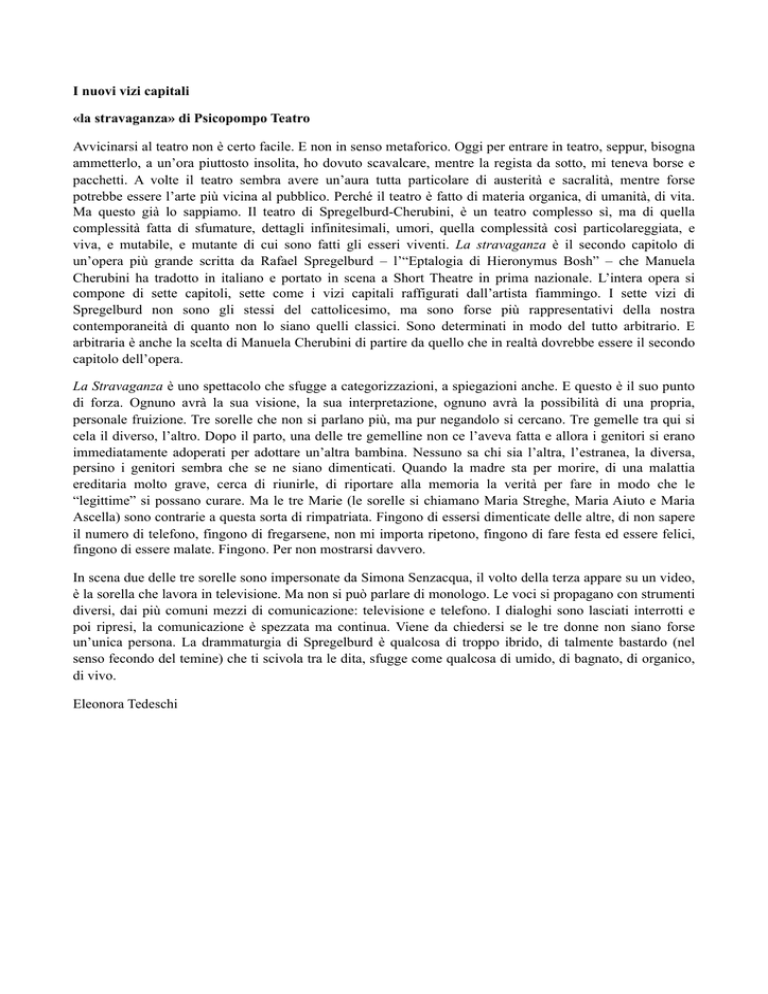
I nuovi vizi capitali
«la stravaganza» di Psicopompo Teatro
Avvicinarsi al teatro non è certo facile. E non in senso metaforico. Oggi per entrare in teatro, seppur, bisogna
ammetterlo, a un’ora piuttosto insolita, ho dovuto scavalcare, mentre la regista da sotto, mi teneva borse e
pacchetti. A volte il teatro sembra avere un’aura tutta particolare di austerità e sacralità, mentre forse
potrebbe essere l’arte più vicina al pubblico. Perché il teatro è fatto di materia organica, di umanità, di vita.
Ma questo già lo sappiamo. Il teatro di Spregelburd-Cherubini, è un teatro complesso sì, ma di quella
complessità fatta di sfumature, dettagli infinitesimali, umori, quella complessità così particolareggiata, e
viva, e mutabile, e mutante di cui sono fatti gli esseri viventi. La stravaganza è il secondo capitolo di
un’opera più grande scritta da Rafael Spregelburd – l’“Eptalogia di Hieronymus Bosh” – che Manuela
Cherubini ha tradotto in italiano e portato in scena a Short Theatre in prima nazionale. L’intera opera si
compone di sette capitoli, sette come i vizi capitali raffigurati dall’artista fiammingo. I sette vizi di
Spregelburd non sono gli stessi del cattolicesimo, ma sono forse più rappresentativi della nostra
contemporaneità di quanto non lo siano quelli classici. Sono determinati in modo del tutto arbitrario. E
arbitraria è anche la scelta di Manuela Cherubini di partire da quello che in realtà dovrebbe essere il secondo
capitolo dell’opera.
La Stravaganza è uno spettacolo che sfugge a categorizzazioni, a spiegazioni anche. E questo è il suo punto
di forza. Ognuno avrà la sua visione, la sua interpretazione, ognuno avrà la possibilità di una propria,
personale fruizione. Tre sorelle che non si parlano più, ma pur negandolo si cercano. Tre gemelle tra qui si
cela il diverso, l’altro. Dopo il parto, una delle tre gemelline non ce l’aveva fatta e allora i genitori si erano
immediatamente adoperati per adottare un’altra bambina. Nessuno sa chi sia l’altra, l’estranea, la diversa,
persino i genitori sembra che se ne siano dimenticati. Quando la madre sta per morire, di una malattia
ereditaria molto grave, cerca di riunirle, di riportare alla memoria la verità per fare in modo che le
“legittime” si possano curare. Ma le tre Marie (le sorelle si chiamano Maria Streghe, Maria Aiuto e Maria
Ascella) sono contrarie a questa sorta di rimpatriata. Fingono di essersi dimenticate delle altre, di non sapere
il numero di telefono, fingono di fregarsene, non mi importa ripetono, fingono di fare festa ed essere felici,
fingono di essere malate. Fingono. Per non mostrarsi davvero.
In scena due delle tre sorelle sono impersonate da Simona Senzacqua, il volto della terza appare su un video,
è la sorella che lavora in televisione. Ma non si può parlare di monologo. Le voci si propagano con strumenti
diversi, dai più comuni mezzi di comunicazione: televisione e telefono. I dialoghi sono lasciati interrotti e
poi ripresi, la comunicazione è spezzata ma continua. Viene da chiedersi se le tre donne non siano forse
un’unica persona. La drammaturgia di Spregelburd è qualcosa di troppo ibrido, di talmente bastardo (nel
senso fecondo del temine) che ti scivola tra le dita, sfugge come qualcosa di umido, di bagnato, di organico,
di vivo.
Eleonora Tedeschi