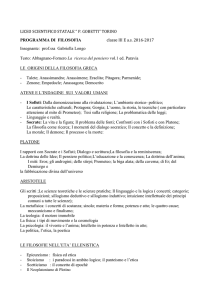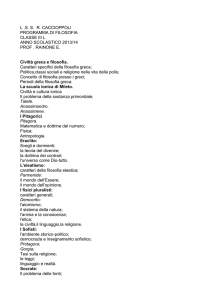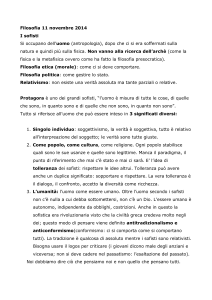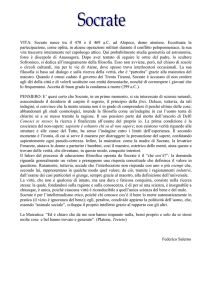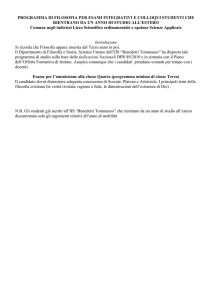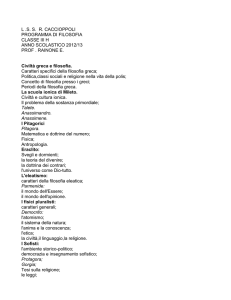Appunti di Pedagogia
(Liceo delle Scienze Umane – Classe I)
α
Prof. Brunello Gensini
♣ Terminologia di base
Il termine pedagogia viene da due parole greche:
Pais (paÊv), che significa “fanciullo”;
Ago (ˆgw), che significa “guidare”, “educare”.
Tale termine significa quindi etimologicamente: “guida, educazione del fanciullo”.
Ma già nel mondo antico – e ancor più in quello moderno – esso assume il significato
più generale di “educazione dell’essere umano, in ogni età della vita”.
Originariamente, nella società greca (p. es. ad Atene), il pedagogo (paidagwgÎv) era
solo una persona (di solito uno schiavo) che accompagnava il fanciullo alla scuola o
alla palestra; ma ben presto con questa parola si indica in generale colui che si occupa
direttamente dell’istruzione e dell’educazione dei giovani.
Istruzione e educazione indicano, rispettivamente, l’acquisizione da parte dell’uomo
di nozioni e competenze, e di comportamenti basati su affetti o valori morali. La voce
greca paideia (paideÀa) designa l’insieme di tutti questi elementi: essa corrisponde
(più o meno) al latino humanitas e al tedesco Bildung. La parola italiana educazione
è intesa spesso come comprensiva anche dell’istruzione; ma molti oggi preferiscono
usare il più recente termine formazione (introdotto dal pedagogista R. Massa).
Se con la parola pedagogo indichiamo chi s’impegna direttamente nella formazione
dei giovani, la parola pedagogista è riferita a chi elabora teorie e modelli in campo
formativo, che egli stesso o altri potranno applicare. Un pedagogista è di solito (ma
non necessariamente) anche un pedagogo, e viceversa, chi applica praticamente teorie
e modelli formativi contribuisce sempre, almeno un po’, alla loro elaborazione.
Quanto si è appena detto fornisce già la risposta alla domanda (non molto profonda)
se la pedagogia sia una scienza o un’arte. Come accade in tutte le discipline (vedi la
medicina, o la psicologia – ma anche l’ingegneria, e perfino la matematica), esistono
aspetti teorici, di pura ricerca, che stanno alla base di applicazioni pratiche, ed
esistono abilità tecniche ed esperienze di fatto (spesso basate anche su intuizioni, o
persino su colpi di fortuna) che contribuiscono agli sviluppi della ricerca.
Più interessante è la questione dei rapporti tra la pedagogia e le scienze umane – cioè
quelle discipline empiriche e sperimentali che studiano l’uomo e che si sviluppano, a
partire dalla prima metà dell’Ottocento, nell’ambito della scienza moderna.
♣ La pedagogia e le scienze umane
La pedagogia non può essere definita, oggi, la “scienza dell’educazione”: tutte le
“scienze umane” attualmente esistenti (e sono decine) hanno titolo per occuparsi di
questioni educative e formative. Psicologia e sociologia, anzitutto, presentano settori
specificamente dedicati a tali questioni: vedi ad es. la psicologia dell’apprendimento,
la psicologia dell’età evolutiva, l’epistemologia genetica, la sociologia scolastica o la
sociologia dei piccoli gruppi, per non parlare della storia dei modelli educativi, o
della psicometria, della docimologia etc. etc.
La pedagogia sembra occupare, oggi, una posizione intermedia tra la filosofia (da cui
essa indubbiamente nasce e a cui resta poi sempre legata) e le “scienze umane” di cui
si è parlato sopra. Queste ultime fanno parte di un gruppo ancor più numeroso, che
comprende le cosiddette “scienze naturali”, le quali sono state anche le prime ad
apparire sulla scena, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento.
La figura cerca di esprimere la presente relazione, e l’attuale rapporto di forze, tra le
varie scienze (naturali ed umane) e la cultura filosofico-pedagogica. Quest’ultima è
rappresentata da un alberello di modeste dimensioni, che ha accanto a sé una fitta
foresta di piante molto più alte e rigogliose. È certo che la nostra società sembra
dipendere sempre più, per il suo sviluppo, dal sapere scientifico e prestare sempre
meno attenzione alla propria tradizione filosofica – cioè al proprio passato.
Un osservatore superficiale potrebbe addirittura pensare (e la precedente figura è fatta
proprio in modo da suggerire tale idea) che l’alberello della filosofia e la foresta della
scienza non abbiano molto in comune: al massimo, il terreno su cui crescono.
Eppure la pedagogia è stata – per secoli, anzi per millenni – la scienza dell’educazione.
Il motivo di questo mutamento è legato al significato che la parola scienza ha assunto
nella cultura contemporanea, lungo un percorso che inizia appunto verso gli inizi del
Seicento, ma che si delinea soprattutto dalla seconda metà dell’Ottocento.
Fino a quel punto il termine scienza indica, per usare le parole di un filosofo stoico,
“la comprensione certa ed immutabile del reale, fondata sulla ragione”: è la stessa
definizione che si sarebbe potuta dare della parola filosofia. Il termine latino scientia
(che corrisponde al greco epistéme) indica per secoli proprio quel tipo di sapere certo
ed immutabile che prende più in generale il nome di “filosofia”. Ancora Galileo, il
fondatore della scienza moderna, si definisce “filosofo”, e Newton chiama “filosofia
naturale” quell’ambito di ricerca che prenderà poi il nome di “fisica” (quest’ultimo
termine, di origine greca, designa del resto proprio la scienza del mondo materiale).
Ampliamo dunque la precedente figura,
andando a cercare più in profondità le
radici delle diverse piante che vi sono
rappresentate. Il “terreno” da cui esse
sembravano nascere limita e chiude la
prospettiva, e corrisponde all’illusione di
chi pretende di capire il presente senza
riferirlo al passato. Le scienze umane, ed
anche le scienze naturali, che tutte
insieme formano la grande “foresta” che
oggi sovrasta l’albero filosofico, sono
molto giovani (due secoli le prime, circa
il doppio le seconde) rispetto a due
millenni e mezzo di storia della filosofia
(e della pedagogia). Ma esse nascono
tutte proprio dal tronco filosofico, né
potrebbero esistere senza di esso; anche
se, dopo la loro nascita ed in parallelo
con i loro sviluppi, quel tronco è andato
perdendo forza ed importanza, fino a
divenire appunto un modesto alberello.
I motivi di questo processo sono troppo complessi e profondi per potervi anche solo
accennare in queste righe: la loro analisi presuppone un attento studio della filosofia
(della cui nascita e dei cui caratteri specifici avremo modo di parlare, ma solo
brevemente, in seguito). Noi ci limiteremo qui ad esaminare le conseguenze che ha
avuto tale processo sui rapporti tra la pedagogia e le moderne “scienze umane”.
La crisi della filosofia – che diviene ben visibile negli ultimi centocinquant’anni – è
anche la crisi dei valori assoluti, cioè di quei principi morali che per secoli e secoli
hanno guidato l’organizzazione della società umana ed ogni progetto educativo
condotto al suo interno. Dopo il tramonto di tali valori, resta solo la voce delle grandi
religioni a indicare che cosa è “giusto” o “sbagliato” in via definitiva; ma si tratta di
voci relativamente deboli, che non tutti sono disposti a seguire: i nostri valori, come
afferma Weber, sono ormai tanti dei in lotta tra di loro «… E su questi dei e sulle loro
lotte domina la sorte: non certo una qualche “scienza”».
Le scienze, infatti, come ci avverte sempre Weber, possono occuparsi oggi solo di
strumenti: esse sanno dirci come raggiungere un certo scopo, ma non hanno alcuna
capacità di dirci se vale la pena raggiungerlo; non sanno indicarci gli scopi migliori,
gli scopi degni di essere perseguiti. Esse sono a-valutative (wertfrei, dice Weber).
In altri termini, la scienza non ha, oggi, verità: non può stabilire il senso e lo scopo
della nostra esistenza e fissare di conseguenza regole assolute: essa non è più,
appunto, scientia in senso latino o epistéme in senso greco: il termine “episteme”, che
sopravvive nella voce epistemologia (= dottrina critica ed organizzativa del sapere
scientifico) è appunto un sopravvissuto: ha perso il significato radicale delle origini.
Ed eccoci dunque di fronte al dilemma con cui si trova oggi alle prese la pedagogia:
essa non può ridursi alle “scienze dell’educazione”, perché così facendo perderebbe
la sua vocazione originaria (che consisteva nel fissare anzitutto scopi e valori), e
diventerebbe un inutile doppione della psicologia dell’apprendimento etc. Ma se resta
fedele alla sua vocazione (filosofica) di occuparsi dei valori, essa deve fare i conti con
la presente debolezza della filosofia, cioè della “pianta” a cui è sempre stata legata.
Le prospettive di sopravvivenza della pedagogia sono dunque le stesse della filosofia:
quest’ultima ha forse ancora qualcosa da dire all’uomo contemporaneo, all’uomo che
punta sempre più sugli sviluppi della scienza e della tecnica? Una prima risposta
potrebbe venire dalle considerazioni che abbiamo sviluppato in relazione alle due
precedenti figure (cioè al loro significato metaforico).
La scienza è di per sé incapace di guardare in profondità nel proprio passato, e quindi
anche di cogliere il senso complessivo del proprio sviluppo. Essa sa (o va sempre più
rendendosi conto) di non avere verità, di non poter fissare regole o modelli definitivamente validi. Ma da dove nasce la crisi della “verità”? C’erano alternative al percorso
che ha condotto la scienza moderna ad abbandonare il grande progetto filosofico? E
soprattutto: si tratta di una crisi ormai irreversibile? La voce della filosofia è oggi
certamente debole; estremamente più debole di quella della scienza (del coro delle
varie scienze che, a modo loro, “risolvono” i problemi dell’uomo contemporaneo);
eppure è l’unica voce che potrebbe dare risposte a quelle questioni essenziali.
♣ L’apprendimento umano: cultura e scrittura
Tutti gli esseri viventi (anche le piante, in una certa misura) apprendono, cioè sono in
grado di modificare il proprio rapporto con l’ambiente, adattandosi ad esso. L’uomo è
tuttavia – per quanto ne sappiamo – l’unico essere vivente capace di ridefinire tale
rapporto, e quindi il suo stesso modo di vivere, in maniera progressiva e attraverso
una continua progettazione del proprio futuro. Ciò è possibile grazie ad un sistema
organico di conoscenze teoriche e di capacità tecniche, che vengono trasmesse da una
generazione all’altra ed insieme incrementate: è quello che si chiama “cultura”.
Jerome Bruner, uno dei maggiori psico-pedagogisti contemporanei, individua alcuni
tratti specifici della cultura e dell’apprendimento umani: ♦ la capacità di costruire
strumenti; ♦ l’organizzazione sociale; ♦ il bisogno di dare un senso alla realtà; ♦ la
prolungata infanzia; ♦ l’uso complesso dei simboli – e in particolare del linguaggio.
Occupiamoci degli ultimi due aspetti, che sono i più attinenti ai temi di cui tratteremo
in seguito. A differenza della maggior parte degli animali, gli esseri umani nascono
piuttosto immaturi dal punto di vista dell’adattamento all’ambiente: essi impiegano
anni – e non già settimane o mesi – per sviluppare l’autonomia propria degli esseri
viventi adulti. In particolare, il cervello umano, a causa della sua stessa complessità,
resta per lungo tempo, anche dopo la nascita, in uno stato quasi “embrionale”: questa
situazione costituisce uno svantaggio, in riferimento alla debolezza che caratterizza il
neonato ed il bambino (ma anche il fanciullo), ma rappresenta un grande vantaggio
dal punto di vista dell’apprendimento.
L’essere umano ha infatti a disposizione, in questo modo, un tempo enormemente
superiore a quello delle altre specie viventi, per acquisire e consolidare tutte le
informazioni necessarie al proprio adattamento all’ambiente: il suo cervello resta
estremamente plasmabile (cioè capace di immagazzinare conoscenze e competenze)
almeno fino all’adolescenza – mentre, ad esempio, un cagnolino è in possesso delle
conoscenze e dei comportamenti da “adulto” già dopo il primo anno di vita.
Veniamo all’ultimo dei punti sopra elencati: l’uso elaborato del linguaggio simbolico.
Il simbolo è lo strumento che consente di evocare tutto ciò che non è immediatamente
presente e (come dice lo stesso termine) di riunire una serie numerosa, o persino
infinita, di cose, riferendola ad un unico segno. Il simbolo per eccellenza è la parola:
la corrispondente voce greca lógos (lÎgov) indica proprio ciò che raccoglie (lego) il
molteplice nel semplice. Lo raccoglie in base ad un elemento comune che si è capaci
di scorgere in un vasto insieme di cose (al limite, nella totalità stessa delle cose). Il
pensiero che riesce a riunire in sé una molteplicità di elementi si chiama concetto – e
i greci dicono ancora lógos, a indicare la stretta relazione tra parola e concetto.
Le precedenti considerazioni ci portano in prossimità della filosofia, che è una
conquista specifica della cultura greca. Ma ciò non significa che i greci siano stati i
primi (e tanto meno gli unici) ad aver intuito la potenza del simbolo e della parola:
essi hanno semmai indagato più a fondo di altri – e quindi sviluppato ed applicato nel
modo più radicale – il senso di tale potenza. Per questo, l’“albero” che rappresenta la
nostra cultura ha radici greche; e per questo le nostre scienze continuano, nonostante
tutto, a parlare (e a pensare) in greco. Ma sulla filosofia ritorneremo più avanti.
Intanto vediamo di comprendere meglio la “potenza” della parola: in che senso,
anzitutto, la parola prevale sull’immagine? L’immagine ha certamente, a sua volta,
un potere simbolico: un triangolo disegnato sulla lavagna è in grado, ad es., di
rappresentare (dunque di riunire in qualcosa di semplice) una quantità infinita di
triangoli. Per certi aspetti, anzi, l’immagine può sembrare perfino più potente della
parola: l’immagine è in genere più ricca e più definita, essa cattura più facilmente
l’attenzione, e può essere compresa in maniera più facile ed immediata (non è un caso
che i libri per bambini siano sempre pieni di figure colorate). Questi sono certamente
dei vantaggi, rispetto alla parola detta o scritta.
Tuttavia, proprio la “ricchezza” e la “compiutezza” dell’immagine la rendono meno
fluida, meno versatile nel riunire in sé il molteplice. Se, come sostiene ancora Bruner,
l’apprendimento e l’intelligenza si sviluppano nel dire e nel pensare cose “al di fuori
del contesto” (cioè nel rendere in qualche modo presente tutto ciò che è fisicamente
assente), dobbiamo riconoscere che l’immagine resta sempre legata a una certa realtà
fisica: essa non è il miglior strumento per indicare ciò che sta “oltre il contesto”.
Cerchiamo di chiarire: un triangolo disegnato sulla lavagna, o il poster di una tigre
appeso alla parete evocano certamente una quantità indefinita di triangoli o tigri che
non stanno in questa stanza. Ma proviamo a rappresentare visivamente concetti come
“armonia”, “tristezza”, “società” etc. (che richiedono una notevole capacità di
astrazione): in questi casi, qualunque immagine, proprio per la sua compiutezza, per
il suo carattere ben definito, non potrebbe esprimere tali significati con la stessa
ampiezza delle corrispondenti parole. L’immagine, in situazioni del genere, chiude,
impoverisce la prospettiva; la parola la lascia del tutto aperta.
L’immagine suggerisce qualcosa di preciso, guida lo sviluppo dei nostri pensieri; e
per questo blocca almeno in parte la nostra fantasia e la nostra creatività. È il motivo
per cui, ad esempio, restiamo spesso delusi dalla visione di un film che vorrebbe
trasporre sullo schermo un romanzo che ci è piaciuto: a volte quasi ci offende la
scelta delle scene e degli stessi attori che rappresentano i personaggi principali,
perché appaiono del tutto diversi da come li avevamo pensati leggendo il libro: qui
l’immagine forza (nel senso che limita, restringe) la nostra capacità rappresentativa.
Non si sta dicendo, naturalmente, che non possano esistere bei film o bei quadri –
immagini, cioè, dotate di grande valore evocativo ed artistico (e poi ci sono i brani
musicali che costituiscono, in qualche modo “immagini sonore”…). Bisogna tuttavia
riconoscere che il linguaggio verbale rappresenta un enorme arricchimento rispetto a
tutto ciò che possono suggerire i simboli costituiti da forme definite e “compiute”.
Anche perché, lasciando da parte la sfera dell’arte, proviamo ad immaginare un libro
di fisica, o di storia, o di psicologia, fatto soltanto o prevalentemente di immagini. Per
non parlare di un elenco telefonico o di un manuale d’istruzioni.
Stabilito quindi l’indiscutibile dominio della parola in ambito simbolico, va aggiunto
che, se tutte le civiltà umane hanno conosciuto l’uso del linguaggio verbale, solo una
parte di esse (storicamente destinata a prendere il sopravvento) ha trasferito la lingua
parlata in quella scritta. Anche alla luce di quanto si è detto sopra, dovrebbe essere
evidente la superiorità della cultura scritta su quella semplicemente parlata.
Se la parola (come ha spiegato Bruner) ci permette di “pensare fuori dal contesto”, è
chiaro che tale capacità resta limitata se richiede la presenza fisica di un soggetto
parlante, che sappia “tutto ciò che noi ancora non sappiamo”. Il limite è dovuto sia al
fatto che un soggetto umano può immagazzinare una quantità limitata di conoscenze,
sia al fatto che egli non è sempre disponibile a comunicarle ad altri.
I libri rappresentano un’ottima soluzione per tali inconvenienti: in essi è contenuta
una quantità illimitata di sapere e, grazie alla stampa o (prima della sua invenzione) al
paziente lavoro degli amanuensi – il loro contenuto è disponibile in ogni momento ad
un numero illimitato di persone interessate a conoscerlo, e contemporaneamente a
persone fisicamente molto lontane tra di loro.
Nelle culture prive di scrittura il sapere non si accumula, ma si riproduce: chi impara
tende a trasmettere ad altri le stesse conoscenze e competenze che gli sono state
insegnate. Innovare è quasi impossibile, e l’apprendimento si basa per la maggior
parte sulla semplice imitazione. In tali culture, certamente, l’immagine svolge un
ruolo non meno importante della parola – proprio perché l’immagine è qualcosa che
resta, anche se non se ne parla, ed è disponibile alla collettività in ogni momento.
Anche le culture scritte, però, non sono necessariamente innovative: spesso i loro
testi fondamentali sono libri sacri, che si tramandano attraverso i secoli, e che non è
lecito modificare o re-interpretare. Tuttavia, in queste culture, è quasi inevitabile che
si scrivano via via nuovi libri e che in essi si sviluppino temi e concetti che integrano
ed arricchiscono i contenuti della tradizione. Diciamo che tali culture sono, almeno in
potenza e tendenzialmente, più dinamiche ed aperte al rinnovamento di quelle che
non conoscono la scrittura. Anche se, per mettere davvero in moto la storia ed il
progresso, come li concepiamo noi, bisogna aspettare – come al solito – i greci.
Tra le culture scritte, hanno particolare rilievo quelle che hanno utilizzato la scrittura
alfabetica. I primi che hanno avuto l’idea di esprimere con un numero assai limitato
di segni tutto ciò che l’uomo può dire o pensare sono stati, quasi certamente, i fenici.
L’alternativa alla scrittura alfabetica è quella ideografica (v. geroglifici egizi, scrittura
cuneiforme arcaica, ideogrammi cinesi) in cui ad ogni parola corrisponde un segno
(spesso anche molto complesso). Tenendo presente quanto si è detto sopra sulla
potenza della parola rispetto all’immagine, si può considerare l’ideogramma come un
elemento intermedio tra le due; dal che segue la superiorità (nel senso della maggior
versatilità e gestibilità pratica) della notazione alfabetica.
Sta di fatto che quasi tutte le scritture ideografiche tendono ad evolversi in scritture
sillabiche (v. sumerico, lineari minoica e micenea) e queste ultime in alfabetiche
(v. ugaritico, aramaico, ebraico, arabo, brahmi, greco, latino…). Resta la grande
eccezione della lingua cinese che ha sviluppato l’antica notazione per ideogrammi in
una scrittura basata non sui fonemi (cioè sulle unità fonetiche, proprie delle lingue
sillabiche ed alfabetiche), ma sui morfemi (cioè sulle unità significanti).
L’invenzione della stampa a caratteri mobili, verso la metà del Quattrocento, e la
diffusione dei computer, nella nostra epoca, hanno evidenziato definitivamente la
grande efficacia delle scritture alfabetiche.
♣ La “preistoria” della pedagogia
Prima che la pedagogia nascesse in Grecia, intorno al VI / V secolo a. C., come
riflessione filosofica sull’educazione, esistevano già da millenni grandi culture umane
che, naturalmente, avevano le proprie strutture educative. In particolare: la civiltà
egizia, le civiltà mesopotamiche e quella indiana (risalenti almeno al III millennio a.
C.), la civiltà ebraica, quella cretese e quella cinese (II millennio a. C). Anche in
Grecia, dopo il periodo cretese e quello miceneo, fiorisce una potente civiltà ionicodorica, unificata culturalmente – anche se non politicamente – da comuni credenze
religiose, comuni cerimonie (v. giochi olimpici), e da una comune scrittura alfabetica.
Anche se si tratta di civiltà molto diverse, e spesso lontane tra di loro nello spazio e
nel tempo, possiamo cogliere alcune somiglianze nei loro sistemi educativi.
♦ Il sapere – ed anzitutto la capacità di scrivere e leggere – non è riservato a tutti, ma
solo a strati privilegiati della popolazione: gli addetti alle cose sacre (i sacerdoti
dell’Egitto o i bramini dell’India); i capi politici e militari (gli aristocratici greci, gli
ksatriya indiani); gli scrivani a servizio dell’autorità religiosa o dell’amministrazione
pubblica (scribi egizi, babilonesi, ebrei*).
♦ Ogni conoscenza è vista come funzionale ad una certa attività (religiosa, militare,
amministrativa), e appunto per questo è destinata solo a coloro che la svolgono. Gli
egizi e i babilonesi sono ad es. profondi cultori della matematica e dell’astronomia,
ma s’interessano a tali dottrine soltanto in relazione alla misura dei terreni, o alla
compilazione dei calendari con le ricorrenze sacre. Manca insomma, in tutte queste
culture, il concetto di un sapere che rappresenti un valore per se stesso.
♦ I metodi d’insegnamento sono estremamente severi ed autoritari: imparare è
anzitutto un dovere nei confronti della società: «L’orecchio di un ragazzo, in verità, si
trova sulla schiena», recita un frammento egizio, alludendo all’uso del bastone.
♦ Il contenuto delle discipline è rigido, ossia viene tramandato in maniera sempre
identica, e non può essere fatto oggetto di critica, e neanche di discussione.
E qui siamo arrivati ad un punto chiave del nostro discorso: tutta la cultura (greca o
non greca) che precede la nascita della filosofia, mostra un rispetto assoluto della
tradizione, cioè di quell’insieme di credenze religiose, di regole e costumi, di valori
etici che strutturano la vita di un popolo. Tutto ciò si può riassumere in un’unica
parola, dicendo che la cultura pre-filosofica si fonda sul Mito.
*
L’educazione ebraica, d’altra parte, costituisce un’interessante eccezione: essa prevedeva che
l’intera popolazione (e soprattutto quella di sesso maschile) acquisisse almeno la capacità di
leggere i testi sacri – ossia la cosiddetta Torah, i primi cinque libri dell’Antico Testamento. Ogni
padre di famiglia svolgeva, di conseguenza, anche un qualche ruolo di maestro presso i propri figli.
Mythos (in greco: màjov) è una di quelle parole che danno un po’ di vertigine: il suo
significato originario, infatti, è precisamente “parola” o “racconto”. Una parola,
dunque che indica anzitutto se stessa; esattamente come il termine lógos che abbiamo
incontrato in precedenza. Ma proprio nella contrapposizione di queste due parole (che
significano entrambe “parola”) possiamo cogliere la novità in cui consiste la filosofia.
Il Mito è infatti il dire dell’autorità (auctoritas: bellissima voce latina, la cui analisi ci
porterebbe assai lontano): esso è ritenuto “vero” per il semplice fatto che una certa
persona, o un certo gruppo sociale, o un certo libro, ha il consenso di tutti o quasi tutti
gli appartenenti alla società. Proviamo a chiedere all’Autorità: «Perché si deve agire
in questo modo?» o: «Perché si deve credere in queste cose?»; e l’Autorità (persona,
o gruppo di persone, o libro) risponde: «Perché lo dico io, e io non posso sbagliare!».
Tentiamo d’insistere, e chiediamo ancora all’Autorità: «Come si può essere sicuri che
tu non sbagli mai?»; e l’Autorità risponde: «Proprio perché lo dico io, che per
l’appunto non sbaglio mai». Un circolo vizioso, insomma – tenuto in vita dal semplice
fatto che l’Autorità possiede la forza sufficiente per mantenersi al potere: contestare
questo tipo di autorità sembra come minimo inutile; ma più spesso si rivela molto
scomodo e soprattutto, in passato, è stato anche estremamente pericoloso.
Poi, un giorno, arriva un tizio che propone un modello diverso di “verità” e di
“giustizia”: questo tizio ritiene che un’idea sia vera, o giusta, non in base alla forza di
chi la sostiene, non in base all’antichità di un certo libro su cui è scritta, e neanche al
numero di persone che la professano. Un’idea, dice costui, deve apparire vera o
giusta in se stessa: deve mostrare da sola, senza l’aiuto di alcuna antica tradizione o
potente casta, che è impossibile negarla o ignorarla. È apparso il primo filosofo.
L’Autorità non è abituata a discorsi di questo tipo – e soprattutto non può trovare
argomenti per farsi obbedire da chi le obietta semplicemente: «Non credo in te, le tue
risposte non mi bastano e non mi convincono». L’Autorità non ha più niente da
dirgli: può solo ordinargli di tacere e, al limite, tappargli la bocca uccidendolo (ed ha
di solito la forza per farlo). A questo punto il filosofo si trova a scegliere tra la vita ed
il suo amore (philía) per ciò che è chiaro (sophía); e sceglie la seconda strada.
Questa strada è qualcosa di assolutamente nuovo, e inevitabilmente, prima o poi, altri
la seguiranno. L’autorità del Mito vacilla, perché qualcuno ha visto che si trattava
solo di una maschera, che ha potere solo finché la gente crede nella sua serietà e
solidità. La nuova forma di sapere che sta nascendo rifiuta la fede (che è un accettare
per buono ciò che non si vede) ed ascolta solo la ragione (la parola che testimonia ciò
che appare, innegabilmente, nella chiarezza della verità). Questa parola è appunto il
Lógos filosofico, che rifiuta il vecchio dominio del Mythos; il filosofo, o uno dei
primi filosofi, che ha scelto di morire per indicare la via, si chiama Socrate.
♣ Gli inizi del pensiero pedagogico
Socrate si può considerare, per alcuni motivi che vedremo più avanti, il fondatore
della pedagogia occidentale; ma quando egli nasce (nel 469 a. C.) la filosofia ha già
almeno un secolo di vita. Altri pensatori, prima di lui, hanno già chiaro che nessuna
autorità (religiosa, politica, militare) portatrice del Mythos può rivendicare quella
verità – cioè quella capacità di non sbagliare – che si esprime nel Lógos.
“Verità”, in greco si dice alétheia („l©jeia) e quest’ultimo termine significa “il non
stare nascosto”, cioè appunto il mostrarsi in assoluta chiarezza. E il sapere che ha per
oggetto il vero (= ciò che non è nascosto) prende il nome di epistéme (¢pist©mh):
questo termine (che come si è detto corrisponde al latino scientia) indica una dottrina
che sta ferma (perché non può essere negata in alcun modo e da nessuno) e che
insieme sta al di sopra (epí) di ogni sapere incerto e di ogni realtà mutevole.
Ma c’è un altro aspetto – non meno importante – che caratterizza la nascita della
filosofia. Si è già visto come già da molti secoli altri popoli (e lo stesso popolo greco)
usino simboli e parole per riunire in un unico concetto una molteplicità di cose. Ma è
il linguaggio filosofico che, per la prima volta riesce a riunire in un’unica parola o
concetto (= in un unico Lógos) tutto ciò che può essere riunito: la totalità di ciò che si
può pensare o di cui si può parlare. È una parola estremamente semplice, che già da
secoli esiste nella lingua greca (ed a cui corrispondono altre parole in altre lingue),
ma che solo adesso viene usata in questa maniera assolutamente radicale. Si tratta
della parola “essere” (eînai – eËnai); ed ogni cosa che tale parola riunisce prende il
nome di “ente” (ón – Ón). La filosofia è anzitutto ontologia.
Tutto questo può sembrare relativamente semplice; eppure si tratta del progetto più
ambizioso che la mente umana abbia concepito in tutta la sua storia: la costruzione di
un sapere infallibile e che non lascia assolutamente nulla fuori dalla sua capacità
conoscitiva. Si capisce allora che tutti i progetti e sistemi educativi che nasceranno
all’interno di tale sapere avranno a loro volta l’ambizione inaudita di formare l’uomo
non più secondo questo o quel modello di società, ma di formarlo in assoluto,
secondo ciò che l’uomo dovrebbe essere alla luce della giustizia e della verità.
Si diceva che Socrate non è il primo a pensare la realtà secondo questa prospettiva
così nuova e radicale; ma egli è il primo a indicare con chiarezza le sue conseguenze
in campo educativo, perché è il primo a chiedersi in modo esplicito che cosa significa
“insegnare” e che cosa significa “imparare” – e a dare risposte che guideranno lo
sviluppo successivo della pedagogia. Tra i pensatori che vengono prima di Socrate (e
per questo sono detti “pre-socratici”) ve ne sono comunque alcuni che hanno dato
altri importanti contributi all’organizzazione ed alla trasmissione del sapere.
La prima corrente di pensiero che propone una distinzione tra le varie discipline, è
quella pitagorica : una scuola fondata da Pitagora (sapiente nato a Samo, isola del
mar Egeo) a Crotone, nell’odierna Calabria. Che alcuni dei primi e più importanti
movimenti filosofici fioriscano in Italia, non è in contraddizione con il loro carattere
greco: parliamo infatti di colonie, fondate dalle più potenti città della Grecia, i cui
abitanti si esprimono in lingua greca e vivono secondo costumi greci (non a caso
l’Italia meridionale verrà detta dai latini: “Magna Graecia”).
I pitagorici mettono al centro della loro dottrina la matematica: essi ritengono infatti
che i numeri non siano semplicemente uno strumento per misurare la terra o calcolare
la posizione dei pianeti (come accadeva tra gli egizi e i babilonesi), ma prima ancora
rappresentino la struttura stessa dell’universo. In questo modo, la scuola pitagorica
anticipa di due millenni quella mentalità scientifica che si formerà nell’Europa
rinascimentale, attraverso le ricerche di Leonardo, Galileo, Newton etc.
La scienza dei numeri (aritmetica) fonda quella delle figure (geometria) e si applica
allo studio dei pianeti e delle stelle (astronomia). Essa consente anche l’indagine dei
suoni: della loro altezza e della loro durata (acustica – o musica, come sarà poi più
spesso chiamata). Vengono così individuate quelle quattro discipline che, a partire
dalla tarda età ellenistica (V sec. d. C.) e fino agli inizi dell’età moderna saranno
indicate come “Arti del Quadrivio”: l’equivalente delle nostre materie “scientifiche”.
Riguardo alle discipline “umanistiche”, la situazione è un po’ più complessa: la
riflessione sull’uomo (e sulla sua capacità di conoscere) è naturalmente già presente
nei primissimi filosofi; ma è soprattutto ai tempi di Socrate, e nella città di Atene, che
l’uomo e la società umana sono messi proprio al centro dell’attenzione (per questo si
parla anche di periodo antropologico della filosofia).
Ma a complicare davvero le cose c’è il fatto che i primi ad interessarsi specificamente
dell’uomo e della società, sono “filosofi” di tipo un po’ particolare, i quali criticano
certamente la tradizione e l’autorità che la rappresenta (come fa appunto la filosofia
in generale), ma non in nome di un Lógos unico ed infallibile. Essi ritengono, invece,
che il “vero” e il “giusto” cambino con i luoghi, i tempi, e le stesse prospettive degli
uomini; in breve, come afferma Protagora, uno dei più famosi tra questi pensatori
(che prendono il nome di sofisti), «L’uomo è la misura di tutte le cose».
I sofisti hanno il gran merito di mettere in moto la discussione: secondo loro nessun
uomo è mai in possesso di una verità definitiva, ed è quindi lecito porre in dubbio
qualsiasi idea o valore, E tanto più numerosi saranno gli uomini che discutono, tanto
più valido sarà il loro eventuale accordo: per questo, i sofisti si dedicano ad insegnare
il loro sapere a tutti coloro che lo chiedono (e che possono pagare le lezioni), senza
distinguere tra aristocrazia e ceti popolari. Essi promuovono così la democrazia.
Mettere in dubbio qualsiasi idea o valore: in fondo proprio questo vuol fare la
filosofia, quando al Mythos oppone il Lógos. Ma la filosofia intende discutere quelle
idee e quei valori che si lasciano mettere in discussione: essa vuole scardinare il
vecchio sapere, perché si sente portatrice di un sapere nuovo e definitivo (= non più
discutibile). Da questo punto di vista, i sofisti non sono filosofi: essi sono piuttosto
grandi anticipatori della cultura contemporanea, di quella cultura scientifica empirica
ed ipotetica che, dopo essere germogliata come un ramo laterale dal tronco della
filosofia, si è via via allontanata da esso, fin quasi a perderlo di vista.
Questa è però storia recente: nel mondo greco, la voce dei sofisti – pur così energica e
brillante – non è destinata a prendere il sopravvento. L’albero filosofico, nato da
pochi decenni, è in grado di impedire, per adesso, una diramazione del genere: quella
diramazione sta già nel futuro dell’albero, è un po’ scritta nel suo DNA. Ma, prima che
ciò avvenga, l’albero dovrà crescere per secoli e secoli.
Socrate, Platone, Aristotele: tre pensatori la cui voce risuona, nel mondo antico, con
una potenza incomparabilmente superiore a quella dei sofisti; e proprio per opera di
questi tre grandi pensatori, la stessa parola sofista – che originariamente voleva dire
semplicemente “sapiente” – assume una connotazione negativa, finisce per indicare il
finto sapiente, colui che non ama la verità, la chiarezza, ma piuttosto l’inganno e la
confusione. La retorica, che è la disciplina prediletta dai sofisti (l’arte di parlare bene
e di impressionare e convincere chi ascolta) è vista da molti come nemica della vera
filosofia: Platone, ad esempio, paragonerà quest’ultima alla medicina (che può a volte
sembrare amara, ma produce salute e benessere), e la prima alla gastronomia (l’arte
di cucinare cibi squisiti, che però, a lungo andare, rovinano lo stomaco)**.
La retorica, comunque, verrà successivamente assunta come una delle tre discipline
“umanistiche” (le Arti del Trivio), quasi a riconoscere alla cultura sofistica di aver
lasciato, dopo tutto, qualche traccia importante. Le altre due arti sono la grammatica
(che è la capacità di tradurre la realtà in linguaggio scritto o parlato – e che Platone,
pur con qualche riserva per la scrittura, di fatto apprezza), e la dialettica (l’arte logica
di argomentare), che Platone identifica con la stessa filosofia. Ma la filosofia è vista,
in effetti, come l’ambito generale del sapere che comprende in sé le varie discipline.
Torniamo ai sofisti e alla profonda distanza che li separa dal loro contemporaneo
Socrate. Tra di essi esiste certamente anche un’affinità: la critica della tradizione
(cioè del Mythos). Ma, come si accennava sopra, si può rifiutare ciò che è autorevole
semplicemente perché ci si vuol liberare da ogni dottrina e valore consolidati (è ciò
che intendono fare i sofisti), oppure perché si vuol costruire la vera dottrina e seguire
il vero valore (e questa è l’intenzione di Socrate). Allo stesso modo, si può distruggere
un edificio solo per fare pulizia e ricavare spazio, o per costruirne uno più stabile.
**
Platone ammette anche una “buona” retorica, ma quest’ultima coincide con la stessa capacità
persuasiva della filosofia (che trae forza dai propri contenuti, e non già dalla forma esteriore).
Qualcuno ha scambiato Socrate per un sofista perché ha colto solo l’aspetto negativo
(distruttivo) del suo pensiero. In effetti può essere questa l’impressione che, in un
ascoltatore superficiale, potrebbe produrre la più nota delle affermazioni di Socrate:
«So di non sapere nulla». Ma il “sapere” che Socrate rifiuta è appunto quello della
tradizione, del mito, e la precedente frase potrebbe dunque essere riscritta come
segue: «So che nulla di ciò che mi hanno insegnato, nulla di ciò in cui credono i miei
concittadini, ha titolo per essere considerato “vero”».
Ma il “so” che apre la frase è un verbo forte: rappresenta il criterio stesso della verità.
Socrate intende dire che si sente capace di riconoscere ciò che non è vero, proprio
perché saprebbe riconoscere il vero, se mai lo incontrasse: è come un cercatore d’oro
che ancora non ha trovato pepite del prezioso metallo, ma sa bene come sono fatte e
come bisogna cercarle – al contrario degli altri cercatori, che hanno riempito le loro
borse di sassi e ferraglia, illudendosi di aver trovato l’oro. Quanto ai sofisti, in questa
metafora essi sarebbero quelli che non credono nell’esistenza dell’oro, che neanche lo
cercano, e che anzi deridono chi lo cerca o chi crede persino di averlo trovato.
Socrate invece non deride nessuno; Socrate sorride. Anche di se stesso – perché sa
bene di essere povero, quasi come gli altri; e sa anche che il non-sapere non è una
colpa: semmai è una sventura (chi non sa è infelice, e merita pietà). Sicché, anche
quando parla con qualcuno che presume di conoscere tante cose, e pian piano lo porta
a constatare che si tratta di un’illusione, lo fa senza cattiveria, con indulgenza; come
se gli dicesse: «Guarda che anch’io, come te, non so niente: cerchiamo insieme la
verità». Ma per ottenere questo risultato egli finge, dapprima, di ammirare la sapienza
del proprio interlocutore, in modo da costringerlo ad esporsi, a mettersi in gioco, ed
infine a toccare con mano la propria reale condizione. Questa è l’ironia socratica.
E siamo al nocciolo della questione: Socrate afferma di non aver niente da insegnare
a nessuno; dice di fare un po’ lo stesso mestiere di sua madre – che era una levatrice,
cioè una donna che aiutava le altre donne a partorire. E come una levatrice può far
partorire solo le donne che hanno già in grembo un bambino, così Socrate avverte di
poter insegnare qualcosa solo a chi è già capace d’intravedere la verità. Maíeusis è, in
greco, l’arte della levatrice, e maieutica è il nome che prende il metodo socratico.
Vediamo di chiarire ciò che vuol dire Socrate: quello che io (maestro) so è, in fin dei
conti, poco importante; l’essenziale è ciò che tu (allievo) sai scorgere dentro di te. Se
ciò che ti dico arriva solo dall’esterno, non potrai mai capirlo: per capire davvero una
cosa bisogna ri-conoscerla, sentirla propria, senza intermediari. Per capire cos’è il
sole, devi vederlo direttamente, non ascoltarne la descrizione e fidarti di chi te ne
parla. Il sole sta lì, e brilla per tutti: io posso indicarti come guardarlo, ma non posso
guardare al tuo posto. E proprio questa è l’essenza (filosofica) della pedagogia.