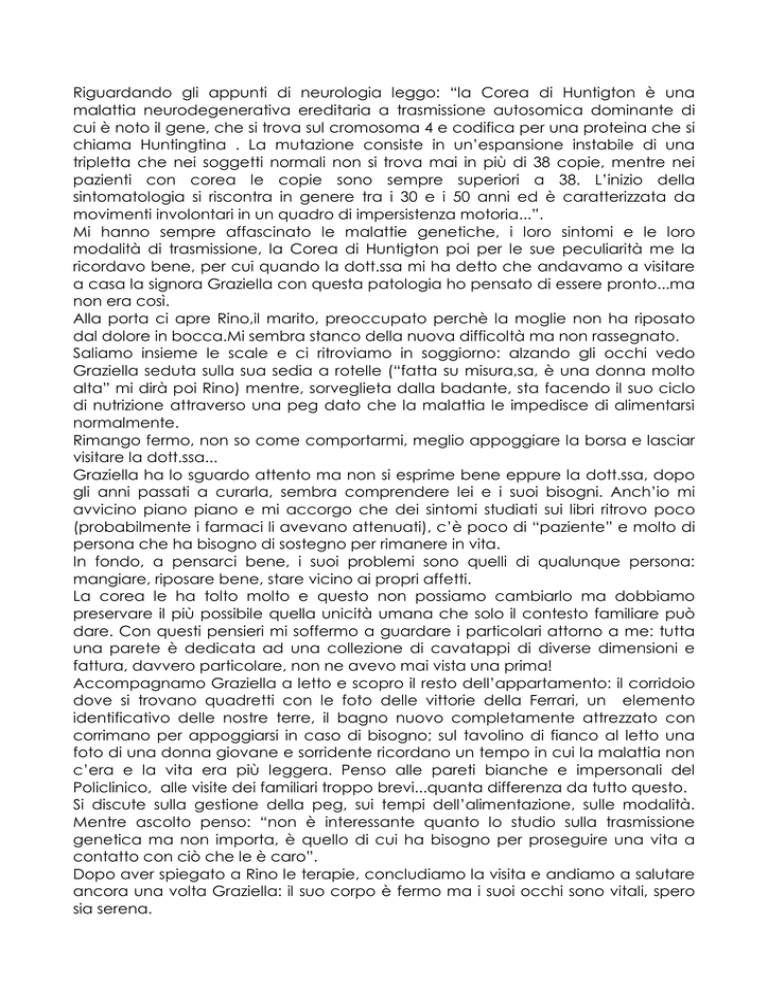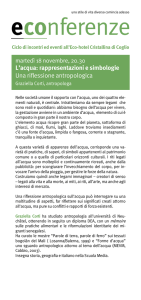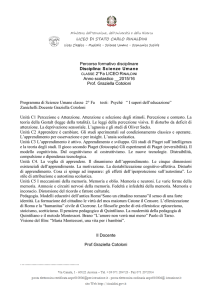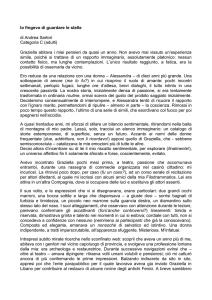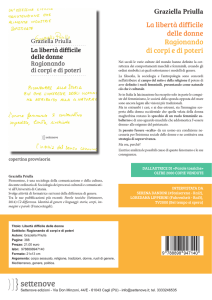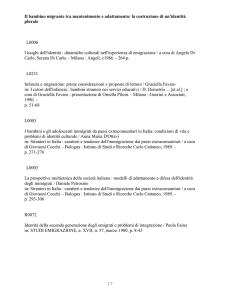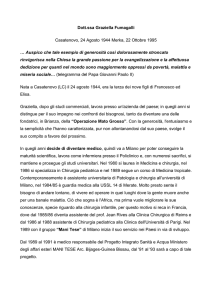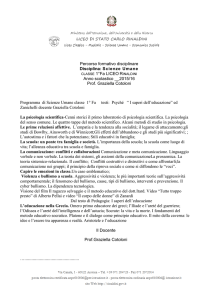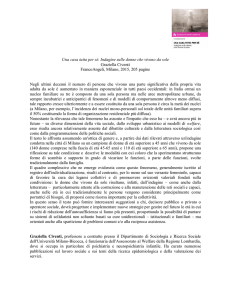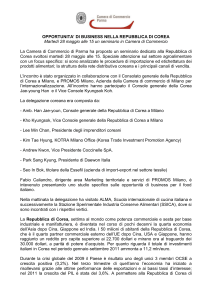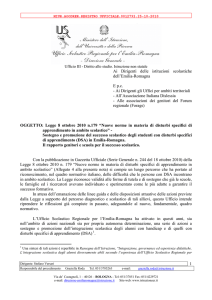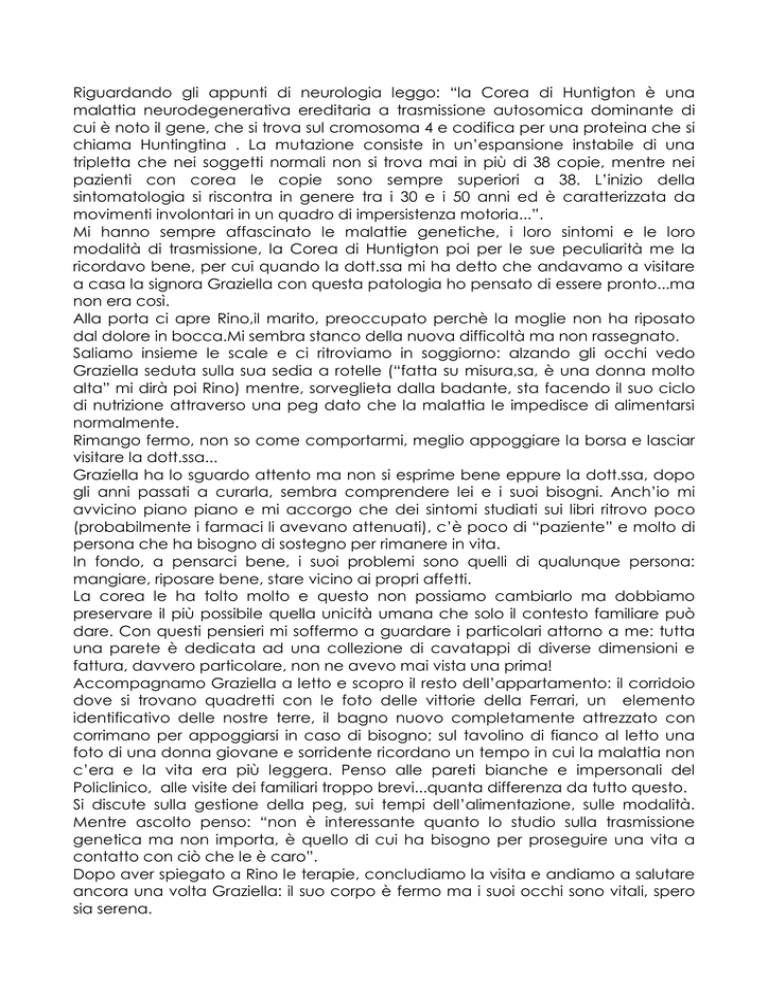
Riguardando gli appunti di neurologia leggo: “la Corea di Huntigton è una
malattia neurodegenerativa ereditaria a trasmissione autosomica dominante di
cui è noto il gene, che si trova sul cromosoma 4 e codifica per una proteina che si
chiama Huntingtina . La mutazione consiste in un’espansione instabile di una
tripletta che nei soggetti normali non si trova mai in più di 38 copie, mentre nei
pazienti con corea le copie sono sempre superiori a 38. L’inizio della
sintomatologia si riscontra in genere tra i 30 e i 50 anni ed è caratterizzata da
movimenti involontari in un quadro di impersistenza motoria...”.
Mi hanno sempre affascinato le malattie genetiche, i loro sintomi e le loro
modalità di trasmissione, la Corea di Huntigton poi per le sue peculiarità me la
ricordavo bene, per cui quando la dott.ssa mi ha detto che andavamo a visitare
a casa la signora Graziella con questa patologia ho pensato di essere pronto...ma
non era così.
Alla porta ci apre Rino,il marito, preoccupato perchè la moglie non ha riposato
dal dolore in bocca.Mi sembra stanco della nuova difficoltà ma non rassegnato.
Saliamo insieme le scale e ci ritroviamo in soggiorno: alzando gli occhi vedo
Graziella seduta sulla sua sedia a rotelle (“fatta su misura,sa, è una donna molto
alta” mi dirà poi Rino) mentre, sorveglieta dalla badante, sta facendo il suo ciclo
di nutrizione attraverso una peg dato che la malattia le impedisce di alimentarsi
normalmente.
Rimango fermo, non so come comportarmi, meglio appoggiare la borsa e lasciar
visitare la dott.ssa...
Graziella ha lo sguardo attento ma non si esprime bene eppure la dott.ssa, dopo
gli anni passati a curarla, sembra comprendere lei e i suoi bisogni. Anch’io mi
avvicino piano piano e mi accorgo che dei sintomi studiati sui libri ritrovo poco
(probabilmente i farmaci li avevano attenuati), c’è poco di “paziente” e molto di
persona che ha bisogno di sostegno per rimanere in vita.
In fondo, a pensarci bene, i suoi problemi sono quelli di qualunque persona:
mangiare, riposare bene, stare vicino ai propri affetti.
La corea le ha tolto molto e questo non possiamo cambiarlo ma dobbiamo
preservare il più possibile quella unicità umana che solo il contesto familiare può
dare. Con questi pensieri mi soffermo a guardare i particolari attorno a me: tutta
una parete è dedicata ad una collezione di cavatappi di diverse dimensioni e
fattura, davvero particolare, non ne avevo mai vista una prima!
Accompagnamo Graziella a letto e scopro il resto dell’appartamento: il corridoio
dove si trovano quadretti con le foto delle vittorie della Ferrari, un elemento
identificativo delle nostre terre, il bagno nuovo completamente attrezzato con
corrimano per appoggiarsi in caso di bisogno; sul tavolino di fianco al letto una
foto di una donna giovane e sorridente ricordano un tempo in cui la malattia non
c’era e la vita era più leggera. Penso alle pareti bianche e impersonali del
Policlinico, alle visite dei familiari troppo brevi...quanta differenza da tutto questo.
Si discute sulla gestione della peg, sui tempi dell’alimentazione, sulle modalità.
Mentre ascolto penso: “non è interessante quanto lo studio sulla trasmissione
genetica ma non importa, è quello di cui ha bisogno per proseguire una vita a
contatto con ciò che le è caro”.
Dopo aver spiegato a Rino le terapie, concludiamo la visita e andiamo a salutare
ancora una volta Graziella: il suo corpo è fermo ma i suoi occhi sono vitali, spero
sia serena.
Scendendo le scale penso di aver fatto poco durante questa visita, di non essere
stato utile ma nello stesso tempo credo di aver imparato che la vita ha tante
dimensioni alcune delle quali bisogna accettare, altre preservare con coraggio.
Ed ora, in un momento in cui riemerge con forza il problema dell’eutanasia,
ripenso a Graziella circondata di attenzioni nella propria casa e mi chiedo, è una
vera scelta la cosidetta “dolce morte”? E’ possibile programmare di essere lasciati
morire prima che una grave malattia si sviluppi o comunque ai suoi albori?
Se avessero detto a Graziella da giovane che non sarebbe più riuscita a mangiare
da sola a causa della Corea di Huntington, forse avrebbe affermato come tanti
“non alimentatemi con la peg o altre macchine, quella non è vita!”. Ora che la
malattia è arrivata però non vedo disperazione nei sui occhi e in quelli delle
persone che le stanno vicino, stanchezza certo, ma anche la consapevolezza che
gli sforzi fatti sono ripagati dal fatto di continuare a stare insieme.
Crediamo davvero che l'eutanasia riguardi solo noi stessi? Siamo veramente in un
settore in cui può dominare da solo il principio della libertà e della
autodeterminazione?
Io credo che la morte non sia una scelta libera ma anzi solo una via obbligata che
il vuoto degli affetti, la solitudine, il senso di inutilità ci costringono a percorrere.
…Penso che non siano i pazienti anziani, cronici e allettati più a rischio di
accanimento terapeutico, anzi al contrario sono proprio quelli che danno più
“fastidio” alla maggioranza dei medici.
Allora quale strumento migliore della mancata assistenza per assecondare la
“libera scelta” di morire di queste persone?
La medicina tecnologica e iperspecialistica di oggi non riesce a dare una risposta
idonea alla richiesta di aiuto di una moltitudine di pazienti, pertanto invece di
cambiare la propria impostazione e formare medici (ma anche uomini e donne)
preparati al sacrificio della cura, si trincera spesso dietro una presunta “libertà
etica” che consente al paziente di fare si sè quello che vuole.
Il medico (soprattutto nel ruolo di specialista, ma non solo) che vede nel paziente
prevalentemente una patologia, di fronte ad una malattia attualmente inguaribile
come quella di Graziella, dirà a lei e ai familiari: “ho fatto tutto il possibile, ma per
la Corea non si può fare molto, ora che vi ho informato decidete voi cosa fare”.
Se neppure il medico crede di poter aiutare e curare un paziente (anche
inguaribile) fino alla fine, come si può pensare che il malato e chi gli sta
accanto,se c’è, creda che valga la pena fare sacrifici per vivere?
E’ questo il diritto di programmare la propria morte? Io non vedo un barlume di
libertà in una scelta di questo tipo.
L’eutanasia, anche intesa come rifiuto della cura, rappresenta la formalizzazione
del fallimento della medicina, vista come “terapia risolutiva” e non “cura
condivisa” . Un fallimento che, come spesso capita, grava sulle persone più deboli
e sole che sarebbero le prime a “giovarsi” di queste nuove “libertà e diritti”.
Noi futuri medici, ma in generale tutti coloro che hanno responsabilità di cura ,
dobbiamo prepararci molto di più ad accettare la frustrazione della “mancata
risoluzione” della patologia, per moltiplicare gli sforzi di ascolto e cura della
persona con cui ci rapportiamo.
Solo se abbiamo la consapevolezza di essere un sostegno per il paziente, in
qualunque momento della sua sofferenza, possiamo trasmettere non illusioni ma
fiducia nella vita.
Se siamo in grado di far capire alla persona malata che avrà da noi aiuto in
qualsiasi stadio della sua patologia cronica, fosse anche solo l’ascolto, allora forse
riuscieremo veramente a trasmettere gli strumenti giusti per valutare con libertà se
continuare a vivere o lasciarsi morire.