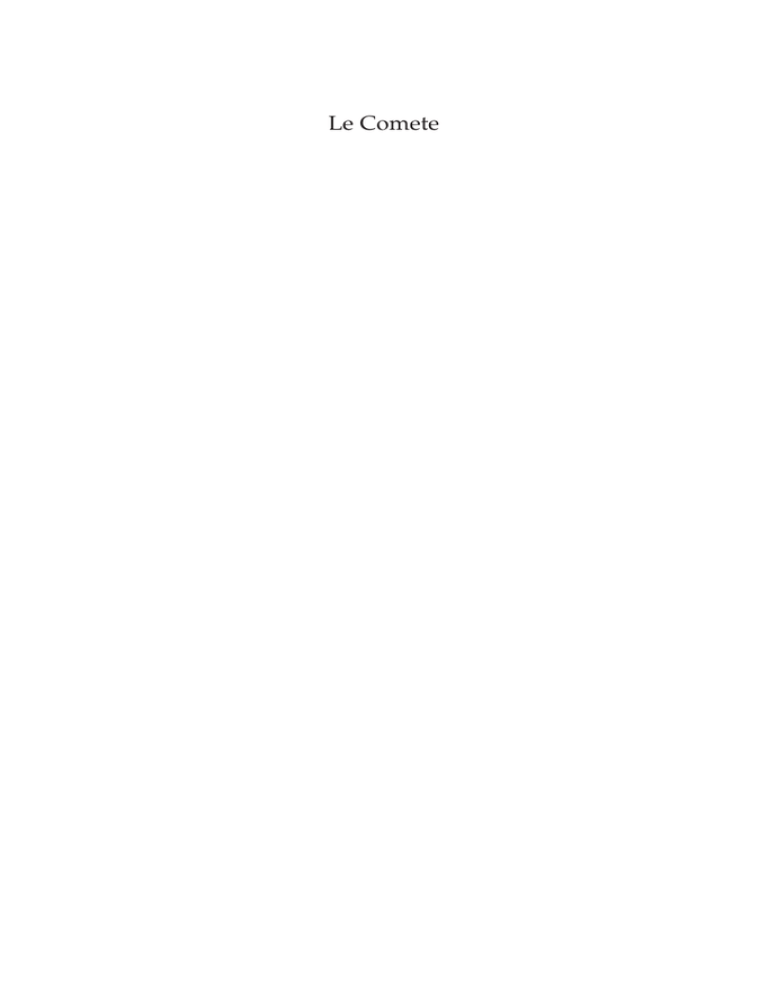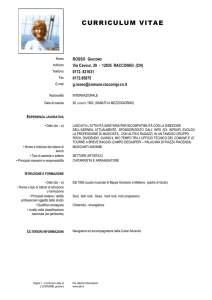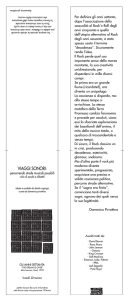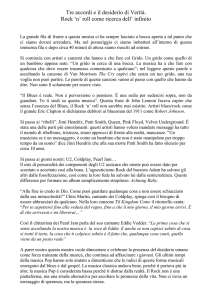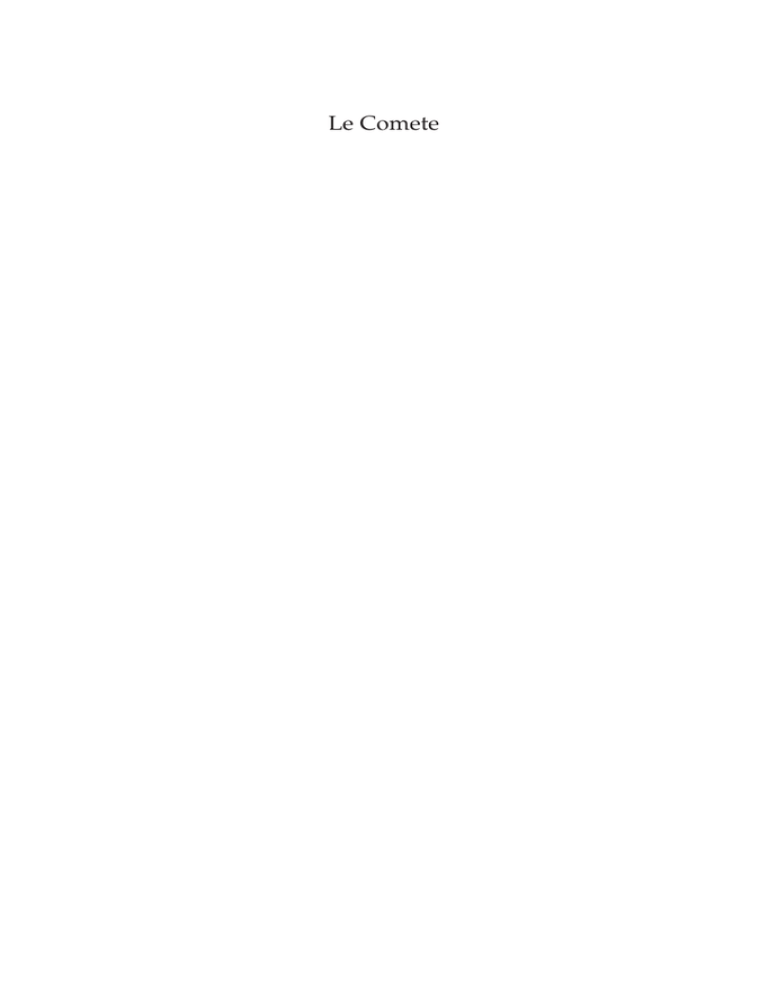
Le Comete
In copertina: © iStockphoto
© 2012 Lindau s.r.l.
corso Re Umberto 37 - 10128 Torino
Prima edizione: settembre 2012
ISBN 978-88-6708-013-7
Walter Gatti
LA LUNGA
STRADA DEL ROCK
Canzoni, desideri, religiosità nelle storie
di un cronista musicale
prefazione di Andrea Monda
postfazione di Giuseppe Frangi
Prefazione
La lunga, anzi inesauribile, strada del rock
Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni, popola uno spazio con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di navi, d’isole, di pesci, di dimore, di
strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Poco prima di morire,
scopre che quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del
suo volto. 1
Al termine della Lunga strada del rock scritta, anzi «percorsa» da Walter Gatti, mi è venuto in mente il famoso epilogoapologo di Borges; anche l’autore di questo saggio si è proposto il compito di disegnare il mondo e forse anche lui, concluso il paziente lavoro, ha finito per realizzare un autoritratto. Il mondo disegnato da Gatti è il brulicante mondo del
rock, un universo popoloso, variegato, degno di un quadro
di Bosch: «Nel pianeta rock si incontrano popoli diversissimi» avverte in apertura e di questo mondo quindi la prima
cosa da fare è una mappa. Una mappa non è l’immagine fotostatica della realtà, perché paradossalmente una mappa è il
contrario dell’oggettività (e qui viene ancora in soccorso Borges con il racconto dei cartografi che su richiesta dell’Imperatore della Cina finirono per realizzare una mappa grande
quanto l’Impero), la mappa non è mai statica ma dinamica
6
A. MONDA
perché è basata sulla ricerca di una «scala», di un valore, di
un principio, di qualcosa che ha a che fare con lo sguardo di
chi ha deciso di esplorare il territorio «mappato»; ne consegue che questa splendida mappa del rock è, anche, in parte,
l’autoritratto del cartografo-esploratore.
Walter Gatti, che ho avuto il piacere di conoscere di persona da poco tempo (ma abbiamo subito azzerato il tempo
pregresso) lo ripete spesso: «L’oggettività non esiste, o comunque non mi interessa. Il rock mi piace e mi piace raccontarlo partendo da ciò che in quella canzone, in quell’autore mi colpisce, colpisce me, la mia storia, la mia sensibilità». E lo ripete anche in apertura di questo saggio quanto
parla dei personaggi del rock, «se il rock è un pianeta, se
mille sono le strade con cui attraversarlo, ecco qui un dedalo di incontri che ho fatto divagando sulle sue strade.
Condotto per lo più da una cosa che chiamerei curiosità.
Che è il mio unico autentico sesto senso».
Un dedalo di incontri, ecco in effetti cos’è questo libro che
avete tra le mani. Incontri di diversa qualità, perché diversissime sono le persone che Gatti con tenacia è andato a scovare (e quanto invidia ho provato per alcuni di questi, da B.
B. King a Shane McGowan, solo per fare due nomi) ma sempre con quel granello di verità che è tipico di ogni incontro.
Anche se ci conosciamo da poco, io e Walter siamo d’accordo sul fatto che solo un incontro può cambiare la vita a conferma dell’aforisma di Oscar Wilde: «Le cose importanti della vita non si apprendono né si insegnano, si incontrano». In
questi 30 anni di passione musicale praticata sul campo Walter Gatti ha vissuto tanti incontri e li restituisce generosamente al lettore con una scrittura a un tempo sobria e fresca.
A spingerlo verso questa «pratica» dell’incontro è appunto la curiosità, la più ambigua (ma pur sempre una) del-
PREFAZIONE
7
le virtù, che lo spinge, ad esempio, a penetrare nella oscurità di un rave-party in Svizzera, una delle pagine più forti
di questo reportage di tre decenni di rock, che lo stimola a
rivolgere domande vere, quindi anche scomode, ai suoi interlocutori. Che gli rispondono con altrettanta verità. Mi
piace molto ad esempio lo scambio con i Metallica quando
affermano l’«inesauribilità» del rock: «Per il resto la chitarra è uno strumento che nel rock non sarà mai approfondito
abbastanza. Non credo a quelli che dicono che è stato detto
tutto», e rispondono per le rime all’affondo del curioso
esploratore: «Però voi siete ricchi: una band celebre, che fa
quel che vuole della sua vita, circondata da rispetto, entusiasmo, successo…». «Ma siamo anche uomini, ognuno con
i propri fantasmi e con le proprie terribili insoddisfazioni».
Punzecchiato sullo stesso tasto, il leader dei Pink Floyd
risponde con maggiore grazia: «Certo che fa piacere», sorride elegante Gilmour, «ma non è questo che ti tiene a galla. Per tornare alla domanda sul chi ce lo fa fare, direi che è
l’onestà verso il nostro lavoro di musicisti e verso il pubblico. Ma una tournée planetaria a volte ti dà meno soddisfazioni emotive di uno show nei teatri. Quel che conta, insomma, è se riesci a tenere la concentrazione sul prodotto
migliore possibile rispetto alle intuizioni musicali che hai. Il
numero di persone che ti applaude, viene dopo. Ora lo sappiamo bene». Mi colpiscono queste battute (ma ce ne sarebbero tante, in quasi ogni incontro brilla una luce, anche piccola) perché mi chiedo se ancora il rock sia un «luogo umano» e forse se lo chiede anche Walter Gatti, visto che del
rock più che di ogni altra realtà umana si predica la fine imminente (o già avvenuta) ormai da decenni, forse fin da
quando è nato grazie a Bill Haley e Chuck Berry, e la risposta si trova forse nell’affermazione di Francesco De Grego-
8
A. MONDA
ri che dichiara semplicemente di amare «da matti» questo
folle mondo del rock, con tutte le sue luci e le sue ombre. È
ancora «umano» il rock, forse sì, forse no, tutto dipende
dallo sguardo che gli si rivolge, se c’è amore in quello
sguardo, come in quello di Walter Gatti.
Spinta da questo amore, la curiosità non può non attivarsi, circolare, contagiare perché non può non voler saperne di più di ciò che fa ardere il cuore. Da questo punto di
vista le parole che segnano il vero autoritratto dell’autore di
questo grande affresco del rock sono quelle di Paolo Conte:
«Parlando di me stesso forse ciò che è affascinante nelle mie
canzoni nasce da un presupposto che considero la caratteristica della mia persona: sono un inguaribile curioso, un
appassionato esploratore della vita come delle arti in generale. Potrei dire che non esistono confini nelle zone umane
ed espressive che non mi interessano».
Una tale curiosità non può non condurre alla verità. E a
tante piccole verità disseminate in queste pagine che rompono luoghi comuni e ricostruiscono tutte insieme un’immagine del rock che non è forse quella a cui ci siamo pigramente assuefatti. Un esempio è nella battuta di Baglioni
sulla felicità del rock: «Sono convinto che per qualsiasi musicista scrivere parole e musica sono episodi di felicità, perché coincide con il momento in cui si mettono i fantasmi
della vita in pattumiera. Le canzoni sono per tutti indistintamente momenti di vita felice, di energia. Anche se parlano di disastri. È la stessa figura del “poeta maledetto” che
mi pare non esista sulla faccia della terra». Splendido: aveva ragione Benigni quando ricordava che il poeta per comunicare la felicità deve essere felice, e per comunicare il
dolore deve essere felice. È la stessa felicità «antica» di Lonnie Brooks: «Sarebbe bello sapere che ogni sera almeno due
PREFAZIONE
9
o tre persone capiscano tutta la storia che c’è dietro quelle
poche note della mia chitarra. Ecco, il blues ha tre grandi responsabilità unite tra loro: far capire, far divertire e far pregare. Questo è il mio lavoro. È il più bello del mondo: per
questo sono felice».
Le tante piccole tessere che Walter Gatti ha collezionato
in trent’anni si tengono e stanno unite insieme in modo naturale, una rincorrendo l’altra e convergendo tutte verso il
centro, anzi il «perno» come rivela acutamente B. B. King:
«Però io penso che tutta la musica sia come una ruota dove
l’importante è il perno, che fa muovere tutto. Ciò che conta
è il perno e come dalla circonferenza della ruota ci si vuol
arrivare. Per il blues il perno è il cuore dell’uomo e il modo
di arrivarci è solo uno: la preghiera. Blues è anima piena di
preghiera».
È un luogo umano il rock, figlio del blues, proprio perché non è solo umano. Un po’ come lo stesso autore di questo libro prezioso: Walter Gatti è un ottimo conoscitore della musica proprio perché per lui la musica non è un semplice pretesto ma non è neanche «tutto». C’è anche qualcos’altro. Questo libro allora non è solo una mappa, ma anche
una «segnaletica» o, se vogliamo, una soglia. Al lettore, ormai ben equipaggiato, il compito di continuare, personalmente, il proprio viaggio.
Andrea Monda
Giornalista e scrittore
J. L. Borges, Epilogo de L’artefice, in Tutte le opere, vol. I, Mondadori, Milano 1991, p. 1267.
1
Introduzione
Ho iniziato a sentire musica in casa mia quando ero ancora un bimbetto. Non ho più smesso. All’inizio c’erano le
canzoni dei miei genitori, poi mia sorella che suonava il
pianoforte e portava a casa i dischi di Beatles e Battisti,
Cream e Procol Harum. Poi ho fatto di testa mia. Quanta
musica ho ascoltato? Boh. Qualche decina di migliaia di dischi e canzoni a occhio e croce (né più né meno di tanti altri miei colleghi più famosi). Comperati, prestati, regalati,
scaricati.
Poi i concerti. Il primo che ho visto era quello degli
Emerson Lake and Palmer con Quadri di un’esposizione. Ero
in terza media, quindi era il 1972. Un altro concerto di cui
conservo un ricordo emozionante l’ho visto in tivù, credo lo
stesso anno: erano i Doobie Brothers trasmessi un pomeriggio dalla Tivù Svizzera, canale televisivo che si vedeva solamente in Lombardia. Me li sono sognati per anni mentre
facevano Long Train Running. E poi ci sono stati i concerti
veri: il primo l’ho visto in prima superiore ed era un’esibizione pomeridiana di Francesco De Gregori e Antonello
Venditti, sul piccolo palco di un cinema di Lodi, vicino all’Adda. E poi Claudio Rocchi nell’aula magna di un liceo,
Eugenio Finardi in un cinema di parrocchia, gli Stormy Six
12
W. GATTI
in una festa dell’Unità, gli Area in una chiesa lodigiana
sconsacrata (che in quei giorni era sede della locale società
pugilistica), Angelo Branduardi e i New Trolls, il festival
del Parco Lambro del ’75 e del ’76 con Area, Rocchi, Alan
Sorrenti, Banco del Mutuo Soccorso, Alberto Camerini (il
miglior chitarrista elettrico di quei giorni), la PFM, gli incredibili Carnascialia, band formata da Mauro Pagani subito dopo l’uscita dalla Premiata. Poi le prime rockstar straniere, gli Atomic Rooster di Chris Farlowe e Vincent Crane
e i Tempest di John Hiseman; poi i Grateful Dead nel parco
di Ginevra, Jimmy Cliff, gli Yes, Taj Mahal.
Nel frattempo anche io suonavo la chitarra e così mi trovavo a salire su qualche palco a fare rock, dai Lynyrd
Skynyrd a Neil Young. Nel ’79 arrivava in Italia il carrozzone di «Woodstock in Europe - 10 anni dopo» per una serata di spinelli e nostalgia a Casalmaggiore: ero lì mentre in
scena andavano Arlo Guthrie, Joe Cocker, Alvin Lee. Erano
anche tempi duri di contestazione, di sassi e cariche di polizia, di concerti saltati o sospesi. Poi si sono riaperte le
frontiere e sono arrivate per me le serate ad ascoltare Lou
Reed all’Arena di Milano, i Jethro Tull, Patti Smith nella leggendaria e tremenda serata di Bologna (amplificazione da
terzo mondo, suoni orribili). E soprattutto Bob Marley nell’immensa bolgia di San Siro nel 1980, uno dei concerti che
tutti avrebbero dovuto vedere una volta nella vita. E poi
venne la sera di Crosby-Stills and Nash al Palasport di Milano (crollato indegnamente pochi mesi dopo e mai più ricostruito).
Io sognavo di fare il giornalista, avevo già scritto qualcosa, ma mai di musica: il concerto dei tre della West Coast
divenne la mia prima recensione di un concerto. Era il 1983.
In un certo senso la storia di questo libro comincia da lì, 30
INTRODUZIONE
13
anni fa. Il resto è passione e professione. Il resto sono i giornali per cui ho lavorato, le radio per cui ho fatto trasmissioni, qualche televisione, tante serate passate a raccontare
in pubblico o in privato la musica e il suo impatto su di me.
I tanti concerti visti con mia moglie, gli amici, i figli. I tanti
festival simil-Woodstock, i viaggi per vedere o intervistare
Pink Floyd o Pearl Jam, Rem o Genesis, Counting Crows o
Dave Matthews. In questo libro ci sono finiti alcuni articoli
che più o meno coerentemente raccontano personaggi e
momenti della musica rock e pop vissuti attraverso la mia
esperienza. Sono soprattutto interviste, perché il genere
della «chiacchierata con il musicista» mi è sempre piaciuto
in modo particolare.
Ma cosa c’è nella musica rock che mi ha sempre messo
in movimento? Oppure cosa c’è in me stesso che è sempre
stato attratto da questo genere musicale? Credo l’incontro,
la consonanza di espressione. A volte la chiamo risonanza:
qualcosa che tocca le corde più intime e fa risuonare tutto.
Qualcosa che tocca il cuore e lì si intrecciano amore e ricordo, destino e dolore, felicità e sensualità, domande e divino. Chi mi ha insegnato ad ascoltare la musica? Non so dirlo esattamente. Certo, ascoltare aiuta ad ascoltare ancora di
più. E anche leggere dà una mano (dai giornali alle riviste
specializzate, ai libri di Adorno o di Glenn Gould, di Greil
Marcus o di Peter Guralnick). E poi chiacchierare, parlare,
confrontarsi, dialogare, scontrarsi con amici e nemici, colleghi e fidanzate, figli e musicisti. Di certo c’è gente che mi ha
aiutato a incanalare da qualche parte in me stesso l’immane curiosità di cose nuove che mi ribolle dentro da quando
ero ragazzino. Non capivo nulla, ma in terza media avevo
letto metà delle opere di Bertolt Brecht, sapevo tutto sull’arte romanica in Lombardia e avevo già visto un paio di
14
W. GATTI
volte 2001 Odissea nello Spazio. Ovviamente da qualche parte tutto questo desiderio famelico di sapere doveva pur andare a finire. Sete di amici, sete di viaggi, sete di scoperte,
sete di amore, di affetto, di abbracci. Come se la mia testa e
il mio cuore fossero così vasti da poter essere riempiti a dismisura e nulla fosse in grado di colmare questa mia sete di
conoscenza. Fuori di retorica e lontano dai misticismi, credo che la cosa fondamentale sia stato scoprire grazie a un
prete, Luigi Giussani, che nulla è estraneo al cuore, che nulla di quel che mi coinvolgeva e mi interrogava era da buttare. Gli incontri, le interviste, i concerti, i nuovi dischi, i festival, i viaggi a rimorchio di artisti più o meno famosi hanno portato con sé quasi sempre questa costante: scoprire
che tipo di desiderio e di cuore potesse battere dentro di loro, dentro alle loro canzoni, dentro al loro pubblico. In ultima analisi cercavo di confrontare il loro desiderio con il
mio, cercavo di vedere cosa rimaneva dopo «due strofe e un
ritornello» (Paolo Conte), se veramente eravamo fatti per
«correre e vincere» (Bruce Springsteen), se «quella lunga
oscurità che ci circonda prima dell’alba» (David Crosby)
era destinata a durare ancora per molto e se era sufficiente
nella vita essere un «uomo semplice, uno che tutti possano
amare e capire» (Lynyrd Skynyrd).
Negli anni nulla ha potuto opporsi alla creazione di un
gusto mio, un insieme di suoni e autori discutibilissimi, ma
di cui vado tremendamente orgoglioso. Nel mio cuore un
posto unico lo occupano per sempre i cavalieri romantici
del southern rock (Allman Brothers Band, Lynyrd
Skynyrd, Marshall Tucker Band, Little Feat e Outlaws: di
questo genere conservo circa mille titoli), al pari dei chitarristi più poderosi del rockblues (Eric Clapton, Stevie Ray
Vaughan e Rory Gallagher sopra tutti) e dei geniacci visio-
INTRODUZIONE
15
nari, prolissi e pazzoidi (in testa Frank Zappa, i Phish, Robert Fripp, Florian Fricke) e con loro gli autori che hanno
espresso al massimo grado la forza del connubio parolemusica (certamente Van Morrison, Dylan, Cohen, Springsteen, Crosby, Young, Pete Townshend, ma anche Roger
Waters, Mike Scott, John Hiatt, Nick Cave e Joe Ely e molti italiani, Giovanni Lindo Ferretti e Francesco Guccini su
tutti). Gusti che difenderei a spada tratta ben sapendo che
sono personali, opinabili, connessi alle ferite che hanno lasciato su di me oppure al fatto che abbiamo sanguinato in
modo eguale. Oppure che siamo stati medicati allo stesso
modo. Perché la musica che più mi piace non è un unguento, ma la dichiarazione spudorata, sfrontata e immodesta di avere una ferita e di non saperla guarire.
Ma ho divagato. Dicevo: ho iniziato a sentire musica
quando avevo i calzoni corti. Poi ho imparato ad ascoltarla.
Non ho più smesso. Spero di non smettere mai. Neppure
quando diventerò sordo.
Walter Gatti
LA LUNGA
STRADA DEL ROCK
1
Territori di storie rock
Nel pianeta rock si incontrano popoli diversissimi. Gente con il sorriso e giovani piangenti, vecchi sdentati e ragazzi rissosi, compagni di viaggio e suicidi, ubriaconi e belle ragazze con il vizio del canto. Paludi tossiche, montagne
da scalare per esprimere libera umanità, deserti dove perdersi e mai più ritrovarsi. I creatori, gli innovativi, i demoniaci, i placidi, i nascosti, i notturni. C’è chi fa i soldi e basta e chi crede che le sette note su una chitarra elettrica siano una forma d’arte. Tra tutti quelli che ho incontrato,
ascoltato, intervistato, sfiorato, evitato, quelli che più mi
hanno colpito, e comunque mi sono risultati affini, sono i
tanti (o pochi) che comunque hanno conservato un barlume
di personalità, di magia, di mistero, di insoddisfazione, di
ansia, di cammino, di sorpresa. Quelli che anche nel bel
mezzo del successo hanno conservato l’istinto degli inizi,
quando contava più raccontare delle storie, piuttosto che
moraleggiare sulla vita propria e altrui. Se il rock è un pianeta, se mille sono le strade con cui attraversarlo, ecco qui
un dedalo di incontri che ho fatto divagando sulle sue strade. Condotto per lo più da una cosa che chiamerei curiosità.
Che è il mio unico autentico sesto senso.
20
LA LUNGA STRADA DEL ROCK
CHUCK BERRY: E TUTTO EBBE INIZIO
Il rock non esisteva, poi Bill Haley e Chuck Berry l’hanno inventato. Un bianco e un nero. Entrambi con la voglia di divertirsi.
Nell’occasione dell’uscita di un film/documentario&concerto sono
riuscito a scambiare con lui pochissime parole al telefono. Nello
stesso anno doveva venire a Roma per una serata di revival, ma
Chuck ha tirato il bidone all’ultimo minuto. Sempre pazzerello e
poco affidabile. È ancora in pista, anche se viaggia verso i 90 anni.
Un film e un disco, identici nel titolo: Hail! Hail! Rock’n’roll («Viva! Viva! Rock’n’roll»). Come potevano essere meglio
festeggiati i sessant’anni di Chuck Berry? Altri avranno avuto la prima intuizione del rock, altri ancora saranno stati i definitivi consacratori, ma il padre rimane lui, il vecchio Chuck.
Elvis Presley ha venduto, nel ventennio della sua entusiasmante carriera, circa 600 milioni di dischi. Lui invece, il neretto del duck walk, il passo dell’oca, ha sempre fatto una considerevole fatica a sbarcare il lunario. Disse John Lennon: «Se
si volesse cambiare il nome al rock’n’roll… lo si potrebbe
chiamare Chuck Berry». Ecco cosa lui dice di se stesso.
Dalle parti di Saint Louis
Molti dei «fondamentali» del rock sono scaturiti, elettrici e
nervosi, dalla Gibson spumeggiante di Berry, che nel centro
del Missouri ha mosso i primi passi: Johnny B. Goode, Roll
Over Beethoven, Sweet Little Sixteen. E un po’ tutti devono a lui
qualcosa: cover dei suoi successi, stile chitarristico, magnetismo sul palco, ritmica o movimenti. I Rolling Stones vedono
la luce (maggio 1963) con un brano scritto da Berry nel ’59,
Come on. I primi quattro album dei Beatles contengono tre
sue canzoni; recentemente Eric Clapton ha affermato: «Penso
TERRITORI DI STORIE ROCK
21
che il primo vero eroe della chitarra rock sia stato lui, Chuck
Berry». E la lista dei doverosi tributi si può allungare tranquillamente: Led Zeppelin, Who, Jimi Hendrix, John Mayall,
Dylan, Springsteen. Persino Frank Zappa. Senza contare che
anche i primi passi dei rockmen di casa nostra (Celentano,
Ricky Gianco, Enzo Jannacci, Gino Santercole) sono stati timidamente mossi dopo ripetute «sedute» di ascolto entusiastico dei suoi dischi. Giorgio Gaber, passato verso il ’65 nelle
file dei rock’n roller, ricorda: «A quei tempi ascoltavo molto
rock, Elvis, Bill Haley, Little Richard. Ma il maestro era lui,
Chuck Berry. Per me inoltre, che ero chitarrista, lui era uno
splendido modello». Charles Edward Anderson Berry era
giunto al successo nel 1955, direttamente con il suo primo 45
giri, Maybellene. Aveva ventiquattro anni. Tre li aveva trascorsi nel riformatorio di Algona, nello Iowa, per furto. Il piccolo villaggio di Wentzville, in cui Chuck è nato il 18 ottobre
del ’26, è a due passi da Saint Louis, nel Missouri. Chicago è
lontana mille miglia, ma è la città del blues e attira il giovanissimo Berry (1947) appena uscito di prigione. Due parole
scambiate al telefono con Chuck confermano tutto:
Cosa vuole che le dica? Erano anni duri. Chi sapeva lavorare
provava a lavorare. Chi aveva voglia di ubriacarsi, provava a
farlo cercando di evitare le retate della polizia e della guardia.
Gli altri si arrangiavano. A me piaceva il blues, ma anche il
country dei bianchi. Sono sempre stato un po’ imprevedibile.
Così suonavo la chitarra e dopo un po’ le cose si sono messe a
girare per il meglio: sono andato a Chicago e ho sfondato.
Sono gli anni della nascita del Chicago Blues, con Muddy
Waters impegnato nell’elettrificazione dei classici moduli
della musica nera del profondo Sud. Attraverso l’incontro
22
LA LUNGA STRADA DEL ROCK
con Waters, Chuck ottiene il suo primo contratto con una
delle più celebri etichette dell’epoca, casa discografica di un
bianco che credeva nella musica nera (e che impazziva per
le donne di colore).
Da quel momento, comunque, Berry sarà uno dei dominatori dell’allora emergente scena del rock’n’roll:
Mi sono bastati due o tre hit, ovviamente a partire da Johnny B.
Goode, e di colpo ero uno dei musicisti più famosi! Anche i big
si accorgevano di me, era troppo divertente sentire la tua voce
e la tua chitarra uscire da tutte le radio…
Dietro di lui arrivano gli altri: prima Bill Haley poi Presley, Little Richard, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent… delle immortali Tutti Frutti, Love Me Tender, Jailhouse
Rock, Rock Around the Clock. Chuck è l’anima nera del nuovo
genere: molto più bluesman del giocoliere Little Richard,
molto più schivo e isolato delle nuove star giovanili, Berry
rompe sin dagli inizi le regole che il rock cercava di darsi per
essere almeno «musicalmente» accettabile, introducendo
parti soliste spropositate, ritmiche, martellanti. La carica erotica del rock, ostentata in Elvis, al limite del volgare in Little
Richard (e in molti successivi emuli), in Berry è gigionesca,
trattenuta e solo più insinuante, ma soprattutto si stempera
nella sostanziale ironia con cui sembra osservare, descrivere
e ridicolizzare sia l’America dei genitori benpensanti che
quella dei figli che scuotono le anche al ritmo della batteria.
Galera e leggenda
Ma il gioco dura poco. Nel ’62, in circostanze mai chiarite
(si parla addirittura di un complotto per toglierlo dalla circolazione), viene denunciato per violenza alla guardarobiera di
TERRITORI DI STORIE ROCK
23
un club privato. Dopo diciannove mesi di reclusione nel penitenziario di Terre Haute nell’Indiana, Chuck torna in libertà, senza una lira, dimenticato dalla scena musicale statunitense, mentre in Inghilterra lo venerano come il fondatore
del rock’n’roll. Si rivolge allora alla casa discografica Chess
per avere i proventi delle sue canzoni incise dai Rolling Stones, dai Beatles e da tutti gli altri, ma si sente rispondere che
il tutto già da tempo è stato venduto a etichette diverse. Come da contratto, nelle tasche di Berry finiscono percentuali ridicole. È il periodo più duro. La vena creativa si appanna anche se qualche perla salta sempre fuori dal suo forziere a dare un tocco di novità. C’è ancora tempo per un successo, My
Ding-a-Ling, che nel ’73 guadagna i primi posti delle classifiche e poi… è di nuovo in prigione. Questa volta è una questione di evasione di tasse sui guadagni dell’ultimo disco. È il
1979, è il definitivo allontanamento di Chuck dalla scena musicale. Appena avuta la libertà, il padre del rock’n’roll torna
nel suo paesello, Wentzville, con la moglie Themetta, con cui
è sposato da quarant’anni, e i quattro figli, acquista un vecchio ranch e lo trasforma in un parco giochi per bambini: il
Barry Park. Se qualcuno ha bisogno di lui, sa dove trovarlo.
Ciao sono Keith
Ma un bel giorno, gli arriva una telefonata di uno dei
suoi fan: Keith Richards, il chitarrista dei Rolling Stones.
La proposta: un concerto per festeggiare i sessant’anni
proprio nella sua Saint Louis. Il 16 ottobre 1986 Chuck sale sulla scena del «Fox» nella capitale del Missouri e di
nuovo lascia senza fiato. «Ah, che tipo Keith! Io gli ho detto lasciami perdere e invece lui ha voluto prendere un volo, poi un altro, poi un pick-up finché e venuto qui a parlarmene: non potevo certo dirgli di no dopo tutte quelle
24
LA LUNGA STRADA DEL ROCK
ore di viaggio…» Risultato: Keith Richards è riuscito ad
assemblare una band che risponde alla perfezione al feeling del «padre», con un grande vecchio di colore al piano,
Johnnie Johnson, con Chuck Leavell, ex Allman Brothers
Band alle tastiere, e alcuni ospiti d’eccezione a far da corona: sua leggenda Eric Clapton, Julian Lennon (figlio di
John), la grande cantante rhythm’n’blues Etta James (che
ai tempi della Chess era la blues woman più desiderata e
corteggiata di Chicago) e uno degli artisti nascenti del
blues nero, il giovane Robert Cray. È una serata memorabile. Roba da mandare a memoria. «I miei idoli – dice
Chuck parlando dei suoi inizi e concludendo una telefonata transcontinentale di sette minuti – sono stati Charlie
Christian, Carl Hogan e T-Bone Walker. Se qualcuno dice
che il rock’n’roll l’ho inventato io, è perché non c’è nulla
di nuovo sotto il sole.»
«Il Sabato», 1 gennaio 1988
Titolo originale: «One, Two, Three, Four and Berry»
CROSBY, STILLS & NASH: TRA LA WEST COAST E L’ITALIA
Era il 30 giugno del 1983: per la prima volta arrivavano nel
nostro Paese i tre cantautori simbolo della West Coast. Ero tra gli
spettatori e questa è la mia prima recensione su un rock show
pubblicata. Inutile dirlo, ma ricordo ancora quasi tutto.
I cancelli si aprono, sono le 18.45. C’è gente che aspetta
dalle 14, ma dice che ne è valsa la pena. Ci si spinge, ci si
urta, ci si insulta, poi finalmente si passa il cordone del servizio di sicurezza e si entra. Il biglietto, 16.000 lire, è nor-
TERRITORI DI STORIE ROCK
25
male per questi tempi. Il Palasport si riempie. La gente è
proprio varia: ci sono i quarantenni, quelli che possono dire dei tempi della protesta «io c’ero» e ci sono i quindicenni punk; c’è molta erba, ma ci sono anche molte camicie
marcate Giorgio Armani. Ce n’è proprio per tutti i gusti. Ma
la prevista fiumana di gente non c’è stata. Crosby, Stills &
Nash sono sempre loro, ma forse qualcuno li ha dimenticati. Forse molti stasera sono allo Stadio Meazza a vedere Inter-Juve, oppure sono rimasti a casa a sorseggiare whisky,
dimentichi dei sogni di libertà degli anni ’60.
Comunque, i fan dei Crosby-Stills & Nash ci sono tutti.
Alcuni, nell’attesa, si sono messi a cantare i successi dei
tempi d’oro del trio, e anche quelli del grande assente, l’amico-nemico Neil Young, ormai da tempo partito per altri
lidi. Tra i quindicimila presenti l’atmosfera inizia a surriscaldarsi. È proprio una bella sera, ma chissà dove è finita
l’aria di speranza che si respirava negli anni della protesta,
quando un concerto poteva cambiare la vita. Erano tempi
di lotte e di ideali. Erano tempi in cui i Jefferson Airplane
cantavano We Can Be Together e Volunteers. Erano i tempi di
San Francisco e della West Coast, delle rivolte universitarie,
della dylaniana Like a Rolling Stone, di Woodstock. Ora, forse, è solo tempo di nostalgie. Mi capita di parlare con un
po’ di gente. C’è molta attesa, ma anche molta tristezza.
Ormai nessuno crede al You Can Change the World gridato
da CSN. Tristezza e nostalgia, perché la musica di protesta
si è ricordata dell’Italia solo nel 1983, quando il dissenso ha
lasciato il posto agli equilibri della vita, cancellando la speranza dai volti e dalle parole. È una serata strana. Tutti si
aspettano buona musica, buone vibrazioni, grandi successi, ma niente di più. Nessuno chiede niente e nessuno si
chiede niente.
26
LA LUNGA STRADA DEL ROCK
21.20 - Band sul palco e ovazioni. Crosby e Nash con Fender, Stills con Gibson Les Paul che cambierà più volte con
una Fender Telecaster e una Gibson doppio manico. Iniziano subito con pezzi da antologia: Love the One You’re With e
Chicago. La band che li sostiene è tra le migliori. La sezione
ritmica è a livelli veramente straordinari con George «chocolat» Perry al basso, Joe Vitale alla batteria e Efrain Toro alle percussioni, tutta gente che è da anni nel giro di Stills. Il
suono è compatto ed energico, molto più vigoroso e duro
che nell’indimenticabile 4 Way Street, ma rimane perfetto e
senza sbavature o concessioni all’hard rock. Mike Finnigan
alle tastiere fa un lavoro superlativo con piano, synth e mellotron, mentre Nash ogni tanto si siede al suo strumento
preferito: il piano a coda Steinway.
L’attacco di Long Time Gone è accolto da un’esplosione di
applausi e David Crosby inizia a prendere contatto con il
pubblico dopo un inizio abbastanza assente. La sua voce,
rabbiosa, che esplode solo a tratti, mentre in altri momenti
è contenuta e sognante, è rimasta quella di una volta: è il
Crosby che da sempre conosciamo. L’atmosfera è incandescente. Stills è il vero dominatore musicale della serata,
ogni pezzo ha un suo assolo, graffiante, lancinante, mai
troppo lungo o fracassone come è sempre stata la caratteristica di questo cowboy del rock. Nash attacca uno dei suoi
brani più belli: Just A Song Before Go e subito dopo ci sono
altri due indimenticabili: The Leeshore e la misticheggiante e
agnostica Cathedral. La prima parte finisce con un applauso
interminabile. Sembra veramente di essere tornati indietro
nel tempo.
Dieci minuti di intervallo e il concerto riprende. I primi
pezzi della seconda parte sono acustici. Stills è l’unico che
riappare con una chitarra, mentre Nash e Crosby affronta-
TERRITORI DI STORIE ROCK
27
no tranquillamente il Palasport armati solo delle loro voci.
Dapprima Whistling Down the Wire, poi Time After Time ci
riportano alle praterie del Texas e ai sogni d’amore e di pace dei tempi che furono. Poi le prime note del loro capolavoro bastano a fare alzare tutti in piedi. È Suite: Judy Blue
Eyes. Stills è virtuoso e aggressivo come mai, inquadrato
da un riflettore azzurro che accentua il carattere sanguigno
di questo uomo del Sud. I 15.000 cantano insieme e il finale
elettrico del pezzo con l’entrata veemente di tutta la band
manda l’entusiasmo alle stelle: da qui alla fine sarà un’ovazione unica. David Crosby sale in cattedra: Almost cut
my hear, inno alla paranoia tratto da Deja vù è interpretato
con forza e drammaticità dalla sua voce che viene dal
profondo, mentre la Gibson di Stills duetta con questa voce
in maniera entusiasmante. Poi ancora Militar Madness di
Nash, poi l’ultimo successo di Stills War Games, e poi il
gran finale, con Wooden Ships di Crosby, mitico sogno di un
mondo nuovo, tra militari sconfitti e vincenti che fraternizzano ingoiando bacche e chiedendosi indifesi «ma chi
ha vinto la guerra?».
Già: chi ha vinto la guerra del mondo nuovo, di quel
mondo da cambiare e da ribaltare? La generazione dei figli
dei fiori ha trionfato oppure è implosa? Si è accontentata di
scrivere belle canzoni? Con Wooden Ships e con le sue domande utopiche, il concerto dovrebbe essere finito, ma tutti
sanno che non è così. In un fragore assordante di applausi,
Crosby, Stills & Nash rientrano e i bis sono il trionfo della
nostalgia: For What It’s Worth, Carry On e soprattutto Teach
Your Children, solare ipotesi di una vita in cui genitori e figli
possono finalmente ascoltarsi, comprendersi, evitare di
guerreggiare da generazioni contrapposte. Mai ascoltato un
bis più classico e strappa-applausi. Ora il concerto è proprio
28
LA LUNGA STRADA DEL ROCK
finito. Dieci minuti di battimani e di «ancora», qualche momento di sosta e si torna a casa. Sono le 23.30. Addio Woodstock-generation: la speranza è finita da un pezzo, tra un po’
finirà anche la nostalgia. Forse l’unica cosa che rimane e
aspettare il prossimo concerto.