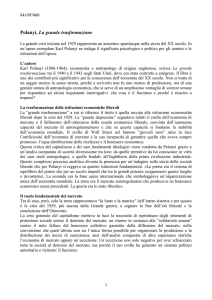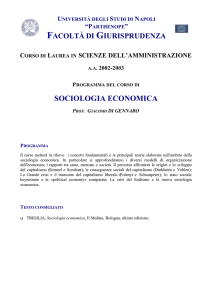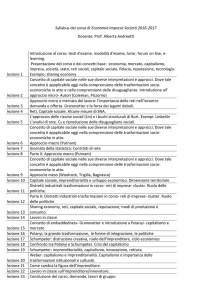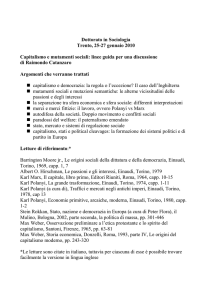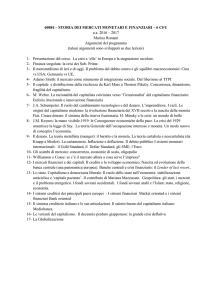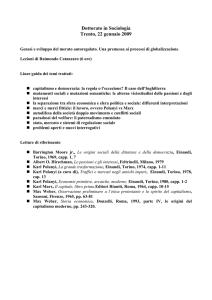Giorgio Morganti
La Grande Crisi può essere considerata uno spartiacque
nella storia economica e sociale. Per farvi fronte tutti i paesi
si videro obbligati a inventare nuove forme di politica
economica diverse da quelle dell’ortodossia liberale. In
questo capitolo incontreremo la posizione di Karl Polanyi
e di Joseph Schumpeter e la loro analisi sulle cause del
declino. Pur muovendo da posizioni culturali e politiche
diverse, entrambi concordano sull’importanza delle cause
sociali e politiche del declino del capitalismo liberale.
Ed entrambi delineano l’emergere di un nuovo
capitalismo più regolato dalle istituzioni politiche.
L’800 fu il secolo d’oro del capitalismo liberale perché in cent’anni non
ci fu una grande guerra, il mercato assicurò una forte crescita della
produzione e degli scambi. Col tempo però emersero però quelle
tensioni sociali e politiche che sono state analizzate nel capitolo
precedente (la classe operaia aspirava al riconoscimento sociale ed
all’integrazione politica). già negli ultimi decenni del secolo
cominciano a manifestarsi le difficoltà del capitalismo liberale a
tenere insieme crescita economica, integrazione sociale e
rapporti pacifici tra gli stati. Sul piano economico sulle realtà
più piccole pesava la concorrenza e queste chiedevano
protezionismo industriale e agrario; ma questo significava frenare
gli scambi internazionali ed intensificare la politica coloniale la
quale sfociò nella prima guerra mondiale.
Dopo la guerra nulla tornò come prima. Il conflitto comportò
costi economici e sociali altissimi e nonostante i tentativi di
ricostruire l’ordine prebellico, le condizioni economiche e
sociali restarono estremamente instabili. Negli anni ’20
l’Europa è duramente provata, deve far ricorso a ingenti prestiti
forniti dagli Stati Uniti, ma la ripresa economica è lenta, la
disoccupazione resta elevata così come i conflitti sociali e
politici. Dal punto di vista economico, il commercio
internazionale stenta a riprendersi e a tornare ai livelli
prebellici, mentre la produzione di manufatti cresce a ritmi
elevati, trainata dalle innovazioni tecnologiche e
organizzative e dal formarsi di grandi imprese.
Il persistente protezionismo doganale ostacola gli scambi e
non aiuta quindi a fronteggiare la tendenza alla
sovrapproduzione dei beni industriali. Anche la domanda
dei paesi meno sviluppati, afflitti dal calo dei prezzi agricoli e
delle materie prime, è debole. In questa situazione, la
dipendenza dai prestiti americani dell’economia europea
(soprattutto quella tedesca gravata anche dai danni di
guerra da ripagare) è molto elevata. Si trattava di una
situazione ad alto rischio, perché l’interruzione dei flussi
creditizi americani avrebbe potuto avere effetti a catena
disastrosi sull’economia europea e mondiale
Ed è proprio questo che si verificò inseguito al crollo della Borsa di
New York nel 1929. La Grande Crisi trascinò tutta l’economia dei
paesi sviluppati in una gravissima e prolungata depressione, con
crollo della produzione, fallimenti a catena delle imprese e
picchi di disoccupazione mai raggiunti in precedenza.
La Grande Crisi si può considerare come uno spartiacque ideale
nella storia economica e sociale. Questa situazione eccezionale portò
tutti i paesi ad allontanarsi dall’ortodossia liberale nella politica
economica interna e internazionale; la nuova prospettiva si basò
sull’assunto che la mano dello stato è indispensabile sia nei
buoni che nei cattivi momenti; esso può garantire una crescita
economica continuata in un’atmosfera di armonia sociale;
l’economia deve porsi al servizio dello stato e non viceversa.
Su questo sfondo si colloca la riflessione di Karl Polanyi e Joseph
Schumpeter. Mentre Durkheim e Veblen contribuirono a mettere a fuoco le
conseguenze sociali del capitalismo liberale, Polanyi e Schumpeter si
concentrarono sulla crisi
di questa forma di organizzazione
economica. Essi studiano i processi di cambiamento che si vanno
sperimentando a partire dagli anni ’30: la formazione di un capitalismo
più regolato, in cui lo spazio del mercato si riduce e l’economia viene
reincorporata nella società.
Anche questi due autori non vengono da percorsi intellettuali diversi e
sono politicamente su posizioni opposte (Polanyi è un socialista e
Schumpeter un liberista conservatore), tuttavia ciò rende più interessante
il fatto che le loro analisi presentino notevoli affinità, contribuendo a dare
un ulteriore importante fondamento alla prospettiva d’indagine della
sociologia economica.
Karl Polanyi (1886 – 1964, ungherese) non si può considerare in senso
stretto come un sociologo economico. Si mosse tra la storia economica,
l’antropologia e la sociologia della vita economica: dalla Budapest di inizio
secolo, dove si accosta al socialismo riformista, alla Vienna del
dopoguerra, dove partecipa al dibattito sui fondamenti metodologici
delle scienze sociali e a quelli su mercato e pianificazione. Costretto a
emigrare in Inghilterra, entra in contatto con il socialismo laburista e si
guadagna da vivere come insegnante tenendo corsi per gli operai. È in
questo periodo che, accanto alla riflessione sul fascismo, comincia a
lavorare al tema delle trasformazioni del capitalismo liberale e si
avvicina agli studi di antropologia e di storia economica. La sua opera
più nota è La grande trasformazione 1944, quando l’autore era ormai
vicino a sessant’anni. Trasferitosi a New York, dove ottiene un incarico di
insegnamento alla Columbia University, si dedicherà agli studi
sull’organizzazione economica delle società primitive, arcaiche e antiche.
Anche Polanyi è un istituzionalista: l’azione economica non è
comprensibile in termini individualistici, ma è influenzata
dalle istituzioni sociali. I suoi saggi in merito sono stati
raccolti dopo la sua morte in due volumi: Economie primitive,
arcaiche e moderne del 1969 e La sussistenza dell’uomo del
1977.
Richiamandosi ai contributi dell’antropologia (Malinowski e
Thurnwald) cerca di mostrare che il motivo del guadagno non è
“naturale” per l’uomo. Le economie primitive non sarebbero
comprensibili se si attribuissero ai loro protagonisti motivazioni
utilitaristiche. Esse funzionano invece sulla base di complesse
reti di obbligazioni condivise che motivano il comportamento
Solo negli ultimi secoli, con il crescere dell’economia di
mercato, il perseguimento del guadagno è diventato
rilevante. È quindi un’istituzione, il mercato, che incentiva
un’azione economica improntata alla ricerca del
guadagno (quindi la naturale propensione dell’uomo al
commercio, l’uomo economico di Smith, era il frutto di un
fraintendimento storico che anticipava ciò che sarebbe
avvenuto molto più tardi). Per Polanyi l’indagine economica
non può essere separata dal contesto storico.
Polanyi individua tre principi fondamentali di regolazione delle
attività di produzione, distribuzione e scambio dei beni che
chiama forme di integrazione dell’economia: reciprocità,
Nelle
società in cui prevalgono la reciprocità e la
redistribuzione non vi è la ricerca del guadagno. Polanyi fa
notare come nella società moderna continuino ad esistere
tali forme di integrazione (reciprocità: genitori con figli e
viceversa; redistribuzione: lo stato sociale mediante la
tassazione e la spesa pubblica redistribuisce risorse e potere
d’acquisto dai più ricchi ai più poveri
Lo
scambio di mercato è la forma di integrazione
dell’economia che appare solo di recente nella storia
dell’umanità che raggiunge il suo culmine nel corso
dell’800: si produce sulla base dei prezzi per determinati
beni e si remunera il lavoro sulla base di prezzi che si
. In presenza di mercati regolatori dei prezzi si dice che sono
mercati autoregolati. È solo in questo quadro che si può
propriamente parlare di motivazioni utilitaristiche dell’azione
economica.
La grande trasformazione ha l’obiettivo di spiegare come siano
emersi i presupposti istituzionali dello scambio di mercato e di
come essi siano stati investiti da una progressiva trasformazione
che sfocia nel superamento del capitalismo liberale, con la
diffusione di forme moderne di redistribuzione legate allo stato.
Prima dobbiamo parlare ancora di due aspetti della
riflessione metodologica di Polanyi:
-
il concetto di sistema economico, tipico della
tradizione della sociologia economica viene legato a quello
di forma di integrazione;
-
le forme di integrazione non rappresentano “stadi”
dello sviluppo (cioè non si avvicendano temporalmente)
ma vi sono di solito più forme che si combinano in un
sistema economico in cui una è prevalente.
Polanyi introduce la distinzione tra economia:
-
formale: il termine economia è sinonimo di economizzare
ed indica il processo razionale di allocazione di risorse
scarse. Tale definizione è tipica dell’economia neoclassica e si
riferisce alla logica formale del rapporto mezzi-fini, che può
essere applicata a vari campi concreti;
-
sostanziale: il termine economia fa riferimento alla
sussistenza umana e cioè che l’uomo dipende per la sua
sopravvivenza dalla natura e dagli altri uomini (egli sopravvive
in virtù di un’interazione istituzionalizzata fra se stesso e il suo
ambiente naturale).
Per Polanyi la fallacia economicistica tende a legare la
sussistenza all’allocazione razionale delle risorse
scarse da parte di soggetti che cercano di ottenere il
massimo reddito dai mezzi di cui dispongono. Ma questo
avviene soltanto laddove si sia affermato lo scambio di
mercato. Per questo egli ritiene importante per le scienze
sociali (storia, antropologia, sociologia economica) un
concetto più ampio di economia che può permettere lo
studio e la comparazione nel tempo e nello spazio di sistemi
economici diversi.
Questo libro parla della grande trasformazione che investe le società occidentali a
partire dagli anni ’30, un cambiamento che porta al superamento del capitalismo
liberale affermatosi nel ‘800. Ne uscirà ridimensionato lo spazio del mercato come
forma di integrazione dell’economia, e lo stato tornerà ad assumere un ruolo più
rilevante per la regolazione dell’economia e della società.
Polanyi si pone due interrogativi:
- quali siano le origini storiche del mercato autoregolato;
- quali siano le conseguenze sociali ed economiche del mercato autoregolato tra gli
ultimi decenni dell’800 e la Grande Crisi del ’29 dalla quale si avvierà la grande
trasformazione.
Polanyi ha già spiegato che l’esistenza di mercati nel commercio dei beni
ha origini ben più antiche e non è decisiva per l’emergenza del nuovo
sistema economico vediamo allora come si formano i mercati per la terra e
per il lavoro. Essi non vengono creati per effetto del graduale sviluppo
della naturale propensione allo scambio (com’era suggerito da Smith e
dagli economisti classici) ma emergono come conseguenza di interventi
politici e di misure amministrative. Questi interventi si sviluppano dal
‘400 all’800, e in forme differenziate nei diversi paesi: per quanto riguarda la
terra si verificò l’eliminazione del controllo feudale, la
secolarizzazione delle proprietà della chiesa, fino ad arrivare al
riconoscimento giuridico della commerciabilità dei diritti di proprietà.
Con la crescita delle città, quindi l’esigenza di mantenimento delle
popolazioni urbane, si sviluppò la piena commercializzazione dei beni
prodotti dalla terra e i proprietari terrieri furono spinti a incrementare
la produzione per la vendita sul mercato.
Polanyi si concentra soprattutto sulla formazione del mercato del lavoro
prendendo in considerazione la storia inglese. In Inghilterra il lavoro restò a
lungo sottoposto a una serie di restrizioni. Ancora nel 1795 fu introdotto il
sistema di sussidi che limitava la dipendenza delle condizioni di vita dalla
vendita della forza lavoro sul mercato (si tratta dell’introduzione di una sorta
di reddito minimo da garantire ai poveri indipendentemente dai loro
guadagni; se essi ricevevano un salario al disotto del livello previsto rispetto
a uno standard che teneva conto del carico familiare, avevano diritto a un
sussidio). A poco a poco questo sistema determinò un abbassamento dei
salari e una crescita consistente dei sussidi Fu così che sotto la pressione
degli imprenditori e della classe media, si arrivò nel 1834 all’abolizione del
sistema dei sussidi e da quel momento cominciò a funzionare
pienamente in Inghilterra un mercato del lavoro concorrenziale.
Polanyi passa poi ad analizzare le conseguenze sociali
dell’affermazione del sistema economico e gli effetti che ne
discendono per l ‘economia, e che porteranno alla Grande Crisi della
fine degli anni ’20. Il punto di partenza di questo nucleo centrale de La
grande trasformazione è l’idea che il lavoro, la terra e la moneta
vengono trasformati in merci, cioè in beni prodotti per essere
comprati e venduti sul mercato. Ma non si tratta di merci come le altre,
perché il lavoro è legato alla vita umana, così come la terra è un
aspetto della natura e la moneta è un simbolo del potere di acquisto.
Non si tratta dunque di vere merci ma di merci fittizie per cui il loro
trattamento come semplici beni economici sui mercati autoregolati
porta a conseguenze distruttive per la società.
Il processo di formazione del mercato del lavoro si
accompagna alla progressiva distruzione delle forme
di protezione tradizionale (parentela, vicinato): gli
individui e le loro famiglie furono sradicati dal contesto
ambientale e sociale in cui vivevano e costretti a spostarsi
per ricercare occasioni di lavoro. Nella fase iniziale della
rivoluzione industriale la forte instabilità di guadagni ha
portato alla formazione di sacche di disoccupazione e di
nuova povertà nelle periferie delle città industriali,
condizioni di lavoro e di vita degradate. Quindi con il
mercato del lavoro si creò anche una miseria moderna, fino
ad allora sconosciuta alle società tradizionali.
Conseguenze sociali non meno pesanti si manifestano anche dal punto
di vista della natura. Il libero scambio dei prodotti, accompagnato dal
miglioramento dei trasporti, mise in crisi quote crescenti di produttori
agricoli, specie nel continente europeo, presto inondato dal grano
americano. I contadini dovettero abbandonare le campagne alla
ricerca di un lavoro e si determinò la distruzione della società
rurale.
Insomma, è vero che i mercati del lavoro, della terra e della moneta
sono essenziali per un’economia di mercato, ma la società non può a
lungo sopportare i costi che le vengono imposti da tali modalità di
funzionamento dell’economia. Ed è proprio per questo che
cominciano a manifestarsi dei meccanismi di autodifesa della società.
Conseguenze sociali non meno pesanti si manifestano anche dal punto
di vista della natura. Il libero scambio dei prodotti, accompagnato dal
miglioramento dei trasporti, mise in crisi quote crescenti di produttori
agricoli, specie nel continente europeo, presto inondato dal grano
americano. I contadini dovettero abbandonare le campagne alla
ricerca di un lavoro e si determinò la distruzione della società
rurale.
Insomma, è vero che i mercati del lavoro, della terra e della moneta
sono essenziali per un’economia di mercato, ma la società non può a
lungo sopportare i costi che le vengono imposti da tali modalità di
funzionamento dell’economia. Ed è proprio per questo che
cominciano a manifestarsi dei meccanismi di autodifesa della società.
.Nel corso degli ultimi decenni dell’800 si manifesta una sorta di
doppio movimento: da un lato si estendono i mercati su tutta la
superficie del globo, dall’altro una rete di provvedimenti e misure
politiche si integrano in potenti istituzioni destinate a controllare
l’azione del mercato relativamente al lavoro, alla terra e alla
moneta.
Sul fronte del lavoro: sviluppo del movimento operaio, delle
organizzazioni sindacali, dei partiti socialisti, nuova legislazione nel
campo sociale e del lavoro (regolamentazione dell’orario di
lavoro, del lavoro minorile e femminile, assicurazione contro gli
infortuni, le malattie, la disoccupazione, la vecchiaia, ecc.).
Dal punto di vista dell’agricoltura: a partire dal 1870 si diffondono
interventi di protezione tariffaria e di sostegno all’agricoltura.
Contadini, proprietari terrieri, ed anche esercito e alto clero,
cercano di difendere, con motivazioni diverse ma convergenti, la
società tradizionale minacciata dal mercato.
Anche il mercato della moneta subisce l’onda protezionista:
importante diventa il ruolo delle banche centrali nei vari paesi che
controllano l’offerta del credito mitigando gli eventuali effetti negativi
derivanti da transazioni internazionali (la crescita dei prestiti attutiva
la deflazione dovuta alla riduzione della moneta a causa dei forti
pagamenti internazionali).
Tuttavia, il nuovo protezionismo ha effetti diversi
sulla società e sull’economia di mercato: dal lato
della società, attenua i costi e le tensioni legate al
diffondersi del mercato; dal lato dell’economia,
genera vincoli crescenti che intralciano il
funzionamento dei mercati autoregolati nel campo
dei fattori produttivi (si riduce la flessibilità e cresce
il costo del lavoro, mentre le tariffe doganali limitano
gli scambi commerciali).
Tuttavia, il nuovo protezionismo ha effetti diversi
sulla società e sull’economia di mercato: dal lato
della società, attenua i costi e le tensioni legate al
diffondersi del mercato; dal lato dell’economia,
genera vincoli crescenti che intralciano il
funzionamento dei mercati autoregolati nel campo
dei fattori produttivi (si riduce la flessibilità e cresce
il costo del lavoro, mentre le tariffe doganali limitano
gli scambi commerciali).
La Grande Crisi del ’2 per Polanyi segna il tramonto del
sistema economico basato sui mercati autoregolati e
porta al superamento del capitalismo liberale. Per lo
studioso ungherese non sono stati né la grande guerra, né
l’avvento del socialismo in Russia e nemmeno quello dei
regimi fascisti in Europa a provocare la crisi del capitalismo
liberale bensì fu il conflitto tra il funzionamento del
mercato e le esigenze della vita sociale. È il nuovo
protezionismo istituzionale innescato dall’autodifesa della
società che irrigidisce e alla fine blocca il funzionamento
dei mercati.
I regimi fascisti, il New Deal americano, il socialismo
russo, sono tutte esperienze che nascono dal fallimento del
capitalismo liberale; in esse vi è un tentativo di
reintrodurre quelle forme di regolazione sociale e
politica che erano saltate con il sistema economico dei
mercati autoregolati che faceva dipendere la società
dall’economia.
Ma in che misura le nuove forme di regolazione possono
essere compatibili con la persistenza del mercato e con
quella della libertà?
I regimi fascisti, il New Deal americano, il socialismo
russo, sono tutte esperienze che nascono dal fallimento del
capitalismo liberale; in esse vi è un tentativo di
reintrodurre quelle forme di regolazione sociale e
politica che erano saltate con il sistema economico dei
mercati autoregolati che faceva dipendere la società
dall’economia.
Ma in che misura le nuove forme di regolazione possono
essere compatibili con la persistenza del mercato e con
quella della libertà?
Per Polanyi la fine della società di mercato non significa
in alcun modo l’assenza di mercati. L’idea di fondo è che il
mercato non sia necessariamente in contraddizione con
obiettivi e strumenti di programmazione economica. Il
socialismo riformista di Polanyi lo porta a condividere l’idea
che in una società veramente democratica il problema
dell’industria si risolverebbe per mezzo dell’intervento
programmato degli stessi produttori e consumatori.
Anche la libertà non scomparirebbe: ci sono libertà cattive
la cui scomparsa non sarebbe che vantaggiosa (la libertà di
sfruttare gli altri uomini o quella di realizzare guadagni non
commisurati ai benefici collettivi) e libertà buone
cresciute insieme al mercato che continuano ad avere un
elevato valore (libertà di coscienza, di parola, di riunione, di
associazione, di scelta del proprio lavoro) ma che è
sbagliato pensare che esse dipendano solo dall’esistenza
dei mercati
autoregolati. Polanyi conclude dicendo che
nella società umana non vi è una determinante unica e che
la fine del capitalismo liberale non comporta
necessariamente quella del mercato e delle libertà.
Anche la libertà non scomparirebbe: ci sono libertà cattive
la cui scomparsa non sarebbe che vantaggiosa (la libertà di
sfruttare gli altri uomini o quella di realizzare guadagni non
commisurati ai benefici collettivi) e libertà buone
cresciute insieme al mercato che continuano ad avere un
elevato valore (libertà di coscienza, di parola, di riunione, di
associazione, di scelta del proprio lavoro) ma che è
sbagliato pensare che esse dipendano solo dall’esistenza
dei mercati
autoregolati. Polanyi conclude dicendo che
nella società umana non vi è una determinante unica e che
la fine del capitalismo liberale non comporta
necessariamente quella del mercato e delle libertà.
Joseph Schumpeter (1883 – 1950) è certo più noto come
economista che come sociologo, ma è opportuno includerlo
nel nostro percorso perché nel suo studio dei fenomeni
economici si è sempre posto al di fuori degli schemi
convenzionali. Egli diede un contributo importante alla
sociologia economica per l’interpretazione del declino
del capitalismo liberale e delle nuove forme di
organizzazione dell’economia.
Per Schumpeter, il cambiamento economico deve essere
posto al centro dell’indagine ma ciò lo spinge
inevitabilmente a misurarsi con il ruolo delle istituzioni.
Schumpeter diede particolare importanza al problema della definizione
dei confini tra economia e sociologia economica .
Per Schumpeter :
-
la teoria economica è caratterizzata da un insieme di proposizioni
analitiche di cui viene argomentata la validità a determinate condizioni
(egli difende come Menger e Weber la validità dell’economia
neoclassica;
-
la storia economica è importante per comprendere i fatti storici e
quindi per capire come i fatti economici e quelli non-economici si
combinino tra loro nell’esperienza concreta;
-
la sociologia economica contribuisce allo studio dell’influenza
dei fattori non economici, cioè quelli istituzionali, sulle attività
economiche e la loro variazione nel tempo e nello spazio.
Il punto di partenza dell’analisi di Schumpeter si individua
chiaramente nell’insoddisfazione per i limiti della prospettiva
economica tradizionale, giudicata incapace di uscire da una visione
statica dell’equilibrio economico. Per Schumpeter la crescita è un
fenomeno graduale, fatto di continui aggiustamenti partendo dalla
combinazione dei fattori dell’economia tradizionale mentre lo
sviluppo implica invece una discontinuità e quindi l’introduzione di
nuove combinazioni (può riguardare cinque dimensioni: creazione di
prodotti; introduzione di nuovi metodi di produzione; apertura di
nuovi mercati; scoperta di nuove fonti di approvvigionamento di
materie prime o semilavorati; riorganizzazione di un’industria, es.
creazione di monopolio).
Egli riconosce che lo sviluppo può derivare da motivi extraeconomici
(crescita della popolazione, improvvisi rivolgimenti sociali e politici)
ma il suo interesse si concentra però sullo sviluppo legato all’azione
degli imprenditori:
siano essi proprietari dei mezzi di produzione oppure manager,
l’importante è che la sua attività sia innovativa e non routinaria (solo
alla prima si collega per Schumpeter il concetto di imprenditore);
non è necessario un rapporto continuativo con una singola
impresa, essi possono lanciare innovazioni in un azienda e poi
spostarsi in altra, e così via;
non devono appartenere ad una specifica classe sociale,
chiunque può aspirare a diventarlo dal basso grazie al credito
concesso dalle banche.
L’imprenditore che vuole realizzare un’innovazione:
deve misurarsi con carenze di informazioni e condizioni di
maggiore incertezza;
deve combattere e vincere le resistenze che vengono dai
suoi schemi mentali consolidati e quelle che vengono
dall’ambiente sociale;
deve superare gli impedimenti giuridici e politici e la
disapprovazione sociale e delle altre imprese minacciate
dall’innovazione.
È per questo che l’imprenditore innovatore deve avere una personalità
che non può essere riconducibile al semplice calcolo razionale
richiamato dalla teoria tradizionale.
In un successivo testo del 1928 egli chiarisce meglio i legami
dell’imprenditore-innovatore con un particolare retroterra sociale e
istituzionale distinguendo tra:
padrone di fabbrica che unisce insieme compiti amministrativi,
tecnici, commerciali; è proprietario dei mezzi di produzione (fase iniziale
dell’economia di mercato);
capitano d’industria, proprietario di capitale azionario, che innova
operando soprattutto attraverso il controllo finanziario sulle aziende, o
manager di formazione tecnica, distaccato dagli interessi capitalistici ma che
è spinto ad innovare dal suo orientamento alla buona prestazione
professionale (fase più evoluta del capitalismo);
fondatore di imprese, si tratta della figura specifica
dell’imprenditore puro, che intrattiene con le imprese solo rapporti
temporanei.
In questo lavoro Schumpeter analizza le trasformazioni del
capitalismo liberale e gli effetti della Grande Crisi nella
prospettiva della sociologia economica perché si mette in
evidenza come il funzionamento dell’economia capitalistica
determini un cambiamento della cultura e delle istituzioni
che a sua volta fa inceppare i meccanismi di
autoregolazione dei mercati (passaggio da capitalismo
non regolato a capitalismo regolato). Egli si dichiarò
d’accordo con la previsione di Marx, ma per motivi diversi:
il capitalismo non sarebbe sopravvissuto, ma non per fattori
di natura economica, bensì per le reazioni culturali e
sociali che il suo funzionamento provocava.
• Perché il declino non ha cause economiche?
Schumpeter si preoccupa inizialmente di contrastare la
tesi che l’evoluzione del capitalismo implichi un
aumento della disoccupazione. La crescita dei disoccupati
negli anni ’30 è risultata molto elevata, ma si è trattato di un
fenomeno temporaneo, legato alla fase di recessione che di
solito segue, nel ciclo economico, una fase di prosperità
legata ad un periodo di innovazione.
Il fenomeno è stato però aggravato da fattori contingenti:
1.
- la coincidenza di una crisi agraria indotta da nuovi metodi di
produzione che aumentano la produttività, a fronte di restrizioni
doganali che limitano gli scambi;
2.
gli effetti deflattivi legati alla politica monetaria e al ripristino
del sistema aureo;
3.
-
i pagamenti di guerra;
4.
-
il livello dei salari, diventati più rigidi;
5.
-
l’accresciuta pressione fiscale.
Per Schumpeter è essenziale il processo di distruzione
creatrice che porta a rivoluzionare il sistema produttivo con
i cicli di innovazione. Nel corso dello sviluppo l’impulso al
formarsi di nuove combinazioni si basa meno sugli
imprenditori individuali e tende a istituzionalizzarsi
all’interno delle imprese più grandi che soppiantano quelle
più piccole (perché hanno più risorse finanziarie,
organizzative, di ricerca, di controllo del mercato). Nel breve
periodo ciò può portare a prezzi alti e a restrizioni della
produzione, ma a medio e lungo termine si diffondono
vantaggi legati alla qualità e ai costi, che migliorano per
effetto dell’innovazione.
Quindi, dal punto di vista dinamico, la concorrenza di tipo
oligopolistico o monopolistico, creando nuovi beni, nuove
tecniche, nuove fonti di approvvigionamento e metodi di
organizzazione è lo stimolo imperioso che a lungo andare
espande la produzione e riduce i prezzi. Le restrizioni e i
profitti imprenditoriali di tipo monopolistico sono il
prezzo necessario, ma temporaneo, da pagare perché possa
esserci l’innovazione e perché i suoi effetti benefici
possano poi diffondersi a tutto il sistema e giungere fino
ai consumatori.
Le cause culturali e sociali del declino
Passiamo così alla seconda parte dell’argomentazione di
Schumpeter che riguarda l’analisi delle cause culturali e
sociali del declino del capitalismo liberale:
1) l’indebolimento della borghesia: le grandi imprese
burocratizzate soppiantano sempre più le piccole e medie
aziende per cui l’imprenditore individuale perde la sua
funzione sociale, ma ciò finisce per indebolire la borghesia
che in passato era alimentata dal continuo formarsi di nuovi
imprenditori di successo. Altro fattore è la disintegrazione
della famiglia borghese
2) la distruzione degli strati sociali che sostenevano la
borghesia: si tratta del ruolo dell’aristocrazia che nei paesi
europei era sopravvissuta alla distruzione del feudalesimo
assumendo un ruolo essenziale per la formazione della
classe dirigente;
3) il diffondersi di un’atmosfera sociale ostile al
capitalismo liberale: da parte di gruppi costituiti dagli
intellettuali che alimentano la critica delle istituzioni del
capitalismo e riescono a ottenere un seguito di massa
(giornalisti, avvocati, leader politici
4) le politiche anticapitalistiche: una serie di misure legislative e
amministrative che si diffondono nei vari paesi: si tratta di interventi
dello stato o della contrattazione collettiva; politiche della spesa
pubblica in deficit per sostenere la domanda e ovviare alle crisi
cicliche; politiche redistributive del reddito attraverso la pressione
fiscale; misure antitrust per contrastare le imprese monopolistiche;
diffusione di imprese pubbliche; legislazione assistenziale e del
lavoro; crescita della contrattazione sindacale nel mercato del lavoro.
Tutte queste politiche, che hanno avuto un’accelerazione dopo la
Grande Crisi del ’29, segnano un allontanamento sempre più
marcato dal “capitalismo del laissez faire” e si avvicinano
sempre più a forme di pianificazione socialista.
Schumpeter vede nel capitalismo americano del New Deal, e poi in
quello che si sarebbe affermato dopo la guerra in America e in
Europa, una sorta di capitalismo laburista, in cui le imprese private
sono sottoposte a oneri fiscali e regolativi crescenti. Egli è dubbioso
sul fatto che un capitalismo che abbia eroso le basi istituzionali su cui
si poggiava possa continuare ad esprimere un elevato dinamismo
economico e intravede l’imporsi di una soluzione apertamente
socialista .