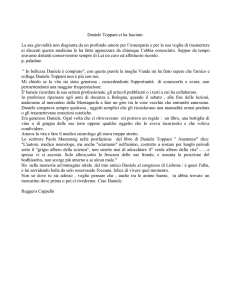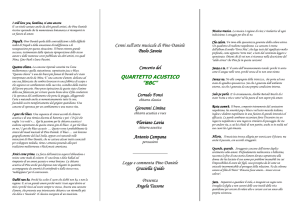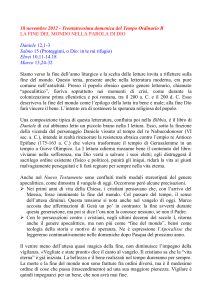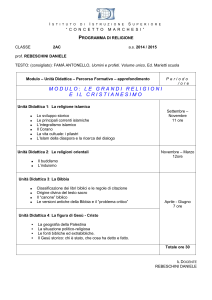leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri
http://www.10righedailibri.it
I edizione: marzo 2012
© 2012 Lit Edizioni 2012
Sede operativa: Via Isonzo 34, 00198 Roma
Arcana è un marchio di Lit Edizioni
Tutti i diritti riservati. La riproduzione di parti di questo testo
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma
senza l’autorizzazionescritta dell’Editore è severamente vietata.
Le illustrazioni a colori sono di Olivia Oliviero
Cover: Laura Oliva
www.arcanaedizioni.it
Marcella Russano
NERO A METÀ
Dalle origini a GRANDE MADRE
tutta la poesia di Pino Daniele
arcana
Indice
Prefazione
Napule è… terra mia
A me me piace ’o blues
Dal taranblues al rock arabe
Canzoniere di un mascalzone latino
Conclusione
7
9
37
87
116
169
Conversazioni con
Note
171
185
A mio nonno
che mi ha insegnato a raccontare
Prefazione
«Il mare non bagna Napoli»
A.M. ORTESE
Se la guardi dall’alto, di notte, Napoli è una distesa di fiammelle. Ardono, come
candele votive accese a un qualche santo. Bruciano, come le anime che consumano la loro permanenza al purgatorio in attesa di essere salvate. Eppure quella salvezza non arriva mai e la vita scorre sempre uguale, tra l’estasi e il tormento, la bellezza e la miseria, in un infinito andirivieni.
Napoli è una città di contrasti, dolorosa, appassionata, volgare e aggrovigliata.
La ami e la detesti tutto insieme. Non può restarti indifferente. E così continui a
guardarla dall’alto del Castel Sant’Elmo, di notte, quando il mare sembra un buco
nero che inghiotte l’universo e la città arde la sua lotta senza tempo. E ti chiedi
com’è possibile che continui ad afferrarti per lo stomaco con la sua violenza e a tenerti fermo immobile con la sua bellezza. Non vedi l’ora di fuggire via e allo stesso
tempo sai che non è una questione di distanze: te la porterai dentro ovunque andrai. Perché Napoli non è una città come un’altra: è un luogo dell’anima e se ci nasci sei marchiato a vita. Te la porterai per sempre addosso e la cercherai ovunque
nelle pieghe del mondo senza trovare nulla che le sia paragonabile.
Napoli è un crocevia. Una mescolanza inestricabile a ogni livello possibile. Culture, classi sociali, architettura, linguaggi, tutto si interseca nei suoi quartieri. Se ne
percorri i vicoli stretti e affastellati non trovi lo spazio materiale per respirare. Si sta
tutti vicini, stretti, attaccati. La struttura perpendicolare dei decumani ti toglie l’aria e ti tiene la testa incollata a terra. Se vuoi vedere il cielo devi tirar su lo sguardo
e allora lo incroci lassù, di un azzurro compatto, di smalto, tra un palazzo e l’altro.
Del mare senti l’odore quando il vento soffia verso la città, ma Napoli te lo nasconde, te lo nega fino all’ultimo, quando camminando tra un vicolo e l’altro a un
tratto te lo ritrovi davanti in tutta la sua maestosità. Quel mare a cui approdano
popoli, linguaggi, musiche e influenze dal mondo intero. Quel mare che è fuga dello sguardo verso l’infinito e che ti fa respirare il desiderio e la voglia di libertà.
“Quella laggiù, dunque, quel vasto presepio di luci sparse tra macchie d’alberi
dalle colline al mare, quell’immota distesa nel grembo fra edifici e monti, in cui il
Vesuvio verberava fuochi e le case barbagli d’oro vecchio, era Napoli. Provò un impulso tenero. Così, senza motivi. All’apparizione del semplice, sereno paesaggio”,
7
così Striano attraverso gli occhi della piccola Eleonora Pimentel Fonseca la descrive nel Resto di niente.
“Eugenia, sempre tenendosi gli occhiali con le mani, andò fino al portone, per
guardare fuori, nel vicolo della Cupa […]. Improvvisamente i balconi cominciarono a diventare tanti, duemila, centomila; i carretti con la verdura le precipitavano
addosso; le voci che riempivano l’aria, i richiami, le frustate, le colpivano la testa
come se fosse malata […]. Come un imbuto viscido il cortile, con la punta verso il
cielo e i muri lebbrosi fitti di miserabili balconi; gli archi dei terranei, neri, coi lumi brillanti a cerchio intorno all’Addolorata; il selciato bianco di acqua saponata,
le foglie di cavolo, i pezzi di carta, i rifiuti, e, in mezzo al cortile, quel gruppo di
cristiani cenciosi e deformi, coi visi butterati dalla miseria e dalla rassegnazione, che
la guardavano amorevolmente”, questa è la Napoli che Anna Maria Ortese descrive attraverso lo sguardo di Eugenia nel racconto Un paio di occhiali, del 1953.
Eccole le due anime del capoluogo partenopeo: la meraviglia che desta tenerezza
e il caos che sconvolge, la bellezza abbagliante e la miseria che devasta. Quei contrasti che ti entrano dentro e non ti abbandonano finché campi, che ti attraggono
e ti respingono in modo irrimediabile. È di questa complessità che è fatta la sostanza
della musica di Pino Daniele, un artista che da oltre trent’anni continua a sperimentare e fondere e contaminare generi, linguaggi, immagini, stili, senza fermarsi
mai. Perché, per quanto da Napoli ci si possa allontanare, è quella l’attitudine che
ti rimane dentro e che, come diceva in una delle sue poesie Antonio De Curtis, te
la porti “sana sana dinto ’e vene”. L’attitudine alla mescolanza, frutto di una storia
secolare di dominazioni che si sono susseguite in questa striscia di terra dalla notte
dei tempi, frutto del groviglio di culture, del dedalo di architetture, dell’intrico di
saperi e influenze che ti rimane scritto dentro come un marchio a fuoco.
Cercando a fondo, scavando a piene mani nella produzione artistica di musicisti
come Pino Daniele, è questa attitudine che ritroviamo pienamente rappresentata.
Pino Daniele che di Napoli e della sua cultura si è fatto alfiere all’età di soli ventun
anni, scardinando le regole della Canzone Napoletana per rifondarla e restituirla al
mondo cambiata per sempre, mescolata col blues, col jazz, con i ritmi latini, e che
adesso, dopo più di trent’anni di carriera, dichiara ai giornali: “Mi sento figlio del
Sud. Sono un garibaldino”1. Attraverso la sua opera, i suoi versi, la sua musica possiamo arrivare a comprendere come il mondo sia cambiato e come sia rimasto sempre, inesorabilmente uguale. La potenza che hanno le sue canzoni va al di là del
tempo e dello spazio e ti trascina lì, in quel luogo dell’anima, dove la vita arde immobile con le sue mille fiammelle accese. Lo scopo di questo libro (che non ha la
pretesa di essere una biografia) è raccontare, come in un viaggio personalissimo, parole, rime, luoghi e soprattutto l’energia che scorre lungo i solchi tracciati dalla musica. Perché come dice lo stesso Pino Daniele: “L’importante è il sentimento”2.
8
Napule è… terra mia
È il 19 marzo 1955, “le lancette degli orologi stavano fra le due e le tre del pomeriggio”1, quando a Via Francesco Saverio Gargiulo, ex Vico Foglie a Santa Chiara,
in un sottoscala, nasce Giuseppe Daniele. Via Gargiulo si trova in un dedalo di
viuzze strette e buie tra alti palazzi in stile liberty a metà tra Via Mezzocannone, dove si susseguono le sedi dell’università, e il chiostro della chiesa di Santa Chiara, un
angolo di silenzio ormai liso in mezzo al cuore pulsante della città. Poco distante la
sede storica del banco lotto in disuso, dove i napoletani affidavano la loro sorte al
fato sperando in un ambo o in un terno, consultando la Smorfia o chiedendo a san
Gennaro di far uscire i tanto sospirati numeri.
Questa è una Napoli brulicante di vita e di persone, caratterizzata dai “bassi” e
dalla convivenza di mille mestieri e attività. Si sta tutti vicini, si condivide lo stesso destino di miseria, ci si arrangia, si lavora operosamente, si parla, si strilla e si lascia scorrere il tempo sempre allo stesso modo. Un ritratto molto vivido di questa
realtà lo troviamo nelle parole del musicista stesso: “Ricordo molto bene il ‘basso’
di Via Gargiulo, i nonni che l’abitavano, i parenti che lo riempivano, uomini e
donne del vicolo, piccolo e stretto di notte, mentre di giorno quasi si allargava, si
estendeva, per la vita vivace che prendeva forma sui basoli di pietra vulcanica: là c’era la bottega del salumiere, da dove usciva un odore sensuale di ‘buattone’, conserva di pomodoro venduta sfusa; nel portone, il falegname, don Vittorio ’o casciaro,
che segava e martellava tutto il giorno; un po’ più in qua, la casa più temuta, quella del prestasoldi, l’usuraio del quartiere, quasi invisibile nel buio della sua casa a
pianterreno. E poi vecchiette sempre sedute con lo scialle sulle spalle, ragazzi che
correvano avanti e indietro, strillando come le rondini sui cornicioni dei palazzi”2.
Il “casciaro”, il salumiere, le vecchiette, i bambini che gridano liberi e ancora inconsapevoli come le rondini, ma soprattutto la sensualità dell’odore della “buatta”:
poche parole che hanno il potere di trascinarci ai piani bassi di quel vicolo non lontano dal mare, dal quale il mare tuttavia non si vede, e farcene sentire odori, colori e rumori che restano immutati nel tempo e che potrebbero descrivere una Napoli eterna, immobile ma allo stesso tempo piena di fermento.
Siamo nel 1955 e il capoluogo partenopeo è in piena speculazione edilizia postSeconda Guerra Mondiale. A “mettere le mani sulla città” è Achille Lauro, sindaco
9
che con i suoi 300mila voti, comprati a suon di pacchi di pasta e paia di scarpe, imprime alla città quel volto da colata di cemento che la caratterizza ancora oggi. I genitori di Pino non versano in buone condizioni economiche e così il bambino, primo di sei fratelli, viene affidato alle zie acquisite Lia e Bianca e si trasferisce nella
poco distante Piazza Santa Maria La Nova. La scena cambia, e in maniera abbastanza considerevole. Al posto del basso al numero 20 abitato da un benevolo “munaciello”3, il piccolo Giuseppe si trasferisce in una zona piccolo-borghese, a un piano abbastanza alto da poter essere illuminato dal sole, cosa che a Napoli ha un significato sociale ben preciso. Ad esempio, gli intellettuali e nobili che portarono
avanti le idee della Rivoluzione del 1799, vivevano nei vicoli scuri del cuore della
città, ai piani alti dei palazzi che la loro servitù, che la rivoluzione non la capì mai,
abitava a piano strada.
Dunque il bambino Giuseppe, che ha ancora negli occhi le impressioni della vita dei bassi, con i giocattoli poveri esposti nella bottega della “zarallara”4, poveri sì
ma che stimolano la fantasia come i cavallucci di cartapesta, le trombette di latta, i
tamburelli, gli strummoli e così via, passa ad abitare a casa delle sue zie, persone
“perbene, lavoratrici, serie, preveggenti” come lui stesso le descrive. Sono le due
donne che si occupano di farlo studiare e gli fanno respirare la passione per le ricorrenze e le tradizioni napoletane, dal cibo alle feste comandate, dai sapori agli
odori ai colori della storia partenopea.
Giuseppe è solo un ragazzino quando incontra quello che definisce “il miglior
compagno, il miglior amico che abbia mai avuto”: Salvatore Battaglia. È insieme a
Salvatore che inizia ad ascoltare la musica americana, ed è insieme a lui che appena
gli è possibile corre a spendere i suoi risparmi per comprare qualche disco del Re del
rock’n’roll: Elvis. Pino ha voglia di suonare e a soli dodici anni acquista per 35mila
lire la sua prima chitarra elettrica, una Eko X27 sulla quale inizia a esercitarsi da autodidatta. Comincia quindi a muovere i primi passi provando con altri ragazzi e formando i primi piccoli gruppi, ma allo stesso tempo, sotto l’ala protettrice delle inseparabili zie, continua ad andare a scuola e prende il diploma da ragioniere.
L’Istituto Tecnico Diaz è in Via Atri, ed è qui che il giovane Daniele si appassiona più approfonditamente agli sviluppi della musica del momento. Siamo alla fine degli anni Sessanta. Il ’68 delle contestazioni spiega le ali su tutto il mondo occidentale e anche a Napoli si respira un’aria diversa, piena di fermento e ricerca. È
una stagione ricca dal punto di vista musicale. Le nuove leve hanno tantissimo da
dire e da sperimentare, e quello che ne verrà fuori segnerà la storia della musica italiana e napoletana negli anni a venire e influenzerà non poco lo stile e la tecnica del
futuro Pino Daniele.
A Napoli infatti ha gettato le sue radici il cosiddetto Naples Power, movimento
musicale che coinvolge una lunga serie di musicisti all’insegna della sperimentazione. L’atmosfera è, dal punto di vista artistico, palpitante, molto fluida e difficile da
districare e collocare con chiarezza poiché molti artisti passano da un gruppo all’altro e si ritrovano a partecipare a una sorta di infinita jam sperimentale.
Intanto il giovane Giuseppe, dopo aver militato in una formazione chiamata
New Jet, compra una Gibson Diavoletto e forma il suo primo vero gruppo: i Ba10
tracomiomachia. Ad accompagnarlo in questa avventura il bassista Rino Zurzolo,
il sassofonista Enzo Avitabile, il batterista Rosario Jermano, il pianista Paolo Raffone e il cantante Enzo Ciervo. La formazione è orientata al jazz-rock e, anche se l’industria discografica non sembra accorgersi di loro, gli anni passati a sperimentare
sono fondamentali per la crescita musicale e personale di Daniele. Tutto è a un passo dall’accadere.
È il 1976 e viene dato alle stampe SUSPIRO, il terzo disco di Jenny Sorrenti. La
cantante, sorella di Alan, è reduce dall’esperienza con il gruppo acid-prog dei Saint
Just, e per il suo debutto da solista decide di rivolgersi a un giovane chitarrista napoletano. Il musicista in questione è proprio Pino Daniele, che a soli ventun anni
fa il suo primo passo nell’industria discografica. SUSPIRO si allontana molto dal rock
progressivo dei primi due dischi della Sorrenti e viene definito dalla critica un bell’esempio di “pop cosmopolita”. La chitarra di Pino Daniele sostiene l’ossatura dei
brani con il suo suono già inconfondibile e fornisce a quel “pop cosmopolita” inflessioni inequivocabilmente blues.
Nello stesso anno il batterista e amico Rosario Jermano consiglia a Daniele di incidere un demo da mandare alle case discografiche e così scocca la scintilla. Un giovanissimo produttore della Emi, Claudio Poggi, ascolta la cassetta inviata da Pino
e non ha dubbi: quel ragazzo ha talento da vendere. Immediatamente porta il demo al direttore Bruno Tibaldi, che fa incidere a Daniele il suo primo 45 giri contenente il brano Che calore e la B side Furtunato.
Ma per capire meglio le emozioni e gli intenti di quel musicista in erba che sarebbe diventato Pino Daniele è interessante ascoltare la puntata della trasmissione radiofonica 40° Parallelo del 2 novembre 1976, trasmessa su Radio Eurosound, un’emittente romana di base all’Eur fondata in quello stesso anno dai fratelli Conteduca.
Franco Mauro, il conduttore del programma, riceve la visita di Claudio Poggi e
della sua recente scoperta discografica. I due sono impegnati negli studi Quattro
Uno di Claudio Mattone in Via Nomentana a Roma, a registrare il primo disco del
musicista napoletano che uscirà all’inizio del 1977, TERRA MIA.
Ascoltando l’intervista si percepisce l’emozione, l’entusiasmo che può dare il fatto di trovarsi davanti a qualcosa che sta per succedere: il Naples Power ribolle come la lava di un vulcano già esploso e Daniele sta per farsi alfiere delle esigenze di
questo movimento culturale, facendole proprie e in qualche modo stravolgendole.
Nell’intervista c’è un passaggio molto interessante nel quale Poggi cerca di definire
quello che sta accadendo nel capoluogo partenopeo: “La situazione è questa, a Napoli non ci sono strutture che permettano ai musicisti di suonare però ci sono delle vere e proprie ‘caverne’, delle cantine dove tutti i musicisti napoletani si riuniscono e partecipano a delle session che se venissero registrate sarebbero un prodotto più unico che raro, qualcosa di favoloso, perché magari trovi Tony Esposito,
Bennato, Alan Sorrenti, Pino Daniele a suonare tutti insieme […]”5.
Dunque questa musica napoletana che si rifonda, si rinnova e trae la sua linfa vitale dalle sperimentazioni di artisti eccezionalmente dotati, confluirà nello stile del
giovane Daniele, che saprà reinterpretarla e farla sua con una voce del tutto eccezionale.
11
Durante la conversazione alla radio il musicista suona dal vivo, accompagnandosi alla chitarra classica, alcuni dei brani che hanno fatto la storia del cantautorato italiano ma anche e soprattutto napoletano, poiché è in dialetto che sono cantati. Ed è qui che ci fermiamo un attimo a riflettere perché nelle parole piene di emozione di questo ragazzo, cresciuto tra Vico Foglie a Santa Chiara e Piazza Santa Maria La Nova, c’è la dichiarazione di un intento profondo e fortissimo che caratterizzerà tutta la sua produzione a venire e che costituisce uno dei tratti salienti della sua espressione artistica.
“Pino Daniele è un cantautore napoletano che cerca di rappresentare una Napoli
diversa da quella che è sempre stata”, dice il musicista. “È sempre stata considerata
in maniera folcloristica e caratteristica […] ma ha delle piaghe enormi, delle miserie enormi di cui non si parla. Si ha paura che, descrivendola sotto un’altra luce, la
città possa essere in qualche modo deprezzata e considerata come un ghetto, un
luogo violento in cui è pericoloso vivere”6. Ed è questo che Daniele vuole in ogni
modo evitare: che il folclore e lo stereotipo della pizza e del mandolino possano nascondere la vera bellezza della città, quella complessità inestricabile che da sempre
la caratterizza.
Vengono in mente le parole di Matilde Serao che nel Ventre di Napoli condannava la visione stereotipata e oleografica della città, dietro la quale si nascondevano
le condizioni disagiate che il governo faceva finta di non vedere: “Non sono fatte
per il Governo le descrizioncelle colorite di cronisti con intenzioni letterarie, che
parlano della Via Caracciolo, del mare glauco, del cielo di cobalto, delle signore incantevoli e dei vapori violetti del tramonto; tutta questa retorichetta a base di golfo
e di colline fiorite, di cui noi abbiamo già fatto e continuiamo a fare ammenda onorevole, inginocchiati umilmente dinanzi alla patria che soffre; tutta questa minuta
e facile letteratura frammentaria, serve per quella parte di pubblico che non vuole
essere seccata per racconti di miserie”7. Come a dire, Napoli non è quella che da
sempre viene descritta a suon di Pulcinella e tamburelli, ma nasconde e cova un lato oscuro di cui non bisogna avere reticenza a parlare.
Nel suo libro Storie e poesie di un mascalzone latino, Daniele parla della differenza tra napoletanismo e napoletanità. Il primo rappresenta tutto l’insieme dei luoghi
comuni su Napoli e i napoletani ed è un atteggiamento a cui questi ultimi si adeguano per inerzia, spinti da pressioni che arrivano dall’interno e dall’esterno della
città stessa. Dall’interno, quando i napoletani recitano la parte dei napoletani, scritta per loro da cliché antichi come il mondo stesso. Dall’esterno, quando la società
con cui vanno a rapportarsi non riesce a classificarli se non entro i termini fissati
dal folclore e dall’oleografia costringendoli alla fine a cedere allo stereotipo. La napoletanità invece è una sorta di fiume carsico che scava e attraversa la città nei secoli, portando con sé i contributi di chi ha saputo amarla e renderne le meraviglie
vive e palpitanti attraverso l’arte e il pensiero nelle sue forme più varie. Daniele cita Eduardo, Murolo, De Simone, Pergolesi e lo stesso Benedetto Croce come vettori della migliore napoletanità. Quella che ti resta addosso, che ti scava e ti impressiona fin nel profondo, finché non la lasci uscire fuori sotto forma di parole,
musica e poesia. La napoletanità, dice Daniele, “esiste come continuità di ispira12
zione, fonte di suggestioni artistiche uniche e irripetibili, modo di vivere in continua trasformazione ma sempre ancorato a certi capisaldi che possono sembrare poco mutevoli”8. Trasformazione nella continuità, ieraticità nel cambiamento. Questo
è il solco artistico in cui la musica di Pino Daniele si insedia descrivendo Napoli, a
partire dal suo primo album, con parole e melodie uniche.
Napule è è la canzone che apre TERRA MIA, e non è soltanto musica: è la descrizione di un luogo dell’anima, è una dichiarazione d’amore e odio, è l’espressione di
una poetica fatta allo stesso tempo di tradizione e innovazione. Il brano è aperto
dai fiati di Enzo Avitabile che viaggiano sugli accordi del piano di Amedeo Forte:
abbiamo già la sensazione di trovarci lì, trascinati dentro una visione. Poi fa la sua
comparsa il mandolino dello stesso Pino Daniele, e quel suono, che è l’espressione
più abusata della tradizione napoletana, qui si trasforma per fare da tappeto alle parole di una città diversa, che non è affatto semplicemente “’o paese d’o sole”.
Napule è mille colore
Napule è mille paure
Napule è ’a voce d’e criature
che saglie chianu, chianu
e tu saie ca nun si’ sulo
Bastano pochi versi per comprendere che ci troviamo davanti alla rappresentazione di un luogo di contrasti. I mille colori fanno da contraltare alle mille paure, e
la disperazione che si avverte da una piccola incrinatura della voce è sanata soltanto
dal vociare dei bambini, l’innocenza che salva e che pone rimedio alla solitudine.
Napule è ’nu sole amaro
Napule è addore ’e mare
E abbiamo quasi la sensazione di stare affacciati al terzo piano di un palazzo in
Piazza Santa Maria La Nova, dove il sole arriva ma è un “sole amaro”, un sole che
illumina ma non riscalda. Del mare sentiamo soltanto l’odore. Ed è una presenza
quasi mitologica perché, anche se la città lo nasconde dietro un immenso intrico di
vicoli, sappiamo che esiste, è dentro di noi e non ci abbandona.
Napule è ’na carta sporca
e nisciuno se ne ’mporta
e ognuno aspetta ’a ciorta
È un crescendo in cui ai fiati, al mandolino e al piano si uniscono batteria, violini e chitarre. Napoli è una carta sporca a cui nessuno presta attenzione, è lasciata
lì a imputridire sotto gli occhi di tutti e a chi la abita non resta altro che affidarsi
alla sorte. È questo l’atteggiamento di rassegnazione che Daniele, con così poche
parole, riesce a rappresentare in maniera più che vivida. Una rassegnazione che si
nasconde sotto la falsa allegria del folclore:
13
Napule è tutto ’nu suonno
e ’a sape tutto ’o munno
ma nun sanno ’a verità
A chi la guarda dall’esterno Napoli offre il suo aspetto migliore:
Basta ca ce sta ’o sole
basta ca ce sta ’o mare
’na nenna a core a core
e ’na canzone pe’ canta’
E sembra che tutto si risolva magicamente. Ma la verità non è questa, e in TERPino Daniele non ha paura di raccontarlo chiaramente con la sua musica e
le sue parole.
Tornando all’intervista radiofonica di 40° Parallelo, c’è un momento in cui Pino decide di suonare dal vivo il brano che darà il titolo a TERRA MIA e lo introduce con un discorso breve ma molto profondo: “Terra mia però io vorrei spiegarlo.
Io sono molto affezionato a questo pezzo perché è tutto me stesso. È Pino Daniele. È tutto quello che io voglio dire. Anche nei dischi che farò in futuro, anche nei
dischi che non farò in futuro (sorride). È tutto quello che io sento e che io voglio
esprimere. Terra mia parla di un ragazzo, di un napoletano, di un romano, di un siciliano, di un milanese, chiamatelo come volete, che guardando la sua terra si accorge che certe cose sono completamente sbagliate. […] Tutti abbiamo avuto delle crisi esistenziali, tutti per un momento abbiamo pensato solamente al fatto di ucciderci, toglierci la vita davanti a una società che nei nostri confronti è sbagliata.
Però bisogna rivolgere lo sguardo alla propria terra e alla forza che un giorno gli altri ti daranno. […] Insieme arriveremo alla libertà”9.
Il discorso già affrontato in Napule è, in Terra mia diventa universale: il disagio
è di chi abita il mondo così come l’impotenza.
RA MIA
Comme è triste e comme è amaro
sta’ assettato a guarda’
tutte ’e cose e tutte ’e parole
ca niente ponno fa’
Così canta Pino Daniele, con il canto della rassegnazione di chi vede la propria
terra abusata, devastata, ed è incapace di trovare un rimedio.
Si m’accido aggio ittato chellu poco ’e libertà
che ’sta terra e ’sta gente
’nu iuorno m’adda da’
Il suicidio non è una soluzione alla disperazione, significherebbe soltanto rinunciare al libero arbitrio, alla libertà che l’occasione di stare al mondo ci ha dato. La
14
parola libertà è un altro dei punti chiave della poetica danieliana, la libertà di cui il
nostro giovane e ancora sconosciuto musicista si fa alfiere nel suo primo Lp.
Nun è ’o vero nun è sempe ’o stesso
tutte ’e iuorne po’ cagna’
oggi è dritto dimane è stuorto
e chesta vita se ne va
Qualcosa possiamo fare, dice il cantato accompagnato dagli archi, tutti i giorni
abbiamo la possibilità di cambiare le cose. E la nostra vita trascorre mentre tentiamo di guadagnarci la libertà.
’E vecchie vanno dinto ’a chiesa c’a curona pe’ pria’
e ’a paura e ’sta morte
ca nun ce vo’ lassa’
Soffrire, chiedere aiuto a Dio, pregare per un mondo migliore ma soprattutto
cercare un modo per combattere e sconfiggere la paura della morte che affligge gli
uomini di tutto il mondo: questo è l’atteggiamento delle antiche generazioni. Ma
oggi bisogna combattere per la libertà, per la libertà della nostra terra, sia essa Napoli o il Sud tutto intero, non bisogna arrendersi né rassegnarsi a quello che il destino ci ha riservato.
In realtà quasi l’intero TERRA MIA è una sorta di manifesto politico in cui un vento di contestazione si leva su Napoli e sul Sud. Pino Daniele rappresenta una condizione di disagio che è sotto gli occhi di tutti e racconta delle ore passate a discutere per cercare caparbiamente una soluzione che non c’è. Amare una terra che non
ti dà niente è la sfida più grande. Non abbandonarla, non rassegnarsi, cercare una
strategia per opporsi allo stato delle cose e alla fine cambiarle è il desiderio di un
musicista napoletano poco più che ventenne.
’Na tazzulella ’e cafè
e mai niente ce fanno sape’
nuje ce puzzammo ’e famme
’o sanno tutte quante
e invece ’e ce aiuta’
c’abboffano ’e cafè
Ecco un’altra delle canzoni simbolo di TERRA MIA: una tazzina di caffè e non ci
fanno sapere mai niente, noi moriamo di fame, lo sanno tutti, e invece di aiutarci
ci riempiono di caffè. È una denuncia aperta ad alcune delle piaghe che affliggono
Napoli in quei tardi anni Settanta. L’abusivismo edilizio, l’aumento indiscriminato
delle tasse, il malaffare, la criminalità a vari livelli, la corruzione nelle istituzioni:
cancri che corrodono la società e che i napoletani sono disposti a mandar giù pur
di non rinunciare alle proprie manie quotidiane, alla loro tazzulella ’e cafè, insieme
15
simbolo della tradizione a cui non si può rinunciare e della auto-gratificazione che
aiuta a sopportare i disastri della vita quotidiana.
Viene subito in mente una delle scene più famose del teatro di Eduardo, quella
in cui nell’opera del 1945 Questi fantasmi, il protagonista Pasquale Lojacono seduto al balcone spiega al suo dirimpettaio immaginario, il professor Santanna, come
la gioia di prepararsi un caffè fatto ad arte lo renda felice. Volendo sorvolare sulla
genialità della tecnica teatrale del maestro De Filippo, che è capace di sostenere da
solo un dialogo con un personaggio che non compare mai dettando i tempi, le modalità e le caratteristiche di quella che per il pubblico diventa una vera e propria
conversazione, Lojacono dice proprio così: “Io, per esempio, professo’ a tutto rinunzierei tranne che a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezzoretta di sonno che uno si è fatto dopo pranzo…”. Per Pasquale però il rito del caffè non ha senso se non è lui stesso a preparare l’aromatica
miscela. Quando il professore “chiede” a Pasquale perché non sia sua moglie a occuparsi della preparazione, questi risponde: “Mia moglie non collabora, è molto
più giovane di me, e la nuova generazione ha perduto queste abitudini che secondo me sotto un certo punto di vista sono la poesia della vita e oltre a farmi occupare il tempo mi danno pure una certa serenità di spirito”. Quindi, come dicevamo, la tazzulella ’e cafè rappresenta per Pino Daniele come per Eduardo il simbolo
delle tradizioni e allo stesso tempo un modo per combattere le “mille paure” della
vita stessa.
Dice Pino Daniele: “Quando lo conobbi, Eduardo mi disse che gli piaceva la
mia canzone ’Na tazzulella ’e cafè, del 1977. E certo, in questa sua preferenza doveva esserci un forte riflesso di quel suo pezzo teatrale in cui la tazzina di caffè, la
macchinetta col beccuccio, gli espedienti semplici ma geniali per rendere il caffè
più aromatico, diventano i simboli di un antico modo di vivere. Tra spaventi, sospetti, colpi di scena, fulmini e apparizioni finte, resta giusto il tempo per bere una
tazzulella di caffè: è l’unica parentesi serena. […] Eduardo, riassumendo la grande
lezione del teatro napoletano, ha portato sulle scene l’attualità, i problemi dell’uomo contemporaneo, i suoi tormenti, le sue piccole gioie e le insidie che ogni minuto lo circondano. E ha dato a tutti un filo di tela da tessere, soprattutto agli artisti più giovani”10.
Dunque la continuità con la migliore tradizione artistica napoletana è dichiarata, ma la musica di Pino Daniele ci porta a compiere un passo ancora oltre:
’Na tazzulella ’e cafè
acconcia ’a vocca a chi nun vo’ sape’
e nuje tirammo annanze
co ’e dolore ’e panza
e invece ’e c’aiutà c’abboffano ’e cafè
Una tazzina di caffè fa stare tranquillo chi non vuole sapere, e noi tiriamo avanti, con i dolori di pancia, e invece di aiutarci ci riempiono di caffè. La tazzulella in
questione non è soltanto il simbolo delle tradizioni, non è solo un luogo dove ri16
fugiarsi dalle “mille paure” che la vita ci riserva, è proprio una sorta di velo da calare su ciò che di più sporco e basso si abbatte sulla gestione politica della vita quotidiana. C’è uno scollamento tra il disagio profondo della vita civile e l’andazzo corrotto che caratterizza la vita politica e sociale.
S’aizano ’e palazze
fanno cose ’e pazze
ce girano, c’avotano
ce jengono ’e tasse
Costruiscono i loro palazzi abusivi, fanno cose da pazzi, ci girano e ci voltano e
ci riempiono di tasse, continua la canzone che è un perfetto blues stile New Orleans
nel quale si denuncia da una parte la rassegnazione della gente che non reagisce, dall’altra l’incoscienza della classe politica che guarda soltanto al proprio profitto.
Ma ciò su cui Pino Daniele si concentra di più, in questo suo primo lavoro, è la
rassegnazione della gente, la mentalità arrendevole che è comunemente imputata ai
napoletani, capaci di abituarsi a qualsiasi condizione a patto che gli venga garantito almeno il minimo indispensabile per sopravvivere.
Ma nun da’ retta
ce sta chi ce penza
’miezo a ’sta gente
ce sta chi ce penza
Così dice il ritornello di un’altra delle canzoni che in TERRA MIA affrontano questo argomento. Ce sta chi ce penza è un blues in settima suonato con i mandolini e
accompagnato dal putipù11. La canzone descrive le condizioni igieniche al limite
della sopravvivenza che caratterizzano un vicolo di Napoli. Non ci sono i mezzi necessari per riparare le fognature e il fetore è terrificante ma la popolazione, invece
di risolvere il problema, si affida alla sorte giocandosi “i numerielli” al lotto. La
mentalità è sempre quella della sopportazione spinta ai livelli più estremi: non bisogna preoccuparsi, tanto ci sarà qualcuno che prima o poi si occuperà di risolvere
la situazione. E intanto la vita trascorre al limite della sopravvivenza.
Panem et circenses, dicevano gli antichi Romani: basta dare al popolo il pane per
farlo sopravvivere e un po’ di divertimento e lo si avrà in pugno. Festa, farina e forca, diceva Ferdinando II di Borbone, che teneva buoni i napoletani concedendo loro oltre che pane e divertimenti anche qualche pubblica impiccagione ogni tanto
per dimostrare il proprio potere. Proprio questo tenere il capo chino e asservirsi
senza discutere al potere costituito, da chiunque esso sia detenuto, ha fatto la storia del nostro paese e del Sud in particolare. Ogni tanto però qualcuno che prova a
scardinare le regole c’è.
Siamo nel 1979 e viene dato alle stampe il secondo disco di Pino Daniele. TERRA MIA aveva rappresentato come dice lo stesso musicista: “La nascita di una nuova canzone napoletana, e anche la denuncia sociale di una generazione che non ac17
cettava compromessi e che nella musica riusciva a esprimere i propri malesseri. Terra mia fu scritta sul divano di casa mia a Santa Maria la Nova 32, le mie ambizioni erano quelle di scrivere canzoni come Luigi Tenco e suonare con i grandi chitarristi, a metà tra futuro e tradizioni”12. Ma PINO DANIELE rappresenta per l’autore un vero e proprio punto di svolta, e la canzone simbolo di questo exploit è Io so’
pazzo, che ha come voce narrante quella di un Masaniello blues, un Masaniello rinnovato che si fa portavoce delle istanze di cambiamento di un’intera generazione:
“Quando scrissi Io so’ pazzo era il 1979 e quella canzone rappresentò lo sfogo a lungo represso di tutta un’ondata giovanile. […] Con Io so’ pazzo partecipai al Festivalbar, mi sembrava il massimo”13.
Ancora una volta c’è il blues, ancora una volta c’è la musica tradizionale napoletana, Rino Zurzolo al basso e Rosario Jermano alla batteria. Ancora una volta Pino
Daniele canta nel suo napoletano italianizzato e ancora una volta si parla di ribellione, di rovesciamento delle regole, di protesta.
Masaniello, nato da un pescatore e una massaia nel quartiere Mercato della città
partenopea, si fece portavoce di una rivolta contro il rincaro delle tasse, imposto
dalla Spagna dei Borboni, che aveva messo in ginocchio la popolazione napoletana. Dopo aver ottenuto la diminuzione della pressione fiscale, Masaniello, che non
era un anti-spagnolo come si potrebbe credere, venne ammesso a Corte assieme alla moglie e cambiò il proprio atteggiamento diventando esigente e spietato nei confronti del popolo stesso. Per questo motivo fu accusato di pazzia dai lazzari che lo
avevano sostenuto durante la rivolta. Lui cercò inutilmente di difendersi: accusò i
suoi detrattori di ingratitudine e, ricordando loro le condizioni in cui versavano
prima della rivolta, pronunciò la frase rimasta proverbiale: “Tu ti ricordi, popolo
mio, come eri ridotto?”. Sentendosi braccato cercò rifugio nella Basilica del Carmine e qui, interrompendo la celebrazione della messa, salì sul pulpito per tenere
il suo ultimo discorso:
Amice miei, popolo mio, gente: vuie ve credite ca io so’ pazzo e forze avite raggione vuie: io so’ pazze overamente. Ma nunn’è colpa da mia, so state lloro che
m’hanno fatto asci’ afforza n’fantasia! Io ve vulevo sulamente bbene e forze
sarrà chesta ’a pazzaria ca tengo ’ncapa. Vuie primma eravate munnezza e mo’
site libbere. Io v’aggio fatto libbere. Ma quanto può dura’ ’sta libbertà? ’Nu
juorno? Duie juorne? E già pecché po’ ve vene ’o suonno e ve jate tutte quante ’a cucca’. E facite bbuone: nun se po’ campa’ tutta ’a vita cu’na scuppetta
’mmano. Facite comm’a Masaniello: ascite pazze, redite e vuttateve ’nterra, ca
site pat’ e figlie. Ma si ve vulite tenere ’a libbertà, nun v’addurmite! Nun pusate ll’arme! ’O vedite? A me m’hanno avvelenate e mo’ me vonno pure accidere. E c’hanno raggione lloro quanno diceno ca ’nu pisciavinnolo nun po’
addeventa’ generalissimo d’a pupulazione a ’nu mumento a n’ato. Ma io nun
vulevo fa’ niente ’e male e manco niente voglio. Chi me vo’ bbene overamente dicesse sulo ’na preghiera pe’ me: ’nu requiam aterna e basta pe’ quanno
moro […]14.
18
Masaniello fu imprigionato e ucciso con la connivenza degli spagnoli. Fu decapitato e il suo corpo fu trascinato per le strade del Lavinaio e poi gettato nell’indifferenza generale tra Porta del Carmine e Porta Nolana. Ma subito dopo la sua morte, il popolo si rese conto di aver perso ogni privilegio e tornò nelle condizioni di
miseria che avevano preceduto la rivolta. Avevano accusato il loro capopopolo di
pazzia, l’avevano rinnegato e qualche giorno dopo iniziarono a piangerlo manifestandogli la propria devozione: una vicenda storica esemplare che dimostra come sia
complesso cercare di cambiare le regole senza che una vera e propria rivoluzione dei
costumi e della morale faccia da base a ciò che si può ottenere con la forza.
Ma torniamo a noi. Il Masaniello voce narrante del brano Io so’ pazzo è un Masaniello particolare, “cresciuto” che, dipintosi il volto di nero per farsi notare, arringa la folla con un discorso di protesta dai toni piuttosto accesi. Il blues, introdotto
dall’armonica suonata dallo stesso Daniele, è supportato dai fiati di James Senese e
il testo della canzone richiama molto da vicino il discorso del personaggio storico:
Io so’ pazzo, io so’ pazzo
e voglio essere chi voglio io
ascite fora d’a casa mia
Io so’ pazzo, io so’ pazzo
c’ho il popolo che mi aspetta
e scusate vado di fretta
Masaniello redivivo si fa portavoce dell’insofferenza di una generazione intera, e
l’autorità costituita non può condannarlo se parla apertamente poiché è pazzo e
quindi può dire quello che vuole e finalmente essere come desidera senza che nessuno possa costringerlo a rientrare nei ranghi. “Oggi voglio parlare”, dice la voce
narrante, dire le cose come stanno senza peli sulla lingua, denunciare, anche violentemente se necessario. L’intento politico è forte, la presa di posizione è aperta,
fino ad arrivare a quell’ultimo verso rimasto famoso per l’uso del turpiloquio, che
in quegli anni nessuno era abituato a sentire nelle canzoni, figurarsi poi al Festivalbar. “‘Io so’ pazzo e nun ce scassate ’o cazzo’. Fu una bella scommessa riuscire a cantarlo in televisione e far passare il disco alla radio, fu una canzone di rottura un po’
coraggiosa ma la cosa bella è che io pensavo a suonare di più la chitarra e non mi
accorgevo che le mie canzoni più belle nascevano così quasi per gioco. […] Veniva
fuori così l’anima del ‘quartiere Porto’ dove sono cresciuto”15.
Masaniello, nato e cresciuto alla fine del Seicento nel quartiere Mercato, si era
fatto portavoce delle esigenze del popolo e aveva combattuto per migliorarne le
condizioni con la forza; Pino Daniele, nato nel quartiere Porto, alla fine degli anni
Settanta del Novecento incarna i panni di un novello capopopolo per farsi portavoce delle esigenze dei giovani del Sud d’Italia. Quei giovani che passano il loro
tempo a desiderare un mondo diverso, che soffrono nel vedere la propria terra devastata dagli abusi della politica e della criminalità, quei giovani che discutono fino allo sfinimento cercando una soluzione a piaghe come la disoccupazione e l’analfabetismo, che desiderano soltanto un domani migliore e un po’ di libertà.
19
Chiove ’ngoppa a ’sti palazze scure
’ngoppa ’e mure fracide d’a casa mia
ma che succede io sto chiagnenno
penzanno ’o tiempo ca se ne va
e cammino ’miezo a via
parlanno ’e libertà
Piove sui palazzi scuri, sui muri diroccati della mia casa, ma che succede? Io sto
piangendo pensando al tempo che se ne va: così dicevano le parole di una delle canzoni più commoventi di TERRA MIA, quella che chiudeva il disco e che ha per titolo la parola chiave della produzione del giovane Pino Daniele: libertà.
Ma che cosa è successo al cantore della libertà? A quel giovane musicista che si
faceva portavoce del disagio generazionale? Agli armonici di quella chitarra che simulavano le gocce di una pioggia salvifica, una pioggia che davvero sembrava avere il potere di cambiare le cose, di pulire l’anima dal male, di far filtrare un raggio
di speranza tra i vicoli bui di una terra così martoriata?
Facciamo un piccolo salto temporale. Siamo nel 2007, dalla pubblicazione di TERRA MIA sono passati precisamente trent’anni. Intervistato per il «Corriere del Mezzogiorno» da Carmine Aymone, Pino Daniele riflette sul suo primo lavoro discografico: “È il disco più bello che abbia fatto finora, anche perché il primo lavoro nasce
sempre in totale libertà, lontano da qualsiasi tipo di meccanismo discografico e condizionamento […]. Era un periodo incredibilmente fertile per la musica in Italia. In
ogni città nascevano scuole, come quella genovese, milanese, romana. E c’era la nostra, quella napoletana. Eravamo tutti attaccati alle nostre radici. Il musicista era un
operatore culturale”16. Ecco, in quell’imperfetto sta tutto il nocciolo della questione:
il musicista era un operatore culturale. Ma che cosa di preciso è cambiato dalla fine
degli anni Settanta a oggi? Che Pino Daniele, pur non vivendoci più, abbia continuato incessantemente a mantenere un rapporto stretto e per così dire “politico” con
Napoli è indubbio. Di sue dichiarazioni sulle condizioni degradate della città è piena la stampa, fino ad arrivare al 2008, anno in cui l’artista organizza un grande concerto a Piazza Plebiscito per portare alla coscienza generale il tema tanto dibattuto
della raccolta differenziata, tirandosi addosso polemiche di ogni genere. Lo accusano
di essersi buttato a Destra perché per organizzare la manifestazione ha accettato di
collaborare con il Ministro Prestigiacomo. Lo accusano di aver tradito il proprio pubblico per aver invitato sul palco Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. Ma lui risponde
così: “Questa non è soltanto la festa di Pino Daniele e del suo pubblico, questa potrebbe essere la sera che mette insieme i mille volti di Napoli, le sue mille facce, le
sue mille voci nella volontà di ricominciare davvero per i bambini di Napoli: loro sono il futuro della città, per loro ha senso scommettere che la nottata può passare, che
l’emergenza può essere superata, che le divisioni, tra artisti, parti politiche, tifoserie,
possono aspettare. Prima bisogna rialzarsi, ritrovare la dignità, perché come diceva
quella canzone, oggi più che mai, Napule ’a sape tutto ’o munno ma nun sanno ’a
verità. Diciamogliela quella verità, mostriamogliela, suoniamogliela, cantiamogliela.
Da musicanti, da lazzari felici, da uomini in blues, da mascalzoni latini”17.
20
Note
Prefazione
1. Intervista al «Corriere della Sera», 3 giugno 2011.
2. Tratto dallo speciale per Mr. Fantasy, 1981.
Napule è… terra mia
1. P. Daniele, Storie e poesie di un mascalzone latino, Pironti, Napoli, p. 9.
2. Ivi, p. 10.
3. Il munaciello è uno spiritello dall’animo volubile che la tradizione vuole si nasconda nelle case dei napoletani. Se prende in antipatia i suoi ospiti può far loro dispetti, nascondere o far sparire le cose, se invece è di buon animo si dice che appaia
nei sogni per dare i numeri del lotto.
4. La zarallara è la venditrice di nastri e fettucce, che all’occasione aveva nel suo
negozio anche i giocattoli rudimentali dell’epoca.
5. Dalla trasmissione radiofonica 40° Parallelo, trasmessa a Radio Eurosound il
2 novembre 1976.
6. Ibidem.
7. M. Serao, Il ventre di Napoli, 1905.
8. P. Daniele, Storie e poesie, cit., p. 66.
9. Dalla trasmissione radiofonica 40° Parallelo, cit.
10. P. Daniele, Storie e poesie, cit., pp. 63-64.
11. Il putipù è uno strumento tradizionale napoletano utilizzato anche in gran
parte del Sud d’Italia. È un tamburo a frizione composto da una membrana in pelle animale o in tela grossa, una canna (generalmente di bambù) e da una camera di
risonanza (in legno o in latta). La canna viene spinta verso il basso e la frizione produce un caratteristico suono dalla tonalità bassa.
12. Dal sito www.pinodanieleonline.it.
13. P. Daniele, Storie e poesie, cit., p. 29.
14. http://it.wikipedia.org/wiki/Masaniello.
185
15. Dal sito www.pinodanieleonline.it.
16. C. Aymone, Pino Daniele a trent’anni da terra mia: “Napoli non si rassegna
ma servono leggi speciali”, in «Corriere del Mezzogiorno», 13 novembre 2007.
17. P. Daniele, Con Nino e Gigi canto di riscatto e di speranza, in «Il Mattino», 8
luglio 2008.
18. P. Treccagnoli, La piazza si divide, Gigi diventa un caso, in «Il Mattino», 8 luglio 2008.
19. Ibidem.
20. L. Cerbini, Intervista a Pino Daniele, in «America Oggi», 11 settembre 2009.
21. Ibidem.
22. G. Borgna, Il tempo della musica, Laterza, Bari, 1983, p. 10.
23. R. Musil, I turbamenti dell’allievo Törless, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 137.
24. M. Décharné, A Rocket in My Pocket, Arcana, Roma, 2011, p. 61.
25. G. Borgna, cit., p. 21.
26. M. Décharné, cit., p. 137.
27. D.M. Epstein, The Ballad of Bob Dylan, Arcana, Roma, 2011, p. 62.
28. G. Borgna, cit., pp. 22-23.
29. J. Kerouac, Sulla strada, Mondadori, Milano, 2008, p. 11.
30. D.M. Epstein, cit., p. 77.
31. Ivi, p. 120.
32. P. Ginzborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino, 1989, p. 345.
33. C.G. Romana, Fabrizio De André. Amico fragile, Arcana, Roma, 2011, pp.
63-64.
34. C.G. Romana, cit., p. 75.
35. G. Borgna, cit., p. 59.
36. C.G. Romana, cit., p. 65.
37. Ivi, p. 75.
38. M. Padalino, The Beatles. Yeh! Yeh! Yeh! Testi commentati 1962-1966, Arcana,
Roma, 2010, p. 49.
39. M. Lang, Woodstock, Arcana, Roma, 2009, pp. 15-16.
40. C. Fabretti, Francesco De Gregori. Fra le pagine chiare e le pagine scure, Arcana, Roma, 2011, p. 14.
41. G. Borgna, cit., p. 133.
42. Ivi, p. 131.
43. G. Zichella, intervista a Pino Daniele, «Popon», 21 gennaio 2011.
44. L. Valtorta, intervista a Carmen Consoli, «XL», ottobre 2009, n. 49.
45. F. Vacalebre, Pino Daniele: “Dopo Clapton ricomincio da indipendente”, «Il
Mattino», 26 giugno 2011.
46. C. Consoli, intervista al Corriere.it, 2009.
47. F. Vacalebre, Pino Daniele: “Dopo Clapton ricomincio da indipendente”, cit.
48. ‘E intanto passa questo Novecento, passiamo noi e si aggiusta il tempo, se
apri il mobile sai dove ti trovi e non lo scordi mai. E intanto passa questo Novecento, camicia fuori dai pantaloni e te lo senti addosso, e resti sveglio tutta la notte, pensando a dove sei stato’.
186