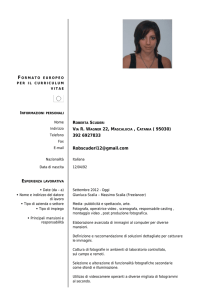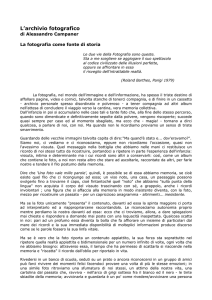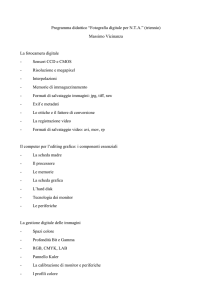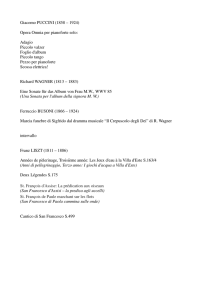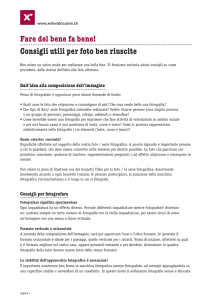Testo Convegno Ravenna 26-­‐27 maggio 2016 “CRIMINI ALLA NAZIONE”. Fotografie di autolesionismi nelle raccolte museali della Scuola di Sanità Militare di Firenze. di Monica Maffioli Nell’ambito dei miei recenti interessi di studio riferiti alla fotografia scientifica in Italia, ho avuto modo di consultare alcuni importanti fondi fotografici e tra questi un inedito nucleo di fotografie conservate presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze. Tra i molti materiali esposti nelle sale del piccolo museo ubicato nel rinascimentale chiostro del Maglio, parte dell’antico convento di San Domenico in Cafaggio, in via Venezia, oltre alla collezione didattica di strumenti medico-­‐farmaceutici, dalla seconda metà del XIX secolo fino alla metà XX secolo, vi sono alcuni documenti fotografici di straordinaria importanza per la storia della medicina e dell’applicazione della fotografia nei diversi ambiti specialistici della stessa disciplina. La Scuola di Applicazione di sanità Militare fu istituita a Firenze da Umberto I con regio decreto del 16 novembre 1882, la prima accademia militare italiana per la formazione di sottotenenti medici di complemento, dotata di una ricca biblioteca di testi, tutt’oggi di grande interesse per la presenza di opere scientifiche edite a partire dai primi del XIX secolo, suddivise nelle diverse branche specialistiche della medicina, e di laboratori per l’insegnamento della traumatologia di guerra, della batteriologia, di laboratori di igiene, di chirurgia sperimentale, di radiografia e di gabinetti di medicina legale e militare. Nel 1916 qui si tenne il primo corso di tossicologia di guerra, a soli tre mesi dall’ecatombe chimica avvenuta a Monte San Michele, avendo sempre un ruolo di riferimento e all’avanguardia nell’insegnamento medico-­‐militare. La Scuola ha continuato la sua attività fino al 1998 quando con decreto legislativo ne è stato deciso il trasferimento a Roma nella sede della caserma della Cecchignola, dove sono stati traslocati tutti gli archivi e a breve saranno dislocate anche le collezioni museali costituite da un migliaio di reperti tra strumenti chirurgici di varie epoche, cere dimostrative per la ricostruzione facciale, strumenti per lo studio della meteorologia, della batteriologia, della chimica, oltre a centinaia di specie di animali velenosi conservati per fini farmaceutici. A ciò si aggiunge la documentazione fotografica, costituita da alcune centinaia di diapositive, ad uso didattico, delle principali malattie endemiche delle colonie africane, alcune rare stampe fotografiche delle prime sperimentazioni radiografiche, un “negativoscopio” a parete contenente 19 negativi su vetro con soggetto “Proiettili di fucile in moto – Getti d’Aria – Correnti d’aria incontranti ostacoli”, “Negative Originali Ottenute e Donate da Lodovico Mach di Vienna”, come indica il cartiglio riportato sul visore. Con molta probabilità si tratta delle immagini presentate dal filosofo e fisico austriaco Ernst Mach all’Esposizione fotografica tenutasi a Firenze nel 1899 con riferimento alle sue ricerche sui movimenti dell’aria attraversata dai proiettili, alle forme ottenute fotografando un getto d’aria o un’onda sonora, e successivamente donate alla Scuola dal figlio. Purtroppo non rimane alcuna testimonianza documentaria della donazione né per quanto riguarda la data in cui avvenne né le ragioni che la motivarono. Infine, e veniamo a ciò che più ci interessa in questa occasione, nel museo si conserva una serie di 5 album fotografici, databili tra il 1917 e il 1918, rilegati in tela rossa e intitolati sul piatto a caratteri d’oro “SCUOLA DI APPLICAZIONE DI SANITA’ MILITARE – FIRENZE / ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE (DIRETTORE TENENTE COLONNELLO MEDICO EDOARDO CARVAGLIO) / SIMULAZIONE ED AUTOLESIONISMO (fotografie – raccolte varie)”. Nell’insieme, si tratta di un ‘corpus’ di 480 stampe fotografiche alla gelatina bromuro d’argento di diversi formati, da cm 5,5 x 4 a cm 24 x 34 circa, al quale vanno ad aggiungersi 11 stampe stereoscopiche alla gelatina bromuro d’argento, anch’esse con soggetto forme diverse di autolesionismi, provenienti, come indicato sul retro della cartonatura, dalla “Raccolta Magg. Medico Mariani Prof. Giuseppe” del Reparto Autolesionisti di Milano. L’eccezionalità dell’insieme fotografico è in primo luogo la consistenza del corpus iconografico dedicato al soggetto ‘autolesionismo’, difficilmente rintracciabile nei più importanti archivi di documentazione fotografica riferiti alla prima guerra mondiale. A mia conoscenza non risultano al momento altri fondi fotografici di riferimento per questo genere di testimonianze, trovandoci per la prima volta di fronte ad un repertorio di straordinaria rilevanza storica e iconografica. Tuttavia, la recente frammentazione e dislocazione in altra sede delle fonti d’archivio e documentarie della Scuola, fondamentali per la contestualizzazione storica di tutti i reperti conservati nel museo, non ci facilita nella ricerca e nella lettura di queste testimonianze fotografiche, oggetto di quella ‘censura’ storica che per molti decenni, almeno fino alla fine degli anni Sessanta, non ha riconosciuto nell’ampio fenomeno dell’autolesionismo, una delle manifestazioni comportamentali più significative e inedite dell’individuo coinvolto nella prima ‘guerra meccanica’, sintomo di una profonda crisi di identità dell’essere umano e della sua istintiva volontà di sopravvivenza e di fuga dagli orrori della trincea e da morte certa. Nei molti diari di guerra che vennero scritti dal fronte, troviamo alcuni sporadici riferimenti al fenomeno, ma, al di là della citazione di uno specifico caso, è nell’intera narrazione dell’atrocità dell’esperienza della guerra in trincea, della consapevolezza dei fanti in prima linea, per lo più provenienti dalle classi subalterne, spesso analfabeti e provenienti dalle aree meridionali della nazione, che riconosciamo la loro consapevolezza di essere solo dei corpi senza identità, strumenti di guerra ‘sacrificati’ alla gloria della patria. Nel noto Diario di un imboscato, pubblicato da Attilio Frescura nel 1919 troviamo, a mio parere, una delle definizioni più lucide della logica che muove l’uomo in guerra a compiere sul suo corpo atti di violenza, mutilazioni irreversibili, segni indelebili della propria volontà di sottrarsi all’ideologia dell’eroicità e dell’onore, esaltata non solo dai comandi militari ma anche dalla società civile: “…è una sorda lotta per l’esistenza fra chi vuol costringere l’uomo a morire e l’uomo che si mutila per non morire.” Il primo caso di autolesionismo di cui siamo a conoscenza è documentato in una sentenza pronunciata il 29 luglio 1915, due mesi dopo l’entrata in guerra dell’Italia, dal tribunale di guerra del X corpo d’armata: coinvolge 46 imputati, di cui 27 condannati a venti anni di carcere “per reato di codardia per ferite provocate in faccia al nemico”. La politica dell’esercito e dei tribunali militari, sostenuti da apposite commissioni mediche, fu quella del rigore ‘punitivo’, dell’affermazione della disciplina come regola prima, dell’esemplarità nell’ infliggere pene durissime, fino alla pena di morte, allo scopo di scoraggiare il fenomeno, che, viceversa, nel corso dei mesi e degli anni acquista dimensioni di massa. Mi sembra opportuno fare riferimento ai numeri per comprendere la vastità del fenomeno: come ci ricorda lo storico Alberto Monticone nella sua introduzione al volume curato insieme a Enzo Forcella, Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, nel 1915 le condanne emesse dai tribunali dell’esercito per atti di autolesionismo furono 1.094, triplicandosi nel 1916, con 3.118 casi accertati e puniti; nel 1917 il numero delle condanne diminuisce a 2.136, forse anche a causa del cambiamento di atteggiamento dell’esercito nei confronti della condanna da imputare, che si trasforma, per ragioni di ‘economia bellica e di forze umane disponibili’, dalla reclusione all’immediato reinserimento al fronte di guerra, vanificando in tal modo le stesse motivazioni dell’autolesionismo. Questi dati vengono confermati anche attraverso una semplice ricerca con lo straordinario strumento informatico di Ngram Viewer Google Books, dove la parola ‘autolesionismo’ è utilizzata per la prima volta nella pubblicistica del 1914, crescendo esponenzialmente, con un suo apice nel 1916, per stabilizzarsi nel 1920 con un incremento numerico costante negli anni successivi. Un’altra causa della riduzione del fenomeno è certamente la maggiore esperienza che i medici via via acquisiscono nel riconoscere le diverse lesioni e malattie procurate e nella diagnosi di autolesionismo e simulazione, in particolare nel caso delle malattie mentali. Nell’agosto del 1917 una circolare dell’Ufficio sanitario del ministero della Guerra istituisce presso la sede di ciascun corpo d’armata degli speciali “Ospedali per autolesionisti” e specifica le norme per la loro organizzazione. Nella circolare si afferma che il personale medico specialistico si deve impegnare nell’organizzazione periodica di conferenze sulle diverse casistiche riscontrate per ampliare la conoscenza agli altri presidi ospedalieri delle diagnosi di autolesionismo e per i casi che verranno considerati non comuni o importanti dovranno essere redatte dai medici delle relazioni particolari che il ministero invierà alle direzioni dei vari ospedali, affinché gli ufficiali medici possano tempestivamente conoscere le nuove forme di autolesionismo e, possibilmente, i mezzi adoperati dagli individui per provocare le infermità. Per le loro caratteristi specifiche, i cinque album della Scuola di Applicazione di Sanità Militare di Firenze sembrano, dunque, essere stati compilati a scopo didattico e classificatorio delle diverse forme di autolesionismi, rispondendo all’esigenza di creare dei repertori di supporto all’attività diagnostica, una sorta di manualistica illustrata che in modo esemplificativo censisce le molteplici forme di lesioni e malattie. In continuità con quanto la fotografia scientifica italiana, fin dalla seconda metà del XIX secolo, aveva prodotto, riconoscendo nella matrice tecnica della fotografia una valida risposta alle istanze di indagine e di conoscenza dettate dalla disciplina deterministica e fenomenologica alla base del pensiero ‘positivista’, il repertorio fotografico che vi sto presentando, trae fondamento da tali principi di ‘razionalità scientifica’, legati alla rappresentazione della ‘realtà’ attraverso l’apparecchio fotografico, operando un radicale cambiamento delle certezze cognitive, soprattutto nel campo delle scienze umane dove la necessità di conoscere ‘l’altro da sé’ diventa l’elemento primario della ricerca. Dagli anni Settanta del XIX secolo, infatti, la ricerca scientifica italiana, grazie alla fotografia, aveva radicalmente trasformato la metodologia di studio delle discipline antropologiche, etniche, sociali, mediche, favorendo un progetto di sistematizzazione e classificazione della specie umana che, dalle teorie darwiniane alla pragmatica schedatura lombrosiana, costituisce a nostro parere, l’ossatura portante della cultura positivista e il riconoscimento dell’“Altro da sé”. La rivoluzione visiva dettata dalla fotografia impone la ricerca delle chiavi di lettura per la documentazione del “Sé”, svela l’identità della persona, il suo ruolo sociale, i suoi legami familiari, ma anche gli stati emotivi e lo stato psicopatologico della malattia mentale, consacrando il trionfo della ritrattistica fotografica. Il medico inglese Diamond, già nel 1865, in un suo discorso alla Royal Photographic Society di Londra, con riferimento ai suoi studi sugli ‘alienati’, aveva già teorizzato l’universalità del linguaggio fotografico poiché l’operatore, afferma “(…) non ha bisogno di nessun altro linguaggio che il suo. Predilige l’ascolto delle sue stesse fotografie, il silenzioso ma esplicito linguaggio della natura che trova davanti ai suoi occhi. Per il fotografo non è necessario usare le vaghe parole che denotano la differenza nelle varie forme di sofferenza mentale, come per esempio, l’angoscia, l’afflizione, la profonda tristezza, il lutto, la melancolia e la disperazione; la fotografia parla da sola ed è capace di indicare il punto esatto che è stato raggiunto nella scala dell’infelicità (…).” Accogliendo pienamente le ragioni di un’imprescindibile delega alla fotografia della capacità di essere l’interprete, attraverso il ritratto delle persone, del loro stato fisico ed emotivo, così come di quello mentale, gli studi di fisiognomica adottano metodologie di classificazione diagnostica e identificativa utile alla formazione di un repertorio di riferimento per il progresso della conoscenza medica, che alla fine dell’Ottocento aprirà la strada alla fotografia d’identità giudiziaria e in stretta continuità con questa, alle fotografie di autolesionismi che qui stiamo presentando. Dalla numerazione d’inventario riportata sulla coperta degli album possiamo rilevare che la serie non è completa, mancando i primi due numeri, e pur presentando tutti la stessa rilegatura e titolatura, sono di dimensioni diverse tra loro e non uniformi nelle modalità dell’impaginato fotografico così come nel trattamento dei dati testuali, in alcuni casi riportati direttamente al di sotto dell’immagine, in altri casi attribuendo alla fotografia una numerazione che rimanda a degli indici in appendice agli stessi album. Questo carattere di disomogeneità, oltre alle evidenti differenze dei formati delle fotografie, fa pensare a un nucleo composito di immagini realizzate da più fotografi e in località diverse, così come ad una più attenta analisi, ci viene confermato dalla presenza di alcune indicazioni autografe di due medici autori di alcune di queste fotografie, il “Capitano Medico Busacchi” e tal “G. Pisenti di Bologna”, oltre alla presenza di un timbro ad inchiostro, apposto su tutte le tavole dell’album inventariato con il numero VII, che documenta la provenienza delle fotografie dall’ “Ospedale Militare di Riserva di Firenze. Gruppo Villa Manetti”. L’impaginato fotografico all’interno degli album varia nella quantità di stampe fotografiche presenti e nel formato delle stesse: i formati più grandi sono disposti uno per tavola, fronte e retro, mentre i formati più piccoli, come ad esempio nell’album numero VI, sono disposti sulle pagine in numero irregolare, raggruppati per genere di lesioni o mostrando una sequenza temporale che testimonia dell’evoluzione della malattia, in alcuni casi fino alla guarigione. Il rigore tassonomico che contraddistingue la costruzione di questi album, a volte è supportato dall’indicizzazione di tutte le immagini presenti nell’album con riferimento al nome della persona, il suo grado militare, l’anno del suo ingresso in ospedale, il numero di verbale e una breve indicazione della ‘sindrome’ o del trauma; in alternativa, le informazioni del tipo di autolesionismo sono riportate manoscritte sulla tavola dell’album. Le fotografie seguono una sequenza riferita al tipo di lesione o sindrome, creando un percorso visivo inedito sia per il tipo di documentazione sia per la qualità tecnica e compositiva delle immagini stesse. Scorrendo le fotografie dell’album inventariato con il numero di catalogo 22. III, proveniente dall’”Ospedale Militare per Autolesionisti del Corpo d’Armata di Roma. Convento di S. Antonio Viale Manzoni n. 1”, come si legge nella prima pagina dell’indice in appendice, per omogeneità e modalità compositive delle inquadrature, le fotografie a mio parere sono opera di un unico autore, purtroppo non identificato. Il soggetto rappresentato, che esso sia un arto con delle ulcerazioni da materiali caustici o la messa in posa del paziente ripreso a mezzo busto con in evidenza gli edemi da stasi degli arti superiori e inferiori, o ancora le posizioni innaturali causate da contratture simulate, paralisi facciali, lesioni oculari, fino alla psicosi simulata, è sempre ripreso contro un fondale scuro che scontorna la figura o parte di essa, nel tentativo di creare delle schede identificative di carattere esclusivamente scientifico, prive di riferimenti al contesto ambientale. Tuttavia, nella maggior parte di esse, e in particolare nella ritrattistica, ciò che colpisce è la presenza, più o meno volontaria, ma comunque parte ineludibile delle scelte compositive dell’autore, che a loro volta hanno delle ricadute nella sua visione estetica, la presenza, dicevo, del fattore umano, o meglio, di una visione empatica con il soggetto, che rivolge il suo sguardo all’obiettivo fotografico mostrando il coraggio delle sue scelte o l’invocazione di una misericordiosa comprensione delle ragioni che lo hanno portato ad infliggere al suo corpo gravi sofferenze pur di poter continuare a vivere. La potenza espressiva di alcune di queste immagini, dove l’attenzione del fotografo è rivolta non soltanto a un attento studio delle luci ma anche alla composizione della figura, evidenziando, per confronto, la patologia, ad esempio di una mano o di una gamba lesionate, con l’altro arto non offeso, suggerisce una sensibilità compositiva per l’inquadratura di tipo professionale, e crediamo, una capacità di visione che fa riferimento alla cultura fotografica tra fine Ottocento e primi Novecento. Non possiamo, in questo caso, non fare riferimento alle schedature fotografiche degli atlanti lombrosiani dell’Uomo delinquente, tuttavia, in alcune fotografie oggetto della nostra riflessione, sembra di riconoscere una maggiore sensibilità nella ripresa, tanto da poter azzardare un confronto con la progettualità e la sintassi estetica dell’utopico catalogo fisiognomico L’Uomo del XX secolo a cui lavorò dal 1911 August Sander. All’interno dell’album le fotografie sono impaginate seguendo un ordine riferito alle diverse tipologie di autolesionismo, così come indicato nell’indice posto sul retro della coperta: lesioni da caustici, autocontusioni, elaiopatie (termine coniato dal medico legale toscano Cesare Biondi studiando sul campo, durante la prima guerra mondiale i vari aspetti dell’autolesionismo), edemi da stasi, lesioni traumatiche degli arti superiori, contratture simulate, camptocormie, lesioni ai condotti uditivi, paralisi del facciale, lesioni oculari e psicosi simulata. La lesione alle mani o ai piedi era la pratica di autolesionismo più frequente, soprattutto nei primi mesi della guerra, ricordata anche da Carlo Salsa nel suo diario quando riferisce che “a Sdraussina ne hanno fucilati parecchi, quasi tutti feriti alle mani”; tuttavia, con il passare dei mesi e vista l’ampiezza del fenomeno, le autorità militari ’depenalizzarono’ tale crimine ordinando ai medici di rimandare i feriti alle mani in trincea. Un’altra patologia spesso citata anche nei diari di guerra è la ‘follia’, considerata dai medici il più delle volte simulata. Ne troviamo testimonianza anche in alcune fotografie dei nostri album, dove vengono mostrate scene di contenimento del paziente in stato di isterismo ma anche individui in stato catatonico, così come molte patologie documentate fotograficamente sono rubricate come forme nevrotiche. Alcune recenti pubblicazioni, in particolare i saggi di Bruna Bianchi, e alcuni casi di studio, tra cui la tesi di laurea specialistica di Andrea Colbacchini del Dipartimento di storia moderna e contemporanea dell’Università di Padova, sono state dedicate al tema del trauma psichico e del corpo mutilato nella Grande Guerra, hanno trattato l’argomento in modo molto approfondito, e a questi lavori rimando per una più ampia analisi sul tema. Tuttavia, non possiamo non ricordare che la difficoltà della diagnosi della simulazione della malattia mentale in periodo di guerra è uno dei temi maggiormente dibattuti dalla psichiatria che si divide in due scuole di pensiero, quella analitica freudiana, che teorizza la nevrosi traumatica, e quella istituzionale, adottata in particolare in Italia, che pratica la terapia d’urto utilizzando le scosse elettriche per riportare il paziente all’ordine mentale e poi rimandarlo al fronte con compiti altrettanto usuranti e a rischio poiché considerati individui socialmente lesivi della pace collettiva delle truppe. Mentre in Gran Bretagna il linguaggio medico adottava già nel 1915 il termine di “shell-­‐shock”, per definire le lesioni psichiche causate dalla guerra, in Italia, come ha giustamente osservato la studiosa Bruna Bianchi nel suo testo Il Trauma della modernità. Le nevrosi di guerra nella storiografia contemporanea, a causa delle pressioni militari, nei manicomi “le diagnosi di nevrosi emotiva e nevrosi traumatica furono progressivamente sostituite da diagnosi che rinviavano alla degenerazione e alla predisposizione o che ponevano un’enfasi particolare sulla volontà di sottrarsi ai propri doveri”, arrivando alla definizione della diagnosi di ‘psicodegenerazione’. Per quanto riguarda più da vicino la storia della fotografia, è interessante citare come ancora alla fine della guerra il tema della simulazione della malattia mentale è empiricamente affrontato dal medico francese Eugène Gelma, il quale suggerisce in un suo saggio, pubblicato nel 1920 nella “Revue Neurologique”, il metodo dell’osservazione dei pazienti trattenuti per diverse settimane nei centri psichiatrici, monitorandoli fotograficamente a loro insaputa, al fine di poter smascherare l’eventuale simulatore. E’ dunque ancora una volta alla fotografia, usata come dispositivo comprovante la ‘realtà, a essere affidata la funzione di documento scientifico, lo strumento insindacabile dell’agire e dell’essere, capace di ‘oggettivare’ anche il comportamento umano nella sua efficacia investigativa del visibile. Torniamo ora agli altri album della raccolta. Se non fosse per la presenza delle indicazioni manoscritte che specificano la tipologia di lesione raffigurata, la straordinaria sequenza fotografica nell’album IV.III porterebbe a credere di essere in presenza di un repertorio di immagini di studio per artisti, uno dei molti insiemi di fotografie amatoriali di cui spesso erano autori, sussidi visivi per la realizzazione di opere pittoriche o scultoree, ma anche esercitazioni accademiche sulle forme anatomiche, sui dettagli del corpo umano in posizione statica o in movimento. Dettagli di figure, teorie di gambe, di mani, corpi nudi in posa come modelli in studio. Viceversa, ciascuna di queste immagini rappresenta il dramma di un individuo che ha fatto del proprio corpo l’unica via di fuga dall’orrore della guerra, nascondendo tra il sangue e le ferite auto inferte la speranza di poter continuare a vivere. Così ancora nell’album V, proveniente dall’Ospedale Militare di Villa Manetti a Firenze, e che in appendice riporta l’Indice dei nomi e delle patologie di ciascun paziente fotografato, la narrazione visiva delle immagini sembra volgere verso una ricerca formale legata a codici del rigore estetico, dove l’accostamento di due stampe fotografiche per pagina crea delle singolari ritmicità geometriche, delle costanti simmetrie: gli arti feriti, le mani, le gambe, gli avambracci, i corpi nudi nelle posizioni causate dalla camptocormia, oggi ci rimandano al linguaggio del teatro delle ombre cinesi, ad un’estetica costruita sulle ombre e sul significato simbolico della gestualità del corpo. Ed è il corpo umano il soggetto dei nostri album, la sua trasfigurazione, la messa in scena di scelte compiute come ‘fuga’ dalla barbarie della guerra, il segno tangibile dell’esasperato tentativo di rimanere in vita, pur accettando il dolore della mutilazione invalidante. Infine, permettetemi un’ultima considerazione. Superato il retaggio storico-­‐critico che per molto tempo ha relegato la fotografia di carattere scientifico ad una lettura puramente informativa, la strada che i visual studies indicano anche nel caso della lettura delle fotografie scientifiche e che personalmente condivido, favorisce un approccio estetico nei confronti dell’immagine visiva e in quanto tale, con un suo codice formale e con le potenzialità per accedere alla sfera emozionale, capace di confrontarsi con i linguaggi visivi delle avanguardie del Novecento e dell’età contemporanea. Benché nelle finalità di queste fotografie possiamo supporre che non vi sia stata alcuna intenzionalità di produrre delle immagini ‘artistiche’, percepite per la loro qualità estetica, nel momento in cui esse sono state trasposte in forma grafica, come ha giustamente osservato Michel Frizot, è molto più difficile per chi le guarda riuscire ad astrarsi dalla percezione abituale che si ha nei confronti della fotografia e dunque applicare tutte le categorie attribuite all’immagine. E come afferma Susan Sontag, la fotografia “pur non essendo in sé una forma d’arte, ha la singolare capacità di trasformare in opere d’arte tutti i suoi soggetti”.