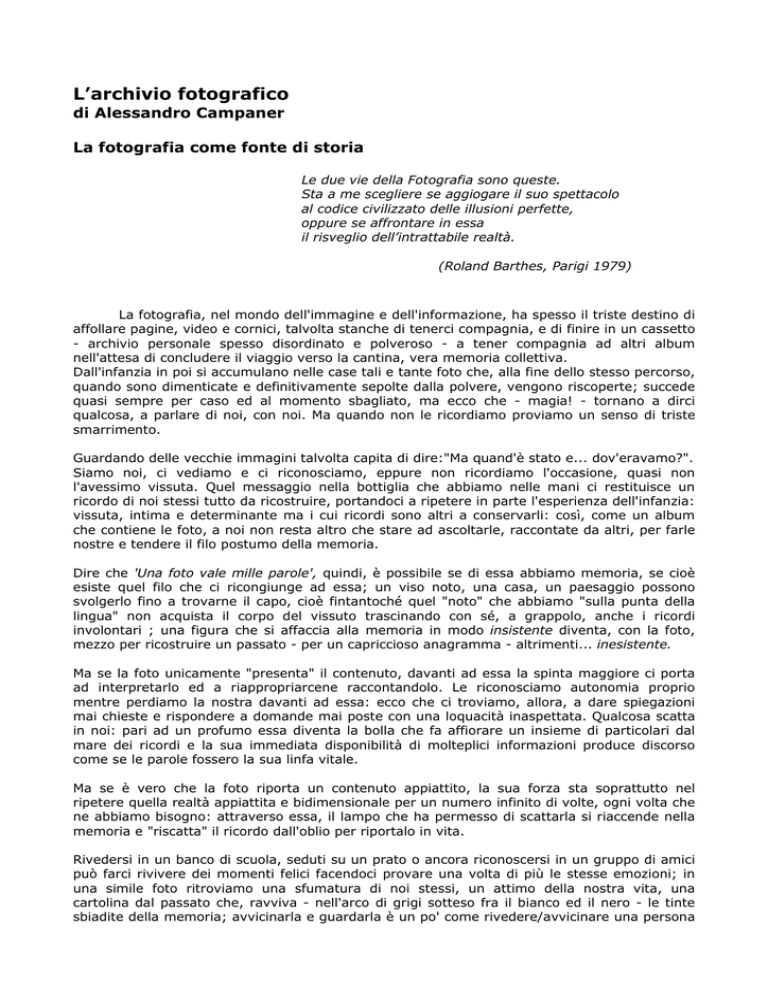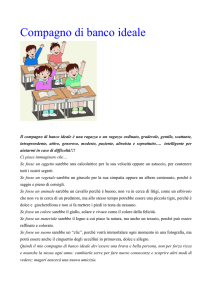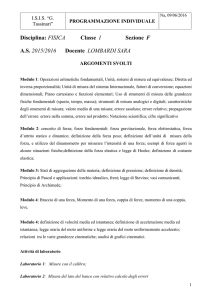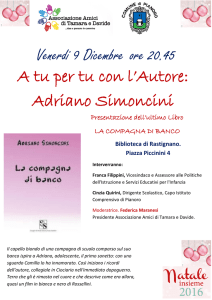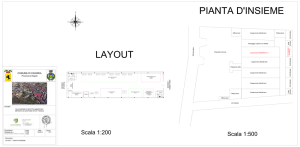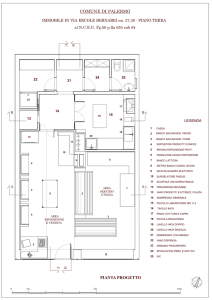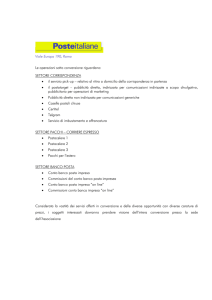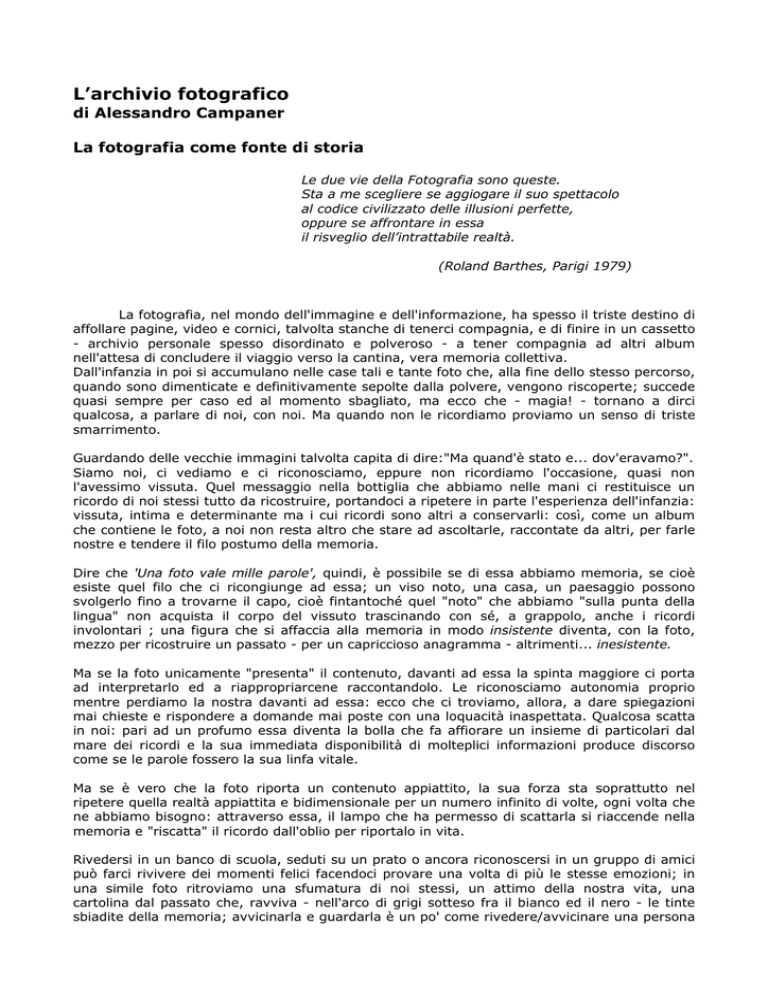
L’archivio fotografico
di Alessandro Campaner
La fotografia come fonte di storia
Le due vie della Fotografia sono queste.
Sta a me scegliere se aggiogare il suo spettacolo
al codice civilizzato delle illusioni perfette,
oppure se affrontare in essa
il risveglio dell’intrattabile realtà.
(Roland Barthes, Parigi 1979)
La fotografia, nel mondo dell'immagine e dell'informazione, ha spesso il triste destino di
affollare pagine, video e cornici, talvolta stanche di tenerci compagnia, e di finire in un cassetto
- archivio personale spesso disordinato e polveroso - a tener compagnia ad altri album
nell'attesa di concludere il viaggio verso la cantina, vera memoria collettiva.
Dall'infanzia in poi si accumulano nelle case tali e tante foto che, alla fine dello stesso percorso,
quando sono dimenticate e definitivamente sepolte dalla polvere, vengono riscoperte; succede
quasi sempre per caso ed al momento sbagliato, ma ecco che - magia! - tornano a dirci
qualcosa, a parlare di noi, con noi. Ma quando non le ricordiamo proviamo un senso di triste
smarrimento.
Guardando delle vecchie immagini talvolta capita di dire:"Ma quand'è stato e... dov'eravamo?".
Siamo noi, ci vediamo e ci riconosciamo, eppure non ricordiamo l'occasione, quasi non
l'avessimo vissuta. Quel messaggio nella bottiglia che abbiamo nelle mani ci restituisce un
ricordo di noi stessi tutto da ricostruire, portandoci a ripetere in parte l'esperienza dell'infanzia:
vissuta, intima e determinante ma i cui ricordi sono altri a conservarli: così, come un album
che contiene le foto, a noi non resta altro che stare ad ascoltarle, raccontate da altri, per farle
nostre e tendere il filo postumo della memoria.
Dire che 'Una foto vale mille parole', quindi, è possibile se di essa abbiamo memoria, se cioè
esiste quel filo che ci ricongiunge ad essa; un viso noto, una casa, un paesaggio possono
svolgerlo fino a trovarne il capo, cioè fintantoché quel "noto" che abbiamo "sulla punta della
lingua" non acquista il corpo del vissuto trascinando con sé, a grappolo, anche i ricordi
involontari ; una figura che si affaccia alla memoria in modo insistente diventa, con la foto,
mezzo per ricostruire un passato - per un capriccioso anagramma - altrimenti... inesistente.
Ma se la foto unicamente "presenta" il contenuto, davanti ad essa la spinta maggiore ci porta
ad interpretarlo ed a riappropriarcene raccontandolo. Le riconosciamo autonomia proprio
mentre perdiamo la nostra davanti ad essa: ecco che ci troviamo, allora, a dare spiegazioni
mai chieste e rispondere a domande mai poste con una loquacità inaspettata. Qualcosa scatta
in noi: pari ad un profumo essa diventa la bolla che fa affiorare un insieme di particolari dal
mare dei ricordi e la sua immediata disponibilità di molteplici informazioni produce discorso
come se le parole fossero la sua linfa vitale.
Ma se è vero che la foto riporta un contenuto appiattito, la sua forza sta soprattutto nel
ripetere quella realtà appiattita e bidimensionale per un numero infinito di volte, ogni volta che
ne abbiamo bisogno: attraverso essa, il lampo che ha permesso di scattarla si riaccende nella
memoria e "riscatta" il ricordo dall'oblio per riportalo in vita.
Rivedersi in un banco di scuola, seduti su un prato o ancora riconoscersi in un gruppo di amici
può farci rivivere dei momenti felici facendoci provare una volta di più le stesse emozioni; in
una simile foto ritroviamo una sfumatura di noi stessi, un attimo della nostra vita, una
cartolina dal passato che, ravviva - nell'arco di grigi sotteso fra il bianco ed il nero - le tinte
sbiadite della memoria; avvicinarla e guardarla è un po' come rivedere/avvicinare una persona
cara dopo un lungo viaggio: le distanze si annullano, il tempo si contrae e tutto si fa 'presente'
nella soddisfazione comune.
Riguardando queste vecchie foto di scuola, d'un tratto, insieme a quel viso noto nel banco di
scuola riaffiorano l'odore della gomma, del sussidiario fresco di stampa o della carta dei
quaderni, lo stridere del gesso sulla lavagna. Ricompaiono le macchie d'inchiostro sulle dita, le
matite colorate, le scale così ampie e quel fagiolo nell'ovatta umida, solo sulla finestra, a
misurare le ore di scuola e i giorni della germinazione.
Quando ci rivediamo in quel banco ci sembra di poter chiudere un cerchio, di poterci
riconciliare con noi stessi in un giro armonico col passato e quello che di esso ci portiamo
ancora dentro.
Siamo noi in quel banco, siamo noi anche su quella ampia scalinata e noi quella palestra
pavimentata col linoleum, noi quelle alte pertiche, quel cortile, così come nostra è quella scuola
distrutta, nostro il tetto sfondato dalle tegole e la paura di quei giorni ora lontani.
Quello che eravamo si è sedimentato in noi, è divenuto nel tempo parola, emozione,
sentimento e riaffiora tutte quelle volte che lo statuario silenzio di un'immagine ci tocca.
Quell'attimo fermato, isolato, cui mancano principio e fine ha in realtà bisogno di noi per
sopravvivere. La complessa alchimia di metalli preziosi che formano l'immagine acquista
spessore solo assieme al testimone che riempie quel silenzio, che scruta quei visi o quegli
oggetti alla ricerca delle parole che rendano loro concretezza.
Siamo sempre pronti a capire una lacrima o un sorriso davanti ad una foto, poiché esiste quella
somiglianza nel provare emozioni, tra le più diverse, davanti ad esse ed anche perché
sappiamo, con un po' d'invidia che esse ci sopravviveranno, eredità spogliata della vita per la
seconda volta, definitivamente destinate a restare volti, case, e paesaggi senza nome, se non
quello della generalità astratta.