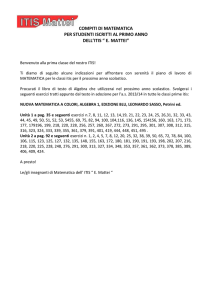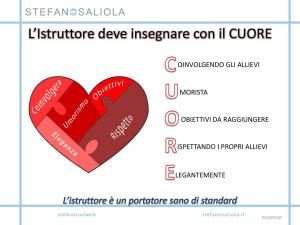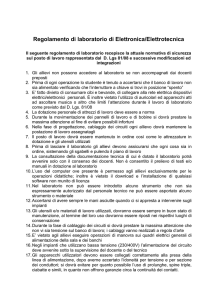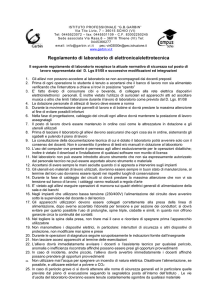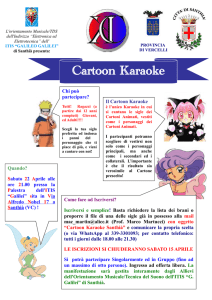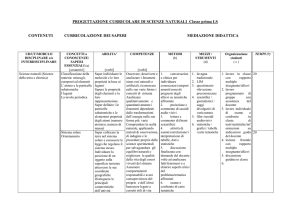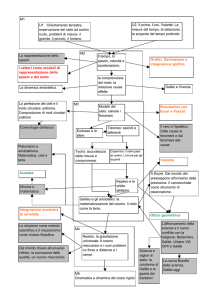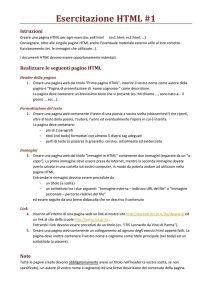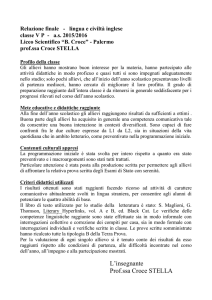Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438.61649 – Fax 0438.450178 – CF 82002710265
sito web: www.itisgalileiconegliano.gov.it – Email: [email protected] – PEC: [email protected]
Elettronica e Telecomunicazioni – Elettrotecnica e Automazione – Meccanica
ESAME DI STATO 2013/2014
CLASSE 5AEA
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Data
15 maggio 2014
Il segretario
Il coordinatore
(Prof.ssa Giuseppina Blasetti)
(Prof. Giancarlo Chieregato)
Timbro della scuola
CONTENUTO:
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI DEI DOCENTI
ALLEGATI SIMULAZIONI 3a PROVA
INDICE
Relazione del Consiglio di classe
Elenco Docenti della classe e materia d’insegnamento
Elenco studenti della classe
Presentazione della classe
Obiettivi
Metodologie didattiche
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Storia della classe e continuità didattica
Attività extracurricolari
Simulazioni delle prove d’esame
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
3
3
4
4
6
6
7
7
8
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
9
12
16
19
22
26
30
32
35
37
39
Relazioni finali e programmi dei docenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Elettrotecnica: proff. Salvatore Intermaggio e Gian Francesco Camatta
Impianti Elettrici: prof. Massimo Da Ros
T.D.P.: proff. Massimo Da Ros e Gian Francesco Camatta
Sistemi: proff. Giancarlo Chieregato e Gian Francesco Camatta
Matematica: prof.ssa Giuseppina Blasetti
Lettere italiane: prof.ssa Maria Vittorina Gerlin
Storia: prof.ssa Maria Vittorina Gerlin
Inglese: prof.ssa Graziella Gottardi
Ed. Fisica: prof.ssa Fiorenza Pinese
Religione: prof. Domenico Ferraro
Diritto ed Economia: prof. Gian Paolo Pradella
Allegati:
1)
2)
3)
Quesiti relativi alle simulazioni della 3° prova
Allegato n.1
Allegato n.2
Allegato n.3
1° simulazione terza prova tipologia B
2° simulazione terza prova tipologia B
tabella valutazione terza prova
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
p. 41
p. 42
p. 43
2
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Elenco Docenti della classe e materia d’insegnamento
Docenti
Materia d’insegnamento
Massimo Da Ros
Impianti Elettrici -Tecnologia Disegno Progettazione (TDP)
Giancarlo Chieregato
Sistemi Automatici
Salvatore Intermaggio
Elettrotecnica
Gian Francesco Camatta
Laboratorio di Elettrotecnica – Lab. Sistemi – Lab TDP
Giuseppina Blasetti
Matematica
Maria Vittorina Gerlin
Lettere italiane e Storia
Graziella Gottardi
Inglese
Fiorenza Pinese
Educazione Fisica
Domenico Ferraro
Religione
Gian Paolo Pradella
Economia industriale ed elementi di diritto
Elenco studenti della classe
1 - BASSANI CHRISTIAN
15 - LIESSI DAVIDE
2 - BUOSI LUCA
16 - LIVOTTO LUCA
3 - BUSETTO FLAVIO
17 - LUVISON ALBERTO
4 - CANZIAN ISAIA
18 - MASO FRANCESCO
5 - CARRER STEFANO
19 - MAZZONI MATTEO
6 - CESCON ALBERTO
20 - MORTEN GIORGIO
7 - CESCON MICHELE
21 - PALLUDO ALESSIO
8 - D'ALTOE' MICHAEL
22 - PELLEGRINET NICOLAS
9 - DOS SANTOS COSTA
23 - PIAI EDOARDO
10 - FAVERO MIRCO
24 - ROSSI GIOVANNI
11 - FERRACIN MAURO
25 - SALVADOR ANDREA
12 - GAIOTTI MARCO
26 - SARTOR FEDERICO
13 - GAMBINO FRANCESCO
27 - VALENTINI FEDERICO
14 - IVAN NICOLO'
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
3
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, nel triennio, non ha avuto la fortuna di mantenere la continuità didattica in
buona parte delle discipline.
Si sono incontrate difficoltà nello svolgimento dell’attività didattica perché un nutrito
gruppo di studenti erano restii ad affrontare uno studio puntuale e rigoroso.
Gli allievi si mostravano più preoccupati per le valutazioni delle verifiche che per la ricerca
del continuo miglioramento personale dal punto di vista culturale.
Nella prima parte dell’anno scolastico, la non adeguata partecipazione alle lezioni e la
scarsa disponibilità all’ascolto unita ad un comportamento spesso di disturbo, da parte di
un nutrito gruppo di allievi, ha rallentato notevolmente lo svolgimento delle lezioni e dei
programmi.
Successivamente gli allievi hanno evidenziato un graduale miglioramento nella
partecipazione e nell’interesse per le attività proposte e il lavoro si è svolto in un clima più
sereno.
Un ristretto gruppo di allievi capaci e motivati ha mostrato un sufficiente interesse per le
attività proposte partecipando al dialogo educativo in modo accettabile e con diligenza; un
altro piccolo gruppo ha lavorato con regolarità riportando esiti complessivamente
sufficienti nelle prove di verifica; infine un terzo gruppo, più numeroso ha incontrato
difficoltà nell’assimilazione dei contenuti fondamentali delle discipline a causa di una
preparazione di base lacunosa, una partecipazione passiva e un impegno discontinuo e
opportunistico.
Nel corso del triennio il consiglio di classe ha costantemente sensibilizzato e stimolato gli
allievi verso una partecipazione attiva ed un impegno costante allo studio. La classe ha
risposto in modo non sempre adeguato evidenziando un interesse settoriale e talvolta
poco approfondito.
Oltre alle normali attività didattiche disciplinari sono state previste delle attività che hanno
coinvolto soggetti, enti e strutture, esterni alla scuola: stage (2 settimane al 4°) e visite
guidate sia di natura specialistica, che culturale; incontri con esperti su problemi legati alla
cittadinanza, legalità e costituzione; incontri con esperti della sicurezza e della
prevenzione rischi giovanili; incontri con esperti del mondo del lavoro e dell’università al
fine di condurre gli studenti verso una scelta autonoma e consapevole.
Dal punto di vista del profitto disciplinare, mediamente quasi tutti gli studenti hanno
assimilato i contenuti essenziali e sanno applicare le conoscenze acquisite per svolgere
compiti semplici e, se opportunamente guidati, qualche volta anche di una certa
complessità.
2. OBIETTIVI
2.1 Obiettivi educativi
-
favorire negli allievi una presa di coscienza delle proprie responsabilità e scelte, che li
prepari ad affrontare gli studi universitari o il mondo del lavoro;
far riconoscere il valore formativo e culturale di tutte le discipline del corso di studio
che concorrono equamente alla loro crescita culturale e umana;
ampliare l’orizzonte culturale degli allievi dotandoli degli strumenti adeguati ad una
lettura critica della realtà che li circonda;
guidare gli allievi verso un’equilibrata maturazione della coscienza di sé in un dialettico
rapporto col mondo esterno e, attraverso il potenziamento delle capacità di auto
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
4
orientamento nelle scelte, impostare un’adeguata partecipazione ai valori della cultura,
della civiltà e della convivenza sociale.
2.2 Obiettivi didattici
-
favorire negli allievi il potenziamento delle capacità logiche, espressive e critiche che
permettano loro di affrontare idee, argomenti e contenuti in genere in maniera
personale e autonoma anche, e soprattutto, in vista di un processo di apprendimento
continuo in tutto l’arco della prorpia vita, come suggeriscono le raccomandazioni
europee.
fornire agli studenti un’adeguata conoscenza della realtà complessa ed articolata nella
quale dovranno vivere ed operare facendo loro cogliere l’interdipendenza tra i
fenomeni economici, politici, sociali e culturali e preparandoli quindi ad un positivo
inserimento in attività culturali ed educative.
-
2.3 Livello di raggiungimento degli obiettivi
Gli obiettivi educativi, anche se a livelli diversi, sono stati raggiunti mediamente da tutti gli
allievi. Il livello di raggiungimento degli obiettivi didattici invece differisce a seconda
dell’area di interesse.
3. OBIETTIVI GENERALI
Allo stato attuale il C.d.C. ritiene che le attività educative e didattiche realizzate abbiano
permesso agli allievi della 5 AEA di conseguire parzialmente e in misura diversa i seguenti
obiettivi:
3.1 Obiettivi educativi/comportamentali
•
•
•
•
•
•
•
Saper assumere atteggiamenti corretti ed educati: (ascoltare attentamente gli altri,
accettare le opinioni altrui, esprimere dissenso motivato, collaborare con i compagni,
rapportarsi con correttezza di linguaggio)
Rispettare l’ambiente e il materiale scolastico
Organizzare in modo efficace il proprio tempo
Saper fare proposte costruttive
Sapersi assumere responsabilità
Partecipare in modo positivo alla vita collegiale della scuola
Saper intervenire rispettando regole condivise, in modo pertinente e motivato, anche
per esprimere una propria eventuale situazione di disagio
3.2 Obiettivi cognitivi trasversali
Conoscenze
•
•
•
Acquisire i contenuti essenziali delle discipline
Ricordare nel tempo le conoscenze acquisite
Riformulare, anche con parole proprie, i contenuti appresi, in modo orale e scritto
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
5
Abilità
•
•
•
•
•
Comprendere un testo, individuandone i punti fondamentali
Esprimersi in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio operativo specifico
Applicare le conoscenze acquisite per svolgere i compiti assegnati e risolvere problemi
significativi
Saper scegliere ed utilizzare gli strumenti, anche informatici
Svolgere e portare a termine in modo organizzato e autonomo i compiti assegnati
Competenze
•
•
•
Analizzare e sintetizzare i contenuti disciplinari
Collegare ed integrare conoscenze e competenze acquisite in ambiti disciplinari diversi
Argomentare una tesi utilizzando le proprie conoscenze
4. METODOLOGIE DIDATTICHE
La didattica è stata organizzata in primo luogo in rapporto alle capacità, agli interessi e ai
ritmi di apprendimento degli studenti e in secondo luogo in rapporto al contesto
disciplinare. Naturalmente il consiglio di classe o il docente della disciplina hanno scelto di
volta in volta la strategia metodologica più appropriata e in particolare per le discipline
specialistiche si tenuto conto del ruolo di primo piano che ricoprono i laboratori
privilegiando la metodologia del “learning by doing” ovvero l’apprendimento attraverso il
fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni.
5. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
5.1 Strumenti di verifica
Gli strumenti utilizzati per le verifiche formative e/o sommative nel corso del processo
didattico sono stati prevalentemente interrogazioni brevi, prove strutturate, semistrutturate
ed esercizi, testi scritti e grafici di varia tipologia (temi, saggi brevi, articoli di giornale,
analisi del testo), lavoro domestico, progetto tecnico (Impianti). Nel corso dell’anno sono
state organizzate anche simulazioni delle prove scritte d’esame per abituare gli studenti
ad affrontare l’esame finale con maggiore serenità.
5.2 Criteri di valutazione
Il Consiglio di Classe, come stabilito in sede di collegio docenti e come riportato nel POF
d’Istituto, ha adottato la seguente tabella di corrispondenza tra prestazioni fornite dagli
allievi e voto a loro attribuito:
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
6
5.2.1 Tabella di corrispondenza prestazione – giudizio/voto
Giudizio/voto
Prestazione
Negativo
2-3
L’allievo non possiede i contenuti più elementari e i rudimenti operativi della disciplina,
perciò è compromessa anche la più superficiale comprensione della medesima.
Gravemente
insufficiente
4
Insufficiente
5
L’allievo ha scarse e disorganiche conoscenze e commette gravi errori. Ha una
competenza procedurale labile.
Sufficiente
6
Discreto
7
Buono
8
Distinto /Ottimo
9-10
L’allievo ha una conoscenza frammentaria e superficiale, commette errori anche
nell’esecuzione di compiti semplici. Mostra incertezze nei collegamenti logici e si
esprime con linguaggio comprensibile ma non del tutto appropriato.
L’allievo conosce gli elementi più significativi della disciplina, sa applicare conoscenze
in compiti semplici senza errori, è in grado di effettuare analisi parziali e, se guidato,
riesce a sintetizzare in parte le conoscenze. Usa un linguaggio semplice ma
sostanzialmente corretto.
L’allievo ha una conoscenza completa, sa applicare i contenuti e le procedure acquisite
in compiti complessi ma con imprecisioni, sa effettuare analisi complete ma non
approfondite e riesce a sintetizzare le conoscenze. Usa un linguaggio chiaro e corretto.
L’allievo ha una conoscenza completa e approfondita, sa applicare i contenuti e le
procedure acquisite in compiti complessi, sa effettuare analisi complete e riesce a
sintetizzare le conoscenze acquisite. Usa un linguaggio corretto.
L’allievo ha una conoscenza completa, coordinata e ampliata, sa applicare le
conoscenze e le procedure in problemi nuovi senza errori, è in grado d’effettuare
analisi complete ed approfondite e sa organizzare in modo autonomo e completo le
conoscenze e le procedure acquisite.
E’ in grado di esprimere valutazioni proprie ed approfondite.
Usa un linguaggio corretto ed appropriato.
5.2.2 Criteri di valutazione per l’ammissione agli esami
Il C. di C. tenendo conto del POF d’Istituto, della programmazione d’inizio anno, delle
indicazioni dell’O.M n. 26 del 15 marzo 2007, stabilisce i seguenti criteri per la
formulazione dei giudizi di ammissione:
•
•
•
Nell’ambito cognitivo, come previsto dal POF d’Istituto, si terrà conto della
conoscenza dei contenuti, la loro comprensione intesa come riformulazione
mediante i codici specifici delle varie discipline, la loro applicazione per risolvere
problemi
Nell’ambito relazionale si presterà attenzione alla capacità di recepire stimoli
esterni, di essere coinvolto nelle situazioni di apprendimento, di avanzare proposte
costruttive
Nell’ambito comportamentale si terrà conto della frequenza, rispetto degli impegni
scolastici, delle regole e delle norme disciplinari, partecipazione al dialogo
educativo e alla vita della comunità scolastica;
Naturalmente per ciascuno studente si terrà conto anche del progresso compiuto rispetto
ai livelli di partenza.
6. STORIA DELLA CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO
La continuità didattica non è stata mantenuta nelle seguenti discipline: Inglese, TDP,
impianti elettrici, Elettronica, italiano e storia.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
7
7. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI NEL CORSO DEL 4° e 5° ANNO
•
Incontro informativo La donazione e il trapianto di organi e di tessuti: una
scelta consapevole, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione
dell’Ulss7 di Conegliano-Servizio per l’Educazione e la Promozione della Salute.
•
Viaggio d’istruzione a Praga
•
Visita alla centrale idroelettrica di Nove (TV) e Museo delle Dolomiti di Erto.
•
•
Attività di orientamento con docenti universitari organizzato dal CORTV
Stage di 2 settimane, nelle aziende del territorio, alla fine del 4° anno di studi.
8. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAMI
Il Consiglio di classe ha programmato nel corso dell’anno scolastico due simulazioni di
Terza Prova, di tipologia B ed una simulazione di prima prova. Per quanto riguarda la
seconda prova si è preferito far svolgere i temi d’esame degli ultimi anni in tempi ridotti
rispetto a quelli normalmente assegnati, nelle ore disciplinari:
Per la terza prova vengono riportati alla fine del socumento la tipologia e le materie
coinvolte. I testi delle due simulazioni vengono allegati al presente documento.
Il tempo per lo svolgimento della prova è stato fissato in 3 ore.
TIPOLOGIA
Æ
B (12 quesiti a risposta aperta)
MATERIE COINVOLTE
Æ
Sistemi, Matematica, Impianti elettrici e TDP
Attribuzione del voto
Æ
Il docente di ciascuna disciplina coinvolta nella
prova ha espresso, per i quesiti di sua pertinenza,
una valutazione in quindicesimi, tenendo conto
che la sufficienza corrisponde a 10/15 e che il
punteggio massimo è 15/15. La valutazione
complessiva della prova è stata ottenuta dalla
media aritmetica.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
8
RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI : Proff. Salvatore Intermaggio e Gian Francesco Camatta
MATERIA : ELETTROTECNICA
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
CONOSCENZA:
Acquisizione corretta delle leggi di Elettrotecnica
Acquisizione degli argomenti
Acquisizione delle regole, dei termini e delle procedure
Acquisizione delle tecniche applicative
COMPETENZA:
Utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire compiti
Saper risolvere problemi
Interpretare problematiche nuove
Interpretare correttamente schemi elettrici
CAPACITA’:
Rielaborare correttamente le conoscenze acquisite
Arricchire ed incrementare le competenze
Analizzare criticamente e valutare la correttezza di risultati
Saper interpretare e costruire schemi elettrici di apparecchiature
METODOLOGIE ADOTTATE:
- Metodo sequenziale.
- Lezione frontale
- Discussione interattiva.
- Verifiche sperimentali in laboratorio.
- Esercitazioni numeriche.
SUSSIDI DIDATTICI.
- Libro di testo.
- Lavagna nera.
- Strumentazione del laboratorio di misure elettriche.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
- Prove scritte.
- Interrogazioni dialogate con la classe.
- Test per controllare il livello di conoscenze.
- Relazioni sulle prove di laboratorio
Per i criteri di valutazione si fà riferimento alle decisioni del consiglio di classe .
La strategia adottata nel corso dell'anno scolastico è stata quella di coinvolgere la classe
nella partecipazione attiva al colloquio quotidiano.
Pochi allievi hanno ben interpretato la volontà dell’insegnante producendo uno sforzo
significativo nel tentativo di seguire di pari passo gli argomenti proposti; altri, studiando
saltuariamente, hanno incontrato maggiori difficoltà nel seguire e comprendere gli
argomenti trattati, si aggiunga poi una non adeguata conoscenza degli argomenti di
supporto svolti negli anni precedenti.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
9
Nel complesso si può dire che un ristretto numero di allievi, costanti nello studio, ha
ottenuto un profitto più che sufficiente; un limitato numero di allievi ha avuto un profitto che
si è alternato fra la piena sufficienza e l’insufficienza non grave; la restante parte degli
allievi ha sempre ottenuto valutazioni non sufficienti. A questo si aggiunga il fatto che
alcuni allievi non hanno recuperato le insufficienze del primo periodo.
La disciplina è stata sempre e comunque improntata allo scopo di favorire la logica e non
la conoscenza mnemonica degli argomenti: questo sicuramente ha incoraggiato e favorito
i volenterosi ma ha frenato i meno impegnati che, comunque, sono stati valutati per i
contenuti e non per le capacità che non sono stati in grado di far emergere.
Il metodo adottato nello svolgimento delle lezioni è stato improntato sul dialogo e sulla
lezione frontale.
L’attività di laboratorio è stata rivolta alla verifica degli argomenti trattati durante le ore di
lezione al fine di affinare le conoscenze e la manualità delle attrezzature.
CONTENUTI DISCIPLINARI
MACCHINA ASINCRONA
Costituzione della macchina asincrona.
Campo rotante.
Funzionamento allo spunto e sotto carico di un motore asincrono.
Caratteristica esterna.
Parametri della macchina e circuito equivalente.
Prove sul motore asincrono e costruzione del diagramma circolare .
Caratteristiche del motore asincrono ricavati dal diagramma circolare.
Rotore avvolto e rotore a doppia gabbia.
Perdite e rendimento
Cenni sul funzionamento della macchina asincrona come generatore.
Campo rotante bifase.
Avviamento di un motore monofase ad induzione.
Caratteristica esterna di un motore monofase ad induzione.
MACCHINA A CORRENTE CONTINUA
Struttura della macchina a corrente continua; induttore , indotto, collettore.
Dinamo come generatore reale.
Caratteristiche esterne della dinamo in funzione del tipo di eccitazione.
Coppia resistente e costante di coppia.
Potenza elettrica e meccanica.
Perdite e rendimento.
Prova a vuoto della dinamo a campo avvolto.
Funzionamento sotto carico e reazione di indotto nella dinamo a poli avvolti .
Funzionamento a vuoto e sotto carico della macchina a corrente continua funzionante
come motore.
Caratteristiche esterne del motore in funzione del tipo di eccitazione.
Rendimento del motore a c.c.
Commutazione.
Funzionamento sotto carico e reazione di indotto del motore a poli avvolti.
Regolazione della velocità del motore a c.c.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
10
MACCHINA SINCRONA
Costituzione della macchina sincrona trifase.
Teoria di Bhen Eschenburg
Cenni sulla teoria di Potier
Alternatore funzionante a vuoto e a carico.
Circuiti equivalenti
Prova a vuoto
Prova in corto circuito.
Parallelo degli alternatori
Potenze e rendimenti.
Macchina sincrona, funzionante come motore:
- sottoeccitata
- sovraeccitata
Curve a V
Potenze e rendimento
MOTORI SPECIALI
Costituzione e funzionamento del motore brushless.
Motore asincrono bifase.
Motore asincrono monofase.
Motore asincrono a poli schermati.
Motore a corrente continua a magneti permanenti.
Motore universale.
Motore sincrono a riluttanza.
Motore sincrono a magneti permanenti.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
11
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE : Prof. Massimo Da Ros
MATERIA : IMPIANTI ELETTRICI
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di :
CONOSCENZE:
1. Conoscenze di base sulle principali apparecchiature di comando, manovra e
protezione per impianti elettrici.
2. Conoscenze di base inerenti la sicurezza degli impianti elettrici
3. Conoscenze di base sugli impianti elettrici utilizzatori
4. Conoscenze di base sulla normativa vigente
COMPETENZE:
1. Definire le caratteristiche funzionali delle apparecchiature di comando, manovra e
protezione per impianti elettrici
2. Calcolare le correnti di guasto e di c.c. in un impianto elettrico utilizzatore in B.T.
3. Applicare le conoscenze di base al dimensionamento di un impianto elettrico
utilizzatore in B.T. e M.T.
4. Applicare le conoscenze di base al dimensionamento di un impianto elettrico
particolare (rifasamento, illuminazione)
CAPACITÀ:
1. Definire le caratteristiche generali di un impianto di terra ed eseguire il
coordinamento delle protezioni contro i contatti indiretti.
2. Definire le caratteristiche generali delle apparecchiature di comando e protezione di
un impianto utilizzatore in B.T. ed eseguire il coordinamento delle protezioni contro
le sovracorrenti.
3. Analizzare un impianto elettrico
utilizzatore in B.T. e M.T. e procedere
autonomamente al suo dimensionamento generale.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
12
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Modulo 1 - PROTEZIONE DALLE TENSIONI DI CONTATTO
•
PERICOLOSITÀ DELLA CORRENTE ELETTRICA (Conte 1) –
1.
2.
3.
4.
5.
•
COLLEGAMENTO A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (Conte 1) –
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Percezione della corrente elettrica
Effetti fisiopatologici
Limiti di pericolosità della corrente
Resistenza elettrica del corpo umano
Limiti di pericolosità della tensione
La dispersione a terra della corrente
Tensione di contatto e tensione di contatto a vuoto
Calcolo della resistenza di terra per vari tipi di dispersori
Dispersori in parallelo
Resistività del terreno
Classificazione dei sistemi in relazione al collegamento a terra
Tensione nominale verso terra
PROTEZIONE DAI CONTATI INDIRETTI (Conte 1) –
1. Generalità e definizioni
2. Impianti di terra
3. Prescrizioni in merito all’impianto di terra
4. Esecuzione dell’impianto di terra
5. L’interruttore differenziale
6. Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione, sistema TT
7. Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione, sistema TN
8. Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione, sistema IT
9. Protezione senza interruzione automatica dell’alimentazione
10. Omissione della protezione contro i contatti indiretti
11. Verifica dell’efficienza della protezione nel sistema TT
•
PROTEZIONE DAI CONTATI DIRETTI (Conte 1) –
1. Protezione totale
2. Protezione parziale
3. Protezione mediante interruttore differenziale
•
SISTEMI A BASSISSIMA TENSIONE (Conte 1) –
1. Protezione mediante i sistemi SELV e PELV
2. Bassissima tensione funzionale (FELV)
•
SICUREZZA ELETTRICA IN PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI
(Conte 1 – cap. 15) –
1. L’influenza dell’ambiente
2. Locali per bagni e docce
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
13
Mod. 2 – SOVRACORRENTI, SOVRATENSIONI E SISTEMI DI PROTEZIONE
•
SOVRACORRENTI (Conte 2) –
1. Generalità e definizioni
2. Sollecitazione termica per sovraccarico e corto circuito
•
APPARECCHI DI MANOVRA (Conte 2) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
Classificazione degli apparecchi di manovra
Arco elettrico e sue modalità di estinzione
Tipi di interruttori
Caratteristiche funzionali degli interruttori
Sezionatori
Contattori
Caratteristiche e criteri di scelta dei contattori
PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI (Conte 2) 1. Classificazione dei relè
2. Relè termico di massima corrente
3. Relè elettromagnetico di massima corrente
4. Protezione magnetotermica
5. Protezione elettronica
6. Interruttori automatici per bassa tensione
7. Fusibili e loro caratteristica d’intervento
8. Caratteristiche funzionali dei fusibili
9. Limitazione della corrente di corto circuito
10. Protezione delle condutture contro i sovraccarichi
11. Installazione dei dispositivi di protezione
12. Protezione delle condutture contro il corto circuito
13. Determinazione della corrente di corto circuito
14. Protezione dei motori asincroni
Modulo 3 – DISTRIBUZIONE, TRASFORMAZIONE E UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA
ELETTRICA
•
CABINE ELETTRICHE (Conte 2) 1. Definizioni e classificazioni
2. Gruppo di misura
3. Lato media tensione
4. Dimensionamento dei componenti MT
5. Trasformatore MT/BT
6. Lato bassa tensione
7. Dimensionamento dei componenti BT
8. Protezioni e loro scelta
9. Impianto di terra
10. Progetto di massima di una cabina
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
14
•
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE A MEDIA E BASSA TENSIONE (Conte 2) –
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Baricentro elettrico di un impianto
Distribuzione centralizzata
Distribuzione a centri di carico
Distribuzione pubblica
Distribuzione in bassa tensione
Realizzazioni costruttive per la distribuzione in bassa tensione
Quadri elettrici per bassa tensione
METODOLOGIA
Generalmente è stata adottata la lezione frontale, sia per il trasferimento di alcune
conoscenze preliminari indispensabili, sia per formalizzare e generalizzare quanto
appreso nelle esperienze pratiche. Si è ricorso anche a metodi attivi di apprendimento,
mettendo gli allievi di fronte a problemi non semplicemente applicativi di procedimenti già
studiati, ma aperti, implicanti una attività di chiarimento, analisi e scelta.
Il modulo 2 è stato realizzato fondendo insieme le ore di TDP e Impianti, tale scelta è stata
condizionata dal tipo di argomento trattato in quanto la parte impiantistica non può essere
separata dalla parte tecnologica costruttiva.
MATERIALI DIDATTICI
Testo adottato:
G.Conte
Impianti Elettrici
vol. 1 e 2
ed.Hoepli
Manuale: La classe nel corso del 5° anno ha realizzato un manuale tecnico,
personalizzato da ogni allievo in base alle proprie impostazioni metodologiche. Il manuale
avendo le stesse caratteristiche di quelli commerciali, è stato utilizzato sia nelle verifiche
scritte e sia nelle simulazioni della 2a prova. Il manuale contiene tabelle, grafici e schemi
dei principali componenti elettrici utilizzati in ambito impiantistico necessari per una
corretta progettazione, in linea con le norme vigenti. Il manuale contiene inoltre formule e
riferimenti normativi tipici dei manuali tecnici del settore. Non contiene parti teoriche
descrittive ed esercizi/svolti.
Laboratorio: alcuni aspetti prettamente applicativi della materia sono stati demandati al
parallelo corso di T.D.P.
Biblioteca: consigliata per consultare pubblicazioni tecniche e normative.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove scritte con risoluzione di problemi anche complessi.
Verifiche orali dal posto, sotto forma di domande sintetiche, per controllare
periodicamente lo stato dello studente.
Riguardo al livello di accettabilità delle prestazioni, ci si è attenuti a quanto
stabilito in sede di gruppo disciplinare e di consiglio di classe.
Per la formulazione della proposta di voto al consiglio di classe per lo scrutinio, che
rappresentava la media ponderata delle misurazioni delle singole prove, si è tenuto conto:
- dei risultati raggiunti,
- della progressione dello studio,
- della partecipazione al dialogo educativo,
- delle abilità espresse dall'allievo.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
15
RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI: Proff. Massimo Da Ros e Gian Francesco Camatta
MATERIA: TECNOLOGIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
CONOSCENZE:
Conoscenze di base su aspetti costruttivi e funzionali delle apparecchiature elettriche
componenti un impianto utilizzatore in BT e un quadro elettrico.
Conoscenze di base sui carichi elettrici, in particolare i Motori Asincroni Trifasi
Conoscenze di base sui sistemi di illuminamento e tecniche di progettazione
Conoscenze di base sui PLC e semplici applicazioni
COMPETENZE:
Definire lo schema elettrico e le caratteristiche costruttive generali di un quadro elettrico.
Definire le fasi operative nella progettazione e realizzazione di un impianto elettrico
utilizzatore.
CAPACITÁ:
Progettare un impianto elettrico utilizzatore secondo la normativa vigente.
Progettare e una cabina elettrica.
Progettare e realizzare un quadretto elettrico di un impianto elettrico utilizzatore in BT.
Progettare e realizzare un pannello con componenti pneumatici comandati da PLC.
Programmare un sistema automatico composto da sensori e attuatori e controllato da
PLC (applicazione: nastro trasportatore).
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
16
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Mod. 1 – SOVRACORRENTI, SOVRATENSIONI E SISTEMI DI PROTEZIONE
•
APPARECCHI DI MANOVRA (Conte 2)
1.
2.
3.
4.
5.
•
Classificazione degli apparecchi di manovra
Tipi di interruttori
Caratteristiche funzionali degli interruttori
Sezionatori
Contattori
PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI (Conte 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Classificazione dei relè
Relè termico di massima corrente
Relè elettromagnetico di massima corrente
Protezione magnetotermica
Protezione elettronica
Interruttori automatici per bassa tensione
Fusibili e loro caratteristica d’intervento
Caratteristiche funzionali e costruttive dei fusibili
Modulo 2 – UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
•
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (Conte 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Radiazioni luminose
Grandezze fotometriche
Caratteristiche delle lampade
Tipi di lampade
Tipi di illuminazione
Calcolo di impianti interni col metodo del flusso globale
Illuminazione di emergenza
•
IMPIANTI DI RIFASAMENTO (Conte 2)
1.
2.
3.
4.
5.
Generalità
Caratteristiche costruttive dei condensatori di rifasamento
Caratteristiche funzionali dei condensatori di rifasamento
Criteri e schemi di installazione dei condensatori di rifasamento
Resistenza di scarica
•
ALIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE DI EMERENZA (Conte 1)
1. Generalità
2. Gruppi di continuità statici (UPS)
3. Gruppi di continuità rotanti
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
17
Modulo 3 – ATTIVITÁ DI LABORATORIO
•
GESTIONE DI UN SELEZIONATORE DI PALLINE COLORATE; GESTIONE DI
UN LAVAGGIO AUTOMATICO; CANCELLO AUTOMATICO; FORATRICE
AUTOMATICA; SEMAFORO; CONTROLLO DI LIVELLO; MISCELATRICE;
GESTIONE DI PISTONI PNEUMATICI TRAMITE PLC;
Ogni gruppo ha lavorato ad almeno due attività di laboratorio a scelta. La realizzazione
veniva eseguita in modo da evidenziare le caratteristiche funzionali e modulari di
questi tipi di impianti, basati sostanzialmente su una logica programmata.
•
PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE
DELL’IMPIANTO
ELETTRICO
DI
UN
CAPANNONE
Progettazione dell’impianto elettrico di un capannone industriale. Relazione finale.
METODOLOGIA
Generalmente è stata adottata la lezione frontale, sia per il trasferimento di alcune
conoscenze preliminari indispensabili, sia per formalizzare e generalizzare quanto
appreso nelle esperienze pratiche. Si è ricorso anche a metodi attivi di apprendimento,
mettendo gli allievi di fronte a problemi non semplicemente applicativi di procedimenti già
studiati, ma aperti, implicanti una attività di chiarimento, analisi e scelta.
Il modulo 1 è stato realizzato fondendo insieme le ore di TDP e Impianti, tale scelta è stata
condizionata dal tipo di argomento trattato in quanto la parte impiantistica non può essere
separata dalla parte tecnologica costruttiva.
MATERIALI DIDATTICI
Testo adottato: G.Conte; Impianti Elettrici vol. 1 e 2
ed . Hoepli
Bove – Guidi Tecnologie e Disegno per la Prog. El. vol 1 e 2
ed. Tramontana
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove scritte di tipo progettuale, con risoluzione di problemi anche complessi.
Verifiche orali dal posto, sotto forma di domande sintetiche per controllare lo stato dello
studente.
Riguardo al livello di accettabilità delle prestazioni, ci si è attenuti a quanto
stabilito in sede di gruppo disciplinare e di consiglio di classe.
Per la formulazione della proposta di voto al consiglio di classe per lo scrutinio, che
rappresentava la media ponderata delle misurazioni delle singole prove, si è tenuto conto:
- dei risultati raggiunti,
- della progressione dello studio,
- della partecipazione al dialogo educativo,
- delle abilità espresse dall'allievo.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
18
RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI : Proff. G. Chieregato e Gian Francesco Camatta
MATERIA : SISTEMI
La classe, con la quale è stato affrontato quest'ultimo anno di corso, non ha consentito di
svolgere l'attività in modo sereno. Gli allievi non hanno seguito con costanza l’attività
didattica e, nella maggioranza dei casi, non hanno ottenuto risultati secondo le
aspettative.
Ci sono stati, prevalentemente, problemi di tipo comportamentale.
Le cause si possono attribuire alla classe numerosa e all’impegno non sempre adeguato
sia a scuola che a casa.
La strategia adottata, nel corso dell'anno scolastico, si è sviluppata in due fasi.
La prima fase aveva come obiettivo l'omogeneizzazione della classe: sono stati introdotti
dei temi specifici, anche in maniera rigorosa, al fine di accostare gradualmente la classe
verso gli argomenti di più alto valore aggiunto.
La seconda fase ha avuto come obiettivo l'acquisizione e il consolidamento delle nuove
conoscenze.
In relazione alla programmazione curricolare e tenendo conto dell’andamento della
classe nel suo complesso, gli allievi hanno raggiunto i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
• sui sistemi in generale e sui sistemi di controllo in particolare;
• sui sistemi del 1° e 2° ordine;
• sul comportamento dei sistemi di controllo analogici;
• sull’interfacciamento verso i sistemi reali.
ABILITÀ:
• di analisi della risposta nei sistemi del 1° e 2° ordine sollecitati in ingresso dai
segnali canonici;
• di intervenire sul comportamento di semplici apparati regolatori.
COMPETENZE:
• saper condurre in maniera autonoma l’analisi di un sistema a catena chiusa;
• saper usare un linguaggio appropriato;
• saper utilizzare correttamente le conoscenze acquisite sui sistemi di controllo;
• saper progettare un semplice sistema di controllo.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
19
In relazione alla programmazione curricolare e tenendo conto dell’andamento della
classe nel suo complesso, gli allievi hanno raggiunto i seguenti obiettivi in termini di :
CONTENUTI DISCIPLINARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistemi di controllo a catena aperta e chiusa.
Caratteristiche e requisiti dei sistemi di controllo.
Algebra degli schemi a blocchi.
Sistemi di controllo on-off, sistemi di controllo analogici e sistemi di controllo gestiti
da dispositivi programmabili (PLC).
Rappresentazione della funzione di trasferimento nel dominio delle frequenze Æ
diagrammi di Bode (modulo e fase) e polari (piano di Gauss)
Il teorema di Fourier e determinazione dello spettro per grandezze periodiche non
sinusoidali.
Sistemi del 1° ordine (rete RC, RL, sistema meccanico, termico ecc...)
Sistemi del 2° ordine (rete RLC) e motore a corrente continua a magneti
permanenti, ecc.
Analisi della risposta nei sistemi del 1° e del 2° ordine nel dominio del tempo con
l'applicazione di ingressi canonici, per esempio il gradino.
Metodi di analisi dei sistemi Æ le trasformate di Laplace, il metodo simbolico, le
operazioni nel dominio trasformato, funzione di trasferimento, determinazione della
risposta nel dominio del tempo Æ Trasformazione e antitrasformazione: i segnali
canonici (gradino, rampa e parabola).
Uso di tabelle di trasformazione e antistrasformazione
Poli e zeri della f.d.t. di un sistema a catena chiusa.
Esame della parte reale delle radici dell'equazione caratteristica.
Il luogo delle radici.
Diagrammi di Bode e di Nyquist per i sistemi a catena chiusa
Rapidità della risposta di un sistema di controllo
Il teorema del valore finale.
L’errore statico in un sistema di regolazione: effetto dei disturbi e delle variazioni
parametriche.
Guadagno statico di anello GH in funzione dell'errore a catena aperta δ e di quello
a catena chiusa ε
Classificazione dei sistemi di controllo in base al tipo: 0, 1 e 2
Errori di regolazione a regime con ingressi a gradino, rampa e parabola, per i
sistemi di tipo 0, 1 e 2.
Il problema della stabilità: concetti generali
I criteri per determinare la stabilità dei sistemi di controllo: Bode, Nyquist e Routh
Margine di fase e di guadagno.
Sistemi di regolazione in condizioni statiche.
Uso del software (program CC) per lo studio del comportamento di un sistema e
verifica delle scelte progettuali
I regolatori standard ed esempio di applicazione:
o Risposta in frequenza di un circuito elettrico (derivatore, integratore,
proporzionale e derivatore, proporzionale e integratore, ecc..)
o I regolatori standard e le reti di compensazione (P, PD, PI, PID).
Il progetto ed analisi di un controllo di velocità del motore a corrente continua.
o Il controllo proporzionale, derivativo e integrativo del sistema motore D.C.
o Regolazione in PWM della tensione su un motore D.C.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
20
ATTIVITÀ DI LABORATORIO
•
•
•
•
Verifica del comportamento in frequenza e nel tempo di un sistema del 1° ordine
come il circuito RC.
Verifica del comportamento in frequenza e nel tempo di un sistema del 2° ordine
come il circuito RLC.
Uso del Program CC per lo studio nel dominio delle frequenze, nel dominio del
tempo e nel dominio delle trasformate di Laplace delle funzioni di trasferimento di
sistemi a catena aperta e chiusa; stabilità di un sistema di controllo. Velocità di
risposta. Errore a regime.
Il controllo della velocità di un motore a corrente continua con regolazione della
tensione in PWM.
MATERIALI DIDATTICI
Il testo adottato; “Sistemi” Vol.3 – Autore G.Licata – Casa Editrice Thecna.
Fotocopie di appunti dalle lezioni.
Orario settimanale di laboratorio:
2 ore
Attrezzature: PLC Siemens (S7)
Computer per la programmazione
Oscilloscopi e apparecchiature ausiliarie
Prototipi realizzati dagli allievi
Spazi:
Laboratorio di Sistemi. e T.D.P.
Biblioteca e Internet: Utilizzati soprattutto per consultare pubblicazioni tecniche e
normative
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove scritte con risoluzione di problemi anche complessi.
Verifiche orali dal posto.
Test inseriti nelle prove di simulazione della 3^ prova scritta.
Programmazione con il programma: Program CC
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
21
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE : Prof.ssa Giuseppina Blasetti
MATERIA : MATEMATICA
La classe, nel triennio, non ha mantenuto la continuità didattica nella disciplina. Ho
insegnato in questa classe solo nel corso del corrente anno scolastico.
Nel periodo iniziale ho incontrato alcune difficoltà dovute a diffidenza da parte degli
studenti, i quali restii ad affrontare uno studio puntuale e rigoroso, si mostravano più
preoccupati per le valutazioni delle verifiche che della correzione dei gravi errori
commessi.
Nella prima parte dell’anno scolastico, la scarsa partecipazione alla lezione e la scarsa
disponibilità all’ascolto unita ad un comportamento spesso di disturbo, da parte di un
nutrito gruppo di allievi, ha rallentato notevolmente lo svolgimento delle lezioni e del
programma.
Successivamente gli allievi hanno evidenziato un graduale miglioramento nella
partecipazione e nell’interesse per le attività proposte e il lavoro si è svolto in un clima più
sereno.
Un ristretto gruppo di allievi capaci e motivati ha mostrato un sufficiente interesse per le
attività proposte partecipando al dialogo educativo in modo accettabile e con diligenza; un
piccolo gruppo ha lavorato con regolarità riportando esiti complessivamente sufficienti
nelle prove di verifica; infine un terzo gruppo, più numeroso ha incontrato difficoltà
nell’assimilazione dei contenuti fondamentali della disciplina a causa di una preparazione
di base lacunosa, una partecipazione passiva e un impegno discontinuo e opportunistico.
I tempi previsti per lo svolgimento d’ogni blocco tematico sono stati ampliati perché
spesso si è reso necessario effettuare richiami a conoscenze pregresse al fine di
garantire a tutti gli allievi un livello minimo di apprendimento e per stimolare, con
adeguate proposte, la comprensione e la rielaborazione degli argomenti svolti.
Ho preferito privilegiare l’aspetto pratico della disciplina rispetto a quello teorico.
Il programma preventivato all’inizio dell’anno prevedeva il blocco tematico relativo alle
Equazioni Differenziali che non è stato affrontato poiché sono venute a mancare ore di
lezione per festività, assemblee di istituto, visite guidate, viaggio di istruzione, conferenze
varie.L’integrale definito è stato trattato in numero di ore decisamente inferiore a quelle
previste con conseguente minor approfondimento delle tematiche reltive.
In relazione alla programmazione curricolare e tenendo conto dell’andamento della classe
nel suo complesso, gli allievi della 5 AEA hanno raggiunto, a livelli differenziati, i seguenti
obiettivi:
CONOSCENZE:
COMPETENZE:
CAPACITÀ’
(sotto la guida dell’insegnante)
- Gli elementi fondamentali
per tracciare il grafico di una
funzione;
- Il significato di integrale;
- Teoremi fondamentali del
calcolo integrale
- Studiare funzioni;
- Risolvere semplici integrali;
- Calcolare aree e volumi
mediante gli strumenti
dell’analisi.
- Interpretare geometricamente alcuni
strumenti dell’analisi;
- Utilizzare gli strumenti dell’analisi per
risolvere problemi tratti anche da altre
discipline;
- Esporre i contenuti appresi con un
linguaggio specifico;
- Condurre la dimostrazione di teoremi
nell’ambito degli argomenti svolti.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
22
GRIGLIA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DI MATEMATICA
Contenuti teorici
Obiettivi specifici
1°Modulo : Calcolo differenziale e studio di funzione
Conoscere definizione e interpretazione geometrica di derivata di una funzione in un
suo punto.
Saper calcolare le derivate delle funzioni fondamentali usando la definizione.
Saper enunciare e dimostrare i teoremi relativi alla derivata di una somma, di un
prodotto, di un quoziente di funzioni.
Applicare i teoremi nel calcolo di derivate non fondamentali.
Conoscere i teoremi di Rolle, di Lagrange e di Chauchy e darne una corretta
interpretazione geometrica.
Conoscere la regola di De L’H pital e saperla applicare nel calcolo dei limiti.
Saper calcolare il massimo e il minimo relativo di una funzione.
Saper interpretare e risolvere un semplice problema di massimo o di minimo.
Saper determinare la concavità e la convessità di una curva.
Saper calcolare un punto di flesso e la relativa tangente.
Conoscere le definizioni di asintoto verticale, orizzontale ed obliquo.
Saper individuare e disegnare un asintoto (verticale, orizzontale ed obliquo).
Saper sintetizzare le varie informazioni relative ad una funzione nel grafico di una
curva.
Derivate e teoremi sul calcolo delle derivate. (ripasso)
Derivata di una funzione composta. (ripasso)
Derivabilità e continuità di una funzione. (ripasso)
Teorema di Rolle. (enunciato e dimostrazione).
Teorema di Lagrange. (enunciato e dimostrazione).
Teorema di Cauchy. ( solo enunciato)
Regola di De L’H pital. ( solo enunciato)
Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.
Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione.
Ricerca dei massimi e minimi relativi con il metodo del segno della derivata prima.
Problemi di massimo o di minimo.
Concavità di una curva e relativi flessi.
Ricerca dei punti di flesso con il metodo del segno della derivata seconda.
Calcolo dei limiti alla frontiera del dominio.
Studio completo di una funzione razionale intera e fratta , di semplici funzioni
esponenziali e logaritmiche e rappresentazione delle relative curve.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
23
Contenuti teorici
Obiettivi specifici
2°Modulo: Integrali indefiniti.
Conoscere la definizione e il significato geometrico del differenziale di una funzione.
Definire l’insieme delle funzioni primitive e l’integrale indefinito di una funzione
continua.
Conoscere le primitive delle funzioni fondamentali ed individuare le primitive di
funzioni notevoli anche con l’uso delle tabelle.
Conoscere il legame tra l’operatore differenziale e l’operatore integrale.
Conoscere la linearità dell’operatore integrale.
Calcolare l’integrale indefinito di semplici funzioni mediante la scomposizione o la
trasformazione della funzione integranda.
Calcolare l’integrale indefinito di semplici funzioni con il metodo della sostituzione.
Calcolare semplici integrali con il metodo di integrazione per parti.
Calcolare l’integrale indefinito di funzioni fratte.
Differenziale.
Integrali indefiniti.
Integrali immediati.
Linearità.
Metodi di integrazione indefinita: scomposizione, sostituzione e per parti.
Integrazione di funzioni razionali fratte.
Contenuti teorici
Obiettivi specifici
3° Modulo: Integrali definiti.
Definire l’area di una superficie chiusa a contorno curvilineo.
Conoscere il significato geometrico di integrale definito.
Esporre la definizione di integrale definito di una funzione.
Stabilire i legami tra continuità, derivabilità e integrabilità di una funzione.
Conoscere e saper ricavare le proprietà fondamentali degli integrali definiti.
Saper calcolare il valore medio di una funzione in un intervallo chiuso.
Conoscere la relazione fondamentale tra integrale definito ed indefinito.
Calcolare l’area della regione di piano compresa tra il grafico di una funzione
continua, l’asse delle x,le rette x=a e x=b nei vari casi possibili.
Calcolare l’area della regione di piano limitata da grafici di funzioni continue.
Calcolo del volume di un solido di rotazione.
Trapezoide.
Integrale definito e relative proprietà.
Teorema della media integrale (enunciato e dimostrazione)
Teorema di Torricelli-Barrow (enunciato e dimostrazione)
Formula di Leibniz-Newton.
Area della parte di piano delimitata da un contorno curvilineo.
Calcolo del volume di un solido di rotazione.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
24
METODOLOGIA
Ogni blocco tematico è stata preceduto dalla verifica che gli allievi possedessero, a livelli
accettabili, i prerequisiti necessari per un corretto approccio al medesimo.
Questa prima fase è stata sempre seguita da lezioni frontali perché la conoscenza dei
nuovi argomenti avvenisse con rigore formale e linguistico. I contenuti affrontati sono stati
correlati da esempi e controesempi al fine di favorire negli allievi una completa
comprensione dei nuovi concetti. In ogni blocco tematico si sono alternate lezioni frontali
con quelle in cui si invitavano esplicitamente gli allievi a collaborare alla costruzione ed
alla scoperta di nuovi segmenti conoscitivi. Gli esercizi, presenti, graduati per difficoltà,
avevano all’inizio lo scopo di controllare la comprensione e consolidare l’acquisizione di
tecniche di risoluzione, mentre successivamente dovevano verificare nell’alunno le
capacità di trasferire conoscenze ed abilità in ambiti diversi da quelli in cui erano state
presentate. Al termine di ogni blocco si è sempre realizzata una verifica, che poteva
essere scritta o orale, ma che doveva controllare il grado generale di apprendimento della
classe.
MATERIALI DIDATTICI
Si è costantemente fatto uso del libro di testo:
Corso base verde di matematica - Bergamini Trifone Barozzi - Zanchelli
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Per controllare il processo d’apprendimento della classe si sono utilizzate le
seguenti tipologie di prove:
- Prova scritta tradizionale ( soluzione di problemi e/o esercizi).
- Questionari a risposta aperta ( tipologia B ).
Le verifiche orali sono state condotte in modo da controllare il grado di coerenza dei
ragionamenti e la capacità di esporre le informazioni acquisite con il rigore e il simbolismo
del linguaggio matematico. Esse sono state integrate da questionari a risposta aperta,
che hanno permesso all’insegnante di avere in ogni momento sufficienti informazioni sul
grado di apprendimento degli alunni.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nelle prove scritte sia strutturate che tradizionali, è stato attribuito a priori ad ogni
esercizio un punteggio adeguato alle difficoltà presentate, in modo che la correzione degli
elaborati fosse la più obiettiva ed omogenea possibile. Quindi si è tramutato il punteggio
grezzo conseguito da ogni allievo in un voto decimale mediante tramite la seguente
formula:
voto=voto
+
min
p
alunno *(voto
-voto )
max
min
max
p
con votomin=1 e votomax=10.
Si è cercato sempre di usare una gamma di voti ampia ( dal 1 al 10) al fine di
differenziare il più possibile le prestazioni degli allievi.
Nella valutazione quadrimestrale per ogni allievo si è tenuto conto, oltre che dei voti
conseguiti nelle varie prove, della situazione di partenza, degli eventuali progressi e delle
abilità effettivamente raggiunte.
Nell’attribuzione dei voti a fine quadrimestre ci si è sempre riferiti alla tabella di
corrispondenza tra voti e prestazioni adottata dal C.d. C. in sede di programmazione.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
25
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE : Prof.ssa Maria Vittorina Gerlin
MATERIA : LINGUA E LETTERE ITALIANE
Nel corso dell’anno scolastico sono state affrontate con la classe non poche difficoltà
derivanti prima di tutto dal cambio di insegnante di Lettere.
La classe non si è dimostrata inizialmente disponibile e collaborativa, anzi spesso critica e
polemica nei confronti della nuova insegnante e delle inevitabili differenze di metodo e di
valutazione (soprattutto degli elaborati scritti). I rapporti sono andati progressivamente
migliorando, ma il clima iniziale non ha favorito lo svolgimento del programma che ha
subito un rallentamento ed in seguito una battuta d’arresto a causa di una lunga assenza
dell’insegnante per motivi di salute.
Il numero elevato di allievi (27) non ha consentito di effettuare un numero adeguato di
verifiche orali che sono state sostituite da questionari scritti. Per una buona parte degli
allievi permangono incertezze e lacune ( ortografia e sintassi) allo scritto.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati globalmente conseguiti i seguenti
obiettivi:
CONOSCENZE
−
−
Conoscenza dei principali movimenti culturali dalla fine dell’’800 alla prima metà del
‘900.
Conoscenza di alcuni grandi autori della letteratura italiana attraverso la lettura
antologica delle loro opere.
COMPETENZE
La classe, pur a livelli molto diversi da allievo ad allievo, ha dimostrato di saper:
−
realizzare una lettura diretta di testi letterari, rilevandone il significato complessivo e
cogliendo le principali caratteristiche formali
−
individuare attraverso i testi il pensiero dell’autore
−
inserire i vari autori nel contesto storico in cui hanno operato
CAPACITÁ
La classe, pur a livelli assai diversi da allievo ad allievo, ha dimostrato di saper:
−
collegare e confrontare autori diversi operanti nello stesso contesto storico
−
sostenere una discussione motivando il suo punto di vista
−
esprimersi in modo sufficientemente ordinato e corretto
−
costruire ragionamenti chiari e coerenti elaborando le proprie opinioni
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
26
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
- Giacomo Leopardi (biografia, il pensiero, pessimismo storico e cosmico)
(8h)
testi:
L’infinito
A Silvia
Dallo Zibaldone : Il giardino sofferente
Indefinito e infinito
La rimembranza
Operette morali:
Il dialogo della Natura e di un Islandese
La ginestra vv.297-317
Quadro di riferimento dell’Italia postunitaria (2h)
La scapigliatura ( caratteri generali )
- Emilio Praga
testi: Preludio
Naturalismo francese (caratteri generali e origini dal positivismo) (2h)
−
Emile Zola
testi: da “Il romanzo sperimentale”: “Lo scrittore come operaio del
progresso sociale”
Il verismo italiano (caratteri generali e confronto col naturalismo francese)
Verga
(biografia)
(12h)
testi:
Il primo progetto dei “Vinti”: classi sociali e lotta per la vita.
Prefazione a L’amante di Gramigna
Prefazione a “I Malavoglia”: I vinti e la fiumana del progresso.
La conclusione de “I Malavoglia”: L’addio di ‘Ntoni
da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”
da “Novelle rusticane: “ La roba”
da Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo
−
Decadentismo e Simbolismo (caratteri generali: individualismo, superomismo,
estetismo ecc.) (7h)
−
−
D’Annunzio
(biografia, estetismo, superomismo, fase del Notturno)
(9h)
testi:
“Il piacere” (sintesi)
da “ Le vergini delle rocce”: “Il programma politico”( Il superuomo)
da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”
La prosa notturna ( cenni)
Pascoli
(9h)
(biografia)
testi: da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente”
da “Myricae” : “Novembre”
“X Agosto”
da “I canti di Castelvecchio”: “ Il gelsomino notturno”
da “La grande proletaria si è mossa”: “Il nazionalismo pascoliano”
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
27
−
Svevo
(6h)
(biografia, la figura dell’inetto)
testi:
−
da “Una vita” “Le ali del gabbiano”
“Senilità” (cenni)
da “La coscienza di Zeno” “La morte del padre”
“Distrazione e malattia”
Pirandello (biografia, contrasto tra forma e vita, umorismo, relativismo conoscitivo)
(9h)
testi: da “Novelle per un anno”:
“Il treno ha fischiato”
“La signora Frola e il sign. Ponza, suo genero”
da “Il fu Mattia Pascal”: “La costruzione della nuova identità”
da Uno, nessuno e centomila: “Pagina conclusiva”
Il teatro: “ Enrico IV” (trama)
Il Futurismo (caratteri generali) (4h)
Marinetti
testi: “Manifesto tecnico della letteratura futurista”
“Manifesto del Futurismo”
“ Bombardamento”
−
L’Ermetismo (caratteri generali) (1h)
Ungaretti
(5h)
(biografia, caratteri generali della poetica)
testi: da “L’allegria”: “Veglia”
“I fiumi”
“San Martino del Carso”
“Mattina”
“Soldati”
da “ Il dolore”: “Non gridate più”
Montale
(5h)
(biografia, la poetica, il correlativo oggettivo)
testi:
da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato”
“Non chiederci la parola”
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
28
METODOLOGIE
Gli argomenti sono stati trattati attraverso lezioni frontali e dialogate, letture di
approfondimento, esercitazioni in classe e a casa.
Discussioni ed esercizi di commento ad articoli di giornale hanno fornito materiale per la
stesura di testi argomentativi oltre che occasioni per rafforzare le capacità espressive.
Gli allievi sono stati abituati ad uno studio ragionato, non mnemonico o nozionistico,
mirato a potenziare abilità di analisi, di sintesi e di critica anche attraverso percorsi
interdisciplinari (letteratura- storia).
MATERIALI DIDATTICI
Il testo in adozione è : Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, La letteratura,volumi 4,5,6, Casa
editrice Paravia
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifiche orali
Prove scritte di diversa tipologia:
Analisi di testi letterari
Articoli di giornale
Saggi brevi
Temi di argomento storico
Le prove e le verifiche effettuate sono depositate in segreteria.
−
−
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per i criteri di valutazione e per la corrispondenza tra voto e livello di apprendimento si fa
riferimento alla tabella approvata dal Consiglio di classe.
In particolare nella correzione degli elaborati scritti sono stati oggetto di valutazione:
−
Le conoscenze relative all’argomento considerato
−
L’efficacia espositiva
−
Il rispetto delle consegne
−
La correttezza morfosintattica, ortografica e lessicale
−
La capacità di costruire un discorso organico e coerente
La valutazione quadrimestrale di ogni allievo tiene conto del grado di raggiungimento degli
obiettivi, della partecipazione in classe, dell’impegno nello studio e del livello di partenza.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
29
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE : Prof.ssa Maria Vittorina Gerlin
MATERIA : STORIA
In relazione alla programmazione curriculare sono stati globalmente conseguiti i seguenti
obiettivi:
CONOSCENZE
Conoscenza dei più significativi avvenimenti che hanno caratterizzato la storia dalla
seconda metà dell’Ottocento alla fine della seconda guerra mondiale sotto il profilo
politico, storico e socioculturale
COMPETENZE
La maggior parte degli allievi ha dimostrato di saper:
−
−
inquadrare un avvenimento nei suoi tratti essenziali
utilizzare alcuni importanti concetti e termini in relazione a specifici ambiti storicoculturali
CAPACITA’
La maggior parte degli allievi ha dimostrato di essere in grado di:
−
−
considerare gli eventi storici nella loro complessità e nella interazione tra i fattori
politici, economici, sociali, culturali e religiosi.
rapportare gli eventi storici allo sviluppo della storia della letteratura
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
−
-
I problemi dell’Italia unita (4h)
I governi della destra (4h)
I governi della Sinistra in Italia: politica interna e questione sociale (2h)
La politica estera della Sinistra e il colonialismo nell’età di Crispi (2h)
Società e cultura agli inizi del xx secolo: la “ belle epoque” (2h)
L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra (1h)
L’età giolittiana (6h)
La prima guerra mondiale (5h)
La rivoluzione russa (2h)
La crisi dello Stato liberale in Italia e la nascita del fascismo (3h)
Il fascismo da movimento a regime (4h)
Gli Stati Uniti e la Germania nella grande crisi del dopoguerra (3h)
La Germania e l’Unione sovietica negli anni Trenta (3h)
La seconda guerra mondiale (8h)
La guerra fredda (3h)
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
30
METODOLOGIE
La presentazione degli argomenti è stata fatta prevalentemente attraverso lezioni frontali
e dialogate.
Lo studio degli eventi storici è sempre stato condotto in relazione agli argomenti e agli
autori della letteratura italiana.
L’attività di recupero è stata svolta in orario curriculare attraverso lezioni di ripasso e con
lezioni partecipate utili ad un maggior coinvolgimento degli allievi.
MATERIALI DIDATTICI
Il testo in adozione è Brancati, Pagliarani, Il nuovo Dialogo con la Storia, La Nuova
Italia. Voll 2-3
VERIFICHE
-
Interrogazioni orali
Questionari scritti a risposta aperta
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per i criteri di valutazione e per la corrispondenza voto-livello di apprendimento si fa
riferimento alla tabella approvata dal Consiglio di classe.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
31
PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE : Prof.ssa Graziella Gottardi
MATERIA : INGLESE
La classe ha affrontato con l’attuale insegnante solo quest'ultimo anno di corso per due
ore di lezione alla settimana. Durante il primo periodo un numeroso gruppo di studenti ha
dimostrato ridotte capacità di attenzione e di concentrazione in classe rendendo, spesso
difficile, lo svolgimento delle attività didattiche. Si è resa necessaria, pertanto, da parte
dell’insegnante una costante opera di coinvolgimento degli allievi poco attenti e motivati.
La situazione è andata migliorando nella seconda fase dell’anno scolastico, durante la
quale gli alunni hanno cercato di superare le difficoltà mostrando maggiore impegno e
volontà di miglioramento. Dal punto di vista del profitto solo alcuni alunni presentano una
buona preparazione, la maggior parte rivela una superficiale o quasi sufficiente
conoscenza degli argomenti trattati.
Le lezioni si sono svolte secondo il calendario previsto all’inizio d’anno con varie
interruzioni nella seconda parte a causa di festività, viaggio d’istruzione e altre attività
scolastiche.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in modo differenziato, i
seguenti obiettivi:
CONOSCENZE
Gli allievi conoscono:
- le fondamentali strutture grammaticali
- le funzioni linguistiche di base per interagire in modo autonomo
- il lessico specifico degli argomenti trattati
ABILITÀ
Gli allievi sono in grado di:
- comprendere in maniera globale testi orali e scritti di media difficoltà
- usare le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche acquisite
- esprimersi oralmente in modo sostanzialmente corretto
- esporre processi
- dare definizioni e descrivere oggetti e strumenti e con un lessico appropriato
COMPETENZE
In diversa misura, gli allievi possiedono competenze di ascolto, interazione orale,
comprensione ma la produzione è per lo più mnemonica a parte alcuni alunni che sono in
grado di rielaborare personalmente i contenuti disciplinari e linguistici effettuando analisi e
sintesi appropriate. Gli alunni sono quindi in grado in varia misura di utilizzare la lingua
straniera per i principali scopi comunicativi.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
32
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
REVISION 8h
Holiday and accommodation
How to book a room
Travelling
UNIT 2 ELECTRIC CIRCUITS 20h
A simple circuit
Types of circuit
Current, voltage and resistance
Tools
Dimensions and measurements
Measuring tools: multimeter and oscilloscope
How Edison and electricity chanced the world
Light bulbs: incandescent, fluorescent and led
Save energy in the home
Turning off standby power
UNIT 3 ELECTROMAGNETISM AND MOTORS 4h
Electricity and magnetism
The electric motor
RECUPERO CURRICOLARE 5h
UNIT 4 GENERATING ELECTRICITY 10h
Methods of generating electricity
The generator
Fossil fuel power station (advantages and disadvantages, photocopy)
Nuclear reactor – How reactors produce heat
Renewable energy 1: water and wind (advantages and disadvantages, photocopy)
Renewable energy 2: sun, geothermal, biomass and biofuels (advantages and
disadvantages, photocopy)
UNIT 5 DISTRIBUTING ELECTRICITY 3h
The distribution grid
Revision: passive form
UNIT 6 ELECTRONIC COMPONENTS 6h
Semiconductors
The transistor
Basic electronic components
Revision: the definite/indefinite articles
UNIT 9 AUTOMATION 8h
What is automation?
How automation works
The development of automation
Robots past and present
Varieties and uses of robots
Automation at home and at work.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
33
SCELTE METODOLOGICHE
La metodologia si è basata sull'approccio comunicativo, con lo sviluppo graduale delle
quattro abilità linguistiche: leggere, scrivere, parlare, comprendere. Si è cercato di usare,
per quanto possibile, la lingua straniera in classe e gli alunni hanno avuto modo di
svolgere varie tipologie di esercizi per poter acquisire una certa autonomia nell'uso della
lingua. In quest'ultimo anno è stata data particolare importanza alla comprensione dei testi
orali e scritti e alla correttezza formale.
MATERIALI DIDATTICI
Il testo adottato: Kiaran O’Malley, English for New Technology, Ed. Pearson Longman,
Milano, 2012.
Fotocopie, ascolti audio.
TIPO DI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state svolte prove scritte e verifiche orali, entrambe concernenti il lavoro svolto in
classe e a casa, all’orale con esposizioni di argomenti trattati e comprensioni di brani
specifici, allo scritto con definizioni, descrizioni e trattazioni sintetiche.
I criteri di valutazione, diversi a seconda dell’ambito scritto/orale della prova, sono sempre
stati comunicati agli studenti.
Oltre ai risultati relativi alle verifiche, la valutazione sommativa ha tenuto conto anche della
partecipazione, dell'attenzione, della capacità di lavoro autonomo, dell'impegno e del
progresso conseguito rispetto ai livelli di partenza.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
34
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE : Prof.ssa Fiorenza Pinese
MATERIA : EDUCAZIONE FISICA
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI E COMPETENZE ACQUISITE
Alla fine del corso di studi l’allievo deve essere in grado di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mantenere un’esercitazione per un tempo prolungato al fine di migliorare la
resistenza in relazione alle proprie capacità;
Aumentare gradualmente il carico di lavoro a livelli sub-massimali per sviluppare la
forza sia specifica che generale;
Compiere movimenti ciclici e aciclici nel più breve tempo possibile;
Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali in
forma economica e coordinata;
Eseguire i fondamentali tecnici-tattici di almeno due discipline sportive di squadra e
due individuali ed elaborare un pensiero tattico-sportivo;
Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e
finalizzati;
Scoprire e orientare attitudini personali nei confronti delle attività sportive specifiche
e attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e/o
tempo libero;
Dimostrare di conoscere le norme elementari di primo soccorso
Conoscere i regolamenti delle principali attività sportive trattate nel corso dell’anno.
Guidare un riscaldamento finalizzato
COMPETENZE
Gli allievi hanno raggiunto una buona autonomia di lavoro (responsabilizzazione),
sanno riconoscere l’importanza psico-fisica del movimento e usano correttamente il
linguaggio specifico
CAPACITÀ
Gli allievi hanno consolidate e migliorate le loro capacità fisiche di forza, resistenza,
velocità e mobilità. Sanno coordinare le loro azioni anche in situazioni variate e
complesse. Sono capaci di affrontare situazioni problematiche personali ed interpersonali.
Utilizzano con consapevolezza e in situazioni mutevoli le proprie capacità fisiche e neuromuscolari e le loro conoscenze. Hanno acquisito un pensiero tattico-sportivo.
Sanno applicare abilità motorie nei diversi giochi di squadra.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
35
1 - CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
UNITÀ DIDATTICA
TEST MOTORI
POTENZIAMENTO
MUSCOLARE
PREACROBATICA
ATLETICA
SPORT DI SQUADRA
PERCORSI COORDINATIVI
SPORT ALTERNATIVI
GIOCHI NON CODIFICATI
VARIE
PERIODO
N° LEZIONI
Sett./Ott
Sett/Mar
4
6
Ott./Nov.
Mar./Apr.
Ott./Mag.
Dic.
Ott/Febb.
Ott/ Febb.
Dic/Mag.
5
6
19
2
4
4
5
TOTALE ORE DI LEZIONE AL 15 MAGGIO: 55
N.B. Durante la stessa ora di lezione si sono sviluppati spesso due argomenti diversi e gli
allievi hanno sempre dato un contributo personale allo svolgimento della lezione.
2 - METODOLOGIE:
Si è utilizzata la lezione frontale dell'insegnante con spiegazione, motivazione del gesto
tecnico, dimostrazione. Il lavoro è stato individualizzato con interventi continui di verifica
dell'insegnante anche individuali e con approfondimenti soggettivi. Si è utilizzata spesso
l’assistenza diretta degli allievi si è privilegiato il lavoro a gruppi
3 - MATERIALI DIDATTICI:
Le lezioni si sono tenute utilizzando la palestra e le attrezzature in essa disponibili, campi
e pedane esterne dell'Istituto.
4 - TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:
La verifica del lavoro è stata continua con controllo, suggerimenti e correzioni del docente.
Al termine di ogni attività didattica è stato valutato il grado di apprendimento
dell'argomento trattato attraverso una prova pratica.
Nei giudizi di valutazione quadrimestrale si sono considerati i miglioramenti ottenuti nelle
varie competenze, la serietà e la partecipazione all'attività scolastica, l' impegno
dimostrato e l’attenzione alle lezioni.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
36
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE : Prof. Domenico Ferraro
MATERIA : RELIGIONE
In relazione alle finalità generali del corso e alla programmazione curricolare, sono stati
complessivamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
•
•
•
•
•
•
•
CONOSCENZE:
Conoscenza generale dei principi della morale.
Conoscenza di alcune tematiche essenziali che caratterizzano la bioetica.
Conoscenza dei principi della dottrina sociale della Chiesa.
COMPETENZE:
Comprensione di termini fondamentali della morale.
Comprensione e rispetto delle diverse posizioni in materia religiosa e etica.
Analisi critica di alcune problematiche legate alla bioetica.
Lettura e analisi corretta e adeguata dei documenti proposti.
CAPACITA':
Cogliere gli aspetti caratterizzanti l’attuale questione morale.
Riconoscere i principi che stanno alla base dell’insegnamento morale della Chiesa e
confrontarli con alcune problematiche attuali.
• Confrontare il cristianesimo con altri sistemi di significato.
• Riconoscere che la fede cristiana impegna il credente ad operare nella società per la
edificazione del bene comune e la promozione umana.
•
•
•
•
•
•
•
METODOLOGIE
Brevi lezioni frontali e discussione in classe.
Analisi dei contenuti proposti, in coppia o in piccoli gruppi.
Risposte/elaborati personali e/o di gruppo relativi a quesiti/tematiche scritte.
Lettura, analisi e commento di documenti significativi.
Visione filmati, analisi e dibattito.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
37
PROGRAMMA SVOLTO
Testo: Sergio Bocchini, Religione e Religioni - ed. Dehoniane vol.2
MODULO 1 QUESTIONI DI ETICA E BIOETICA
•
Introduzione all’etica
•
Problem Solving applicato a questioni etiche
•
Comportamento a scuola: il saper controllarsi, il rispetto delle cose altrui
•
Le dipendenze
•
La pena di morte
•
Il perdono
•
L’eutanasia
MODULO 2 AMORE E SESSUALITÀ
• Fasi della coppia: innamoramento ed amore
• I contraccettivi
MODULO 3 IL MATRIMONIO
• Tratti caratteristici dei sacramenti
• Il sacramento del matrimonio
MODULO 4 LA MORALE SOCIALE
• Il mercato delle armi
• La dottrina sociale della chiesa
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
38
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE : Prof. ssa Giampaolo Pradella
MATERIA : ECONOMIA INDUSTRIALE ED ELEMENTI DI DIRITTO
Il programma è stato svolto cercando di raggiungere gli obiettivi realisticamente perseguibili
nell'esiguo tempo a disposizione: due sole ore settimanali, per un totale di circa 60 ore
nell’anno scolastico.
Si è cercato di collegare gli istituti studiati a fattispecie concrete in modo da ottenere un
migliore coinvolgimento e una più attiva partecipazione da parte degli studenti che hanno,
mediamente, dimostrato sufficiente interesse per la disciplina anche se, a volte, senza la
partecipazione attiva al dialogo educativo.
Gli obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale miravano a:
• acquisire i contenuti specifici della disciplina (conoscenze);
• decodificare, organizzare e rielaborare i contenuti degli argomenti di studio
(competenze);
• esporre in forma chiara i contenuti essenziali della disciplina utilizzando gli strumenti
dell’analisi e della sintesi (capacità).
Nel corso dell’anno scolastico sono stati conseguiti i seguenti risultati:
CONOSCENZE:
L’allievo conosce, con diversi livelli di approfondimento, la nozione giuridica di
imprenditore e di impresa, sa classificare e distinguere i vari tipi di imprenditori, conosce la
nozione di contratto di società e i caratteri fondamentali dei vari tipi di società, conosce gli
aspetti essenziali del contratto di lavoro subordinato e della legislazione sociale. Per
quanto riguarda economia industriale sa che cosa si intende per attività economica e
conosce la nozione di sistema azienda con la sua organizzazione, le varie operazioni e
aree della gestione. Conosce inoltre l’impostazione per la rilevazione e contabilità
aziendale che ha come obiettivo il Bilancio d’Esercizio e la sua analisi. Comprende quindi
il significato di patrimonio, di costi e ricavi, per giungere ad una semplice analisi
patrimoniale-finanziaria ed economica dell’azienda. Conosce per grandi linee la Breakeven analysis e l’approccio ad una gestione aziendale programmata e controllata.
COMPETENZE:
Gli allievi sono, mediamente, in grado di interpretare la normativa civilistica e di cogliere le
principali problematiche economico-aziendali.
CAPACITA':
La maggior parte degli allievi espone gli elementi essenziali della disciplina utilizzando un
linguaggio giuridico-economico appropriato e sono in grado di risolvere semplici casi
proposti.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
39
METODOLOGIE:
Presentazione degli argomenti da trattare evidenziando, il più possibile, i collegamenti con
la realtà (per stimolare curiosità ed interesse). Lezione frontale con coinvolgimento della
classe e discussione guidata, chiarimenti degli eventuali quesiti o dubbi per consentire di
cogliere l’essenza e la finalità degli argomenti oggetto di studio.
MATERIALI DIDATTICI:
Libro di testo: “Diritto ed economia industriale” G. Baccelli – C. Robecchi , Ed. Scuola &
Azienda; appunti dell'insegnante.
TIPOLOGIE DI PROVE:
Le verifiche formative sono state prevalentemente orali; quelle sommative sia orali che
scritte.
SVILUPPO TEMPORALE E INDICAZIONI SINTETICHE SUL PROGRAMMA SVOLTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SETTEMBRE: il rapporto di lavoro subordinato (cenni a: i collaboratori
dell’imprenditore – lavoratori subordinati e lavoratori autonomi; i contratti di lavoro
collettivi ed individuali; la cessazione del rapporto di lavoro);
OTTOBRE: l’imprenditore; il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo;
l’imprenditore commerciale e lo statuto dell’imprenditore commerciale;
NOVEMBRE: l'azienda e i segni distintivi; le creazioni dell’ingegno; le invenzioni;
il know how; l’avviamento;
DICEMBRE: le società in generale; il contratto di società e i diversi tipi di società;
GENNAIO: le società di persone e le società di capitali;
FEBBRAIO: le società di capitali S.p.a. e S.r.l. (in particolare per la società per
azioni solo il modello tradizionale di governance);
MARZO: il sistema azienda e la sua organizzazione;
APRILE: la gestione delle aziende; il bilancio d’esercizio;
MAGGIO: l’analisi del bilancio d’esercizio; la Break-even analysis;
GIUGNO: l’attività di programmazione e controllo.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
40
Allegato n 1: 1a Simulazione della 3a prova d’esame Tipologia B
(mercoledì 1 aprile 2014)
SISTEMI AUTOMATICI
1 - Se un sistema è classificato di tipo 1 qual è, con dimostrazione, l'errore a regime se l'ingresso è un
gradino unitario ?
2 - Quali sono le due formulazioni del criterio di Bode sulla stabilità?
3 - Come si ricava l'espressione → GH =(δ – ε) / ε ?
IMPIANTI ELETTRICI
1- Il candidato illustri come si determina, in un sistema TT, l’impedenza a monte del punto di connessione al
fine del calcolo della corrente di cortocircuito trifase e monofase. La potenza richiesta nel punto di
connessione influisce su tale valore? Si motivi la risposta anche con riferimenti normativi.
2 - Il candidato illustri brevemente cosa si intende per rifasamento di un impianto ed elenchi i principali
benefici derivanti da tale accorgimento tecnico.
3 - Una linea aperta, a tensione trifase industriale, con carichi distribuiti realizzata mediante quattro cavi
1x50mmq in EPR posati in canala (unico circuito) alimenta i seguenti tre carichi trifase:
1. Carico ohmico-induttivo con corrente assorbita I1= 16.5 A con fattore di potenza 0.9;
2. Carico ohmico-induttivo con corrente assorbita I2= 8.5 A con fattore di potenza 0.85;
3. Carico ohmico-induttivo con corrente assorbita I3= 25.5 A con fattore di potenza 0.85.
Sapendo che la massima corrente richiesta circolante nel tratto iniziale della linea è pari a 50 A, il candidato,
facendo uso della tabella allegata, trascurando le cadute di tensione, determini:
1. Le caratteristiche dell’interruttore magnetotermico a protezione della linea sapendo che la
potenza totale richiesta nel punto di connessione è 30KW;
2. La sezione minima delle calate ai tre carichi (unico circuito - EPR).
MATEMATICA
1-
Determina i punti di massimo e minimo relativo e i punti di flesso della funzione y =
2 - Dopo aver enunciato il teorema di Rolle, verifica che per la funzione y =
x3
x2 −4
1
nell’intervallo
x − x 2 +1
4
[-2;2], valgono le ipotesi del teorema di Rolle e trova il punto (o i punti) la cui esistenza è assicurata dal
teorema.
3 - Determinare i valori dei parametri a e b in modo che la funzione di equazione y =
2ax
x2 + b
presenti un
flesso nel punto F(2;1/4).
TECNOLOGIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE
1- Nelle figure sottostanti sono rappresentati un cilindro a doppio effetto azionato da un distributore con
elettrovalvola monostabile e il diagramma sequenziale richiesto.
Diagramma sequenziale
C1
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
41
Si vuole azionare il cilindro con un pulsante PS con contatto normalmente aperto (NO) per un singolo ciclo.
S1 e S2 siano due sensori di posizione (o fine corsa) con contatti (NO) e YV1 l’elettrovalvola monostabile.
L’alunno, prevedendo di utilizzare le apparecchiature che più ritiene opportune, produca:
1 – lo schema funzionale in logica cablata della sequenza richiesta;
2 – il programma in linguaggio KOP per un eventuale azionamento utilizzando il PLC
3 – una breve spiegazione del funzionamento.
2 - Dati, come da figura, due cilindri a doppio effetto azionati da due distributori comandati da due
elettrovalvole monostabili YV1 e YV2, siano S1, S2, S3 e S4 i sensori di posizione (NO). PS pulsante di
avviamento ciclo singolo e PC quello di ciclo continuo.
Diagramma sequenziale
C1
C2
L’alunno realizzi lo schema funzionale della sequenza richiesta in logica cablata e in linguaggio KOP del
ciclo singolo.
3 - L’alunno apporti le modifiche allo schema funzionale e al programma in KOP del quesito precedente al
fine di realizzare il ciclo continuo dove con il pulsante PC si avvii il ciclo continuo e con PS si arresti il ciclo.
Allegato n 2: 2a Simulazione della 3a prova d’esame Tipologia B
(giovedì 15 maggio 2014)
SISTEMI AUTOMATICI
1- Descrivere i componenti di un sistema di controllo della velocità di un motore a corrente continua.
2 - L'equazione differenziale del circuito RLC serie e la corrispondente equazione alle trasformate di
Laplace.
3 – Cos’è l’equazione caratteristica e, successivamente, applicare il criterio di Routh-Hurwitz alla seguente
equazione caratteristica 3 s4 + 8 s3 + 2 s2 + 10
IMPIANTI ELETTRICI
1 - Dopo aver definito cosa si intende per contatti indiretti, il candidato elenchi i metodi - azioni di
prevenzione necessarie per la protezione dai contatti indiretti nei sistemi TT secondo quanto dettato dalla
norma CEI 64-8.
2 - Nel rispetto della CEI 64-8 quale condizione si deve verificare affinché sia garantita la selettività verticale
nel caso di tre differenziali collegati in cascata? Il candidato chiarisca la risposta con un esempio numerico.
3 - Il candidato spieghi come si determina il valore massimo della resistenza di terra per il corretto
coordinamento dei dispositivi di protezione nei sistemi TT secondo la CEI 64-8.
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
42
MATEMATICA
1 - Dopo aver rappresentato la parabola di equazione y=x2-2x, calcolare l’area della superficie compresa tra
la curva e l’asse x nell’intervallo [−1;2]
2 - Enuncia il teorema della media integrale e illustrane il significato geometrico. Calcola il valore medio
()
della funzione f x =
1
x2
nell’intervallo [2;8]
( )
3 - Illustra la regola di integrazione per parti e determina la primitiva della funzione f x = e
x
( x +1) che
passa per il punto (0;1/2)
TECNOLOGIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE
1 - Dati, come da figura, due cilindri a doppio effetto azionati da due distributori comandati da due
elettrovalvole monostabili YV1 e YV2, siano S1, S2, S3 e S4 i sensori di posizione (NO).
P1 pulsante di avviamento ciclo singolo (NO).
Diagramma sequenziale
C1
C2
L’alunno disegni, in logica cablata, lo schema funzionale del circuito elettrico che realizza la
l’automazione richiesta dal diagramma sequenziale.
2 - L’alunno disegni in linguaggio KOP il programma che realizza l’automazione di un ciclo singolo della
sequenza riportata nel diagramma del quesito 1.
3 - L’alunno illustri, anche con disegni, le caratteristiche e il funzionamento degli interruttori differenziali;
Allegato n 3: tabella di valutazione terza prova
DESCRITTORI
Pertinenza a quanto
richiesto
Conoscenza dei
contenuti
Correttezza
d'esecuzione,
proprietà linguistica,
efficacia espositiva
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
buona
3
ampia e
buona
approfondita
7
6
sufficiente
2
sufficiente
scarsa
1
superficiale scarsa
5
4
3-1
ottima
buona
sufficiente
insufficiente
scarsa
5
4
3
2
1
Totale
ITIS G. Galilei – Classe 5 AEA - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2013/2014
43