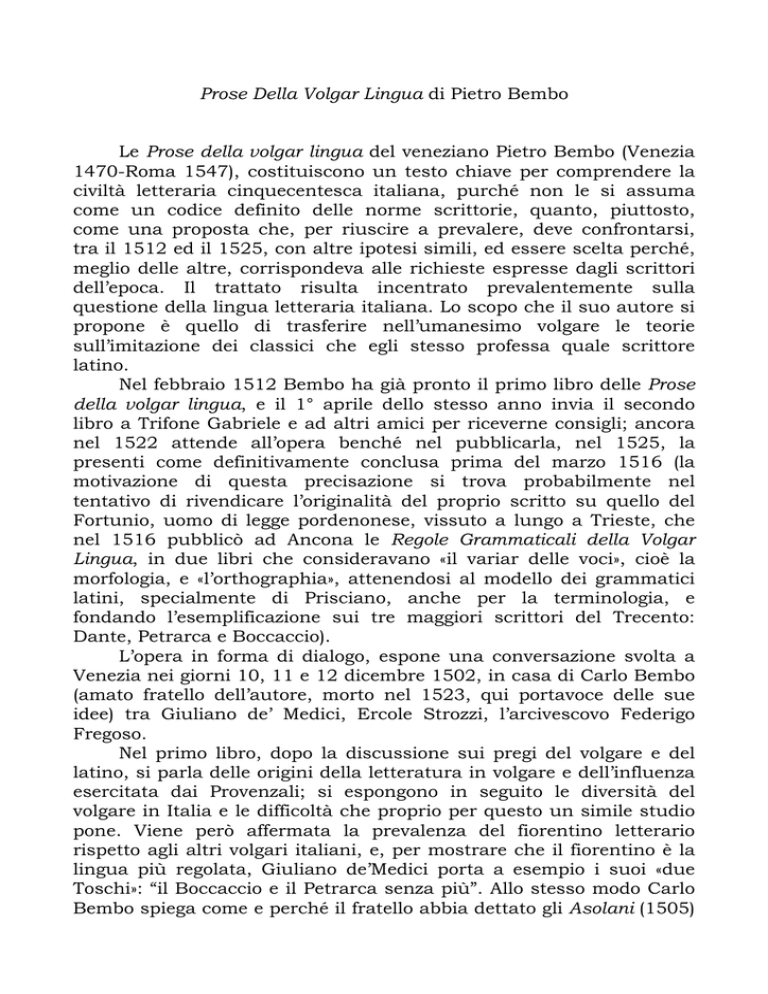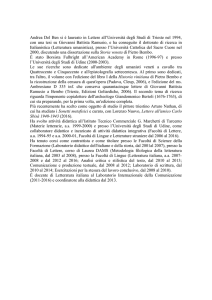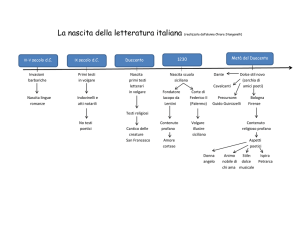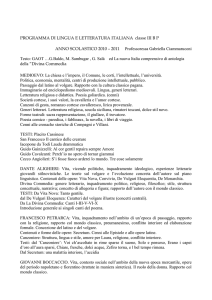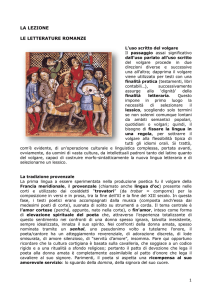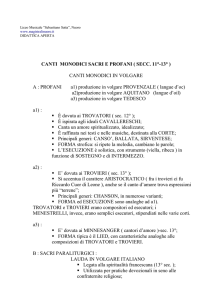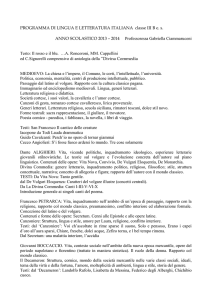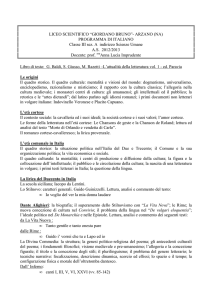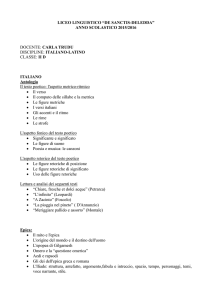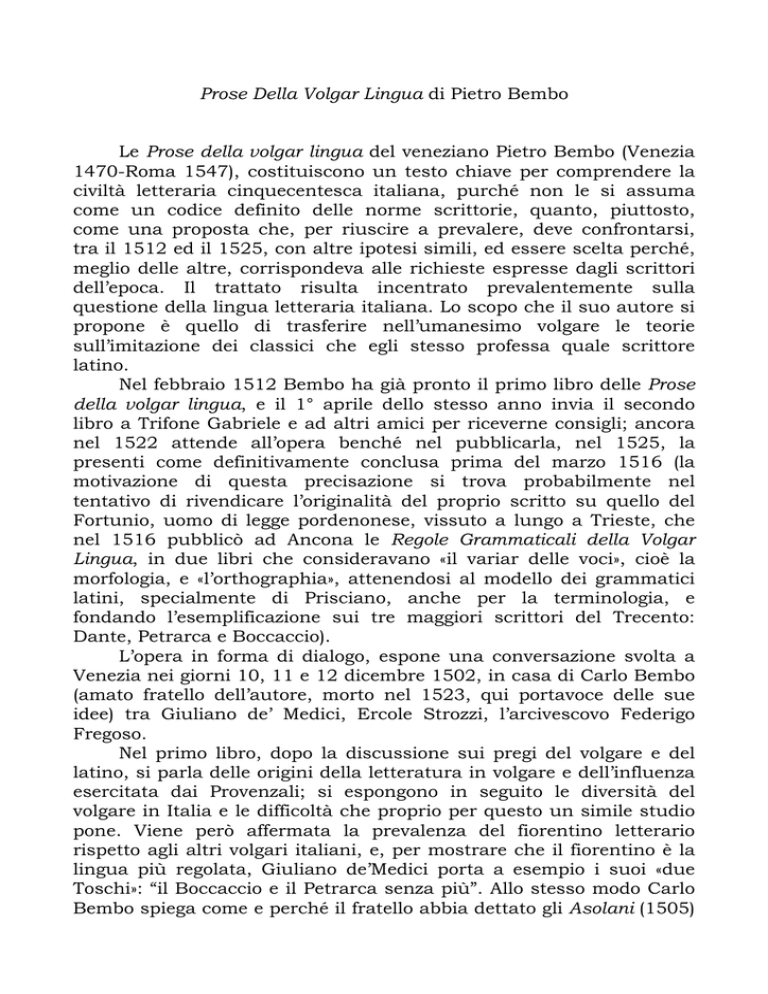
Prose Della Volgar Lingua di Pietro Bembo
Le Prose della volgar lingua del veneziano Pietro Bembo (Venezia
1470-Roma 1547), costituiscono un testo chiave per comprendere la
civiltà letteraria cinquecentesca italiana, purché non le si assuma
come un codice definito delle norme scrittorie, quanto, piuttosto,
come una proposta che, per riuscire a prevalere, deve confrontarsi,
tra il 1512 ed il 1525, con altre ipotesi simili, ed essere scelta perché,
meglio delle altre, corrispondeva alle richieste espresse dagli scrittori
dell’epoca. Il trattato risulta incentrato prevalentemente sulla
questione della lingua letteraria italiana. Lo scopo che il suo autore si
propone è quello di trasferire nell’umanesimo volgare le teorie
sull’imitazione dei classici che egli stesso professa quale scrittore
latino.
Nel febbraio 1512 Bembo ha già pronto il primo libro delle Prose
della volgar lingua, e il 1° aprile dello stesso anno invia il secondo
libro a Trifone Gabriele e ad altri amici per riceverne consigli; ancora
nel 1522 attende all’opera benché nel pubblicarla, nel 1525, la
presenti come definitivamente conclusa prima del marzo 1516 (la
motivazione di questa precisazione si trova probabilmente nel
tentativo di rivendicare l’originalità del proprio scritto su quello del
Fortunio, uomo di legge pordenonese, vissuto a lungo a Trieste, che
nel 1516 pubblicò ad Ancona le Regole Grammaticali della Volgar
Lingua, in due libri che consideravano «il variar delle voci», cioè la
morfologia, e «l’orthographia», attenendosi al modello dei grammatici
latini, specialmente di Prisciano, anche per la terminologia, e
fondando l’esemplificazione sui tre maggiori scrittori del Trecento:
Dante, Petrarca e Boccaccio).
L’opera in forma di dialogo, espone una conversazione svolta a
Venezia nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 1502, in casa di Carlo Bembo
(amato fratello dell’autore, morto nel 1523, qui portavoce delle sue
idee) tra Giuliano de’ Medici, Ercole Strozzi, l’arcivescovo Federigo
Fregoso.
Nel primo libro, dopo la discussione sui pregi del volgare e del
latino, si parla delle origini della letteratura in volgare e dell’influenza
esercitata dai Provenzali; si espongono in seguito le diversità del
volgare in Italia e le difficoltà che proprio per questo un simile studio
pone. Viene però affermata la prevalenza del fiorentino letterario
rispetto agli altri volgari italiani, e, per mostrare che il fiorentino è la
lingua più regolata, Giuliano de’Medici porta a esempio i suoi «due
Toschi»: “il Boccaccio e il Petrarca senza più”. Allo stesso modo Carlo
Bembo spiega come e perché il fratello abbia dettato gli Asolani (1505)
«in fiorentina lingua», alla maniera dei Greci che preferivano la lingua
Attica «più vaga e più gentile».
L’ideale suggerito dal Bembo è quindi quello della lingua
fiorentina, ma la lingua delle regolate scritture perché, aggiunge,
quando si vedono certi i fiorentini seguire l’andazzo dei tempi, si
dubita «che l’essere a questi tempi nato fiorentino, a ben volere
fiorentino scrivere, non sia di molto vantaggio».
Nel secondo libro il discorso da storico e filosofo si fa più
spiccatamente retorico e dunque si passa a trattare della scelta e
della disposizione delle “voci”, in una esemplificazione ben sostenuta
da una fitta rete di citazioni. Carlo Bembo (sempre portavoce del
fratello/autore)
imposta
la
propria
tesi
sulla
necessaria
corrispondenza tra la materia di cui si scrive e la scelta della forma
adoperata per esprimerla. Se la materia può essere infatti grande,
bassa o mezzana, anche le “voci” dovranno essere rispettivamente
gravi, lievi o temperate. Di qui deriva la condanna della lingua della
Commedia di Dante, che talvolta adopera insieme a forme fiorentine,
voci «rozze e disonorate», ossia arcaismi, latinismi, francesismi e
neologismi inaccettabili. Meglio quindi seguire come modelli esemplari
di scrittura in volgare da imitare la lingua poetica del Canzoniere e la
prosa del Decameron. A questo proposito è importante ricordare che
tanto nel primo quanto nel secondo libro delle Prose, il Bembo
organizza e propone un canone degli scrittori in volgare che, dopo
quello dantesco contenuto nel De vulgari eloquentia, rappresenta un
notevole sforzo di riflessione critica intorno alla tradizione letteraria
precinquecentesca, a partire dalla Scuola siciliana. Lo scrittore,
attento soprattutto all’aspetto linguistico e poi stilistico del problema,
intende mostrare, attraverso un elenco preciso di autori, quanti
rimatori e prosatori ci sono stati in Italia che hanno operato fuori
Firenze e della Toscana, offrendo un primo, non trascurabile
contributo alla storiografia della letteratura italiana.
Nel terzo libro è racchiusa, infine, un’esposizione dei punti più
importanti della grammatica italiana, fatta da Giuliano de’ Medici.
Attraverso numerosi rinvii ai testi petrarcheschi, boccacciani,
danteschi e di molti autori ancora, si danno dunque le norme
fondamentali di una grammatica del volgare, rivendicando
definitivamente la pari dignità dell’italiano rispetto al latino.
L’effetto prodotto dalle Prose del Bembo fu importantissimo: da
allora molti grammatici si posero a compilare manuali conformi ai
suoi principi (tale è ad esempio Le Tre fontane, un’opera di Nicolò
Tiburnio, 1526), ed inoltre anche tanti letterati iniziarono a seguirne
le norme (valga un esempio per tutti: Ludovico Ariosto, il quale
ripubblicò per la terza volta, nel 1532, l’edizione definitiva
dell’Orlando Furioso, frutto di un’accurata revisione linguistica svolta
tenendo conto, ed accettando infine pienamente, la teoria bembiana).
L’impostazione del Bembo, alla luce di quanto esposto in questo
dialogo, si può dunque definire eminentemente retorica, in quanto egli
si rivolge scopertamente agli scrittori, spronandoli a cercare una
lingua elegante attraverso l’imitazione dei migliori trecentisti toscani.