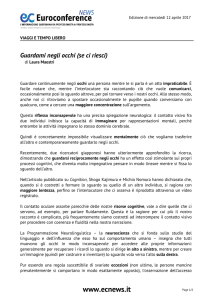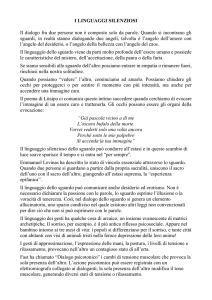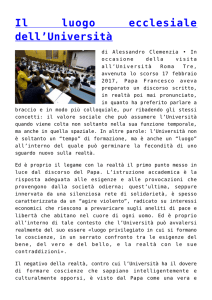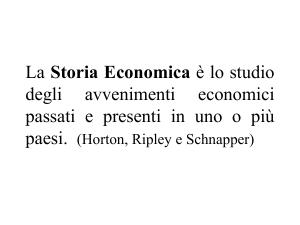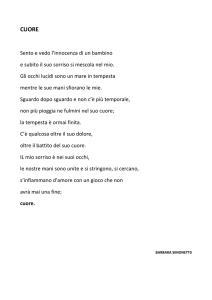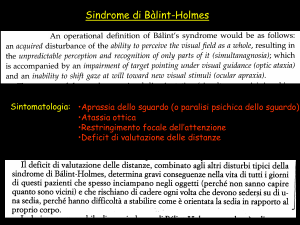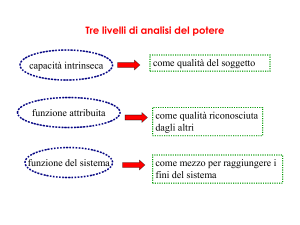9. Storie del riconoscimento
«Che cosa farai con un carrettino di legno, con una bambola di pezza, con una conchiglia a metà
affondata nella sabbia se sei ancora nella fase della vita umana in cui si cammina a quattro zampe e
ci si stupisce di tutto, e se per un attimo sei riuscito a evadere il marcamento ossessivo di quegli
isterici giganti che non sono mai stupiti ma sembrano sempre spaventati? È chiaro: li metterai in
bocca e assaporerai fino in fondo la fragranza acidula della vernice che ricopre il carretto, la vena
pastosa della bambola, il sole e l’acqua salata di cui è intrisa la conchiglia. Il mondo, per te, è un
repertorio di gusti, un serbatoio inesauribile di affascinanti misteri da svelare mettendoli a stretto
contatto con l’interno del tuo corpo, con quella parte del tuo essere più nascosto che sa aprirsi e
richiudersi su ciò che è altro da te, e succhiarlo e spremerlo e addentarlo e tormentarlo finché non ti
ha comunicato i suoi segreti.» Bencivenga Ermanno 2010 La filosofia come strumento di
liberazione, Raffaello Cortina Editore, Milano p. 19
«Un’ammissione talmente sincera della propria incompletezza ed incertezza è un buon punto da cui
cominciare, forse, nel momento in cui esseri umani, capaci di considerarsi come persone variamente
disabili [o diversamente abili], intendono lavorare insieme per creare una società liberale e
progressista.» Nussbaum Martha C. 2004 Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge.
Carocci editore, Roma 2005 p. 403
Un ingresso a partire dal vissuto:
«l’attesa che anticipa attraverso il ricordo»
Edmund Husserl 1913 Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica,
Einaudi, Torino 2002 p. 261.
Un ingresso a partire dall’urgenza del riconoscimento di sé:
- in dimensione temporale (diacronia): «Con la memoria e con la promessa la problematica del
riconoscimento di sé raggiunge simultaneamente due sommità. L’una si volge verso il passato,
l’altra verso il futuro. Ma vanno pensate insieme nel presente vivente del riconoscimento di sé,
grazie ad alcuni tratti che esse possiedono in comune.» Ricoeur Paul 2004 Percorsi del
riconoscimento (Parcours de la reconnaissance), Raffaello Cortina, Milano 2005, p.127
- in dimensione spaziale (sociale, intersoggettivo) (sincronia): «Nel mutuo riconoscimento si
compie il percorso del riconoscimento di se stessi.» (Ricoeur 2004 p. 212)
- con una logica interna plurima: 1. «Io penso che interpreto soprattutto per far conoscere al
paziente i limiti della mia comprensione.» Winnicott W. Donald 1971 Gioco e realtà, Armando
editore, Roma 1995 p. 152 2.« Devo a lui l’aver capito il meccanismo infernale della dipendenza,
perché è vero che da tutto — proprio da tutto, anche e soprattutto dalle persone — si può diventare
dipendenti. Devo a lui l’aver capito l’inevitabilità del descrivere il futuro come un’infantile
prosecuzione del presente, perché non esiste progresso se non casuale.» Edoardo Nesi, a proposito
di David Foster Wallace in appendice a Wallace David Foster 2008 Una cosa divertente che non
farò mai più, Minimum fax, Roma 2010 3. «seguire logiche senza ragione» (Elisa [cantante])
(come a proposito di Alice nel paese delle meraviglie o di razionalità senza sistemi…)
Un ingresso a partire dalla percezione: «Si racconta che negli anni ‘60 una multinazionale andò
in giro per l’Africa, con uno schermo portatile e un generatore di elettricità, per mostrare nei
villaggi sperduti un filmato sui grandi macchinari agricoli che produceva. Dopo varie proiezioni, si
accorse però che il filmato non sembrava avere alcun effetto, e alla fine si decise a domandare agli
spettatori che cosa avessero recepito. La sorprendente e unanime risposta che ricevette fu: la
presenza di un pollo che passava a un certo momento in un angolo dello schermo, e di cui gli
occidentali non si erano nemmeno accorti. La sorpresa svanì quando si rifletté sul fatto che, in
1
fondo, ciascuno può percepire della realtà soltanto ciò che è in grado di riconoscere e
comprendere.» Odifreddi Piergiorgio, Elogio della scienza, La Repubblica 22 marzo 2010
Un ingresso a partire dal coinvolgimento nel sociale: (da Nietzsche… il tema delle
considerazioni inattuali … )
«… hanno saputo attraversare il male senza pensare di essere la personificazione del bene.»
Cozzi Ambrogio, Ripensare il totalitarismo oggi in Recalcati Massimo (a cura di) 2007 Forme
contemporanee del totalitarismo, Bollati Boringhieri, Torino p. 262
«… ne sapremmo assai di più delle complessità della vita se ci fossimo applicati a studiare con
determinazione le sue contraddizioni, invece di perdere tanto tempo con le identità e le coerenze, le
quali hanno il dovere di spiegarsi da sole.»(Saramago José 2000 La caverna, Einaudi, Torino p. 18)
Il complesso di Jessica Rabbit :«…io non sono cattiva, è che mi disegnano così» (ma lei non può
che riconoscersi come disegno - cartoon)
1. I significati e gli atti.
La densità del termine riconoscimento e le possibili storie sembrano ospitate già nella sua
polisemia, nel suo doppio significato, nella sua doppia ambivalenza.
1.1. La polisemia, per effetto di una doppia ambivalenza. Lo sottolinea il filosofo Paul Ricoeur
che, nell’opera Percorsi del riconoscimento (il suo ultimo libro, pubblicato nel 2004, l’anno della
sua morte [in italiano ed. Raffaello Cortina Milano 2005]), richiama con percorsi linguistici,
filologici e filosofici (fondati sullo studio della parola e del suo uso sociologico plurimo [individua
infatti ben 23 classi di significato]), la storia complessa, l’evoluzione e la densità del senso del
termine.
1.1.1. Per coglierne una prima ambivalenza originaria è opportuno, forse necessario, richiamarlo
nella lingua francese: reconnaissance (Parcours de la reconnaissance), parola che indica
immediatamente sia riconoscimento (riconosco) che riconoscenza (sono grato); ambivalenza che,
pur non immediatamente, compare anche nella lingua italiana. Non si tratta (qui e nelle altre
ambivalenze o plurivalente) di omonimia, ma di polisemia “controllata” (“polisemia regolata”)che
si mostra in grado di registrare, sottintendere e conservare una relazione tra i diversi atteggiamenti
di riconoscimento e di gratitudine, sostenendo e avviando così l’analisi della cultura del
riconoscimento.
1.1.2. Quell’ambivalenza proficua si rafforza, fa emergere una seconda ambivalenza, anche ad
opera di un rovesciamento implicito nello stesso termine e nel suo uso: il rovesciamento «del verbo
“riconoscere” dal suo uso nella forma attiva al suo uso nella forma passiva: io riconosco
attivamente qualcosa, delle persone, me stesso; io chiedo di essere riconosciuto dagli altri.»
(Ricoeur Paul 2004 Percorsi del riconoscimento, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, p. 4). Del
resto un riconoscere cui non corrisponda un corrispettivo essere riconosciuti segnala più
l’insuccesso che l’accadere del riconoscere, almeno in termini affettivi.
1.1.3. È allora possibile, da subito, segnalare preliminarmente l’incontro tra le due ambivalenze
richiamate (riconoscimento / riconoscenza; riconoscere / essere riconosciuti): «Non è forse nella
mia identità autentica che io chiedo di essere riconosciuto? E se, per fortuna, mi capita di esserlo, la
mia gratitudine non va forse rivolta a coloro i quali, in una maniera o nell’altra, hanno riconosciuto
la mia identità riconoscendomi?» (Ricoeur 2004 p.5)
1.2. la radice della dinamica della polisemia e della transizione linguistica che la esprime.
«nella presa in esame lessicografica degli usi della lingua comune, il passaggio da un significato
all’altro avviene infatti per impercettibili salti, e ciò in quanto il principio di questi scarti infimi
risiede nel non-detto della definizione precedente, sotto il quale si dissimula il generarsi stesso della
2
sequenza ordinata di significati nell’ambito di quella che abbiamo chiamato polisemia regolata. La
nostra attenzione sarà dunque rivolta proprio a questo gioco di scarti, come anche alla spinta del
non-detto grazie alla quale tali scarti si scavalcano a vicenda tanto abilmente da dare l’impressione
che la derivazione scorra come un flusso continuo di significati.» (Ricoeur 2004 p.8) Il non-detto
costituisce il cammino di riconoscimento proprio della parola e ne determina l’evoluzione
semantica.
1.3. il problema filosofico afferrato e proposto dall’intero arco delle transizioni presenti nella
polisemia. In quel flusso di significati del termine, imposti da quanto un significato non dice,
celando e anche segnalando con il suo implicito rimandare, prende corpo e viene a tema un
problema filosofico che è ad un tempo “riconoscimento” di una mancanza, segnalazione di una
proposta, articolazione di un progetto.
«La mia ipotesi di lavoro si basa sulla convinzione che il filosofo non debba rinunciare a costituire
una teoria del riconoscimento degna di questo nome, teoria in cui siano al tempo stesso riconosciuti
e superati gli scarti di senso generati da ciò che si può chiamare lavoro della domanda. Spetta alla
responsabilità di un filosofo militante, formatosi alla disciplina di quella storia filosofica dei
problemi che trova il suo complemento nella storia delle opere e delle dottrine, di comporre, a un
grado superiore di complessità, una catena di significati concettuali in cui venga preso in
considerazione lo scarto tra significati derivanti da problematiche eterogenee.
Il filosofo può trovare un incoraggiamento sul versante del lessicografo alla ricerca di elementi di
raccordo — abbiamo parlato di implicito, di non-detto — in grado di assicurare la transizione da
una definizione all’altra. Spetta a questi elementi di raccordo creare e al tempo stesso superare gli
scarti dissimulati sotto l’apparenza di una genesi continua di significati nuovi a partire da significati
preesistenti. Noi tenteremo un lavoro simile, sull’implicito e il non-detto, però a livello concettuale,
con la speranza di compensare quel primo effetto di sconnessione prodotto dalla
problematizzazione, per mezzo di un effetto di concertazione tra filosofemi resi consonanti dal
lavoro sulle transizioni.» (Ricoeur 2004 p.23)
1.3.1. riconoscere e essere riconosciuti (una attenzione e una domanda [ripresa della seconda
ambivalenza sopra menzionata]) «Nel mettere in pratica questa convinzione, la mia ipotesi di lavoro
circa una possibile derivazione dei significati sul piano del concetto trova incoraggiamento e
sostegno in un aspetto significativo dell’enunciazione del verbo in quanto verbo, ovvero nel suo
impiego sia nella forma attiva — riconoscere qualche cosa, degli oggetti, delle persone, sé, un altro,
l’un l’altro — sia nella forma passiva — essere riconosciuto, chiedere di essere riconosciuto. La
mia ipotesi è che gli usi filosofici potenziali del verbo “riconoscere” possano essere ordinati
secondo una traiettoria che parte dall’uso nella forma attiva e arriva all’uso nella forma passiva.
Questa inversione a livello grammaticale costituirebbe l’impronta di una inversione della medesima
ampiezza sul piano filosofico. Riconoscere in quanto atto esprime una pretesa, un claim, a esercitare
un dominio intellettuale sul campo dei significati, delle asserzioni significanti. Al polo opposto
della traiettoria, la domanda di riconoscimento esprime un’attesa che può essere soddisfatta solo in
quanto mutuo riconoscimento, sia che quest’ultimo resti un sogno inaccessibile, sia che richieda
procedure e istituzioni tali da elevare il riconoscimento al piano politico.» (Ricoeur 2004 p.23-24)
1.3.2.dal conoscere al riconoscere (dalla semplice conoscenza al coinvolgimento) «Altra
implicazione della nostra ipotesi di lavoro: in occasione di questa inversione dalla forma attiva alla
forma passiva, e congiuntamente al progressivo predominio della problematica del riconoscimento
reciproco, il riconoscimento acquisisce uno statuto sempre più indipendente rispetto alla cognizione
come semplice conoscenza. Allo stadio iniziale del processo, il tipo di dominio proprio dell’atto di
riconoscimento non differisce in maniera decisiva da quello che ritroviamo nel verbo “conoscere”
alla forma attiva. […] l’impiego del verbo nella forma attiva sembra collegarsi a operazioni
intellettuali contrassegnate da una iniziativa della mente.» (Ricoeur 2004 p.24-25)
1.3.2.1. La rilevanza del cambiamento di prospettiva è posto in evidenza con il termine rivoluzione
e con il richiamo, per analogia, alla rivoluzione copernicana; si tratta di «replicare con una seconda
3
rivoluzione alla rivoluzione copernicana e di cercare sul versante delle “cose stesse” le risorse per lo
sviluppo di una filosofia del riconoscimento progressivamente sottratta alla tutela della teoria della
conoscenza.» (Ricoeur 2004 p.33) Ed è come abbandonare la stessa impostazione della filosofia di
Descartes e di Kant (a suo tempo indicata come una rivoluzione copernicana della filosofia per la
decisione di porre al centro della fondazione filosofica e scientifica la soggettività e le strutture a
priori della mente) per individuare le radici ontologiche (non metafisiche) di una teoria del
riconoscimento.
1.3.3. identità e distinzione nella relazione del riconoscimento in analitica distinzione.
1.3.3.1. identificare è distinguere [un quasi-paradosso]: « … propongo di assumere come prima
accezione filosofica la coppia identificare/distinguere. Riconoscere qualche cosa come la cosa
medesima, come identica a sé e non come altra da se stessa, implica distinguerla da ogni altra.
Questa prima accezione filosofica verifica le due caratteristiche semantiche che, come abbiamo
visto, sono congiunte all’uso del verbo nella forma attiva, cioè l’iniziativa della mente nel dominio
sul senso e la quasi-indistinzione iniziale tra “riconoscere” e “conoscere”.» (Ricoeur 2004 p.25)
1.3.3.2. riconoscimento di sé: «È pur sempre di identità che si tratta a proposito del riconoscimento
di sé. Nella sua forma personale, l’identità costituirà al tempo stesso la posta in gioco di questo
riconoscimento e il legame tra le problematiche che si raggruppano all’interno di questo ambito.»
(Ricoeur 2004 p.26)
1.3.3.3. riconoscimento reciproco: «Quanto alla terza tematica quella che va sotto il titolo del
riconoscimento reciproco, possiamo dire sino da ora che con essa la questione dell’identità
raggiungerà una sorta di punto culminante; è infatti proprio la nostra identità più autentica, quella
che ci fa essere ciò che siamo, a chiedere di essere riconosciuta.» (Ricoeur 2004 p.26)
1.3.4. un filo conduttore nella articolazione in progetto filosofico della transizione semantica del
termine “riconoscimento”: «Una ragione supplementare per privilegiare questo ordine tematico tra
le accezioni filosofiche del termine “riconoscimento” sta dunque nel fatto che la progressione lungo
questo asse sarà contrassegnata da un crescente affrancamento del concetto di riconoscimento dal
concetto di conoscenza. Allo stadio ultimo, il riconoscimento non solo si separa dalla conoscenza
ma le apre la strada.» (Ricoeur 2004 p.26)
2. Riconoscimenti
2.1. Odissea: un lungo viaggio di ricostruzioni e riconoscimenti
Odisseo e il cane Argo
«Essi dunque facevano questi discorsi tra loro.
E un cane, che era sdraiato, sollevò il capo e le orecchie,
Argo, il cane dell’intrepido Odisseo, che egli stesso
s’era allevato, ma non goduto: andò prima
alla sacra Ilio. Con lui i giovani un tempo cacciavano
capre selvatiche, daini e lepri:
ma ora, partito il padrone, giaceva in disparte
sul molto letame di muli e di buoi
che stava ammucchiato davanti alle porte, finché lo toglievano
i servi di Odisseo, per concimare il grande podere.
Giaceva il cane su di esso, Argo, pieno di zecche.
Allorché vide Odisseo accanto,
scodinzolò e piegò entrambe le orecchie,
ma al proprio padrone non poté
avvicinarsi. Questi distolse lo sguardo e si terse una lacrima,
facilmente eludendo Eumeo; poi domandò:
«Eumeo, che meraviglia, questo cane sopra il letame!
È bello il suo aspetto, ma non so chiaramente
se era anche celere con questa figura,
4
o se era come sono i cani da mensa
degli uomini: li allevano per lusso i padroni ».
E tu rispondendo, o porcaro Eumeo, gli dicesti:
«Oh sì, questo è il cane di un uomo che è morto lontano:
se per l’aspetto e l’azione fosse così
come quando Odisseo, partendo per Troia, lo lasciò,
subito ne ammireresti la celerità e la forza.
Nei recessi della selva profonda non gli sfuggiva
una fiera che egli inseguisse: eccelleva nel seguire le peste.
Ma ora è in miseria: il padrone gli è morto lontano
da casa e le donne, incuranti, non l’accudiscono.
Quando i padroni non ordinano, i servi
non vogliono più lavorare a dovere.
Zeus dalla voce possente toglie metà del valore
ad un uomo, appena lo umilia il servaggio ».
Detto così, entrò nella casa ben situata
e si diresse nella gran sala, tra i pretendenti egregi.
E subito il fato della nera morte colse Argo,
quando ebbe visto Odisseo dopo venti anni.»
Odissea XVII, 290-327
2.1.1. Paul Ricoeur, nell’opera citata Percorsi del riconoscimento (del 2004, Raffaello Cortina
Editore, Milano 2005, pp. 90-93), prende in considerazione il tema «Ulisse si fa riconoscere»
mettendo subito in evidenza la natura ambivalente e di reciprocità del riconoscimento. «Il famoso
racconto del ritorno di Ulisse a Itaca è incontestabilmente un racconto di riconoscimento di cui
l’eroe è al tempo stesso il protagonista e il beneficiato. È giusto affermare che egli si fa riconoscere
da altri partner secondo una gradualità sapientemente orchestrata e un’arte del differimento molte
volte commentata dai critici.» «Ulisse è ricevuto come “straniero” e tuttavia accolto come
“ospite”.» Si tratta di una reciprocità forse debole, perché il riconoscimento di Ulisse si accompagna
alla sua ripresa di possesso della casa e del potere e ad una implacabile vendetta. Ma «il differito
progredire del riconoscimento di Ulisse da parte dei suoi è ricco di insegnamenti…» Il
riconoscimento progressivo e graduale, orchestrato come in un vero e proprio dramma (quasi in un
crescendo) del riconoscimento (il cane, la nutrice e la servitù, il figlio, la sposa, il padre), ha
l’effetto di dar vita al riconoscimento della «intera configurazione della famiglia con la diversità dei
rispettivi ruoli.» Così come, la stessa strategia del differimento, permette di porre in evidenza la
forte carica simbolica dei segni che determinano il riconoscimento e una certa forma di reciprocità
(almeno funzionale): la cicatrice, l’arco e il suo piegarsi, la forma del letto nuziale, il ricordo di
antichi eventi vissuti assieme… Ne deriva una storia dei segni e del loro essere sede fisica,
materiale di riconoscimenti. Vale anche in viceversa: è il riconoscimento e la sua urgenza (una
attenzione al riconoscimento come definizione generale di conoscenza e di cultura) a generare
l’attenzione al segno e alle sue differenze (a volte impercettibili) e alla loro efficacia nel
determinare il riconoscimento e le sue reciprocità (riconoscimento / riconoscenza; riconoscere /
essere riconosciuti).
2.2. i discepoli di Gesù verso Emmaus: “quomodo cognoverunt eum in fractione panis”
«In quel medesimo giorno, due dei discepoli si trovavano in cammino verso un villaggio, detto
Emmaus, distante circa sessanta stadi da Gerusalemme, e discorrevano fra loro di tutto quello che
era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano, Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro.
Ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Egli disse loro: «Che discorsi sono questi che vi
scambiate l’un l’altro, cammin facendo?». Si fermarono, tristi. Uno di loro, di nome Cleopa, gli
disse: «Tu solo sei straniero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? ».
Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Il caso di Gesù, il Nazareno, che era un profeta potente in
5
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i gran sacerdoti e i nostri capi lo hanno
consegnato per essere condannato a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui quello
che avrebbe liberato Israele. Ma siamo già al terzo giorno da quando sono accaduti questi fatti.
Tuttavia alcune donne tra noi ci hanno sconvolti. Esse si sono recate di buon mattino al sepolcro,
ma non hanno trovato il suo corpo. Sono tornate a dirci di aver avuto una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcun, dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come
avevano detto le donne, ma lui no l’hanno visto» Allora egli disse loro: « O stolti, e tardi di cuore a
credere a quello che hanno detto i profeti! Non doveva forse il Cristo patire, tutto questo ed entrare
nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo riguardava in
tutte le Scritture. “Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece finta di proseguire.
Ma essi lo costrinsero a fermarsi, dicendo: «Resta con noi, perché si fa sera ed il sole ormai
tramonta». Egli entrò per rimanere con loro. Or avvenne che mentre si trovava a tavola con loro
prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò e lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi
e lo riconobbero. Ma egli disparve ai loro sguardi. Si dissero allora l’un l’altro: «Non ardeva forse il
nostro cuore quando egli, lungo la via, ci parlava e ci spiegava le Scritture?». Quindi si alzarono e
ritornarono subito a Gerusalemme, dove trovarono gli Undici riuniti e quelli che erano con loro.
Costoro dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone ». Ed essi raccontarono
ciò che era accaduto lungo il cammino e come l’avevano riconosciuto allo spezzare del pane.»
(Luca 24, 13-35)
2.2.1. due note: 1. nella frase «E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo
riguardava in tutte le Scritture» è espressa la logica che struttura il testo dei Vangeli come
documenti delle professioni di fede nella messianicità di Gesù propria delle prime comunità
cristiane; 2. il racconto pone al centro anche l’attenzione ai segni e ai simboli del riconoscimento.
2.2.2. un accostamento: « Il venditore gli indicò uno dei tre tavoli coperti da tovaglie di plastica e
uscì da dietro il banco con una bottiglia e due bicchieri. Servì il vino, i due uomini si guardarono
fugacemente negli occhi e scoprirono le stesse ombre, le stesse occhiaie, lo stesso glaucoma storico
che consentiva di vedere realtà parallele o di leggere l’esistenza secondo due linee narrative
condannate a non coincidere mai: quella della realtà e quella dei desideri. I naufraghi della stessa
nave hanno un sesto senso che permette loro di riconoscersi, come i nani.» (Luis Sepùlveda 2009
L’ombra di quel che eravamo, Guanda, Parma p.18)
2.3. Hannah Arendt: Ritorno in Germania; un difficile (impossibile) riconoscimento (un
passato che non può essere riconosciuto, compreso…)
«Questo saggio racconta il ritorno in Germania di una ebrea tedesca dopo la Shoà: è il primo e forse
più drammatico tentativo di fare i conti con «quel passato che non passa» che ancor oggi, a mezzo
secolo di distanza, costituisce il doloroso e inquietante rovello dell’identità e della coscienza
tedesche. […] Hannah Arendt, che ormai è universalmente riconosciuta come la maggiore
pensatrice tedesca del secolo in quest’opera ha raccolto osservazioni e considerazioni legate al suo
«ritorno in Germania» nel 1950, dopo il lungo esilio iniziato nel 1933 che l’aveva condotta prima a
Parigi e successivamente, a partire dal 1941, negli Stati Uniti — paese che, come per tanti altri
esuli, anche per la Arendt divenne una seconda e «più vera patria» e dove morì nel 1975. Occasione
del viaggio che ebbe la durata di quasi sei mesi e permise alla allieva-amante di Heidegger nonché
allieva-amica di Jaspers di girar in lungo e in largo per le devastate città tedesche, l’invito a lavorare
per la rappresentanza della Jewish Cultural Reconstruction che aveva sede a Wiesbaden, per
«raccogliere e ordinare i frammenti di una civiltà distrutta, e nella misura in cui questo era ancora
possibile, riconsegnarli alle istituzioni culturali ebraiche. Ma contemporaneamente dovette anche
confrontarsi criticamente con quello che aveva cercato di definire ricorrendo alla metafora dello
shock della realtà» (I. Nordmann). Quello shock le cui angosciose conseguenze si riverberano nelle
affermazioni contenute in un saggio di molti anni posteriore rispetto al presente, tradotto per la
prima volta in italiano: «quando ripenso agli ultimi vent’anni, ho la sensazione che questa questione
sia stata posta in sottordine, potremmo dire “in sonno”, da qualcosa di cui è davvero molto difficile
6
parlare e con cui è quasi impossibile venire a patti, ossia l’orrore puro, nella sua nuda mostruosità.
Quando per la prima volta dovemmo porci di fronte a questo orrore, sembrò a me, e non solo a me,
che esso trascendesse ogni categoria morale, mandando sicuramente in frantumi ogni fattispecie
giuridica. Possiamo dirlo in modi diversi. Io ero solita dire che si trattava di qualcosa che non
sarebbe mai dovuto accadere, perché gli uomini non sarebbero stati capaci né di punirlo né di
perdonarlo. Infatti non potremo mai riconciliarci con tale orrore, non saremo mai capaci di venirci a
patti come in realtà dovremmo fare con tutte le cose del passato. [...] Al contrario, con il trascorrere
del tempo “quel” passato ha assunto una tale immagine che a volte siamo tentati di pensare che tutto
ciò non avrà fine finché non l’avremo noi. Quel passato si è rivelato irriducibile a chiunque, e non
solo per la nazione tedesca» (H.Arendt, Comandamenti contro l’orrore, in «Liberal» 1995,3;
conferenza del 10.02.1965). Oggi sappiamo che le cose stanno esattamente come la Arendt aveva
profeticamente previsto.» (Arendt Hannah 1950 Ritorno in Germania, Donzelli editore, Roma
1996, dall’Introduzione di Angelo Bolaffi p. 6, 8-9)
2.3.1. l’impossibile riconoscimento:
« So nel frattempo che sui miei tesori c’è scritto LÀ RESTO. Che il Lager mi ha lasciato tornare a
casa per stabilire la distanza di cui ha bisogno per ingrandirsi nella mente. Dal mio ritorno, sui miei
tesori non c’è più scritto QUI IO SONO, ma neppure LÀ ERO. Sui miei tesori c’è scritto: DI LÀ
NON VENGO VIA. Sempre più il Lager si estende dal lobo temporale sinistro a quello destro.
Perciò devo parlare del mio intero teschio come di un territorio, del territorio di un Lager.
Impossibile proteggersi, né con il silenzio né con il racconto. Si esagera nell’uno come nell’altro,
ma un LÀ ERO non c’è in nessuno dei due. E non c’è neppure una giusta misura.»
Müller Herta 2009 L’altalena del respiro, Feltrinelli, Milano 2010 p. 247
Gennaio 1945, la guerra non è ancora finita: per ordine sovietico inizia la deportazione della
minoranza rumeno-tedesco nei campi di lavoro forzato dell’Ucraina. Qui inizia anche la storia del
diciassettenne Leopold Auberg, partito per il Lager con l’ingenua incoscienza del ragazzo ansioso
di sfuggire all’angustia della vita di provincia. Cinque anni durerà poi l’esperienza terribile della
fame e del freddo, della fatica estrema e della morte quotidiana. Per scrivere questo libro Herta
Müller ha raccolto le testimonianze e i ricordi dei sopravvissuti e in primo luogo quelli del poeta
rumeno-tedesco Oskar Pastior. Avrebbe dovuto essere un’opera scritta a quattro mani, che Herta
Müller decise di proseguire da sola dopo la morte di Pastior nel 2006. È infatti attraverso gli occhi
di quest’ultimo, quelli del ragazzo Leo nel libro, che la realtà del Lager si mostra al lettore. Gli
occhi e la memoria parlano con lingua poetica e dura, metaforica e scarna, reale e nello stesso
tempo surreale — come la condizione stessa della mente quando il corpo è piagato dal freddo e
dalla fame. Fondato sulla realtà del Lager, intessuto dei suoi oggetti e della passione, quasi
dell’ossessione per il dettaglio quale essenza della memoria e della percezione, L’altalena del
respiro è un potente testo narrativo, una grande opera letteraria. (dalla terza di copertina)
3. riconoscimento percezione conoscenza
[introduzione, per schema, alla sezione, come da percorso in diapositive: la sequenza
3.1. conoscere è riconoscere (Platone)
3.2. il riconoscimento sensibile (Argo) (per visioni)
un dato di partenza: intenzionalità e trasparenza del percepire; un formalizzatore non avvertito,
non tematizzato
questioni di mimetismo: riconoscimento e sopravvivenza nella ambivalenza della mimesis
1. mimetizzarsi per riconoscersi, acquisire e darsi una forma
(come accade nei processi educativi: una lunga e sofferta storia di mimesis)
2. mimetizzarsi per evitare il riconoscimento (di essere riconosciuti)
la capacità mimetica (insetto) come il suo riconoscimento (tordo) sono condizione indispensabili di
sopravvivenza: educazione, inserimento, relazioni, successo, riconoscimenti…
sguardi professionali
3.3. il riconoscimento per “visione concettuale” (Emmaus): il “pensiero visivo”
7
per fare chiarezza: «C’è una veneranda teoria filosofica, la Teoria dei dati sensoriali…, secondo la
quale l’esperienza fornisce dei dati che, poi, l’intelletto organizza sotto forma di pensieri e di
credenze. Per quanto veneranda, la teoria è sbagliata di sana pianta…» Calabi Clotilde 2009
Filosofia della percezione
concetti percettivi: l’incontro visione-concetti
sulla base della natura e della funzione dei concetti e del pensare: “Il pensiero è l’immagine logica
del mondo” L. Wittgenstein, Tractatus logico philosophicus;
sulla base della natura della percezione: “percepire consiste nella formazione di concetti percettivi”
R. Arnheim, Arte e percezione visiva. Il bambino riconosce i triangoli (e la triangolarità) prima di
definire il triangolo, i cani (e la caninità) prima di definire il cane
il riconoscimento per sequenze logiche che variano in relazione ai contesti culturali (logiche
multiculturali). Un problema (compito) elementare: mettere in sequenza una torta, un bambino che
piange, un bambino che mangia la torta. Le sequenze…
3.4. il riconoscimento impossibile (Arendt) gli orrori del XX secolo
una testimonianza: «Io ero solita dire che si trattava di qualcosa che non sarebbe mai dovuto
accadere, perché gli uomini non sarebbero stati capaci né di punirlo né di perdonarlo. Infatti non
potremo mai riconciliarci con tale orrore, non saremo mai capaci di venirci a patti come in realtà
dovremmo fare con tutte le cose del passato. [...] Al contrario, con il trascorrere del tempo “quel”
passato ha assunto una tale immagine che a volte siamo tentati di pensare che tutto ciò non avrà fine
finché non l’avremo noi. Quel passato si è rivelato irriducibile a chiunque, e non solo per la
nazione tedesca» (H.Arendt)
la radice filosofica dell’impossibile riconoscimento
il baratro dell’assoluto nulla: «noi, ad un assoluto contrario dell’essere abbiamo già detto addio da
un pezzo, ci sia esso o non ci sia, si possa o anche non si possa darne ragione» (Platone, Sofista,
258e)
3.5. Come sintesi e conclusione problematica operativa: un metodo e un cammino.
un cammino: dal guardare al vedere in conclusione operativa “trasformare lo sguardo in
visione”
concetti e postulati: occorre distinguere tra guardare e vedere «Infatti è possibile guardare
senza vedere… il saper-vedere indica il possesso di una particolare attitudine percettiva…
vedere è fatto complesso e intenso: 1. è un processo attivo … non passiva recezione “Ogni
guardare si muta in un considerare, ogni considerare in un riflettere, ogni riflettere in un
congiungere. Si può quindi dire che noi teorizziamo già in ogni sguardo attento rivolto mondo”
J.W.Goethe 2. vediamo molto più di quanto appare… è in atto un completamento, un
completamento visivo, gestaltico, un completamento nel e del vissuto individuale e sociale,
conoscitivo emotivo 3. il gioco / flusso dal primo piano allo sfondo (alone e viceversa);
come nella coscienza: “il flusso di coscienza non può mai consistere di pure attualità” E. Husserl
esempi e situazioni (eterogenee): così accade
nella pittura: “Il pittore non dipinge quello che vede, ma vede quello che dipinge” Gombrich
in visita ad una mostra: «lo sguardo del visitatore si costruisce su percezioni quasi individuali.
Tuttavia questi modi decostruiti del vedere lasciano vuoti pericolosi … allora il visitatore si
premunisce di apparati di riempimento della propria insanabile crisi e si congiunge con altri
seguendo attento il flusso di parole della guida. Il visitatore diviene un gruppo e sciama serrandosi
con altri sotto la guida di un esperto che ricodifica il suo sguardo secondo canoni interpretativi che
colmano la distanza tra lo sguardo e l’opera» Putti Riccardo, “Gente in mostra” in Grasseni C. 2008
Imparare a guardare.
in una fiera bovina: il ruolo degli esperti e ispettori di razza “formatore dello sguardo”
confronta: le osservazioni dell’opera ultima di Maurice Merleau-Ponty , L’occhio e lo spirito
(1960) un testo scritto in una casa di campagna, in Provenza, dalle cui finestre si poteva
contemplare quel mont Sainte-Victoire, più volte dipinto da Paul Cézanne: simbolo di una radicale
rimessa in discussione ed esame, attraverso la pittura, del meccanismo della visione.]
8
In gioco è sempre la realtà (interna, esterna, intermedia) che è oggetto continuo di riconoscimento.
Attraverso visioni e concetti …e attraverso tutto il contesto o gli intermedi che affiancano immagini
e parole e sono coinvolti nel guardare, nel vedere, nel pensare, nello scoprire… nel riconoscere.
3.01. visione: «Lo sguardo, la visione, strumento che separa, che porta il mondo fuori di noi e,
costruendo le intersezioni tra pensiero soggettivo e datità del mondo, consente il riconoscimento
della realtà.» Come sostenuto nelle tesi di Merleau-Ponty e in quelle contemporanee di LévyStrauss: la visione come attività di riconoscimento del mondo. (Faeta Francesco, Lo sguardo, il
corpo, l’immagine. In Grasseni Cristina (a cura di) 2008 Imparare a guardare. Sapienza e
esperienza della visione, Franco Angeli, Milano, p. 39)
3.02. concetti: il riconoscimento della realtà nella «trasparenza del pensiero, che può pensare una
cosa solo assimilandola, trasformandola in pensiero» (Faeta o.c. p. 40) e così costruendo in concetti
e teorie “visioni” del mondo.
3.03. la sequenza: 3.1. conoscere è riconoscere (Platone); 3.2. il riconoscimento sensibile (Argo, il
cane); 3.3. il riconoscimento sensibile-concettuale [per visioni concettuali] (Emmaus, i discepoli);
3.4. il riconoscimento impossibile (Arendt e la Germania). Un cammino: dal guardare al vedere.
3.1. conoscere è riconoscere e portare alla memoria: riconoscere (per) pensieri; risvegliarsi alle
(proprie) idee, con arte maieutica (dialogo) e sulla scorta della sensibilità.
«Osservare attentamente vuol dire ricordare con precisione» Edgar Allan Poe, Racconti. Gli omicidi
della rue Morgue, Einaudi, Torino 1983 p. 66
3.1.1. Platone dal dialogo: Menone. Conoscere è riconoscere le forme della mente; come a
segnalare che l’intera conoscenza è riconoscimento; l’intera conoscenza si iscrive dialetticamente
nella coppia di termini: anamnesi e lethe, reminiscenza e oblio.
«L’anima, dunque, poiché immortale e più volte rinata, avendo veduto il mondo di qua e quello
dell’Ade, in una parola tutte quante le cose, non c’è nulla che non abbia appreso. Non v’è, dunque,
da stupirsi se può fare riemergere alla mente ciò che prima conosceva della virtù e di tutto il resto.
Poiché, d’altra parte, la natura tutta è imparentata con se stessa e l’anima ha tutto appreso, nulla
impedisce che l’anima, ricordando (ricordo che gli uomini chiamano apprendimento) una sola cosa,
trovi da sé tutte le altre, quando uno sia coraggioso e infaticabile nella ricerca. Sì, cercare ed
apprendere sono, nel loro complesso, reminiscenza [anamnesi].» Platone, Menone 81 c-d
Conoscere è ricordare, portare alla memoria, ricostruire e mettere in azione la memoria interiore. In
questo contesto Platone colloca l’arte e la funzione del dialogo; una tecnica filosofica che porta
ciascuno a far affiorare alla mente, in modo assolutamente personale, il patrimonio di forme mentali
di orientamento nella realtà, è l’arte della conoscenza attuata in forma maieutica. Si tratta di un
apprendimento che è sollecitato dall’esperienza sensibile, quale motore per alcuni aspetti esterno,
ma che si attiva in un procedimento interno, nella memoria interiore e non nasce per
indottrinamento o convinzione dall’esterno. La conoscenza è sempre un riconoscimento; del resto
ogni tappa riprende e ridefinisce quelle precedenti collocandole in un contesto di significato e di
conoscenza nuove, in un ricordare che è riprendere, riconoscere di nuovo e ridefinire.
3.1.2. Platone dal dialogo: Repubblica; il Mito di Er. Riconoscersi vivendo.Vivere è riconoscere la
propria natura.
«Dopo che tutte le anime avevano scelto le rispettive vite, si presentavano a Lachesi nell’ordine
stabilito dalla sorte. A ciascuno ella dava come compagno il demone che quegli s’era preso, perché
gli fosse guardiano durante la vita e adempisse al destino da lui scelto. [...] Dopo che anche gli altri
erano passati, tutti si dirigevano verso la pianura del Lete in una tremenda calura e afa. [...] Al
calare della sera, essi si accampavano sulla sponda del fiume Amelete, la cui acqua non può essere
contenuta da vaso alcuno. E tutti erano costretti a berne una certa misura, ma chi non era frenato
dall’intelligenza ne beveva più della misura. Via via che uno beveva, si scordava di tutto. Poi
s’erano addormentati, quando, a mezzanotte, era scoppiato un tuono e s’era prodotto un terremoto: e
9
d’improvviso, chi di qua, chi di là, eccoli portati in su a nascere, ratti filando come stelle cadenti.»
Platone, Repubblica 620e-621b.
3.2. il riconoscimento sensibile (riconoscere per visioni; la prospettiva è: dal guardare al vedere)
3.2.01. Un’osservazione preliminare che deve essere richiamata a marcare la differenza tra guardare
e vedere: tutti guardano, non tutti vedono o non necessariamente vedono le stesse cose; basta
pensare a un’opera d’arte, a un’espressione algebrica scritta per un non matematico, a un testo
scritto in cinese per chi non conosce la lingua, a lastre radiografiche per chi non è medico e, in
realtà, a tutti gli oggetti del vivere quotidiano cui si presti un minimo di attenzione e che sono dati
all’uso. Il vedere presuppone orientamenti abitudinari, di tipo percettivo e concettuale, che
permettono di notare ed entrare in relazione con ciò che il semplice guardare non permette di
vedere.
3.2.02. Un altro dato di partenza: la percezione è «intrinsecamente relazionale» quindi sede naturale
e immediata di riconoscimento. Sarà graduale, dinamico, incerto e progressivo, ma la sua
intenzionalità è collocata nel riconoscimento. Rovesciando la sequenza: il riconoscimento è
questione di sguardi.
3.2.03. Intenzionalità e trasparenza del percepire: un formalizzatore non avvertito, immediato,
solitamente non problematizzato. «L’introspezione ci insegna che l’esperienza è trasparente. Detto
in altre parole, quando ci concentriamo sulle nostre esperienze, noi vediamo attraverso di esse, e
cioè ci rappresentiamo le qualità delle cose o, come possiamo anche dire, ci rappresentiamo il modo
in cui le cose si presentano e non il modo in cui le esperienze si presentano. […] La loro natura
rappresentazionale è, cioè, ciò che rende conto della loro intenzionalità.» (Calabi Clotilde 2009
Filosofia della percezione, Laterza, Roma-Bari, p.42,43) La natura intenzionale della percezione,
cioè il suo rimandare al percepito con immediatezza, è ciò che rende la percezione “trasparente” (e
proprio in forza della trasparenza è intenzionale, altrimenti richiamerebbe l’attenzione su di sé
presentandosi come oggetto e non svolgerebbe la funzione di rimando, o di percezione, che ne
costituisce l’essenza e la funzione). Ne consegue che, in quanto “trasparente” e perciò intenzionale,
nel guardare e nello stesso vedere non vediamo l’esperienza che decide dei modi del nostro
percepire. Il mezzo del vedere è nascosto alla nostra attenzione dall’oggetto della visione e, in tal
modo, non si porta all’attenzione e non si mette a tema l’incidenza che il mezzo ha nel determinare
la visione e l’oggetto d’esperienza.
3.2.04. Tanto per richiamare la complessità della questione e il dibattito che la sorregge: le ipotesi.
«Limitandoci al caso del vedere, non potrebbe esserci un riconoscimento soltanto visivo e, più in
generale, un riconoscimento intrinsecamente percettivo che non richiede alcuna capacità di
classificazione e dunque non richiede applicazione di concetti? Naturalmente, bisogna spiegare che
cosa sia il riconoscimento visivo. In alternativa, si potrebbe sostenere che è possibile vedere un
oggetto senza che sia necessario riconoscerlo. Come al solito, i filosofi si dividono.
Questo capitolo è diviso in tre parti. Nella prima parte introduco la teoria T1, secondo la quale c’è
un tipo di vedere che è indipendente dal riconoscimento (in qualunque forma). T1 distingue fra
questo tipo di vedere e il vedere che ha luogo attraverso un riconoscimento che passa attraverso i
concetti (per questa teoria il riconoscimento passa necessariamente attraverso i concetti). Nella
seconda parte, dopo aver illustrato un’obiezione a T1, presento T2, secondo la quale non ci può
essere vedere in assenza di classificazioni concettuali: per T2 il riconoscimento concettuale è
condizione necessaria del vedere. Nella terza parte, dopo aver esposto due argomenti contro T2,
introduco la teoria T3, che dice che il vedere richiede una qualche forma di riconoscimento di ciò su
cui verte e un certo grado d’attenzione, ma il riconoscimento non passa necessariamente attraverso
concetti e l’attenzione può essere molto debole. Le obiezioni contro T1 e T2 mi porteranno a
concludere che T3 è la teoria migliore.» (Calabi 2009 o.c. p.82-83)
3.2.1. questioni di mimetismo, di riconoscimento e di sopravvivenza nell’immediato percepire.
La storia dell’insetto e del tordo è una storia di mimesis. Il primo deve mimetizzarsi se vuole
sfuggire alla cattura (sopravvivere), il secondo deve smontare la mimetizzazione se vuole catturare
10
la preda (sopravvivere). La mimesis e il suo contrario, il riconoscimento, sono quindi
biologicamente l’arte del sopravvivere (e forse la base e il contesto per il sopravvivere dell’arte; si
può tornare a pensare, come voleva la tanto criticata teoria di Platone, che la mimesis sia l’essenza
dell’arte e il suo intrinseco dinamismo, visto che ogni mimesis è avvicinamento senza termine e
finalmente destinata all’insuccesso, a restare altro da ciò che imita.)
La storia… «Ma quel giorno, per ragioni ascrivibili all'equilibrio della natura, un attimo prima che il
tordo sbucasse da quel tunnel, l'insetto foglia fece in tempo ad assumere la forma e i colori della
foglia su cui posava, risultando così invisibile proprio all'occhio dallo sguardo infallibile...
La vita dell'insetto, quanto quella del tordo, dipende dai loro due modi di vedere finalizzati al
rilevamento di due differenti cose nel medesimo percetto: il modo di vedere dell'insetto è finalizzato
a far scomparire il proprio corpo nell'immagine della foglia, quello del tordo a separare il corpo
dell'insetto dall'immagine della foglia. Per molte specie il colore è uno strumento decisivo nella
lotta per la sopravvivenza. La natura dipinge immagini il cui significato è di vitale importanza per
gli esseri vedenti. Spesso si omette che la mimesi e i concetti di somiglianza, analogia e similitudine
da essa derivati hanno origine da una funzione biologica e non filosofica o concettuale, come da più
parti si teorizza.» (Di Napoli Giuseppe 2006 Il colore dipinto. Teorie, percezione e tecniche,
Einaudi, Torino p. XIII.)
Il problema del mimetismo è irrisolto nella sua ambivalenza quasi antinomica. Mimetizzarsi per
riconoscersi, acquisire e darsi una forma (come accade nei processi educativi: una lunga e sofferta
storia di mimesis) o per evitare il riconoscimento (in un perenne carnevale)? La capacità mimetica
(insetto) come il suo riconoscimento (tordo) diventano condizione indispensabile di sopravvivenza
e di adattamento. I processi educativi si affidano fondamentalmente e prioritariamente ad esercizi di
mimesis. Al buon esito di questi esercizi si attribuisce il riconoscimento e giudizio di ammissione
alla socialità e alla normalità; lo stesso riconoscimento di genialità / creatività è formulabile in
termini di variazione nei confronti e sullo sfondo di prestazioni considerate normali (imitative o
confermative).
3.2.2. questioni di professione e di apprendimento: le skilled visions (sguardi professionali).
Un esperimento “quotidiano” accade, ad esempio, per il visitatore di una mostra: «Lo sguardo del
visitatore dunque si costruisce su percezioni quasi individuali. Tuttavia questi modi decostruiti del
vedere lasciano vuoti pericolosi nell’esperienza soggettiva dell’opera e allora il visitatore si
premunisce di apparati di riempimento della propria insanabile crisi e si congiunge con altri
seguendo attento il flusso di parole della guida. Il visitatore diviene un gruppo e sciama serrandosi
con altri sotto la guida di un esperto che ricodifica il suo sguardo secondo canoni interpretativi che
colmano la distanza tra lo sguardo e l’opera» (Putti Riccardo, “Gente in mostra”: una riflessione tra
spazi, corpi e sguardi, in Grasseni Cristina (a cura di) 2008 Imparare a guardare. Sapienza e
esperienza della visione, Franco Angeli, Milano, p.111), ma anche in esperimenti di laboratorio ove
il docente, ad esempio chirurgo, guida gli studenti a vedere… e in una bottega di falegname ecc.
Gli studi della Skilled Visions [skilled: specializzato, qualificato, professionale; skilled vision:
sguardo professionale], lo studio quindi sulla “competenza dello sguardo”, condotti secondo una
prospettiva multidisciplinare (ecologia della pratica quotidiana, ad esempio negli studi etnografici
su cacciatori, sugli artisti del travestitismo nei locali drag queen di Verona, neuroscienze, medicina,
per esempio sulla produzione e lettura di immagini di risonanza magnetica del cervello confrontata
con lo sguardo all’opera del neurochirurgo, sull’apprendistato dei radiologi nella lettura delle lastre
topografiche, architettura e urbanistica ecc.) e «intesa ecologicamente, cioè come investigazione su
come si strutturano gli ambienti di apprendimento e di saper fare in relazione alla competenza
visiva, in diversi ambiti conoscitivi e professionali», portano a sottolineare alcune costanti, pur nelle
loro differenze attuative:
3.2.2.1. la «socializzazione dell’apprendimento dello sguardo professionale, nell’interazione con
diversi tipi di artefatti e di contesti di pratica esperta.» (Grasseni Cristina (a cura di) 2008 Imparare
a guardare. Sapienza e esperienza della visione, Franco Angeli, Milano, p. 10; un testo di bilancio e
di guida al tema)
11
3.2.2.2. «la tesi che lo sguardo esperto risulta essere una tecnica sofisticata, …risultato di un lungo
addestramento effettuato grazie a strumenti materiali [come le tavole comparative di Linneo nel
caso del naturalista], e alla assidua frequentazione del campo sottoforma di lunghi apprendistati
dell’occhio (Bleichmar, 2007). (Grasseni 2008 o.c. p.10)
3.2.2.3. lo sguardo (il guardare e vedere) è coinvolgimento totale: «Se lo sguardo è una «tecnica del
corpo» (Mauss, 1936), imparare a guardare significa coinvolgere sensi ed emozioni in un saper fare.
L’idea dell’apprendistato di sguardi competenti rimanda a vere e proprie “scuole dello sguardo”,
che ci riguardano tutti, permeando ogni aspetto della vita quotidiana, professionale, artistica,
estetica... Come guarda il mondo un artista? O un visitatore di una galleria d’arte? Come le nostre
storie determinano i nostri sguardi sul mondo?» (Grasseni 2008 o.c. p.11)
3.2.2.4. una diversità di paradigmi teorici: «Porre il problema degli sguardi esperti in relazione
all’ecologia della visione in una prospettiva antropologica richiede però necessariamente un
confronto con i diversi paradigmi teorici relativi all’inculturazione della visione, alla lettura
culturale delle immagini e alla diversità dell’apprendistato della competenza in diverse culture
visive.» (Grasseni 2008 o.c. p.11) Emblematico è il racconto di P. Odifreddi, riportato in apertura.
3.2.2.5. la percezione sinestetica: «… la nuova e ormai radicata sensibilità per la visione sinestetica
e la sua capacità di rendere olisticamente un senso di realtà. Lo sguardo è pratica di un corpo dotato
di un sensorium complesso, non analiticamente distinto in compartimenti stagni, ma fatto di
capacità tattile fine, di udito, olfatto... Rispetto a ciò, il documento visivo rende un’ampia gamma
inespressa di percetti di confine, visivi, ma anche sonori, tattili etc.» (Grasseni 2008 o.c. p.12)
3.2.2.6. una pluralità di sguardi in contemporanea: «… riabilitazione della visione basata sulla presa
d’atto che esistono molte forme dello sguardo, molte forme del vedere: una pluralità delle forme e
del senso degli sguardi competenti, abili, sapienti...» (Grasseni 2008 o.c. p.12) Un esempio
applicato all’oggetto (nel caso un fuso in legno) «Se interroghiamo visivamente lo stesso oggetto,
quindi, esso parla a noi in maniera diversa a seconda delle nostre storie di vita, delle nostre
(multiple) appartenenze a diverse «comunità di pratica» (Wenger, 1998). Vediamo l’ostentazione di
uno stesso oggetto, ma mentre per uno di noi esso può apparire in tutta la sua quotidiana
funzionalità, per un altro esso può solo avere rimandi letterari e fiabeschi (da Shakespeare alla Bella
Addormentata nel Bosco). [un altro esempio] nelle mostre bovine e nelle visite alle stalle dove il
ruolo degli esperti e degli ispettori di razza diventa quasi di “formatore dello sguardo” degli astanti.
Nel setting particolare delle mostre bovine la valutazione dei capi di allevamento è
fondamentalmente «una questione di sguardi» (Berger, 1972), ovvero di una professionalità della
visione…» (Grasseni 2008 o.c. p.14)
Concludendo in sintesi e conferma: «Pur guardando tutti la stessa cosa, oltre a vedere sotto certi
aspetti effettivamente la medesima cosa, per molti altri essa ci mostra un’ulteriore e non meno vasta
gamma di informazioni visive che solo occhi allenati riescono davvero a vedere. L’occhio può
essere addestrato al conseguimento di particolarissime capacità, tali da costituire in alcuni settori
delle vere e proprie competenze professionali”: basti guardare nell’ambito della medicina le diverse
strumentazioni utilizzate nelle indagini diagnostiche, dalla radiografia ai raggi X, alle ecografie, agli
ultrasuoni …» Di Napoli Giuseppe 2004 Disegnare e conoscere. La mano, l’occhio, il segno,
Einaudi, Torino p. 85
«L’esperto e il novizio vedono cose diverse, ed esperti diversi vedono per essi in modo diverso»
Arnheim Rudolf 1969 Il pensiero visivo. La percezione visiva come attività conoscitiva, Einaudi,
Torino 1974 p. 354
Sono illuminanti le osservazioni dell’opera (ultima) di Maurice Merleau-Ponty (1908-1961),
L’occhio e lo spirito, scritto nel 1960 (Merleau-Ponty muore nel 1961). Un testo scritto in una bella
casa di campagna, in Provenza, dalle cui finestre si poteva contemplare quel mont Sainte-Victoire,
più volte dipinto da Paul Cézanne (1839-1906), che resterà come simbolo di una radicale rimessa in
discussione ed esame, attraverso la pittura, del meccanismo della visione (in ripresa continua del
tema e della visione realizzata soprattutto dal 1883-1887).
12
3.3. il riconoscimento per visione concettuale (in forma di incontro tra visione e concetti) o «il
pensiero visivo»
3.3.01. il passaggio: “dal cogliere una data struttura attraverso la pura percezione” il passaggio alla
ricerca di strutture organizzative. «Varrà qui la pena menzionare una differenza decisiva tra il
cogliere una data struttura attraverso la pura percezione e una problem situation nel senso più
ristretto del termine. Nella semplice percezione, il problem-solving si limita a trovare la struttura
inerente negli stimoli. L’osservatore si trova di fronte a un compito più difficile quando una
situazione si presenta organizzata in un modo che occulta le connessioni necessarie per arrivare a
una soluzione. A volte una mancanza di ordine e di unità nel dato percettivo fornisce l’incentivo
alla ricerca. In altri casi, una incongruenza tra il percetto così come si presenta e l’immagine della
situazione finale da raggiungere genera una tensione che preme verso la soluzione. L’atto di
ristrutturare può consistere semplicemente nel guardare in modo diverso alla situazione, o può
richiedere una effettiva ridisposizione delle componenti. La ristrutturazione di una Gestalt è
un’attività eminentemente dinamica delle forze di campo, ma lo stesso si può dire di ogni
strutturazione. In effetti, una struttura, per definizione, non cessa mai di essere una costellazione di
forze. Proprio come un pattern sociale apparentemente stabile, un gruppo familiare per esempio,
rimane sempre un raggruppamento più o meno equilibrato di varie forze motivazionali, così un
pattern percettivo, un pezzo di musica o un quadro vengono colti come un sistema di vettori
variamente diretti.» Arnheim Rudolf 1992 Per la salvezza dell’arte, Feltrinelli, Milano 1994,p.246
3.3.02. per fare chiarezza fin dall’inizio. «C’è una veneranda teoria filosofica, la Teoria dei dati
sensoriali…, secondo la quale l’esperienza fornisce dei dati che, poi, l’intelletto organizza sotto
forma di pensieri e di credenze. Per quanto veneranda, la teoria è sbagliata di sana pianta
(perlomeno, sono in molti a pensare che lo sia), ma non è la sola a essere sbagliata perché l’errore
che la vizia colpisce qualunque teoria dica che l’esperienza percettiva è il primo stadio di un
processo a due stadi in cui il soggetto riceve dell’informazione dall’ambiente. Poi concettualizza
l’informazione di cui dispone. […] …l’esperienza percettiva, per avere autorità sulle credenze e
cioè per poterle giustificare, deve avere anch’essa un contenuto che può essere intrattenuto solo da
un soggetto che possieda concetti. Calabi Clotilde 2009 Filosofia della percezione, Laterza, RomaBari p. 99,100
3.3.03. come premessa 1: la doppia sede della pluralità dello sguardo e del conseguente
riconoscimento: a) il soggetto, per “il doppio radicamento dei meccanismi della visione alle
dinamiche corporali e sociali” (Grasseni 2008 o.c. p.21); b) l’oggetto: “lo stesso identico oggetto in
uno stesso contesto culturale cambia statuto di oggettualità: da oggetto a icona, da icona a
fantasma…” (Grasseni 2008 o.c. p.22)
3.3.04. come premessa 2: i concetti sono la nostra “immagine logica del mondo” Wittgenstein
3.3.1. l’incontro visione-concetti sulla base della rappresentazione. (I. Kant)
«…non si può negare che non tutte le rappresentazioni — ed è Kant stesso ad ammetterlo —
possano venire ricondotte a concetti (empirici o logici): si tratta, di conseguenza, di radicare questo
“al di là” [della visione, l’invisibile o l’indicibile della visione] non in giochi linguistici del pensiero
con se stesso, ma nelle rappresentazioni stesse o, meglio, nell’esperienza che di esse abbiamo e
nelle forme che a tale esperienza vengono date. Esperienza che, di fronte a specifici orizzonti che
mettono in gioco, in essa, atti che hanno nelle funzionalità corporee il loro radicamento, rivela la
stratificata complessità del rapporto conoscitivo tra il “sentire” e il “pensare” […] … le immagini
“fanno pensare” anche quando non conducono ad un concetto o a una “forma”. Ovvero: il nostro
pensiero, il pensiero del senso comune, ha nel come se dell’immaginazione simbolica il modo per
“apparire” senza le costruzioni fantastiche della metafisica, rivelando una “priorità” dell’esperienza
in modo molto più efficace di qualsivoglia sua concettualizzazione. […] Questo è il contesto per
affrontare o vedere delinearsi un possibile orizzonte veritativo per le immagini; o la verità
(specifica) dell’immagine; attività veritativa che attesta cioè un senso del mondo prima – e certo
non “contro” le sue caratterizzazioni ontologiche.» Franzini Elio, Immagine e pensiero, in
13
Lucignani Giovanni, Pinotti Andrea 2007 (a cura di) Immagini della mente. Neuroscienze, arte,
filosofia, Raffaello Cortina, Milano, pp.148, 152, 153.
3.3.2. l’incontro visione-concetti sulla base dei concetti, del pensare. (L. Wittgenstein)
Il pensiero è l’immagine logica del mondo. Infatti. Noi ci facciamo immagini dei fatti; il pensiero è
l’immagine logica dei fatti; la nostra percezione del mondo è una percezione logico-concettuale; ne
consegue che la totalità dei pensieri è l’immagine del mondo. Si può ulteriormente ribadire
l’efficacia dell’affermazione “immagine logica del mondo” riferita alle teorie, se si pensa che
nessuna definizione logica è possibile senza schemi (senza schematismi), che all’immaginazione
fanno riferimento.
3.3.2.1. Uscire dall’errore delle tradizioni antropologiche dualistiche. Antonio Damasio, nell’opera
L’errore di Cartesio, denuncia il dualismo metafisico tra estensione e pensiero (corpo e anima) da
lui teorizzato in quanto ritenuto indispensabile per poter giungere a idee chiare e distinte.
«…l’opposizione di mente e corpo definita da Cartesio, è ciò che — ironicamente — proprio le
neuroscienze mettono ora in dubbio: la razionalità in quanto tale è emotiva, il pensiero logico
dell’uomo che pensa, vuole e sceglie è incarnato. Una ragione pura, astratta dalla materialità del
corpo e dell’ambiente naturale e sociale, priva di contraddizioni, impermeabile alle sollecitazioni di
emozioni e contesti, produrrebbe secondo il neurobiologo Antonio Damasio un’intelligenza
patologica e strategie di vita incoerenti» (Cappelletto Chiara 2009 Neuroestetica. L’arte del
cervello, Laterza, Roma - Bari p. 5.) La tradizione di Cartesio era antica e autorevole, radicale è ora
il cambiamento: «Se per Platone il corpo era la tomba dell’anima, ora ne sembra piuttosto la culla, e
questo consentono di capirlo almeno Vico, i teorici dell’arte tedeschi, i fenomenologi francesi che
lo hanno descritto come trascendentale incarnato, mostrandone i rapporti sensibili con il mondo,
che a sua volta è fatto di corpi prima che di percetti.» (Cappelletto 2009 o.c. p. 155). Ribaltamento e
cammino di riconoscimento, anche concettuale, della realtà che va affidata proprio all’immagine,
alla visione e all’arte come sede specifica di produzione dell’immagine e della visione, se l’arte non
è mimesi. «… sarebbe anzi proprio l’aspetto sorprendente e inusuale dell’opera a provocare una
risposta che altrimenti manca all’uomo abituato alle regolarità del proprio ambiente: l’opera deve
disabituare, distanziare, straniare, creando quel paradossale sistema di inesauribile sorpresa che è
l’arte stessa, dato il quale si può tentare l’avventura del riconoscimento.» (Cappelletto 2009 o.c. p.
108)
3.3.2.2. visione e concetti, analisi verbale e comprensione intuitiva
«Un …pregiudizio vuole che l’analisi verbale possa paralizzare la creazione e la comprensione
intuitive. […] Il delicato equilibrio di tutte le nostre facoltà – che unico ci permette di vivere in
maniera piena e di lavorare bene – viene turbato non solo quando l’intelletto interferisce con
l’intuizione ma anche quando il sentimento sfratta il ragionamento. Un’orgia di autoespressione non
è più produttiva che una cieca obbedienza alle regole.» (Arnheim Rudolf 1954 Arte e percezione
visiva, Feltrinelli, Milano 200611 p. 24, 25) «Sono gli stessi principi ad operare nelle più svariate
qualità mentali perché la stessa mente funziona come un tutto. Ogni percezione è anche pensiero,
ogni ragionamento è anche intuizione, ogni osservazione è anche invenzione. […] … fu una
salutare lezione la scoperta che la visione non è soltanto una registrazione meccanica di elementi,
ma l’afferrare strutture significanti. E se ciò era vero per il semplice atto di percepire un oggetto,
tanto più doveva valere anche per l’approccio artistico alla realtà. L’artista, ovviamente, si rivelava
tanto meno un semplice registratore meccanico quanto meno lo era il suo organo della vista. Era
ormai impossibile pensare alla rappresentazione artistica come ad una trascrizione pedissequa di
apparenze accidentali, eseguita particolare per particolare; in altre parole si era trovato un appoggio
scientifico alla convinzione crescente che le immagini della realtà possono essere valide anche se
sono assai discoste da ogni somiglianza “realistica.” (Arnheim R. 1954. p. 27)
3.3.2.3. “Concetti percettivi” «… la somiglianza di triangoli diversi per dimensione, orientamento e
colore, si considerava passibile di riconoscimento solo da parte di osservatori il cui cervello fosse
abbastanza maturo da aver enucleato il concetto generale di” triangolarità” fuori dalla immensa
varietà di osservazioni individuali. Di conseguenza il fatto che bambini molto piccoli e animali non
14
allenati a un genere di pensiero logico astratto, potessero eseguire tali compiti senza difficoltà, destò
sorpresa e lasciò sconcertati. Tali risultati sperimentali richiedevano un completo capovolgimento
della teoria della percezione. Non sembrava più possibile considerare la visione come se questa
procedesse dal particolare al generale. Al contrario, divenne evidente che le configurazioni
strutturali essenziali costituiscono i dati primari della percezione, sicché la “triangolarità” non è già
il prodotto successivo d’un processo astrattivo intellettuale, ma un’esperienza diretta e più
elementare che non la registrazione di particolari individuali. Il fanciullo vede (e afferra) la
“caninità” prima ancora di essere in grado di distinguere un cane dall’altro. […] Se ciò che
abbiamo testé affermato è corretto, saremo costretti a dire che il percepire consiste nella formazione
di “concetti percettivi.” Ad un normale modo di pensare questa terminologia apparirà alquanto
spiacevole, giacché di solito si considera che i nostri sensi siano limitati a dati concreti, mentre i
concetti hanno a che fare con dati astratti. Sia ben chiaro, peraltro, che l’uso che qui si fa della
parola “concetto” non dovrà in alcun modo suggerire che l’atto di percepire sia un’operazione
intellettuale. I processi che sono stati descritti devono essere considerati come aventi luogo entro
l’apparato visivo. L’uso, dunque, di questo termine dovrebbe indicare che c’è una sorprendente
somiglianza tra le attività elementari dei sensi e quelle più elevate del pensiero o del ragionamento.
[…] La percezione compie ad un livello sensoriale, ciò che, nel campo del ragionamento, si indica
come “comprensione.” L’atto di vedere d’ogni uomo, inoltre, anticipa in forma modesta, quella
tanto ammirata capacità dell’artista di creare degli schemi che siano in grado di dare
un’interpretazione all’esperienza attraverso forme organizzate. Ogni visione esteriore comprende
anche una visione interiore.» (Arnheim R. o.c. p. 57-59)
3.3.2.4. riconoscimento secondo sequenze logiche che variano in relazione ai contesti culturali
(logiche multiculturali) «Racconta una maestra di aver mostrato ai bambini di paesi diversi tre
immagini - una torta, un bambino che piange e un bambino che mangia la torta – chiedendo loro di
metterli in sequenza. I bambini italiani hanno messo il bambino che piange dopo aver mangiato la
torta, col mal di pancia, perché ha mangiato troppo; i bambini di altri paesi hanno indicato prima il
bambino che piange perché ha fame, poi la torta e infine il bambino che ride. L’insegnamento che
se ne ricava è che non c’è errore, da parte di nessuno. Si tratta di punti di vista diversi, ugualmente
legittimi. La definizione del concetto di errore in un contesto interculturale è la prima cosa che i
bambini e la maestre hanno appreso assieme». Amoroso Bruno 2009 Per il bene comune. Dallo
stato del benessere alla società del benessere, Diabasis, Reggio Emilia, p. 130 (La stessa
situazione accade in società “evolute” quando le sequenze, che riprendono luoghi e pregiudizi
diffusi, cadono in situazioni di “usteron – proteron”).
Si tratta, in generale, di sequenze che determinano la differenza tra un fenomeno reale e lo stesso
fenomeno “percepito” (dal caldo, alla sicurezza, fiducia, povertà…). Non è qui in questione l’errore
ma il diverso riconoscimento e le conseguenti diverse scelte pratiche.
3.4. il riconoscimento impossibile
3.4.1. le due esperienze richiamate
3.4.1.1. Hannah Arendt, nel drammatico tentativo di fare i conti con «quel passato che non passa»
che ancor oggi, a mezzo secolo di distanza, costituisce il doloroso e inquietante rovello dell’identità
e della coscienza tedesche: «quando ripenso agli ultimi vent’anni, ho la sensazione che questa
questione sia stata posta in sottordine, potremmo dire “in sonno”, da qualcosa di cui è davvero
molto difficile parlare e con cui è quasi impossibile venire a patti, ossia l’orrore puro, nella sua nuda
mostruosità.» (Arendt Hannah 1950 Ritorno in Germania)
3.4.1.2. Leopold Auberg (in Müller Herta 2009 L’altalena del respiro, Feltrinelli, Milano 2010)
Richiama l’esperienza dei suoi cinque anni (dai 17 anni) a causa della deportazione della minoranza
rumeno-tedesco nei campi di lavoro forzato dell’Ucraina organizzata dai sovietici: «Perciò devo
parlare del mio intero teschio come di un territorio, del territorio di un Lager. Impossibile
proteggersi, né con il silenzio né con il racconto. Si esagera nell’uno come nell’altro…».
15
3.4.2. la radice filosofica. Platone esprime la necessità di collocare il non-essere tra i generi sommi
del pensiero e della realtà, sostenendo la “contraddizione” presente nel dire che il non-essere è e
contravvenendo drammaticamente alle tesi originarie della filosofia greca espresse da Parmenide.
La scelta coraggiosa permette la scoperta e la difesa dell’identico e del diverso, del moto e della
quiete, della possibilità di distinguere tra le realtà, i concetti, i principi (bene, male; vero, falso …).
Il passo è pluricitato: «Forestiero. E noi invece non solo abbiamo dimostrato che il non essere è, ma
del non essere abbiamo chiarito anche la forma che lo costituisce, perché dopo di aver dimostrato
che la natura del diverso è, e si trova sminuzzata per tutti quanti gli esseri nei rapporti reciproci; di
ciascuna particella di essa, che si contrapponga all’essere abbiamo avuto l’audacia di dire che
questa per l’appunto è realmente il non essere.» Sofista 258 b-d
In questa stessa sede emerge però la scelta altrettanto radicale di “dare addio” al non-essere inteso
come un assoluto, all’“assoluto nulla”; situazione che comporterebbe la totale distruzione del
pensiero e della realtà. Nel dialogo Sofista, presentando il non-essere tra i generi sommi, Platone
esprime infatti questa importante e fondamentale segnalazione o precisazione. «Nessuno ci obietti
che noi, pur dichiarando il non essere come il contrario dell’essere, osiamo dire che è. Giacchè noi,
ad un assoluto contrario dell’essere abbiamo già detto addio da un pezzo, ci sia esso o non ci sia, si
possa o anche non si «possa darne ragione» (Sofista, 258e) Il non essere di cui parla Platone,
collocato tra i generi sommi (in quanto uno dei cinque generi sommi) non si caratterizza come
l’assoluto contrario dell’essere esistente in sé, come il puro nulla, ma come quel non-essere che
sancisce la singolarità e identità di ogni realtà di cui si predica l’essere, indicandone con ciò anche
la differenza e alterità nei confronti di ogni altra singolarità determinata. Ma la questione del Nulla,
come assoluto contrario dell’Essere, filosoficamente si è posta e ricompare in un altro contesto
all’interno di un altro percorso di riflessione. Nel dialogo Parmenide, compare il pensiero del non
essere come assoluto contrario dell’essere, come idea che rivendica un “di per sé” e, nel proprio
riscontro etico, l’idea del nulla fa emergere l’ipotesi del male come assoluto. Se di ogni realtà
visibile vi è un modello ideale (universale e come essenza) che permette di conoscere e definire il
reale individuale, e se quell’ideale, in quanto principio, costituisce una realtà in sé, assoluta
(kath’autò), allora esiste anche lo “squallore in sé”, la “sporcizia in sé” ecc. Squallore, sporcizia,
sconfitta e “ogni altra cosa di natura vile e spregevole al massimo grado” esistono “in sé”, fanno
parte del mondo ideale, esistono nella loro gratuità e quindi come assolutamente ingiustificati e
ingiustificabili (senza alcuna ragione, ma fonte dei possibili ragionamenti), esistono come principi.
In questo contesto, di fronte ad una simile ipotesi, compare il senso di totale smarrimento, vertigine,
orrore della follia espresso dal giovane Socrate di fronte a Parmenide “venerando e terribile”. «mi
tormentò già una volta il pensiero che ciò fosse estensibile universalmente. Ma se appena mi
adagio in quest’opinione, subito ne rifuggo per il timore di perdermi, precipitando in un abisso di
stoltezza...» Ma è solo un istante: «è perché sei ancora giovane» replica Parmenide, «e la filosofia
non ti ha ancora preso come prevedo che ti prenderà in futuro, quando non avrai più ribrezzo per
nessuna di queste cose”» (ripreso da Agamben Giorgio, L’idea della scrittura, Quodlibet, Macerata
2002 p.67-68).
Hannah Arendt presenta il totalitarismo come il “male assoluto”. Assolutezza che si impone di
fronte alla esperienza della assenza di concetti e di parole per definire l’esperienza vissuta di fronte
alla distruzione totale gratuita individuale e sociale. Esperienza della shoah che persiste, è sempre
presente e non si lascia raccontare; di essa non è possibile il riconoscimento, perciò resta
inamovibile, tragicamente sempre presente, non si consegna, nella parola e nel riconoscimento, al
ricordo come se fosse un semplice passato.
3.5. un cammino: la differenza e il passaggio dal guardare al vedere
3.5.01. un caso specifico: la voce delle immagini. «…le immagini non parlano da sole: dietro il loro
saper parlare a noi sta tutta l’abilità (skill) della nostra capacità di guardare. L’antropologia della
visione quindi lavora sul radicamento delle immagini nel loro contesto percettivo e sulla mutabilità
di questo rispetto alle locali e specifiche condizioni del contesto sociale. L’ampia nozione di skill
16
rimanda a quella di conoscenza tacita sotto le molte spoglie di sapere incorporato, saper fare,
fabrilità, apprendimento mimetico...» (Grasseni 2008 o.c. p.11) «È proprio dell’esperienza
dell’antropologo (come anche dell’apprendista) provare stupore e straniamento, non saper vedere
cosa realmente accade. Sottoporsi a un apprendistato dello sguardo significa anche subire un
apprendistato culturale, di ruoli e relazioni socializzate — detto altrimenti, per “trasformare lo
sguardo in visione”, occorre “acquisire forme di conoscenza pregiudiziale” (Faeta, 2003, p. 21).»
(Grasseni 2008 o.c. p.12) «E, soprattutto, poiché le immagini non parlano da sole, o almeno,
parlano e ci parlano soltanto a partire dalla nostra condizione e capacità di visione, che cosa accade
di esse, a cosa si accede di esse e con esse allorché le si osserva? Le immagini, infatti, implicano
necessariamente la storia culturale dello sguardo, implicano necessariamente la storia materiale e
culturale della grammatica come della sintassi di chi filma: lo stile come progetto volontario e
involontario di restituzione e conoscenza antropologica, così come la storia culturale dello sguardo
della comunità dei vedenti. Delle diverse comunità di spettatori. (Marabello Carmelo, Tra segni e
senso. La storia, le storie, lo sguardo, in Grasseni 2008 o.c. p.43-44)
3.5.1. occorre distinguere tra guardare e vedere. «Infatti è possibile guardare senza vedere
(possiamo volgere lo sguardo su qualcosa e pensare ad altro), ma non è possibile vedere senza
pensare a quel che si vede, poiché il vedere è già in sé un atto mentale, un fenomeno di coscienza,
dal quale non ci possiamo separare per essenza.» Di Napoli Giuseppe 2004 Disegnare e conoscere.
La mano, l’occhio, il segno, Einaudi, Torino p. 75
«Il saper-vedere indica il possesso di una particolare attitudine percettiva in virtù della quale il
visibile appare sempre foriero di una incipiente visibilità, che si mostra come tale solo a chi ha
sostenuto un chiaro e mirato addestramento finalizzato al rilevamento di ciò che agli occhi dei più
non appare visibile.» (Di Napoli 2004 p. 86) «Ciò che, attraverso l’occhio, entra nel cervello non è
il mondo così com’è, cosa del tutto priva di ogni possibilità, ma la sua visibilità. Questa funzione
percettiva dell’occhio non è però, come sembra, puramente ricettiva e passiva ma è fin dall’inizio
un processo attivo, selettivo e mirato; quindi strutturato e correlato a specifiche aspettative e
motivazioni.» (Di Napoli 2004 p. 95)
3.5.1.1. un esempio: « La brillante lettura del misterioso Venere e Cupido del Bronzino (National
Gallery di Londra) proposta da Panofsky (Studi di iconologia) è stata seriamente contraddetta da
quella di Maurice Broch, la quale un giorno sarà a sua volta messa in discussione. Ma questo non
conta! Nella storia dell’arte, l’importante non è che le interpretazioni o le teorie siano definitive, ma
che la loro coerenza e la loro pertinenza ci costringano a guardare le opere, a guardarle davvero, e ci
offrano così un’opportunità di farle nostre.» (Di Napoli 2004 p. 86)
3.5.2. vedere è fatto complesso e intenso: «“Il semplice guardare una cosa non ci permette infatti di
progredire. Ogni guardare si muta in un considerare, ogni considerare in un riflettere, ogni riflettere
in un congiungere. Si può quindi dire che noi teorizziamo già in ogni sguardo attento rivolto
mondo” (J.W.Goethe, La teoria dei colori, Il Saggiatore,Milano 1979, p.4). Se il nostro occhio
dovesse «vedere» solo ciò che appare, non solo vedrebbe meno di quanto abitualmente vediamo, ma
cadrebbe molto spesso in valutazioni errate, lavorando paradossalmente di più. In realtà noi
vediamo molto di più di quanto appare. Il vedere non è limitato alle apparenze, ma esprime una
percezione che è già anche immaginazione oltre che riflessione. Visualizzare l’invisibile è rendere
visibile un pensiero formatosi sulle intuizioni del vedere. Il termine «intuito» infatti deriva dal
latino intueri, che significa letteralmente «visione dall’interno», vedere dentro le cose con l’occhio
della mente. La visualizzazione condensa (come fenomeno percettivo) nel proprio vissuto psichico
le inferenze inconsce, i desideri e le idiosincrasie; in una parola, le passioni dello spirito. Ai
mutamenti dell’orizzonte esterno relativi alle prospettive spaziali si impongono adesso i mutamenti
dell’orizzonte interno dovuti alle prospettive temporali dei ricordi (passato) o delle aspettative
(futuro). Ora il campo percettivo è un ritaglio nel mondo, e l’atto percettivo una durata nel tempo
(un ritaglio momentaneo nel continuum della coscienza), che interagendo costituiscono l’unità (il
senso) nella molteplicità. Il visibile non è più di fronte al vedente, ma lo avvolge in una visione
totale e lo sguardo non è più unilaterale, ma irradiante e diffusivo. Il soggetto non si rapporta più in
17
modo orientato con l’esterno, è avvolto dal visibile; può quindi avere una percezione dall’interno di
ciò che è invisibile allo sguardo ottico.» (Di Napoli 2004 p, 76)
3.5.2.1. così accade nella pittura: «“Il pittore non dipinge quello che vede, ma vede quello che
dipinge”, sostiene Gombrich. Questa affermazione enuncia e distingue due differenti accezioni e
funzioni del vedere: 1) ciò che il pittore «non dipinge» è il mondo così come appare ai suoi occhi,
quale oggetto di un «vedere» riferito alla facoltà comune, e condivisa da ogni vedente, di percepire
direttamente e immediatamente le apparenze visibili del mondo esterno, la cui varietà di aspetti e
dovizia di particolari dipendono essenzialmente da due fattori: dalle condizioni ottico-fisiche della
visibilità e dal livello di attenzione prestato dal vedente; 2) di converso alla prima, la seconda
accezione, «il pittore vede quello che dipinge», riferisce un vedere la cui funzione non è più quella
di percepire il mondo esterno, a tutti immediatamente visibile, in questo caso ora ciò che il pittore
«vede» è l’oggetto di un suo pensiero visivo, reso visibile dall’attività pittorica: l’oggetto del suo
vedere è a un tempo anche il prodotto del suo dipingere.
Essendo poi il processo del vedere chiamato a produrre in se stesso e per se stesso l’oggetto
(pittorico) della visione, il fattore più rilevante di questo secondo tipo di vedere è la motivazione.
Giacché se nel primo caso abbiamo un mondo (esterno e collettivo) manifestamente visibile, nel
secondo abbiamo a che fare con un mondo (interno e soggettivo) latente e non vedibile, che si-favedere unicamente mediante l’atto pittorico, mediante cioè uno sguardo ulteriore con cui il pittore
attraversa il velo della visibilità fenomenica per rendere visibile ciò che non è mai frontale né
attuale. Solo allora, come dice Starobinski, il pittore «nasce al destino mirabile che si è inventato: si
offre trionfante agli occhi dell’universo. La sua più alta felicità non consiste solamente né nell’atto
di vedere e neppure nell’energia del fare, poiché è nell’atto complesso di fare-vedere».
Questo far vedere, comunque, questo portare alla visibilità una latenza vedibile è sempre connesso e
intessuto con quel vedere in cui il visto non coincide mai con il visibile; per cui, essendo sempre più
di quanto si manifesti nell’ottica e nella fisiologia dell’occhio, esso è sostanzialmente una
produzione di visione. […] Si comprende allora perché il pittore non rappresenti quello che vede,
ma rappresenti per “far vedere”». (Di Napoli 2004 p, 83,84,85)
«È ampiamente condivisibile il programma che Valéry si era imposto: “il mio problema essenziale,
fu, resta, quello di istituire una scienza dei modi di vedere…a ogni modo di vedere corrisponde un
«mondo» — mondo poetico, pittorico, economico, astronomico – mondano.”» (Di Napoli 2004 p.
99) E ancora: «L’occhio di Klee è un occhio formatore, generatore, produttore di visione, di una
visione intesa come un processo di figurazione, di continua genesi (gestaltung come ricerca della
bildung) di continua apertura all’«intramondo», a quel mondo intermedio a cui Klee dichiara di
appartenere, «il regno tra i morti e i non nati», tra la visione ottica e la «preistoria del visibile»; il
mondo sorgivo della visione. «L’arte non ripete le cose visibili, ma rende visibile». Con questa
frase, divenuta celebre, ha inizio la fondamentale Confessione creatrice di Klee, che sintetizza un
principio, uno sorta di legge la cui portata non sarà più limitata alla poetica personale, ma diverrà la
cifra di tutte le correnti e i movimenti artistici del Novecento. (Di Napoli 2004 p.104-105)
3.5.3. la dinamica percettiva decritta fenomenologicamente come un continuo rimando
dell’attenzione dal primo piano che contorna e delinea oggetti e lo sfondo, l’alone che, ad un tempo,
comprende e circonda l’oggetto in primo piano, ma anche mette a disposizione sfondo e alone da
cui possono emergere nuove oggettività cui fanno da alone e sfondo gli oggetti precedentemente
noti e ora presenti come ricollocati. Ogni osservare come vedere è allora un estrarre che presentifica
ciò a cui rivolge la propria attenzione e riconosce; contemporaneamente neutralizza, senza negare,
ciò cui riserva un nuovo destino di presenza (presenza – contesto) e di disponibilità attenzionale.
« Nel genuino percepire inteso come un percepire attento, io presto attenzione all’oggetto, per
esempio a questo foglio, lo afferro come cosa che esiste qui e ora. Poiché ogni percepito ha uno
sfondo d’esperienza, l’afferrare può dirsi un estrarre. Infatti, tutt’intorno al foglio stanno libri,
matite, il calamaio, ecc.; anch’essi sono in un certo modo «percepiti», percettivamente presenti nel
nostro «campo intuitivo»; ma, mentre noi prestiamo attenzione al foglio, a essi non prestiamo
alcuna attenzione né li afferriamo, neanche in maniera secondaria. Si manifestano, ma non sono
18
estratti e posti per sé. Ogni percezione di cosa ha quindi un alone di «intuizioni» di sfondo (o visioni
di sfondo, nel caso in cui nell’intuire sia già presente un prestare attenzione), e anche questo alone è
un «vissuto di coscienza», o in breve «coscienza», e precisamente «di» tutto ciò che di fatto viene
visto nello «sfondo» oggettuale insieme a ciò che viene attentamente percepito. (p.81) […]
Il nostro discorso verte esclusivamente sull’alone di coscienza, che inerisce all’essenza di una
percezione compiuta nella modalità del «prestare attenzione all’obiectum» e su ciò che si trova
nell’essenza propria di questo alone. In ciò è implicita la possibilità di certe modificazioni del
vissuto originario, che indichiamo come libero dirigersi dello «sguardo» — non dello sguardo
puramente e semplicemente fisico, ma di quello «spirituale» — dal foglio di carta inizialmente
guardato a oggetti precedentemente manifestatisi e quindi «implicitamente» dati alla coscienza;
oggetti che dopo che lo sguardo si è diretto verso di essi diventano esplicitamente dati alla
coscienza, «attentamente» percepiti o «incidentalmente notati». (p.82) […] Ma anche per tali vissuti
è manifestamente vero che quelli attuali sono circondati da un alone di inattuali: il flusso di
coscienza non può mai consistere di pure attualità. (p.83) […] L’essenza della corrente dei vissuti
di un io desto implica poi che, come dicemmo sopra, la catena delle cogitationes che fluisce in
maniera continua sia costantemente circondata da un medium di inattualità sempre pronte a
convertirsi nel modo dell’attualità, come viceversa le prime in quello dell’inattualità» (p.84)»
(Husserl Edmund 1913 Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica,
Einaudi, Torino 2002 p.81-84 passim)
4. riconoscimento di sé, dell’altro (in inscindibile concomitanza: il riconoscimento
della propria alterità)
4.1. riconoscimento (agnizione) e catastrophé sono il cuore della tragedia classica.
4.1.1. Nella Poetica, Aristotele dedica una attenzione particolare alla Tragedia, ne presenta la
natura, la struttura, gli affetti e quindi gli effetti che provoca. È arte della verosimiglianza e
appartiene quindi al campo della mimesis: descrive non fatti accaduti, ma fatti possibili, possibili
proprio in quanto verosimili; anche la tragedia, come l’arte, rappresenta la realtà, e in ciò è mimesis,
ma essa rappresenta la realtà dal punto di vista della possibilità: rappresenta la possibilità della
realtà, esplora la realtà secondo la prospettiva della possibilità (si tratta di un contesto di ambiguità
e ambivalenza: in quanto verosimile è mimesis, in quanto possibile non è mimesis).
4.1.2. Tra le sei parti che compongono la tragedia, la centralità spetta al racconto più che ai
personaggi, e proprio il racconto, nell’intreccio in cui è presentato il fatto (intreccio e fabula), la
peripezia genera il riconoscimento determinando la soluzione (la catastrophé) che la tragedia vuole
rappresentare e realizzare (e la “catarsi” che la tragedia, secondo alcuni, ha il fine di attuare).
La peripezia, «il mutamento delle azioni che si compiono verso il loro contrario, e questo secondo
verosimiglianza o necessità» (Poetica 1452 a 22-24), determina il riconoscimento, «il mutamento
dall’ignoranza alla conoscenza, oppure dall’amicizia all’inimicizia, di coloro che sono determinati
dalla buona o dalla cattiva sorte». Aristotele usa il termine anagnorisis «per indicare l’episodio
improvviso con il quale la situazione di irriconoscibilità si rovescia [katastrophé] in
riconoscimento.» (Ricoeur 2004 p. 92)
4.1.3. Parte qui l’analisi dei riconoscimenti. Il più bello (poeticamente più riuscito) è quello che
accade assieme alla peripezia e si iscrive nella trama della stessa azione drammatica (Poetica 1452 a
32-33); riconoscimenti che derivano dai fatti stessi e sono perciò capaci di suscitare nel grado più
elevato pietà e terrore, emozioni attraverso le quali la tragedia realizza il proprio ruolo catartico.
L’opera diventa presentazione e studio dei molti possibili segni artefici di riconoscimento e della
loro efficacia nel creare il ribaltamento e la soluzione proprio nel riconoscimento: azioni, cose
inanimate, ricordo, ragionamenti e parole dei personaggi… Nel riconoscimento, scoperta e
agnizione, la tragedia ha il suo compiersi e risolversi drammatico.
4.2. riconoscimento da ripresa (un’antitesi tra ricordo e ripresa)
19
4.2.1. Le filosofia sistematiche, come quella di Hegel che domina il suo tempo definendosi “la
filosofia”, “il sistema scientifico della filosofia”, sono filosofie del ricordo. In essa, poiché non può
essere che una, unica e totale, tutto avviene secondo necessità, quindi non accade mai nulla di
imprevisto, di nuovo, di imprevedibile che abbia bisogno di riconoscimento (l’imprevedibile è
consegnato e solo momentaneamente all’ignoranze dei principianti o dei non addetti). Si tratta di
una filosofia che annulla il tempo, in essa non vi è una reale, né utile distinzione tra passato presente
e futuro; così come di filosofia che annulla la singolarità rendendola manifestazione storica
dell’universale, nobilitando e portando il singolo, così promette, ad essere espressione
dell’universale e trovare così il senso del proprio esistere in un momento del sistema. La legge della
necessità logica (per quanto di natura dialettica) che struttura il sistema, la rende filosofia che lo
costruisce una cultura della ripetizione e del ricordo. Il sistematico vive di ricordi, nella dialettica
dell’et-et.
4.2.2. A quel modo di pensare Kierkegaard oppone la centralità del singolo (contro l’universale) e
della possibilità (contro la necessità). Il ricordo cede il posto alla ripresa e nella ripresa il singolo
trova il proprio riconoscimento, scopre e vive la propria essenza non come necessità, ma come
possibilità.
Le dimensioni del tempo diventano la sede reale dell’esistenza, non perché la vincolano a identità
già consolidate o a progetti prestabiliti e necessari, ma in quanto passato e futuro sono radice e
impulso della scelta presente, contesto naturale e proprio di sostegno della possibilità, essenza
dell’esistenza. L’etica autentica è ripresa: l’uomo attua la scelta di sé. Posto di fronte alla propria
singolarità e, quindi, alla propria concreta finitudine, l’uomo assume la piena responsabilità di se
stesso come risultato e come compito, si apre nella concretezza del suo vissuto, e non come se fosse
di fronte a una categoria, alla dimensione della possibilità.
Nella filosofia di Hegel prendono forma le categorie del ricordo, quelle che condannano a vivere di
ricordi: necessità, razionalità sistematica, sviluppo, progresso, mediazione, passaggio, totalità; «la
dialettica è ideologia del risentimento» (Deleuze).
La filosofia di Kierkegaard apre alle categorie del riconoscimento: possibilità, scelta, libertà, salto,
impegno, paradosso, nulla, angoscia, dono, attesa, ripresa. Riprendere procedendo, non ricordare
retrocedendo.
4.3. riconoscimento e il passaggio attraverso l’oggetto: Winnicott: «L’uso di un oggetto e
l’entrare in rapporto attraverso identificazioni» Così titola il cap.6 dell’opera di Winnicott W.
Donald 1971 Gioco e realtà, Armando editore, Roma 1995.
In generale, osserva Ricoeur: «… il passaggio attraverso il fuori precede regolarmente il ritorno su
se stessi.» (Ricoeur 2004, p.128)
4.3.1. oggetti transizionali. In Gioco e Realtà, Winnicott esplora estesamente quella che egli delinea
come la fase “transizionale” dello sviluppo dell’Io, durante il quale il bambino costruisce
un ponte, per così dire, tra pura soggettività e realtà oggettiva, condivisa. Per riuscire in questo
arduo compito, dice Winnicott, il bambino fa uso di qualcosa che appartiene al mondo esterno
«magari uno straccio di lana, o l’angolo di una coperta, o di un piumino, o una parola, o una ninnananna... il cui uso diventa di importanza vitale per il bambino al momento di andare a dormire, ed è
una difesa contro l’angoscia, specie l’angoscia di tipo depressivo. Forse qualcuno di questi oggetti
soffici è stato trovato e usato dal bambino, e diventa allora ciò che io chiamo oggetto
transizionale...». Winnicott W. Donald 1971 Gioco e realtà, Armando editore, Roma 1995
Prefazione di Renata Gaddini p.11)
4.3.1.1. una necessaria distinzione tra entrare in relazione con l’oggetto, usare l’oggetto. «E’ forse
necessario soffermarsi un po’ più a lungo per esporre il mio punto di vista sulla differenza che c’è
tra l’entrare in rapporto con l’oggetto e il fare uso di un oggetto. Nell’entrare in rapporto con
l’oggetto il soggetto consente che certe modificazioni abbiano luogo nel suo sé, modificazioni di
quel tipo che ci ha portato a inventare il termine “carica”. … L’entrare in rapporto con l’oggetto è
un’esperienza del soggetto che si può descrivere, in termini del soggetto, come un essere isolato. …
20
Per esempio, se l’oggetto si deve usare, esso deve necessariamente essere reale, nel senso di essere
parte di una realtà condivisa, e non un fascio di proiezioni. È questo, io credo, che crea l’enorme
differenza esistente tra il mettersi in relazione e l’usare. … l’entrare in rapporto può essere descritto
in termini del soggetto individuale, e che l’uso non può essere descritto se non in termini di
accettazione dell’esistenza indipendente dell’oggetto, della sua proprietà di essere stato sempre là
dove si trova. … Vorrei ricordare qui che l’aspetto essenziale, nel concetto di oggetti e fenomeni
transizionali, è (secondo la mia presentazione dell’argomento), il paradosso, e l’accettazione del
paradosso: il bambino crea l’oggetto, ma l’oggetto era lì in attesa di essere creato e di divenire un
oggetto investito di carica.» (Winnicott 1971 o.c. p. 154, 155-156)
«Nella sequenza, si può dire che il mettersi in rapporto con l’oggetto viene per primo, mentre l’uso
dell’oggetto viene per ultimo: nel mezzo, tuttavia, vi è la cosa forse più difficile dello sviluppo
umano, o almeno il più arduo di tutti i primi insuccessi che debbono essere sanati. Questa cosa che
esiste fra l’entrare in rapporto e l’usare è il collocamento che il soggetto fa dell’oggetto fuori
dell’area del controllo onnipotente del soggetto stesso; vale a dire la percezione dell’oggetto come
un fenomeno esterno, non come una entità proiettiva ; di fatto, un riconoscimento di esso come una
entità per se stessa.» (Winnicott 1971 o.c. p. 156-157)
4.3.1.2. La frontalità soggetto – oggetto nel passaggio dall’entrare in rapporto con l’oggetto all’uso
dell’oggetto. «Questo passaggio (dall’entrare in rapporto all’uso) significa che il soggetto distrugge
l’oggetto.» Il bambino, cioè, distrugge l’oggetto inteso come mettersi in rapporto, come relazione;
la distruzione dell’oggetto come oggetto transizionale per poter passare all’uso dell’oggetto. Il
processo di distruzione che è in atto suggerisce la delicatezza del passaggio, la delicatezza della
distruzione degli oggetti transizionali. Si tratta di una distruzione che culmina poi in un doppio
esito, in una doppia e contemporanea costruzione: la presenza dell’oggetto di fronte ad un soggetto,
oggetto inteso come realtà in sé e oggetto d’uso, la netta distinzione del soggetto dall’oggetto e la
definizione conseguente del soggetto come realtà in sé, definita da una specifica identità.
«Un filosofo in poltrona potrebbe da ciò arguire che in pratica non esiste una tal cosa come l’uso di
un oggetto; se l’oggetto è esterno, allora esso viene distrutto dal soggetto. Se il filosofo però si
alzasse dalla sua poltrona e si sedesse sul pavimento con il suo paziente, scoprirebbe che esiste una
posizione intermedia. In altre parole, scoprirebbe che, dopo “il soggetto entra in rapporto con
l’oggetto”, viene “il soggetto distrugge l’oggetto” (quando diventa esterno); e poi potrebbe venire:
“l’oggetto sopravvive alla distruzione da parte del soggetto”. Ma la sopravvivenza può esserci o non
esserci. Un nuovo elemento interviene così nella teoria dell’entrare in rapporto con l’oggetto. Il
soggetto dice all’oggetto: “Io ti ho distrutto”, e l’oggetto è lì per ricevere la comunicazione. Da
questo momento il soggetto dice: “Salve oggetto!”. “Io ti ho distrutto”. “Io ti amo”. “Tu hai valore
per me perché sei sopravvissuto al mio distruggerti”. “Mentre io ti amo, continuamente ti distruggo
nella fantasia” (inconscia). Qui comincia per l’individuo la fantasia. Il soggetto può adesso usare
l’oggetto che è sopravvissuto. È importante notare che non solo il soggetto distrugge l’oggetto
perché l’oggetto è posto fuori dell’area del controllo onnipotente. E’ ugualmente significativo
formulare ciò in modo capovolto, e dire che è la distruzione dell’oggetto che pone l’oggetto fuori
dell’area del controllo onnipotente del soggetto. In questi modi l’oggetto sviluppa la propria
autonomia e la propria vita, e (se sopravvive) porta il suo contributo al soggetto, a seconda delle sue
proprietà. In altre parole, a causa della sopravvivenza dell’oggetto, il soggetto può ora cominciare a
vivere una vita nel mondo degli oggetti, e così il soggetto comincia ad avvantaggiarsi in modo
incommensurabile; ma il costo che deve essere pagato sta nell’accettare la continua distruzione,
nella fantasia inconscia, relativa all’entrare in rapporto con l’oggetto. […] Si intende generalmente
che il principio di realtà coinvolge l’individuo in rabbia e distruzione reattiva, ma la mia tesi è che
la distruzione ha un ruolo nel fare la realtà, collocando l’oggetto al di fuori del sé. Perché ciò
avvenga sono necessarie condizioni favorevoli.» (Winnicott 1971 o.c. 157-158, 159)
4.3.1.3. dall’oggetto al soggetto. In richiamo: «Quando Winnicott parla di oggetto transizionale che
simbolizza un viaggio, occorre tenere a mente che si tratta di un viaggio in due direzioni, l’una
intesa a creare la realtà oggettiva dell’oggetto, l’altra protesa a creare la realtà oggettiva del
21
soggetto, l’ Io sono». Uno dei suoi concetti di base è che esista una fase di transizione nello
sviluppo emozionale, «uno stadio teorico che precede la separazione del “non-me” dal “me”».
(Winnicott 1971 o.c. p. pref. Gaddini 12) I fenomeni transizionali sono consentiti al bambino a
causa del riconoscimento intuitivo, da parte dei genitori, della tensione insita nella percezione
oggettiva, e noi non poniamo al bambino la questione della soggettività o oggettività proprio là
dove c’è l’oggetto transizionale. (Winnicott 1971 o.c. p. 42) Non è l’oggetto, naturalmente, che è
transizionale. L’oggetto rappresenta la transizione di un bambino da uno stato di essere fuso con la
madre ad uno stato di essere in rapporto con la madre come qualcosa di esterno e separato.
(Winnicott 1971 o.c. p. 43) …la varietà dei modi in cui i bambini usano il loro primo oggetto
posseduto come “non-me”. (Winnicott 1971 o.c. p. 24) …con l’uso che il bambino fa di oggetti che
non sono parte del suo corpo ma che non sono ancora pienamente riconosciuti come appartenenti
alla realtà esterna. (Winnicott 1971 o.c. p. 25)
4.3.1.3.1. in diversa formulazione, la tesi di Winnicott: «Il voltarsi dall’oggetto all’io produce l’io, il
quale sostituisce l’oggetto perduto. Questa produzione è una generazione tropologica e deriva dal
bisogno psichico di sostituire gli oggetti perduti. In questo modo, nella melanconia non solo l’io
diventa sostituto dell’oggetto, ma questo atto di sostituzione istituisce l’io come una risposta
necessaria o una “difesa” contro la perdita. Nella misura in cui l’io è “un sedimento degli
investimenti oggettuali abbandonati”, coincide con il congelamento di una storia di perdita, la
sedimentazione di relazioni di sostituzione nel corso del tempo, la risoluzione di una funzione
tropologica nell’effetto ontologico del sé.» Butler Judith 1997 La vita psichica del potere. Teorie
della soggettivazione e dell’assoggettamento, Meltemi, Roma 2005 p. 158
4.3.2. le tre zone e l’area intermedia (una topica dinamica dello psichismo)
La distinzione soggetto oggetto fa pensare ad una topica o area spaziale duale della psiche: esterno,
interno. La natura dinamica del processo psichico e il ruolo in esso giocato dagli oggetti
transizionali impone invece una topica dello psichismo (della sua dinamica) a tre aree. Tra esterno e
interno vi è un’area intermedia. «Ciò che io vorrei affermare è che se vi è il bisogno di questa
doppia definizione, vi è anche il bisogno di una definizione tripla; la terza parte della vita di un
essere umano, una parte che noi non possiamo ignorare, è una area intermedia di esperienza a cui
contribuiscono la realtà interna e la vita esterna.» (Winnicott 1971 o.c. p. 25) «Quest’area
intermedia di esperienza, di cui non ci si deve chiedere se appartenga alla realtà interna o esterna
(condivisa), costituisce la maggior parte dell’esperienza del bambino, e per tutta la vita viene
mantenuta nella intensa esperienza che appartiene alle arti, alla religione, al vivere immaginativo ed
al lavoro creativo scientifico.» (Winnicott 1971 o.c. p. 43)
«Un disco scuro al centro, un effervescente anello di luce rossa che sprizza infinite scintille di fuoco
nell’oscurità circostante: con questa copertina, disegnata dallo stesso Autore, si presenta
nell’edizione originale inglese Playing and Reality. Quando leggo negli scritti di Winnicott
dell’inaccessibile profondità del sé, il nucleo centrale dell’individuo, è a questo disco scuro che mi
viene di pensare, circondato dall’anello incandescente… Ma quando, in questo volume, egli ci parla
della sorgente di vita che è il vivere con immaginazione con la capacità di fare uso dell’esperienza
culturale in ogni suo senso; quando ci parla della molla che rappresenta, per l’individuo la capacità
di conferire ad ogni cosa esistente il contributo del suo proprio punto di vista, che gli permette di
vedere ogni cosa nella sua propria maniera autentica e creativa, anche allora ho pensato a questa
figura. […] E’ forse qui che ha sede, per l’individuo diventato adulto, la quintessenza dell’area
intermedia, compresa tra la realtà interna e quella esterna, quella zona di sé così intensamente
personale, dipendente come essa è nel suo esistere, e nell’uso che di essa si può fare, dalle prime
esperienze di vita che sono proprie di ogni individuo? E’ lì allora, da quell’angusto territorio di luce,
che l’individuo, che avrà potuto da bambino iniziare un rapporto di fiducia con il mondo esterno —
dapprima attraverso gli oggetti transizionali, in seguito attraverso il gioco ed il giocare
immaginativo condiviso — troverà la dirompente spinta ad esplorare e ad approfondirsi nella vita
culturale, e saprà gioire del suo retaggio culturale, e perpetuare “vertute e conoscenza”.» (Winnicott
1971 o.c. Prefazione di Renata Gaddini p.9-10)
22
4.3.2.1. un’area intermedia fondamentale, dinamica e perenne. «Si prende qui per assunto che il
compito di accettazione-di-realtà non è mai completato, che nessun essere umano è libero dalla
tensione di mettere in rapporto la realtà interna con la realtà esterna, e che il sollievo da questa
tensione è provveduto da un’area intermedia di esperienza (cfr. Riviere, 1936) che non viene messa
in dubbio (arte, religione, etc.). Questa area intermedia è in diretta continuità con l’area del gioco
del bambino piccolo, che è “perduto” nel gioco. Nell’infanzia questa area intermedia è necessaria
per l’inizio di un rapporto tra il bambino e il mondo ed è resa possibile da cure materne abbastanza
buone nella prima fase critica. Essenziale a tutto ciò è la continuità (nel tempo) dell’ambiente
emozionale esterno e di particolari elementi nell’ambiente fisico quali l’oggetto o gli oggetti
transizionali.» (Winnicott 1971 o.c. p. 41-42) (questo passo da Winnicott, Playing and Reality, è
significativamente citato in A Honneth, Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del
conflitto, il Saggiatore, Milano 2002 pp. 126-127)
4.3.2.2. «Si usa fare riferimento alla “prova-di-realtà”, e fare una distinzione precisa fra
appercezione e percezione. Io sto qui spezzando una lancia in favore di uno stato intermedio tra la
incapacità e la crescente capacità del bambino di riconoscere e accettare la realtà. Sto pertanto
studiando la sostanza della illusione, quella che viene concessa al bambino e che, nella vita adulta, è
parte intrinseca dell’arte e della religione, e che tuttavia diventa il marchio della follia allorché un
adulto pone un eccesso di richieste alla credulità degli altri costringendoli a condividere un’illusione
che non è quella loro. Noi possiamo condividere un rispetto per l’esperienza illusoria e se lo
desideriamo possiamo raccogliere insieme e formare un gruppo sulla base della similarità delle
nostre esperienze illusorie. Questa è una delle radici naturali del raggrupparsi tra esseri umani.
Spero sia chiaro che io non mi sto riferendo esattamente all’orsacchiotto del bambino piccolo, o al
primo uso che fa il lattante del suo pugno (o del pollice o delle dita). Non sto specificatamente
studiando il primo oggetto dei rapporti oggettuali. Io mi preoccupo del primo oggetto posseduto, e
dell’area intermedia compresa tra ciò che è soggettivo e ciò che è oggettivamente percepito.»
(Winnicott 1971 o.c. p. 26). Processo che è all’origine dello «sviluppo di un modello personale»
(Winnicott 1971 o.c. p.26).
4.3.2.2.1. La distinzione tra “entrare in relazione” con l’oggetto e “usare” l’oggetto, studiata e
posizionata nella fase o zona “intermedia”, quando la zona intermedia viene considerata sia come
processo all’origine dello «sviluppo di un modello personale», sia, e di conseguenza, come un’area
perenne e non semplicemente consegnata a un’età (magari infantile) della persona, diventa
fondamentale per comprendere la relazione che la persona intrattiene con gli oggetti. Se è vero che
l’“entrare in relazione” cede il posto all’“uso”, è altrettanto certo che le due dimensioni (come l’area
intermedia in cui la dinamica accade) sono sempre presenti e operanti nella vita del soggetto.
Possiamo sempre “entrare in relazione” con oggetti d’“uso”, interessati da un particolare
investimento affettivo, di natura estremamente varia (dal ricordo, al feticismo…). La macchina
pubblicitaria deve il proprio successo e la propria presa commerciale alla persistenza delle due
situazioni di rapporto: dovrà dimostrare che l’oggetto in merce non è destinato al semplice uso, ma
diventa la sede fisica di una relazione singolare, particolare, unica del soggetto con la realtà (in
fondo: “un diamante è per sempre»! «toglimi tutto ma non il mio rolex», «“vuoi salire?”, “no,
volevo solo guidare”).
4.3.2.2.2. Altrettanto vasta è la funzione degli “oggetti transizionali”, ben oltre la fase infantile del
riconoscimento di sé e dell’altro come realtà oggetto/soggetto. L’oggetto esterno (per lo più
costituito dal capo, ma non per l’esigenza di un capo), che sostituisce l’Ideale dell’Io si pone alla
base della «pulsione gregaria» su cui sociologicamente si regge un sistema sociale e politico
totalitario. « L’oggetto che il gruppo pone al posto dell’Ideale dell’Io non ha strettamente a che fare
con l’esistenza di un capo, di una persona cioè che ne sia l’espressione. Freud dice del resto
chiaramente: «Davvero l’istinto gregario non lascia alcun posto per il capo; quest’ultimo si limita ad
aggiungersi al gregge casualmente, ad avere con esso una connessione talmente accidentale che a
partire da tale pulsione niente sembra sfociare nel bisogno di un dio; al gregge manca il pastore.»
Ciò che Freud sostiene in queste righe appare abbastanza inesplicabile se non si coglie appieno ciò
23
che Bion in seguito definirà «assunto di base». La massa non ha bisogno di un capo in senso stretto.
La massa ha bisogno di avere un’area nella quale l’assunto di base possa esplicarsi in modo
adeguato. La funzione dell’oggetto è quella di consentire il funzionamento psicotico, non è affatto
quella di guidare le masse. Identificare un regime totalitario con la presenza di un dittatore significa
non cogliere la sostanza maggiore della questione dei totalitarismo almeno così come viene posta da
Freud. […] La funzione principale dell’oggetto non è tanto quella di guidare quanto di
«proteggere», di essere uno scudo che protegge da quei nemici sui quali viene proiettata la propria
aggressività criminale.» Voltolin Adriano Forme attuali della «pulsione gregaria, in Recalcati
Massimo (a cura di) 2007 Forme contemporanee del totalitarismo, Bollati Boringhieri, Torino p.
209, 210.
4.4. riconoscimento e identità come assoggettamento: Foucault, Butler
«Dovremmo tentare di cogliere l’assoggettamento nella sua istanza più materiale, ossia quale
processo di costituzione dei soggetti» (Michel Foucault, Due letture)
« Si trattava, né più né meno, di fondare un’autonomia attraverso la sottomissione: diventare un
individuo attraverso l’appartenenza e affermare la propria personalità con mezzi impersonali.»
(Bauman Zygmunt 1991 Modernità e ambivalenza, Bollati Boringhieri, Torino 2010 p. 218)
4.4.1. ambivalenza dell’assoggettamento nella costruzione del soggetto (e del genere): autonomia
attraverso e nella sottomissione (soggettamento/assoggettamento) «assujettissement: il simultaneo
processo di formazione e regolamentazione del soggetto» (Butler p.35).
L’età moderna, secondo cliché accettati, è l’epoca della formazione del soggetto. Il termine è
considerato sinonimo di individuo e persona; più precisamente la parola soggetto dovrebbe indicare
il processo attraverso il quale l’individuo o la persona diventano soggetto. Si impone quindi lo
studio dell’“assoggettamento”. Questa parola, nel suo stesso aspetto linguistico, conserva un doppio
significato o meglio una ambivalenza con conseguente relazione tra il suo doppio significare. Indica
infatti sia un assoggettamento come dipendenza, sottomissione, sia un assoggettamento come farsi,
costituirsi, divenire soggetto. La relazione interna alla ambivalenza consiste nella tesi centrale
espressa da Foucault e rielaborata da Butler: attraverso l’assoggettamento – sottomissione accade
l’assoggettamento – formazione.
«In quanto forma di potere l’assoggettamento è paradossale. Essere dominati da un potere esterno a
noi è una delle forme note e dolorose che il potere assume. Altro è, tuttavia, scoprire che ciò che noi
siamo, il nostro stesso costituirci come soggetti, dipende in qualche modo proprio da quel potere.
Siamo abituati a pensare al potere come a ciò che si impone al soggetto dall’esterno, a ciò che
schiaccia, che spinge in basso e relega a un livello inferiore. Questa è certamente una buona
descrizione di parte di ciò che fa il potere. Se però, seguendo Foucault, comprendiamo che il potere
forma il soggetto e al contempo delinea le condizioni stesse della sua esistenza e la traiettoria del
suo desiderio, allora esso non è più semplicemente ciò cui ci opponiamo, ma anche, in un senso
forte, ciò da cui dipendiamo per la nostra esistenza e ciò che accogliamo e proteggiamo nel nostro
stesso essere. Il modello abitualmente utilizzato per comprendere questo processo è il seguente: il
potere si impone su di noi e noi, indeboliti dalla sua forza, arriviamo a internalizzarlo o ad accettane
le condizioni. Questo ragionamento non considera, tuttavia, che “noi” che accettiamo quelle
condizioni, ne siamo fondamentalmente dipendenti per la “nostra” stessa esistenza. Non esistono
dunque le condizioni discorsive per l’articolazione di un “noi” qualunque? L’assoggettamento
consiste esattamente in questa dipendenza fondamentale da un discorso che non scegliamo mai, ma
che, paradossalmente, dà inizio e sostegno alla nostra possibilità di azione. L’“assoggettamento”
indica il processo del divenire subordinati al potere tanto quanto il processo del divenire un
soggetto.» Butler Judith 1997 La vita psichica del potere. Teorie della soggettivazione e
dell’assoggettamento, Meltemi, Roma 2005 p.7-8
Zygmunt Bauman propone il tema in questi termini (con riferimento ad un esperimento di Emily
Cho che offrì alle donne americane un servizio di consulenza computerizzata nel campo della moda
1981, ma si tratta dell’antinomia della società contemporanea): «… si trovavano alle prese con un
24
compito ambivalente che non erano in grado di affrontare con precisione perché le sue due facce
parevano annullarsi a vicenda. Si trattava, né più né meno, di fondare un’autonomia attraverso la
sottomissione: diventare un individuo attraverso l’appartenenza e affermare la propria personalità
con mezzi impersonali. L’unicità che cercavano doveva essere determinata a livello comunitario
(ossia inequivocabile). L’individualità, potremmo dire, non bastava da sola, se non era comunicata e
percepita come tale, e questo significa condivisa con gli altri. Secondo: la risposta al dilemma. Le
clienti di Emily Cho videro la risoluzione dell’ambivalenza come un compito da svolgere. Sia
l’appartenenza che l’unicità individuale erano considerate degli attributi che non sono dati per
natura, ma richiedono uno sforzo cosciente per produrli e sostenerli; devono essere «costruiti». E
costruirli era visto come il compito (forse il dovere) della persona in questione.» Bauman Zygmunt
1991 Modernità e ambivalenza, Bollati Boringhieri, Torino 2010 p. 218
L’efficacia dell’assoggettamento deriva dalla sua insopprimibile e feconda ambivalenza che Judith
Butler immediatamente richiama: “sottomettersi a” e “diventare soggetto” (formarsi come soggettopersona); un’ambivalenza che, come per ogni ambivalenza, risulta operativa sulla base di due
caratteristiche: 1. se non si propone alcuna transizione concettuale da una concezione all’altra («per
così dire, dal potere inteso come esterno al soggetto, che “agisce sul” soggetto, al potere come
costitutivo del soggetto, che è “agito dal soggetto” Butler 1997 o.c. p.20) 2. se tra i due sensi si
coglie tuttavia la relazione: è possibile acquisire la costituzione di soggetto e quindi costruire una
propria identità solo attraverso un processo di dipendenza e sottomissione (in forme varie) a norme
e processi sociali (ci si assoggetta assoggettandosi). «Il tema della subordinazione riformulato da
Foucault, come ciò che non è solo imposto al soggetto, ma anche come ciò che lo forma, cioè come
ciò che è imposto a un soggetto attraverso la sua stessa formazione, suggerisce una ambivalenza
relativa al luogo in cui il soggetto emerge… Consideriamo il dato che un soggetto non solo è
formato nella subordinazione, ma ancora che questa subordinazione fornisce la condizione di
possibilità della durata di questo stesso soggetto» (Butler 1997 o.c. p. 29,30; trad. it. p.13)
4.4.1.1. L’urgenza di una analisi parallela di una teoria della psiche e di una teoria del potere. Se
«l’“assoggettamento” indica contemporaneamente il processo attraverso il quale si diventa
subordinati ad un potere e il processo attraverso il quale si diventa un soggetto» occorre allora
approfondire «gli specifici meccanismi attraverso i quali il soggetto è formato nella sottomissione.»
Allora una teoria che intende esplorare «l’intero dominio della psiche» deve accompagnarsi ad una
teoria che studi «quale sia la forma psichica assunta dal potere… sotto il suo doppio aspetto di
subordinazione e di produzione», visto che «la sottomissione è una condizione della
soggettivazione.» Ne consegue: «occorre allora pensare assieme la teoria del potere e la teoria della
psiche». L’intreccio tra i due settori è immediatamente imposto e messo in luce dalla ambivalenza
del termine assoggettamento e dalla dinamica specifica del suo realizzarsi: «… il potere che appare
inizialmente esterno, imposto al soggetto, mentre lo costringe alla subordinazione, assume una
forma psichica che costituisce l’identità propria del soggetto.» (Butler 1997 o.c. p. 23-24, trad. it.
p.8)
4.4.1.1.1. L’ambivalenza richiamata del termine e del processo di assoggettamento ha dunque la
capacità di illuminare sull’ambivalenza del potere politico sociale, ad un tempo oppressore e
creatore del soggetto. «Il potere è ad un tempo esterno al soggetto e il suo luogo proprio», dichiara
l’autrice. Questa doppia significazione è, secondo Butler vissuta psichicamente dal soggetto, e
questa vita psichica del potere crea quello che l’autrice chiama «attaccamento passionale» o
«appassionato» a se stesso (passionate attachment). Il soggetto è infatti appassionatamente attaccato
alla propria subordinazione. Solo questo “appassionato attaccamento alla propria sottomissione”
genera un passaggio dall’esterno all’interno: dall’assoggettamento come subordinazione ad un
potere esterno all’assoggettamento come formazione dell’individuo in soggetto. Cioè,
l’attaccamento appassionato al proprio assoggettamento determina il costituirsi del soggetto in
termini di «trasmutazione del padrone in una realtà psichica … il potere che inizialmente appare
come un esterno, imposto al soggetto, in grado di porre il soggetto in uno stato di subordinazione,
assuma una forma psichica che costituisce l’identità stessa del soggetto.» (Butler 1997 o.c. p.9). Un
25
misto di sudditanza e auto-rimprovero (da cui ha origine la cattiva-coscienza di cui parla Nietzsche
nella Genealogia della morale) e di formazione di sé attraverso il riconoscimento. La dinamica
(ancora una volta dialettica) di questo costituirsi è sottolineata dal riconoscimento, chiarita
dall’immagine del voltarsi per riconoscersi; un voltarsi che inaugura un processo cangiante di
definizione di sé, una “inaugurazione tropologica del soggetto”. (ripreso poi in 4.4.3.)
4.4.1.1.1.1. chiarire che il processo di soggettivazione è un processo di sottomissione (in un termine
ambivalente: “assoggettamento”) e che tale sottomissione deve la propria efficacia in quanto si
realizza come auto-sottomissione, auto-rimprovero, rende necessario capovolgere, in questo campo,
una sequenza antica e ancora operativa. Se si vuole formulare il processo di formazione del soggetto
utilizzando gli antichi (ma non troppo) termini metafisici di anima e corpo è allora il caso di mettere
in discussione la sequenza che Platone ha consegnato alla cultura occidentale. Contrariamente alla
sua teoria occorre prendere atto che non è il corpo ad essere carcere dell’anima, ma è l’anima a
incarcerare il corpo; ciò risulta evidente in quel processo di auto-carcerazione che si verifica
nell’assoggettamento e rende efficace il processo nei termini contemporanei della costituzione e
della sottomissione del soggetto; e, sempre in questo processo, l’anima è “essa stessa un elemento
della signoria che il potere esercita sul corpo”. In questa direzione vanno le analisi di Foucault in
Sorvegliare e punire (in linea con il pensiero di Hegel e di Nietzsche): «l’uomo di cui parlano e che
siamo invitati a liberare è già in se stesso l’effetto di un assoggettamento [assujettissement] ben più
profondo di lui. Un’“anima” lo abita e lo conduce all’esistenza, che è essa stessa un elemento della
signoria che il potere esercita sul corpo. L’anima, effetto e strumento di un’anatomia politica;
l’anima prigione del corpo (Foucault 1975, p.33).» (Butler 1997, o.c. p.36-37)
4.4.1.1.2. È ancora a partire del concetto di assoggettamento (assujettissement) espresso da Foucault
e dalla sua ambivalenza che è possibile portare a chiarezza, nel costituirsi del soggetto, il ruolo del
genere e la sua relazione con la sessualità; chiarire cioè il “rapporto conflittuale e strutturante tra
sesso e genere”. È attraverso l’assoggettamento che si forma per la persona il genere; e
l’assoggettamento è qui contemporaneamente (vista la sua ambivalenza) contesto di vincolo e di
libertà o di opportunità. Più precisamente «è dall’attaccamento passionale alla propria
subordinazione che nasce il genere, ed è a partire dal genere che può costituirsi l’identità sessuale
[non viceversa: nonostante il peso e il ruolo del corpo e dei suoi dati anatomici, esso non può venire
inteso come sede di una identità sessuale anatomica naturale (presunta) da cui derivi
automaticamente, immediatamente e semplicemente il genere; ciò significa trascurare due dati
fondamentali: la natura culturale del genere, la potenzialità aperta ed enorme della corporeità nel
suggerire, sostenere i progetti di vita della persona]. Il doppio senso dell’assoggettamento
corrisponde pressochè proporzionalmente alla distinzione sesso / genere. Per un verso,
dall’assoggettamento alla legge, alla legge del sesso: tu sei una ragazza, tu sei un ragazzo. Per un
altro verso, tu sei appassionatamente attaccato a questo assoggettamento che contemporaneamente
ti apre l’accesso a te stesso proprio mentre ti ingiunge di avviare la costruzione di una identità, cioè,
e necessariamente, a inventarla, a creare la sua specifica forma.» (Butler 1997 o.c. p.13 dalla
prefazione di Catherine Malabou all’ed. francese: Butler Judith 1997 La vie psychique du pouvoir,
ed. Léo Scheer 2002)
4.4.2. Il tema dell’assoggettamento, proprio nella sua ambivalenza, ha una lunga tradizione
filosofica. «La questione dell’assoggettamento e del modo in cui il soggetto è costituito nella
subordinazione è il tema di tutta la sezione della Fenomenologia dello Spirito di Hegel che
ricostruisce l’incontro con la libertà a partire dall’analisi della schiavitù e dalla sua sconfortante
caduta nella situazione della “coscienza infelice”.» (Butler 1997 o.c. p. 8-9) L’aspetto ambivalente
dell’appartenenza come sottomissione e realizzazione é il tratto proprio della teoria politica di
Hegel, come anche di Platone e forse dei pensatori politici moderni o, quindi, una formula – schema
essenziale della teoria politica in generale. In particolare, la dialettica servo-padrone formulata da
Hegel nella Fenomenologia dello Spirito, compare in Nietzsche nella immagine della coscienza
ripiegata su di sé e lì spiega la Genealogia della morale («Le auto-mortificazioni che tentano di
correggere la corporeità insistente della coscienza di sé fondano la cattiva coscienza.»); presente
26
infine nella tesi psicanalitiche di Freud, nel processo di identificazione che accompagna il formarsi
del Super-Io e definisce la strategia interna alla psiche tra Es, Super-Io e Io; è ripresa in rilettura da
Foucault e da Butler che specificano filosoficamente e storicamente sia la dinamica della
definizione di sé secondo il genere, sia, più in generale, il processo dell’assoggettamento come
costituzione di soggetti. «Riletta a partire dal rapporto padrone – schiavo, la problematica di
Foucault dell’assoggettamento diventa una logica di ciò che Butler chiama l’“autoincarcerazione” o
l’“autoschiavitù”.» Può anche configurarsi come una fenomenologia psicanalitica fondamentale dei
processi di realizzazione come processi di sottomissione (con la batteria di doveri e divieti che tale
contesto comporta) e conseguente amore / attaccamento nei confronti della “propria” schiavitù.
4.4.3. riconoscimento e assoggettamento: lo “schema” (inteso in senso kantiano) del voltarsi, della
“conversione” (in riprese e riferimento alla katastrophé greca, di Aristotele, e alla metànoia
cristiana, di Paolo).
Il potere che da esterno, imposto al soggetto, diventa autoimposizione, assume con ciò stesso «una
forma psichica che costituisce l’identità stessa del soggetto». Ma qui viene alla luce una nuova
forma dell’ambivalenza, il voltarsi e la sua ambivalenza: voltarsi contro se stessi, voltarsi in
costruzione di se stessi; ed è l’ambivalenza del riconoscimento (dell’autoriconoscimento).
(nota bene: “voltarsi” è inteso come schema nel senso degli schemi illustrati da Kant [Critica della
Ragion pura]; si tratta di procedure di costruzione conoscitiva e pratica dell’esperienza; per questo
ruolo costituente, in vista di una gestione concettuale dei dati d’esperienza, lo schema si caratterizza
per la sua natura plastica, propria degli schemi; qui diventa il modificarsi della conoscenza della
propria soggettività attraverso i riconoscimenti.)
4.4.3.1. voltarsi contro se stessi. Quando ciò che è esterno, fonte di subordinazione, diventa interno,
nella forma dell’auto-rimprovero, allora il formarsi della soggettività è consegnata al movimento
del voltarsi, del riconoscersi, come un «voltarsi contro se stessi», un auto-rimprovero, un’automortificazione.
4.4.3.2. voltarsi in riconoscimento e costituzione di sé. In quanto però quel voltarsi contro se stessi è
opporsi ad un se stesso che ancora non c’è in quanto la soggettività si forma attraverso quel
processo di assoggettamento, allora è un voltarsi verso di sé per un autoriconoscimento e una
costituzione di sé: «che tale atto di voltarsi venga considerato generativo o produttivo appare
estremamente rilevante per la nostra trattazione della produzione o generazione del soggetto.» « Se
non c’è formazione del soggetto al di fuori di un attaccamento appassionato a coloro ai quali si è
subordinati, allora la subordinazione si dimostra indispensabile al divenire del soggetto.» (Butler
1997 o.c. p.13) È un voltarsi che è un formarsi, riconoscersi del soggetto. Fino ad affermare che «il
soggetto è la modalità del potere che si volta su se stesso: il soggetto è l’effetto del contraccolpo del
potere.» (Butler 1997 o.c. p.12)
4.4.3.2.1. occorre mettere meglio in luce la dinamica e la natura del voltarsi come costituzione di sè:
quel «voltarsi sembra servire come inaugurazione tropologica del soggetto». Nel processo di
soggettivazione che l’ambivalenza del voltarsi (del riconoscersi) mette in atto emerge cioè il tratto
maggiormente specifico della formazione del soggetto; si tratta di un formarsi aperto, precario nella
sua fortunata apertura: «il voltarsi sembra servire come inaugurazione tropologica del soggetto, un
momento fondante il cui stato ontologico rimane permanentemente incerto.» La soggettività resta
sempre in questo formarsi tropologico, in questo voltarsi (senza mai restare di sale, alla Lot). Lo
studio dell’assoggettamento (sia in generale sia nel processo di definizione del soggetto secondo il
genere) diventa lo studio di un formarsi perennemente tropologico, in perenne disponibilità al
rivolgimento, alla variazione, al voltarsi intesi come modalità e “schemi” (in senso kantiano) della
definizione di sé, dell’assoggettamento, della costituzione di sé come soggetto. « Nessun soggetto
può emergere al di fuori di questo attaccamento, formato in uno stato di dipendenza, ma nessun
soggetto può permettersi di “vederlo” mai pienamente. Questo attaccamento, nelle sue forme
primarie, deve contemporaneamente arrivare a essere ed essere negato; affinché il soggetto possa
emergere, il suo arrivare a essere deve consistere nella sua parziale negazione.» (Butler 1997 o.c.
p.14
27
4.4.4. il contesto di una soggettivazione personale e sociale precaria. Si deve tener sempre presente
l’origine: la soggettivazione nasce da un assoggettamento-sottomissione che è il contesto di
costituzione della soggettività; essa nasce in forza di un attaccamento appassionato del soggetto a
quella subordinazione che “soggettiva”, una subordinazione quindi che in forza di questo
attaccamento passionale si trasforma in auto-subordinazione. Su questo procedimento delle origini,
perciò strutturale e costante, fanno leva i progetti di subordinazione e dominio del potere e del
sociale. Essi, esterni, hanno un alleato potente nell’interno del soggetto: possono far leva su quel
progetto di assoggettamento a cui ciascuno deve il proprio essere soggetto, un essere soggetto nella
dipendenza. Tuttavia proprio in questa dinamica ha sede la precarietà. Ma è una precarietà doppia:
la precarietà delle soggettivazioni personali, ma anche la precarietà dei progetti di dominio e di
subordinazione che il potere sociale al comando vorrebbe imporre; esso deve pur sempre fare i conti
con una interiorizzazione auto-subordinante le cui forme ed esiti risultano imprevedibili e non certi
nel garantire il successo della logica della subordinazione; non si tratta mai di una interiorizzazione
puramente di tipo mimetico (vedi Butler 1997 o.c. p. 135); l’autorità esterna diventa un elemento
interno (“tramite l’identificazione [il bambino] porta l’autorità inattaccabile dentro di sé” (p. 86),
Butler 1997, p. 135), ma nel corso di questa traslazione essa subisce un processo di
personalizzazione che ne modifica i tratti in termini non prevedibili.
Il ragionamento può venire ricostruito citando in sequenza ravvicinata alcuni passaggi di Judith
Butler (Butler 1997, p.23-26)
- il quesito: «Come avviene che la soggettivazione del desiderio richieda e istituisca il desiderio per
l’assoggettamento? […] Pur sostenendo che le norme sociali sono internalizzate, non abbiamo
ancora spiegato cosa effettivamente sia l’incorporazione o, più generalmente, l’internalizzazione, né
cosa significhi per una norma venire internalizzata o cosa succeda a una norma nel processo di
internalizzazione. […] »
- la risposta: «Ritengo che tale processo di internalizzazione costruisca la distinzione tra vita
interiore ed esteriore, offrendoci una distinzione tra psichico e sociale che differisce
significativamente da una descrizione dell’internalizzazione psichica delle norme. […]»
- la sede della vulnerabilità del soggetto: «Se, però, la produzione stessa del soggetto e la
produzione di quella volontà sono le conseguenze di una subordinazione primaria, allora è
inevitabile la vulnerabilità del soggetto nei confronti di un potere non di sua fattura. Tale
vulnerabilità qualifica il soggetto come essere sfruttabile. […] La soggettivazione sfrutta il
desiderio per l’esistenza lì dove l’esistenza è sempre conferita da qualche altro luogo; essa
sottolinea una vulnerabilità primaria nei confronti dell’Altro allo scopo di esistere.»
- la sede della precarietà dell’“assoggettamento” (inteso nei due sensi): «Accettare le condizioni di
potere sulle quali non ci si è mai accordati, ma rispetto alle quali si è vulnerabili e dalle quali si
dipende per la propria esistenza, sembra essere una banale operazione d’assoggettamento alla base
della formazione del soggetto. “Assumere” il potere non è, tuttavia, un processo semplice in quanto
il potere non viene riprodotto meccanicamente quando viene assunto. Viceversa, in quel momento il
potere rischia di assumere un’altra forma e un’altra direzione. … Per chiarire il processo attraverso
il quale il potere sociale produce riflessività nel momento stesso in cui limita le forme di socialità, è
necessaria una nuova descrizione del dominio della soggettivazione a livello psichico.» (Butler
1997, p.23-26)
4.4.4.1. Occorre affrontare la situazione creata dalla “forclusione”: una esclusione non avvertita
come tale in quanto viene prima di ogni esplicita esclusione o preclusione, costituisce un limite non
colto e a questa impossibile tematizzazione essa affida la propria efficacia nel costituire limiti. La
forclusione colloca quindi in una perdita non avvertita e non rimossa come perdita (che dunque si
nega al pensiero, al possesso, al pianto ed è “melanconia”, un “dolore incompleto e irrisolvibile”
perchè irriflesso, inavvertito) che segna il limite della riflessività del soggetto e lo consegna,
costituendolo, al proprio irrisolto limite e alla minaccia della sua dissoluzione in termini di
“assoggettamento”: «Non c’è forse un desiderio di piangere — e al tempo stesso un’incapacità di
piangere — ciò che non si è mai riusciti ad amare, un amore cui vengono a mancare le “condizioni
28
necessarie all’esistenza”? Questa non è semplicemente la perdita dell’oggetto o di un qualche
insieme di oggetti, ma della possibilità propria dell’amore: la perdita della capacità di amare, il lutto
infinito per ciò che fonda il soggetto.» (Butler o.c. p. 28) In questa situazione, «Affinché una perdita
possa prefigurare il soggetto, affinché lo renda possibile (e impossibile), dobbiamo considerare
quale parte giochi la perdita nella formazione del soggetto. Esiste una perdita che non può essere
pensata, né può essere posseduta o pianta, che rappresenta la condizione di possibilità per il
soggetto? … Dal momento che il soggetto non riflette su tale perdita — e non può farlo — tale
perdita segna il limite della riflessività, ciò che supera (e condiziona) i suoi circuiti. Tale perdita —
intesa come forclusione — inaugura il soggetto e lo minaccia di dissoluzione.» (Butler 1997,
o.c.p.28).
4.4.4.2. Nell’impegno di prendere in esame “quale parte giochi la perdita nella formazione del
soggetto”, il caso della “forclusione”, di una perdita operante che non può essere pensata o
rimpianta come perdita, si evidenzia una nuova (efficace e subdola) forma operativa del potere nel
gestire i processi di assoggettamento e dell’ambivalenza che li caratterizzano: « In quanto
forclusione, la sanzione non opera per proibire desideri già esistenti, ma per produrre alcuni tipi di
oggetti e per impedire ad altri di accedere al campo della produzione sociale. In questo modo, la
sanzione non agisce secondo l’ipotesi repressiva, così come viene postulata e criticata da Foucault,
ma come meccanismo di produzione in grado, tuttavia, di operare sulla base di una violenza
originaria.»; e, per esplicitare: « Ci sono, chiaramente, vari modi di rifiutare l’amore e non tutti si
qualificano come forme di forclusione. Cosa succede, però, quando una certa forclusione
dell’amore diviene condizione possibilitante per l’esistenza sociale? Non produce, forse, una
socialità afflitta da melanconia, una socialità nella quale la perdita non può essere pianta perché non
riconosciuta come perdita, perché ciò che si è perduto non ha mai avuto alcun diritto all’esistenza?
(Bulter o.c. p. 29)
4.4.4.2.1. La riflessione compare nelle Confessioni di Agostino. «Agostino azzarda il paradosso:
“Eppure, se è vero che conserviamo nella memoria quanto ricordiamo e che, privi del ricordo
dell’oblio, non potremmo assolutamente riconoscere la cosa udendo pronunciare il nome, la
memoria conserva l’oblio” (ibidem, x, 16.24). È infatti la memoria che, nel momento del
riconoscimento dell’oggetto obliato, attesta l’oblio. Sofisma? Può darsi. “Eppure in qualche modo,
in modo sia pure incomprensibile e inesplicabile, sono certo di ricordare anche l’oblio stesso,
affossatore di ogni nostro ricordo” (ibidem, x, 16.25).» (Ricoeur 2004 p. 136)
Si può riprendere la definizione della melanconia, così come presentata da Foucault – Butler: la
melanconia è il ricordo dell’oblio; la memoria della dimenticanza; un lutto impossibile per un fatto
che non compare alla mente; l’impossibilita del togliersi di un’esclusione in quanto non è avvertita
come esclusione.
4.4.5. Per concludere (o solo per interrompere momentaneamente), nel ricostruire il processo di
soggettivazione, torna al centro la natura plastica della soggettivazione e dei meccanismi di
fondazione e preclusione (compresa la “forclusione”) operanti nel suo costituirsi, quindi anche della
sua riflessività, del suo voltarsi, del suo riconoscersi: «Un’analisi critica della soggettivazione
comprende: (1) una descrizione delle modalità con le quali il potere regolatore mantiene i soggetti
in uno stato di subordinazione attraverso la produzione e lo sfruttamento del desiderio di continuità,
visibilità e posizione (2) il riconoscimento del fatto che il soggetto, pur prodotto come continuo,
visibile e localizzato è, ciononostante, tormentato da un residuo inammissibile, una melanconia che
segna i confini della soggettivizzazione; (3) una spiegazione dell’iterabilità del soggetto che mostra
come l’agency possa consistere esattamente nell’opposizione e nella trasformazione delle
condizioni sociali dalle quali è stata generata. Per quanto una tale formulazione possa difficilmente
rappresentare la base per una visione ottimistica del soggetto o di una politica centrata sul soggetto,
comunque essa può rappresentare una provocazione e una forma di cautela rispetto a due forme di
desiderio teoretico: da un lato, che l’assunzione e l’affermazione di una “posizione-di-soggetto”
rappresenti il momento definitorio della politica; dall’altro, che l’eliminazione del soggetto quale
tropo filosofico sottovaluti i requisiti linguistici per avere la speranza di essere accolto dalla società.
29
[…] L’analisi della soggettivazione è sempre duplice, e traccia contemporaneamente le condizioni
necessarie alla formazione del soggetto e la necessità per il soggetto — e la sua prospettiva — di
rivoltarsi contro tali condizioni per poter emergere. […] Il paradosso temporale del soggetto è tale
che dobbiamo necessariamente perdere la prospettiva di un soggetto già formato per poter
descrivere il nostro stesso divenire. Tale “divenire” non è un processo semplice o continuo, ma una
scomoda pratica della ripetizione e dei suoi rischi, necessaria eppure incompleta, oscillante
sull’orizzonte dell’essere sociale.» (Butler 1997, o.c. p. 33-34)
4.5. la sede del riconoscimento nell’alterità e il riconoscimento di sé come altro
(riconoscimento e dissimmetria; “l’asimmetria dell’interpersonale” - Lévinas)
Nelle tesi di Foucault e Butler sul tema dell’“assoggettamento” e nella lunga tradizione culturale cui
quelle tesi fanno riferimento è messa di nuovo in evidenza la natura aperta e mai chiudibile della
lunga e appassionante storia del riconoscimento del proprio processo di “assoggettamento”: della
formazione della soggettività della persona in relazione. Questa si presenta come la sede per una
corretta ed efficace impostazione del tema del riconoscimento dell’altro. In tre passaggi, tre
movimenti: 1. l’accadere dell’altro in simultaneità e dissimmetria io-altro (Ricoeur); 2. dall’altro
all’io, non dall’io all’altro o come rovesciare Kant (Lèvinas); 3. il riconoscimento di sé come altro.
4.5.1. movimento 1. L’accadere dell’altro e il riconoscimento. È il riconoscimento dell’altro la
sede in cui prende forma una radicata e personale alterità e l’intrinseca (non imposta dall’esterno)
attenzione all’altro: si tratta dell’esperienza dell’altro vissuta come momento indispensabile del
proprio assoggettamento e, in conseguenza, si tratta dell’esperienza dell’altro che fa leva sulla
consapevolezza della propria intrinseca e essenziale alterità. Ciò che va prevalentemente segnalato è
la natura di evento dell’accadere dell’altro, la sua logica che si attiene a quella del dono (lo
“schema” del dono sta dietro e dentro la logica del riconoscimento / riconoscenza), la irriducibile e
irrinunciabile dissimmetria nel processo di riconoscimento. Si tratta di nodi centrali delle riflessioni
di Paul Ricoeur in Percorsi del riconoscimento.
«Va tuttavia subito precisato che non ci si trova qui di fronte a una configurazione della soggettività
in certa misura già data, sulla base delle cui caratteristiche si possano tracciare in un secondo
momento le linee della questione del riconoscimento. Il riconoscimento infatti non interviene, con
le sue dinamiche e le sue processualità, in un momento secondo rispetto alla costituzione della
soggettività. Piuttosto al contrario, Ricoeur ci dà la possibilità di constatare come la questione del
riconoscimento coincida con la posta in gioco del costituirsi di un soggetto all’interno di un
contesto (sociale, politico, economico ecc.) dal quale il soggetto è sempre preceduto e determinato.
[…] Relativamente alla dimensione conflittuale cui necessariamente il riconoscimento dà luogo, lo
spunto ulteriore cui Ricoeur ricorre è costituito da un altro tipo di logica, e precisamente la logica
del dono. O meglio, a quella che non può essere ritenuta propriamente una logica, in quanto già da
sempre contrassegnata da una dissimmetria non ricomponibile. Per cui il dono e il controdono si
ritrovano a illustrare esemplarmente quella che secondo Ricoeur costituisce appunto l’alternativa a
una logica della reciprocità, intesa in senso economico e mercantile. Se infatti la logica della
reciprocità implica una fondamentale simmetria, quanto meno formale, quello che Ricoeur chiama
“mutuo riconoscimento” si caratterizza per il fatto di assumere a proprio fondamento la
ineliminabile dissimmetria che contraddistingue la dimensione del rapporto con altri. Così come
ogni tentativo di spiegare il dono in termini di logica è destinato al fallimento, in quanto implica un
riconoscimento del dono come tale, ossia secondo le categorie del pensiero logico e formale (per cui
nel momento in cui riconosco un dono la sua gratuità viene azzerata e la sua essenza di dono
scompare), allo stesso modo la struttura del riconoscimento dovrà assumersi in quanto struttura
radicalmente “aperta”, in(de)finita.» (Ricoeur Paul 2004 Percorsi del riconoscimento, Raffaello
Cortina, Milano 2005 XV, XVI dall’introduzione di Fabio Polidori)
In modo più analitico: dalla dissimmetria alla reciprocità; la reciprocità sulla base della
dissimmetria. La mutualità consiste nel gestire la dissimmetria, sia in ambito privato che in quello
30
sociale ed è questa capacità a determinare la situazione del riconoscimento, nella sua irriducibile
ambivalenza: riconoscimento / riconoscenza.
4.5.1.1. premessa di tipo trascendentale (Kant – Husserl): la simultaneità e la causalità reciproca (e
il continuo rimando interno che essa determina) sono lo “schema” e la categoria trascendentali base
per il riconoscimento;
4.5.1.2. ciò senza annullare le dissimmetrie; anzi, la dissimmetria costituisce, nella causalità
reciproca, la condizione del riconoscimento. La reciprocità si costituisce solo sulla base e grazie alla
dissimmetria; una reciprocità senza alterità è una contraddizione etica, ontologica e logica; una
reciprocità tra identici non è reciprocità poiché non vi è nulla da scambiare e porre in reciprocità.
«Lo stesso e l’altro entrano in una relazione i cui termini non formeranno mai una totalità. … Una
relazione in cui io e l’altro diventassero intercambiabili ricondurrebbe le cose all’indietro,
dall’infinito alla totalità.» (Ricoeur 2004 p.179, 180) e al totalitarismo.
4.5.1.3. il riconoscimento nella dissimmetria attraverso la percezione analogica (percezione,
“appercezione”, analogica e non ragionamento analogico);
4.5.1.4. la dialettica specifica del riconoscimento: superare la dissimmetria originaria nel rapporto
considerandola tuttavia come insuperabile, infinitamente insuperabile e perciò fonte di densità della
relazione presente nel riconoscimento.
«… una difficoltà che la fenomenologia incontra nel derivare la reciprocità dalla presunta
dissimmetria originaria del rapporto tra me e altri. …si impegna a superare la dissimmetria che, in
una certa maniera, persiste sullo sfondo delle esperienze di reciprocità e non consente che la
reciprocità si manifesti come un superamento sempre incompiuto della dissimmetria.
La dissimmetria è imposta dal carattere originario dell’autosufficienza dell’ego nell’ambito della
riduzione di ogni trascendenza naturale a una coscienza trascendentale per la quale ogni realtà
deriva dalla autoesplicazione (Selbstauslegung) del mio ego come soggetto di ogni conoscenza
possibile. … Il mio stesso corpo proprio si offre come primo analogon di un corpo proprio altrui, la
cui esperienza immediata, intuitiva, mi resterà per sempre inaccessibile; sotto questo aspetto, si
tratta della insuperabile verità della dissimmetria originaria sul piano percettivo e intuitivo. Ciò
nonostante, il senso della nozione di “appercezione analogica”, che non ha a che vedere con il
ragionamento per analogia, consiste nel fatto di essere una trasposizione categoriale, preintellettiva,
in quanto rinvia a una prima creazione di senso, in base alla quale il rapporto tra me e l’estraneo è
un rapporto da modello a copia.
Per quanto le innumerevoli varianti della “appercezione analogica” possano essere discusse
all’infinito, resta che essa ha il merito di preservare intatto, e persino di esaltare, l’enigma
dell’alterità. È ovvio che l’altro non resta per me uno sconosciuto, altrimenti io non potrei nemmeno
parlarne; resta solamente “percepito”, non soltanto come un altro me stesso, nel senso esclusivo del
termine, ma come un altro io, un alter ego, nel senso analogico del termine; in tal modo l’analogia
protegge la dimensione incognita originaria dell’esperienza per sé dell’altro; in tal senso, l’io e
l’altro non “compaiono” veramente; soltanto io appaio, sono “presentato”; l’altro, supposto analogo,
resta “appresentato”.
Su questa dissimmetria, al tempo stesso superata e preservata, si costituiscono di volta in volta un
mondo naturale comune e delle comunità storiche che condividono valori comuni. Questi due nuovi
gradi di costituzione sono presupposti dalla relazione di reciprocità. Occorre attribuire la massima
importanza operazioni di costituzione di una comunità (Vergemeinschaftung) che, dalla asimmetria,
ricava la reciprocità. Si tratta di una vera propria costituzione di secondo grado; è infatti necessario
che l’altro sia mio analogo affinché, oltre all’esperienza dell’io, sia in grado di comporsi con
l’esperienza di altri su una base di reciprocità, sebbene il concatenarsi di queste costituzioni tragga
il proprio senso dalla esperienza originaria di me stesso in quanto ego.» (Ricoeur 2004 pp. 176-178)
4.5.2. movimento 2. Dall’altro all’io, non dall’io all’altro o come rovesciare Kant (Lèvinas)
Ricoeur nota come il movimento (di togliere e conservare, un nuovo aufhebung) interno alla
dissimmetria che fonda e costituisce la relazione e il riconoscimento, in Lévinas si compie secondo
31
una direzione rovesciata nei confronti di quanto afferma Kant nella Critica della ragion pura: non
dall’io all’altro, ma dall’altro all’io. [Il tema era in qualche modo impostato analogamente in
Husserl, nella seconda parte delle Idee, considerata la “simultaneità” che caratterizza il
riconoscimento e, in modo più radicale, l’esigenza della relazione, della condivisione e
dell’intersoggettività come condizione di oggettività, anche nel campo delle teorie “scientifiche”]. Il
riconoscimento, per Lévinas, parte dalla manifestazione dell’altro, dall’apparire del volto e dal
concretarsi dell’esperienza di infinito che quell’apparire comporta. Si tratta di un rovesciamento che
è contestuale ad un altro più ampio: la priorità dell’etica sulla ontologia. Il movimento non va
dall’io all’altro (questa direzione ospita e nasconde il rischio della assimilazione e della riduzione
dell’altro al medesimo; il rischio di una cultura totalitaria), ma dall’altro all’io: questa è la direzione
dell’apertura che dà vita al riconoscimento come capacità di stare nella dissimmetria in relazione
all’altro e anche in relazione a se stesso; l’appercezione dell’altro è infatti all’origine della
appercezione di sé come altro (del comparire, apparire a sé come altro) e dunque all’origine del
cammino senza fine di auto-riconoscimento. (vedi 4.5.3.)
«Con Emmanuel Lévinas la dissimmetria originaria tra l’io e l’altro procede dal polo altro verso il
polo io. Questo rovesciamento si ricollega a un rivolgimento più fondamentale che pone l’etica in
posizione di filosofia prima relativamente all’ontologia. In Totalità e infinito, l’idea di essere viene
integrata nel processo di assimilazione di tutte le differenze, comprese quelle istituite tra me e altri
all’interno di una fenomenologia della percezione come quella di Husserl. Sotto questo aspetto, le
due idee di essere e di totalità si sovrappongono, mentre fa eccezione l’idea di infinito. …
E di colpo, sospinto dalla escatologia della pace, lo sguardo si inverte e si apre allo “sfolgorio della
esteriorità o della trascendenza sul volto d’altri” (Totalità e infinito p.25). Il concetto di questa
trascendenza rigorosamente sviluppata, continua Lévinas, “si esprime con il termine di infinito”. In
certo qual modo, tutto viene detto in una pagina. Sarà tuttavia necessario un grosso volume per
operare effettivamente il rovesciamento dalla totalità ontologica all’infinito secondo l’etica, per
grazia della mediazione del volto.» (Ricoeur 2004 p. 179-180) [torna il tema del velo nella
dialettica della ri-velazione, nella “epifania del volto”]
4.5.2.1. In conclusione e bilancio, ciò che è in gioco: «il misconoscimento della dissimmetria nella
relazione tra me e l’altro», che rischia di essere «un misconoscimento più sottile che misconosce se
stesso. […] Tale oblio della asimmetria, consumato dalla riuscita delle analisi del mutuo
riconoscimento, costituirebbe l’ultimo misconoscimento nel cuore stesso delle effettive esperienze
di riconoscimento.» (Ricoeur 2004 p.287,288)
4.5.2.2. «Ancora una volta, e al di là di ogni disputa intorno alla priorità di Husserl o di Lévinas,
vorrei trasformare in avvertimento le obiezioni che entrambi i maestri di fenomenologia, ciascuno a
suo modo, incontrano; in un avvertimento rivolto a ogni concezione del primato della reciprocità
sull’alterità dell’uno rispetto all’altro dei protagonisti dello scambio. Il problema consisteva
apparentemente nel sormontare la dissimmetria per rendere ragione della reciprocità e della
mutualità; ora tale problema si rivela capovolto: in che modo integrare la mutualità con la
dissimmetria originaria, dato il sospetto che questa dissimmetria possa minare dall’interno la fiducia
nella potenza di riconciliazione collegata al processo del riconoscimento? In tal caso, la mia tesi è
che la scoperta di questo oblio della dissimmetria originaria rappresenta un vantaggio per il
riconoscimento nella sua forma mutuale.
A essere in gioco è il senso del “tra” sul quale abbiamo tanto insistito nel corso della discussione
che ci ha condotto a distinguere la mutualità sul piano delle relazioni “tra” protagonisti dello
scambio dalla reciprocità concepita come una forma trascendente di circolazione di beni o di valori
i cui singoli attori altro non sarebbero se non dei vettori.
Nel “tra” dell’espressione “tra protagonisti dello scambio” si concentra la dialettica della
dissimmetria tra io e altri e la mutualità dei loro rapporti. E l’integrazione della dissimmetria alla
mutualità nello scambio dei doni contribuisce al pieno significato di questo “tra”.» (Ricoeur 2004 p.
289)
4.5.2.3. «L’ammissione della dissimmetria minacciata di oblio viene anzitutto a ricordare il
32
carattere insostituibile di ciascuno dei partner dello scambio; l’uno non è l’altro; si scambiano i
doni, ma non i posti. Il secondo vantaggio di questa ammissione è dato dal fatto che essa protegge la
mutualità contro le insidie dell’unione fusionale, sia che ciò avvenga nell’amore, sia che avvenga
nell’amicizia o nella fratellanza, tanto in scala comunitaria che cosmopolitica; nel cuore della
mutualità viene preservata una giusta distanza, la giusta distanza che integra l’intimità con il
rispetto.» (Ricoeur 2004 p. 289)
4.5.3. Il riconoscimento di sé come altro. L’attenzione all’altro è costitutiva della soggettività; si
traduce in attenzione e in continuo riconoscimento della propria alterità. L’attenzione e l’attesa della
perenne propria alterità nella forma di riconoscimento e di riconoscenza, rende l’attenzione e la
relazione all’altro un fatto di costituzione soggettiva, esse non vengono lasciate a propositi o
raccomandazioni morali che il soggetto vive come dovere esterno, obbligo meritorio ma pur sempre
faticoso precetto; sono processi eticamente e ontologicamente costituenti. (La filosofia assume qui
le forme del dialogo inteso non come veste formale del dire ma come relazione antropologica e sede
di autoidentità o di “assoggettamento”.)
Una testimonianza: «Nel bisogno di riconoscimento da parte dell’altro il soggetto depone parte
della propria autonomia e ripone aspettative di riconoscimento, secondo Eugène Enriquez (1983), se
consideriamo la sua fondamentale opera Dall’orda allo Stato. Alle origini del legame sociale. In
quella dinamica prende forma il legame sociale come vincolo e possibilità.» (Butler 1997 o.c.p.188)
4.5.3.1. Le citazioni, poetiche e filosofiche, sul tema dell’autoriconoscimento come apertura alla
propria alterità si sprecano:
Platone: riconoscersi nel variare: «anche durante il tempo in cui ogni vivente si dice che vive come
unità e che è lo stesso in realtà esso si chiama nello stesso modo, ma non conserva mai in sé le
stesse cose…non solo nel corpo, ma anche nell’anima: i modi, le consuetudini, le opinioni, i
desideri, i piaceri, i dolori, le paure, mai alcuna di queste cose rimane la stessa nella stessa persona,
ma alcune nascono, altre si perdono…» (Convito 207e).
Aristotele: aprirsi nel sociale alla propria complessità. Il sociale è il luogo di scoperta e
realizzazione progressive della propria natura come natura complessa; della propria complessità. È
un aprirsi alla propria complessità, alla perfezione (mesòtes) della propria complessità. Osserva
Sigieri di Brabante (1235-1282, Tractatus de anima intellectiva, in Quaestiones in tertium De
Anima (Louvain Paris 1972, cap.VIII) «E bisogna pensare a quanto il Filosofo dice nel secondo
libro della Politica, che cioè Socrate ha distrutto la città volendo troppo la sua unità. All’essenza del
composto infatti pertiene la molteplicità delle differenti parti. E poiché l’uomo è un composto
naturale più perfetto di altri, come una certa città, non è affatto sconveniente, né ha dell’incredibile
il fatto che sia meno unitario (minus unus) di altri composti naturali che non hanno se non una sola
forma semplice o una sola perfezione» (da Caccia Emanuele 2005 La trasparenza delle immagini,
B.Mondadori, Milano 218 nota).
Rimbaud: «Je est autre». Flaubert: «Madame Bovary c’est moi». Nietzsche: «tu sei sempre un
altro», «dell’uomo si può amare che egli sia una transizione». Lacan: il soggetto non è l’io ma
l’inconscio. Borges: «Anni di solitudine gli avevano insegnato che i giorni, nella memoria, tendono
a uguagliarsi, ma che non c’è un giorno, neppure di carcere o d’ospedale, che non porti una
sorpresa, che non sia, controluce, una rete di minime sorprese.» (Borges dal racconto L’attesa,
Borges Luis Jorge 1952 L’Aleph, Feltrinelli, Milano 2001, p. 138)
4.5.3.2. una conferma nella teoria e prassi psicanalitica. Il transfert analitico affettivo.
4.5.3.2.1. la tesi generale: «Non c’è cura analitica senza transfert; anzi, non c’è cura senza transfert.
Ogni cura «psi», che lo si voglia o no, che se ne sia consapevoli o no, si fonda sul transfert, il cui
potere si realizza indipendentemente dall’intenzione del terapeuta, indipendentemente dalla sua
adesione a una teoria che ne consideri o meno l’azione; quando qualcuno che soffre si rivolge a
qualcuno supposto essere in grado di offrire un aiuto, una risposta al proprio dolore,
automaticamente il transfert entra in azione. Scrive Freud nella quinta delle Cinque conferenze sulla
psicoanalisi: «La traslazione si instaura spontaneamente in tutte le relazioni umane, esattamente
33
come nel rapporto tra malato e medico; essa è dovunque l’autentico supporto dell’influsso
terapeutico e agisce tanto più vigorosamente quanto meno se ne sospetta la presenza.» (S.Freud,
Cinque conferenze sulla psicanalisi, Opere vol.6, Boringhieri, Torino 1980, p. 169). (Lolli Franco
Degradazione autoritaria nel maneggiamento del transfert in Recalcati Massimo (a cura di) 2007
p. 278)
4.5.3.2.2. l’origine mitica (archetipica) del transfert: i discorsi-dialoghi del Convito di Platone; in
particolare il racconto di Aristofane. «Lacan, nel Seminario VIII, affronta il tema del transfert
attraverso l’analisi del Simposio platonico, dunque, attraverso lo studio e la comprensione del
fenomeno dell’amore. È interessante notare come questo abbinamento tra transfert e amore in Lacan
ripercorra in parte l’accostamento che Freud opera, in Psicologia delle masse e analisi dell’Io, tra il
fenomeno dell’identificazione con il capo, lo stato amoroso e l’ipnosi.» (Lolli Franco in Recalcati
Massimo (a cura di) 2007 p. 285)
«Quando dunque la natura umana fu tagliata in due, ogni parte, vogliosa della propria metà, le si
attaccava, e gettandosi le braccia attorno, avviticchiandosi l’un l’altra, nella brama di fondersi
insieme morivano di fame e in generale di inazione, perché nulla volevano fare l’una staccata
dall’altra. […] Ognuno di noi è dunque la metà di un uomo resecato a mezzo com’è al modo delle
sogliole: due pezzi da uno solo; e però è sempre in cerca della propria metà» (Platone, Simposio
191ab, d)
4.5.3.2.2. i rischi di una “degradazione autoritaria” nella gestione del transfert.
4.5.3.2.2.1. nella terapia psicanalitica, e nella terapia in generale: «Quanto si è osservato, negli
scorsi anni, nel campo del trattamento e recupero di soggetti tossicodipendenti può essere letto
mediante questa lente; la creazione di comunità terapeutiche si è spesso realizzata intorno a figure
carismatiche (in funzione della propria esperienza personale o della forza delle proprie convinzioni
ideologico-religiose), intorno, cioè, alla persona di un fondatore che ha intriso di sé, della sua
personalità e delle sue certezze l’opera che andava a costruire. A costui viene riconosciuto il posto
privilegiato di garante ultimo e di depositano incontestabile di un sapere che si incarna in un
progetto riabilitativo specifico, imbevuto del proprio stile e del proprio pensiero. Il sapere è del
fondatore; il potere che ne deriva e che si esercita su chi si trova in uno stato di bisogno è,
ovviamente, enorme. L’occupazione, infatti, del posto di colui che sa comporta degli effetti
inevitabili nelle relazioni che si instaurano: produce un iperinvestimento transferale, ovvero una
polarizzazione del transfert su una persona — una concentrazione della dinamica transferale sul
«capo» — che solo in un secondo tempo può riversarsi su coloro che collaborano allo stesso
progetto. La potenza del legame transferale si accompagna al massiccio travaso libidico sull’oggetto
amato che diventa «sempre più magnifico, più prezioso, fino a impossessarsi da ultimo dell’intero
amore che l’Io ha per sé, di modo che, quale conseguenza naturale, si ha l’autosacrificio dell’lo.
L’oggetto ha per così dire divorato l’Io».(S.Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, Opere
vol.9, Boringhieri, Torino 1980, p. 301). Un effetto di identificazione con il capo che non è estraneo
al mondo della psicoterapia e della psicoanalisi. La psicologia dell’Io, ad esempio, ha elaborato una
teoria del transfert che fa dell’identificazione con il terapeuta e con l’analista il perno centrale della
cura. Secondo tale prospettiva, la cura di un soggetto deve puntare alla sua identificazione con l’Io
dell’analista, ritenuto il modello capace di “correggere” le problematiche dell’analizzante.» (Lolli
Franco Degradazione autoritaria nel maneggiamento del transfert in Recalcati Massimo (a cura
di) 2007 p. 280). Identificazione che rappresenta il fallimento dell’azione terapeutica in quanto crea
e rafforza dipendenze e annulla quel processo di autonomia nella gestione di sé (autoliberazione)
che è uno degli obiettivi primari perché il trattamento psicanalitico possa dirsi, in qualche modo,
riuscito.
4.5.3.2.2.2. nelle relazioni sociali, nelle forme plurime della alienazione nella storia e nell’età
contemporanea (se ne menzionano quattro):
(1) Marx: le quattro forme della alienazione nei processi di produzione e nei rapporti sociali: un
crescendo. «Abbiamo considerato da due lati l’atto di alienazione dell’attività pratica umana, del
lavoro. 1) Il rapporto dell’operaio col prodotto del lavoro come oggetto estraneo e avente un
34
dominio su di lui. Rapporto ch’è contemporaneamente rapporto col mondo sensibile, cogli oggetti
naturali, come mondo che gli sta di fronte estraneo, nemico. 2) Il rapporto dell’operaio con l’atto di
produzione nel lavoro. Rapporto ch’è il rapporto dell’operaio con la sua propria attività come
estranea, non sua, l’attività come passività, la forza ch’è debolezza, la generazione ch’è impotenza,
l’energia fisica e spirituale propria dell’operaio, la sua vita personale — che cos’è la vita se non
attività — come un’attività rivolta contro lui stesso, e da lui indipendente, a lui non appartenente.
L’autoalienazione; come vedemmo sopra l’alienazione della cosa. […]Abbiamo ancora da trarre
dalle precedenti una terza caratteristica del lavoro alienato. […] Il lavoro alienato fa dunque:
3) della specifica essenza dell’uomo, tanto della natura che dello spirituale potere di genere,
un’essenza a lui estranea, il mezzo della sua individuale esistenza; estrania all’uomo il suo proprio
corpo, come la natura di fuori, come il suo spirituale essere, la sua umana essenza; 4) che
un’immediata conseguenza, del fatto che l’uomo è estraniato dal prodotto del suo lavoro, dalla sua
attività vitale, dalla sua specifica essenza, è lo straniarsi dell’uomo dall’uomo. Quando l’uomo sta
di fronte a se stesso, gli sta di fronte l’altro uomo. Ciò che vale del rapporto dell’uomo al suo
lavoro, al prodotto del suo lavoro e a se stesso, ciò vale del rapporto dell’uomo all’altro uomo, e al
lavoro e all’oggetto del lavoro dell’altro uomo. In generale, il dire che la sua essenza specifica è
estraniata dall’uomo significa che un uomo è estraniato dall’altro, come ognuno di essi dall’essenza
umana. L’alienazione dell’uomo, è in genere ogni rapporto in cui l’uomo si trovi con se stesso, si
realizza soltanto e si esprime nel rapporto nel quale l’uomo sta con gli altri uomini. Dunque, nel
rapporto del lavoro alienato ogni uomo considera gli altri secondo la misura e il rapporto in cui si
trova egli stesso come lavoratore.» K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, pp. 193200 (passim) tr. di G. Della Volpe, Ed, Riuniti, Roma 1971
(2) Freud: le dinamiche del totalitarismo in “Psicologia delle masse e analisi dell’Io”
«L’aspetto suggestivo, ipnotico, incantatorio del transfert può tradursi in una potente arma il cui
utilizzo poco accorto rischia di sconfinare in un dispotismo assoluto. È alto infatti il pericolo di una
degradazione del transfert immaginario in direzione di una deriva totalitaria del rapporto, di un
rapporto che, a quel punto, non ammette dissenso.» (Lolli Franco in Recalcati Massimo (a cura di)
2007 p. 284)
(3) il recente totalitarismo soft: «Il totalitarismo è soft quando non ha bisogno della coercizione e
della repressione per produrre assoggettamento, perché quest’ultimo è dato preliminarmente. Il
totalitarismo è soft quando l’assoggettamento è preventivo. Anzi, in linea di principio, quella soft
sarebbe la forma compiuta del totalitarismo, se avesse una stabilità che, invece, non possiede. Ma
da cosa dipenderebbe questo assoggettamento preliminare, questo adattamento integrale alle
condizioni poste dal potere? Una risposta corrente è: dalla mancanza di alternativa. Il mondo
sarebbe solo quello che ci viene propinato mediaticamente come l’unico mondo vivibile.» (Fabio
Galimberti La macchina della rimozione in Recalcati Massimo (a cura di) 2007 p.265)
(4) alla radice: un assoggettamento originario: la macchina della rimozione. «Assoggettamento
originario. È vero che lo stesso Freud pensa il soggetto come fin dall’inizio sottomesso; ma non
tanto a un potere definito (come quello familiare, del padre o della madre), quanto a quello del più
potente meccanismo psichico: la rimozione. Per Freud, infatti, la rimozione è originaria e accade
prima ancora di qualsiasi repressione. Come preciserà Lacan, ritornando alla forza di questo
concetto, il primo tempo del soggetto è quello dell’alienazione. Il soggetto nasce nell’Altro, che è
ciò che per lui conferisce senso e ordine alla vita. Ma l’alienazione non è un destino, perché l’Altro
è insufficiente, strutturalmente non può abolire l’esperienza tragica della vita, la sua precarietà, la
sua caducità e fondamentale insensatezza. Ogni soggetto si trova prima o poi confrontato con
questo nichilismo radicale: niente ha veramente senso, niente è veramente ordinato, niente è
davvero duraturo.» Fabio Galimberti La macchina della rimozionein Recalcati Massimo (a cura di)
2007, p. 266
4.5.3.2.3. esito del ruolo terapeutico del trasfert analitico: fare i conti con la propria alterità
« … ricordarci … come la proiezione all’esterno di ansie e angosce corrisponda al tentativo di
evitare di fare i conti con la divisione soggettiva, con l’alterità che ci abita, e che ancor prima che
35
all’esterno incontriamo al nostro interno. Fare i conti con questa alterità, con il mancato
padroneggiamento di noi stessi, con il senso di spaesamento che ci attraversa, è l’unico punto di
appiglio possibile per provare a sottrarsi all’omogeneo, tenendo anche presente che un certo grado
di conformità è sempre necessario alle istituzioni per la loro sopravvivenza. Quale sia questo grado
di tolleranza è tutto da verificare, ma non in assunti teorici, bensì in una quotidianità che richiede
l’assunzione di responsabilità dei propri atti, poiché nessuno può verificare per noi questo aspetto
della convivenza. […] Uscire da una mentalità cospirativa della storia per ritrovare nella storia un
ambito di possibilità ed esperienze in cui la presenza dell’Altro sia foriera di interrogativi sulla
nostra presenza al mondo, cercare di far sì che le appartenenze siano una risorsa per aprirsi
all’esterno, e non barriere erette a difesa dell’ortodossia di un’unica salvezza, sono solo buoni
consigli, se non vengono calati in una pratica che parta dagli insuccessi delle buone intenzioni nel
quotidiano, se non si ritrova il coraggio di sperimentare e interrogare l’agire, senza reti, anzi,
facendo i conti con i buchi che smagliano la rete che ci costituisce come soggetti. Un modo di
essere e di agire possibile, che alcune figure hanno incarnato; pensiamo a Primo Levi, a Victor
Serge, a Dietrich Bonhoeffer e a tanti altri, come Germaine Tillion che hanno saputo attraversare il
male senza pensare di essere la personificazione del bene.» (Cozzi Ambrogio Ripensare il
totalitarismo oggi in Recalcati Massimo (a cura di) 2007 Forme contemporanee del totalitarismo,
Bollati Boringhieri, Torino, p.261-262
In appendice.
Già facevano i conti con la propria alterità coloro che, nel Medioevo, scolpivano mostri (mostra) in
gargouilles e bassorilievi. (esempi in diapositive)
5. scienze scoperta e riconoscimento (epistemologia)
«In ogni nuovo stile della visibilità si cristallizza un nuovo contenuto del mondo. Non solo si vede
in un altro modo, ma si vedono altre cose.» Wölfflin, Concetti fondamentali della storia dell’arte
cit., p. 476 (in Di Napoli 2004 p. 94). La situazione del riconoscimento è anche epistemologica;
accade come fatto strutturale nelle rivoluzioni scientifiche.
5.1. La logica della rivoluzione scientifica
5.1.1. È necessario preliminarmente prendere in esame e precisare modi diffusi di intendere la
logica dello sviluppo scientifico. 1. La costruzione di una teoria scientifica non si attua passando dal
mondo alla teoria, ma da una concezione teorica dominante ad una nuova; la logica delle rivoluzioni
scientifiche deve chiarire questa dinamica. 2. La scienza non procede né in modo cumulativo, né in
modo progressivo; lo sviluppo scientifico, in forma rivoluzionaria, ha luogo perché nuovi dati, sullo
sfondo dei concetti del paradigma dominante, pongono nuovi problemi e attendono risposta. 3. La
nuova teorie non può essere intesa come un nuovo modo di vedere e leggere gli stessi dati,
considerati come in sé assoluti e neutri, ma mette in condizione di vedere realtà diverse (scoperte) e
complessivamente un nuovo mondo.
5.1.2. La dinamica della rivoluzione scientifica: un movimento in tre tempi (un valzer
epistemologico). 1. Una teoria scientifica è dominante (è la scienza ed è considerata vera in quanto
riporta la struttura della realtà), è condivisa in termini di senso comune e di orientamento condiviso.
2. Sullo sfondo di quel senso comune la ricerca evidenzia anomalie, casi che la teoria non poteva
prevedere e non è in grado di riportare a propri termini e alle regolarità scientifiche proclamate; la
teoria diventa anzi qui la sede in cui si accumulano le anomalie e si avviano le modifiche della
teoria allo scopo di ricondurre l’anomalia a ciò che ci si deve attendere. 3. L’accumulo delle
anomalie rende la teoria non più praticabile, complessa, ingestibile; viene smaltito scientificamente
non in forza di continue modifiche del sistema dominante ma attraverso un cambiamento radicale di
prospettiva e di punto di vista; un mutamento di paradigma che porta a riconoscere nell’anomalia
una nuova realtà.
36
5.2. Due esempi storici presentati da Thomas Samuel Kuhn nell’opera La struttura delle
rivoluzioni scientifiche. Come mutano le idee della scienza, del 1967 (ed. italiana Einaudi, Torino
1978)
5.2.1. « Fin dalla remota antichità molti avevano visto che un qualunque corpo pesante, appeso a
una corda o a una catena, oscilla avanti e indietro fino a raggiungere alla fine uno stato di quiete.
Per gli aristotelici, che credevano che un corpo pesante si muovesse per sua natura da una posizione
più elevata verso uno stato di riposo naturale in una posizione più bassa, un corpo oscillante era
semplicemente un corpo che cadeva con difficoltà. Vincolato dalla catena, esso poteva raggiungere
lo stato di riposo nel suo punto più basso soltanto dopo un movimento tortuoso e un periodo di
tempo considerevole. Galileo invece, quando guardò un corpo oscillante, vide un pendolo, ossia un
corpo che quasi riusciva a ripetere lo stesso movimento più e più volte all’infinito.» (Kuhn 1967,
147-148)
5.2.2. « Si consideri innanzitutto un caso particolarmente famoso di mutamento di paradigma: la
nascita dell’astronomia copernicana. Quando la teoria precedente, il sistema tolemaico, fu
sviluppata per la prima volta nel corso degli ultimi due secoli prima di Cristo e dei primi due dopo
Cristo, esso riusciva meravigliosamente a prevedere le mutevoli posizioni sia delle stelle che dei
pianeti. Nessun altro sistema antico aveva funzionato così bene; per le stelle, l’astronomia tolemaica
è ancor oggi largamente usata quando si richiedono valutazioni approssimate; per quanto riguarda i
pianeti, le previsioni di Tolomeo erano altrettanto buone di quelle di Copernico. Ma un successo
straordinario non è mai, per una teoria scientifica, un successo completo. Sia per quanto riguarda la
posizione dei pianeti che per la processione degli equinozi, le previsioni fatte in base al sistema
tolemaico non corrispondevano mai perfettamente alle migliori osservazioni disponibili. […] Di
fronte ad una data discrepanza, gli astronomi erano stati ogni volta in grado di eliminarla
introducendo qualche particolare riadattamento nel sistema tolemaico di cerchi composti. Ma col
passare del tempo, chi avesse guardato al risultato complessivo degli sforzi fatti da parecchi
astronomi nel quadro della ricerca normale avrebbe osservato che la complessità dell’astronomia
cresceva ad un ritmo molto più rapido della sua accuratezza e che una discrepanza corretta in un
punto aveva probabilità di saltar fuori in un altro. Poiché la tradizione astronomica fu più volte
interrotta per ragioni estranee e poiché, in assenza della stampa, le possibilità di comunicazione tra
gli astronomi erano molto limitate, queste difficoltà furono riconosciute solo lentamente. Ma alla
fine se ne ebbe coscienza. Nel XIII secolo, Alfonso X poteva dichiarare che se Dio lo avesse
consultato quando stava creando l’universo, gli avrebbe potuto dare dei buoni consigli. Nel XVI
secolo, un collaboratore di Copernico, Domenico da Novara, sosteneva che era impossibile che un
sistema così farraginoso e poco preciso come era diventato allora il sistema tolemaico potesse
essere vero per la natura. E Copernico stesso, nella prefazione al De revolutionibus, scriveva che la
tradizione astronomica che egli aveva ereditato aveva finito col creare semplicemente un mostro.
Fin dall’inizio del XVI secolo, i migliori astronomi d’Europa in numero sempre crescente
riconoscevano che il paradigma dell’astronomia non era riuscito a risolvere i suoi problemi
tradizionali. Questo riconoscimento preparò il terreno sul quale fu possibile a Copernico
abbandonare il paradigma tolemaico ed elaborarne uno nuovo. La sua famosa prefazione costituisce
ancor oggi una descrizione classica di uno stato di crisi.» (Kuhn 1967 p. 92-93)
5.3. Epistemologia nel riconoscimento
«Molti lettori saranno certamente tentati di dire che ciò che muta con un paradigma è soltanto il
modo in cui lo scienziato interpreta le osservazioni che, per se stesse, sono determinate una volta
per tutte dalla natura dell’ambiente e dell’apparato percettivo. […] Ciò che avviene durante una
rivoluzione scientifica non è completamente riducibile a una reinterpretazione di dati particolari e
stabiliti una volta per tutte. In primo luogo, i dati non sono stabiliti inequivocabilmente. Un pendolo
non è una pietra che cade, l’ossigeno è aria deflogistizzata. Di conseguenza, i dati che lo scienziato
raccoglie da questi oggetti diversi, sono essi stessi differenti… […] Gli scienziati perciò parlano
spesso di «un velo che casca dagli occhi» o di «un lampo» che «illumina» un rompicapo
37
precedentemente oscuro, mostrando così i suoi elementi sotto una luce nuova che per la prima volta
permette di giungere alla soluzione. In altre occasioni, la illuminazione necessaria avviene nel
subconscio. Nessun senso comune del termine ‘interpretazione’ corrisponde a questi lampi
d’intuizione attraverso cui nasce un nuovo paradigma.» (Kuhn 1967 p. 150,151,152)
Tornando alla rivoluzione copernicana: « Considerando le cose da questo stesso punto di vista, i
copernicani che negavano al sole il suo tradizionale titolo di ‘pianeta’ imparavano non solo che cosa
significava ‘pianeta’ o che cos’era il sole; al contrario essi mutavano il significato del termine
‘pianeta’ in modo che esso potesse continuare ad operare utili distinzioni in un mondo in cui tutti i
corpi celesti, e non solo il sole, venivano visti in modo differente da come erano stati visti prima.»
(Kuhn 1967 p. 158)
5.3.1. un richiamo dagli episodi precedenti: « Or avvenne che mentre si trovava a tavola con loro
prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò e lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi
e lo riconobbero. Ma egli disparve ai loro sguardi. Si dissero allora l’un l’altro: «Non ardeva forse il
nostro cuore quando egli, lungo la via, ci parlava e ci spiegava le Scritture?». (Luca 24, 30-32)
5.4. Contro il metodo: la tecnica dirompente per riconoscere
«(…E la mia tesi è che l’anarchismo aiuta a conseguire il progresso in qualsiasi senso si voglia
intendere questa parola. Anche una scienza fondata sui principi della legge e dell’ordine avrà
successo solo se saranno consentiti di tanto in tanto modi di procedere anarchici.) È chiaro, quindi,
che l’idea di un metodo fisso, o di una teoria fissa della razionalità, poggia su un visione troppo
ingenua dell’uomo e del suo ambiente sociale. Per coloro che non vogliono ignorare il ricco
materiale fornito dalla storia, e che non si propongono di impoverirlo per compiacere ai loro istinti
più bassi, alla loro brama di sicurezza intellettuale nella forma della chiarezza, della precisione,
dell’«obiettività», della «verità», diventerà chiaro che c’è un solo principio che possa essere difeso
in tutte le circostanze e in tutte le fasi dello sviluppo umano. È il principio: qualsiasi cosa può
andar bene.» (Feyerabend Paul K. 1975 Contro il metodo, Feltrinelli, Milano 1979 p. 25)
38