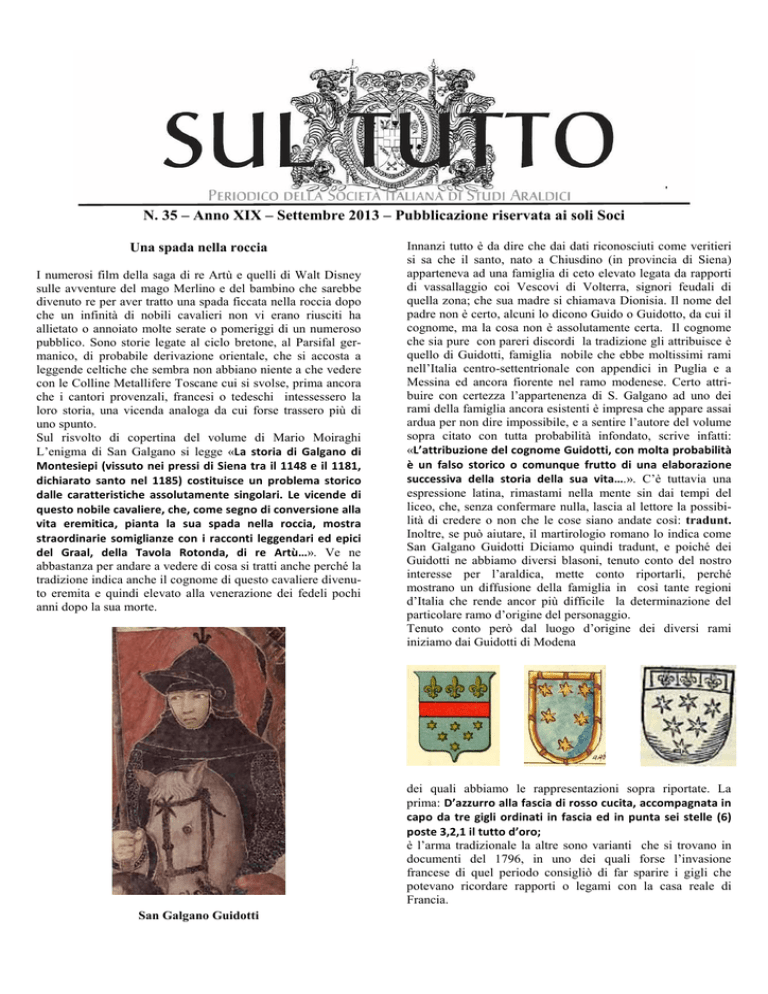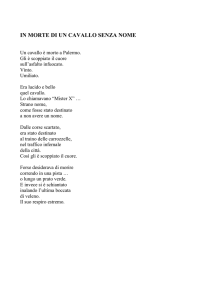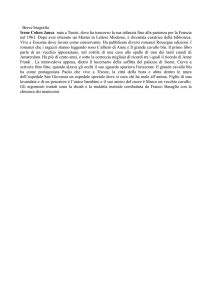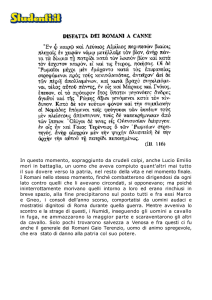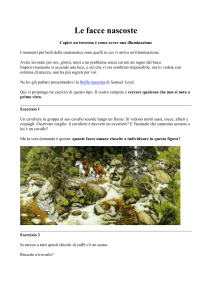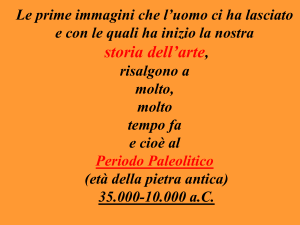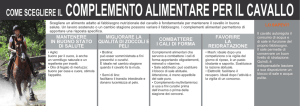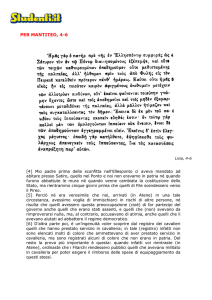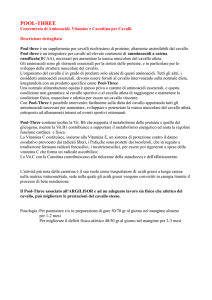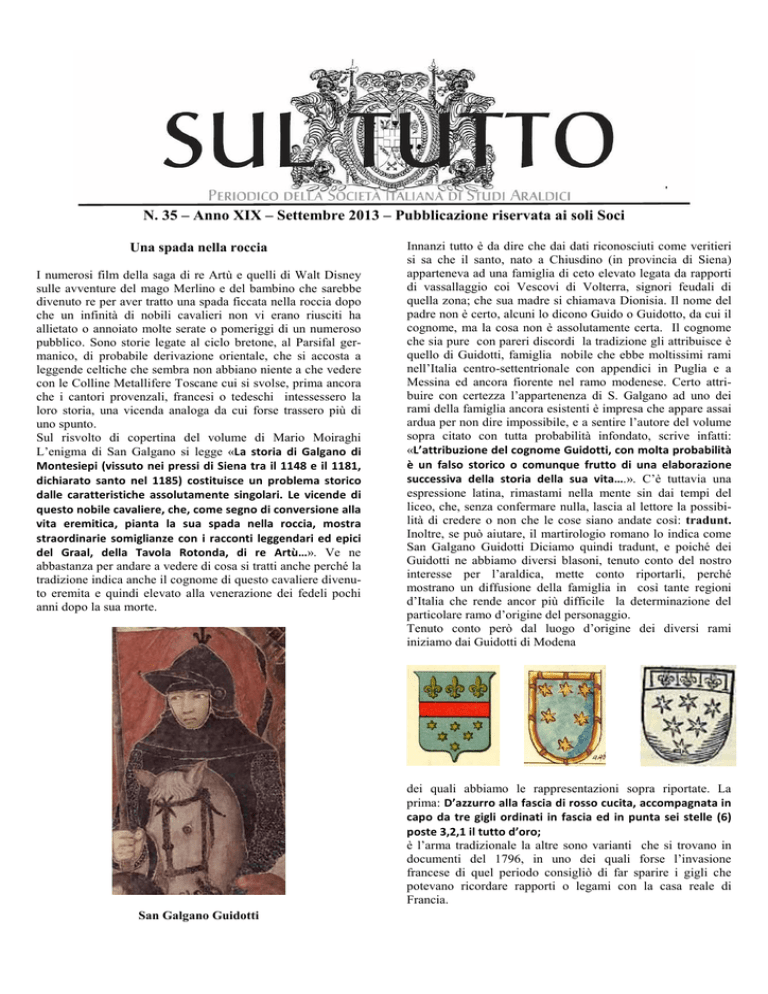
N. 35 – Anno XIX – Settembre 2013 – Pubblicazione riservata ai soli Soci
Una spada nella roccia
I numerosi film della saga di re Artù e quelli di Walt Disney
sulle avventure del mago Merlino e del bambino che sarebbe
divenuto re per aver tratto una spada ficcata nella roccia dopo
che un infinità di nobili cavalieri non vi erano riusciti ha
allietato o annoiato molte serate o pomeriggi di un numeroso
pubblico. Sono storie legate al ciclo bretone, al Parsifal germanico, di probabile derivazione orientale, che si accosta a
leggende celtiche che sembra non abbiano niente a che vedere
con le Colline Metallifere Toscane cui si svolse, prima ancora
che i cantori provenzali, francesi o tedeschi intessessero la
loro storia, una vicenda analoga da cui forse trassero più di
uno spunto.
Sul risvolto di copertina del volume di Mario Moiraghi
L’enigma di San Galgano si legge «La storia di Galgano di
Montesiepi (vissuto nei pressi di Siena tra il 1148 e il 1181,
dichiarato santo nel 1185) costituisce un problema storico
dalle caratteristiche assolutamente singolari. Le vicende di
questo nobile cavaliere, che, come segno di conversione alla
vita eremitica, pianta la sua spada nella roccia, mostra
straordinarie somiglianze con i racconti leggendari ed epici
del Graal, della Tavola Rotonda, di re Artù…». Ve ne
abbastanza per andare a vedere di cosa si tratti anche perché la
tradizione indica anche il cognome di questo cavaliere divenuto eremita e quindi elevato alla venerazione dei fedeli pochi
anni dopo la sua morte.
Innanzi tutto è da dire che dai dati riconosciuti come veritieri
si sa che il santo, nato a Chiusdino (in provincia di Siena)
apparteneva ad una famiglia di ceto elevato legata da rapporti
di vassallaggio coi Vescovi di Volterra, signori feudali di
quella zona; che sua madre si chiamava Dionisia. Il nome del
padre non è certo, alcuni lo dicono Guido o Guidotto, da cui il
cognome, ma la cosa non è assolutamente certa. Il cognome
che sia pure con pareri discordi la tradizione gli attribuisce è
quello di Guidotti, famiglia nobile che ebbe moltissimi rami
nell’Italia centro-settentrionale con appendici in Puglia e a
Messina ed ancora fiorente nel ramo modenese. Certo attribuire con certezza l’appartenenza di S. Galgano ad uno dei
rami della famiglia ancora esistenti è impresa che appare assai
ardua per non dire impossibile, e a sentire l’autore del volume
sopra citato con tutta probabilità infondato, scrive infatti:
«L’attribuzione del cognome Guidotti, con molta probabilità
è un falso storico o comunque frutto di una elaborazione
successiva della storia della sua vita….». C’è tuttavia una
espressione latina, rimastami nella mente sin dai tempi del
liceo, che, senza confermare nulla, lascia al lettore la possibilità di credere o non che le cose siano andate così: tradunt.
Inoltre, se può aiutare, il martirologio romano lo indica come
San Galgano Guidotti Diciamo quindi tradunt, e poiché dei
Guidotti ne abbiamo diversi blasoni, tenuto conto del nostro
interesse per l’araldica, mette conto riportarli, perché
mostrano un diffusione della famiglia in così tante regioni
d’Italia che rende ancor più difficile la determinazione del
particolare ramo d’origine del personaggio.
Tenuto conto però dal luogo d’origine dei diversi rami
iniziamo dai Guidotti di Modena
dei quali abbiamo le rappresentazioni sopra riportate. La
prima: D’azzurro alla fascia di rosso cucita, accompagnata in
capo da tre gigli ordinati in fascia ed in punta sei stelle (6)
poste 3,2,1 il tutto d’oro;
è l’arma tradizionale la altre sono varianti che si trovano in
documenti del 1796, in uno dei quali forse l’invasione
francese di quel periodo consigliò di far sparire i gigli che
potevano ricordare rapporti o legami con la casa reale di
Francia.
San Galgano Guidotti
Altro ramo assai importante della famiglia è il bolognese che a
sua volta ne diede origine a diversi altri:
Altro ramo è quello dei Guidotti di Lucca che presentavano
quest’Arma
Di questi stemmi il primo a sinistra è certamente vero:
D’azzurro a sei stelle (5) poste 3,2,1 col capo d’azzurro a tre
gigli d’oro fra i quattro pendenti di un lambello di rosso.
L’altro è indicato su internet come arma del ramo di Modena
ma sulla sua veridicità non si è certi in quanto si rifà all’arma
del ramo fiorentino dei Guidotti, che, come di seguito indicato presenta numerosi alias. I primi due
Troncato: nel primo d’oro, al leone leopardato d’azzurro, nel
secondo d’argento a tre pali d’azzurro.
Si potrebbe a questo punto continuare ancora a lungo perché
di questa famiglia esistono rami a Siena, a Pistoia, a Bari a
Messina, i Guidotti del Mugello, i Guidotti Magnani ed altri
ancora, Nell’armoriale delle famiglie italiane sono poi
riportati ancora altre stemmi o blasonature relative ai vari rami
della famiglia Guidotti, fra cui, seppure incompleta una descrizione del blasone del ramo senese, che per contiguità
territoriale potrebbe essere quello cui con maggiore probabilità avrebbe potuto appartenere il santo se fosse vissuto qualche tempo dopo, oppure pisana da quel che scrive il Moiraghi,
che fa presente come il vescovo di Volterra fosse anche
l’Arcivescovo di Pisa. Onestamente non si ha però nessun
elemento per indicare a quale dei rami della famiglia il santo
possa appartenere, tuttavia dato che l’origine di tutti i Guidotti
è nel ceppo modenese è a questo che in qualche modo sembra
dovercisi riferire.
La storia di questo santo per molti versi assomiglia a quella di
un romanzo, nato, fra il 1148 ed il 1150, da nobile famiglia a
Chiusdino, un paese nelle vicinanze di Siena, la tradizione
indica che venne investito quale cavaliere e che come tale
agisse alle dipendenze del Vescovo di Volterra, signore
feudale del luogo, per proteggere il paese da attacchi esterni e
mantenere l’ordine. Periodo nel quale si dimostrò superbo,
violento e dissoluto. Diede una svolta alla sua vita la morte del
padre, dopo la quale, secondo la deposizione fatta dalla madre
nel corso del processo di canonizzazione, ebbe delle visioni
mistiche che lo portarono ad un totale cambiamento nel suo
comportamento. Nella prima gli sarebbe apparso in sogno San
Michele Arcangelo, il capo supremo dell’esercito celeste degli
angeli fedeli a Dio che ha il compito di combattere le forze del
male, che lo avrebbe convinto a lasciare le armi sino allora
usate per entrare nella milizia celeste.
A
B
L’arma A: Inquartato, decussato nel 1° e 4° d’argento, al
crescente montante di rosso; nel 2° e 3° fasciato, ondato
d’azzurro e d’oro.
L’arma B: Inquartato, decussato nel 1° e 4° d’argento, al
crescente volto in banda di rosso; nel 2° e 3° fasciato,
ondato d’azzurro e d’oro.
C
D
L’arma C: Inquartato, decussato nel 1° e 4° d’argento, al
crescente montante di rosso; nel 2° e 3° fasciato, ondato
d’azzurro e d’oro; con il capo di rosso caricato di un
leopardo d’oro posto in mezzo a tre gigli dello stesso.
L’arma B: Inquartato, decussato nel 1° e 4° d’argento, al
crescente volto in banda di rosso; nel 2° e 3° fasciato,
ondato d’azzurro e d’oro; con il capo di rosso caricato di un
leopardo d’oro posto in mezzo a tre gigli dello stesso.
Sempre a Firenze si trova ancora un'altra arma dei Guidotti,
del tutto diversa dalle precedenti: D’oro al cervo saliente di
rosso.
2
In una seconda visione l’arcangelo lo avrebbe portato al
cospetto della Madonna e dei dodici Apostoli. Il terzo evento
decisivo ai fini del suo totale cambiamento di vita avvenne nel
viaggio cui sua madre lo aveva costretto per andare a visitare
la fanciulla designata su promessa sposa. Giunto ad un punto
del suo viaggio il suo cavallo rifiutò di andare avanti, dovette
tornare indietro e ritentò ancora il giorno successivo, qui la
scena si ripeté. Galgano allora si fermò in preghiera e chiese al
Signore perché il cavallo lo portasse dove avrebbe trovato la
sua pace spirituale. Giunto sulla collina di Montesiepi l’animale si fermò, Galgano comprese di essere giunto a destinazione e di dover entrare a far parte della milizia celeste, sfoderò quindi la spada e la conficcò nel terreno come una croce.
vita di san Gal gano costituisce l’elemento reale e morale di
maggior conte-nuto. Galgano diviene così il cuore simbolico,
e il modello di riferimento per la figura del cavaliere che
raggiunge l’apice della propria missione , trasformando la
spada nella croce della militia Christi».
Che dunque la storia di questo santo abbia in qualche modo
influito nella creazione e sviluppo delle avventure legate alla
ricerca del Santo Graal appare abbastanza plausibile e probabilmente attraverso i canali indicati sempre dal Moiraghi, attraverso gli scambi fra l’Europa centrale e Pisa, allora potenza
marinara di prima grandezza.
P.G.
I plenipotenziari del Regno di Sardegna a Cherasco
Era il Natale del 1180, si diede quindi all’esperienza eremitica
e l’anno successivo, dopo aver ottenuto da papa Alessandro III
il permesso alla fondazione di una comunità monastica, nel
novembre morì. Subito dopo la morte del santo a Montesiepi
venne costruita una cappella, al centro della quale si trova il
masso entro il quale il cavaliere infisse l’arma. Un paio di secoli dopo nella parte inferiore della torre campanaria venne
realizzata una cappella più piccola della precedente che fu affrescata dal Lorenzetti.
Nel frattempo, persone invidiose del gesto compiuto andarono
per svellere la spada ma non ci riuscirono, altri tentativi effettuati nel secoli seguenti sin quasi ai giorni nostri, non sono
riusciti a trarre la spada dal terreno in cui era stata conficcata.
L’ultimo tentativo fu infatti compiuto da un vandalo nel 1993
L’hanno rotta ma non sono riusciti ad estrarla. Esami scientifici hanno comunque accertato la presenza del metallo della
lama anche in profondità, mentre la spada, a giudizio di esperti che ne hanno esaminato la parte sporgente, corrisponde perfettamente ad una vera spada del XII secolo. Abbiamo quindi
in Italia, sulle colline a sud ovest di Siena, la nostra spada
nella roccia, frutto però non della poesia dei trovatori ma di
fatti che hanno solide prove di realtà.
Lo studio del professor Moiraghi a questo punto determina
una serie di identità fra la storia del Graal e quella di Galgano
e altrettante differenze tanto da fargli scrivere che: «la storia
del Santo toscano vive di una propria vita e proprie immagini, la cui connessione con la Bretagna o non esiste o pur
sembrando di esistere, deve essere rivista, perché na-scon
de significati reconditi». Infine tenuto conto che la vicenda di
Galgano è ricca di simboli cavallereschi, il professore
suppone che il Chretien e il Wolfram, rispettivamente autori
del Perceval francese (1190) e del Parzifal tedesco (1210) si
siano in qualche modo appropriati della sua storia. Afferma
infatti che «Se il complesso leggendario per-siano costituisce
la parte più consistente della futura materia di Bretagna, la
Nell’anniversario della firma del Trattato di Cherasco avvenuta nella notte fra il 27-28 aprile si è tenuta in questa cittadina piemontese la tradizionale rievocazione, che oltre a rivangare la vittoria dell’allora generale Bonaparte ha voluto richiamare alla memoria i plenipotenziari del re Vittorio Amedeo III
alla trattativa. Venne chiesto ad un membro della SISA d’intervenire sull’argomento e di seguito se ne riporta l’intervento.
La notte fra il 27 ed il 28 aprile 1796 con la firma della tregua
d'armi da parte dei due inviati sabaudi, il generale Giuseppe
Sallier de la Tour e il colonnello Enrico Costa di Beauregard,
si concluse la cosiddetta Guerra delle Alpi, iniziata nel 1792
con l’invasione da parte della Francia della Savoia e di Nizza,
senza essere preceduta da alcuna dichiarazione di guerra,
proseguita per quattro anni con una resistenza che indispettì i
Francesi che ritenevano di raggiungere in pochi giorni Torino
e che ebbe il suo epilogo sui campi vicino a Mondovì dopo le
vittorie riportate da Bonaparte sugli Austriaci a Montenotte,
Millesimo e Dego, che lasciarono isolato l'esercito sardo. La
cui sorte era segnata ma che malgrado fosse con reparti ridotti
a meno della metà della forza organica mostrò sulle colline attorno a Mondovì una combattività ed una compattezza che
meravigliò lo stesso avversario: quei soldati, fra cui certamente erano molti antenati dei presenti, fecero molto di più di ciò
che era lecito aspettarsi dalle loro condizioni, in quell'ultima
battaglia si battevano infatti per difendere le loro case e la loro
patria. Anche se consci di dire una cosa in contrasto con gli
storiografi sia del tempo, sia risorgimentali sia di gran parte
dei contemporanei, furono loro i veri patrioti, non coloro che
sono stati ammantati di questo titolo una volta giunti i
Francesi per aver indossato il berretto frigio ed essersi rivoltati
contro l’autorità costituita dopo essere stati foraggiati dagli
invasori e guidati da alcuni rinnegati.
La battaglia di Mondovì
3
Nella piana di Mondovì dopo una difesa accanita i resti
dell’esercito piemontese si piegarono alla superiorità numerica
dei Francesi, al terzo attacco essi sfondarono le linee
piemontesi e non vi fu più nulla da fare se non ripiegare e
chiedere una tregua d’armi. Il generale Colli, l’ufficiale
dell’esercito austriaco imposto quale comandante dell’armata
austro-sarda, non poteva evidentemente essere il
plenipotenziario del re Vittorio Amedeo III, fu così scelto per
andare a trattare l’armistizio coll’allora generale Bonaparte, il
generale Giuseppe Sallier de la Tour di cui il sovrano aveva
profonda stima e fiducia, al quale si affiancò Enrico Costa di
Beauregard che come capo di Stato maggiore dell’armata
meglio di ogni altro conosceva la situazione.
Arma Costa di Beauregard
Quest’ultimo discendeva da una famiglia che sin dalla prima
metà del Seicento si era posta al servizio dei Duchi di Savoia,
figlio di un appassionato agronomo aveva scelto di
intraprendere la carriera militare ed aveva raggiunto il grado
di capitano divenendo fra l'altro un eccellente topografo. Dopo
il matrimonio e l’arrivo dei figli, cambiò i gradi di capitano
con l'incarico di gentiluomo di camera di S.M. che gli lasciava
più tempo per dedicarsi alla famiglia. La sua posizione
rispetto alle idee portate dalla rivoluzione francese non era del
tutto contraria vedeva positivamente quelle di rinnovamento in
merito alla giustizia sociale, ma non accettava minacce, né
cambiamenti di sovranità, né di mettere in discussione
l'autorità del sovrano cui era pronto a dare la vita. All'inizio
del 1792, quando la minaccia francese si fece sentire più
pressante volle rientrare anch'egli nell'esercito e per ottenerlo
dovette penare molto. L'incarico di gentiluomo di camera del
re era incompatibile con quello di ufficiale, dovette quindi fare
una lunga trafila burocratica per essere esentato da questo
incarico ed essere riammesso nelle file dell'esercito, dove
rientrò col suo grado. Fu testimone dell'invasione della Savoia
nel 1792 e della inettitudine del generale Lazary che non fu in
grado di organizzare un minimo di resistenza malgrado avesse
ai suoi ordini truppe eccellenti. Nel 1793 entrò nel reggimento
dei Granatieri Reali dove divenne prezioso collaboratore del
suo comandante il colonnello Bellegarde. Nell'aprile del 1794
era sull'Aution col figlio Eugenio sottotenente dei Granatieri, i
Francesi entrati nel territorio della neutrale repubblica di
Genova presero alle spalle le difese piemontesi, durante i
combattimenti il figlio venne ferito e a seguito della ferita
morì qualche giorno dopo, sostituito dal fratello Vittorio, poco
più che quattordicenne. Il re per il suo comportamento durante
la ritirata al Colle di Tenda, lo promosse maggiore e l'anno
dopo tenente colonnello ed accolse la richiesta del generale
Colli di averlo come capo di Stato Maggiore. Nell'ottobre del
1795, i Francesi battuti gli Austriaci a Loano li costrinsero a
lasciare la Liguria, si rivolsero quindi contro i Piemontesi
schierati sulla displuviale delle montagne fra Piemonte e
Liguria, e risalendo per le valli che dalla costa scavalcano le
Alpi Liguri li presero sul fianco e sul tergo costringendoli ad
4
una ritirata durante la quale dovettero aprirsi il passo combattendo per raggiungere Ceva e Mondovì. Il Costa di Beauregard fu quindi chiamato dopo questo all'opera di riordinamento delle unità piemontesi fra mille difficoltà e fece il
possibile. Nella seconda decina di aprile del ‘96 i Francesi
battuti gli Austriaci investirono le posizioni piemontesi attorno
a Mondovì, le truppe fecero quel che poterono come ho già
detto. Poi fu inviato a Cherasco ad affiancare il generale de la
Tour per le trattative dell’armistizio. In merito alle quali scrisse nella lettera che indirizzò alla moglie: «Ho passato una
notte terribile. Ho firmato per ordine del re una tregua d’armi col generale Buonaparte alle condizioni più umilianti e
più pericolose … il tutto aspettando che si compiaccia di
darci una pace a suo capriccio … C’è da morire di rabbia e di
vergogna.». Dopo la firma della pace pur essendo savoiardo
non fu espulso dal Piemonte perché un articolo segreto del
trattato di pace consentiva al sovrano di poter utilizzare i
savoiardi già al suo servizio. Così riprese il suo incarico, e fu
chiamato a ricostituire la forza armata, parte della quale fu
inviata a combattere a fianco dei Francesi contro gli Austriaci,
poi quando il generale Brune, che aveva sostituito Napoleone,
volle chiudere la partita e costrinse il sovrano sabaudo a rinunciare al trono ed a partire per la Sardegna, rimase al suo posto
secondo gli ordini ricevuti. All’arrivo dei Russi guidati dal
Suworof con la parte di quel rimaneva dell'esercito si schierò
con essi e venne nominato quartiermastro generale dell'esercito, poi la politica di Vienna che voleva mano libera in Italia
fece sì che Suworov fosse dirottato altrove, il ritorno di Napoleone e la battaglia di Marengo misero poi fine alla speranza
di liberarsi dei portatori della libertà. Nei 14 anni che passarono fra Marengo e la fine del dominio francese, visse in ritiro, ospite con la moglie e la famiglia a casa del cognato. La
sua opera fu preziosa nel 1814, nel momento in cui giunsero le
truppe austriache in Savoia, perché con l’autorità che gli derivava dai suoi trascorsi impedì ogni ritorsione contro quella
parte della popolazione che, indottrinata da 20 anni di propaganda filo francese, aveva fatto opposizione, ciò malgrado che
i rivoluzionari filo francesi gli avessero messo in prigione il
padre, che a seguito delle torture subite era morto, e confiscato
le proprietà. Il re nel ’14 per il suo passato lo promosse maggior generale, lo nominò capo di Stato Maggiore e Quartiermastro generale ma preferì non tornare in servizio.
L’altro plenipotenziario sabaudo, il più noto, era Giuseppe
Amedeo Sallier de la Tour, appartenente ad una famiglia che
da tempo aveva fornito a Casa Savoia magistrati, diplomatici e
militari. Entrato, nel 1745, ancora tredicenne quale sottotenente nel reggimento dei Dragoni del Genevese combatté
nella guerra di successione d’Austria, comportandosi molto
bene, dopo la guerra proseguì in carriera, salendo sino al
grado di maggior generale, mantenendo, anche da generale
come accadeva allora, il comando del suo reggimento.
A
B
A: Arma dei Sallier de la Tour. B: Arma indicata dal de Foras
per i Sallier de la Tour decorati dell’Ordine della SS.ma
Annunziata
Se si scorrono le patenti con le quali vengono motivate le sue
promozioni si leggono ripetute le parole, zelo, applicazione,
esattezza, lodevoli saggi di fermezza, doti che lo avevano
fatto grandemente apprezzare al sovrano. Ma poiché è
soprattutto in guerra che si fa la fama di un generale, egli se la
acquistò nel 1793 nella campagna per il tentativo di
riconquista della Savoia. Era agli ordini del fratello, Vittorio
Amedeo, comandante del corpo d’armata della Val di Susa,
chiamato a concorrere all’azione del corpo comandato dal
Duca di Monferrato che avrebbe attaccato i Francesi passando
dal Piccolo S. Bernardo, mentre egli sarebbe passato per il
Moncenisio. Giuseppe de La Tour ebbe il comando
dell’avanguardia e scendendo dal Moncenisio si fece strada
rapidamente con ardite manovre tanto che ebbe l’ordine di
andare a raggiungere la colonna del Duca di Monferrato con la
quale raggiunse Moutiers dove dovette fermarsi, perché il
principe, secondo le direttive della Corte, venne chiamato a
diffondere proclami senza andare ancora avanti, nella speranza
che minacce e lusinghe avrebbero convinto i Savoiardi ad
insorgere contro i Francesi, cosa che non avvenne, perché chi
venne mandato ad organizzare le rivolte fu lasciato senz’armi
e senza denaro. Poi a fronte della controffensiva francese
guidata dal generale Kellerman, al de la Tour fu affidato il
compito di comandare la retroguardia per proteggere il
ripiegamento del grosso delle forze oltre il San Bernardo.
Compito che assolse egregiamente, tanto che poco dopo a
riconoscimento della sua bravura venne promosso tenente
generale. Nel maggio del 1794 ebbe il comando del corpo
d’Armata della Valle di Susa, in un momento particolarmente
critico, perché i Piemontesi avevano perso il Moncenisio,
parte delle valli di Susa e del Chisone sino all’altezza di
Exilles e Fenestrelle. Seppe mantenere le posizioni e
nell’inverno fra il 94 ed il 95, riconquistò gran parte del
terreno perso. Nel febbraio del ’95 fu a capo della delegazione
che a Milano con l’Arciduca Ferdinando definì la
pianificazione operativa per la campagna dei mesi successivi e
in aprile assunse il comando del corpo d’armata che presidiava
il settore montano dal Colle di Tenda alla Val Germanasca,
riuscendo a respingere i tentativi francesi di guadagnare
terreno in quel settore. Nel febbraio del ’96, alternando
compiti di comando ai diplomatici, fu inviato a Vienna a
pianificare la campagna del ’96, dove fece ogni sforzo per
convincere gli Austriaci ad intervenire in forze, non poteva
credere che essi, a partire dall’Imperatore, mentre
assicuravano di aver già avviato in Italia consistenti rinforzi e
di essere pronti ad inviarne altri, non avessero in realtà alcuna
intenzione di far fronte agli oneri che a parole dicevano di
volersi assumere, perché, come scrisse l’ambasciatore
piemontese alla corte austriaca, “il carattere franco e leale di
questo valoroso ed onesto soldato è tale che gli ripugna di
non credere alle assicurazioni delle persone con cui sta
trattando”. Quando tornò in Piemonte ai primi di aprile era
già in corso l’offensiva francese. Il 13 aprile fu incaricato dal
re di raggiungere ad Acqui il generale austriaco Beaulieu, che
aveva il comando dell’armata austriaca da cui dipendeva
anche la piemontese, per concordare il da farsi, vi giunse dopo
le sconfitte di Montenotte e Millesimo e alla notizia di quella
di Dego, qui trovò una situazione di caos totale dalla quale era
chiaro che gli Austriaci avrebbero cercato solo di salvare il
salvabile dei resti del loro esercito. Il re gli dette allora ordine
di raggiungere il generale Colli e di assumere il comando delle
truppe piemontesi se questo si fosse dato ammalato o si fosse
assentato, aveva presentato infatti le sue dimissioni a Vienna.
Giunse a Mondovì nel pieno della battaglia ma poiché il
generale Colli era al suo posto, non tirò fuori dalla tasca il
foglio della sua nomina. Assisté qui alla disperata resistenza
delle truppe piemontesi di cui ho già detto. Il 27 aprile
ricevuta la lettera con la quale il re lo incaricava di andare a
trattare l‘armistizio con Bonaparte scrisse al sovrano: «…il
gen. Colli mi ha consegnato la lettera del Marchese di
Cravanzana in data di oggi il cui contenuto è l’ordine di V.M.
di recarmi subito dal generale Bonaparte per trattare un
armistizio. Obbedisco e parto all’istante, assicurando a V.M. il
mio zelo, ma osservando che il Marchese di Cravanzana che
era certo a conoscenza delle intenzioni di V.M. riguardo alle
condizioni dell’ armistizio da proporre, non me le ha fatte
conoscere, e che la memoria allegata alla sua lettera non
contiene che vaghi cenni sugli aspetti d’interesse, ma un solo
ordine preciso concludere e firmare l’armistizio, temo che il
mio zelo non potrà rimpiazzare questa mancanza
d’istruzioni». Ciò spiega le difficoltà in cui venne a trovarsi e
la necessità di dover accettare le durissime condizioni
dell’armistizio, cui seguì la pace di Parigi del mese dopo.
Dopo questo ebbe un periodo di stasi, i sovrani preferirono
averlo accanto piuttosto che fuori Torino, poi nel dicembre del
’97 fu nominato governatore della città e provincia di
Alessandria, area di grande importanza strategica per la
sopravvivenza del Piemonte. Nel dicembre del 1798 alla
partenza dei sovrani per la Sardegna si ritirò a vita privata. Fu
però uno spazio breve perché nel maggio del ‘99 quando le
truppe del generale Suworov riconquistarono il Piemonte,
liberandolo dai Francesi, nel maggio venne investito di tutti i
poteri in campo militare, politico ed economico che cedette
poi a Thaon de Revel quando questi fu nominato
Luogotenente Generale del Re e a lui venne affidato il
compito di ricostituire l’esercito, cosa che gli riuscì bene,
tanto che le truppe regie, insieme alle austriache batterono più
volte i Francesi e giunsero a riconquistare Nizza. Venne
premiato per questo con l’Ordine Supremo della Santissima
Annunziata di cui fu insignito nel novembre del ‘99. Al
ritorno dei Francesi guidati da Napoleone, dopo Marengo,
mentre il figlio Vittorio Amedeo si arruolava nell’esercito
austriaco per continuare a combattere contro l’invasore, lui si
mise a riposo. La sua fedeltà fu riconosciuta alla
Restaurazione quando venne nominato Maresciallo di Savoia.
Due belle figure di ufficiali dell’antico esercito di Sardegna,
ambedue Savoiardi quasi a voler sottolineare la fedeltà di
questi antichi sudditi della dinastia sabauda, che seguirono
passo a passo con indomabile energia tutte le vicende di quel
sanguinoso dramma, non piegati dal dolore delle perdite
familiari e dai problemi economici conseguenti alla confisca
dei beni, cui venne affidato uno dei compiti più duri per un
soldato che aveva speso tutto se stesso per il suo paese al di
sopra del limite delle sue possibilità, e che ben
rappresentavano le migliaia di uomini che avevano combattuto
non tanto contro le nuove idee ma per difendere le proprie
case da un’aggressione ingiustificata e dai saccheggi che ne
seguirono.
MDB
5
Il CAVALLO,
fra le più belle conquiste dell’uomo
Il cavallo insieme al leone ed all’aquila è uno degli animali
araldici per eccellenza. Può venire rappresentato sia montato
da un cavaliere armato e bardato secondo l’uso del tempo
oppure più semplicemente nudo e anche in questo caso in
varie posture, allegro, spaventato, inalberato. Riguardo la
simbologia un noto antico araldista scrisse :«Il più nobile che
si pone nell’arme egli è il cavallo, per cui cominciarono i gesti
eroici di que’cavalieri che i loro nomi resero immortali. Ei fu
dedicato al Sole e a Marte, essendo un animale bellicoso e
magnanimo, che però indica magnanimità e vittoria, ed è
verace contrassegno del cavaliere».
Si vuol qui prima di riportare l’interessante articolo del
Generale Massimo Jacopi, già comandate delle Batterie a
Cavallo, che traccia un sintetico profilo del ruolo del cavallo
attraverso i secoli, ricordare almeno alcune delle forme in cui
viene rappresentato
fermo
inalberato e brigliato
spaventato
6
allegro
Dopo questa breve parentesi araldica il lavoro del Generale
Jacopi,
ALFS
Il rinnovato interesse da parte dell’uomo per il cavallo
costituisce una occasione per raccontare il ruolo essenziale
del cavallo nella storia dell’uomo e della società.
I cavalli che ornano i vari siti archeologici del mondo, a fianco
dei bisonti, degli orsi e dei cinghiali, ci ricordano che nel
paleolitico superiore gli uomini cacciano il cavallo per nutrirsi. Il suo addomesticamento risalirebbe a circa 5.500 anni
fa. Le più antiche vestigia archeologiche che l’attestano si trovano in Asia centrale, nel nord del Kazakistan, sul sito di
Botai.Il cavallo, presente allo stato selvaggio nel continente
asiatico, viene introdotto addomesticato in Cina, in Asia
occidentale, in Europa ed in Africa, con l’avanzare delle tribù
nomadi.
L’equitazione o l’arte di montare a cavallo appare solamente
nel’Antichità, quando l’uomo scopre che egli può utilizzare la
potenza e la rapidità della sua cavalcatura per spostarsi, per
cacciare e combattere i suoi nemici. Le prime rappresentazioni
artistiche dei cavalli addomesticati compaiono in Mesopotamia, fra il 2300 ed il 2100 a.C., sotto l’impero degli Accadi.
A partire da -2° millennio, due popoli del Vicino Oriente, i
Kassiti e gli Hurriti, contribuiranno allo sviluppo dell’allevamento del cavallo. Diventato un animale di prestigio, per la
sua utilizzazione militare e cinegenetica, il cavallo diventa
l’oggetto di una trattatistica specializzata. Per gli Egiziani esso
è, ad esempio, contrariamente all’asino, bestia da soma per eccellenza, una creatura nobile e coccolata.
L’armata dell’imperatore Qin
Il cavallo da guerra sarebbe stato introdotto in Egitto dagli
Hyksos, provenienti dall’Asia, allo stesso tempo del carro
intorno al -17° secolo prima della nostra era. Fino ad allora,
gli Egiziani lo impiegavano solamente per dei compiti,
diciamo civili. All’epoca del Nuovo Impero, la battaglia di
Kadesh, che ha luogo nel -14° secolo nel sud della Siria
attuale, costituisce uno degli esempi più conosciuti dell’impiego in massa dei carri da combattimento. Essi contribuiscono ad evitare il peggio a Ramesse 2° di fronte agli Hittiti, superiori di numero. Un celebre bassorilievo del tempio di
Abu Simbel rappresenta il faraone sul suo carro alla testa della
sue truppe speciali.
spaventato
corrente
Il poema intitolato La terza battaglia di Kadesh evoca l’amore
per i due cavalli del suo attacco e precisa anche i suoi nomi:
“Vittoria a Tebe” e Mut è soddisfatto”. Gli Hittiti dominano
anche loro l’arte dell’addestramento del cavallo. I documenti
più antichi conosciuti, che trattano della maniera di seguirli e
curarli, sono dovuti a Kikkuli, un cavaliere hurrita, al servizio
degli Hittiti. I metodi di allevamento moderni si ispirano ancora a questo testo. Il cavallo da guerra è così entrato nella storia
dell’umanità. Nel -853 il re assiro Salmanazar 3°, impegna
nella battaglia di Qarqar, sempre in Siria, 2 mila carri e 5.500
cavalieri, con i quali affronta le truppe a cavallo e cammellate
della coalizione dei regni di’Egitto di Siria e d’Israele.
In Cina - dove il cavallo, spesso associato al dragone,
rappresenta un animale celeste - il primo imperatore Qin Shi
Huang-di, che regna dal -221 al -210, si fa costruire un
mausoleo a misura della sua megalomania. Negli anni 1980,
gli archeologi hanno riportato alla luce, nei pressi di Xian, su
una superficie di circa 21 mila m2, un esercito di terracotta a
grandezza naturale. In tale contesto, risultano allineati, come
in una parata, 130 carri da combattimento in legno, centinaia
di cavalli alti m. 1,50 e più di 8 mila soldati in armi. Qin,
unificatore dell’immensa Cina, non avrebbe certo portare a
buon fine la sua opera senza l’impiego del cavallo.
Bucefalo sia morto per le ferite riportate nella battaglia di
Hydaspe nel -326, oppure sia vissuto fino a 30 anni. In ogni
caso il suo proprietario lo innalzerà al rango di dio e fonderà
sulla sua tomba la città di Bucefalo, al giorno d’oggi Phalia
nel Pakistan.
Alessandro Magno ed il suo cavallo Bucefalo
I cavalli dell’Imperatore Qin
In Occidente, dove l’uso della staffa e della sella,
contrariamente all’Asia, risulta ancora ignorato, i Greci ed i
Romani impie-gano ugualmente dei carri con attacchi, sia per
la guerra, come anche per le corse nei circhi. Un celebre
cratere di Vix, probabilmente fabbricato in un laboratorio
greco dell’Italia del sud, mostra 8 quadrighe, ovvero un carro
da combattimento a due ruote ed un attacco di quattro cavalli
di fronte.
Cavalleria leggera o pesante
La guerra da quel momento si svolge anche a cavallo. Gli
Assiri sono i primi a sviluppare una cavalleria, seguiti dagli
Sciti. Essa viene denominata “leggera”, in quanto costituita da
combattenti senza armatura, dotati di arco e di armi da getto,
per contrapporla alla cavalleria “pesante”, che sarebbe stata
istituita, sai dai Persiani, sia dai Sarmati. La necessità di
proteggere gli uomini ed i cavalli porta a selezionare delle
razze capaci di sopportare il peso di una corazza. Questi
cavalieri e le loro monture, pesantemente protetti e designati
con il termine di “catafratti”, vengono impiegati per sfondare
le formazioni della fanteria nemica. La maggior parte dei
popoli dell’Eurasia occidentale, dai Parti ai Bizantini,
passando poi per i Romani sotto l’Impero, hanno sviluppato
questo tipo di formazione, antenata della cavalleria medievale.
Essa costituisce l’arma decisiva delle truppe macedoni di
Filippo 2° di Macedonia e di suo figlio Alessandro Magno.
Ed è proprio in sella a Bucefalo, che Alessandro conquista il
suo impero fino all’India. Non sappiamo esattamente se
Un'altra cavalleria celebre è quella costituita, più di 10 secoli
dopo da Carlo Magno. Il suo sviluppo deve molto allo
scontro frontale degli eserciti carolingi con i cavalieri
provenienti dall’Asia centrale, gli Avari, che minacciano le
frontiere occidentali dell’Impero. Ogni tribù dispone di una
cavalleria pesante, formata da guerrieri che indossano la
corazza e che maneggiano la lancia e da cavalieri più mobili,
muniti di arco a doppia curvatura, ai quali è attribuito io
compito di molestare ed assillare il nemico. Se forse gli Avari
non possono essere considerati gli inventori della staffa,
nondimeno essi sono quelli che l’hanno introdotta in
Occidente. La staffa, accessoria dell’arte equestre, conferisce
al cavaliere un migliore assetto e gli consente di caricare,
armato di lancia e della sua spada, che mantiene a due mani.
Allo stesso modo, la comparsa della sella foderata e dei ferri
da cavallo per proteggere i piedi dei cavalli, due oggetti la cui
esistenza viene attestata in Europa nel 10° secolo. Il celebre
Arazzo di Bayeux (il famoso telo ricamato che narra la
conquista dell’Inghilterra da parte dei Normanni nel 1066), ci
evidenzia che ben 202 quadrupedi (cavalli e muli) facevano
parte della spedizione del duca Guglielmo di Normandia.
Arazzo di Bayeux - Particolari
7
Il cavallo nel Medioevo, animale nobile per eccellenza, viene
ricordato nella letteratura epica, come il cavallo Broiefort, la
fedele cavalcatura di Ogier o Ogerio, compagno di Carlo Magno o come il cavallo Baiardo, dotato di poteri magici, figura
della chanson de geste delle Ardenne, da non confondersi con
il Baiardo, cavaliere “senza macchia e senza paura”, di ben 5
secoli più tardi.
Nella società medievale, il cavallo viene designato con diversi
termini a secondo il suo ruolo: “destriero”, animale di grande
taglia, impiegato nei tornei ed, in teoria, per il combattimento.
In realtà il suo prezzo d’acquisto molto elevato gli risparmia le
cariche sanguinose. Il “corsiero”, certamente meno oneroso,
gli viene generalmente preferito. Questo, rapido e più leggero,
viene anche particolarmente apprezzato per la caccia. Alla fine
del Medioevo, l’animale viene bardato con placche di ferro,
così come l’uomo che lo monta e sarà una delle ragioni della
disfatta francese di Crecy nel 14° secolo. Gli arcieri inglesi
hanno, infatti, vinto la cavalleria pesante, attaccando i loro
cavalli e successivamente eliminando i cavalieri immobilizzati
sotto il peso delle loro armature. Ma non si deve confondere il
destriero ed il corsiero con il “palafreno”, cavalcatura di
prestigio per la parata, mentre il robusto “ronzino” è adibito al
trasporto di pesanti carichi. Quest’ultimo, considerato comune
e di poco valore, costituisce il cavallo dei cavalieri poveri e la
cavalcatura degli uomini d’arme. Per quanto concerne il bravo
cavallo da soma costituisce un animale da tiro o da basto,
mentre la giumenta è il piccolo cavallo con andatura ambia,
preferito dalle dame più ricche dell’aristocrazia.
A partire dal 16° secolo, il declino della cavalleria porta ad
una relativa minore importanza della cavalleria pesante a
vantaggio di quella leggera. I cavalieri, molto mobili, vengono
armati con armi bianche o da fuoco. I conquistadores spagnoli,
arrivati con le loro cavalcature, reintroducono sul suolo americano il cavallo, scomparso nell’era glaciale. Gli animali,
diventati nuovamente selvaggi, popoleranno le grandi piane
del nord e verranno addomesticati dalle tribù indiane americane. L’indiano ed il suo cavallo sono ormai pronti per entrare
nella leggenda dell’Ovest americano.
Cariche … al trotto
In Europa, quando si dice cavalleria, la si abbina di norma ad
un modo di vivere determinati valori ed in caso di conflitto
alla … carica. Il termine evoca da solo, nella memoria
collettiva, i cavalieri lanciati al galoppo sui campi di battaglia.
Una rappresentazione, parzialmente inesatta. In realtà. L’andatura e lo sviluppo della carica varia a seconda dei reggimenti e delle epoche. In effetti, secondo quanto riferisce un
esperto cavaliere (1): “L’addestramento degli uomini e delle
cavalcature, capaci o meno di sostenere le più veloci andature, il peso delle armi difensive, la scelta e le armi da fuoco o delle armi bianche costituivano altrettanti elementi che
spiegano perché i corazzieri degli inizi della Guerra dei 30
Anni caricavano al trotto e che i cavalieri di Carlo 12° di
Svezia (re, 1697-1718) caricavano al galoppo”. La carica al
galoppo diviene di nuovo l’andatura delle cariche di cavalleria
dell’Europa dell’Ovest solamente a partire dalla seconda metà
del 18° secolo, sotto la pressione del re di Prussia, Federico
2°, che lancerà sistematicamente i suoi squadroni al galoppo.
Dai corazzieri di Napoleone alle Guerre Mondiali
Le cariche della cavalleria della Grande Armée di Napoleone
contribuiranno a forgiare la leggenda imperiale. La più grande
e la più celebre è stata quella del maresciallo Gioacchino
Murat ad Eylau, alla testa di 8 mila cavalieri, l’8 febbraio
1807; forse la più gloriosa è da considerare quella del ge8
nerale Lassalle, ucciso a Wagram il 6 luglio 1809. I reggimenti di corazzieri e di carabinieri, protetti da corazze e da
elmetti e montati su dei possenti cavalli, vengono utilizzati per
gli attacchi frontali.
Scontro di cavalleria alla battaglia di Wagram (1809)
Il generale Lassalle guida la sua ultima carica a Wagram
I Dragoni, sebbene facciano parte della cavalleria pesante - o
grossa cavalleria - essi sono sprovvisti di corazzetta. La cavalleria leggera è costituita da ussari, lancieri, cavalleggeri e da
cacciatori. Il loro compito è quello di assillare l’avversario, a
colpi si sciabole e con cariche improvvise e ripetute sui fianchi.
La carica dei Dragoni del Re a Carassone (1796)
Le cariche vengono condotte in formazione o in ordine sparso
e vengono, di norma, lanciate sull’artiglieria e sulle
retroguardie, allo scopo di disorganizzare le formazioni avversarie. Il cavallo, cavalcatura del combattente, viene anche
utilizzato per il trasporto del materiale, dei viveri, dei feriti …
dei bagagli degli ufficiali superiori e dei generali. Un
elemento, tratto da un dizionario militare della fine del 19°
secolo, precisa che un cavallo posto in attacco per il traino,
può tirare un carico di 700 Kg. per 10 ore al giorno.
Durante la Grande Guerra sono presenti un gran numero di
cavalli al fronte e la mobilitazione di guerra (acquisti e
requisizioni) riguarda anche il quadrupede. Questa presenza
importante del cavallo riflette il posto ancora rivestito
dall’animale in una società in corso di industrializzazione, ma
sostanzialmente ancora rurale. La grande maggioranza degli
animali viene impiegata per la trazione. Gli equidi (cavalli o
muletti), nei terreni accidentati o bombardati, dimostrano la
loro efficienza e la loro adattabilità. Nel corso della guerra
l’effettivo dei cavalli andrà progressivamente diminuendo, pur
rimanendo quasi costante quello dell’artiglieria.
La cavalleria italiana dopo Caporetto va a far fronte al
nemico
I progressi della meccanica, con l’impiego dei veicoli
motorizzati, porteranno alla scomparsa progressiva delle unità
di cavalleria e della trazione ippomobile nel corso della 2^
Guerra Mondiale ed in tale contesto, le cariche della cavalleria
polacca, contro i carri tedeschi nel settembre 1939 (ripetizione
delle cariche contro i corri sovietici del 1934) e le cariche
italiane di Isbuschenskij e di Jagodnij, dell’estate 1942, entreranno a far parte della leggenda.
Da ultimo, vale la pena ricordare come, al termine della 2^
Guerra Mondiale, molti ufficiali di cavalleria abbiano sofferto
la fine della Cavalleria, per così dire “storica” ed abbiano accettato con perplessità e grande pena di vedere la loro Arma,
definitivamante separata dal loro secolare e fedele partner, il
cavallo.
Fra questi sembra opportuno citare, a titolo d’esempio, il valoroso maggiore delle Voloire, Emiliano Vialardi conte di Sandigliano (2), reduce d’Africa e partigiano, che nel 1947, decide di lasciare il servizio attivo, lasciandoci questo poetico brano, dal titolo “Tutto è finito”:
“Ed ora tutto è finito. La benzina ha annegato i cavalli e s’è
portata via tutta la bellezza, tutta la poesia, tutta la giocondità
che erano con loro. Le ruote veloci dei trattori villani
sconvolgono quei terreni di brughiera sui quali gli zoccoli dei
nostri cavalli sfioravano appena le erbe rade, nel disteso
galoppo. Rumori di ferraglia, fracasso di arroventati motori,
stridio di freni hanno avuto facile vittoria sull’armoniosa
eleganza dei cavalli ed una massa d’acciaio di un triste grigio
informe ne ha per sempre nascosto gli splendenti colori dei
mantelli. Sulle centenarie tradizioni è passato un vento
d’uragano, che porta il nome di progresso e può ben darsi che
di tante cose belle fosse ineluttabile la fine nel precipitoso
evolversi degli ultimi tempi, anche se qualcosa ancora si
sarebbe potuta salvare, solo che i nostri generali di Roma non
fossero stati così proni ai deliranti ordini del caporale di
Predappio. Con un frego di penna ti stroncarono memorie e
costumanze, gelosamente conservate nei più gloriosi
reggimenti, sostituendo – udite, udite – i laceri e scoloriti
stendardi, che ti facevano piangere a vederli passare, con
altri che ti facevano chiudere gli occhi, tanto erano fiammanti
nella chiassosità delle tinte. Si mutarono regolamenti sanciti
dall’esperienza di molti e molti anni, si tacquero le storie
delle antiche guerre piemontesi e si cominciò alacremente a
distruggere l’Esercito Italiano. Tutto è finito !
Sulle strade corrono adesso le jeeps americane e coprono di
polvere l’epopea dei vecchi cavalli.
Tutto è finito !”
Con questi pensieri pieni di amarezza, di nostalgia e di rimpianto, il maggiore Vialardi, piemontese d’origine e monarchico per cultura e tradizione familiare, lascia un mondo, quello della cavalleria senza i cavalli, che non è più il suo !!
In effetti, la Cavalleria scende da cavallo, le scuderie vengono
trasformate in rimesse per carri armati, i maneggi vengono
asfaltati e … niente più nitriti e tintinnio di speroni .
NOTE
(1) Chauviré Frederic, “Il cavallo nella storia militare”, n.
249 della Revue Historique des Armees del 2007;
(2) Gen. Emiliano Vialardi conte di Sandigliano (Moncalieri
1898 - 1978 Torino) dal suo quaderno di memorie, intitolato
“Commiato”.
Massimo Jacopi
- Spigolature Melitensi -
Nella così ricca produzione storiografica relativa all’Ordine
Giovannita che, voglio ricordare : « Prima di essere militare e
religioso era stato ospedaliero» così come ricordava il re
Ruggiero di Sicilia che, fondando la Grancia di Messina, a
vantaggio dei cavalieri di S. Giovanni, invocava la «maledizione dei trecentodiciotto santi di Dio » sopra chiunque ne
avesse violato i privilegi… e che ben due bolle, una di Pio IV
e l’altra di Pio VI, esentavano da ogni giurisdizione laica ed
ecclesiastica e da ogni tribunale, anche di legati pontifici o di
eminentissimi cardinali, l’Ordine di Malta… trovo alcune
curiosità storico-cerimoniali che, mi piace, evidenziare,
all’attenzione del lettore.
Trattasi di realtà «a sé stanti», del tutto particolaristiche, degne
di non cadere nell’oblio!
9
Un cappellano conventuale pronuncia i voti al fine di
essere ricevuto quale cavaliere dell’Ordine di Malta.
Questa risulta essere una “curiosità religiosa”, per il fatto che
«i cappellani conventuali raramente prestavano i voti di
professione ».
I tre voti sembravano, per questi sacerdoti, quasi inutili, in
quanto, essi, li avevano già pronunciati essendo chierici.
Tuttavia questa professione li faceva “transitare” dal clero secolare a quello regolare e dava loro il diritto di poter ricevere
una commenda.
L’Ordine, da parte propria, cercava di scoraggiare tali generi
di vocazioni !
La cerimonia si svolgeva nella chiesa magistrale della villa
sull’Aventino (dopo la definitiva collocazione dell’Ordine a
Roma). La messa era celebrata da un arcivescovo.
Il Gran Maestro, vestito con il gran mantello nero e larghi
paramenti grigi, portava il gran collare d’oro e sedeva, in coro,
sotto il proprio baldacchino accanto al Vangelo.
La sopravveste grigia, decorata con la grande croce ricamata
di bianco, si presentava al disotto del mantello.
Appese attorno al baldacchino erano collocate le bandiere
delle varie lingue e quella, più grande, dell’Ordine.
Facevano coro al Gran Maestro i membri del Sovrano Consiglio allocati nei banchi ricoperti di drappi rossi.
Vestivano, anch’essi, l’abito da cerimonia con il mantello nero
ornato della croce bianca di lana posta sulla spalla sinistra.
Sul braccio sinistro portavano una larga stola gialla ornata
degli “strumenti della passione” e, dall’apertura del mantello,
si poteva intravedere la tunica gialla dei Balì e quella rossa dei
commendatori.
Sui banchi delle navate spiccavano le uniformi degli altri
dignitari:
i cavalieri di giustizia con i propri paramenti bianchi; i donati
di giustizia con i loro paramenti verdi; i cavalieri d’onore e
devozione con i loro paramenti neri.
Le dame d’onore e devozione con la piccola croce appuntata
sul petto.
Terminata la Messa, il postulante, in mezzo a due padrini,
inginocchiato davanti al Gran Maestro chiedeva quindi di
essere ricevuto ed ammesso nella compagnia dei fratelli della
Sacra Religione dell’Ospedale di S. Giovanni di
Gerusalemme.
Dopo aver risposto a varie domande di rito, poste dal Gran
Maestro, quest’ultimo pronunciava la formula solenne: « Vi
riceviamo quindi con affetto e non vi promettiamo che pane
ed acqua, fatiche e disagi e semplice vestimento».
Quindi, dopo aver assestato un piccolo schiaffo al postulante
che, con le mani appoggiate sul Vangelo, pronunciava la
formula di giuramento: «faccio voto a Dio Onnipotente ed alla Gloriosa Vergine Maria ed al Santo Giovanni Battista, di
osservare e mantenere l’obbedienza, la povertà e la castità come si conviene a tutti i buoni religiosi cattolici», il Gran Maestro, preso il mantello nero gli mostrava la croce bianca ad
otto punte dicendogli: «Questa croce ci è stata data bianca in
segno di purezza. Le otto punte, che vedete, sono il simbolo
delle otto beatitudini».
Quindi lo rivestiva del mantello e della stola.
Il bacio di ubbidienza concludeva la cerimonia.
Trattandosi dell’investitura di un cappellano non era richiesta
la benedizione della spada né degli speroni.
Per lo stesso motivo non era presente, sul leggio, la bolla del
Gran Maestro che lo nominava cavaliere di Malta (cioè atte-
10
stante che, il postulante, aveva presentato le prove di nobiltà
obbligatorie per gli altri professi).
A seguito del Gran Maestro e del Ricevitore, tutti i cavalieri,
poi, si avviavano verso l’uscita della Chiesa.
Le associazioni tedesche dell’Ordine di Malta potevano
vantarsi di conservare intatto l’ideale cavalleresco.
Lo spirito feudale dei propri paesi d’origine, l’arte gotica, il
codice segreto della giustizia e dell’onore, la genuinità della
memoria della “Santa Weheme” avevano contribuito a definire le associazioni della Slesia e quella renano-westfaliana le
più tradizionali e devote dell’Ordine.
I cavalieri tedeschi, al contrario di quelli francesi, (dove non
erano più rappresentati i nomi che avevano illustrato le tre
lingue di Provenza, di Francia e di Alvernia) rappresentavano
il fior-fiore del Gotha germano-cattolico.
Essi andavano fieri della propria prova di Germania costituita
dalla esibizione dei sedici quarti di nobiltà per cento anni e, di
fronte alle quali, impallidivano gli otto quarti, per cento anni,
della prova di Francia ed i quattro-quarti, per duecento anni,
della prova d’Italia ed erano tanto più rigorosi in quanto
frequentavano i cavalieri teutonici (usciti dall’ordine di S.Giovanni) ed i cavalieri protestanti di Malta (quelli cioè del Baliato del Brandemburgo).
Sette commende di questo baliaggio, distaccatesi al momento
della riforma erano nominalmente sopravvissute presso alcuni
nobili di alto lignaggio (così come quelle del Gran Priorato
russo ortodosso di Parigi).
Benché il Gran Magistero di Roma non fosse in relazione né
con i primi, né con gli altri, le considerava tuttavia legittime
(era la sua:«piccola chiesa scismatica») perché esse non avevano mai praticato discontinuità con le regole dell’Ordine,
mentre, invece, il Gran Priorato d’Inghilterra (dove, l’Ordine,
era stato soppresso da Enrico VIII) datava solamente dal regno
della regina Vittoria.
Il presidente delle associazioni renano-westfaliane e quello
della associazione slesiana (che si era collocata a Monaco di
Baviera dopo l’occupazione sovietica) dirigevano i propri
cavalieri con disciplina perfetta ed i rapporti con il gran magistero erano sempre rimasti amichevoli e costanti.
La tenda rossa (detta anche grata o, volgarmente gabbia)
consisteva nella usanza, tipicamente romana, di nascondere/
celare, dietro una tenda, appunto, rossa, i porporati che assistevano ad un rito religioso.
Questa regola era stata adottata, nelle chiese romane, dopo il
1870, per la ragione che, questi porporati, sudditi della Santa
Sede, si trovavano, ormai, in territorio italiano, dove, la porpora, non era protetta dal trattato del Laterano.
Questa pratica, esclusiva della chiesa di Roma, non vantava
altro motivo che quello della “tradizione”; al contrario, non
era in vigore presso le chiese dell’Ordine, che rappresentava,
appunto, la propria sovranità territoriale, sulla quale, invece, la
porpora, era stata sempre rispettata.
Altresì, al fine di veder garantiti formalmente i propri diritti
sovrani, anche in ambito religioso, oltreché giuridico e costituzionale, l’Ordine, desiderava veder restaurata quella antica carica di: «Priore della Chiesa Conventuale» che, a Malta, deteneva, un prelato, indipendente dalla giurisdizione vescovile.
Non si trattava, dunque, di una questione di mero prestigio né
di soli interessi spirituali!
I cavalieri professi sarebbero stati, in questo modo, “più liberi”, verso la Congregazione dei Religiosi, poiché, il prelato, al
quale sarebbero stati sottoposti, sarebbe, a sua volta, dipeso,
direttamente dal Papa.
Come gli altri Ordini Monastico-Militari, la cui origine era
strettamente legata ai Luoghi Santi, nei quali, gli antichi
crociati, avevano compiuto le proprie gesta più gloriose, anche
l’Ordine Giovannita si faceva merito di aver posseduto ed in
parte di ancora possedere un certo numero di Sante Reliquie
che, da quei luoghi, originarono.
Tra le molte, tuttavia, alcune, furono particolarmente “considerate, amate e venerate” dai gran maestri e dai cavalieri tutti.
La sacra immagine miracolosa di Nostra Signora di Filerno
che si voleva attribuire a S.Luca e che, si narra, fosse apparsa,
una volta, insieme a S. Giovanni, nel cielo di Rodi, per
mettere in fuga l’esercito turco, era sempre stata la più
venerata. Questa sacra immagine, per molti secoli, sparì.
Se ne persero le tracce durante il lungo peregrinare che toccò
all’Ordine, nella sua lunga storia.
Altra antichissima reliquia fu: la Santa Spina donata al Gran
Maestro d’Aubusson dal sultano Bajazet unitamente alla mano
destra di S.Giovanni che furono, entrambe, trasferite, da Rodi,
dal gran maestro Villiers de l’Isle-Adam quando fu sconfitto
da Solimano “il magnifico” e che profusero le loro grazie e
protezioni ad ogni tappa del loro lungo percorso che le portò
da Candia a Citera; da Messina a Baia; da Cuma a Civitavecchia; da Viterbo a Corneto; da Nizza a Villafranca e da questo
luogo fino a Siracusa, prima che, Carlo V, donasse all’Ordine,
in feudo, l’isola di Malta.
Da Malta seguirono il gran maestro Hompesch a Trieste e furono, di poi, a S.Pietroburgo, con il suo successore, lo zar
Paolo I; da lì, passarono quindi a Copenhaghen (dove le portò
la vedova dello zar Alessandro III) al fine di poterle salvare
dalla furia degli atei iconoclasti.
Successivamente giunsero a Belgrado dove, la figlia di questa
zarina, la principessa Anna Petrowna, le donò ai Karageo-r
gevitch.
Era forse, laggiù, la signora di Filerno, per proteggere la
«chiesa del silenzio» martirizzata dal comunismo sovietico ?
Se, dunque, i cavalieri di Malta, non avevano potuto recuperare l’immagine santa di Nostra Signora di Filerno, la mano
destra di San Giovanni era stata, al contrario, conservata dalle
monache del famoso monastero delle “Commendadoras de
San Juan”, le ultime religiose dell’Ordine residenti a Barcellona.
La reliquia della Santa Spina, donata da Bajazet, era invece
passata di mano, tra vari principi russi, fino a che, uno di loro,
molto devoto, non l’aveva donata a Benedetto XV.
Alberto Gamaleri Calleri Gamondi
UNA BELLA STORIA FAMILIARE
Giuseppe REVIGLIO della VENERIA, I REVIGLI DI
BRA - Notizie storiche e genealogiche di una famiglia del
vecchio Piemonte, Centro Studi Piemontesi,Torino, 2012, p.
255.
È veramente davvero difficile recensire il volume in modo
più compiuto e aderente alla sua realtà di quanto abbia
fatto, nella prefazione al testo, una triade di studiosi-amici,
quale quella composta da Enrico Genta Ternavasio,
Gustavo Mola di Nomaglio e da Roberto Sandri Giachino.
A essa e, naturalmente, al libro, rimandiamo non solo chi sia
interessato alle vicende e ai personaggi di questa famiglia
dell’aristocrazia piemontese, ma anche chi voglia mutuare
conoscenza storica al piacere della lettura, mentre queste
poche righe si propongono in via esclusiva la presentazione,
per sommi capi, del lavoro ai soci della SISA.
L’autore, a quanto ho recepito nel corso di alcune
conversazioni, intervenute con lui sul tema, ha impiegato più
tempo ad assumere la ferma decisione di scrivere la storia
della propria famiglia, che non a stenderla materialmente.
Questo suo lungo dubbio non è soltanto comprensibile, ma
decisamente lodevole. La più che considerevole fatica
affrontata - peraltro sottraendo spicchi di tempo al riposo, alla
famiglia e allo svago, giacché Pippo della Veneria era ancora
in piena fase di attività lavorativa – vedeva sull’altro piatto
della bilancia una serie di incognite. Prima tra esse,
l’interrogativo: al di là dei membri della famiglia e di qualche
prossimo parente, l’argomento avrebbe rivestito un pur
minimo interesse per gli ‘estranei’, per i lettori? Al secondo
posto, lo scrupolo più che legittimo di far salvo il proprio
nome dal men che equivoco alone di encomiatore dei propri
maggiori, meritato da quanti, purtroppo non pochi, hanno –
incautamente, quanto meno – sacrificato la verità storica a
vanità scarsamente fondate.
Tali perplessità risultano nei fatti tutte brillantemente superate.
11
Il volume, dal punto di vista oggettuale, è più che accattivante,
Grafica e impaginazione rientrano a pieno titolo nella eccellenza della tradizione editoriale del Centro Studi Piemontesi.
L’iconografia, forte di 93 illustrazioni in bianco e nero nel
testo e di 44 piccoli stemmi (dal segno nitido e dalla
rispondenza alla ortodossia blasonica) di personaggi di casa
Reviglio e di loro alleanze matrimoniali, è impreziosita
dall’inserto quadricromico fuori testo, che conta 16 pagine. Le
immagini, scelte con competente cura, riproducono ritratti,
armi gentilizie, frontespizi di opere a stampa, fogli di
manoscritti, di lettere, esterni e interni di dimore, fotografie
d’epoca, epitalami, orazioni funebri. Esse implementano e
arricchiscono lo scritto in termini davvero armonici.
La prosa piana e scorrevole, del tutto aliena da enfasi di sorta,
ma sorretta da puntuali riferimenti documentali, narra cinque
secoli di vita di una famiglia della nobiltà di Bra,
esponendone, con lineare sincerità, le luci, senza sfumarne le
ombre, a partire da quel Girardino, ascritto al notabilato
cittadino e di non improbabile origine francese. Quindi, gli
apparentamenti con la migliore aristocrazia subalpina,
l’estinzione in essa del ceppo del nizzardo archiatra Guigonis
con il susseguente inquarto dell’arma, gli infeudamenti, la
concessione del comitatus, le cariche e gli alti uffici.
In particolare, due sono i punti che suscitano in chi scrive
un particolare interesse:
i fasti della Accademia de’ Signori Illuminati di Bra, istituzione culturale, fondata nel 1702, sotto l’alto patrocinio di Madama Reale Giovanna Battista di Savoia, sodalizio che, quindici anni più tardi, a opera dell’Abate Bartolomeo Reviglio
della Veneria, maestro delle cerimonie, si trasformò in colonia
arcadica, direttamente dipendente dall’Arcadia romana. Il Reviglio ne fu il primo custode e la portò a un decennio di auten
tica fama nazionale, annoverando tra i suoi ranghi esponenti
ragguardevoli della poetica e della musica del tempo, tra i quali non guasta ricordare i nomi di due donne, non solo grandi
dame per altissima nascita, ma memorabili per l’intensa attività svolta in campo culturale (erano en-trambe di celebrata beltà e Arcadi romane), quali Aurora San-severino, figlia del
principe di Bisignano e consorte prima di un Acquaviva, conte
di Conversano, e, rimastane vedova (a un anno dalle nozze,
celebrate quando lei era appena undi-cenne), quindi di un Gaetani dell’Aquila d’Aragona, principe di Piedimonte, duca di
Laurenzana, eccetera, a Bra nota con il nome arcadico di “la
Perenna”, e di Aurelia d’Este, figlia del marchese Sigismondo
IV e di una Grimaldi di Monaco, andata sposa al patrizio napolitano Francesco Gambacorta, duca di Limatola, che all’Accademia di Bra prese nome di “la Concentrata”; la vita, a noi
ben più prossima, di Enrichetta Balbo di Vinadio, figlia di
Cesare, personaggio non minore del Risorgimento, e di
Félicie Vallet de Villeneuve, moglie di Carlo Reviglio della
Veneria alla vigilia del fatidico 1848.Ma di fatti, di dati, di
notizie, interessanti o gustosi, ve ne sono a bizzeffe: dalle
faide braidesi tra i Brizio e i Boarino, alla vie de Boheme (ma
non spinta a sconvenienti eccessi) di un simparico Reviglio di
fine Ottocento. Assai chiarificanti, alla fine, le otto ‘tavole
delle parentele’, congiunte a due, genealogiche, che riflettono
le generazioni dei Reviglio a noi più vicine. Apprendiamo,
così, che l’autore avrebbe pieno diritto a posporre al suo nome
un numero romano, facendosì chiamare Pippo II della Veneria, giacché il nonno omonimo era noto come Pippo e il
cugino germano del nostro, di poco più giovane e anche lui
battezzato come Giuseppe, ha Epi come diminuitivo.
Asco
12
STEMMA del SEMINARIO VESCOVILE di
CHIOGGIA
Ancora una volta il bravo e infaticabile araldista Giorgio
Aldrighetti, di Chioggia, ci presente il suo ultimo lavoro di
araldica ecclesiastica. Questa volta si tratta dello stemma del
Seminario Vescovile di Chioggia che sarà senz’altro
d’interesse per i soci SISA, (Società Italiana Studi Araldici).
Ricordiamo che tra tutti i tipi d’araldica moderna, visto la
mancanza in Italia di un ufficio araldico che si occupa di
stemmi personali, al contrario dei paesi d’oltre manica, quella
ecclesiastica è forse quella più viva e possiamo considerarci
fortunati che ci sia un’araldista del calibro di Aldrighetti che si
occupa anche di questo tipo d’araldica. Il disegno è quello del
valido disegnatore araldico Enzo Parrino di Monterotondo
(Roma) che da anni collabora con Giorgio Aldrighetti.
La sua blasonatura: D’azzurro al calice d’oro, cimato dall’
ostia al naturale, caricata dal cristogramma JHS, con le
lettere di nero, il tutto accompagnato nel canton destro del
capo da una crocetta greca patente d’argento e similmente nel
canton sinistro, da una crocetta cucita di rosso. Ornamenti
esteriori: due angeli al naturale, sostenenti lo scudo e
l’iscrizione circolare, in lettere maiuscole di nero,
SEMINARIO VESCOVILE CHIOGGIA.
AMG
Sul tutto periodico della SISA riservato ai Soci
Direttore
Alberico Lo Faso di Serradifalco
Comitato redazionale
Marco Di Bartolo, Andrew Martin Garvey,
Vincenzo Pruiti, Angelo Scordo
Testata del periodico
di † Salvatorangelo Palmerio Spanu
Indirizzi postali
Direttore: Piazza Vittorio Veneto n. 12 10123 Torino
Redattore: Marco Di Bartolo, via IV novembre n. 16 10092
Beinasco (Torino)
Sito Internet
www.socistara.it
Posta elettronica
[email protected]
[email protected]
I contributi saranno pubblicati se inviati su supporto ma-gnetico in
formato word o via e-mail ai sopraccitati indirizzi. Quanto pubblicato
è responsabilità esclusiva dell’autore e non riflette il punto di vista
della Società o della redazione. Gli scritti verranno pubblicati
compatibilmente con le esigenze redazionali ed eventualmente anche
in due o più numeri secondo la loro lunghezza. La redazione si
riserva la possibilità di apportare qualche modifica ai testi per
renderli conformi allo stile del periodico