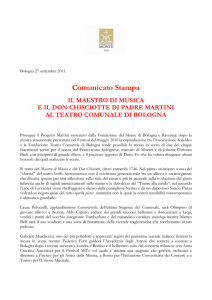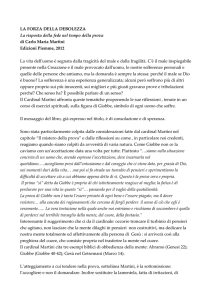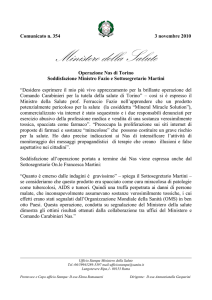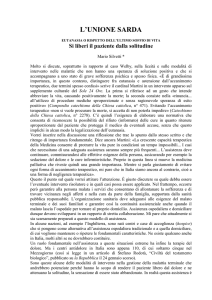Roberto Trovato
Dario G. Martini
l’antiapocalisse
Un autore teatrale italiano
fra due millenni
ARACNE
Copyright © MMV
ARACNE EDITRICE S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
00173 Roma
via Raffaele Garofalo, 133 A/B
(06) 93781065
ISBN 88–548–0180–1
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
I edizione: agosto 2005
Indice
Capitolo I
Dall'esordio al premio Riccione
7
Capitolo II
Da un trittico scherzoso a La mano mancina
43
Capitolo III
Da La Signora dell'Acero Rosso a Perché non gridate?
71
Indice dei nomi
91
Capitolo I
Dall’esordio al premio Riccione
Per analizzare la personalità di Dario G. Martini, uno degli autori
drammatici italiani più interessanti1 degli ultimi anni, mi pare utile
partire da un episodio che mi è stato raccontato. Nella primavera del
2003, esattamente il 27 marzo, a Zagabria, Martini, è stato presentato
a Suzana Glava, giovane docente di letteratura presso l’Istituto di italianistica della locale Università. Il commediografo era nella capitale
croata assieme a Mario Mattia Giorgetti, direttore di «Sipario», per
presentare, su iniziativa dell’Unesco, il volume Suvrumena Talijanska
Drama — Izabrani autori, antologia di testi italiani, scelti a cura dello
stesso Giorgetti2, per proporre alla Croazia una panoramica (quanto
più possibile significativa) della più recente produzione teatrale degli
scrittori del nostro Paese. Durante uno dei ricevimenti offerti per l’occasione da Flavio Andreis, direttore dell’Istituto italiano di Cultura,
Martini incontrò Suzana Glava. «Questo — disse alla docente De
Andreis — è l’autore di In nome del figlio, il dramma che lei stessa ha
tradotto con il titolo U Ime Sina».
La giovane docente, guardando con sorpresa l’uomo che le veniva
presentato commentò laconica: «Ma lei ha i capelli bianchi».
«Perché? — disse Martini — a Zagabria è proibito avere i capelli
bianchi?».
«Ma no, ma no — replicò immediatamente la Glava — Mi scusi,
mi scusi tanto… Sono rimasta sbalordita nel rendermi conto che lei è
una persona già avanti con gli anni. Leggendo e traducendo il suo te1
G. ANTONUCCI, Storia del teatro italiano del Novecento, Edizioni Studium,
Roma 2002, p. 281, dopo aver scritto «La verità è che il teatro degli anni Novanta è
assai più ricco e articolato di quanto esso appaia da certi resoconti e bilanci» fa un
preciso riferimento al «teatro di costume e satirico di Dario G. Martini».
2
Nel volume, edito in Croazia nel 2003, oltre alla pièce di Martini, sono
raccolti Abélardo ad Eloisa ad Abélardo di Maricla Boggio, Flamenco Matto
di Elena Bono, Tre sull’altalena di Luigi Lunari, Veronica, meretrice e scrittora di Dacia Maraini, La piscina nel cortile di Carlo Maria Pensa e Francesco e
il re di Vincenzo Ziccarelli.
7
8
Capitolo I
sto, così carico di sdegno per i mali che ci affliggono e così voglioso
di qualcosa che aiuti a migliorare la condizione umana, pensavo che le
sue fossero parole di un ragazzo ancora animato da fresco entusiasmo,
parole di un autore che sa contestare decisamente, senza paura, ciò che
ci passa accanto, parole di un… di un… al massimo di un trentenne.
Mi scusi».
La pronta risposta di Martini fu: «Lei oggi mi ha gratificato, forse
senza accorgersene, dell’elogio migliore che io abbia mai ricevuto».
In effetti l’aver conservato, sino agli anni della completa maturità,
la capacità di sdegnarsi per le ingiustizie e la voglia di combatterle, è
una delle caratteristiche più tipiche dell’autore di cui mi occupo in
questa stringata monografia3. Indicherò più avanti come nella più recente delle sue opere, Perché non gridate?, Martini abbia saputo polemizzare con asprezza contro la più tremenda delle ingiustizie sofferte
dagli esseri umani, quella della morte. Conviene per ora richiamarmi
ad una polemica, che si manifestò in tutta l’Europa, alla fine del secondo conflitto mondiale, tra chi riteneva che per l’arte fosse necessaria una sorta di tabula rasa sulla tragedia vissuta, un ricominciare da
capo che facesse astrazione, per quanto possibile, da ogni sofferenza
patita dai popoli e dagli individui, e chi invece riteneva fosse indispensabile un indugio e un’insistita meditazione sui mali patiti al fine di
guarirne definitivamente. I due contrastanti punti di vista alimentarono, naturalmente, opposte correnti di pensiero. Finì con l’avere la me3
Sul drammaturgo hanno scritto contributi articolati: C. GARELLI, Commediografi: Dario G. Martini, in AA.V V., Genova libro bianco, Sagep, Genova 1967, pp.
136–138; M. MANCIOTTI, Il teatro: Dario G. Martini, in A A.VV., La letteratura ligure. Il Novecento, Costa & Nolan, Genova 1988, vol. II, pp. 275–278; E. ANDRIUOLI, Dieci drammaturghi e quattro poeti drammaturghi (Ricerche sul teatro del
Novecento in Liguria), EL, Savona 1995, pp. 222–243; P. BRUNO, Il teatro di Dario
G. Martini, su «Agave», dicembre 1995, pp. 45–48; R. TROVATO, Dario Guglielmo
Martini: Teatro per cambiare, in Filologia romanza e cultura medievale. Studi in onore di Elio Melli, Dell’Orso, Alessandria 1998, pp. 829–849; E. BUONACCORSI, Il
teatro in Liguria dal 1945 al 2000, in AA.VV., Bilancio della Letteratura del Novecento in Liguria. «Atti del Convegno (Genova, 4–5 maggio 2001)», a cura di G.
Ponte, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Genova 2002, pp. 135–136; R. TROVATO, Il teatro in Liguria nel Novecento: autori, registi, scenografi e attori, in F. DE
NICOLA – R. TROVATO, Parole e scene di un secolo in Liguria, Dell’Orso, Alessandria 2002, pp. 146–150.
Dall’esordio al premio Riccione
9
glio chi proponeva di non dimenticare, ma semmai di approfondire le
ragioni dei tanti lutti e delle ferite lasciate ai giovani delle nuove generazioni.
Tra i sostenitori delle tesi del non dimenticare vi furono i curatori
di due antologie poetiche uscite a Firenze e a Bergamo, una nel 1955 e
l’altra nel 1958, rispettivamente a cura di Gian Maria Mazzini e di Remo A. Borzini. Sia la prima di tali antologie, Il fiore–Rassegna della
nuova generazione poetica, uscita per i tipi della Editoriale Kursaal, e
sia la seconda, Poeti nuovi nel quadro della lirica post–bellica italiana, pubblicata dalla Nuova Italia Letteraria, ospitarono versi di Dario
G. Martini, che già nel 1952 aveva suscitato l’attenzione di alcuni critici, in particolare di Piero Chiara, con un volume di poesie dal titolo
A greve cuore4. E come poteva essere, se non greve, il cuore di chi era
ancora frastornato dalla crudeltà della guerra? Nelle due antologie figuravano voci destinate ad imporsi: Maria Luisa Spaziani, Pier Paolo
Pasolini, Rocco Scotellaro, David Maria Turoldo, Elena Bono e Vittorio Sereni. Martini fu chiamato in causa da Gian Maria Mazzini soprattutto per una composizione, Quasi candela accesa che cito integralmente perché ha in sé un nucleo drammaturgico che fra poco espliciterò:
Quasi candela accesa
in notte senza vento,
ai limiti del nulla il mio destino.
Oh spegnetemi alfine
se l’ardere non giova a chi sta solo.
Il curatore commentò: «È interessante notare come il modernissimo
contenuto (quel senso […] dell’inutilità del proprio impegnarsi) assume nella […] lirica modi levigatamente classici, quasi petrarcheschi,
con bell’effetto di mordente»5.
Richiamandosi al titolo della raccolta A greve cuore, il commentatore aveva rilevato poco prima: «Martini è uno di quei giovani che più
si sentono crocifissi al loro secolo, inchiodati alla responsabilità di es4
5
Il volume uscì nel 1952 per i tipi della genovese Edizioni Liguria.
G.M. MAZZINI, op. cit., p. 92.
10
Capitolo I
so. […] Una posizione non del tutto cristiana né del tutto prometeica, i
cui sviluppi — necessari in un senso o nell’altro — vanno attentamente seguiti, non solo nel quadro di una letteratura, ma in quello più vasto della storia di una generazione»6.
Va fatta una precisazione: Dario G. Martini, l’autore drammatico
italiano che forse più di ogni altro, operando a cavallo tra due millenni, si è battuto contro gli assertori del nulla, tanto che mi è riuscito agevole, dopo aver analizzato a fondo la sua opera, definirlo l’antiapocalisse, è partito se non proprio da posizioni scettiche (potrei addirittura dichiararle paranichilistiche) per giungere infine a sostenere a
spada tratta la necessità di un impegno assoluto contro gli assertori,
più o meno in buona fede, del malinconico non ne vale la pena.
Le note dolenti di A greve cuore piacquero poco ai recensori genovesi. Toccò loro maggior fortuna a Milano, ma Martini non se ne
crucciò. Non sembrava amare molto, allora, l’attualità anche perché
era costretto a sopportarla quotidianamente con il suo lavoro di
cronista. Egli ne prese presto le distanze, dedicandosi, oltre che al
teatro e alla poesia, allo studio della storia. Il giornale per il quale
allora lavorava, “Il Corriere Mercantile”, a partire dai primi anni
Cinquanta gli commissionò servizi sul passato di Genova. Da tali
articoli, poi raccolti in volume, nacquero tre libri di successo: La
Liguria e la sua anima7 (con la collaborazione di Divo Gori),
L’uomo dagli zigomi rossi. Cristoforo Colombo visto fuori del mito8, agile biografia colombiana, e Genovesi malelingue9, indagine
sul tipico mugugno dei liguri. Accennavo in precedenza alla vaga
allergia del Dario G. Martini d’allora per ciò che gli passava attorno. Quando gli accadde di riunire in volume le pagine de L’uomo
dagli zigomi rossi, alle quali venne conferito nel 1974 il premio
Caffaro d’oro, le fece precedere da un’epigrafe costituita dai vv. 7–
10 del secondo componimento dei Canti di Leopardi, intitolato Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze: «O Italia, a
6
Ivi, p. 90
Il libro è stato edito a Savona da Sabatelli per la prima volta nel 1965.
8
Il volume fu stampato a Savona da Sabatelli nel 1971.
9
Il libro fu pubblicato a Savona da Sabatelli nel 1968.
7
Dall’esordio al premio Riccione
11
cor ti stia / far ai passati onor; ché d’altrettali / oggi vedove son le
tue contrade, / né v’è chi d’onorar ti si convegna».
Dirò più avanti come la vocazione storicistica di Dario G. Martini
gli sia stata fondamentalmente propizia per dare serietà e consistenza
ai suoi drammi evocativi di grandi eventi. Tornando al teatro va detto
che Martini, nato il 14 gennaio 1923 a Pamparato, presso la Val Casotto sul crinale fra Piemonte e Liguria, vi si addestrò con commedie
in dialetto ligure, scritte per Radio Genova, delle quali hanno dato esauriente conto Carlo Beretta10 e Cesare Viazzi11. E proprio la frequentazione di Radio Genova è stata determinante per fare di Martini
un autentico uomo di teatro: lo fece esordire in ambito nazionale il
primo aprile 1950 con una radioscena dedicata a Valerio Bacigalupo,
uno dei campioni del grande Torino scomparsi nella tragedia di Superga, che inaugurò il programma Raccontate la vostra storia; gli fece
inventare per un attore ligure, Giuseppe Marzari, un personaggio, o
sciô Ratella, voce dei tipici mugugni genovesi, la cui popolarità durò
fra il 1950 e il 1974. Tale collaborazione cementò ulteriormente la sua
amicizia con Enrico Bassano, che lo aveva aiutato nei suoi esordi nel
giornalismo e che lo volle accanto a sé, come co–autore, per una serie
di produzioni commissionate per il premio Italia e per altre importanti
iniziative dell’emittente di Stato. Chiarirò meglio nelle pagine seguenti la collaborazione Bassano–Martini, sulla quale peraltro una giovane
studiosa ha scritto un interessante saggio12. Tornando alla radioscena
dedicata al giocatore del grande Torino, va ricordato che piacque molto a Vittorio Veltroni, allora tra i maggiori dirigenti Rai. Questi, nel
presentare ufficialmente la nuova rubrica, riconobbe a Martini «una
squisita sensibilità radiofonica».
È utile insistere sull’episodio inaugurale di Raccontate la vostra
storia perché in quella mezz’ora di trasmissione si coglieva già uno
dei temi nodali del teatro di Martini: la consapevolezza che nulla av10
C. BERETTA, Storia del teatro dialettale genovese, Edizioni Tolozzi, Genova
1974, pp. 151, 156, 262, 272, 274.
11
C. V IAZZI, 40 anni di teatro radiofonico genovese, 1928–1967, Erga, Genova
1968, pp. 75, 78–81, 88, 93, 95, 131, 134, 152, 155.
12
P. BARTALINI, Un felice sodalizio: Enrico Bassano e Dario G. Martini, in
AA.V V., Teatro in Liguria alle soglie del 2000, a cura di R. Trovato e L. Venzano,
Erga, Genova 1997, pp. 54–68.
12
Capitolo I
viene nell’universo senza che ovunque ne rimanga traccia e l’altrettanto sicura consapevolezza che talvolta dai misteri da cui siamo
avvolti ci giungono segnali che potrebbero aprirci varchi inaspettati
per meglio interpretare la nostra sorte, se solo li sapessimo decifrare.
Riguardo alla citata radioscena riporto quanto scrisse Gino Cornali il 6 aprile 1950 nella rubrica «La settimana alla radio» del
«Corriere d’Informazioni». Sotto il titolo Invito all’autobiografia
l’articolista annotò:
La storia che ha inaugurato la rubrica […] ha avuto un […] merito: quello
della sua semplicità. Chi raccontava era un signore di Genova, Dario Guglielmo Martini, che aveva tutta l’aria di sapere perfettamente il fatto suo anche nel leggere al microfono. La sua era un’avventura esile, ma indubbiamente suggestiva: rievocava la figura di Bacigalupo, il portiere azzurro. Cresciuti insieme da ragazzi, Valerio e Dario si divertivano a prendere a pedate
un pallone nei prati di Vado Ligure; e un giorno Valerio portò l’amico davanti al passaggio a livello e qui, facendogli ascoltare il cigolio delle sbarre che
si abbassavano per l’arrivo di un treno, gli disse che in quel cigolio sentiva le
prime note del Claire de lune di Beethoven. Il pomeriggio del 4 maggio
1949, il signor Martini, uscendo dall’ufficio, si sentiva come svagato: gli ronzava nella testa, fastidiosamente, il tema iniziale del Claire de lune, e non
riusciva a liberarsene: fino a che uno strillone, passandogli accanto, non lo risvegliò: annunciava una edizione straordinaria con la notizia della tragedia di
Superga. Nient’altro che questo: ma esposto con una semplicità e una immediatezza non comuni.
Pur condividendo il parere di Gino Cornali sulla semplicità e l’immediatezza della radioscena di Martini, osservo che una lettura anche superficiale del testo permette di conoscere quanto fossero complesse e
lungamente meditate le motivazioni della prolifica operosità di Martini.
Qualcuno saprà che cosa sia l’entanglement, parola inglese di difficile traduzione. Potrei usare il termine impigliamento, oppure, come
ha fatto Massimiliano Pagani, curatore della versione italiana del libro
di Amir D. Aczel, intitolato Entanglement.. Il più grande mistero della
fisica13 far notare che, sebbene lo stesso termine «abbia corrispondenza in italiano con le parole groviglio, ingarbugliamento, confusione,
13
Il volume, uscito a New York nel 2001 per i tipi di Four Walls, Eight
Windows, è stato pubblicato in italiano dall’editore Raffaello Cortina di Milano nel
2004.
Dall’esordio al premio Riccione
13
ecc., e nonostante sia stato tradotto in passato con termini quali correlazione (Enrico Beltrametti), intreccio (Mario Rasetti), nel contesto di
questo libro si è preferito attenersi all’abitudine attualmente diffusa
nella letteratura scientifica di mantenere l’inglese»14.
Amir D. Aczel, docente di matematica al Bentley College, nel
Massachusetts, noto per la sua attività di divulgatore scientifico, ha
fatto il punto su quello che è considerato il maggiore mistero della fisica: il fatto cioè che qualcosa che accade qui può far sì che qualcos’altro accada molto lontano. C’è in tutto l’universo una misteriosa
forza d’armonia per cui due particelle misurate una volta insieme obbediscono poi a uno stesso legame, o entanglement, anche se si trovano poi a migliaia di chilometri o addirittura ad anni luce di distanza.
Là fuori, per dirla con Einstein, c’è un immenso mondo che esiste, indipendentemente da noi esseri umani e che sta là davanti a noi come
un enorme, eterno enigma, solo parzialmente alla portata delle nostre
indagini. Pur non essendo un esperto di fisica, Martini ricordava una
battuta pronunciata da Amleto: «Ci sono più cose in cielo e in terra,
Orazio, di quante ne conosca la tua filosofia». La radioscena dedicata
a Valerio Bacigalupo ebbe molti consensi perché, a livello subliminale, molti sapevano allora delle misteriose connessioni, oggi rese note
dalle più recenti acquisizioni degli studi sulla meccanica quantistica.
Dopo il successo della puntata inaugurale di Raccontate la vostra
storia, Martini continuò per qualche anno a seguire parallelamente due
versanti della propria attività: da una parte il côté drammatico e dall’altro quello comico. Tale parallelismo fu vivo anche nella produzione per il teatro dialettale15. Anche la già accennata collaborazione con
Bassano per testi destinati al vasto pubblico nazionale della Rai oscillò
14
M. PAGANI, Nota al lettore, in A.D.ACZEL, Entanglement. Il più grande mistero dell’universo, op. cit., p. 1.
15
Appartengono al filone patetico–drammatico le commedie L’angiou co–a
trombetta, in collaborazione con Vito Elio Petrucci, in onda su Radio Genova il 14
ottobre 1956 (verrà pubblicata dalla rivista «A voxe de Zena», n. 11, luglio 1961); O
resveggin ammaccou, premio Genova 1960, in onda il 22 giugno 1960, pubblicata
dalla rivista «Genova», fascicolo n. 6, giugno 1960. Appartengono invece al filone
comico le commedie O barba Renzo, in collaborazione con Vito Elio Petrucci, in
onda sulla stessa rete il 17 ottobre 1957; Caccia a–a vorpe, trasmessa da Radio Genova il 19 giugno 1957; Ciù un pittin, in onda da Radio Genova il 13 ottobre 1963.
14
Capitolo I
tra i due versanti. La serietà del binomio Bassano–Martini, a parte tre
spettacoli pedagogico–didascalici, destinati ai ragazzi, portati in tournées in varie città della penisola, si espresse soprattutto con il copione
Vento d’agosto, prodotto per il premio Italia, che si avvalse dell’interpretazione fra gli altri di Elena Zareschi e Giulia Lazzarini. Nel
settore del divertimento, Martini ottenne un primo successo, nell’ambito dialettale, in coppia con Silvio Torre, con un paradossale divertissement intitolato L’uomo di carta, e un secondo come coautore
di uno dei primi esperimenti italiani di teatro da camera con la pièce
dal titolo Il dente senza giudizio, andata in scena, per la regia di Adolfo Perani, il 27 aprile 1954 al Duse di Genova, allora diretto da Nino
Furia, che aveva sede in piazza Tommaseo. Autori di questo testo che
precede «le riviste di Fo–Durano–Parenti Il dito nell’occhio e Sani da
legare»16 erano quattro giovani, allora pressoché sconosciuti: Martini,
Adolfo Perani, Silvio Torre e Enzo Tortora. Scene e costumi di carta e
di juta (dal che la battuta «Aiutati che la juta t’aiuta»). Lo spettacolo, i
cui testi erano stati coordinati da Martini, fu un tale trionfo, che, in
luogo delle preannunciate tre sole rappresentazioni, ebbe quarantotto
repliche nello stesso teatro ed altre undici all’Augustus17, prima di essere allestito numerose volte all’Alfieri di Torino, all’Odéon di Milano
e al Quattro Fontane di Roma. Il sorprendente successo era dovuto al
coraggio e alla grinta con cui erano affrontati, con pungente cattiveria
e in polemica con l’imperante conformismo di quegli anni, argomenti
allora di stringente attualità.
A proposito de L’uomo di carta, andato in scena al Duse di Genova
il 16 giugno 1959, è interessante riportare un brano della recensione di
Giorgio Striglia, comparsa sul «Corriere Mercantile» il 24 giugno
1959:
Tutt’altro che nuovi alle fortunate esperienze teatrali, specialmente sul piano
dello spettacolo attuale, tra la cronaca e la fantasia, i due autori hanno riversato in questa loro ultima fatica […] una vivace ondata polemica, addolcita
dal desiderio di far sorridere — e spesso francamente ridere — lo spettatore,
16
G. COSTA, su «Roma», 1970, p. 46.
M. MANCIOTTI, È scomparsa Emma Fedele. Fu tra i protagonisti del risveglio
teatrale, su «Il Secolo XIX», 23 maggio 1981.
17
Dall’esordio al premio Riccione
15
nutrita da una costante aderenza alla realtà, innervata spesso di notazioni che
paiono svagate e sono sostanzialmente poetiche.
Quello stesso giorno Enrico Bassano nella parte finale della sua critica, uscita su “Il Nuovo Cittadino”, rilevava che gli sviluppi della
commedia erano «fortemente originali, e vivacissimo il dialogo, ed estrose le battute, e vividi i personaggi. Qua e là appaiono addirittura i
pungenti strali della rivista, con riferimenti attualissimi, e sberleffi e
impertinenze godibilissimi». Lo spettacolo, che eredita in maniera intelligente lo schema della vecchia farsa goviana e quasi gli stessi personaggi: il marito un po’ pazzo, la moglie di sano e quadrato realismo,
la figlia moderna, il fidanzato della figlia e via dicendo, racconta le vicende di Spasimo Fravega. Questi, ossessionato dalla cronaca nera, inventa un giornale che porta solo le buone notizie. Quello che i due autori intendevano dire con il lavoro era che l’uomo trova nei delitti e
nelle sciagure altrui un triste conforto per i nostri mali, che sono al paragone tanto minori.
Un giorno ho chiesto a Martini le ragioni della sua costante voglia
di far ridere sfruttando i possibili equivoci o nonsense insiti nell’uso
della parola.
Perché — mi ha risposto — il riso è una delle poche risorse che abbiamo per
attenuare gli effetti dello stress. C’è una scienza nuova, la psiconeuroendocrinoimmunologia (già il solo citarla induce al sorriso, non ti pare?) che spiega come mai Tommaso Moro in una sua preghiera chiedesse a Dio il dono di
saper ridere. Oggi siamo tutti vittime, più o meno consapevoli, di perenni
tensioni. Lo stress stimola cortisone ed endorfine che abbassano le nostre difese immunitarie. Sai perché mi fa piacere che tu ricordi Il dente senza giudizio? Mi fa piacere perché c’era in quello spettacolo una carica d’ironia, un rifiuto dei luoghi comuni e soprattutto una presa a gabbo del nostro modo di
esprimerci che mi hanno accompagnato per tutta la vita. Te ne do un piccolo
esempio proprio da quello spettacolo:
Scena in alta montagna. L’atmosfera è sottolineata dall’irrompere di un popolare coro alpino. Arriva un ometto che scopre la moglie intenta a tradirlo
tra massi coperti di neve, a pochi passi da un ghiacciaio tra nugoli di stelle
alpine. L’ometto grida:
Perfida fedifraga! Farmi le corna qui, verso la vetta del monte Bianco, a
tremila e ottocento metri d’altezza. Come hai potuto cadere così in basso?
Ma non era quella dell’umorismo la corda privilegiata da Martini
negli anni dell’apprendistato. La corda privilegiata era quella già risuo-
16
Capitolo I
nata nelle poesie di A greve cuore e che ritroveremo nel suo autonomo
testo teatrale d’esordio, L’ultimo venuto, la prima novità assoluta italiana presentata nella mitica Borsa d’Arlecchino, che vedrà di lì a poco
impegnato il regista Aldo Trionfo. L’argomento della commedia in un
atto L’ultimo venuto è la morte. A questo punto è opportuno fare una
premessa che aiuterà a comprendere come in tutti i testi di Martini,
compresi quelli brillanti, scaturiti dal côté comico, la Grande Nemica
sia sempre in qualche modo una contestata presenza, sino a dover essere
affrontata frontalmente, come si vedrà più avanti, nel più recente e impegnativo testo di Martini, quel Perché non gridate? che è, a mio parere, un vero e proprio finale di partita tra l’autore e la morte.
Per chiarire meglio l’annunciata presenza della grande nemica, mi
richiamo ad una conferenza tenuta recentemente a Genova da Fernando Savater, docente di Filosofia all’Università di Madrid e uno degli
intellettuali spagnoli più noti. Martini lo stima molto e, lo noto qui per
inciso, ha parlato a lungo di lui per spiegare l’uso delle citazioni ai miei allievi per i quali ha tenuto con me, qualche anno fa, un seminario
di drammaturgia. Il filosofo basco è ammirato da Martini non soltanto
perché ha sostenuto e sostiene che, se qualcuno ha detto una cosa benissimo, è sciocco volerla parafrasare. È meglio riferirla esplicitamente, citandone, ovviamente, la fonte. Savater è ammirato da Martini
perché è, anche lui, un puntiglioso oppositore del nulla. Nella già ricordata conferenza a Genova, prima della quale Martini ha avuto con
lui un cordiale colloquio, il filosofo iberico ha affrontato il tema Don
Chisciotte e la morte, per dire un po’ controcorrente rispetto alle più
note interpretazioni del romanzo di Cervantes (quella di Miguel de
Unamuno, ad esempio) che l’innamorato di Dulcinea, combattendo i
mulini a vento, combatteva in sostanza la consapevolezza della propria caducità. «Morirà, ha sostenuto Savater, quando non sarà più sorretto dalla fantasia». Il non voler morire è, secondo Savater, alla fonte
di ogni sincera ispirazione creativa e lo è anche secondo Martini che
ha avuto questa intuizione molti anni fa, prima che Savater la enunciasse in maniera articolata.
L’ultimo venuto è andato in scena alla Borsa d’Arlecchino di Genova, preceduto da un testo di André Roussin, Gli allegri bugiardi, e seguito da uno di Luigi Bonelli, Il topo, il 23 dicembre 1957 per la regia
di Aldo Trabucco.
Dall’esordio al premio Riccione
17
Ha osservato un saggista: «È un atto unico che poggia su di una
buona invenzione di fondo: un uomo, che ha avuto un figlio schiacciato da un’automobile, simula nei confronti di un amico un analogo
incidente mortale al fine di poter assistere alla felicità dell’altro
quando gli si rivela la verità, che il suo ragazzo, cioè, è vivo e sta
bene»18.
Essere vivi, ecco ciò che conta. E qui mi torna in mente una considerazione di David Herbert Lawrence, citata da Martini nelle sue
chiacchierate con i miei studenti: «Per l’uomo l’unico vero, grande
miracolo, è quello di essere vivo»19.
Recensendo l’atto unico, Giannino Galloni parlò di un giovane autore, nuovo per le scene di prosa, che «si muove con delicata misura
tra una appena accennata satira e un pathos alla fine convincente»20.
Della novità del commediografo Enrico Bassano scrisse sul “Corriere Mercantile”: «L’atto è forte, originale, sostanzioso nell’assunto
umano e poetico, ingegnoso nella costruzione e nel taglio delle poche
scene; è senz’altro un’opera bella, che segnala un ingegno vivo e fervido, un cuore che batte senza meccanismi predisposti».
Replicata per alcune settimane a Genova, in quelle che Roberto De
Monticelli definì «le catacombe di Arlecchino»21, la pièce fu poi scelta con Trentanove anni di Gino Pugnetti per inaugurare la stagione del
Teatro Minimo di Bologna il 19 gennaio 1960. Anche nel capoluogo
emiliano, annotò un cronista genovese: «Successo vivissimo per la
bella e umana commedia del Martini. […] Il Martini è stato portato alla ribalta dopo molte chiamate, e applaudito da un magnifico pubblico
interamente conquistato e commosso dalla trama originale e dalla sicura e sincera ansia drammatica dei personaggi»22.
Nel frattempo la pièce si era imposta dai microfoni di Radio Monteceneri, andando in onda il 9 gennaio 1959. Il testo di Martini, diretto
da Enrico D’Alessandro, era stato così presentato il 3 gennaio 1959
18
M. MANCIOTTI, Il teatro, cit., p. 276.
La citazione si legge alla pagina 134 del volume di D.G. MARTINI, a mia cura,
Le parole di Amleto. Teoria e pratica di scrittura teatrale, EL, Savona 1996.
20
G. GALLONI, Roussin, Martini, Bonelli, su «L’Unità», 24 dicembre 1957.
21
Così De Monticelli intitolava l’articolo dedicato alla Borsa d’Arlecchino comparso su «Il giorno» il 14 gennaio 1958.
22
L’ultimo venuto di Martini a Bologna, su «Nuovo Cittadino», 3 gennaio 1959.
19
18
Capitolo I
sulle pagine del settimanale «Radioprogramma svizzero» da un articolista che si firmava con la sigla g. b:
Dario Guglielmo Martini, giornalista di valore […], è anche autore teatrale
dal genuino istinto vigoroso e dalla tecnica raffinata. Quest’atto unico […] ne
è una dimostrazione quanto mai convincente. In breve spazio di battute, entro
una scena che sembra destinata piuttosto ad accogliere l’azione d’una farsa o
d’una commedia grottesca, egli sa far sbocciare un dramma, esasperandolo
poi sino a tragedia e concludendolo con un metafisico–lirico grido del protagonista — l’Uomo in sé e per sé, spirito infinito, costretto nel carcere
d’inesorabili limiti di materia finita — che squarcia il velo su un aspetto persino misterioso della condizione umana: la felicità di quel che non accade.
L’eco dei consensi ricevuti dal lavoro, pubblicato in Italia sulla rivista «Il palcoscenico» e tradotto in tedesco da Emo Lonardi col titolo
Der letze Agenkommen, suggerì a Giovanni Fusco, autore tra l’altro
della colonna sonora del film Hiroshima, mon amour di Alain Resnais, l’idea di fare del copione di Martini un’opera musicale, che entrò
il 29 luglio 1962, per la regia di Filippo Crivelli, nel repertorio della
Rai e che verrà replicata più volte.
Fu tuttavia dai tre atti di Bocca di lupo che lo sgomento della caducità sofferto da Martini, già avvertibile in molte delle poesie della già
ricordata silloge A greve cuore, ebbe modo di delinearsi scopertamente con la tragica vicenda di un ergastolano, Jean. L’ossessione di una
condanna senza limiti ha creato le premesse per un rifiuto della morte
del tutto iperbolico. Significativamente è una doppia morte che il protagonista sfida nel tentativo di esorcizzare l’inesorabilità dell’estremo
commiato.
A questo punto, confortato dalle dichiarazioni di Martini e dai frequenti contatti che ho con lui, mi pare utile dire quali sono gli scrittori
a cui egli si è richiamato maggiormente o che comunque sia hanno inciso profondamente sul suo modo di pensare e di fare teatro. Su tutti
spicca il nome di Shakespeare, capace, per riprendere Harold Bloom,
di pensare «in maniera più vasta e originale di qualunque altro scrittore. […] Shakespeare superò tutti i suoi predecessori […] e inventò
l’umano come lo conosciamo tuttora»23. Due testi di Martini, in particolare Studio 13 e Perché non gridate?, testimoniano della puntigliosa
23
H. BLOOM, Shakespeare. L’invenzione dell’uomo, Rizzoli, Milano 2001, p. 16.
Dall’esordio al premio Riccione
19
e appassionata attenzione con la quale egli ha scandagliato tutte le opere del grande drammaturgo elisabettiano–giacobiano. Altri nomi tuttavia hanno avuto nella sua formazione un’importanza rilevante: uno è
Dostoevskij24. Non a caso il personaggio non visibile, ma di cui si parla molto nella pièce intitolata In nome del figlio, pone proprio il grande scrittore russo al centro di una triade che si apre con Kierkegaard e
si chiude con Pessoa. Il filosofo danese gli è caro per almeno tre ragioni: l’antidogmatismo; il valore attribuito all’ironia e l’importanza
data alla responsabilità del sé nei confronti altrui e di sé stesso. Martini concorda con Kierkegaard nella denuncia di un’informazione sempre asservita al potere e nel ritenere che si possa ambire ad un oltre
non fatto di sole illusioni. Del poeta portoghese Fernando Pessoa invece apprezza l’aver capito quanto possa essere frantumato il nostro io
e la sincerità che un giorno gli ha fatto scrivere i seguenti sei versi,
collocati nella seconda parte della lirica intitolata Foschia:
Nessuno sa cosa vuole.
Nessuno conosce quale anima possiede,
né cosa è male, né cosa è bene.
(Quale ansia distante piange vicino?).
Tutto è incerto e disperato,
25
Tutto è disperso, nulla è intero .
Tornando a Dostoevskij, mi è già accaduto di notare altrove26 che
egli è molto amato da Martini, non tanto e non solo per avere scandagliato a fondo le nostre contraddizioni riguardo al problema del male,
come ne La leggenda del grande inquisitore da I fratelli Karamazov,
ma soprattutto per il modo con il quale, al di là delle problematiche
24
Dello scrittore russo Martini ha parlato a più riprese nel già ricordato seminario di drammaturgia, citando in primo luogo un’opinione di Forster tratta da Aspetti
del romanzo: «Nessuno ha esplorato l’animo umano profondamente come Dostoevskij. […] in Dostoevskij personaggi e situazioni rappresentano sempre qualcosa al
di là di loro stessi. L’infinito li accompagna. Pur rimanendo ben individuati, si estendono ad abbracciarlo e lo invocano per esserne abbracciati». Il brano si legge in
D.G. MARTINI, Le parole di Amleto, cit., p. 39.
25
Poesie di Fernando Pessoa. Cronistoria della vita e delle opere. Versione, bibliografia e note a cura di Luigi Panarese, Lerici Editore, Milano 1967, p. 25.
26
Una pietà che viene da lontano, su «Sipario», n. 629, novembre 2001, pp. 23–24.
20
Capitolo I
sulla predestinazione e sul libero arbitrio, ha intuito che l’umanità stava avviandosi alla crisi per la resa al naufragio consistente nella santificazione del nulla, e, forse anche in misura maggiore, per non aver
saputo porre argine ai singoli egoismi e per aver dimenticato
l’aspirazione ai grandi orizzonti.
Altri insegnamenti sono venuti a Martini da Cechov, che richiamandosi al fare alacre dei genovesi, provato da una battuta de Il gabbiano, ha sostenuto a più riprese che è proprio nel fare che si deve ricercare la speranza di riscatto per l’uomo; da Gogol, che gli ha dimostrato quanto possa essere corrotta e disumana la burocrazia; da Puskin, che ha sottolineato quanto possa essere ingiusta la cosiddetta
giustizia.
Oltre che dal suo primo maestro, Enrico Bassano, e da Eduardo De
Filippo, Martini ha tratto spunti fecondi per il suo teatro anche da autori che non hanno scritto per il palcoscenico. Da Pound ha appreso
che muoversi controcorrente comporta rischi che pure occorre correre
se si vuole difendere la dignità dell’uomo; Borges lo ha colpito, tra
l’altro, per un’affermazione tratta da una prefazione nella quale si legge: «Il nostro destino è tragico perché siamo irreparabilmente imprigionati dal tempo e dallo spazio, ma nulla, di conseguenza, è più lusinghiero di una fiducia che elimina le circostanze dichiarando che
ogni uomo è tutti gli uomini e che non c’è nessuno che non sia l’universo».
Altri nomi che hanno fornito spunti, che egli ha saputo rielaborare
con autonomia, sono il Voltaire del Dizionario e di Candido, il Pascal
dei Pensieri, Montaigne, Rabelais, Goethe, Schiller e Schopenhauer.
Di quest’ultimo ama citare in particolare due riflessioni: «Più uno appartiene alla posterità e più è straniero ai suoi contemporanei»; «Non
andare a teatro è come lavarsi la faccia, al mattino, senza avere a disposizione uno specchio».
E ancora: Nietzsche e Dürrenmatt. Quest’ultimo ha affermato «La
nostra è l’epoca di un crudele grottesco, visto che viviamo in maniera
assurdamente infelice mentre il nostro pianeta avrebbe risorse più che
sufficienti per sopperire ai bisogni di tutti».
Martini è pure in consonanza con due uomini di teatro importanti
come Peter Brook e Brecht. Del primo ripete una riflessione che sta
Dall’esordio al premio Riccione
21
alla base della sua idea del teatro, non solo quando si cimenta con la
critica teatrale, ma anche quando compone testi pensati per la scena:
«Chi si occupa di teatro oggi, o perché lo fa o perché ne scrive, è
un po’ come i Maya che usavano rotelline per far correre i giocattoli
dei loro bambini e non si sono mai accorti che in quelle rotelline c’era
il principio della ruota che, ove ne avessero avuto consapevolezza, sarebbe stato in grado di cambiare, ovviamente in meglio, la loro esistenza».
Il teatro potrebbe essere dunque una ruota per l’evoluzione dell’umanità, aiutando a rendere la vita diversa da quella che è.
Il secondo è l’autore dal quale Martini ha imparato a usare il teatro
per servire la causa dell’uomo, in particolare laddove questa risulti
mutilata o offesa. Del grande drammaturgo tedesco Martini ama citare
tre battute. La prima è sulla non affidabilità della giustizia umana:
«Sono talmente innocente che mi arrestano»27. La seconda evidenzia
l’assurdità delle guerra: «O si elimina il popolo o si elimina la guerra:
tutte e due insieme non possono coesistere»28. La terza sottolinea la
superfluità dei lunghi eloqui: «In due minuti si potrebbe passare sotto
silenzio tutto quello che c’è da dire»29.
Anche secondo Martini il teatro deve fornire un aiuto per interpretare
la realtà, elemento imprescindibile per chi voglia battersi per un futuro
meno mortificante e deludente, mettendo nel conto il disinteresse, se
non addirittura l’opposizione, di quanti vogliono che nulla cambi.
Tornando alla produzione teatrale di Martini analizzo ora il radiodramma Bocca di lupo, il cui testo sarebbe poi apparso sul n. 6 della
rivista «Ridotto» nel giugno 1964. L’autorevole funzionario della Rai,
Gigi Michelotti, lo ricevette da Bassano. Michelotti fece sapere all’autore che il suo testo, pur apprezzabile, non avrebbe avuto il nulla
osta della Commissione alla valutazione dei copioni da trasmettere per
l’arduità del soggetto, inadatto ad un pubblico indifferenziato come
quello radiofonico. Più oltre dirò come anche l’emittente transalpina
27
La battuta è pronunciata dal protagonista nel primo atto di vejk nella seconda
guerra mondiale, Einaudi, Torino 1973, p.25.
28
La battuta, tratta dalla prima sequenza de Le visioni di Simone Machard è pronunciata da Père Gustave (B. BRECHT, Teatro, a cura di E. Castellani, Einaudi, Torino 1965, p. 189).
29
La battuta è di John nella settima sequenza di Nella giungla della città, Ivi, p. 179.
22
Capitolo I
«France Culture», dopo aver premiato nel 1998 un suo altro dramma,
La signora dell’acero rosso, nella traduzione francese curata da Monique Baccelli col titolo La dame à l’érable rouge, ne congelerà la realizzazione con un non placet giunto all’ultimo minuto per la scabrosità
dell’argomento trattato. Prima della stesura in forma di radiodramma,
il soggetto di Bocca di lupo era stato sintetizzato nella proposta di un
film, intitolato Quasi candela accesa, che si aggiudicò nel 1952 il primo premio ad un concorso del Centro Sperimentale di Cinematografia. A presiedere la giuria, segnala uno studioso30, era il regista Alessandro Blasetti. Finalmente Bocca di lupo, nella sua definitiva forma
teatrale, giunse alla ribalta del Goldoni di Roma il 15 aprile 1961. Il
plot del dramma può essere così sintetizzato: un ergastolano, Jean, che
ha ucciso la moglie Marie, perché deluso da lei, talvolta sogna in carcere sua madre e la donna amata. Dopo l’arrivo del Nuovo provvisorio
compagno di cella, l’uomo dalla pelle color calce sogna che l’ultimo
venuto gli seduca la moglie. Al risveglio l’ergastolano si vendica uccidendo l’intruso. Il titolo della pièce deriva da un lato dal nome dell’alta finestrella a piramide tronca rovesciata, chiusa da solide sbarre,
dalla quale penetra nelle celle dei carcerati l’aria e la luce del giorno e
dall’altro si richiama all’omonimo romanzo di Remigio Zena. Nella
tesi di laurea, dal titolo La donna nel teatro di Dario G. Martini, Alessandra Accorsi ha osservato: il dramma, pur essendo una «polemica
presa di posizione contro la reclusione a vita, affronta sotto varie angolazioni, il rapporto uomo–donna». In realtà la pièce scandaglia anche il tema della caducità dell’esistenza, consueto in Martini, con l’assurdo di due omicidi posti in maniera paradossale come rifiuto alla inesorabilità della morte. Sul tema della consapevolezza di quanto sia
effimera la felicità sono interessanti due brani del dialogo iniziale fra
la madre e Marie, la moglie dell’ergastolano, entrambe viste in sogno
dal protagonista:
MARIE (dopo un istante di immobilità ) — Sono stufa di aspettare.
LA MADRE — Anch’io. Ho le mani stanche, ma il cuore no… bisogna
pazienti.
MARIE — È inutile. Non verrà più.
LA MADRE — Non dire più. È una parola che precipita. Non gli piaceva.
30
E. ANDRIUOLI, op. cit., p. 242.
essere
Dall’esordio al premio Riccione
23
Poco oltre il loro dialogo così prosegue:
MARIE (assorta) — Diceva: “Mi piacciono i tuoi occhi perché ridono.
C’è tanta gioia, nei tuoi occhi, da farmi dimenticare la nostalgia che ne avrò”.
(Altro tono) Era felice con me.
LA MADRE — Non è mai stato felice. Ha capito presto che nessuno può esserlo… (Si ode in lontananza una musica dolce) Una volta — eravamo in campagna, lui era ancora un ragazzo — si arrabbiò perché, durante la messa, il
suono delle campane disturbava, in chiesa, la musica dell’organo. Tornò in
chiesa, più tardi, e dette fuoco alle corde delle campane… Ci fu pericolo di
un incendio. Quando lo sgridai, disse: ‘Quella musica, mamma, non la sentiremo più’. ‘Caro — gli risposi — potrai ancora ascoltarla’. E lui, con la voce
di chi scopre cos’è la vertigine: ‘Non quella! Non così. Mai più come l’ho
sentita prima che le campane suonassero! Mai più! Mai più!’. (Con altro tono, dopo una pausa) Anche questo tu non lo sai… Troppe cose non sapevi di
31
lui… Era impossibile che tu potessi amarlo .
Nonostante la realizzazione con estrema povertà di mezzi, lo spettacolo al Goldoni di Roma, in cui Franco Castellani era impegnato nel
duplice ruolo di regista e interprete della parte principale, ebbe un imprevedibile successo. Considerata la concomitanza con altre prime romane al debutto di questa novità assoluta di un giovane autore italiano
andarono tanti “vice”. Molto calorosi furono i consensi: lo spettacolo
fu molte volte applaudito a scena aperta e alla fine vi furono una ventina di chiamate, cinque delle quali per l’autore. Il recensore de «Il
Messaggero» scrisse il 16 aprile 1961: «Dario G. Martini […] ha costruito questi tre atti con la sapienza dell’autore consumato e al tempo
stesso con la sincerità e l’onestà del neofita».
Il cronista de «Il Paese» elogiò lo stesso giorno la vivacità della
“scrittura teatrale” di Martini. Due giorni dopo il critico del «Giornale
d’Italia» rese conto di un successo dovuto allo spirito dell’opera, che
aveva «un evidente carattere lirico e una carica estremamente fantastica». Sulle pagine del “Quotidiano” di Roma il 18 aprile era esaltato
l’equilibrio della commedia, «che si sviluppa in senso verticale per assurgere ad altezze notevoli, permeata com’è di dolorante umanità e di
tragica poesia».
31
D.G. MARTINI, Bocca di lupo, su «Ridotto», n. 6, giugno 1964, pp. 15–16.
24
Capitolo I
Il recensore de «Il Tempo», dopo aver evidenziato il 17 aprile che
il lavoro rivelava «doti di salda struttura teatrale, non disgiunte da una
non comune forza poetica», affermò che all’autore andava riconosciuto il merito di aver affrontato «una tematica cupa e difficile ma condotta sempre con mano ferma, in un’atmosfera a mezzo tra sogno e
realtà». Il cronista di «Momento sera» del 17–18 aprile espresse consensi per il racconto «costruito con bella evidenza» e lodò una «commedia senza dubbio difficile nella sua impostazione non solo letteraria
ma anche tecnica». Su «Telesera» del 17–18 aprile si leggeva: «Si
tratta di un dramma di grande interesse: il problema della pena dell’ergastolo è affrontato da un punto di vista esclusivamente umano,
nei suoi aspetti più sconvolgenti».
La recensione comparsa su «Arcoscenico» nel maggio 1961, in occasione di una ripresa, riportava: «Il dramma […] è davvero degno di
nota e di attenzione perché rivela un temperamento teatrale di primissimo ordine».
Bocca di lupo ebbe quarantaquattro repliche, inusuali per una novità
italiana data in un teatro della capitale. La pièce verrà ripresa il 16 giugno 1963 all’Astra di La Spezia dal Gruppo d’Arte Drammatica Eleonora Duse, che si conquistò l’accesso alla rassegna nazionale di Pesaro32. Nella città marchigiana la compagine, per la regia di Neldo Costa,
si esibì con buon esito il 23 ottobre 1963. Un articolista del “Resto del
Carlino”, che si siglava m. z., nella recensione intitolata L’ergastolano
non può sognare elogiò il 25 ottobre 1963 il testo per «un grande, potente e indistruttibile enunciato che Martini ha sintetizzato nello slancio
dell’amore assoluto e nel desiderio di sognarlo al di là delle contingenze
e in un ambiente che a tutto spinge fuor che a meditare».
Il 12 maggio di quello stesso anno, Bocca di lupo, che nel frattempo era stata tradotta in francese da Anne Donte Guedy e in tedesco da
Emo Lonardi, col titolo rispettivamente Le sang et la chaux (Il sangue
e la calce) e Lebenslänglich (Per tutta la vita), era stato trasmesso alla
Radio della Svizzera italiana, che l’avrebbe poi ripresa il 30 gennaio
1968. Il cronista del “Giornale del Popolo” di Lugano ne diede il 31
32
Il Festival nazionale d’Arte Drammatica di Pesaro, che ha quasi sessant’anni
di vita, è la manifestazione teatrale più antica e gloriosa del dopoguerra riservata agli
Amatori.
Dall’esordio al premio Riccione
25
maggio 1963 un’ampia descrizione, nella quale si parlava di “limpida
poesia” e dell’amore dell’uomo per la donna.
A Pesaro e in Svizzera, e successivamente a Montecarlo, a Genova
e altrove venne rappresentata la commedia in tre atti, Angela e il diavolo, un altro successo di Martini. La pièce, che era stata segnalata al
Premio Riccione del 1958, è una sorta di favola, all’apparenza ottimistica, che ha al centro il personaggio dello sconosciuto, apparentabile,
come per qualche verso lo straniero di Vento d’agosto, ai giovani on
the road di quella generazione negli Stati Uniti d’America. Martini
scrisse Angela e il diavolo tra il 1956 e il 1957. E proprio nel 1957
Jack Kerouac pubblicava il celebre romanzo Sulla strada. Lo sconosciuto di Angela e il diavolo, un ragazzo, che ha fatto delle strade, da
lui percorse ininterrottamente, la sua dimora elettiva, viene accusato di
aver tentato di violentare Angela, una adolescente orfana che ha difficoltà ad esprimersi e che è ospitata in un convento. La giovane è stata
sfiorata, nel buio della sua cameretta, da qualcuno che si presume volesse stuprarla. I sospetti cadono sullo sconosciuto e diventano certezza quando Angela lo riconosce. Un maresciallo dei carabinieri, dotato
di buon senso, lo salva dal linciaggio degli abitanti del paesino in cui è
ambientata la vicenda. Egli scopre che il riconoscimento da parte della
ragazza è dovuto al fatto che essa ha scorto nel volto del giovane
qualcosa che assomiglia al Cristo di un’immagine sacra che porta
sempre con sé. Pièce a lieto fine dunque, con la morte appena intravista nelle minacce dei benpensanti all’ipotetico diavolo. Benpensanti
sui quali Martini aspramente ironizzava, coprendo di ridicolo una stizzita marchesa dalla cattiva coscienza, costantemente ammantata di alterigia. La prima assoluta della commedia, pubblicata su «Palcoscenico» nell’agosto 1959, si ebbe da Radio Monteceneri il 25 ottobre di
quello stesso anno, con la regia di Enrico D’Alessandro. Ma il vero
successo dei tre atti giunse con l’allestimento diretto da Sandro Bobbio, interprete anche della parte di un carabiniere che venne reso molto comico33. Con questa pièce Bobbio si impose al Festival nazionale
33
Bobbio era stato tra i fondatori del nuovo Teatro Stabile di Genova, anche se,
non appena il nuovo organismo si assestò, venne emarginato. Costituì allora una
compagnia, La Società Amici del teatro, con attori dilettanti spesso più bravi dei
professionisti.
26
Capitolo I
dei Gruppi di Teatro Amatoriale di Pesaro nel 1961. Grazie al primo
premio per la miglior regia, egli venne delegato, con la commedia di
Martini, a rappresentare, nel settembre 1961, il nostro paese al secondo Festival Internazionale del Teatro Amatori di Montecarlo. A tale
rassegna, che si svolge ogni quattro anni, parteciparono compagini
provenienti da vari paesi europei e dagli Stati Uniti. Per la chiusura, il
16 settembre, fu scelta la rappresentazione di Angela e il diavolo. Nella recensione dello spettacolo, comparsa su «Combat» il 21 settembre
1961, Marcelle Capron scrisse che bisognava ringraziare la Federazione italiana del Teatro Amatori: «de nous faire connaître e de défendre
un jeune auteur, Dario G. Martini».
Il giornale «La presse» di Tunisi sottolineò le divagazioni piacevoli
e le battute divertenti del testo di Martini. Paul Deila, critico di «Nice
Matin», il 19 giugno 1961 riconobbe al commediografo italiano l’abilità con cui aveva definito i caratteri dei vari personaggi. Le successive rappresentazioni della pièce ebbero luogo nell’ordine il 29 ottobre
a Reggio Emilia, nell’ambito della rassegna “Maria Melato”, il 18 novembre all’ex teatro Balilla di via Cesarea a Genova e il 13 dicembre
al teatro Kursaal di Locarno. Quest’ultima rappresentazione venne trasmessa in diretta dalla televisione della Svizzera italiana. Una successiva ripresa dalla stessa emittente, il 4 febbraio 1962, piacque molto
alla critica e al pubblico. Il lavoro ebbe successive repliche radiofoniche in Svizzera il 16 febbraio 1962, il 27 novembre 1963 e il 18 settembre 1965.
Lo spazio ampio concesso ai primi testi di Martini è giustificato
dalla scarsa conoscenza della sua produzione antecedente il premio
Riccione. Inoltre tali testi dimostrano la coerenza dell’itinerario da lui
percorso.
A questo punto è opportuno accennare ai copioni scritti in collaborazione con Enrico Bassano. Commissionato per il Premio Italia, Vento d’agosto andò in onda per la prima volta sul programma nazionale
della Rai il 22 novembre 1958 (in quegli anni non imperando ancora
nel nostro Paese la televisione, i programmi radiofonici erano seguiti
da un grande pubblico), per la regia di Umberto Benedetto, con un
cast eccezionale costuito nei ruoli principali da Elena Zareschi, Giulia
Lazzarini e Ivo Garrani. Il radiodramma è la storia di un misterioso
straniero il cui preannunciato arrivo e la cui musica rompono consoli-
Dall’esordio al premio Riccione
27
dati equilibri, scatenando furie distruttrici. Il recensore del «Corriere
di Sicilia», che si siglava M, scrisse tra l’altro il 30 novembre 1958:
Non si tratta per noi di un processo alle streghe, né di una simbologia teologica vera e propria. Non è la definizione in assoluto di un Male o di un Bene;
una Presenza metafisica quale il demoniaco. Piuttosto, intendiamo noi, un
quid lirico, una figurazione allusiva, sfumata, che mentre si sottrae ad ogni
individuazione troppo concettuale, assomma in sé tutti gli inespressi e gli inesprimibili: quelle inquietudini e malesseri e trasalimenti che, latenti in noi,
possono d’un tratto scatenarsi, diventare furia selvaggia, rottura d’argini; figurazione in una parola di una carica emozionale e fantastica che fanno della
vita umana, per dirla con Shakespeare, una cosa “fatta di sogno”. Il drammatico sta piuttosto nell’ambivalenza che questo quid lirico racchiude potenzialmente: questa musica, questa dolcezza suadente che ci apre ad orizzonti
d’anima più vasti e meravigliosi o ci precipita in affanno orgiastico in fondo
a cui è l’annientamento, mutandosi da quella serpeggiante dolcezza in vorticoso uragano (il vento d’agosto, cui il titolo allude). Ma è da noi, in definitiva
che dipende la scelta fra l’una e l’altra delle due possibilità: è sempre dentro
di noi, religiosamente ed eticamente, che si decide il nostro destino.
Vento d’agosto, pubblicato sul n. 292 de «Il dramma», nel gennaio
1961, era stato intanto replicato dalla Rai il 31 maggio 1959 e verrà ripreso negli anni successivi. Radio Monteceneri lo programmò l’11 novembre 1959, il 27 marzo 1963 e poi la sera del 26 aprile 1964. Se ne
ebbero anche un’edizione da Capodistria, in sloveno, e due in palcoscenico: una al teatrino di piazza Marsala di Genova, a partire dal 24
maggio 1974, a cura dei Lettori di Vittoriano De Ferrari, e l’altra a
Cecina Mare, a cura de “La soffitta”, il 12 agosto 1991. La ripresa genovese venne recensita il 26 maggio 1974 sul «Il Secolo XIX» da Carlo Marcello Rietmann. Il critico scrisse tra l’altro:
Il vento d’agosto è una specie di tornado che passa e distrugge. È un’irosa
contaminazione della natura che entra nella gente e la squassa: giovani travolti dall’insania, alberi divelti, tetti incendiati, animali sgozzati nelle stalle.
A questa ondata di violenza gli autori hanno voluto dare un aspetto umano, il
volto pallido d’uno straniero che non parla, ma con un ghigno enigmatico fa
sentire una sua musica strana, eccitante, che promette sventure.
Quello stesso giorno Tullio Cicciarelli notò su «Il lavoro» che l’arrivo dello straniero affascinante e diverso consentiva: «agli autori di
affermare che ‘il male è dentro di noi’ e che l’unica arma per debellare
28
Capitolo I
la struttura della superstizione è la chiarezza della persuasione, mentre
la violenza e l’intolleranza conducono alla proliferazione del fanatismo per cui Satana sarà sconfitto attraverso esemplari esami di coscienza».
Altrettanto impegnativo per il binomio Bassano–Martini fu il radiodramma, definito idillio, Il ciliegio Giovanni, che la Rai mise in onda
per la prima volta sul secondo programma il 26 agosto 1961, con replica il 31 agosto dell’anno successivo. Tra gli interpreti si segnalarono Franco Graziosi, Corrado Gaipa, Adolfo Geri, Paolo Giuranna e
Vittorio Sanipoli. La trama del lavoro è molto semplice. Rivolta ad un
albero, una bambina dice: «Sei bello, ti voglio bene. Quando sarò
grande, ti sposerò».
Sul «Radiocorriere», in data 26 marzo–1 aprile 1961, Carlo Maria
Pensa annotava:
I guai cominciarono il giorno in cui il ciliegio pensò che avrebbe voluto diventare almeno un poco simile agli uomini: “Vorrei aver braccia per stringerti, mani per accarezzarti”. Perché? Cose da innamorati, si sa. E allora avvenne che lei, la ragazza, si ingelosì dell’ombra di lui, si ingelosì d’un aquilone
che gli s’era impigliato fra i rami. E il ciliegio si sentiva sempre più lontano
dal suo mondo, quello fatto di terra e di radici e di foglie; sempre più simile
agli uomini senza però mai riuscire ad essere un uomo. “Perciò debbo lasciarti. Se rimanessi, l’ansia di farmi umano tornerebbe, svegliata da un respiro
caldo, e tu fuggiresti ancora”. Una storia d’amore, dicevamo, che finirà con la
morte, con la musica delle scuri dei taglialegna. Ma non sarà triste; poiché
soltanto in questo modo il ciliegio rimarrà per la fanciulla come essa lo aveva
desiderato. I significati dell’idillio sono trasparenti e non vorremmo forzare
l’immaginazione dell’ascoltatore. La poesia ha un linguaggio che non pretende formule magiche per comprenderla; basta abbandonarcisi. Con quel po’ di
candore che ognuno di noi, anche i più smagati, conserva nella parte più segreta di sé. Abbandonarcisi come ad un sogno. Come a una di quelle illusioni
che non vorremmo mai veder trasformate in realtà.
Il ciliegio Giovanni venne rappresentato il 7 luglio 1962 al teatro
Duse di Genova dagli allievi della scuola di recitazione “Ermete Zacconi” diretta da Aldo Trabucco. A quanto accennavo, Martini da solo
e assieme a Bassano, si è mosso su due versanti: uno decisamente
drammatico e l’altro più propenso all’ironia. Appartiene a questo secondo fronte la commedia musicale Via Nuvola 33, scritta dal binomio
Dall’esordio al premio Riccione
29
Bassano–Martini e andata in onda per la prima volta il 27 giugno
1958. Il lavoro verrà ripreso dalla Rai nel 1968 e nel ’78.
Gianna Anguissola scrisse su «Il Corriere Lombardo» il 24 giugno
1958:
Via Nuvola 33, a cui prevediamo un ricco susseguirsi di prodotti affini, ha
una buona trama perché rispecchia la nostra vita, le nostre vicende di schiavi
dei commendatori autoritari e bizzosi come i primi baroni. Qualcosa come I
racconti dell’impiegato mimati da Marcel Marceau, e siamo certi che a una
rappresentazione visiva il mondo di Marceau non sarebbe estraneo. Amilcare
Mariottini, impiegato N. 24, disegna i fiorellini sulle fatture, e ama segretamente la segretaria d’ufficio. Il commendatore lo scaccia per via dei fiorellini, indirizzandolo ironicamente in via Nuvola 33 dove potrà comprarsi un castello per sognare. Il N. 24 ci va, ed abita nel castello dove la realtà di tutti i
giorni si trasfigura fin che il Commendatore non lo richiama sulla terra perché i fiorellini sulle fatture hanno avuto successo alla luce delle pubbliche relazioni della Ditta.
In sostanza Bassano e Martini hanno fatto inventare ad Amilcare
Mariottini le poetic relations. Definita musical all’italiana, la commedia venne realizzata per la Rai con le musiche di Giovanni Fusco.
Il componimento successivo è Scandalo a Sweet Spring, testo ironico e gradevole, con minore spazio concesso alla musica ed uno maggiore ai dialoghi. La vicenda è quella di un pilota, componente di una
pattuglia acrobatica, che, nel corso di un’esercitazione, si stacca dagli
altri aviogetti e con la scia del suo aereo scrive in aria le parole “Ti
amo”. Ne segue uno scandalo, con relativa inchiesta e immancabile
lieto fine. Sotto l’allegra trama si colgono la severa contestazione degli apparati bellici e la presa in giro dei servizi segreti. La pièce, interpretata fra gli altri da Ernesto Calindri, Carlo Ninchi, Marina Bonfigli
e Checco Rissone, per la regia di Alessandro Brissoni, esordì il 12 luglio 1960 sul programma nazionale (verrà replicata l’anno successivo). Anche per questo lavoro critiche e ascolti furono ampiamente positivi. Positiva, questa volta unicamente sul fronte degli incassi, fu la
commedia La bella Rosin, scritta dal duo Bassano–Martini, interpretata da Erminio Macario, affiancato da Maria Fiore e Carlo Campanini.
La prima assoluta avvenne il 22 giugno 1961 al Carignano di Torino.
Martini si infuriò a tal punto per le varianti apportate al testo da manifestare l’intenzione di far bloccare la rappresentazione, che era inserita
30
Capitolo I
nell’ambito delle manifestazioni del centenario dell’Unità d’Italia.
Bassano si oppose affermando che era risaputo che Macario manipolasse ciò che recita, come faceva Govi. Non averlo previsto li avrebbe
fatti tacciare quanto meno di ingenuità. Inoltre non intendeva far nascere uno scandalo a Italia ’61. Martini ebbe comunque un duro scontro con Macario. Questi, dopo avergli obbiettato di sapere bene ciò
che piace al pubblico, aggiunse che i fatti gli avrebbero dato ragione.
In effetti da un punto di vista economico i fatti andarono come aveva
previsto l’attore: il lavoro venne replicato dopo Torino nei maggiori
teatri italiani. In una silloge di poesie, Ad personam, dedicate da Martini agli amici più cari ve n’è una, Rosin, scritta per Bambù, moglie di
Giancarlo Zuccaro, che è stato di Martini uno dei fautori più assidui e
convinti. Per il loro interesse riporto alcuni versi:
Io serbo tra i ricordi miei più cari
Giancarlo che a Torino, al Carignano,
dice alla bella Rosin di Bassano
e anche mia: ‘Che brava Maria Fiore,
ma quel Macario grandissimo attore,
perché ha maciullato tanto il testo?
Capisco le risate, ma c’è modo…’
Lo sai, Bambù. Badava solo al sodo
il buon Macario e “Su, non farne un dramma”
mi disse quando tanto protestai
per lo scempio al copione. E un telegramma
mandò ogni sera a me ed a Bassano
precisando la cifra dell’incasso
come a dire: “Commedia elegante?
Quel che davvero conta è il contante”.
Furono centinaia i telegrammi
ma per Erminio né io né Bassano
34
scrivemmo più. E senza farne drammi .
La bella Rosin ottenne un grande successo di pubblico, anche se
qualche critico avanzò riserve. Ci furono però due importanti eccezioni. Vito Pandolfi, ad esempio, in un articolo pubblicato su «Roma» il
28 ottobre 1961 osservò: «Certo Bassano e Martini non hanno inteso
andare più in là di un normale teatro d’uso. Ci domandiamo però se al
34
D.G. MARTINI ,
Ad personam, EL, Savona 1995, pp. 37–38.
Dall’esordio al premio Riccione
31
posto delle ambizioni sbagliate non siano preferibili intenti che puntano senza tanti scrupoli al puro divertimento. Cioè, una produzione media è necessaria per sostenere quella di qualità, anzi, per suscitarla,
magari in contrasto e polemica».
Poco più oltre aggiunse: «Numerosi sono i momenti dello spettacolo che prendono il pubblico, divertendolo e interessandolo, e diversi
sono gli elementi positivi della rappresentazione, i toni delicati e sorridenti che s’intonano alle qualità espressive di Macario».
Una recensione del tutto favorevole fu quella di Giulio Trevisani,
comparsa il 23 giugno 1961 su «L’Unità». Il critico lodò la creazione
di Buondì Cerea, il piccolo capostazione che crede di ospitare la bella
Rosin ed è invece alle prese con una sosia della favorita del re, inviata
in un piccolo paese per stornare l’attenzione dalla vera amica del sovrano. Molto acute furono le osservazioni di Trevisani sul linguaggio
della pièce:
Alla sua base c’è, è vero, il linguaggio stesso di Macario, fatto di periodetti,
di allusioni sintetiche, di reticenze; ma c’è di nuovo qualche cosa che lo ha
permeato di candore e di ironia, di sentimento e di satira. È una commedia,
insomma, che bisogna gustare battuta per battuta. Fa parte di quella tecnica
che si definisce avanguardista (tipico lo Jonesco della prima maniera) la
scomposizione, il disintegramento della parlata corrente; qui scomposizione e
disintegramento non sono adibiti alla svalutazione della frase fatta ma alla
rapida estrosissima associazione di idee dal pensato all’impensabile, a getto
continuo, con i più inopinati sbalzi nella satira (come quel regno dell’onestà
che sarà inaugurato dalla repubblica) o nel paradosso poetico (come quel bene del popolo fatto con la dolcezza delle caramelle).
A proposito della collaborazione fra Bassano e Martini, segnalo i
tre copioni che, sotto lo pseudonimo Ben e Dam, i due autori scrissero
per i ragazzi di Rossaldo (Aldo Rossi), con la collaborazione dello
stesso Rossaldo: Tornar bambini con Riccardo Billi e Serena Bassano,
che, dopo l’esordio avvenuto all’Astra di La Spezia il 25 novembre
1959, compì una lunga tournée in tutta Italia; Qui tutti in gamba, che
debuttò il 20 aprile 1960 al Margherita di Genova, per andare poi al
Massimo di Sampierdarena, al Cantero di Chiavari e infine al Manzoni di Milano per una lunga serie di repliche; L’allegria apre il sipario,
che esordì a Frosinone il 21 gennaio 1972.
32
Capitolo I
Da quanto scritto in precedenza emerge con chiarezza che Martini
aveva già ben delineate in sé fin dagli esordi le costanti delle proprie
motivazioni; motivazioni volte ad opporsi sempre più decisamente alle
teorie del naufragio e del nulla. Proprio dall’inizio degli anni ’60 in
poi i convincimenti dell’autore di cui mi occupo, da me definito, forse
un po’ iperbolicamente, l’antiapocalisse, si fanno più netti, come comprovano due testi che vanno considerati il discrimine tra due fasi:
quella dell’apprendistato e quella della raggiunta maturità. Alludo a
Qualcosa, comunque e a Fine dell’alibi, due drammi che denunciano,
in maniera sempre più marcata, la necessità di reagire alla caduta di
ogni valore. Citando nelle pagine precedenti i maggiori autori ai quali
Martini si è ispirato e i suoi diretti maestri, non ho fatto il nome di Aldo Capasso, che nel periodo tra le due guerre mondiali ha avuto un
ruolo importante come promotore culturale e come critico e che è stato
tra i primi a credere, assieme ad Antonio Pinghelli35, poeta e narratore
ligure di spicco, nelle qualità di Martini. Molti anni dopo Capasso avrebbe individuato nella pietà della condizione umana uno dei motivi
più tipici dell’operosità di Martini36. E per questo lo volle con sé tra
gli scrittori aderenti al movimento del “realismo lirico37”. Tra le liriche di Martini più apprezzate da Capasso ve n’erano due, intitolate ri35
Antonio Pinghelli, nato a Savona nel 1910 e morto a Milano nel 1999, è autore
di molti volumi di poesie e di un libro di racconti, La scomparsa del mare e altre
novelle (1937).
36
A. CAPASSO, Prefazione a D.G. MARTINI, Il maglio, EL, Savona 1993, pp. 5–7.
37
Che cosa sia stato il realismo lirico viene bene chiarito da Graziella Corsinovi
nella prefazione a Tredici poeti per il terzo millennio di Liliana PORRO ANDRIUOLI
(Le Mani, Recco 2003, p. 10): “Il manifesto del movimento, firmato da quattro poeti, Aldo Capasso, Lionello Fiumi, Giuseppe Gerini, Elpidio Jenco, sotto forma di
‘lettera aperta’ ‘ai poeti italiani di tutte le tendenze’, poneva le basi di un tipo di poesia sempre perseguito da Aldo Capasso: una poesia che privilegiava l’intelleggibilità
e la comunicatività, il rapporto con la realtà quotidiana e l’uomo comune, senza tuttavia sottovalutare mai l’aspetto tecnico–formale della poesia, senza il quale non esiste vera poesia. Insomma, l’esigenza di una intelleggibilità immediata del verso, espressione di verità essenziali, di sentimenti e di problemi reali, comuni a tutti gli
uomini, non poteva essere confusa col pressapochismo; e il ‘dovere della chiarezza
espressiva’, in evidente polemica con l’oscurantismo cervellotico di molta produzione lirica coeva, non doveva costituire un alibi per evadere dal labor limae e dalla tekne, sempre accuratamente esercitati da Aldo Capasso”.
Dall’esordio al premio Riccione
33
spettivamente Non udrò più le strida e Bimba zoppa38, inserite nella
sesta sezione della già ricordata silloge A greve cuore. Capasso le considerava esemplari espressioni del “realismo lirico”. A mio parere, le
due liriche manifestano in termini concreti quella rivolta contro le ingiustizie che è da sempre il substrato dell’ispirazione di Martini. In
quei versi sono riconoscibili la concreta presa sul reale e il grido di
protesta vivo nell’autore rispetto al male sofferto dalle creature umane. Nella prima lirica è una giovane donna pazza, nella seconda una
bambina zoppa. Forte impatto sulla realtà e ribellione sono termini che
mi paiono pertinenti anche per definire i sopra segnalati Qualcosa,
comunque e Fine dell’alibi. Al primo venne assegnato l’8 settembre
1962, con decisione unanime, il Premio Riccione. Commentando il riconoscimento, Lorenzo Ruggi39, il presidente della giuria di cui facevano parte tra gli altri Gino Cervi, Giorgio Guazzotti, Gino Damerini,
Maner Lualdi ed Eligio Possenti, affermò che il premio era «toccato
ad un giovane scrittore assai promettente». Pur essendo naufragato il
progetto di realizzarla con tempestività a teatro, la pièce venne pubblicata nel novembre di quello stesso anno sul n. 314 della rivista «Il
dramma». In prima assoluta il copione verrà realizzato dalla radio della Svizzera italiana la domenica sera dell’8 dicembre dell’anno successivo. L’esordio in palcoscenico avverrà il 4 febbraio 1965 nella versione, approntata per l’occasione, al Piccolo Teatro Brandon Ave di
Toronto. Nel frattempo il lavoro era stato tradotto da Emo Lonardi in
tedesco col titolo Etwas immerhin. A Toronto il programma di sala iniziava con un’introduzione, in inglese, di B. M. Corrigan, docente di
Letteratura italiana nella locale Università. Per il suo interesse ne riproduco alcune parti tradotte:
Quest’anno il club ha scelto per la prima volta un testo contemporaneo di un
drammaturgo pressoché esordiente, Dario G. Martini, giornalista genovese.
La sua pièce in tre atti […] ha vinto il Premio Riccione nel 1962 ed è stata
pubblicata da “Il Dramma” nello stesso anno. Chi ha familiarità con Come le
foglie di Giacosa riconoscerà che Qualcosa, comunque affronta, a due generazioni di distanza, una situazione più o meno analoga. Nei due drammi il ca38
D.G. MARTINI, A greve cuore, op. cit. pp. 73 e 77.
L. RUGGI, Storia di un premio
Il “Riccione” ha sedici anni, su «Il lavoro
nuovo», 13 novembre 1962.
39
34
Capitolo I
pofamiglia, nel primo Giovanni, nel secondo Carlo, è un grande lavoratore,
onesto, molto legato ai figli, ma incapace di condividere con loro i suoi ideali
né più in grado di capire i loro problemi. In entrambi i testi una concezione
materialistica dell’esistenza, a scapito dei valori spirituali, porta al disastro.
Mentre in Come le foglie Nennele preserva l’unità della famiglia e resta salda, nonostante ciò che le frana accanto, la giovane Anna, la nipote di Carlo in
Qualcosa, comunque, soggiace più facilmente alle insidie, finendo per restare
vittima di una brutalità più forte di lei. Tuttavia lo spirito di Nennele sembra
animare la poetica figura della sorella che non c’è più del dramma di Martini.
Il suo amore, la sua pietà e il suo tenero ricordo dell’infanzia e della giovinezza la rendono il coro della tragedia che sente giungere, anche se, malauguratamente, è incapace di evitarla. Anna rappresenta la poesia dell’umile quotidianità, così come Ettore, con la sua innocente mania per la pesca, condivisa
da Carlo, ne rappresenta il côté umoristico.
Subito dopo la Corrigan proseguiva:
L’argomento del dramma è quello che Martini ha nuovamente affrontato nel
successivo Fine dell’alibi, presentato al Teatro del Convegno di Milano nel
gennaio 1964 e pubblicato in febbraio su «Il Dramma». L’alibi al quale i personaggi dei due lavori di Martini fanno ricorso è un arido scetticismo. Franco
disprezza i valori nei quali crede suo padre e ritiene il fratello Marco responsabile della morte di Anna. Tra l’altro è incoerente, in quanto in un mondo da
lui definito assurdo, nessuno dovrebbe essere responsabile di ciò che fa. Colpevolezza e innocenza, in un mondo veramente assurdo, non potrebbero esistere. Marco è geloso di Anna. Non crede alla cattiveria, come Franco non
crede alla bontà. Luca sembra indignato per i difetti del fratello, ma non sa
vedere i propri. Basta una delusione amorosa per farlo diventare un ladro.
Tutti ritengono Carlo responsabile di non esercitare l’autorità che essi stessi
si sono rifiutati di accettare. L’amore che un tempo univa la famiglia sopravvive soltanto nei ricordi della sorella che non c’è più e nella sollecitudine di
Rina per la sorte del marito e dei congiunti. Carlo infine decide di non parlare
più e si impegna nella costruzione di un’arca che, dopo il diluvio, galleggerà
senza correre rischi. Franco, in extremis, capirà il padre e lo aiuterà. Qualcosa, comunque è un’eccellente illustrazione della nobile concezione di Martini
sulla funzione del teatro, basata su un auspicio di Jean Vilar: Il teatro deve
unire, in questi tempi diversi, uomini e donne di tutte le fedi confessionali e
politiche, e quindi concorrere alla creazione di una società nuova, radicalmente differente dalla nostra, avvelenata dallo scetticismo.
Riferendosi al parallelo Giacosa–Martini, la già citata Alessandra
Accorsi ha osservato:
Il milieu storico–sociale in cui vengono calati i personaggi delle due pièces rical-
Dall’esordio al premio Riccione
35
ca perfettamente quello dell’epoca in cui i due autori vivono: da una parte lo sfiorire dei brillanti anni della belle époque, dall’altra un’Italia in pieno boom economico dove però i segnali di crisi evidentissimi trapelano dalle parole e dai gesti
dei protagonisti. Si potrebbero definire due drammi, che fanno riferimento ad
un’unica matrice, quella del realismo, inquadrando il dramma borghese giacosiano sull’onda delle suggestioni veriste e i tre atti di Qualcosa, comunque come appartenenti al filone del neorealismo sociale, considerate le tematiche di disagio
giovanile e di conflitto generazionale che emergono.
La caducità dell’esistere, tema principale dell’operosità di Martini,
si manifesta nelle parole della ragazza che non c’è più. Questa, alludendo al proprio accomiatarsi dalla vita, dice, rivolta al padre:
Eppure è accaduto tutto di colpo, senza che avessi il tempo di accorgermene,
se non un momento, un momento solo, prima della fine… (Quasi in un grido)
È il mio rimorso, papà! Dovevo lasciarti abituare al pensiero che me ne sarei
andata … (Disperata) Ma non sapevo! Non ho potuto! (Come se rispondesse
ad una voce che la chiama) E neanche oggi posso aiutarti! (Affranta, dopo
40
una lunga pausa). Capita sempre così, senza preavviso… .
Sottolineo, sempre in relazione alla caducità dell’esistenza e a come Martini ponga la consapevolezza di tale caducità a sostanza di ogni disvalore, una delle battute finali dello scettico Franco al padre che
lo esorta a reagire:
Perché? Per chi? Siamo tutti morti, papà! Tutti. Ci pensavo, venendo qui, poco fa… C’era un morto con il berretto a righe che guidava il tram, e un altro
morto a darmi i biglietti e tanti altri morti seduti nella vettura e qualcuno in
piedi, a leggere il giornale del vicino. È solo questione di tempo, papà! Per
chi vuoi resistere? Per le tue ossa? Spariranno. La vita è assurda, vuota, non
41
ha senso! .
Poco dopo scatta la reazione di Carlo:
Ma è per questo che bisogna fare. Fare qualcosa, qualunque cosa, proprio
perché non c’è speranza, perché non c’è scopo, perché tutto sembra inutile.
Non dire alla vita Io ti do, perché tu mi dai. No. Sarebbe un mercato. Bisogna
40
D.G. MARTINI, Qualcosa, comunque, su «Il Dramma», n. 314, novembre
1962, p. 15.
41
D.G. MARTINI, Ivi, p. 38.
36
Capitolo I
dare perché lei non dà, proprio perché non dà, perché poi si finisce, perché si
42
deve sparire! Bisogna dare! Bisogna fare! .
Scrivendo per il «Corriere Canadese» di Toronto, un critico che si
siglava L.M. annotò il 27 gennaio 1965:
In Qualcosa, comunque, l’autore affronta con crudezza e lucidità i problemi
che più affliggono il mondo moderno, togliendo la maschera ad un conformismo ipocrita del vecchio mondo standardizzato per scaraventarci in faccia in
tutta la sua terribile realtà il dramma che affligge i contemporanei. […] Il
giovane drammaturgo ci introduce quasi in punta di piedi in casa di una famiglia piccolo–borghese di una qualsiasi città italiana. I personaggi del
dramma hanno ciascuno i propri guai, le proprie fisime e in tale clima
l’azione si dipana in un crescendo spietato e crudele.
Il lavoro, cui venne aggiunto il sottotitolo “per non essere distrutti”
e con varianti al testo, volute in gran parte dal regista e protagonista
Enzo Tarascio, andò in scena soltanto il 16 marzo 1973 al Litta di Milano, a cura della Compagnia de “Il collettivo teatrale” di Antonio Degradi.
Quasi concordemente la critica deplorò il fatto che un testo di così
forte denuncia, in presa diretta con una realtà destinata a farsi, soprattutto per i giovani, sempre più minacciosa, avesse dovuto aspettare
tanto tempo per giungere alla ribalta nel nostro paese. Il più esplicito a
questo proposito fu Carlo Maria Pensa che, in un articolo a tutta pagina per «La Fiera Letteraria», scrisse il 15 aprile 1973:
Ancora una volta, il discorso che vogliamo e dobbiamo fare è quello della
dissennatezza degli uomini e degli enti di teatro in Italia (Stabili in testa), della loro indifferenza quando non addirittura della loro colpevole idiozia. Dario
G. Martini, giornalista genovese che in teatro non è l’ultimo venuto, vinse,
con Qualcosa, comunque, il Premio Riccione 1962. Millenovecentosessantadue, si badi. Rappresentato dieci anni fa, questo copione avrebbe rivelato uno
scrittore ricco di fermenti anticipatori, coraggiosamente attento ai guasti che,
allora, cominciavano a prodursi nella famiglia e nella società, e ancora capace, tuttavia, di esprimersi — linguaggio e articolazione drammatica — secondo i moduli di un naturalismo vistosamente voluto, e sincero fino ai limiti
del melodramma.
42
Ibidem.
Dall’esordio al premio Riccione
37
Dopo aver esposto gli snodi della vicenda Pensa concludeva:
Tutto questo materiale umano ci arriva, dal palcoscenico, passando attraverso
l’inevitabile diaframma di un’epoca che dal ’62 a oggi, si è divorata e vomitata infinite volte. Dario G. Martini, da giornalista, capisce certamente questi
nostri rilievi sullo stacco tra cronaca e decantazione artistica; e avrebbe tutte
le ragioni per rammaricarsi, come facciamo noi, d’aver sofferto una così lunga e pregiudizievole anticamera.
Rammarichi, quelli di Pensa condivisi da Roberto De Monticelli43,
Alberto Blandi44, Giuseppe Biscossa45 e da altri recensori, tutti concordi, comunque, nel valutare positivamente il testo. Il quale testo fu
apprezzato dal pubblico, come testimoniano le ventinove repliche al
Litta, per l’incisività con cui Martini aveva fatto un’impietosa radiografia della famiglia di Carlo Degoli, un ferroviere in pensione. Marco, il figlio maggiore, ammazza, per amore o forse per gelosia, Anna,
la cugina giovanissima ma già traviata. Finirà, a sua volta, sotto i colpi
del fratello minore Franco, spacciatore di droga. Il terzo figlio, Luca,
si interessa di politica, anche se è su sponde opposte a quelle del fratello maggiore. Della quarta figlia, morta da tempo, si ode invece solo
la voce.
Paradossalmente contribuì al grosso successo la sopportazione con
la quale il pubblico milanese, la sera dell’esordio, dovette aspettare
quasi un’ora e mezza prima che la rappresentazione avesse inizio. Il
sipario si aprì con inusuale ritardo per il temporaneo sequestro della
protagonista da parte del fidanzato che non voleva che essa apparisse
sul palcoscenico in abiti succinti. Di tale fatto parlarono il giorno dopo
quasi tutti i quotidiani italiani. Anche i settimanali patiti del pettegolezzo imperversarono a lungo sull’accaduto con servizi illustrati da foto piccanti a pagina intera.
Va aggiunto che Qualcosa, comunque, ebbe anche un’edizione radiofonica in versione greca, diffusa da un’emittente di Atene.
43
R. D E MONTICELLI, Diluvio in casa del ferroviere, su «Il giorno», 18 marzo 1973.
44
A. BLANDI, Una crisi familiare tra simboli e delitti, su «La stampa», 18
marzo 1973.
45
G. BISCOSSA, Qualcosa, comunque o la speranza per non essere distrutti, sul
«Giornale del Popolo di Lugano», 30 marzo 1973.
38
Capitolo I
Nella sopra citata recensione canadese della Corrigan era notata la
connessione tra questo testo e Fine dell’alibi. Quest’ultima pièce,
benché scritta successivamente, fu allestita prima di quella premiata
con il Riccione. In effetti Fine dell’alibi venne rappresentata per la
prima volta il 16 febbraio 1964 al Teatro del Convegno di Milano con
la regia di Enrico D’Alessandro. Fu pubblicata nello stesso mese sul n.
329 de «Il Dramma». Nella recensione comparsa il 17 febbraio 1964
sul «Corriere Lombardo» Carlo Terron annotò:
Ecco un copione animato da nobili intenzioni. Quinto non ammazzare. Citazione dal programma, tanto perché non sussistano equivoci: “Ci si chiede se
la protesta di chi ha troppo ucciso e non vuole più uccidere abbia senso in un
mondo apparentemente condizionato non dalla volontà dei singoli, ma
dall’equilibrio. Equilibrio di forze che sembrano sfuggire alla possibilità di
incidere, di modificare, concessa ad ogni individuo. Richiamo, in altre parole,
alla somma delle responsabilità individuali, unico rimedio per opporsi ed evitare le stragi collettive. Fino a tanto che ognuno di noi non avrà il coraggio di
liberarsi dalle sue personali viltà, scetticismi, sfiducia, cinismo, opportunismo
e così via, tutto sarà inutile e ci faremo, più o meno consapevolmente, complici dell’incombente apocalisse. Giù le maschere, basta con gli abili e fuori
le personali proteste.
Subito dopo Terron proseguiva:
Su queste basi il richiamo ad Hiroshima non è una appropriazione indebita allo stesso modo che l’ombra dell’ufficiale americano che si assunse la responsabilità di sganciare la prima atomica e ne ebbe poi squassata la coscienza, si
accampa come protagonista di diritto della commedia.. Quel tale si chiama,
com’è noto, Claude, Claude Eatherly […] Si sa come l’infelice ha reagito, distrutto da un incoercibile senso di colpa: reiterati tentativi di suicidio, furti e
rapine scoperti per farsi incarcerare e soddisfare un bisogno di autopunizione,
ricovero coatto in manicomio. Un comodo mezzo per farlo tacere, quantomeno per invalidare la sua protesta con la scusa che è matto. Ebbene, nella
commedia Claude Eatherly è diventato Claude Loving e in scena non appare
mai. Sta chiuso al piano di sopra di un’isolata casa di montagna, dove Eve
Sheffield, giovane americana eroina del no, a metà Elettra e a metà fanciulla
del West, lo tiene nascosto dopo averlo fatto fuggire dalla clinica psichiatrica
dove era stato rinchiuso. […] Anche Hiroshima ha scelto una emblematica
variazione. Si è trattato di un ordigno infernale che anziché polverizzare creature, edifici e cose ha trasformato due milioni di abitanti in spaventose statue
di pietra, così, di colpo, come li ha colti, chi nei loro letti, chi per strada, chi
carezzando la testa dei propri figli, chi facendo l’amore.
Dall’esordio al premio Riccione
39
Eve non riuscirà a salvare Claude e il giornalista Sid Carrel, che
l’ha aiutata a far fuggire il pilota all’unico fine di realizzare uno scoop, dopo essersi rivelato a sua volta un essere abietto, anche lui oppresso dai rimorsi, si suiciderà.
Eugenio Ferdinando Palmieri su «La notte» del 17 febbraio 1964
affermò che uno dei personaggi, Sid altro non era «se non il simbolo
esplicito dell’umanità che per scetticismo, per sfiducia, per rassegnazione alle leggi non vuole nemmeno assumersi la responsabilità di
comportarsi come dovrebbe».
Il recensore della «Nazione» di Firenze osservò quello stesso giorno: «Sid Carrel è un uomo del nostro tempo, pronto a crearsi mille alibi pur di non sottrarsi al dilagante conformismo».
Un critico genovese, Giorgio Striglia, annotò nel gennaio 1964 sul
primo numero di «Controcorrente»: «I tre atti corrono veloci, stringati,
ricchi di azione scenica».
Diversi furono i pareri della critica. Terron, che pure fu benevolo
nei confronti di Martini, gli rimproverò un eccesso di teatralità. Di opinione diversa fu Eligio Possenti che scrisse su «Il dramma» nel febbraio 1964: «Ascoltando il lavoro trepidavano nell’anima i ricordi di
Hiroshima. […] Il dramma è ristretto, ma le sue risonanze si dilatano
nello spazio e nel tempo».
È curioso rilevare che proprio per questo spettacolo due critici abbiano definito Dario G. Martini una sorta di anti–Beckett. Alludo a
Giovanni Mosca e ad Achille Colombo. Il primo osservò il 17 febbraio 1964 sul «Corriere d’Informazioni»: «Buon esito di Fine dell’alibi, commedia in tre atti di un simpatico giornalista di Genova che
non si perita di opporre il suo teatro positivo al teatro negativo di Beckett e d’altri di quel calibro». Affibbiata a Martini la taccia di “Don
Chisciotte atomico”, Mosca elogiava comunque l’autore per il tentativo di opporsi al teatro di Beckett e compagni «sul quale sventola la
nera bandiera del disfacimento e della disperazione». Il secondo critico intuì in Martini un oppositore del nulla. Significativamente annotò:
«Questo lavoro fa un contrapposto alle idee oggi alla ribalta, quelle di
Jonesco, se vogliamo di Beckett: il nostro nichilismo, quando non è
moda o posa inutile, prende la forma dell’alibi rispetto alle presunte
responsabilità che non vogliamo assumere».
40
Capitolo I
La maggior parte dei giornali italiani si occuparono della pièce per
l’argomento affrontato e per l’essersi Martini posto ancora una volta
controcorrente nei confronti delle tesi circolanti allora in gran parte
dei teatri europei. Alcuni dei giudizi furono discordi. Il direttore del
settimanale «Zic Zac», in una nota dell’8 febbraio 1964, prese pungentemente a gabbo la disparità di opinioni con le sotto riportate argomentazioni:
Lo spettacolo — che ha sullo sfondo la figura di un alter ego del pilota di Hiroshima — ha ottenuto un vivo successo di pubblico […] ed ha visto i critici
tutti concordi nel rilevare i consensi avuti dal lavoro e nel lodare la nobiltà
delle intenzioni del testo — piuttosto divisi in ordine ai valori della rappresentazione. Partiti dal proposito di punzecchiare (con amicale crudezza) Martini con qualche zigzagante sfottò, abbiamo letto diligentemente le moltissime recensioni. Alla fine, però, ci siamo resi conto che l’alibi concesso festosamente all’autore — con la piena assoluzione decretatagli dagli spettatori —
è meno facilmente accordabile ad alcuni dei critici posti a confronto (fatta eccezione per quelli liguri che si sono trovati sostanzialmente d’accordo). Giudicatene voi. Per Roberto De Monticelli («Il giorno») la vicenda del dramma
“non regge un impegno così grosso”. Per Domenico Manzella («L’Italia»)
viceversa “ogni azione, ogni intervento, più che una concessione alle esigenze dello spettacolo, costituisce un meditato ausilio per dare concretezza scenica all’idea fondamentale”, al tema cioè della responsabilità. Per Vittorio
Catalani («Settimana Radio TV») Martini — a proposito del quale nelle varie
critiche sono stati chiamati in causa, più o meno a proposito, i nomi di
Brecht, Beckett, Betti, Giovaninetti e Bacchelli — è “uno scrittore teatralmente valido, la cui abilità di rapido creatore di situazioni riesce a calamitare
il pubblico”. Carlo Terron («Corriere Lombardo») dice che se l’autore ha un
difetto è quello di essere “fin troppo scopertamente scaltro”. Carla Ravaioli
(«Settimana Incom») afferma, da parte sua, che “il lavoro è condotto con notevole abilità”. Ma all’opposizione ecco un P.C. («24 ore») per il quale “il
meccanismo è così ingenuo che merita rilevarne l’ingenuità”.
Passando al dialogo l’articolista annotò:
È “avvincente e scaltrito” per Angelo Frattini («Il Sole»), “buono tutt’al più per
un giallo televisivo” (il già citato De Monticelli), “chiaro quanto sicuro” per
Franz Romani («Il Secolo XX»), artificioso per A.L. («L’Unità»), “di riporto, di
generica imitazione” per Gian Maria Guglielmino («Gazzetta del Popolo»),
“teso alla ricerca in un sottile sforzo di introspezione psicologica, dei richiami
più profondi al senso della dignità umana” per il «Roma» di Napoli. Vediamo
la regia di Enrico D’Alessandro. “Ha dato vita ad uno spettacolo bene ideato”
Dall’esordio al premio Riccione
41
per Eugenio Ferdinando Palmieri («La Notte»), “ha sottolineato con discrezione i possibili valori del testo”, Carlo Maria Pensa per «Gente», è stata “chiara e
ordinata” per Carlo Terron, “perfetta” per Franz Romani, “corretta e accurata”
per Mosca («Corriere d’Informazioni»), ma c’è anche chi l’ha vista “alquanto
mediocre” o “piuttosto disattenta” (ancora De Monticelli questa volta su «Epoca») e chi non l’ha neppure ritenuta meritevole di una citazione (l. Bar. per «La
Nazione»). Nemmeno i due maggiori interpreti si sono sottratti alla disparità di
opinioni. Anna Miserocchi “la cui bravura attribuisce a Eve Sheffield
un’inquietudine intensa, a tratti bruciante” (Raoul Radice, «Corriere della Sera») e Adolfo Geri, che ha dato a Sid “la esasperata sofferenza di un aggressivo
sarcasmo intelligentemente precisato e magistralmente messo a punto” (Carlo
Terron), per Gian Maria Guglielmino si sono semplicemente difesi “in probabile difetto di convinzione”, mentre per Mosca non hanno saputo sfuggire ad una
recitazione “annaspante”. È chiaro — dopo quanto si è esposto — che è molto
difficile trovare due critici perfettamente concordi sullo stesso argomento. È
chiaro inoltre — almeno per i lettori consapevoli — che non si può attribuire lo
stesso valore al parere di un Carlo Terron, come a quello, si fa per dire, di Gian
Maria Guglielmino. Ma è infine chiarissimo — ed eccoci al nocciolo della questione — che l’alibi non regge per i critici a confronto. Ecco la ragione per la
quale abbiamo risparmiato a Martini le punzecchiature in programma, preferendo zigzagare tra i pareri in contrasto di chi l’ha giudicato. La vita è, nonostante tutto e tutti, ancora bella: quella attorno al Teatro sovente spassosa, con e
senza alibi.
La reprimenda ai critici del direttore di «Zic Zac» ha forse fornito
lo spunto a Martini per Il sesso di pietra, il primo dei tre divertenti atti
unici di Eppure sopravvive. Da quanto scritto sopra appare evidente
che il Martini di allora non era quello de La mano mancina o di Perché non gridate? Alcuni degli addebiti mossigli erano in parte giusti,
come riconosce lo stesso Martini. «Allora ero più preoccupato dell’urgenza di alcune cose da dire che del come dirle e badavo più ai
contenuti che alla forma. E questo i critici sensibili come Terron erano
in grado di percepirlo. Perciò debbo loro gratitudine».
Per parte mia aggiungo che dopo le ventinove repliche a Milano, lo
spettacolo avrebbe dovuto compiere una lunga tournée.
Malauguratamente ciò non fu possibile perché il protagonista della
pièce, Adolfo Geri, cadde fuori dal teatro, dopo l’undicesima recita
(venne provvisoriamente sostituito da Franco Morgan). Poiché la sua
immobilità si protrasse per qualche tempo, la tournée già programmata dovette essere annullata. Per la cronaca segnalo che il testo verrà ripreso nel 1965, nel ’66 e nel ’67 da gruppi amatoriali.
42
Capitolo I