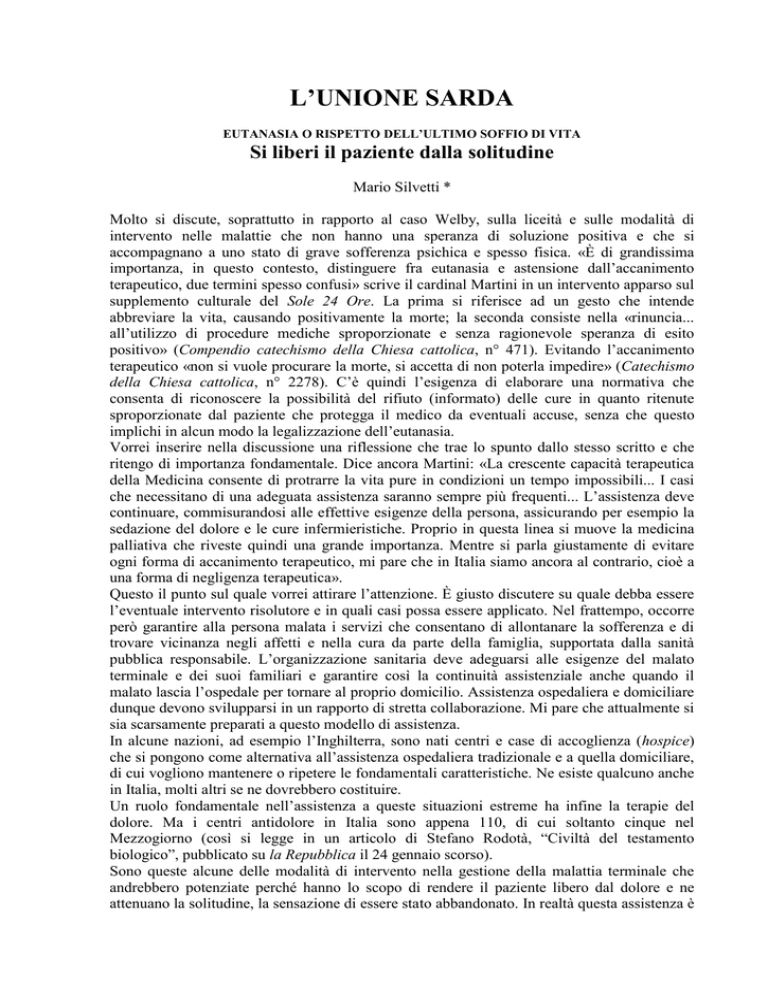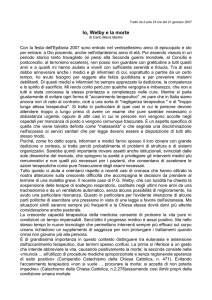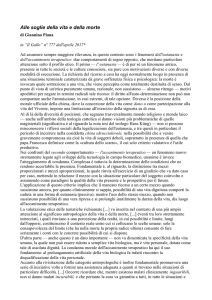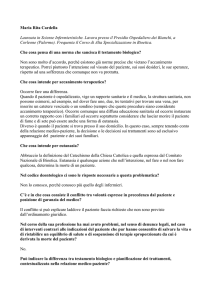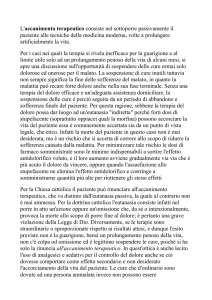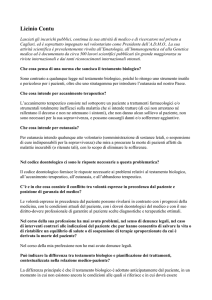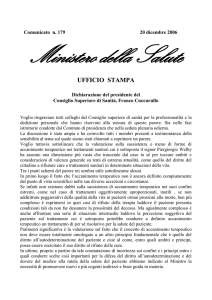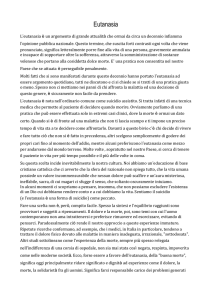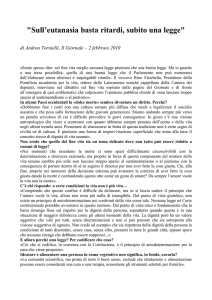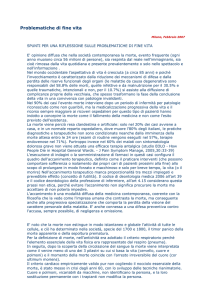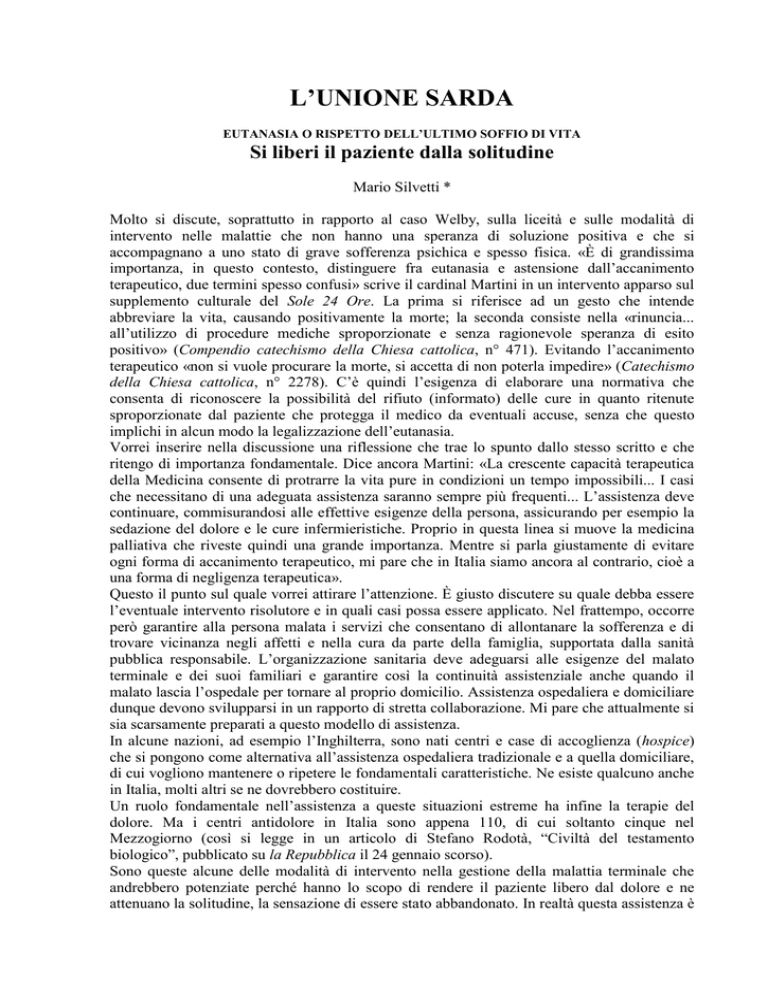
L’UNIONE SARDA
EUTANASIA O RISPETTO DELL’ULTIMO SOFFIO DI VITA
Si liberi il paziente dalla solitudine
Mario Silvetti *
Molto si discute, soprattutto in rapporto al caso Welby, sulla liceità e sulle modalità di
intervento nelle malattie che non hanno una speranza di soluzione positiva e che si
accompagnano a uno stato di grave sofferenza psichica e spesso fisica. «È di grandissima
importanza, in questo contesto, distinguere fra eutanasia e astensione dall’accanimento
terapeutico, due termini spesso confusi» scrive il cardinal Martini in un intervento apparso sul
supplemento culturale del Sole 24 Ore. La prima si riferisce ad un gesto che intende
abbreviare la vita, causando positivamente la morte; la seconda consiste nella «rinuncia...
all’utilizzo di procedure mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza di esito
positivo» (Compendio catechismo della Chiesa cattolica, n° 471). Evitando l’accanimento
terapeutico «non si vuole procurare la morte, si accetta di non poterla impedire» (Catechismo
della Chiesa cattolica, n° 2278). C’è quindi l’esigenza di elaborare una normativa che
consenta di riconoscere la possibilità del rifiuto (informato) delle cure in quanto ritenute
sproporzionate dal paziente che protegga il medico da eventuali accuse, senza che questo
implichi in alcun modo la legalizzazione dell’eutanasia.
Vorrei inserire nella discussione una riflessione che trae lo spunto dallo stesso scritto e che
ritengo di importanza fondamentale. Dice ancora Martini: «La crescente capacità terapeutica
della Medicina consente di protrarre la vita pure in condizioni un tempo impossibili... I casi
che necessitano di una adeguata assistenza saranno sempre più frequenti... L’assistenza deve
continuare, commisurandosi alle effettive esigenze della persona, assicurando per esempio la
sedazione del dolore e le cure infermieristiche. Proprio in questa linea si muove la medicina
palliativa che riveste quindi una grande importanza. Mentre si parla giustamente di evitare
ogni forma di accanimento terapeutico, mi pare che in Italia siamo ancora al contrario, cioè a
una forma di negligenza terapeutica».
Questo il punto sul quale vorrei attirare l’attenzione. È giusto discutere su quale debba essere
l’eventuale intervento risolutore e in quali casi possa essere applicato. Nel frattempo, occorre
però garantire alla persona malata i servizi che consentano di allontanare la sofferenza e di
trovare vicinanza negli affetti e nella cura da parte della famiglia, supportata dalla sanità
pubblica responsabile. L’organizzazione sanitaria deve adeguarsi alle esigenze del malato
terminale e dei suoi familiari e garantire così la continuità assistenziale anche quando il
malato lascia l’ospedale per tornare al proprio domicilio. Assistenza ospedaliera e domiciliare
dunque devono svilupparsi in un rapporto di stretta collaborazione. Mi pare che attualmente si
sia scarsamente preparati a questo modello di assistenza.
In alcune nazioni, ad esempio l’Inghilterra, sono nati centri e case di accoglienza (hospice)
che si pongono come alternativa all’assistenza ospedaliera tradizionale e a quella domiciliare,
di cui vogliono mantenere o ripetere le fondamentali caratteristiche. Ne esiste qualcuno anche
in Italia, molti altri se ne dovrebbero costituire.
Un ruolo fondamentale nell’assistenza a queste situazioni estreme ha infine la terapie del
dolore. Ma i centri antidolore in Italia sono appena 110, di cui soltanto cinque nel
Mezzogiorno (così si legge in un articolo di Stefano Rodotà, “Civiltà del testamento
biologico”, pubblicato su la Repubblica il 24 gennaio scorso).
Sono queste alcune delle modalità di intervento nella gestione della malattia terminale che
andrebbero potenziate perché hanno lo scopo di rendere il paziente libero dal dolore e ne
attenuano la solitudine, la sensazione di essere stato abbandonato. In realtà questa assistenza è
necessaria soprattutto oggi, che è profondamente cambiato il modello di rapporto medicopaziente. Negli ultimi decenni è avvenuta una trasformazione per cui si è passati da una
concezione paternalistica ad un’altra, che vede la persona malata sempre più autonoma.
Si afferma oggi, a ragione, che il pazienta ha diritto di conoscere il programma diagnosticoterapeutico e di esprimere il proprio consenso informato. Questa nuova situazione rende il
paziente più fragile se lo si lascia solo con le sue responsabilità decisionali. Scrive ancora
Martini: «È responsabilità di tutti accompagnare chi soffre, soprattutto quando il momento
della morte si avvicina...». Purtroppo, l’attuale organizzazione sanitaria troppo spesso non
offre ai pazienti un’assistenza che permetta di vivere “in modo umano” la morte. A me pare
che a questa grave carenza si debba rimediare.
(ex Primario di Pediatria all’ospedale Giuseppe Brotzu di Cagliari)
martedì 20 febbraio 2007