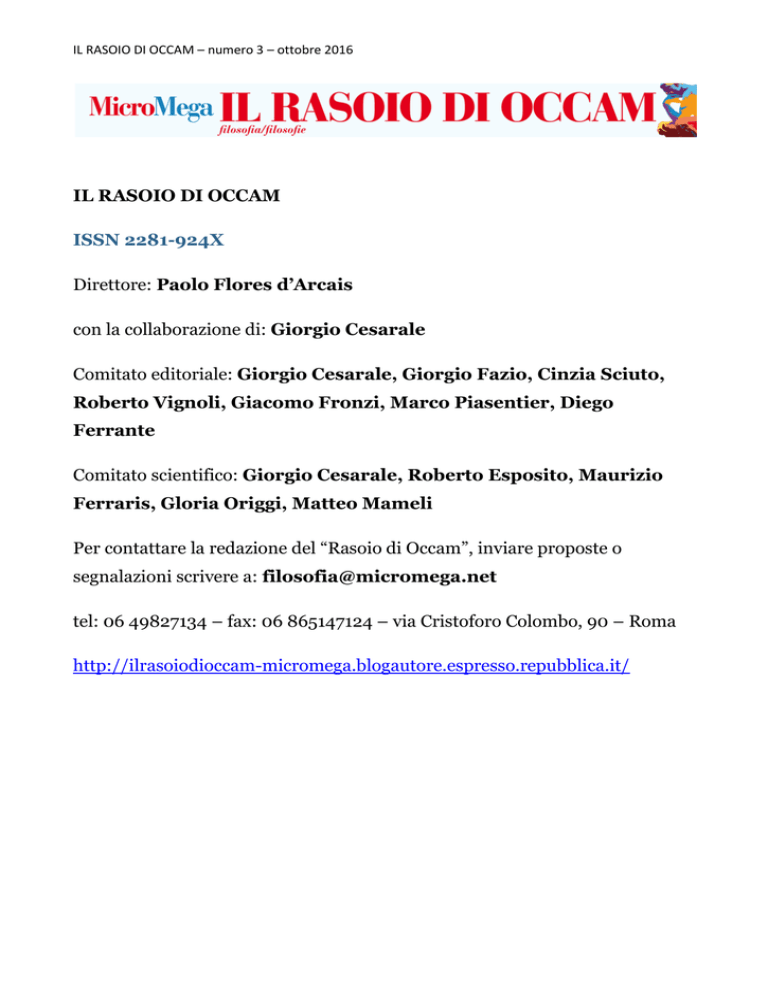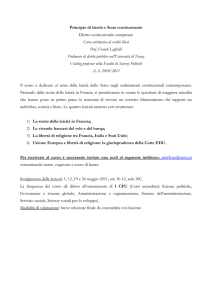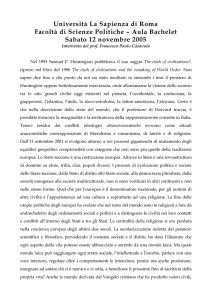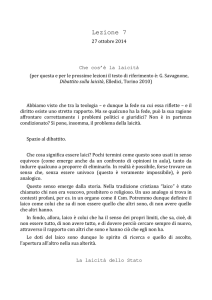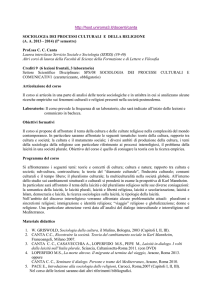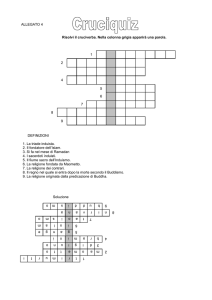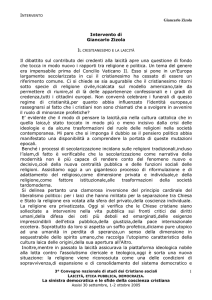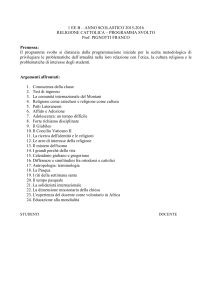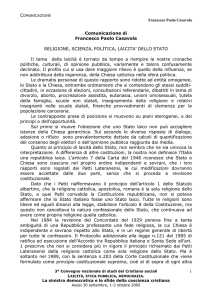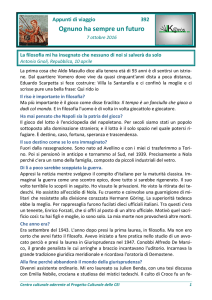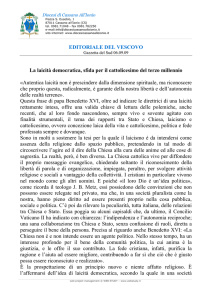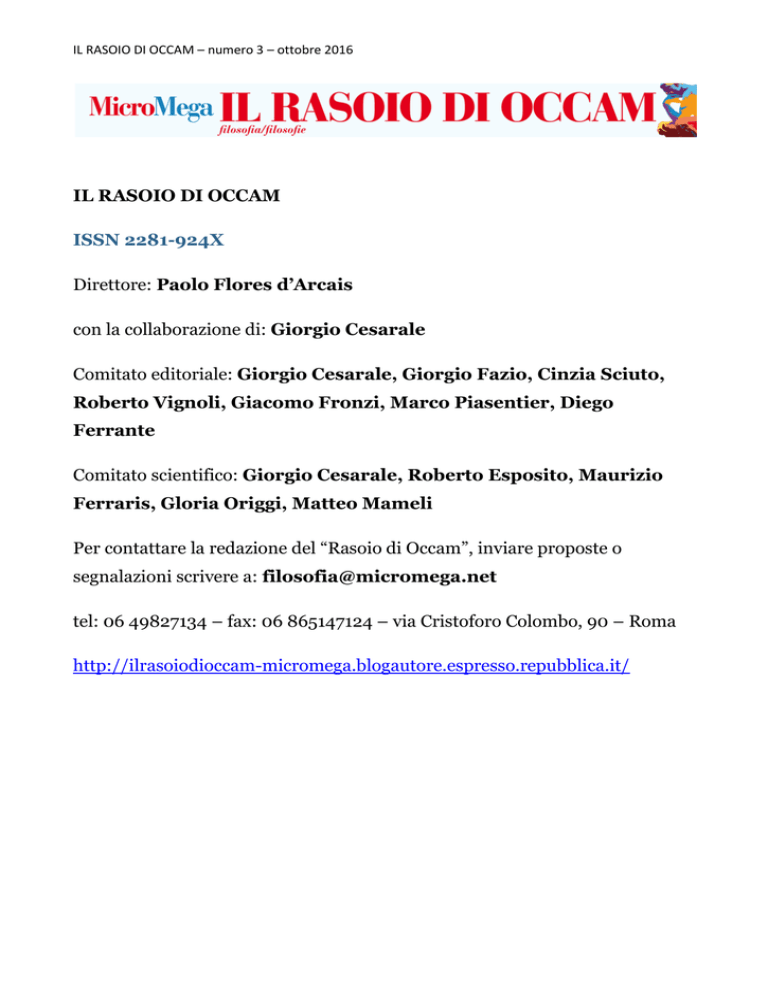
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
IL RASOIO DI OCCAM
ISSN 2281-924X
Direttore: Paolo Flores d’Arcais
con la collaborazione di: Giorgio Cesarale
Comitato editoriale: Giorgio Cesarale, Giorgio Fazio, Cinzia Sciuto,
Roberto Vignoli, Giacomo Fronzi, Marco Piasentier, Diego
Ferrante
Comitato scientifico: Giorgio Cesarale, Roberto Esposito, Maurizio
Ferraris, Gloria Origgi, Matteo Mameli
Per contattare la redazione del “Rasoio di Occam”, inviare proposte o
segnalazioni scrivere a: [email protected]
tel: 06 49827134 – fax: 06 865147124 – via Cristoforo Colombo, 90 – Roma
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Per una buona pratica della filosofia. Riflessioni a partire da
un cattivo esempio
di ANDREA CAVAZZINI e MARIA TURCHETTO
Il “Rasoio di Occam” ha già parlato, con un articolo a firma di Paolo Favilli, della Storia del
marxismo recentemente uscita per Carocci. Di quest'opera collettiva gli autori prendono in esame
il saggio dedicato alla presenza di Marx nel pensiero francese contemporaneo, per criticarlo ed
elevarlo ad esempio di una cattiva pratica di trasmissione dei contenuti filosofici.
L’ARTICOLO IN PDF
La Storia del marxismo in tre tomi curata da Stefano Petrucciani per l’editore Carocci e pubblicata
nel 2015 è un encomiabile tentativo di fare informazione e buona divulgazione[1]. Tanto più
lodevole quanto più non si potrebbe esagerare l’importanza di fornire alle generazioni più giovani
delle conoscenze precise e verificabili sul marxismo, questa componente decisiva della storia degli
ultimi due secoli che è ormai un oggetto della conoscenza storica.
Ci sono però altre ragioni che fanno di questa pubblicazione un utile stimolo per la riflessione.
Innanzitutto, occorre precisare che si tratta di una storia principalmente filosofica, in quanto
consacrata allo studio e all’analisi delle forme teoriche del marxismo[2]. Tuttavia, una specificità di
Marx e del marxismo consiste nel mettere in questione le partizioni disciplinari troppo nette e
abituali e di articolare filosofia, economia politica, storiografia, sociologia... Perciò, i concetti e le
teorie che compongono queste forme del marxismo appartengono a pratiche teoriche e a regimi
discorsivi differenti, e si inscrivono in congiunture storiche e politiche specifiche. Storia filosofica
dunque, ma che corrisponde ad una pratica della filosofia per cui è centrale il rapporto con una
molteplicità di saperi e con la storia globale.
Inoltre, tra i “generi” del discorso filosofico, quest’opera occupa una posizione specifica. Essa si
rivolge infatti ad un pubblico che si suppone già maturo ed informato, ma non “specialista”. Il suo
ambito è quindi distinto sia dall’insegnamento scolastico della filosofia e dalle finalità didattiche in
senso stretto, sia dalla produzione specialistica dell’Università. Posizione feconda e coraggiosa,
perché scommette sull’esistenza di un pubblico “ideale” di lettori che desiderano certo imparare
qualcosa ed accedere a nuovi strumenti critici e a nuove conoscenze, ma che sono anche già
portatori di saperi e di esperienze più o meno strutturati, e soprattutto la cui “volontà di sapere”
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
nasce più da curiosità intellettuali, da esigenze etiche o politiche, che da obblighi istituzionali o
professionali.
Il rapporto con un pubblico siffatto non dovrebbe essere sottovalutato nell’accostarsi a questa e ad
altre pubblicazioni. Ormai molti anni fa, Franco Fortini deplorava la scarsissima attenzione rivolta
dalla cultura italiana alla comunicazione didattica e scolastica, alla prosa pedagogica e divulgativa,
e lo “stato quasi generale di abbandono e di irresponsabilità in cui sono tenuti i testi destinati alla
scuola”[3] – fenomeni tanto più gravi quanto più, ricordava Fortini, è da questi strumenti che
l’enorme maggioranza trae gli strumenti per razionalizzare la propria esperienza e orientarsi nel
mondo. Questo fenomeno si doveva in primo luogo alla tendenza elitista della cultura umanisticoletteraria italiana, ma è stato trasformato e aggravato dal sorgere dell’industria culturale di massa,
che relativizza i confini tra espressione e concetto, educazione e entertainment, discorso pubblico e
effusione emotiva: perciò “gli uomini di sapere si sono messi a scrivere come letterati: quando
parlano, non chiamano mai la verifica”[4] . Schiacciate tra l’intuizione rarefatta e la conversazione
intima o frivola, finiscono così sacrificate qualità come l’oggettività, l’accessibilità, il rigore che
sono consustanziali alle scritture didascaliche e “formative” nella misura in cui esse si propongono
di facilitare l’uscita generale dallo “stato di minorità”. Scritture, queste, che suppongono non solo il
necessario e decisivo rapporto personale del ricercatore-autore con la sua materia, ma anche un alto
grado di padronanza di strategie di oggettivazione: criteri di obiettività, tecnica compilativa, rigore
terminologico, scrupolosità nei riferimenti fattuali… Tutti requisiti intesi a neutralizzare un rapporto
“esoterico” all’oggetto trattato, sottraendolo all’arbitrio e all’iperspecialismo, e permettendone una
circolazione “pubblica” effettivamente educativa.
È un fatto importante che un’opera storico-filosofica raccolga la sfida di queste esigenze e cerchi di
fornire una conoscenza precisa e un inquadramento razionale di un oggetto – il marxismo – che per
sua stessa natura rifiuta la frammentazione dei microspecialismi e resta indissociabile da interessi e
persuasioni irriducibili all’organizzazione scolastica e istituzionale dei saperi.
Un capitolo di quest’opera – “Marx in Francia” affidato a Manlio Iofrida (pagine 43-76 del secondo
tomo) – incarna però in modo addirittura clamoroso una maniera di praticare la (storia della)
filosofia in cui le esigenze di razionalizzazione e oggettivazione correlate al lettore ideale di cui
sopra sono del tutto disattese. Questa maniera consiste in un’oscillazione caratteristica tra
l’ultraspecializzazione dei settori di ricerca e l’espressione soggettiva di una “visione del mondo” –
due tendenze discorsive altamente autoreferenziali che finiscono per sopprimere nella pratica della
filosofia il momento comunicativo e formativo richiesto dalla divulgazione “alta” e dalle esigenze
civili e morali del suo pubblico ideale. Vorremmo procedere all’esame critico del testo di Manlio
Iofrida, concentrandoci non tanto sulle tesi che lo sottendono quanto sulla sua natura di discorso
inverificabile che si riduce ad un monologo senza oggetto né destinatario. Ci sembra che lo scarto
tra questo capitolo e le esigenze immanenti all’opera collettiva esprima con particolare chiarezza il
contrasto tra differenti maniere di esistere del discorso filosofico. A partire da ciò, sarà possibile
cercare di impostare un discorso su possibilità e limiti della pratica della filosofia, che va ben al di
là dell’episodio contingente da cui prendiamo le mosse.
Il testo di Iofrida inizia con un’affermazione programmatica alquanto impegnativa: si tratta di
capire “come possono essere «rinnovati» alcuni aspetti” del pensiero di Marx a partire dalla sua
ricezione filtrata da alcune caratteristiche peculiari della cultura francese (p. 43). È chiaro che
questa problematica è del tutto legittima per quanto riguarda le posizione del ricercatore Iofrida:
resta però che essa non è identica al compito di offrire una conoscenza precisa delle appropriazioni
francesi di Marx dopo il 1945. Questi due obiettivi potrebbero teoricamente coesistere, ma a
condizione che la questione del “rinnovamento” sia sostenuta e preceduta dall’adempimento del
primo compito, quello di far conoscere un oggetto storico ricostruito nei suoi tratti generali
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
accertabili. Invece, qui l’interpretazione di ciò che è vivo e ciò che è morto nel Marx
“francesizzato” finisce per sostituire interamente la ricostruzione di questa appropriazione.
Una prima conseguenza evidente di questo disinteresse per l’aspetto storico-informativo è che il
testo non definisce mai, e quindi non delimita, il suo oggetto. Viene certo detto en passant che si
tratta della “ricezione del pensiero di Marx”, e della “storia del marxismo nel dopoguerra in
Francia” (ibid.). Ma con ciò non si è ancora detto granché di preciso: perché né Marx in quanto
corpus testuale e concettuale né il marxismo in quanto corrente di pensiero, discorso teorico e
movimento politico sono delle entità omogenee la cui unità e coerenza sarebbero immediatamente
evidenti (guarda caso, sono in particolare due filosofi francesi ad averlo segnalato nel modo più
radicale, cioè Althusser e Sartre).
In una storia della ricezione di Marx e/o del marxismo occorre quindi definire cosa si intende per
“Marx” e “marxismo”: fanno parte del “marxismo” tutti i teorici che leggono Marx e ne riprendono
i concetti? Oppure solo quelli che sono anche militanti o compagni di strada di una componente
qualunque del movimento operaio, socialista e/o comunista? E viceversa, tutti i marxisti dal punto
di vista politico sono anche interpreti originali di Marx, oppure il loro “Marx” è filtrato dal
“canone” terzinternazionalista delle opere di Marx, Engels, Lenin e Stalin? E quando un autore
parla di “Marx”, in quale misura non sta invece parlando del “marxismo” come fenomeno storicopolitico, dell’ortodossia post-staliniana, o addirittura del senso storico-universale della politica
comunista? Quali testi di Marx sono accessibili a tale o talaltro autore in una data congiuntura? E
attraverso quali orizzonti di precomprensione questi testi sono letti?
Inoltre, e ampliando la prospettiva, quali discipline o sfere della cultura sono pertinenti in uno
studio del marxismo? Nelle ricezioni di Marx il ruolo dei filosofi di professione o formazione è
stato sempre innegabilmente importante, ma ciò non significa che sia stato esclusivo – tanto più in
una situazione culturale come quella francese dopo il 1945, in cui si assiste ad un prodigioso
mutamento del sapere che investe i confini disciplinari. In questo processo, Marx e il marxismo
giocarono un ruolo decisivo proprio nel senso di un discorso che ricostruisce i confini e gli statuti
dei saperi, eccedendo quindi la “filosofia per filosofi”, e anzi ridefinendo implicitamente ciò che la
filosofia può e deve fare. Nel contributo di Iofrida, non una parola è detta della ricezione di Marx e
del marxismo in antropologia (Lévi-Strauss, Lucien Sebag, Maurice Godelier…), in linguistica e
teoria del discorso (Michel Pêcheux…), in teoria letteraria (Roland Barthes…), in economia
(Charles Bettelheim, Henri Denis, Michel Aglietta e la Scuola della regolazione…). Ancora una
volta ribadiamo che è perfettamente legittimo dedicare uno studio alle sole letture filosofiche di
Marx, ma a condizione di esplicitare i criteri della costruzione dell’oggetto. Mancano insomma
delle domande (e delle risposte) preliminari, che preserverebbero il testo dal cadere nell’arbitrario.
Tali questioni preliminari sono forse un po’ astratte – e quindi sospette di aridità e pedanteria – ma
difficilmente evitabili se si vuole delimitare precisamente l’oggetto di un contributo storico e (far)
capire di cosa si sta parlando. A partire da esse, alcune scelte erano possibili (e esplicitabili) per
impostare il testo. Ad esempio si poteva (la lista non è esaustiva): 1) studiare le correnti intellettuali
e teoriche marxiste politicamente rilevanti; 2) analizzare le letture filosofiche di Marx dotate di un
certo “peso” teoretico; 3) seguire l’influenza di Marx nella cultura francese andando oltre gli autori
che si definiscono politicamente marxisti; 4) ricostruire il ruolo del marxismo nella trasformazione
delle scienze umane in Francia. Invece di distinguere queste strade possibili ed esplorarne una o
diverse, Iofrida fa come se tutto fosse ovvio come se l’oggetto e il corpus del suo testo non avessero
bisogno di alcuna definizione, e così associa arbitrariamente correnti letterarie influenzate dal
marxismo (il Surrealismo), filosofi marxisti e lettori di Marx (Sartre e Althusser) e autori nonmarxisti interpellati dal marxismo come fenomeno politico e intellettuale (Blanchot, Bataille,
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Merleau-Ponty). Diventa perciò opaco cosa colleghi o separi questi autori i cui discorsi e il cui
rapporto a Marx e/o al marxismo hanno degli statuti estremamente diversi.
D’altronde, anche le ragioni di studiare tali autori piuttosto che altri non sono mai dichiarate.
Distinguere e fissare degli oggetti precisi avrebbe potuto orientare la selezione degli autori o delle
correnti cui dedicare un’attenzione particolare. È incontestabile che qualunque prospettiva adottata
avrebbe imposto una selezione di autori e correnti e sarebbe stata quindi incompleta e parziale, ma
delimitare un oggetto e attenersi al compito di ricostruirne il profilo storico, fa sì che alcune scelte si
impongano di conseguenza. Si vuole parlare delle correnti intellettuali dotate di rilievo politico?
Allora bisogna parlare di collettivi-rivista come Socialisme ou Barbarie e Arguments o dei gruppi
sociologico-militanti attorno a Félix Guattari, Henri Lefebvre e Georges Lapassade. Si vuol parlare
delle “grandi” letture filosofiche di Marx? Allora occorre parlare di Gérard Granel e di Michel
Henry, di Lucien Sève e di Kostas Axelos… Si vuole parlare dell’influenza diffusa di Marx e del
marxismo presso dei pensatori non-marxisti in Francia? Allora non si può non parlare di Raymond
Aron e Michel Foucault. Si sceglie invece di concentrarsi sulle scienze umane? Dunque impossibile
tacere di Jacques Lacan e Claude Lévi-Strauss…
L’arbitrarietà dell’operazione di Iofrida si manifesta non solo nella selezione degli autori, ma anche
nel loro trattamento. Essi vengono gerarchizzati, non in base all’importanza storica della loro
attività – importanza che può essere misurata, ripetiamolo, solo a partire dalla delimitazione di un
oggetto storico dai contorni quanto più possibile precisi – ma secondo la loro prossimità alla visione
del mondo iofridiana.
Qualche esempio di “stranezze” certo minori, ma comunque significative nel contesto di una Storia
del marxismo con finalità divulgativa: Sartre e Althusser sono due figure colossali e complesse sotto
tutti i punti di vista, non pare possibile consacrar loro lo stesso spazio concesso a Tran Duc Thao (p.
58). Allo stesso modo, Bataille (p. 48) ha con Marx e il marxismo un rapporto molto più esplicito
che Blanchot (p. 50), le cui citazioni sembrano indicare un’influenza decisiva di Kojève e Bataille
quando si tratta di convocare temi e concetti marxiani o marxisteggianti. Bataille commenta
esplicitamente Marx e i marxisti, Blanchot fa delle allusioni anonime: pare discutibile dedicare loro
lo stesso spazio come se avessero lo stesso rapporto con l’oggetto in questione.
Problemi ancora più gravi sorgono nel trattamento di Sartre e Merleau-Ponty. Iofrida considera
Merleau-Ponty il filosofo francese più importante del secondo Novecento, e tende sistematicamente
a rivalutarlo nei confronti di Sartre. Però, ciò che il lettore vuol sapere dal testo di Iofrida, non è
cosa quest’ultimo pensi di Sartre e Merleau-Ponty, ma il ruolo rispettivo di Sartre e Merleau-Ponty
nella ricezione di Marx (del marxismo) in Francia dopo il 1945. Ora, rispetto a questo compito forse
modesto ma preciso, la tendenza di Iofrida a lanciarsi nella difesa e illustrazione della grandezza di
Merleau-Ponty finisce per produrre delle vere e proprie falsificazioni. Iofrida è perentorio: “Mentre
Sartre teorizzava l’impegno, ma in un quadro che non andava al di là di un democraticismo
generico allargato a un socialismo altrettanto generico, era il suo amico Merleau-Ponty ad affrontare
in modo articolato il problema di un aggiornamento del marxismo (…). L’incontro con Marx è ben
documentato già in Fenomenologia della percezione (1945), e si potrebbe risalire anche a La
struttura del comportamento (1942), ma la riflessione più sistematica è certo quella che troviamo in
Umanesimo e terrore (1947)” (p. 54). Inoltre, nel paragrafo dedicato a Sartre: “Poco senso avrebbe
rifarsi, per un discorso sul marxismo di Sartre, a L’es¬sere e il nulla (1943) o anche alla famosa
conferenza sull’esistenzialismo (Sartre, 1946): la maturazione politica di Sartre (…) è stata lenta e il
suo approccio al marxismo per lungo tempo subalterno a quello di Merleau-Ponty, che gli fu
maestro in questo campo. Il paradosso è anzi che, anche dopo la famo¬sa rottura del 1953, e le
critiche di Merleau-Ponty in Le avventure della dialettica (1955), questa subalternità continua,
come se Sartre si trovasse sempre un passo indietro rispetto all’amico” (p. 61). Quindi, la pertinenza
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
di Sartre per il marxismo francese comincerebbe solo nel 1960, con la Critica della ragion
dialettica.
Queste poche righe sembrano chiudere la questione con sicurezza “magistrale”. Tuttavia, esse
nascondono numerose trappole. Innanzitutto, per Iofrida Merleau-Ponty, sarebbe già un interprete di
Marx nelle sue opere teoretiche pubblicate tra il 1942 e il 1945. Si tratta di una tesi che meriterebbe
di essere maggiormente argomentata, ma soprattutto occorrerebbe distinguere l’operazione di un
filosofo che utilizza Marx per costruire il proprio percorso da un confronto con Marx, il marxismo e
il comunismo nel contesto del dopoguerra e della guerra fredda, quale Merleau-Ponty intraprenderà
nel libro del 1947. Insomma, il fatto di leggere e usare Marx nei lavori di un filosofo universitario
non può avere lo stesso statuto del tentativo di pensare la rivoluzione oltre il terrore staliniano
cercando di conciliare esistenzialismo e marxismo e rivolgendosi non già ad un jury de thèse ma al
Partito comunista francese. Iofrida omette di precisare tutto ciò, il risultato è che il lettore non
apprende granché su cosa dica Merleau-Ponty di Marx e del marxismo, né del perché lo dica e a chi.
Si direbbe quasi che il ruolo di Merleau-Ponty nell’introduzione di Marx in Francia si riduca ad
aver menzionato Marx (e Lukács) in un momento in cui nessun altro lo faceva. E infatti, ci viene
detto che negli anni ’40, mentre Merleau-Ponty lavorava sul marxismo, Sartre era un democratico
generico, teorizzava l’impegno e scriveva opere che non sono degne di figurare tra le ricezioni del
marxismo in Francia. Ora, nel 1946, Sartre pubblica nei Temps modernes il saggio “Matérialisme et
révolution”, critica esistenzialista del materialismo dialettico a cui Umanesimo e terrore cerca di
rispondere nei termini di un dialogo più costruttivo – cioè in effetti difendendo l’esistenzialismo e le
sue buone ragioni politiche e teoriche di fronte agli attacchi dei marxisti ortodossi del PCF contro
Sartre[5].
Si direbbe quindi che la ricezione del marxismo in Francia passi anche attraverso Sartre almeno dal
1946: infatti, contrariamente a quanto afferma Iofrida, gli interventi di Merleau-Ponty non
precedono, ma seguono, le prese di posizione di Sartre e rispondono ad esse. Infine, Iofrida
menziona la “famosa rottura” del 1953 tra i due filosofi, ma senza dire una parola sull’oggetto del
contendere – che è, guarda caso, il rapporto con il comunismo francese e sovietico – né sul fatto che
essa avviene anche intorno alla pubblicazione dei primi capitoli di Les communistes et la paix tra il
1952 e il 1954, lunga riflessione di Sartre su proletariato, partito e azione collettiva, che fonda
teoricamente la posizione del “compagno di strada”e che precede ovviamente la Critica del 1960.
Chi non sapesse tutto questo per altre vie, non lo verrebbe a sapere dal testo di Iofrida. L’autore è
certo libero di disprezzare Sartre e di esaltare Merleau-Ponty. Ma questa opzione non dovrebbe
impedire, in un contributo storico, di ricostruire correttamente dal punto di vista tematico e fattuale i
ruoli e le posizioni rispettivi dei due filosofi nella ricezione francese del marxismo. Soprattutto, il
lettore dovrebbe essere messo in condizione di farsi un’idea del dibattito tra i due sodali-avversari,
delle sue poste in gioco politiche e filosofiche, del suo contesto storico, dei suoi momenti, episodi e
date salienti, del contenuto generale dei testi principali coinvolti in questo confronto, piuttosto che
trovarsi di fronte quasi esclusivamente dei giudizi sommari e inverificabili sul valore rispettivo di
Sartre e Merleau-Ponty.
Se poi consideriamo un livello ulteriore, cioè l’interpretazione del senso globale di un’opera, di un
autore o di un pensiero, il quadro non fa che aggravarsi. Iofrida distingue raramente ciò che gli
autori dicono dalla sua interpretazione del senso di ciò che dicono; e quando lo fa, non dimostra mai
che la sua interpretazione effettivamente regge il confronto con i testi. Per esempio, Iofrida dice che
con Blanchot “il Marx e il Lenin dell’espropria¬zione violenta della classe borghese vengono
inseriti nella pratica poetica” (p. 53). Però il passaggio di Blanchot citato subito prima dice soltanto
che nella poesia “l’immagine prima (…) diviene incessantemente un potere più complesso e più
forte di trasformare il mondo in un tutto tramite l’appropriazione del desiderio” (p. 52). Il legame di
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
queste posizioni blanchottiane con la dittatura del proletariato forse esiste, ma si dovrebbe fare lo
sforzo di dimostrarlo. Il passaggio seguente è poi un esempio di interpretazione che potremmo
definire “trascendente”, la quale elimina con sovrano disprezzo tutto il lavoro di lettura e di
commento di un testo a favore di un’estrapolazione vertiginosa verso le regioni sublimi del Senso
fondamentale e dell’Essenza nascosta: “A cosa si riduceva, in sintesi, l’analisi di Le parole e le cose
di Foucault (1966), in cui il dialogo col marxismo era centrale, anche se in sordina? All’idea che era
inutile opporre la soggettività operaia all’enorme sviluppo tecnologico di cui si stava dimostrando
capace il capitalismo: era inutile, ma anche politicamente errato e controproducente, poiché portava
in realtà al totalitarismo” (p. 65-66).
La stessa “violenza ermeneutica” colpisce poco dopo Althusser, il quale “era convinto del fatto che
la scienza e la tecnologia del neocapitalismo non potessero essere trattate con concetti umanistici,
condivideva l’individuazione, in esse, di un fondo «ultratecnico» della tecnica, ma, al posto della
letteratura, pensava di poter mettere, non ancora la lotta di classe, ma un marxismo rinnovato, un
marxismo della «surdeterminazione», che avrebbe aperto a una rivoluzione assoluta, a una società
che nulla aveva a che fare con la società borghese” (p. 69). O ancora: “Il tipo di marxismo che egli
propone non è affatto, nonostante le apparenze, legato a un’idea leninista. Come in Foucault e
Derrida, dietro l’idea di scienza si nasconde l’opposto: la rivoluzione come evento imprevedibile,
come rottura surdeterminata, come lampo e precipitare di eventi” (p. 66). A titolo di esempio finale,
citiamo questo passaggio surrealista in tutti i sensi del termine: “La prospettiva surrealista di una
rivoluzione attraverso la letteratura e, soprattutto, la poesia, col suo riferimento centrale al
Romanticismo di Novalis e Nerval, nonché alla figura di Sade, e con la centralità che ha in essa il
riferimento all’inconscio freudiano, portava in una direzione antiumanistica che sarà piuttosto la
generazione strutturalista degli anni sessanta a cogliere: attraverso la lettura del Bataille del
dopoguerra, ormai riconciliatosi col Papa del surrealismo, Althusser, Foucault, Deleuze, Derrida
saranno i veri figli di Breton, ben più della generazione esistenzialista, che, con l’eccezione del
solito Merleau-Ponty, non lo ha molto amato” (p. 47). Senza voler minimamente interloquire con
Iofrida in quanto interprete del senso ultimo e profondo dei pensieri di Althusser o Foucault,
chiediamo allo storico della filosofia che Iofrida dovrebbe essere in questo contesto: quale lettore di
Althusser e Foucault li riconoscerebbe in queste righe che – ricordiamolo – hanno il compito di
introdurre un pubblico non specialista alle grandi linee del dibattito marxista in Francia? Certo, è
del tutto legittimo e indispensabile interpretare un autore attraverso categorie che non ha egli stesso
elaborato. Ma appunto l’interpretazione è una pratica che presuppone il rispetto preliminare dei testi
e dei contesti, non l’espressione incontrollata e incontrollabile di associazioni e suggestioni,
soprattutto se l’atto interpretativo è interno ad un testo il cui fine è fornire una conoscenza
introduttiva e degli strumenti critici di base.
Infine, molti termini e nozioni sono utilizzati in modo del tutto vago, onde non c’è modo di sapere
cosa significhino nemmeno per Iofrida, a fortiori per gli autori commentati. Ad esempio, Iofrida
evoca un marxismo ortodosso rispetto al quale gli autori commentati costituirebbero una rottura o
un’opposizione. Ma non viene mai detto nulla sulla natura di questo marxismo ortodosso, ciò che
rende impossibile misurare la radicalità delle eresie. Ancora: quando Iofrida vuol fare un
complimento a un autore, dice che questi non è leninista o è anti-leninista. Ma non c’è nessun
tentativo di spiegare cosa si intenda per leninismo. Iofrida sembra aver sentito dire da qualche parte
che il leninismo è una brutta cosa, quindi si affretta a stornare ogni sospetto di leninismo dagli
autori che ha deciso di approvare. Perciò ci assicura che Althusser non è leninista (p. 66), mentre
Sartre reintrodurrebbe il leninismo nel marxismo critico francese che ne era vergine (p. 65). Però, si
dà il caso che Althusser si sia richiamato apertamente a Lenin per costruire sia la sua teoria della
surdeterminazione che la sua visione della filosofia, e che Sartre abbia rinunciato già alla fine degli
anni Cinquanta a fiancheggiare il PCF e sia diventato al contrario l’interlocutore dei movimenti di
contestazione terzomondisti, anticoloniali, gauchisti, criticando quindi il primato del partito sul
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
movimento e l’azione “di base”. Ancora una volta, non si tratta di negare a priori la plausibilità
dell’interpretazione di Iofrida, ma di chiedersi come possa una lettura pertinente prescindere
completamente da alcuni dati fattuali inaggirabili - come i testi scritti e firmati dai suddetti
autori[6].
D’altronde, il testo rigurgita di espressioni come “giacobinismo”, “volontarismo”, “prometeismo”,
“politicismo”, che non sono riferiti ad alcuna corrente politica o teorica precisa, ad alcun insieme
testuale o concettuale, ma servono solo a veicolare l’approvazione o la disapprovazione dell’autore.
Tramite ammiccamenti e allusioni, omissioni e sovrainterpretazioni, il testo di Iofrida produce un
effetto immediatamente valutativo, in spregio di ogni bisogno di conoscenza, di orientamento o di
chiarificazione. La valutazione agisce su oggetti lasciati vaghi e imprecisi, caratterizzati attraverso
luoghi comuni e “per sentito dire”, senza mai confrontare l’apprezzamento positivo o negativo alla
resistenza e all’oggettività dei testi, dei contesti, dei concetti e delle biografie. Lo stesso dicasi di
nozioni meno politiche e più strettamente filosofiche, quali “positivismo”, “soggettivismo”,
“determinismo”, “antiumanismo”.Tutti questi concetti sono evocati senza che se ne precisino la
definizione, il quadro problematico e la provenienza. D’altronde, la proliferazione degli -ismi come
nozioni autoevidenti è in genere il sintomo più chiaro del fatto che le ricostruzioni verificabili sono
state abbandonate a profitto di un navigare a vista nel “si dice”, nel brassage irrazionale delle
opinioni che sono la materia prima dell’industria culturale.
Possiamo quindi concludere che questo testo rompe il patto implicito con il lettore virtuale di cui
abbiamo detto all’inizio, lettore che è il presupposto di un’opera come la Storia del marxismo. Ci si
può chiedere a questo punto com’è possibile che una tale incongruità sia passata inosservata nel
contesto di un’opera collettiva. Una pubblicazione quale la Storia del marxismo richiede
necessariamente, se non un lavoro collettivo in senso stretto, almeno il ruolo decisivo di un’equipe
coordinatrice. Com’è dunque possibile che il testo di Iofrida non sia stato sottoposto ad
emendamenti sostanziali?
La spiegazione risiede forse appunto nel carattere per nulla collettivo e razionalmente coordinato
della pratica filosofica in Italia, cioè nella predominanza sia di una specializzazione ad oltranza che
rende incomunicabili e inverificabili le singole ricerche, sia di un’abitudine inveterata al monologo
che fa di ogni ricercatore una coscienza pura alle prese con i massimi problemi. Del resto, sia
l’insegnamento universitario della filosofia che le pubblicazioni librarie consistono
tradizionalmente in una serie di monologhi idiosincratici tra uno specialista e il suo “mondo”
problematico e testuale, di cui studenti e lettori (eventuali) sono solo fruitori passivi ed esterni.
Le incongruità del testo di Iofrida sono appunto un’estremizzazione quasi caricaturale di questo
monologare, tanto più evidente quanto più esso non riesce ad essere “filtrato” e corretto nemmeno
dal vincolo di un’opera collettiva e ad intento pedagogico ben delimitato: non c’è dubbio infatti che
“Marx in Francia” sviluppa un discorso puramente “privato”, il quale, ansioso com’è di mettere in
piedi una “visione del mondo” normativa e valutante, finisce per perdere di vista non solo ciò di cui
parla, ma anche la posizione da cui parla e a chi.
Se questi tratti riguardassero solo Manlio Iofrida o un suo singolo contributo non meriterebbero
un’attenzione particolare. Crediamo invece che essi siano rivelatori di una situazione generale della
filosofia (almeno in Italia), una situazione rispetto alla quale opere come la Storia del marxismo in
cui questo testo è apparso rappresentano in via di principio una controtendenza. È su questa
situazione che l’analisi critica di questo lavoro vorrebbe avviare una riflessione. È noto infatti che la
filosofia soffre di una crisi durevole d’identità – come praticamente tutte le forme del sapere e della
cultura, ma con caratteri specifici, in particolare nel contesto italiano.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Con il venir meno della centralità istituzionale e culturale che le aveva affidato il neoidealismo di
Croce e Gentile, la filosofia in Italia ha non solo perduto l’evidenza del suo mandato sociale, ma è
stata anche singolarmente incapace di riflettere su questa perdita. La filosofia italiana nelle sue
correnti dominanti è stata in genere molto attenta al proprio statuto politico e ideologico, al proprio
rapporto con le “grandi narrazioni” – marxista, cristiana, liberale – ma molto reticente o disattenta
rispetto alla verifica dei propri strumenti, dei propri circuiti istituzionali (scuola, università,
edizione…), delle proprie modalità di esercizio, della realtà dei propri produttori e consumatori…
Così, si è prodotta una scissione tra le vette delle prospettive etico-politiche e gli automatismi non
interrogati delle istituzioni del sapere e della cultura, tra l’elaborazione di “visioni del mondo” più o
meno significative e la quotidianità dei manuali scolastici (nei licei) e dello specialismo erudito
(all’Università). Alla fine del Novecento, con la crisi delle grandi prospettive e culture politiche, la
situazione non è cambiata di molto. La struttura materiale della pratica della filosofia è rimasta
determinata passivamente dai dispositivi istituzionali e dalla loro logica autoriproduttiva: nei licei,
la dossografia storicistica dei manuali è stata tendenzialmente sostituita dalla centralità della
didattica e della metodologia, all’Università lo specialismo tradizionale si è andato adeguando ai
criteri internazionali di valutazione (impact factor, peer review…) da cui dipendono i finanziamenti
e le carriere. In parallelo, al venir meno del mandato politico-ideologico, ha risposto la ricerca
convulsa di una legittimità sociale attraverso i media, le psicoterapie “leggere” e la culturaspettacolo: aldilà della sua esistenza scolastica e accademica, la filosofia popola quotidiani,
settimanali e televisioni, il mondo del counseling e quello dei “festival” estivi. In tutti questi casi, le
esigenze di grandi meccanismi economici e politici e di vasti corpi professionali impongono al
campo filosofico una fisionomia ed un’evoluzione programmaticamente sottratte all’esplorazione
delle possibilità intrinseche di quest’ultimo e ad un rapporto adulto e produttivo con dei soggetti
interessati a tale campo per ragioni etiche, politiche e intellettuali.
Si dirà che tale è il destino di praticamente tutti i campi del sapere e di tutte le forme della cultura
nel mondo contemporaneo. Ciò è senza dubbio vero, ma solo in parte. Se osserviamo le discipline
letterarie, da un lato, e quelle scientifiche, dall’altro, non possiamo non constatare, proprio in Italia,
un impegno teorico e pratico considerevole nei confronti delle proprie condizioni di esistenza, della
presa di coscienza critica del proprio statuto sociale, dei propri interlocutori reali e virtuali: un
impegno di cui il campo filosofico non offre molti esempi. Nel campo letterario, pensiamo ai
dibattiti, che risalgono al dopoguerra, sull’introduzione dei metodi di analisi stilistica e poi
strutturalista (contro il culto dell’intuizione estetica e dell’impressionismo), a quelli sul “pubblico
della poesia”, sulla funzione della critica e dei suoi differenti generi, sulla letteratura nell’epoca
dell’industria culturale di massa e dei media… Nell’ambito scientifico, si pensi invece ad opere
come la Storia del pensiero filosofico e scientifico diretta da Ludovico Geymonat, agli interventi
critici di un Lucio Russo sull’insegnamento delle scienze a scuola, e al lavoro di associazioni come
l’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali) sull’insegnamento e la
divulgazione scientifici. Insomma, altre discipline sono state capaci – sia pure con difficoltà ed esiti
ambivalenti – di unire nella propria autoriflessione la coscienza lucida delle loro condizioni
materiali di esistenza, la volontà di praticare e difendere le proprie specificità e il proprio valore
culturale, e il rapporto con un pubblico non specialista ma colto e “impegnato”, a cui si devono ad
un tempo rigore intellettuale e prospettive generali. Al contrario, le forme dominanti della filosofia
hanno continuato e continuano ad occuparsi dei Grandi Temi metafisici e del Senso dell’Esistenza
fingendo di non sapere – o meglio, occultando attivamente tramite queste logomachie – che la
filosofia è, oltre che un atto del pensiero puro, una materia d’insegnamento, una disciplina
accademica, un settore del mercato editoriale e audiovisivo, e (forse) un interesse ed una passione
per dei soggetti pensanti, che si attendono e meritano di essere trattati come tali.
Sarebbe possibile aprire una riflessione su come evitare il monologo inverificabile, la vacuità
pretenziosa e le valutazioni arbitrarie nella pratica filosofica? C’è da sperarlo. Vorremmo suggerire
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
che una tale riflessione non potrebbe trascurare l’organizzazione concreta del lavoro filosofico, che
è anche un certo rapporto con le sue condizioni materiali. Una tale riflessione cioè non potrebbe
essere essa stessa monologica, ma dovrebbe necessariamente articolarsi alla messa a punto di gruppi
e programmi di lavoro, strategie coerenti per iniziative editoriali e culturali, pratiche riflessive
dell’insegnamento e della ricerca, organizzazione degli scambi e delle collaborazioni tra
interlocutori diversi.
Queste forme di riflessione e di attività esistono già senza dubbio, forse non hanno mai smesso di
esistere, e meriterebbero di non restare nella marginalità delle iniziative “private” dei soliti
volenterosi di cui vivono, sfruttandole e ostacolandole al tempo stesso, le istituzioni in crisi.
Sarebbe forse opportuno che un’inchiesta cominciasse su questi modi della filosofia che possono
ancora sottrarla alla dissoluzione nella chiacchiera e negli automatismi istituzionali. Si tratta di
un’aspirazione modesta e esigente ad un tempo, ma forse corrispondente a bisogni reali, e quindi
potenzialmente salutare entro un campo, quello filosofico, così spesso diviso tra falsa modestia e
false esigenze.
NOTE
[1] Per una presentazione dei singoli contributi, rimandiamo alle recensioni dettagliate di Paolo
Favilli, (http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/10/la-nuovastoria-del-marxismo-in-italia/) e di Vittorio Morfino in corso di pubblicazione in Critica marxista.
[2] Come segnala Paolo Favilli nella sua recensione, questo sguardo autonomo sulle forme teoriche
si può correlare al venir meno della connessione tra tali forme e “le forme assunte dall’antitesi dei
subalterni”.
[3] F. Fortini, “Premessa” a Ventiquattro voci per un dizionario di lettere, Milano, Il Saggiatore,
1968, Milano, EST, 1998, p. 23.
[4] F. Fortini, “Editoria di cultura e editori di moda” (1986), in Un dialogo ininterrotto. Interviste
1952-1994, a cura di Donatello Santarone, Torino, Bollati-Boringhieri, 2003, p. 445.
[5] Si veda a questo proposito Florence Caeymaex, communication présentée au colloque annuel du
Groupe d’Etudes Sartriennes international, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Paris, 17 juin
2005, http://www.philopol.ulg.ac.be/telecharge....
[6] Ricordiamo solo Pour Marx (1965) e Lénine et la philosophie (1968) di Althusser e, di Sartre, il
libro-dialogo con i dirigenti gauchisti On a raison de se révolter (1974).
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
La filosofia del “limite” nel secolo del nichilismo. Intervista a
Remo Bodei
di FRANCESCO POSTORINO
Remo Bodei ha recentemente pubblicato "Limite" (il Mulino), una importante riflessione filosofica
sull'idea di limite nell'epoca della globalizzazione. In questa intervista, si ricapitolano di questa
riflessione i tratti principali.
Il concetto del «limite» come è stato interpretato nelle diverse epoche e, in particolare, nella
modernità?
Diversamente dal mondo antico, dove l’andare oltre i confini stabiliti dalla divinità è hybris che
viene punita, la modernità è un andare al di là dei limiti, un plus ultra, un navigare verso l’ignoto.
Nelle sue avventure spirituali e nello slancio verso la scoperta di terre incognite, il pensiero
moderno ha infranto i divieti di indagare sui misteri della natura, del potere e di Dio, rivalutando
così la curiosità prima condannata come “concupiscenza degli occhi”. Sebbene non si debba avere
una concezione trionfalistica della modernità, come innovazione pura, completa rottura dei ponti
con il passato, essa certamente ha sfidato molti tabù imposti dalla tradizione, specie quelli segnati
dalla religione cristiana.
Il lungo, ma oggi accelerato processo della cosiddetta globalizzazione ha ovviamente portato
mutamenti radicali all’idea di limite. I confini degli Stati sono diventati “porosi”, civiltà prima
lontane o indifferenti si intersecano, si incontrano e si scontrano. I mezzi di comunicazione di massa
e le migrazioni mutano il panorama. Ma le principali civiltà contemporanee hanno davvero
cancellato tutti i limiti? O non è meglio sostenere che alcuni li hanno addirittura riproposti e perfino
violentemente rafforzati mediante la restaurazione dogmatica di fedi, mentalità e comportamenti del
passato (come nel caso dell’applicazione letterale della sharia, che significa, appunto, ritorno alla
“strada battuta”)? Ci sono limiti da rifiutare e limiti da conservare. Per distinguerli occorre coltivare
l’arte del distinguere, lasciandosi guidare, nello stesso tempo, da un’adeguata conoscenza delle
specifiche situazioni, da un ponderato giudizio critico e da un vigile senso di responsabilità.
Se guardiamo specificamente alla filosofia, nel periodo da Locke a Kant, la filosofia moderna si è
interrogata a lungo sui limiti dell’intelletto umano. Fin dove può giungere una solida conoscenza
basata sull’esperienza o sul sapere matematico prima di lasciare spazio alla fede o alla metafisica,
ossia a questioni indecidibili e a convinzioni non razionalmente argomentabili? Se per Locke ogni
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
idea trae il suo materiale unicamente dall’esperienza dei sensi, è chiaro che non si può attribuire
valore di verità a quanto si pone al di fuori di essa. Kant, a sua volta, delimita la sfera di validità
dell’esperienza paragonando l’intelletto a un’isola dai confini ben precisi, circondata da un mare di
apparenze, verso il quale gli uomini si sentono però irresistibilmente attratti.
La tentazione da evitare è quella di lasciarsi attirare dalle Sirene della metafisica, che invitano allo
scriteriato viaggio nell’oceano dell’apparenza, di lasciarsi sedurre da ciò che è inverificabile e
contrario all’unica verità alla nostra portata, quella dettata dall’esperienza. Non bisogna quindi
abbandonare il solido terreno di quest’isola dai “confini immutabili” per affrontare un’impresa che
è, comunque, destinata al naufragio. Sul terreno della dialettica, ossia dell’illusione di poter
risolvere problemi insolubili (ad esempio, se l’anima è mortale o immortale o se l’universo è finito
o meno), non ci sono altro che “antinomie”, soluzioni in contraddizione tra loro.
Lei traccia una linea continua che parte da Machiavelli, Hobbes e giunge fino a Nietzsche,
Bataille e Simone Weil. Il nichilismo contemporaneo si rivela l’esito coerente del processo
moderno di secolarizzazione? Non vi è rottura cioè tra moderno e post-moderno?
Il nichilismo, nel suo volto meno drammatico, implica l’impossibilità di giungere a norme e a
forme di conoscenza di natura assoluta. L’aforisma 125 della Gaia scienza di Nietzsche, una volta
stabilito che l’espressione “Dio è morto” è pronunciata dall’“uomo folle”, un pazzo che non si è
reso conto di avere compiuto un’azione più grande di lui, è in grado di scatenare conseguenze
imprevedibili. Ammazzando Dio – unità di misura fissa e dispotica di tutti i valori, guida morale,
oltre che religiosa – egli ha, infatti, essiccato la sorgente di tutti i comandamenti e di tutti i limiti,
ma, nello stesso tempo, ha anche creato uno spazio di libertà, che rischia di trasformarsi in un vuoto
che gli uomini, privati di una fede che dava senso alle loro vite, non sono ancora capaci di colmare
(lo stesso uomo folle dice anche di essere venuto “troppo presto”, in quanto la notizia di un simile
misfatto non è ancora arrivata “alle orecchie degli uomini”). L’esclamazione “Dio è morto e noi lo
abbiamo ucciso” non è quindi un grido di giubilo, perché scarica sugli uomini la terribile
responsabilità di vivere in un mondo privo di stabili punti di riferimento e tendenzialmente votato al
nichilismo.
Come ho appena detto, la modernità ha cercato da Kant a Locke e oltre di porre dei limiti al
relativismo, di stabilire delle frontiere tra il conoscibile e l’inconoscibile, di mettere in mora la
metafisica. Il cosiddetto pensiero post-moderno ha generalmente tratto le conclusioni e sostenuto
l’assenza di ogni verità assoluta, ripetendo la nozione del primo Nietzsche che non esistono fatti ma
solo interpretazioni. Si è però avvitato su se stesso ed è diventato pura retorica, dimenticando,
inoltre, che Nietzsche stesso ha poi considerato “vile” chi non cerca la verità. Il postmoderno
(termine che mette insieme troppe cose eterogenee fra di loro) ha comunque portato alle estreme
conseguenze aspetti già presenti nella modernità (si pensi soltanto a Hume, a Schopenhauer o a
Nietzsche stesso).
Rimaniamo sul pensiero moderno. Galileo e Newton cercano di cogliere, con metodi
matematici, il significato ultimo della natura. La filosofia di Hegel, con la peculiare
esaltazione del Concetto, sembra tradursi in una sorta di panlogismo. Come si conciliano
questi e altri residui metafisici con la direzione immanentistica e «senza limiti» inaugurata
dalla stessa modernità?
La ragione non costituisce in Hegel un pinnacolo gotico, un vertice del pensiero astratto che si
innalza e domina sovranamente la realtà effettuale (Wirklichkeit), espungendone il negativo,
unificandone le parti forzatamente e senza residui e cancellandone gli aspetti empirici. Malgrado
alcuni clamorosi errori, egli non ha l’improntitudine di voler piegare i saperi scientifici adattandoli
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
al letto di Procuste della sua filosofia. Queste accuse, che avevano un senso polemico quando
furono formulate da Schelling, da Feuerbach o dal giovane Marx, si sono poi inflazionate e
banalizzate. Il pensiero hegeliano non è monolitico, non è prevaricazione dell’idea sulla realtà
effettuale, non è sintesi conciliatoria degli opposti o «panlogismo». Hegel ha una straordinaria
fedeltà alle contraddizioni, al dolore, al negativo, che per lui (contro ogni tentazione utopistica) non
scompariranno mai, sono ineliminabili dalla vita.
Hegel aveva inoltre una profonda conoscenza delle scienze, specie dell’analisi infinitesimale, da cui
traeva il concetto stesso di infinito e di rapporto. Si è reso conto di qualcosa che solo con Cantor e
poi con Gödel verrà alla luce, vale a dire contraddizioni interne a ogni forma di conoscenza (per
Cantor, ad esempio, ciò accade attraverso quei numeri transfiniti che hanno mostrato il paradosso
secondo cui la parte – poniamo l’insieme dei numeri interi dispari – è «equipotente», ossia
ugualmente infinita, come l’insieme dei numeri naturali interi, pari e dispari); in termini hegeliani,
nessun sistema dunque può giustificare se stesso. In questo senso, si potrebbe dire che Hegel lega
ogni filosofia alla sua epoca, al “proprio tempo appreso con il pensiero”. In più, non bisogna
guardare solo alla logica, ma all’insieme appunto del sistema, come in una lingua non si guarda solo
alla grammatica.
In contrasto con la kantiana “isola dai confini immutabili”, Hegel è contro ogni limite, se non altro
per il fatto che l’idea di limite implica che la limitazione medesima sia già stata implicitamente
trascesa. Egli ha perciò voluto abbandonare il terreno solido dell’esperienza ristretta, la verità come
assenza di movimento, per arrischiare il “viaggio di scoperta” della sua Fenomenologia dello
spirito. In essa la verità non consiste più nel poggiare sul fondamento immediato di qualcosa
(l’intelletto kantiano o l’Essere della metafisica tradizionale), ma nel continuo oltrepassare se stessa,
nel ‘fare il punto’ ad ogni tappa per poi proseguire. La dialettica moderna nasce sotto il segno di
questa metafora dell’Oceano nordico. Tra apparenza e verità, tra fenomeno e noumeno non vi è più
opposizione assoluta: nei fenomeni si mostra anzi il progressivo apparire della verità.
La narrazione liberale, laica e occidentale riassume meglio di altre civiltà il senso autentico
del «limite»?
Contro ogni forma di razzismo e di sciovinismo, è giusto rifiutare la gerarchia tra le culture,
sostenere il concetto di métissage di tutti gli uomini, di impollinazione culturale reciproca, di
rivalutazione delle “differenze”, di rifiuto della boria dell’Occidente che si autoproclama portatore
dell'unica civiltà degna di questo nome. Ma quando ci si ricollega alla propria cultura quale fonte
primaria di espressione e come orizzonte simbolico immediato e la si equipara idealmente alle altre,
occorre - credo - stare anche attenti a non obbedire a radicati pregiudizi ideologici ponendole tutte
meccanicamente sullo stesso piano. Capisco che forse a qualcuno queste posizioni potranno
dispiacere o sembrare apologetiche e so bene che l’“Occidente” ha tremende responsabilità storiche
nelle tragedie verificatesi nel pianeta durante l’ultimo mezzo millennio. Eppure, alcune conquiste
del cosiddetto “razionalismo occidentale” sono preziose. E non soltanto nel campo delle scienze,
ma anche in quello delle forme politiche, come il liberalismo (che ha il suo centro nell’idea di
libertà) e la democrazia (che ha il suo centro nell’idea di eguaglianza). A meno che non si creda di
rispettare realmente una cultura oppressa rivalutando direttamente l'opera dello stregone, il rogo
delle vedove, le pratiche di infibulazione.
Anche oggi, nell’epoca della globalizzazione, diversi tempi storici coesistono nel nostro pianeta per
effetto di culture che vivono in diverse fasi di sviluppo o in diverse condizioni: dinanzi a quello
dell’accelerazione e dei riferimenti globali introdotto dalle potenze coloniali, resta spesso in molti
paesi il tempo più lento delle società tradizionali, che come ha mostrato Jared Diamond in Il mondo
fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali, ha anche i suoi vantaggi.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Ricorrendo a una terminologia weberiana, si può dire che dovunque lo “spirito del capitalismo” è
stato esportato, ha dovuto necessariamente abbandonare il suo humus etico, che lo sosteneva e lo
rendeva accettabile, in quanto sorretto da delicati servo-meccanismi di promozione e di
autorettificazione di un sistema messo a punto attraverso lotte e compromessi durati a lungo e non
immediatamente riproducibili. Il suo impatto su società relativamente stazionarie o a sviluppo più
lento (caratterizzate dalla "storia fredda") è stato spesso devastante. I “tentacoli del progresso” che
l'Occidente ha lanciato sul resto del mondo hanno trasferito i processi di industrializzazione o la
tecnologia applicata alle comunicazioni, all'igiene pubblica, ma non hanno esportato e plasmato in
loco una cultura adeguata, né altri popoli colonizzati o influenzati dall'Occidente sono stati
generalmente in grado di sviluppare degli anticorpi o degli 'ammortizzatori' a questo impatto. Il
senso di colpa dell’Occidente o di altri popoli, anche rispetto al passato, è certo un sentimento
nobile, che implica anche la necessità di una riparazione per le devastazioni che sono state compiute
in interi continenti. Gli europei si sono senz’altro presentati in vesti di evangelizzatori e di
missionari della civiltà e hanno distrutto innumerevoli culture.
In questa prospettiva, i moderni processi di globalizzazione hanno avuto il pregio di mettere in
rapporto civiltà per secoli o millenni isolate o relativamente isolate, di promuovere le conoscenze
reciproche, i viaggi e i commerci, ma hanno anche preteso di portare ogni popolo e gruppo allo
stesso livello della cultura dominante. Il risultato è che le gerarchie tra culture si sono accentuate.
Lei scrive che l’insediamento della democrazia sostituisce il potere divino e il carattere rigido
di ogni possibile autorità. Eppure Alexis de Tocqueville e J. S. Mill, solo per fare gli esempi
più noti, ci mettevano in guardia di fronte ai pericoli della «tirannia della maggioranza» e del
conformismo di massa.
È vero che la democrazia attuale subisce una deriva verso la tirannia della maggioranza e il
conformismo di massa (aggiungerei verso il populismo). Alla politica si affianca e si intreccia,
infatti, con sempre maggiore intensità, il pettegolezzo. Già Heidegger aveva denunciato la
“chiacchiera” come segno del conformismo che esonera il singolo dalla responsabilità delle sue
affermazioni, ma si riferiva ancora a quei discorsi spontanei, frivoli o banali, che ci sono sempre
stati. Oggi la comunità di vicinato, con le sue comari e le sue lingue lunghe, è quasi scomparsa,
sostituita da una fiorente industria del gossip. E, come è accaduto anche nel passato, per motivi di
convenienza e di consenso, la politica preferisce bypassare il pensiero critico e mettersi in sintonia
con il senso comune dominante. La differenza consiste nella sostituzione dei consiglieri del principe
con specialisti raccolti in “serbatoi di pensiero” governativi o di partito.
Ciò dipende anche dal fatto che essa è sempre più minacciata dalla scarsità di risorse da
ridistribuire, sia materiali che simboliche. Il loro prosciugarsi − entro un orizzonte d´aspettative
sociali decrescenti − viene surrogato da un pathos ipercompensativo di partecipazione mimetica alla
vita pubblica, da un’inflazione di sceneggiature, psicodrammi e messaggi politici sopra le righe.
Azzarderei pertanto l’ipotesi secondo cui gli elementi spettacolari tendono, in questo caso, a
crescere in proporzione diretta all’aumento delle difficoltà da superare. Si possono cioè considerare
gli ingredienti di teatralità fine a se stessi, puramente emotivi, in parte come sostituti di azioni
efficaci e, in parte, come pubblici cerimoniali propiziatori. Certo, nessuna politica si riduce a
teatralità, per quanto non si riesca a farne a meno. Il populismo è nefasto proprio perché la politica a
“uso esterno” prevale sulla soluzione coraggiosa dei problemi. Ma quale politico è disposto a fare a
meno di un consenso più facilmente acquisibile?
Non è agevole contrapporre a questa passività, che è alla base del conformismo di massa, il modello
di democrazia partecipativa. Come già osservava Bobbio, per diverse ragioni esso ha oggi poche
possibilità di essere accolto: perché in società complesse come le nostre, i cittadini sono giudici
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
poco informati sui loro stessi interessi; perché la politica ha costi altissimi e può essere esercitata
efficacemente solo da chi possiede o è in grado di procurarsi ingenti mezzi finanziari e di godere di
estese reti di influenza; perché i poteri occulti condizionano le scelte palesi; perché il pluralismo
confina con il corporativismo o, addirittura, con una moderna versione del feudalesimo; perché,
infine, dove prevale l’individualismo di massa la visione dell’interesse generale è sempre più
lontana dall’essere perspicua. Sarebbe già molto, come sostiene un allievo di Bobbio, Michelangelo
Bovero, se essa non degenerasse nel “governo dei peggiori”, la “cachistocrazia” o se le oligarchie
venissero, almeno in parte, erose e messe allo scoperto (senza confondere élites e oligarchie). Per
evitare che la democrazia diventi un involucro vuoto o appaia come una conquista scontata
dimenticando le aspre lotte per la sua conquista e il suo mantenimento, occorre prendere sul serio i
motivi della disaffezione nei suoi riguardi, scoprendo tuttavia al loro interno anche il simultaneo,
silenzioso appello al compimento di alcune delle promesse inevase.
Eventuali vie d’uscita dalle sue difficoltà devono dunque passare attraverso gli interstizi delle
aspirazioni dei cittadini (come il bisogno di identità e di speranza che il populismo a suo modo
soddisfa, o di eguaglianza come correttivo degli effetti perversi della lotteria naturale e sociale e
come articolazione con il merito all’interno dell’economia di mercato) e la messa in opera di
contrappesi alla concentrazione dei poteri nelle mani dell’esecutivo (dovuta anche all’accresciuta
necessità di decisioni rapide nel contesto della globalizzazione). Solo così si potranno contrastare la
fuga dalla politica, l’attrazione del populismo e il conformismo di massa.
Sostiene che il mondo è sempre più diviso tra la retorica del giovanilismo e una miope
gerontocrazia. Da dove bisogna iniziare al fine di reintrodurre l’età di mezzo, quale
espressione, a suo parere, di responsabilità generazionale?
Riformulerei così la domanda: Come rendere i giovani e i vecchi più responsabili anche in modo da
trasmettere alle generazioni future una società più giusta? Non sarà certo sufficiente armarci di
valori etici più coerenti e tenaci per far fronte ai rischi che il futuro ha in serbo. Il senso di
responsabilità, la fermezza, il coraggio, la propensione al rischio ponderato, l’attribuzione di dignità
e diritti a ogni essere umano, potranno, tuttavia, non solo fornire strumenti per muoverci in uno
scenario mondiale sempre più coinvolgente, per selezionare in modo adeguato i desideri e i piani di
vita individuali, ma anche per predisporre gli anticorpi necessari a resistere al richiamo di nuove
violente o seducenti mitologie. Ma, senza il loro radicamento e la trasformazione dei principi morali
in istituzioni politiche giuridiche, la loro efficacia sarà lasciata alla buona volontà dei singoli.
Questo accade sempre meno nel rapporto di solidarietà intergenerazionali, dove la presenza
pubblica dello Stato sociale o del Welfare sta diminuendo e lascia sempre più spazio alla famiglia in
cui nonni e padri sostengono con i loro salari (e pensioni) giovani senza lavoro che stanno a casa
fino a oltre i trenta’anni.
Un peso determinante ha avuto, specie sulla disoccupazione giovanile, la recente crisi finanziaria
del 2007-2008, che sembra più strutturale che congiunturale e che ha mostrato, nello stesso tempo, i
limiti e la capacità adattativi del capitalismo. Al di là della sua resilienza attraverso cicli di
“distruzione creativa”, al capitalismo, proprio secondo Schumpeter, i pericoli potrebbero
paradossalmente derivare non tanto dai suoi fallimenti, quanto dai suoi successi. Minando le
istituzioni sociali che lo sorreggono, incrinando i vincoli di solidarietà che caratterizzano i rapporti
tra Stato e cittadino, tali buoni risultati sono “inevitabilmente” destinati a creare le condizioni
secondo il criterio della lunga durata, che mette in rilievo differenze macroscopiche, condizioni in
cui esso non sarà più in grado di sopravvivere.
Una filosofia del «limite» che strumenti ermeneutici e teorico-politici deve impiegare in un
contesto multiculturale oramai in alta tensione?
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Quando, per un eccesso di multiculturalismo, è stato permesso alle donne indiane ciò che nella
stessa India non è stato mai permesso, ossia di abortire in ritardo, dopo che si è visto attraverso
l’ecografia il sesso del nascituro, su ottomila casi, settemilanovecentonovantasei sono aborti di
femmine e quattro, aggiungo, sono un errore. Questo esempio mostra come si debbano porre dei
limiti a chi giunge da noi con altre culture, consentendo loro la libertà di culto e di pensiero, ma
negando loro, oltre che, ovviamente, la propagazione violenta del proprio credo, l’asservimento
della donna o la poligamia. La sfida della convivenza è, anche qui, seria e bisognerebbe avere un
doppio coraggio: da un lato, non lasciarsi intimidire dall’aggressività e dalla chiusura in se stesse di
molte culture con cui si viene a contatto (a carattere ‘adolescenziale’, caratterizzate spesso da un
negativismo e da un eccesso di legittima difesa, tipico di identità ancora fragili), le quali, proprio
perché posseggono identità deboli, sono le meno disposte a negoziarle; dall’altro, guardare al lato
oscuro del nostro universalismo, ascoltando le voci altrui e domandandoci dove potrebbe aver torto.
I particolarismi e i ‘fondamentalismi’ nascono infatti soprattutto all’interno dei popoli e dei gruppi
che sono stati esclusi dal “banchetto dell'universalismo” e che perciò rifiutano o diffidano di un
gioco in cui sono abituati a perdere sempre. E ciò avviene non solo nelle periferie del pianeta, ma
nel suo centro politico, come si evince dal progressivo fallimento delle politiche di integrazione, del
melting pot in una società multiculturale per eccellenza, come quella degli Stati Uniti.
Sull’universalismo a senso unico e sulle complementari reazioni di rigetto che esso provoca
occorrerebbe interrogarsi a fondo. Si rischia altrimenti di rinfocolare i bigottismi e i parrocchialismi
dei cosiddetti movimenti particolaristici, fondamentalisti o separatisti (sino a giungere alle
ridicolaggini linguistiche di certe frange del femminismo estremista americano, secondo il quale
bisognerebbe dire non solo, His-tory, ma anche Her-story).
La convivenza è tuttavia possibile, ma in forme nuove che devono essere trovate e applicate. Altre
fedi o altre morali − come quella stoica − hanno diffuso l’dea dell’unità del genere umano, per cui
nessun uomo è in realtà uno straniero, da escludere dalla comunità. Molti imperi e molti Stati hanno
avuto natura multinazionale: da quello romano a quello austro-ungarico, da Bisanzio all’Unione
Sovietica. Ciò li ha resi più tolleranti verso l’alterità, ma non ha potuto cancellare i confini tra
inclusione ed esclusione. Li ha solo spostati, distinguendo tra lealtà o slealtà verso l’imperatore o
verso lo Stato, fedeltà o infedeltà, devozione o meno alla causa. Oggi la convivenza, soprattutto sul
piano delle tradizioni e della religione, dovrebbe essere impostata sul criterio fondamentale della
pluralità delle posizioni e delle fedi che nessuno deve imporre con la forza o, in certi casi, a
semplici colpi di maggioranze parlamentari.
Soprattutto, per evitare i conflitti a base religiosa (reale o apparente) occorre capire che le fedi non
si riducono a meri apparati dottrinali o rituali: nel corso dei millenni s’intrecciano con tradizioni e
forme di vita da cui è arduo scorporarle. Uno dei motivi più forti dell’ostilità mostrata in diversi
paesi nei confronti dell’Occidente non dipende tanto dalla sua professione del Credo cristiano,
quanto dal fatto che la diffusione dei suoi stili di vita (anche attraverso il cinema e a televisione)
minaccia consolidate gerarchie sociali, mettendo, ad esempio, in discussione il ruolo subordinato
della donna. Bisogna, con amarezza, riconoscere che a livello planetario non si è ancora presa piena
coscienza di quanto − già nel Cinquecento, ai tempi delle guerre di religione in Francia − sosteneva
Michel de l’Hôpital: “non importa quale sia la vera religione, ma come si possa vivere insieme”.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Riconoscimento reciproco o disaccordo politico? Axel
Honneth e Jacques Rancière a confronto
di GIORGIO FAZIO
Ne “Il Rasoio di Occam” si è già discusso a lungo delle ultime pubblicazioni del filosofo tedesco
Axel Honneth. Completiamo ora la ricognizione della ultime fasi del suo pensiero, prendendo in
considerazione il dibattito che egli ha recentemente ingaggiato con un altro protagonista della
scena filosofica mondiale, Jacques Rancière.
Nel momento in cui in Italia sono uscite, a poca distanza una dall’altra, le ottime traduzioni dei due
libri di Axel Honneth Il diritto della libertà e L’idea di socialismo[1] - riaccendendo i riflettori sulla
proposta teorica di uno dei protagonisti della scena filosofica contemporanea - è stato pubblicato
negli Stati Uniti, nella serie “New Directions in Critical Theory“ della Columbia University Press,
un interessante volume intitolato Recognition or Disagreement.[2] Si tratta della trascrizione di un
dialogo, tenutosi nel 2009 presso il prestigioso Istituto di Scienze Sociali di Francoforte, che ha
visto protagonisti lo stesso Axel Honneth e il filosofo francese Jacques Rancière. Oltre a questo
dialogo, nel volume sono riportati anche altri contributi dei due filosofi: due testi che aprono il
libro, in cui Honneth e Rancière provano a mettere a fuoco quali sono, dal loro punto di vista, i
problemi e i limiti degli approcci del proprio interlocutore, e altri due articoli, che chiudono il
volume, a cui viene affidato il compito di chiarire in positivo il cuore delle loro diverse posizioni. Si
tratta nel complesso, quindi, di un testo estremamente interessante e ricco di spunti teorici, che offre
l’occasione per ritornare su molte delle questioni che stanno emergendo nel dibattito suscitato in
Italia dalla recente pubblicazione dei due volumi di Honneth a cui si è appena fatto riferimento.
Mettendo a confronto due esponenti di spicco del pensiero critico contemporaneo, appartenenti per
di più a due aree culturali diverse - la filosofia tedesca e la filosofia francese - questo testo offre
anche la possibilità di svolgere alcune riflessioni sulla questione più complessiva dei compiti e delle
sfide cui è messa di fronte oggi una teoria critica della società. Volendo intendere qui con questa
denominazione ogni approccio teorico che, facendo interagire diversi ambiti disciplinari, tenta di
offrire strumenti di analisi dei principali meccanismi di ingiustizia, di esclusione e di dominio delle
nostre società tardo o iper-moderne, contrassegnate dal dominio economico e culturale del
„neoliberalismo“; e d’altra parte, cerca di concettualizzare in maniera riflessiva l’agenda dei
movimenti di emancipazione del proprio tempo, lavorando in vista della realizzazione dei loro
obiettivi. Teoria critica della società vuol dire, quindi, allo stesso tempo e necessariamente teoria e
prassi: in questione è un approccio che, comunque sia declinato, se tenta di mettere a fuoco i
meccanismi sistematici di ingiustizia che permeano le nostre società, non può esimirsi dal porsi in
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
relazione, e in qualche modo al „servizio“, dei movimenti sociali che lottano per l’emancipazone,
ossia per la rimozione di ogni ostacolo alla piena realizzazione della libertà e dell’eguaglianza di
tutti gli individui.
Il titolo del volume che ospita il confronto tra Honneth e Rancière – Riconoscimento o Disaccordo
– pone da subito efficamente in tensione i due concetti-cardine attorno a cui ruotano le diverse
strategie seguite dai due pensatori per dare corpo al programma di una teoria critica e, in qualche
modo, per rispondere alla sfida più spinosa di fronte a cui essa oggi si vede messa di fronte: come
ripensare il tema dell’emancipazione e come, da qui, acquisire criteri capaci di valutare la qualità
dei movimenti e delle lotte sociali, offrendo loro anche una prospettiva e un orizzonte di ampio
respiro. Sotto i titoli di «reciproco riconoscimento» - o, secondo la terminologia più recente di
Honneth, di «libertà sociale» - e di «disaccordo», Honneth e Rancière hanno tentato, infatti,
ciascuno partendo dal proprio punto di vista, di rimettere mano all’idea di «emancipazione
universale» che animava al fondo il pensiero marxista, e lo hanno fatto sotto la pressione di istanze
per molti versi accostabili. E per entrambi, ripensare il tema dell’emancipazione ha significato
innanzitutto svincolarlo da quelle premesse che, come ha efficamente ricostruito lo stesso Honneth
nel suo ultimo testo, L’idea del socialismo, animavano la teoria socialista dell’Ottocento, anche
nella sua versione marxiana: la centralità del proletariato, il determinismo storico, l’economicismo.
Lotte per il riconoscimento. Ripensare il tema dell’emancipazione
All’inizio dei loro itinerari teorici tanto Honneth quanto Rancière sono partiti dalla constatazione
che il soggetto della trasformazione sociale non poteva più essere fatto coincidere con un attore
collettivo sociologicamente determinato - il proletariato industriale - immaginato come portatore
„naturale“ di interessi economici oggettivi e universali, prodotti automaticamente dalla stessa
dinamica del capitalismo. Entrambi hanno assunto che il tema dell’emancipazione umana doveva
essere depurato da ogni lettura teleologica, lineare e necessitante della storia: dal postulato, cioè,
che la «società dell’avvenire» sorge necessariamente dalle contraddizioni del sistema capitalistico;
postulato, questo, che finiva per relativizzare lo stesso ruolo della prassi dei soggetti sociali. Ed
entrambi, infine, hanno capito che era necessario prendere le distanze dall’economicismo, ossia
dall’idea per cui per realizzare una società post-capitalista, bisogna abbattare il sistema economico
capitalistico ed è da questo abbattimento che conseguono automaticamente anche le condizioni di
una democrazia reale. Tanto per Rancière quanto per Honneth, l’esperienza del socialismo reale ha
dimostrato, ad abundantiam, che la questione dei diritti individuali e della democrazia si ripresenta
immutata, in tutta la sua irriducibile autonomia e cogenza, anche in una società non o postcapitalistica. In realtà, il confronto critico con l’eredità del marxismo, intrapreso dai due filosofi
all’inizio della loro carriera, si lascia accostare anche per qualcosa di piu profondo: ossia per il
modo in cui tutte queste esigenze sono precipitate alla fine nell’importanza che entrambi hanno
accordato al tema del «riconoscimento». Esiste infatti anche una versione rancèriana della «lotta per
il riconoscimento» (Honneth) e, per convincersene, come suggeriscono anche i due curatori del
volume, è sufficiente operare uno scavo genealogico sulle sue opere della maturità e, in particolare,
su quella che ha dato fama internazionale al filosofo francese, ossia Il Disaccordo (1995).
Come è noto, Rancière prese parte nel 1965 alla compilazione dell'importante volume collettaneo
Lire le Capital (Leggere il Capitale), insieme al suo maestro Louis Althusser, a Étienne Balibar, a
Roger Establet e a Pierre Macherey. Solo alcuni anni dopo, tuttavia, egli aveva già interrotto il suo
sodalizio scientifico con Althusser. Questo distacco fu motivato innnazitutto dai contrasti sorti
riguardo alla valutazione politica degli eventi del maggio 1968. Ma alla base di questa diversa
valutazione politica c’era un motivo teorico fondamentale. Per Rancière, l’approccio althusseriano
tendeva a riprodurre costantemente una forma di «rottura epistemologica» tra il piano scientifico
della teoria e quello della vita ordinaria. Il marxismo strutturalista produceva una disgiunzione
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
radicale tra la filosofia – intesa come scienza delle leggi del dominio e dello sfruttamento della
società capitalistica, ma anche come scienza degli apparati ideologici che impediscono di
riconoscere queste stesse leggi - e la prospettiva della gente ordinaria. È quello che Rancière ha poi
denominato il circolo vizioso della «scienza dell’ineguaglianza», a cui egli ha contrapposto poi il
«metodo dell’eguaglianza». Da una parte la scienza delle leggi del dominio dimostra che i dominati
sono tali perché ignorano le leggi dello sfruttamento e dell’oppressione. D’altra parte, essa dimostra
che questa stessa ignoranza è il prodotto del meccanismo del dominio. Il risultato è quindi che
coloro che possiedono la scienza sociale sono sempre un passo avanti rispetto alla gente ordinaria,
scoprendo ogni volta una nuova forma di soggezione e di ineguaglianza. La teoria critica si chiude
in una torre d’avorio e dietro la pretesa di aver raggiunto una comprensione totale del dominio
sociale, assume un atteggiamento paternalista nei confronti dei soggetti il cui assoggettamento deve
„illuminare“, perdendo di vista, d’altra parte, il terreno delle lotte che si agitano concretamente sul
piano della fattualità storica. Per superare questa impostazione, Rancière diede avvio negli anni
settanta ad una nuova linea di ricerca. Una delle prime tappe di questa nuova fase fu l’analisi degli
archivi dei discorsi della classe operaria (La parole ouvrière, 1976). Dall’analisi di questi discorsi
emergeva un dato fondamentale: le battaglie del proletariato, prese in considerazione in queste
ricerche, non concernevano soltanto le richieste di aumento del salario o una diversa organizzazione
del processo lavorativo, quanto e soprattuto la richiesta dei proletari di vedere «riconosciuta la
propria capacità di parlare a nome di se stessi». In queste lotte non era in questione tanto la richiesta
di riconoscimento di un’identità sociologicamente e culturalmente definita, quindi, bensì la richiesta
di vedere riconosciuta un’«eguale intelligenza». Il disaccordo su specifiche misure sociali ingiuste
implicava una più radicale lotta per il riconoscimento della capacità di prendere parte al dissenso. I
lavoratori volevano «essere riconosciuti in qualcosa di altro rispetto alla mera forza e al mero vigore
delle braccia operaie: volevano mostrare che i lavoratori possono anche asserire ciò che è giusto e
ragionevole, che essi devono avere il loro posto».[3] Detto diversamente: le loro lotte non erano
finalizzate a dare espressione ad un’oggettiva coscienza di classe ma, paradossalmente, a liberarsi
della propria esistenza proletaria, per rigettare l’ordine prestabilito e le posizioni che esso assegna.
Le battaglie operaie ruotavano attorno alla «questione della dignità proletaria».
Se si volge lo sguardo ai primi passi della ricerca di Honneth non si ha difficoltà a riconoscere come
anche il suo tentativo di ripensare criticamente il tema dell’«emancipazione», fuori dalle secche del
marxismo dogmatico, ha preso le mosse da intuizioni non lontane da quelle che erano state alla base
della rottura di Rancière con Althusser. Come Honneth ha dichiarato in molte ricostruzioni
retrospettive del suo primo itinerario teorico, ciò che lo spinse ad allontanarsi dall’impostazione
teorica della prima scuola di Francoforte, seguendo le orme già tracciate da Jürgen Habermas, fu
innanzitutto il proposito di congedarsi dal paternalismo cui metteva capo l’impostazione dei primi
francofortesi, Horckheimer e Adorno. Questo paternalismo scaturiva dalla tendenza della teoria
critica ad operare una generalizzazione del sospetto contro le forme e le strutture della società
borghese, che finiva per squalificare la coscienza dei soggetti, delle persone in carne ed ossa, nei
contesti della loro vita ordinaria, integrata nel sistema capitalistico. È per superare questo fossato tra
la teoria critica e la vita ordinaria, che anche Honneth avvertì l’esigenza di compiere un
supplemento di analisi delle motivazioni che stanno alla base del conflitto sociale. Più o meno nello
stesso periodo degli anni settanta in cui Rancière scandagliava gli archivi dei discorsi della classe
operaia, l’allievo di Habermas fu attirato dai risultati delle ricerche di storici come E. P. Thompson
e Barrington Moore, e dalle loro analisi delle rivendicazioni lavorative delle classi operaie,
nell’emergente società capitalistica. Queste ricerche ponevano in evidenza come il motivo
dell’opposizione alla disuguaglianza in termini di beni materiali aveva una base motivazionale più
profonda. Nel capitalismo emergente e gradualmente predominante, la protesta sociale delle classi
più basse aveva come finalità ultima quella del riconoscimento della dignità operaia: si trattava
della richiesta, da parte dei lavoratori, di un adeguato riconoscimento e di un’adeguata stima sociale
per il ruolo da loro assunto nella conservazione e nella riproduzione della società. Le fonti
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
motivazionali della resistenza e della protesta della classe operaia affondavano, più che
nell’insoddisfazione per la propria situazione materiale, nel sentimento di ingiustizia che scaturiva
dalla sensazione che le forme di vita e di realizzazione che ai loro occhi sembravano degne di
rispetto, non venivano riconosciute dal resto della società. Fu dall’appropriazione critica e dalla
generalizzazione teorica dei risultati di questi studi e di altri – oltre alle ricerche sulla resistenza
proletaria di Barrington Moore, i vari studi sul significato del danno al rispetto di sè fra le
popolazioni colonizzate, la letteratura sul ruolo sociale del disprezzo nelle esperienze femminili di
oppressione – che Honneth giunse infine a formulare una tesi fondamentale, destinata a fondare una
nuova teoria filosofica: il nucleo di tutte le esperienze di ingiustizia va cercato nel rifiuto del
riconoscimento sociale, ossia nei fenomeni di umiliazione e di disprezzo.[4]
Simili sono dunque le istanze da cui hanno preso le mosse gli itinerari teorici di Rancière e di
Honneth. Analoga è stata l’esigenza di lasciarsi alle spalle l’economicismo e il determinismo storico
del marxismo dogmatico. Accostabile è infine il modo in cui, su questo percorso, entrambi hanno
incontrato il tema del riconoscimento. E tuttavia, le strade che hanno seguito per dare sviluppo a
queste intuizioni iniziali hanno preso direzioni molto diverse. Ed è opportuno approfondire questa
divergenza, prima di entrare nel vivo del vero e proprio confronto consegnato alle pagine di
Recognition or desagreement?
Diverse interpretazioni delle lotte per il riconoscimento
Nel suo testo della maturità - Il disaccordo - Rancière ha conservato intatta l’idea centrale, già
elaborata nei suoi primi scritti: ossia che il movente originario del conflitto sociale è sempre il
desiderio di emancipazione, inteso come lotta per il riconoscimento della capacità di prendere
parte al dissenso. In questo testo, tuttavia, al posto della dicotomia operari/borghesi subentrano
quelle di povero/ricco e di intelligenza anonima/intelligenza degli esperti. Inoltre, la categoria di
oppressione borghese lascia il posto a quella di „polizia“. Il campo di problemi preso in esame del
filosofo è ormai ben più ampio: l’ambizione è quella di fornire strumenti critici in grado di risalire
alle logiche essenziali della politica e della democrazia. La tesi che dà avvio alla ricerca è che tutti
gli accordi politici si fondano in termini fondamentali su una forma di esclusione. Fin dalla polis
antica, e dalla teorizzazione filosofica della politica compiuta da Platone, l’organizzazione politica
prevede una fondamentale suddivisione per parti del popolo al suo interno, che nega l’uguaglianza
come principio politico. Si tratta, in altri termini, dell’ingiustizia fondamentale che deriva
dall’attribuzione di principio dell’uguaglianza e della libertà al demos perché possa accedere alla
polis e, al contempo, dalla determinazione di tale partecipazione come calcolo degli “aventi diritto”.
Rancière denomina polizia questa logica gerarchizzante che divide il popolo tra chi ha il diritto di
partecipare alla comunità politica, in quanto competente a prendere parte alla deliberazione sugli
affari comuni, e chi non ha parte, è escluso, in quanto incompetente. Ma se l’organizzazione politica
come forma di governo legittimo si fonda sempre sull’esclusione di qualche gruppo di persone dai
principi normativi su cui vige l’accordo, è necessario partire dal disaccordo per stare veramente
dalla parte della democrazia. Non si può partire dalla ricostruzione dei presupposti di una
situazione ideale dall’intesa comunicativa, come aveva fatto Habermas. Solo partendo dal
disaccordo è possibile giungere a una forma più esigente di universalismo, capace di corrispondere
alla lotta permanente volta ad allargare le forme restrittive in cui lo stesso universalismo è ogni
volta concretizzato e particolarizzato storicamente. Ecco quindi la tesi di Rancière: la vera
«politica» coincide con quei momenti in cui l’ordine gerarchizzante ed escludente della «polizia» è
messo in questione dagli interventi di coloro che non sono contati all’interno dei principi esistenti di
legittimazione. Non contati vuol dire che non esiste un linguaggio accettato o categorie per il loro
specifico modo di esistenza. Chi può farsi carico di queste rotture è la «parte dei senza parte», ossia
il popolo:
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Il popolo si identifica con il tutto della comunità in nome del torto arrecatogli dagli altri elementi
della comunità. I senza-parte – i poveri dell’antichità, il terzo Stato o il proletariato moderno – non
possono in effetti ottenere altro se non il niente o il tutto. Eppure è grazie all’esistenza di questa
frazione dei senza-parte, di questo niente che è tutto, che la comunità esiste come comunità politica,
ovvero come comunità divisa sulla base di un litigio fondamentale, un litigio che riguarda il calcolo
delle sue parti ancor prima di riguardare i loro diritti. Il popolo non è una classe tra le altre.[5]
La rottura democratica sgorga nel momento in cui gli esseri anonimi della «parte dei senza parte»
costituiscono se stessi come soggetti politici. La forza motivazionale che sta dietro questi momenti
di rivolta è la lotta per vedere riconosciuta l’eguaglianza. Ricondotta a questo suo nucleo generativo
originario, la democrazia non è altro che il «potere di tutti e di ciascuno»: un principio dinamico,
che diventa reale nei momenti in cui viene aperta la possibilità per chiunque – per i „non esperti“,
per gli „ignoranti“ - di partecipare alla discussione e di qualificare posizioni polemiche. Essa è
quindi un movimento privo di origine, di archè, ma quindi anche privo di fine ultimo, di telos.
La teoria del riconoscimento di Honneth, presentata per la prima volta nel testo che uscì nello stesso
anno de Il Disaccordo - Lotta per il riconoscimento (1995)[6] - non condivide la premessa iniziale
del ragionamento di Rancière: ossia che tutti gli accordi politici si fondano in termini fondamentali
su un universalismo escludente. Accettare questa premessa vorrebbe dire, come fa appunto il
filosofo francese, ridurre l’ordine sociale a polizia, ossia all’effetto di dispositivi di governo
gestionali, organizzativi, contabili, nonché gerarchizzanti e disciplinanti. Ma il punto è che se si
analizza a fondo l’ordine sociale si scopre che, in realtà, le pratiche e le istituzioni che lo
costituiscono non sono affatto solo l’effetto di dispositivi di suddivisione, di gerarchizzazione e di
disciplinamento. Esse rimandano piuttosto ad un sistema morale di aspettative normative: ad una
fragile struttura di progressive relazioni di riconoscimento. Se non fosse così, se cioè i differenti
ambiti di azione della società non traessero la loro legittimità anche dalla promessa normativa di
assicurare forme di riconoscimento reciproco, non si spiegherebbe perchè gli individui
continuerebero a prendervi parte, a riprodurle e a tenerle in vita con le loro stesse azioni. Non si
spiegherebbe perchè - detto con Durkheim - l’ordine sociale rimarrebbe in piedi. Non è un caso
allora, per Honneth, se ciò che storicamente innesca e provoca le lotte per la trasformazione sociale
sono proprio i deficit nella realizzazione dei principi di riconoscimento istituzionalizzati o le
asimmetrie strutturali interne ad un sistema di riconoscimento dato. I conflitti sociali scaturiscono di
regola dall’esperienza morale di quello che è considerato un disprezzo non fondato, ossia una
violazione delle aspettative legittime di riconoscimento. E anche nel caso di quei conflitti
rivoluzionari che puntano a far saltare un sistema di norme sociali nel suo complesso – come la
rivoluzione francese o la lotta contro la schiavitù – e in cui quindi emergono nuove richieste di
riconoscimento e nuovi orizzonti di aspettative morali, in questione è sempre l’obiettivo di
istituzionalizzare nuovi principi normativi di riconoscimento reciproco.
La divergenza tra Honneth e Rancière non finisce tuttavia qui. Ciò che allontana il primo dal
secondo è anche l’importanza che la sua teoria del riconoscimento assegna alla dimensione etica dei
conflitti sociali, alla loro «grammatica morale». Si potrebbe dire che se per Rancière la vera posta in
gioco dei conflitti sociali è sempre in primo luogo l’emancipazione politica, ossia la rottura dei
dispositivi di governo che suddividono in parti la società, aprendo la possibilità per chiunque di
partecipare alla discussione politica, per Honneth, invece, il vero criterio di misura con cui leggere e
giudicare i conflitti sociali è in ultima istanza l’emancipazione etica dei soggetti, ossia la conquista
delle condizioni di possibilità di una vita libera e pienamente realizzata. Anche la teoria del
riconoscimento di Honneth conferisce un ruolo di primo piano alla partecipazione non coercitiva e
democratica alla vita pubblica. E tuttavia, questa partecipazione è letta sempre in relazione al
contributo che essa dà ai processi di formazione dell’identità personale dei soggetti. «Solo il
soggetto che che ha imparato, attraverso le risposte riconosciute da parte del suo ambiente sociale,
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
ad apparire in pubblico senza vergogna, è capace di sviluppare il potenziale per la sua personalità
libera da coercizioni, e quindi di costruire un’identità personale».[7] Detto in modo più semplice: è
per conquistare un buon rapporto con se stessi, per essere veramente liberi, realizzati e felici, che i
soggetti si uniscono in un «noi collettivo» e – come lavoratori, come donne, come gay, come
cittadini - lottano nello spazio pubblico affinchè siano rispettate e riconosciute dimensioni negate
della loro identità e il significato che queste dimensioni hanno per tutta la società. In queste lotte per
il riconoscimento le identità che chiedono riconoscimento prendono forma, si articolano e si
trasformano anche dinamicamente, non sono affatto già date. E tuttavia, questo movimento ha
sempre, in ultima istanza, un telos: quello appunto di pervenire ad un riconoscimento sociale della
propria complessa identità, e per suo tramite ad una vita pienamente realizzata in tutti i suoi aspetti
e in tutte le sue sfaccettate dimensioni.[8]
Democrazia senza telos o democrazia eticamente orientata?
È possibile a questo punto entrare nel merito del vero e proprio confronto tra Honneth e Rancière.
Ed è possibile anche capire su quali punti battono le critiche incrociate che i due filosofi si
rivolgono nel corso della loro discussione riportata nel volume Recognition or Desagreement? Non
stupisce innanzitutto che, muovendo dalla sua idea di democrazia egualitaria, Rancière prenda di
mira il legame che Honneth istituisce nella sua teoria del riconoscimento tra emancipazione e
autorealizzazione etica. Il punto della critica è presto detto: se si assume che l’autorealizzazione dei
soggetti, ossia la loro «integrità etica», è il motore e il movente ultimo delle lotte per il
riconoscimento, ci si deve far carico inevitabilmente anche di una idea teleologica della libertà dei
soggetti, nonchè di una idea teleologica della relazione tra i soggetti e del movimento che permette
ai soggetti e a questo tipo di relazione di tendere verso un pieno compimento. Ma proprio questi
schemi teleologici sono in contraddizione con il carattere di processo aperto, strutturalmente
eccedente la totalità, che è proprio della democrazia, in quanto movimento privo di archè e di telos.
Ma le lotte della «parte dei senza parte» non sono volte a vedere riconosciuta un’identità nè a
vedere realizzata un’integrità etica. Al contrario, dal momento che i gruppi e gli individui sono già
da sempre riconosciuti in identità determinate e gerarchicamente ordinate, i processi di
soggettivazione democratica sono processi di dis-identificazione. Se le persone sono identificate in
accordo a certe categorie normative e normalizzanti, è solo nei momenti di ribellione e di negazione
di queste identità che essi riescono a diventare soggetti. Si dis-identificano, ossia si rendono
indipendenti dalle categorie di identificazione che vigono all’interno dell’ordine politico dato e, così
facendo, articolano un nuovo tipo di soggettività. L’obiettivo di queste prassi democratico-radicali è
quello di riconfigurare politicamente il mondo comune, operando un continuo contrasto alla
chiusura dell’ordine dato e alla privatizzazione dell’intelligenza comune. Ma ciò vuol dire, di
nuovo, che dal punto di vista di una teoria radicalmente egualitaria e democratica non ci può essere
alcuna teleologia, nè alcuna idea di progresso morale inteso come motore della storia.
«L’eguaglianza non è un sogno del futuro, essa è piuttosto il potere che è già al lavoro nelle nostre
relazioni».
Cosa risponde Honneth a queste obiezioni? Muovendo dalla sua impostazione, il teorico del
riconoscimento ha buon gioco nel rilevare, nelle idee di democrazia egualitaria di Rancière, un
eccesso di astrattezza, di indeterminatezza e di a-storicità. L’idea di democrazia radicale di
Rancière, osserva Honneth, finisce per circoscrivere e confinare la vera politica soltanto a quei
momenti eccezionali che mettono in questione l’ordine politico nella sua totalità, sospendendolo e
interrompendolo. Cosa dire allora di tutte quelle lotte democratiche che sono volte a riappropriare e
a reinterpretare principi normativi già istituzionalizzati? Sono lotte, queste, che proprio perché si
riferiscono a principi normativi condivisi, possono utilizzare il linguaggio della prima persona
plurale e possono puntare a convincere la controparte della giustificabilità di una nuova
appropriazione o di una nuova interpretazione di un principio normativo già riconosciuto
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
istituzionalmente. Del resto, se la politica fosse solo interruzione e sospensione dell’ordine
normativo esistente, essa non potrebbe dare un resoconto positivo di ciò che viene contestato. Dal
momento che coloro che sono esclusi non possono far uso di un linguaggio comune, orientato alla
comprensione reciproca, questi non possono nemmeno usare il pronome «noi» per articolare i loro
interessi o desideri. Dovendo interrompere la logica della mutua comprensione, la «parte dei senza
parte» può ricorrere soltanto alla prospettiva della terza persona per nominare l’ingiustizia di essere
esclusa. Al più, può utilizzare il linguaggio in termini estetici, tentando di includere nella propria
azione un momento di apertura estetica del mondo, capace di incrinare l’ordine esistente del
sensibile. Tutto ciò ha però una conseguenza ancora più grave: la democrazia dei «senza parte» di
Rancière finisce per tagliare i ponti con il campo del sociale. Proprio per scavare un fossato radicale
tra «polizia» e «politica», Rancière non ha più strumenti concettuali per distinguire chiaramente chi
sono i soggetti determinati che lottano per la giustizia e quali sono i contenuti concreti e
giustificabili delle loro rivendicazioni. Honneth giunge così a rovesciare l’impostazione di
Rancière. In realtà, egli afferma, il processo democratico non può essere completamente privo di
telos. Per essere veramente tale, esso deve essere qualificato e soggiacere ad una certa «costrizione
normativa». Come si legge anche in Il diritto della libertà – dove Honneth si confronta con le teorie
della democrazia che si ispirano a Claude Lefort e a Hannah Arendt - il processo democratico «è
all’altezza della propria pretesa di libertà solo se, nello stesso tempo, incoraggia e rafforza le
aspirazioni alla libertà che si manifestano anche nelle altre due sfere d’azione», ossia le relazioni
personali e il mercato.[9] Questo punto spiega anche perché, per Honneth, il referente di una teoria
critica volta a rintracciare «le opportunità per il presente della realizzazione della libertà sociale»
non possono essere movimenti sociali determinati o intermittenti pratiche di democrazia radicale dal
basso, con tutte le loro difficoltà, che si ripresentano ogni volta - basti pensare a questo proposito
alla parabola di Occupy - a prendere forma durevole e istituzionale. Per Honneth, la libertà sociale
avanza facendo leva su soggettività più astratte: «conquiste istituzionali», «modifiche legislative»,
consolidati «cambi di opinione» nella sfera pubblica, trasformati «in norme giuridiche vincolanti».
In un giro successivo di discussione, Rancière e Honneth rispondono ciascuno alle obiezioni
dell’altro, ma di fatto non fanno che ribadire il cuore dell’irriducibile divergenza dei loro sguardi
filosofici sul mondo sociale e politico: l’uno tipicamente francese, si potrebbe dire, addestrato ad
una critica del sospetto nei confronti di tutto ciò che è «normativo», e volto a riportare alla luce
l’intreccio irrisolvibile tra apparati istituzionali, dispositivi di potere e processi di normalizzazione,
di disciplinamento e di soggettivazione; l’altro tipicamente tedesco, si potrebbe dire, animato dalla
volontà di difendere e rilanciare il «progetto incompiuto della modernità» (Habermas) e le sue
promesse normative di libertà ed emancipazione. Infine, nei due testi che chiudono il volume,
vengono enunciate compiutamente le due diverse opzioni teoriche.
Rancière ribadisce che un pensiero critico deve insistere oggi in primo luogo sui temi
dell’eguaglianza e della democrazia, o meglio di una democrazia egualitaria. Questo vuol dire
accostarsi ai movimenti sociali valutando la loro capacità di produrre conflitto politico, ossia una
messa in questione dei dispositivi di governo „normativi“ e normalizzanti che irregimentano e
spoliticizzano lo spazio pubblico. Si tratta quindi di porsi al fianco di tutte le pratiche di democrazia
radicale che, dal basso, mirano a incrinare, attraverso la presa di parola discorsiva e conflittuale
degli esclusi, dei poveri e degli „ignoranti“ del nostro tempo – detto con la formula con cui lo stesso
Rancière in più occasioni si è dichiarato sintonico, «la democrazia del 99 per cento» - le logiche
escludenti delle istituzioni esistenti, e la loro tendenza a suddividere e a gerarchizzare in esperti e
incompetenti, in tecnici e profani, in élite e in sudditi passivi il popolo.
Honneth ribadisce che una teoria critica della società deve ripartire oggi da un ideale a suo dire
superiore rispetto a quello dell’eguaglianza, perchè capace di ricomprenderlo in un orizzonte
normativo più ampio: l’ideale della libertà, dell’autodeterminazione individuale. Di questo ideale
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
moderno si tratta di riportare alla luce, contro tutte le sue interpretazioni individualistiche e
«negative», la sua radice intersoggettiva e sociale e la diversità delle sue diverse sfere di esercizio.
Proprio ripartendo da un’idea di libertà come libertà sociale – ossia, come libertà dell’«Io» che si
apprende e si accresce nelle pratiche sociali e nelle norme di un «Noi», oggettivate all’interno delle
diverse istituzioni sociali - la teoria critica deve accostarsi ai movimenti sociali valutando la loro
capacità di rivitalizzare quei circuiti di agire comunicativo e di reciproco riconoscimento, di
solidarietà e di cooperazione sociale, che soli permettono di far comprendere come le istituzioni
sociali sono qualcosa di cui portiamo in comune la responsabilità, in quanto membri di una
comunità che cooperano tra loro. Circuiti, questi, che sebbene atrofizzati nelle nostre società
neoliberali, si erano pur sempre fatti strada, attraverso prassi sociali e conquiste istituzionali,
nell’«era socialdemocratica» (Ralf Dahrendorf).
Disaccordo o riconoscimento reciproco, dunque; rivolte democratiche della „parte dei senza parte“
– che Rancière non esita a presentare come il punto di partenza dal quale è possibile ripensare oggi
anche l’ipotesi comunista - o lotta gradudale per riancorare le diverse e tra loro irriducibili sfere
sociali – e in particolare il mercato - in prassi e istituzioni democratico-sociali, e con ciò per
riprendere in mano il programma, e il sogno, di una trasformazione socialista della società.
Più che continuare a seguire passo passo questa discussione, può essere più interessante, giunti a
questo punto, porre qualche ulteriore domanda. Nel leggere questo dialogo sorge spontaneo
chiedersi infatti se l’alternativa tra «riconoscimento» e «disaccordo» è poi davvero un aut-aut
ineludibile: se è possibile aspirare a un quadro teorico che riesca a tenere unite le istanze fatte valere
da entrambi – per esempio l’eguaglianza e la libertà, ma anche la discontinuità „rivoluzionaria“ e la
continuità „riformista“, oppure l’innovazione democratica dal basso e la riproduzione creativa delle
istituzioni sociali. Ma soprattutto: c’é qualcosa che, in definitiva, rimane non tematizzato da
entrambi gli interlocutori di questo confronto?
E la giustizia economica?
Marx, Polanyi e l’idea di una società socialista
Per rispondere a queste domande, può essere utile fare un passo indietro e tornare a un altro
dibattito filosofico: quello tra lo stesso Honneth e Nancy Fraser. Se si riprende in mano questa
discussione del 2003 - Redistribuzione o riconoscimento? [10] - non si farà fatica ad accorgersi che,
per strano che possa sembrare, alcune critiche che Fraser muoveva al filosofo tedesco presentano
notevoli analogie con quelle formulate dallo stesso Rancière. Nel corso della discussione, infatti,
Fraser opponeva al monismo della teoria del riconoscimento di Honneth – ossia al suo fondarsi su
un unico principio normativo, quello appunto del «reciproco riconoscimento» – un paradigma
teorico incentrato su due assi normativi, analiticamente distinti e tra loro irriducibili: quello della
«redistribuzione» e quello del «riconoscimento». Questi due assi della teoria della giustizia,
spiegava Fraser, possono trovare un unico fondamento morale nel principio della parità
partecipativa, inteso come radicalizzazione democratica dell’idea liberale dell’eguale autonomia di
ciascun individuo. Una teoria della giustizia che si fonda sul principio della «parità partecipativa»,
argomentava Fraser, non ha bisogno di una concezione etica delle forme di partecipazione
necessarie allo sviluppo umano, come quella di Honneth. Essa assume che i partecipanti la
sceglieranno da sè secondo la loro moralità.
«Lungi dal voler prevedere le loro scelte, la giustizia come parità partecipativa punta ad assicurare
loro la possibilità di decidere liberamente e indipendentemente dalle relazioni di controllo. Così,
cerca di rimuovere gli ostacoli all’uguaglianza presenti nelle maggiori aree sociali - dalla politica al
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
mercato del lavoro, dalla famiglia alla società civile. In questo modo, essa cerca di dare agli attori
sociali la possibilità di partecipare alla pari in qualsiasi area decidano di accedere».[11]
Questo principio ammette dunque tanto la ragionevolezza del disaccordo etico quanto l’eguale
valore morale dell’essere umano. In questo senso esso è compatibile con tutte le concezioni della
vita buona che rispettano l’eguale autonomia. Nello stesso tempo esprime una concezione specifica
di ciò che questo rispetto richiede – e in questo senso sa offrire un quadro teorico capace di
risolvere casi di conflitto in cui, per esempio, le rivendicazioni per il riconoscimento delle
minoranze culturali contrastano con le rivendicazioni per l’eguaglianza di genere. A veder bene,
dunque, non si è molto distanti dalle posizioni di Rancière e dalla sue critiche al perfezionismo etico
della teoria del riconoscimento di Honneth, e alle conseguenze teleologiche e armonicistiche – nel
senso di negazione del conflitto e del pluralismo etico – che questo perfezionismo rischia di
produrre sul piano politico. Conseguenze, queste, contro cui Rancière, come si è appena visto,
richiama il principio della democrazia egualitaria come potere di chiunque, e l’idea di
emancipazione come lotta per prendere parte alla discussione e per qualificare il dissenso.
E tuttavia, a differenza di Rancière, Fraser batteva anche su un altro punto nella sua critica a
Honneth. La teorica statunitense accompagnava la sua difesa del principio della «parità
partecipativa», quale fondamento di una rinnovata teoria della giustizia, con il richiamo alla
necessità impellente di rimettere al centro l’analisi delle logiche sistemiche del capitalismo. La
critica a Honneth precipitava infatti su una tesi fondamentale: la teoria del riconoscimento tende a
trascurare un’analisi dell’ordine sociale capitalistico nella sua dimensione sistemico-relazionale,
ossia – come la teorica ha chiarito anche nei suoi scritti successivi - non solo in quanto sistema
economico, ma in quanto «insieme strutturato di relazioni sociali». L’ordine sociale capitalistico
costituisce un insieme strutturato di relazioni sociali, in quanto esso trae la sua forza da una parte
dalle logiche interne al sistema economico: la proprietà privata dei mezzi di produzione, un „libero“
mercato che costringe ciascuno a lavorare per il proprio sostentamento in condizione di strutturale
asimmetria di potere decisionale, la tendenza del capitale a espandersi senza fine. Dall’altra parte, il
sistema economico capitalistico trae la sua forza anche dalle relazioni di „sfruttamento“ che esso
intrattiene con la sfera «esterna» della riproduzione sociale (per esempio con il lavoro non retribuito
di cura delle donne), con la sfera «esterna» della natura (attraverso il saccheggio delle risorse
naturali) e con la sfera «esterna» della politica (attraverso la trasformazione della politica in ancilla
economiae). Si tratta ogni volta di relazioni sociali tra il sistema economico ed ambiti ad esso
esterni che producono crisi sociali, le quali, quindi, non scaturiscono soltanto dalle contraddizioni
dei paradigmi interni dell’economia – come voleva Marx - ma anche dalle contraddizioni tra
l’economia e la società, tra l’economia e la famiglia, tra l’economia e la natura – come ha mostrato
Polanyi, a cui Fraser ha dedicato diversi studi negli ultimi anni. Laddove, il compito di una teoria
critica dovrebbe essere quello di ripensare la società, la politica, la relazione tra i sessi, la relazione
con la natura in una dimensione nuova che non sostenga l’espansione del capitale.[12]
Sul piano di teoria sociale, il cuore della critica di Fraser a Honneth era dunque un punto invece
vistosamente assente nelle critiche di Rancière: il richiamo al fatto che la caratteristica distintiva
della società capitalistica è la creazione di un sistema di mercato quasi-oggettivo, anonimo e
impersonale, che segue una propria logica – quella dell’accumulazione del profitto – che tende a
inglobare e a sussumere le logiche degli altri ambiti sociali. Si tratta di un sistema che è
culturalmente integrato ma che non è governato direttamente da schemi di valutazione: ossia che sta
in piedi non solo in forza di principi normativi istituzionalizzati, come quelli del «reciproco
riconoscimento» (o della «libertà sociale»), che „promettono“ a chi vi prende parte la
sperimentazione e l’accrescimento di una forma specifica di libertà. Questo sistema di relazioni sta
in piedi anche per logiche e dinamiche che ormai si sono autonomizzate e sembrano sfuggire al
controllo di chiunque. Se si perde di vista questa dimensione sistemica del capitalismo non si può
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
capire perché la società capitalistica comprende due ordini di subordinazione analiticamente distinti,
anche se tra loro intrecciati: la stratificazione di classe, radicata principalmente nei meccanismi del
sistema economico, e la gerarchia di status, basata sui modelli istituzionalizzati di valore culturale.
Questi due ordini di subordinazione si intrecciano in mille forme nella società globale. Tuttavia, ciò
non toglie che il principio del riconoscimento reciproco – e anche quello della libertà sociale - non
può bastare da solo a coprire tutte le istanze di giustizia.
In conclusione, si sarebbe tentati di dire che un quadro teorico come quello proposto da Fraser
sembra maggiormente in grado di tenere unite le istanze fatte valere da Rancière e da Honneth,
sottraendosi d’altra parte ai loro deficit, per come emergono nel corso del loro confronto.
Soprattutto, una prospettiva come quella di Fraser sembrerebbe capace di riportare alla luce quale è,
in definitva, l’elemento mancante in entrambe le teorie. Proprio l’esigenza che entrambi hanno
avvertito, fin dall’inizio dei loro itinerari teorici, di rimettere al centro della teoria critica l’analisi
delle motivazioni delle lotte sociali, per superare il fossato tra teoria e prassi, ha finito per
subordinare o far perdere di vista l’importanza dell’analisi di quei meccanismi anonimi e sistemici
di produzione dell’ingiustizia, che passano sopra la tesi degli attori sociali.
E tuttavia, anche il quadro teorico di Fraser continua a lasciare in sospeso alcune domande: chi sono
oggi gli attori e i soggetti della lotta contro il capitalismo, in quanto sistema di relazioni sociali? È
verosimile pensare che la chiarificazione concettuale e l’intensificazione reale dei meccanismi di
produzione di ingiustizia creati da questo sistema - come la scandalosa crescita di diseguaglianze
economiche, la compressione di diritti e di garanzie sociali, l’acuirsi di crisi sociali e ambientali di
carattere epocale - sia sufficiente a riaccendere le lotte per la redistribuzione economica e per
l’eguaglianza deliberativa in tutte le sfere della società, anche nel mercato? Non continua a trovare
conferma, oggi più che mai, il fatto che i conflitti per la giustizia economica e per la redistribuzione,
nonostante l’acuirsi delle diseguaglianze, non riescono a conquistare il centro della scena politica,
mentre i conflitti per il riconoscimento e per le identità, pur nel loro irrisolvibile intreccio con quelli
di classe, hanno sempre maggiore presa sociale? E non è forse questa una prova indiretta della tesi
di Honneth che, anche in passato, le lotte per l’eguaglianza e per la redistribuzione s’inscrivevano
sempre in un orizzonte motivazionale ed etico più profondo, ossia nell’aspirazone a una forme di
vita diversa, non individualistica ma comunitaria?
È alla luce di queste domande che sembra acquisire maggiore chiarezza anche l’ultimo approdo di
ricerca di Honneth, consegnato al volume L’idea del socialismo. Come è stato osservato, in questo
testo Honneth sembra aver compiuto una vera e propria svolta.[13] Da una critica immanente delle
forme dell’eticità moderna (Hegel) è passato ad una critica normativa della società (Kant):
dall’analisi storico-ricostruttiva delle realizzazioni sociali della libertà sociale nelle diverse sfere
d’azione della modernità, volta a isolare punti di appoggio per future realizzazioni, è passato a
delineare un progetto normativo, a tratti „utopico“ e idealizzante, di società socialista, che si appella
in definitiva alle risorse morali dei singoli e dei gruppi sociali. Ci si può interrogare sui limiti di
questa proposta teorica – come la difficoltà, nell’idea di società socialista di Honneth, a riconoscere
il carattere inaggirabile del pluralismo etico e del conflitto politico. E tuttavia, è forse anche una
consapevolezza profonda ad aver spinto il filosofo tedesco a scrivere questo suo testo sul
socialismo: ossia che oggi abbiamo bisogno anche di questo, di ricominciare a immaginare l’utopia
di una società diversa, e a sperare che questo possa far convergere in un progetto comune lotte
diverse, e a far accendere la molla dell’impegno etico e politico, dei singoli e dei gruppi, per
praticare forme di vita solidali e cooperative e, a partire da qui, per lottare per una società più giusta
e più umana.
[1]
[1] A. Honneth, Il Diritto della Libertà. Lineamenti per un’eticità democratica, trad. it. di C.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Sandrelli, Codice Edizioni, Torino 2015; Id., L’idea di socialismo. Un sogno necessario (2015),
trad. it. di M. Solinas, Feltrinelli, Milano, 2016.
[2]
[2] J. Rancière, A. Honneth, Recongnition or Disagreement. A Critical Encounter on the Politics of
Freedom, Equality, and Identity, ed. By K. Genel and J.-P. Deranty, Columbia University Press,
New York 2016.
[3]
[3] A. Faure e J. Rancière, La parole ouvrière, Paris, La Fabrique Éditions, 2007, p. 9. Cfr. anche J.
Rancière, Heretical Knowledge and the Emancipation of the Poor, in Staging The People. The
Proletarian and His Double, Verso, London 2011, pp. 34-57.
[4]
[4] Su questa prima fase dell’itinerario di ricerca di Honneth cfr. A. Honneth, Riconoscimento e
conflitto di classe. Scritti 1979 – 1989, a cura di E. Piromalli, Mimesis, Milano-Udine 2011.
[5]
[5] J. Rancière, Il disaccordo, trad. it. di B. Magni, Meltemi, Roma 2007, pp. 30-31.
[6]
[6] A. Honneth, Lotta per il riconoscimento, trad. it. C. Sandrelli, Il Saggiatore, Milano 2002.
[7]
[7] N. Fraser, A. Honneth, cit., p. 213.
[8]
[8] In Il diritto della libertà, Honneth ha ribattezzato questa autorealizzazione che noi acquisiamo
solo nella relazione con gli altri, «libertà sociale», distinguendola da due altre forme - deficitarie - di
libertà: la libertà «negativa» e la libertà «riflessiva». Per potere essere attinta, egli ha spiegato, la
libertà sociale necessita di istituzioni, capaci di formare modelli di coordinamento delle azioni, che
armonizzino gli scopi degli uni con quelli degli altri, facendo riconoscere nella realizzazione degli
scopi dell’altro il completamento necessario alla realizzazione dei propri scopi. Una «ricostruzione
normativa» può mostrare come nello sviluppo storico delle singole sfere differenziate della società
moderna - nelle relazioni personali, nell’agire economico, nella formazione democratica della
volontà - si sia già prodotta una realizzazione sociale parziale delle concezioni istituzionalizzate
della libertà sociale. Ciò è avvenuto per esempio nei processi di democratizzazione delle relazioni
familiari e di coppia, nei riconoscimenti sociali e giuridici del ruolo e della dignità dei lavoratori
all’interno del mercato del lavoro capitalistico, nelle forme di partecipazione delle democrazia di
massa della seconda meta del Novecento. Tutti movimenti, questi, che oggi registrano una battuta
d’arresto o una vera e propria regressione e che tuttavia continuano ad indicare la direzione verso
cui devono muoversi le lotte sociali, per vedere riconosciuta realmente quella libertà sociale, che
costituisce anche il principio guida del socialismo.
[9]
[9] «La partecipazione dei membri della società alla formazione della volontà pubblica è tanto più
paritaria, spontanea e consapevole quanto più è avanzata la realizzazione della libertà sociale nelle
relazioni personali e nei rapporti economici. Perciò coloro che nel ruolo di cittadine e di cittadini si
confrontano e cercano di accordarsi sul bene della loro comunità non sono indifferenti rispetto ai
rapporti sociali in queste sfere; essi soggiacciono anzi al peculiare obbligo, generato dalle norme
autoriferite del processo democratico, a prender posizione su tutto ciò che, entro tali sfere, nei vari
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
momenti storici, contrasta la concreta attuazione del principio istituzionalizzato della libertà». A.
Honneth, Il diritto della libertà, cit., p. 477.
[10]
[10] N. Fraser, A. Honneth, Redistribuzione o riconoscimento?, trad. it. E. Morelli e M. Bocchiola,
Meltemi, Roma 2003, p. 233.
[11]
[11] N. Fraser, Redistribuzione o riconoscimento?, cit., p. 276.
[12]
[12] Cfr. N. Fraser, Che cosa significa essere marxisti oggi?, in conversazione con G. Origgi,
„Micromega“, 1/2016, p. 171.
[13]
[13] Cfr. L. Cortella, La via normativa al socialismo, http://ilrasoiodioccam-micromega.blogaut...
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Religioni e democrazia: per una laicità flessibile
di GIANCARLO GALEAZZI
Un filosofo credente critica l’impostazione di “MicroMega” sulla laicità perché “rigida” e, come
la “laicità alla francese”, inadeguata ai tempi.
1. Premessa
Muoviamo da una constatazione: la laicità –che è un prodotto storico, più precisamente una
acquisizione moderna- ha molteplici significati politico e religioso, culturale e sociale. Accenniamo
pertanto ai diversi significati di laicità, per occuparci poi della laicità in riferimento a democrazia e
religioni, e mostrare infine come oggi la laicità vada ripensata alla luce delle res novae della
postmodernità e della postsecolarizzazione. Della laicità si può parlare sia in senso ristretto con
riguardo alla politica e alla religione (e al loro rapporto), sia in senso allargato, con riguardo alla
dimensione umanistica ed epistemologica (in diversi ambiti).
Dal punto di vista politico, la laicità riguarda la fondazione dello stato moderno (come stato non
confessionale) e riguarda il rapporto tra religione e politica, che può configurarsi come distinzione
(“date a Dio quel che è di Dio, date a Cesare quel che è di Cesare”) o come opposizione (se si
ritiene la politica come dimensione pubblica e la religione come dimensione privata). Più
precisamente, riguardo al rapporto tra Stato e Chiesa, la laicità si può configurare in un duplice
modo: come separazione (“libera Chiesa in libero Stato”) e come collaborazione (con “Concordati”
e “Intese” tra Stato e Chiese). In pratica le diverse impostazioni hanno trovato espressione in
diversi modelli, tra cui quello francese (stato laico), quello italiano (stato concordatario) e quello
americano (stato pluralista).
Dal punto di vista religioso, la laicità riguarda la cosiddetta libertà religiosa ma intesa come
“possibilità di credere e di non credere”, per cui tale libertà si configura in una quadruplice
modalità: come libertà di religione (di scelta religiosa degli individui), della religione (di esercizio
cultuale delle Chiese), nella religione (di opinione nella comunità ecclesiale) e dalla religione (da
parte di atei, agnostici e indifferenti). Può essere interessante notare che a questa quadruplice libertà
individuata in campo religioso si potrebbe far corrispondere altrettante forme di libertà civile:
rispettivamente di libertà di pensiero, di azione, di espressione e di critica, evidenziando così la
possibilità di un collegamento democratico tra religione e politica.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Oltre a questi significati, che attengono al politico e al religioso (in ottica statuale o istituzionale o
coscienziale) e sono i significati più noti e utilizzati, esistono altre accezioni del termine, che lo
dilatano alla considerazione della persona: a livello di struttura, di saperi e di comportamenti: meno
noti, non sono certo meno importanti; anzi riteniamo che lo stesso significato politico e religioso,
dovrebbe essere letto alla luce della dimensione antropologica e assiologica.
Dal punto di vista della persona, la laicità si configura come difesa della dignità umana (dei suoi
diritti e delle sue libertà) di fronte al potere delle istituzioni (come lo Stato e la Chiesa). Si può
allora sottolineare che le libertà, che si accompagnano alla laicità, hanno una radice comune: la
dignità dell’uomo, riconosciuta come “diritto ad avere diritti”; una dignità riconosciuta dallo Stato
(liberale, socialista o democratico che sia) e dalle religioni (in particolare da quelle monoteistiche,
le quali concepiscono la persona hominis come immagine e somiglianza della persona Dei).
Dal punto di vista degli ambiti, la laicità si configura come rivendicazione di autonomia mondana,
cioè delle realtà terrene (alle quali è riconosciuto valore di fini propri), delle forme del sapere,
dell’agire e del fare (in una logica di pluralismo epistemologico); in questi casi, due possono essere
gli orientamenti principali: per alcuni si tratta di “distinguere per unire”, per altri invece di “scindere
per dividere” .
Dunque, siamo in presenza di una evidente complessità semantica della laicità (una questione di
merito); ad essa va aggiunta una complessità stilistica della laicità (una questione di metodo), per
dire che ci sono diversi modi di affrontare, trattare e porgere il problema della laicità: c’è una
modalità polemica e una modalità dialogica, una modalità irascibile e una modalità mite, una
modalità arrogante e una modalità conciliante, ecc. Certamente influisce sugli atteggiamenti la
personalità di chi li sostiene, ma non solo: influisce anche l’idea che si ha della laicità, e a volte non
c’è soluzione di continuità tra l’idea (quale laicità) e l’espressione (laicità perché). Ciò che
andrebbe tenuto sempre presente è che la laicità per principio vuole essere alternativa
all’assolutismo, al dogmatismo, al fanatismo, all’integralismo, al fondamentalismo, e pertanto deve
fare attenzione a non far suoi questi atteggiamenti contestati alla religione.
1. 2. Forme di laicità
Laicità come categoria storica
In ogni sua accezione, la laicità è categoria storica: a partire dal suo significato politico e religioso
è legata al contesto moderno e occidentale: non c’era laicità nelle antiche forme di “cesaropapismo”
e di “teocrazia”, e non c’è laicità nelle moderne forme di “dittatura” e di “autarchia”: in tutte queste
forme, la politica e la religione finiscono per usarsi reciprocamente e contaminarsi indebitamente.
Quindi la laicità compare nel momento in cui si distingue politica e religione: l’indicazione
evangelica sintetizza bene tale distinzione: “date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che
è di Dio”. Certo, si potrebbe chiedere che cosa sia di Cesare e che cosa sia di Dio, ma in ogni caso il
principio è posto, chiedendo di non confondere politica e religione, sia nel senso di non fare della
politica una religione, sia nel senso di non fare della religione una politica: entrambe le
impostazioni alterano tanto la politica quanto la religione.
Più precisamente, la laicità, nella sua genesi, appare legata a principi (illuministi e cristiani) come
quelli di libertà, eguaglianza e fratellanza e come quello di tolleranza, rispetto e riconoscimento; e,
così. si configura come antitesi rispettivamente al totalitarismo politico e al fondamentalismo
religioso. Quindi la distinzione tra politica e religione si caratterizza come laicità, in quanto avviene
nel reciproco rispetto dell’una e dell’altra, cioè nella convinzione che ciascuna deve procedere juxta
propria principia, senza indebite identificazioni o strumentalizzazioni.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Due tipi di laicità
La conquista della differenza tra politica e religione pone nuovi problemi: quelli relativi alla
distinzione teorica (una separazione o a una opposizione?) ovvero quelli riguardanti la loro
relazione pratica (intese e concordati ledono la laicità o la rendono concretamente possibile?). La
risposte a questi interrogativi configurano molteplici tipi di laicità che vanno dalla “laicità rigida”
(o estrema o radicale o escludente), che rifiuta ogni riconoscimento pubblico della religione
(collocata nel privato, e, anche così, più o meno tollerata) alla “laicità flessibile” (o moderata o
includente o mite, per usare un termine che viene oggi applicato anche al diritto, all’economia,
ecc.), che riconosce pubblicamente la religione (per cui si concludono con le Chiese specifici patti
regolativi). Si tratta di due forme di laicità che, per esempio, hanno trovato espressione
rispettivamente nel “modello francese” e nel “modello italiano”. Più precisamente, (come ha
ricordato Giuseppe Dalla Torre) in Francia l’idea di laicità ha conosciuto diverse versioni: la laicità
di lotta alla religione, la laicità di separazione rispetto alle religioni, la laicità come neutralità non
conflittuale con la religione, la laicità laicizzata, cioè deideologizzata, la laicità comprensiva del
fatto religioso, la laicità positiva o rinnovata.
Tuttavia, semplificando, si potrebbe parlare di modello francese per indicare una “incompatibilità”
fra laicità e religione, e di un modello italiano per indicare invece una “compatibilità” a certe
condizioni. In altri termini, nel primo caso si ritiene che la laicità sia strutturalmente altro dalla
religione, mentre nel secondo caso si ritiene necessario chiarire tanto l’idea di laicità, quanto l’idea
di religione: se questa è sacralista, clericale, fondamentalista o integralista, inevitabilmente (e
conseguentemente) rifiuta la laicità e dalla laicità è logicamente rifiutata; se invece la laicità è
irreligiosa, antireligiosa, antichiesastica o anticlericale non può venire a patti con la religione, la
quale logicamente la rifiuta. Le cose cambiano, se la religione e laicità s’incontrano sul terreno della
“secolarità”, cioè del riconoscimento dell’autonomia delle realtà temporali; tale “autonomia” è altra
cosa rispetto alla mera “strumentalità” che il sacralismo attribuisce loro, ed è altra cosa rispetto alla
assoluta “indipendenza” che il secolarismo attribuisce loro.
L’autonomia, cui si fa riferimento, è una impostazione non semplicemente ipotetica (teorica), ma
reale (storica), che ha trovato espressione in due testi fondamentali: uno civile, cioè la Costituzione
della Repubblica italiana (in vigore dal 1948, ma elaborata tra il ’46 e il ’47) e l’altro ecclesiale,
cioè la Costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio ecumenico Vaticano II (pubblicata nel
1965, ma elaborata negli anni Sessanta). Vediamo più da vicino questi due riferimenti.
Laicità è Costituzione Italiana
Dal punto di vista civile, la secolarizzazione, come aspetto della modernità, è stata pur
faticosamente realizzata e almeno nella prima modernità in termini di “secolarità”: il testo
costituzionale italiano ne è una efficace espressione. Infatti, il criterio ispiratore della Costituzione
italiana è stato considerato (con sentenza della Corte Costituzionale) proprio il “principio laicità”,
pur se la parola “laicità” non è mai usata nel testo costituzionale, ed è una laicità che con la
religione entra in dialogo non solo in termini pattizi, ma anche e soprattutto culturali, tant’è che i
diritti di libertà ed eguaglianza e i doveri di solidarietà e giustizia sono recepiti nella loro radice sia
evangelica sia illuministica: la elaborazione dei primi “principi fondamentali” (e specificamente i
primi tre articoli) sono sotto questo profilo esemplari, in quanto nascono dall’incontro di culture
diverse (liberale, socialista repubblicana, marxista e cattolica).
Bisogna peraltro aggiungere che la secolarizzazione si accentua nella seconda modernità in termini
di “secolarismo”, per cui si pongono nuovi problemi sul rapporto laicità e religione, e due sono le
scuole di pensiero: per la prima il secolarismo è un approdo inevitabile della secolarizzazione, per
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
cui lo scontro con la religione è prima o poi inevitabile; per la seconda invece, la secolarizzazione è
al bivio tra secolarità e secolarismo, e quella secolaristica è una deriva, che può essere evitata, e ciò
comporta salvaguardare non solo il rapporto laicità e religione, ma il senso stesso della
democrazia. Tutto ciò si riflette anche a livello di legislazione italiana e di dibattitto intorno alla
Carta costituzionale, per cui il rapporto tra religioni e democrazia è di tutta attualità, e al cuore di
tale rapporto si pone il diritto alla laicità.
Laicità e Chiesa Cattolica
Dal punto di vista ecclesiale, a partire dal Concilio Vaticano II la secolarizzazione viene
legittimata nella sua versione secolare (non secolaristica): così nella Gaudium et spes il Vaticano II
si è interrogato sul rapporto chiesa-mondo, superando sia la posizione dell’alternativa o del
contrasto (chiesa o mondo), sia la posizione del parallelismo o del collegamento (chiesa e mondo),
per giungere alla posizione della presenza o collaborazione (chiesa nel mondo).
Si tratta di una acquisizione importante che era stata per alcuni aspetti anticipata da alcuni pensatori
del personalismo cristiano (da Jacques Maritain ad Emmanuel Mounier a Romano Guardini) e che,
per altri aspetti, sarà sviluppata dalla Dottrina sociale della Chiesa. Questa, avviata con l’enciclica
Rerum Novarum (1891), viene di decennio in decennio celebrata (tra l’altro con la Quadragesimo
anno di Pio XI e il Radiomessaggio di Pio XII nel 1942); dopo mezzo secolo, questo filone si è
sviluppato sempre più chiaramente in senso democratico: così il Radiomessaggio di Pio XII per il
60°, l’enciclica Mater et magistra di Giovanni XXIII per il 70°, la lettera di Paolo VI Octogesima
adveniens, l’enciclica Laborem exercens per il 90° e, infine, l’enciclica Centesimus annus di
Giovanni Paolo II: documenti che costituiscono altrettante tappe nella presa di coscienza ecclesiale
della laicità e del ruolo che i fedeli laici hanno nel suo esercizio (oggetto pure di una specifica
esortazione apostolica del 1988, quella di Giovanni Paolo II sui Christifideles Laici).
Questo riconoscimento della legittima secolarizzazione politica ed economica si fa ancora più
evidente con il magistero sociale di Giovanni XXIII (e precisamente con l’enciclica Pacem in
terris), di Paolo VI (con quella grande enciclica, Populorum progressio, che -come la Rerum
novarum- sarà celebrata, per sottolineare l’avvio di un nuovo filone del Magistero sociale), di
Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI (rispettivamente con le encicliche Sollicitudo rei socialis e
Caritas in veritate: a 20 anni e a 40 anni dalla Populorum progressio): si tratta di un secondo filone
della Dottrina sociale della Chiesa che dilata la sensibilità sociale e richiama ulteriormente la
portata della laicità: se ne trova una precisa sintesi nel Compendio della Dottrina sociale della
Chiesa (2004).
L’una e l’altra sono accentuate in modo rinnovato dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, che
può considerarsi come l’avvio di un terzo filone, incentrato sulla “cura della casa comune”. In
particolare, è da rilevare che la questione ecologica viene da Bergoglio caratterizzata come
“ecologia integrale”, in alternativa all’antropocentrismo moderno e all’ecocentrismo postmoderno:
in diverso modo queste due impostazioni sono espressione di secolarismo: egocentrico (storicismo
immanentista) o biocentrico (ecologia profonda), mentre l’impostazione di Papa Francesco si
configura come umanesimo ecologico o ecologia umanistica, nel senso cioè che l’antropologia non
s’impone alla ecologia né si dissolve nell’ecologia, ma nella ecologia trova espressione un nuovo
umanesimo solidale, che riconosce la dignità universale (di tutti gli esseri) e quella specifica (della
persona umana), e riconosce l’unità universale (della famiglia cosmica) e quella specifica (del
genere umano), proponendo quindi una visione caratterizzata da “nessi” che, senza cancellare la
specificità degli ambiti, li mette in relazione in nome della unità della persona.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Forse, più che di “filoni” (che potrebbero essere considerati sostitutivi) si potrebbe più
appropriatamente parlare di “cerchi”, per evidenziare la dilatazione progressiva, che ingloba le
precedenti acquisizioni. Così inteso, il percorso della Dottrina sociale della Chiesa mostra come
quello della laicità sia principio sempre più presente e conciliabile con il Magistero sociale, che
peraltro tiene ferma la distinzione tra “laicità” (come “secolarità”) e “laicismo” (come
“secolarismo”).
1. 3. Laicità e secolarizzazione
Laicità e monoteismi
C’è stato, dunque, un incontro della religione con la laicità, e riguarda specificamente la Chiesa
cattolica, ma è significativo per mostrare che il rapporto tra ecclesialità e laicità può contribuire a
valorizzare il dialogo. Non a caso, proprio al tema del dialogo sono stati dedicati alcuni documenti
fondamentali del Vaticano II come Unitatis redintegratio (sul dialogo interconfessionale con le
chiese cristiane) e Nostra Aetate (sul dialogo interreligioso con i monoteismi e le religioni
mondiali), ma qui interessa soprattutto il dialogo in chiave sociale, che lo collega alla laicità; in
proposito si può ricordare l’enciclica programmatica di Paolo VI intitolata Ecclesiam suam, e la
costituzione conciliare Gaudium et spes sul dialogo socio-culturale con il mondo contemporaneo. A
partire da questi testi è stato un susseguirsi di contributi pontifici e vaticani in tema di dialogo, che
hanno portato a valorizzare la laicità, a partire dal dialogo, che è una delle espressioni fondanti della
laicità.
Un’altra espressione essenziale alla laicità è la libertà, e anche da questo punto di vista si può citare
un documento conciliare, oltre a testi pontifici. In particolare, del Vaticano II è la Dichiarazione
Dignitatis humanae, che pone proprio il problema della libertà religiosa come madre di tutte le
libertà. E nel successivo Magistero si andrà sempre più precisando il carattere “propositivo” e non
“impositivo” della fede, e sarà accentuata la differenza tra “proselitismo” e “testimonianza” con un
crescendo di testi che fanno perno sulla libertà religiosa e che, conseguentemente, evidenziano il
nesso tra libertà e laicità.
Da quanto detto, dovrebbe risultare che laicità e religione non sono da considerare in opposizione o
in alternativa, almeno laddove la religione abbia fatto suo il “guadagno storico” della laicità, pur
prendendo le distanze dalla “conquista impazzita” del laicismo. Si tratta di una distinzione che,
ovviamente, non è condivisa da certo pensiero laico, ma, seppure la valutazione possa essere
discussa, è da riconoscere che la Chiesa cattolica ha avviato e sviluppato un nuovo atteggiamento
nei confronti della laicità, un tema al centro di tanti dibattiti conciliari e postconciliari, che hanno
portato a operare una serie di precisazioni lessicali, per cui la Chiesa parla ad intra di “laicalità”
ecclesiale da parte del “laicato” cattolico, e ad extra di “laicità” mondana da parte dei fedeli “laici”
impegnati nel mondo nei processi di secolarizzazione. Non solo: aperture alla laicità sono da
segnalare oltre che nel mondo cattolico, anche in quello protestante, che anzi è particolarmente
sensibile al tema della laicità. In ogni caso, sono pure da segnalare nel mondo protestante e in
quello cattolico forme di fondamentalismo.
Per quanto riguarda gli altri due monoteismi, risulta che l’ebraismo per certi aspetti e soprattutto
l’islam per certi altri debbano ancora fare i conti con la laicità. La cosa riguarda specialmente
l’islam, tanto che si è giunti a parlare di “scontro di civiltà”: dopo quello ideologico, saremmo in
presenza di quello culturale e religioso, causato dal cosiddetto “fondamentalismo islamico”. Senza
entrare nel merito della ipotesi suggerita da un politologo statunitense, ciò che risulta evidente è il
nuovo ruolo che le religioni svolgono nello scenario della globalizzazione.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Laicità e modernità
Al riguardo vorrei dire che, a ben vedere, ogni comunità (religiosa o civile che sia) si trova sempre
di fronte ad un bivio, quello tra l’opzione violenta (colonialismo o proselitismo) e l’opzione
nonviolenta (confronto o testimonianza). Quando si vuole imporre una cultura o una fede, quando si
vuole esportare una democrazia o una rivelazione, la politica e la religione fanno una scelta di tipo
“ideologico” che le configura in modo diverso rispetto a quando optano invece per una scelta di tipo
“dialogico”. Quindi, quella ideologica non è una tentazione esclusiva della religione, bensì di ogni
società: politica o religiosa che sia: in fondo alla base della impostazione che le ideologizza c’è la
convinzione che sia un loro dovere “convincere” o “convertire” l’altro.
E’ stata la modernità (e non è stato facile) a pervenire a una concezione che fa perno su libertà,
eguaglianza e fratellanza, e che, a tal fine, muove dalla tolleranza, per aprirsi al rispetto e giungere
al riconoscimento. Quanto di questo percorso civile (che possiamo rubricare sotto la voce
“illuminismo moderno” in senso lato) sia debitore della radice religiosa (in questo caso cristiana)
permette di evidenziare che non la religione per se stessa, ma una sua alterazione è negatrice della
laicità, per cui non si dovrebbe rifiutare la religione tout court, ma solo un suo specifico aspetto (più
o e meno inquinato e inquinante).
Si tratta di precisazioni importanti, per cui può servire ricordare le concezioni relative al rapporto
tra religione e violenza. Una posizione è quella che definirei dell’illuminismo ideologico, secondo
cui la religione è istrumentum belli, in quanto è caratterizzata da assolutismo, intolleranza e
fanatismo, e quindi sono inevitabili (sotto diversa forma) le guerre di religione come guerre tra le
religioni. Un’altra posizione è quella che definirei del realismo politico, secondo cui la religione è
istrumenti regni, in quanto è caratterizzata da valori e convinzioni che possono essere utilizzati per
governare, e quindi è inevitabile (prima o poi) una strumentalizzazione della religione, che perciò
può essere coinvolta (direttamente o direttamente) nella violenza del potere. Un’altra posizione
ancora è quella che chiamerei del “purismo teologico”, secondo cui la religione è, per sua natura,
nemica della violenza, perché il suo è un messaggio di fratellanza: questa impostazione non trova
riscontro nella storia. Alla luce di questa si pone un’altra posizione che chiamerei del “bipolarismo
teologico”, per dire che in ogni religione ci sono due dimensioni alternative: quella dialogica è
caratterizzata da apertura, e quella ideologica è invece caratterizzata da chiusura; quindi, a seconda
degli atteggiamenti che le religioni assumono, e che sono sempre frutto di una loro scelta, consegue
una dimensione violenta, inquisitoria o censoria che la laicità non può accettare, ovvero una
dimensione aperta, disponibile e rispettosa, con cui la laicità può intendersi.
Dunque, solo a livello di religione che opta per la libertà, solo con la religione connotata in termini
di ascolto e di dialogo, di libertà e di pluralismo, i sostenitori della laicità possono trovare una
adeguata sponda. Ne consegue ancora una volta che laicità e religione non sono di per sé
incompatibili; lo sono se la religione si configura in termini ideologici o ideologizzati, strumentali o
strumentalizzati; quando ciò non avviene, la religione risponde alla sua più vera vocazione e può
incontrarsi con la laicità, per cui si potrebbe addirittura affermare che la laicità è banco di prova
della stessa religiosità. Occorre ribadire che quello della ideologizzazione è un rischio non solo per
la religione, ma anche per la laicità: il fanatismo di questa non è peggiore del fanatismo di quella.
Pertanto il problema non è scegliere tra due fondamentalismi (il male minore?), ma evitare ogni
fondamentalismo. In tale ottica, alla laicità può essere attribuito il compito non di rigettare la
religione, bensì di contribuire alla purificazione della religione, denunciando il fondamentalismo
religioso. La religione, per converso, può assolvere il compito di purificare la laicità, affinché non
finisca per essere intolleranza nei confronti di ogni religione e magari dar luogo a un
fondamentalismo antireligioso.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Laicità e religione
Allora, l’incontro di religione e laicità porta tanto la laicità quanto la religione non a ignorarsi o,
peggio, a combattersi, bensì a misurarsi tra loro per aiutarsi a incrementare la loro sensibilità per la
libertà e la loro attitudine al dialogo, dal momento che entrambe devono evitare rispettivamente il
secolarismo e il religionismo. In tal modo laicità e religione contribuirebbero e collaborerebbero
alla “umanizzazione”, che è la grande sfida oggi, in presenza della crescente “disumanizzazione”
etica e “deumanizzazione” tecnica (l’ipotizzato “postumano” -almeno nella versione del
“transumano”- appare sempre più per quello che è , cioè “antiumano”).
Ci può essere, quindi, un impegno comune, per religioni e laicità, se non si attardano su vecchie
polemiche: pro o contro la laicità ovvero pro o contro la religione. Contrasti che, pure, hanno avuto
la loro ragione d’essere, quando la religione si attestava su posizioni premoderne e antimoderne, per
cui rifiutava la laicità, e la laicità rifiutava la religione, configurata come alienazione o illusione.
Contrasti che non hanno più ragione d’essere, quando ecclesialità e laicità si ritrovano a condividere
(come nel caso della Chiesa Cattolica) valori quali il pluralismo e il confronto, la libertà e il
dialogo, la tolleranza e la democrazia.
Occorre aggiungere che contrasti, invece, permangono in presenza di religioni che non abbiano
attraversato l’illuminismo moderno. Questo d’altronde non si può imporre, come del resto ogni
esperienza culturale, tanto più che la storia non si ripete; pertanto è di un nuovo illuminismo che si
avrebbe bisogno: come è stato salutare l’illuminismo nella secolarizzazione, così potrebbe esserlo
altrettanto un nuovo illuminismo nella postsecolarizzazione. Fermo restando il richiamo alla libertà
e al dialogo, bisogna però che esso sia rispondente al nuovo contesto, che è caratterizzato dalla
globalizzazione e dalla postsecolarizzazione. Di conseguenza, l’illuminismo va ripensato, e quindi
la stessa laicità.
E’ evidente, allora, che il bivio non è tra laicità e religione, bensì tra ideologia laica o religiosa e
umanità laica o religiosa, tra chi considera la religione come ideologia” e chi la considera come
“fratellanza”, tra una religione che sceglie di essere “ideologica” e una religione che sceglie di
essere “dialogica” o (per usare il linguaggio di Jean Luc Nancy) tra una religione “terrestre” o
“chiusa” e una religione “celeste” o “aperta”. Pertanto, in attesa che i tempi maturino per un dialogo
tra religione e laicità, si potrebbe operare su un duplice fronte: quello della democrazia e quello
dell’educazione (e non occorre ricordare che a più riprese e da più parti è stato messo in evidenza il
nesso tra le due).
Dal punto di vista sociale, va ribadita la distinzione (che non è scissione) tra piano religioso (fedeltà
al proprio credo) e piano politico (fedeltà alle istituzioni politiche a cominciare dalla carta
costituzionale): è principio fondante della laicità che le regole della democrazia devono valere per
tutti a prescindere dalle convinzioni religiose di ciascuno (così, per esempio, la distinzione tra
“reato” e “peccato”, tra legge dello Stato e legge della Rivelazione). Insomma, la distinzione tra
credenti e cittadini permette di perimetrare la legge religiosa nell’ambito della comunità che
l’accetta per fede, e di far valere la legge costituzionale nell’ambito della convivenza civile che,
sotto questo profilo, prescinde dalle appartenenze confessionali; tra l’altro, una tale distinzione
permette di valutare meglio il senso delle due legislazioni.
Dal punto di vista culturale, si rende necessario puntare sulla conoscenza: nulla quanto la
conoscenza ha valore laico, se avviene nel rispetto reciproco e nella ricerca comune. Sotto questo
profilo, un ruolo importante può svolgere la scuola (almeno quella statale), quando accompagni
l’opera di istruzione formale con l’opera di educazione valoriale (valori illuministici ma anche
evangelici), entrambe tanto più necessarie oggi che la scuola è all’insegna sia della multiculturalità
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
fattuale, sia della interculturalità progettuale, per cui si rende necessario impegnarsi teoreticamente
e praticamente a realizzare nelle classi una relazionalità che riconosca la diversità non meno che la
pariteticità, in modo che le differenze non si trasformino in diseguaglianze, e il pluralismo nelle sue
diverse espressioni (etniche ed etiche, cultuali e culturali) sia visto come una ricchezza, che
certamente pone qualche problema, la cui soluzione però è un guadagno per tutti.
Ebbene, la società contemporanea ha sviluppato in presenza della crescente multiculturalità tutta
una serie di opzioni: dal multiculturalismo alla interculturalità, alla transculturalità, anche se nello
stesso tempo si sono manifestate forme di intolleranza, di xenofobia o di razzismo. E’ evidente che
l’odierna società plurale sta conducendo al suo interno la sua battaglia per scegliere tra apertura e
chiusura, tra inclusione ed esclusione, tra solidarietà e narcisismo. Dal canto suo, la Chiesa
cattolica va rinnovando i suoi atteggiamenti teorici e pratici in presenza del pluralismo religioso e
della conflittualità religiosa. Al riguardo va segnalato che. a partire dal cosiddetto “spirito di Assisi”
(1986), la Chiesa ha inaugurato un nuovo stile relazionale interreligioso, tanto che un documento
del 1996 chiarisce che l’evangelizzazione non si esplica solo nell’annuncio, ma in “dialogo e
annuncio”, e che il documento della Commissione internazionale del 2016, nel riconoscere gli errori
della Chiesa nella sua opera evangelizzatrice, afferma che “le guerre di religione e la guerra alla
religione sono insensate”.
Dunque, l’idea di liquidare la religione che in passato è sembrata a qualcuno una espressione di
laicità, in realtà, non solo cozza contro la storia, ma contraddice il senso stesso della laicità, e la sua
rivendicazione di libertà. E’ vero che la secolarizzazione ha inciso sulla religione in Europa e nel
mondo occidentale, non è vero che abbia determinato il superamento della religione: è vero che per
alcuni aspetti l’ha inquinata, come è vero che per altri aspetti l’ha depurata. Infatti, la Chiesa
cattolica ha potuto negli ultimi settant’anni configurarsi (lo riconosceva Norberto Bobbio) come la
maggiore istituzione a difesa dei diritti dell’uomo, impegnata tra l’altro anche a denunciare le
idolatrie del profitto, del potere, del prestigio e del piacere: su questi fondamenti la modernità ha
costruito un edificio, che oggi appare più traballante della stessa religione. La Chiesa cattolica,
peraltro, non si limita a denunciare una situazione di crisi, ma s’impegna pure e soprattutto ad
annunciare un nuovo umanesimo per una società capace, senza strabismi, di coniugare insieme
religiosità e laicità; esse vanno riconosciute come valori umani, che stanno a cuore tanto della
democrazia quanto della religione, nella consapevolezza che possono diventare disvalori quando si
cede ai sacralismi e ai secolarismi.
1. 4. Laicità e postsecolarizzazione
Laicità e globalizzazione
Da quanto detto, dovrebbe risultare che la laicità è tipica della modernità, ma, alla luce della
consapevolezza che la modernità non s’identifica con la secolarizzazione (questa ne costituisce solo
un aspetto), si pone il problema di (o se) ripensare la laicità in riferimento alla postsecolarizzazione.
Questa può mettere in discussione la laicità, almeno quella della secolarizzazione, che considerava
la religione in termini residuali, per cui, la laicità si poneva come critica della religione (intesa quale
alienazione o illusione o risentimento).
La globalizzazione ha dilatato il problema: nello scenario mondiale, per un verso, un ruolo pubblico
importante svolge certamente la Chiesa Cattolica, che ha attraversato il processo di
secolarizzazione, operando nei suoi confronti una valutazione che ne ha distinto i “guadagni storici”
e le “verità impazzite2; e, per altro verso, un ruolo differente ma non meno significativo è svolto
dalla religione musulmana, che il processo di secolarizzazione non ha vissuto e non sembra
intenzionata a viverlo, almeno in riferimento agli esiti che ha prodotto sul cristianesimo europeo e
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
sull’occidente cristiano. In questa situazione, la tentazione di applicare all’islam quanto ha
sperimentato il cristianesimo può sembrare operazione valida; invece, non è così: e perché la storia
non si ripete, e perché soprattutto non si può dimenticare che la laicità è una categoria storica, una
categoria tipicamente moderna e occidentale: è il prodotto culturale di un processo, e ha dato
risultati positivi; tuttavia non ha valore assoluto, ma pur sempre relativo, per cui la sua validità deve
essere nuovamente provata, ed è evidente che la sua vitalità dipende dalla capacità di calarsi nel
nuovo contesto storico.
Ne consegue che nella postmodernità sarebbe un errore considerare la religione come nella
modernità, cioè qualcosa di “residuale”, in via di estinzione: oggi non si può sottovalutare la
religione, e con la sua presenza pubblica occorre fare i conti. Da qui l’ipotesi di una nuova laicità,
che non rinuncia a rivendicare libertà e dialogo, pluralismo e confronto, tolleranza e solidarietà, ma
lo fa alla luce della nuova situazione, in particolare della nuova situazione determinata dalla
presenza dell’islam e dal terrorismo che all’islam dice di ispirarsi.
Tutto ciò rende la situazione difficile, tanto più che molto diversificate ne sono le interpretazioni, le
quali, al di là delle singole valutazioni, finiscono in un modo o in un altro per mettere sotto
processo la laicità. Ebbene, è importante capire le ragioni di chi l’assolve e quelle di chi, invece la
condanna. Le ha richiamate Marco Ventura in un articolo su Le laicità parallele di Francia e
Turchia (in “La Lettura”, n. 244, 31 luglio 2016, p. 9): secondo alcuni, la laicità va difesa dal
fondamentalismo nell’interesse della stessa religione; la laicità va difesa dal crescente pregiudizio
antislamico; la laicità va difesa dalla pretesa musulmana di essere uno stato nello stato; secondo
altri, invece, la laicità è responsabile dell’odio e della violenza; la laicità è, insieme, con la libertà
religiosa la proiezione sul mondo musulmano dell’universalismo coloniale occidentale; la laicità è
un estremismo che tenta di sradicare tutte le religioni.
Ecco perché, di fronte a questa situazione, c’è bisogno di ripensare la laicità: per vedere come
possa ancora essere valida in un contesto come quello della postsecolarizzazione. A tal fine, appare
evidente tra l’altro la necessità di una nuova mentalità, portatrice di una duplice consapevolezza,
secondo cui le religioni che si fanno guerra e la laicità che fa guerra alle religioni hanno fatto il loro
tempo; e quindi è tempo che la laicità si presenti come patrimonio comune di credenti e non
credenti, perché non è la confessionalità a costituire lo spartiacque tra laici e non laici.
Infatti, quello che conta è come si vive la propria religiosità e la propria laicità: esse sono o possono
essere compatibili se fondate sulla dignità umana e se sono finalizzate alla promozione umana;
diversamente, religione e laicità celano sotto differenti etichette lo stesso prodotto, ossia l’ideologia,
vale a dire la strumentalizzazione dell’uomo. Ciò avviene quando il dialogo è ridotto a stratagemma
o strategia, il pluralismo è considerato come contingenza da superare, la tolleranza è declassata a
sopportazione o indifferenza, il rispetto è limitato alla enunciazione astratta, la solidarietà è
esercitata in senso assistenzialistico o paternalistico. Ecco, quando gli aspetti, che hanno
accompagnano la genesi e lo sviluppo della laicità, perdono la loro originaria dimensione di
riconoscimento, di reciprocità, di responsabilità, la laicità finisce per essere una bandiera vecchia
che non garrisce più ai venti nuovi, e al suo posto si colloca l’ideologia. Questa per altre ragioni può
contaminare anche la religione, quando l’identità diventa un feticcio, quando la testimonianza si
trasforma in proselitismo, quando la salvezza si presenta come un monopolio, quando la fede si
traduce nel fanatismo. Ebbene, in ogni caso, l’ideologia si combatte favorendo una rinnovata idea di
laicità e di religione che non abbiano la pretesa di “convincere” o di “convertire”, ma solo
l’esigenza di “condividere” o di “confrontare”.
Una tale impostazione può animare sia l’impegno dei credenti sia l’impegno dei non credenti, nel
senso che laicità come antideologia preserva la religione dal fanatismo e dal fondamentalismo, e
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
preserva la politica dal totalitarismo e dall’autarchia. Dunque, politica e religione insieme nella
accettazione della laicità e nel rifiuto della ideologia. In breve, l’ideologia tende a trasformare
politica e religione in impostazioni divisive, per cui in politica si tende a parteggiare invece di
partecipare, e in religione si tende ad assolutizzare il proprio credo invece di metterlo in relazione
con il credo altrui. Ciò nuoce sotto tutti i punti di vista: nuoce alla concezione laica di radice
moderna, nuoce alla concezione religiosa (come quella cristiana) che ha attraversato e, almeno in
parte, assimilato la modernità e quindi la laicità, e soprattutto nuoce alla concezione religiosa che
identifica la modernità con la secolarizzazione e vede nella laicità (anche per certe esperienze
moderne) qualcosa di antitetico alla religione. Ma così non è, se la laicità non fa di tutto per apparire
come nemica del “sacro” (anzi del “santo”), e se la religione non fa di tutto per configurarsi come
“clericale” o “ierocratica”. Si può e si deve invece ipotizzare che laicità e religione siano chiamate a
incontrarsi per la loro comune tendenza alla umanizzazione dell’uomo, e possano perseguire tale
obiettivo se si pongono a difesa della libertà: così la religione “propone e non impone la fede”
(Concilio Vaticano II), e così la laicità è “la possibilità di scegliere tra avere una fede e non averne”
(Agnes Heller), e su queste basi fanno del dialogo non solo un metodo intellettuale ma uno stile
esistenziale.
Tornare all’Illuminismo?
Al riguardo è interessante una recente riflessione della filosofa Heller sul terrorismo (Aristotele
contro l’Isis, in “La Lettura”, n. 247, 21 agosto 2016, pp. 6-7). Dopo quello degli anni Settanta
(Settembre nero) e dopo quello di inizio secolo (Al Qaeda), la terza ondata di terrorismo è quella del
“fondamentalismo islamico (Isis). Secondo la pensatrice ungherese, “i fondamentalisti non
rinunciano alla modernità; essi non rinunciano al capitalismo o alla tecnologia moderna, anzi l’Isis
ne fa uno strumento di potere. Rinunciano alla libertà e ai valori dell’Illuminismo. Il
fondamentalismo è un fenomeno moderno, offre fondamenti in un mondo dove non ce ne sono”.
Dal momento che, secondo la Heller, “non v’è dubbio che una solida base per il terrorismo è una
visione nichilista del mondo e dell’umanità”, questa filosofa ritiene che “come risposta alla sfida del
terrore globale possiamo ancora una volta tornare all’Illuminismo”.
Ed è la posizione anche di Paolo Flores d’Arcais nel suo saggio sul fondamentalismo islamico La
guerra del sacro. Terrorismo, laicità e democrazia radicale (ed. Cortina, Milano 2016). Si tratta precisa Flores- di una guerra dichiarata non ai governi occidentali, bensì ai valori rivoluzionari
dell’eguaglianza, della laicità e delle libertà civili, perciò questo il filosofo paventa il pericolo che
siano istituite scuole islamiche accanto a quelle cattoliche in nome della libertà religiosa. Per
combattere tale guerra Flores D’Arcais indica sinteticamente tre condizioni: una efficace
integrazione, che richiede ingenti investimenti; una rigorosa laicità; e nessuna concessione di
diversità a chi propone diseguaglianza dei diritti. E anche per Flores il riferimento necessario è
all’Illuminismo, più precisamente a una sinistra egualitaria e illuminista (che peraltro riconosce che
non c’è: non c’è più o non c’è ancora).
A parte ciò, occorrerà (a me sembra) un illuminismo capace di misurarsi con una situazione che è
nuova -cioè il mix di globalizzazione, terrorismo e islam- e con una consapevolezza che è nuova cioè che la cultura occidentale moderna è all’insegna della separazione degli ambiti del sapere e
dell’agire, mentre la cultura orientale (islamica, cinese o indiana) appare caratterizzata da una
impostazione in cui è difficile separare filosofia, religione e politica, e volerlo fare significherebbe
imporre indebitamente un paradigma epistemologico. Non solo: c’è pure da chiedersi se tale
paradigma sia di per sé valido o se non vada rivisto nel nuovo contesto.
Complessità della religione
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Al riguardo è utile la riflessione operata da Charles Taylor nell’intervento su Democrazia, diversità,
religione del 2015 (Occidente e islam: l’incontro è possibile, in “Vita e Pensiero”, n. 3, maggiogiugno 2016, pp. 13-21, in particolare pp. 16-17). In questo saggio il filosofo canadese destabilizza
la teoria delle sfere, secondo cui la “società è come formata da diverse sfere: la sfera politica, la
sfera religiosa, la sfera dell’arte, la sfera dell’economia… A causa di questa nozione delle sfere
differenti, pensiamo che ogni cosa ricada in una di queste categorie. E, naturalmente, l’idea della
separazione tra politica e religione è basata sul concetto che si tratta di sfere chiaramente diverse.
Ebbene, il problema è che gran parte della vita umana non può essere interamente colta da queste
suddivisioni. (…) Questo tipo di pensiero a blocchi unici è molto comune, perché abbiamo una
certa idea ipersemplificata della sfera religiosa, della sfera politica, della sfera culturale, e così
come abbiamo, nella nostra società, un’idea ipersemplificata della religione”.
Questa complessità -precisa Taylor- è di tutta evidenza sia riguardo all’islam, sia riguardo al
fondamentalismo. “Se consideriamo l’islam, dobbiamo riconoscere che presenta un’incredibile
varietà nello spazio e nel tempo” (ma -aggiungiamo- la varietà è di casa a ben vedere anche nel
mondo cristiano e specificamente -come notava il card. Carlo M. Martini, nello stesso mondo
cattolico). Non solo: secondo Taylor e “ritroviamo la stessa varietà tra gli esempi offerti dal mondo
di oggi di quello che definiamo all’ingrosso come fondamentalismo, e che sono invece reazioni a
diversi tipi di modernità”, e forme che restringono la complessità del fenomeno (ancora una volta
questo vale per il fondamentalismo islamico come per quello cristiano). Avverte Taylor: “tutte
queste considerazioni riguardo alla complessità della religione, e alla distinzione tra la religione e
altre cose, vogliono dire che dobbiamo fare delle scelte nel nostro modo di categorizzare. Se si
categorizza in un certo modo… se si fa di ogni erba un fascio, si opera una stigmatizzazione”.
Ebbene, “ciò che sta dietro alla stigmatizzazione, ciò che la fa funzionare è la visione
ipersemplificata di quello che è una religione e nel nostro caso di quello che è l’islam”. Taylor
conclude sostenendo che “dobbiamo combattere con forza questa tendenza nelle nostre società, per
andare in un’altra direzione”. Quindi “dobbiamo rapidamente ristrutturare le nostre categorie e
ricomporle in una nuova combinazione che ci permetta di vedere le distinzioni importanti e di
sapere come agire alla loro luce, in modo ben diverso”.
Complessità della laicità
Dunque, l’impostazione moderna, che ha portato con sé tutta una serie di acquisizioni positive, ha
portato anche a una antropologia scissa, nel senso che tra gli ambiti (le sfere) c’è separazione, per
cui si rende oggi evidente che la laicità finisce per configurare una antropologia sommatoria,
risultato di tanti ambiti che sono tra loro divisi. Il che applicato a politica e religione induce a
ritenere che la distinzione, indubbiamente positiva sotto certi aspetti, non lo sia sotto certi altri,
perché l’unità del soggetto umano ha finito coll’essere compromessa: la divisione epistemologica ha
avuto la meglio sulla unità antropologica. e l’umanesimo, che ne è scaturito, ha risentito di tale
primato.
Occorre, quindi, fuoriuscire da una tale logica e aprirsi a visioni più articolate. Certe distinzioni, che
pur sono state utili, non possono essere ripetute acriticamente, perché perpetuano una
schematizzazione che è facile quanto fuorviante. E non serve inventarsi nuove distinzioni, come
quella, per esempio, tra “islamici” e “islamisti”, tanto più che non risultano analoghe distinzioni tra
“cristiani” e “cristianisti”, tra “giudei” e “giudaisti”; e, d’altra parte, c’è da chiedersi chi sia
legittimato a operare tali valutazioni, a stabilire chi sono gli uni e chi sono gli altri. Anche per
questo, mi sembra che sia da evitare la identificazione della laicità con un modello, quello
illuministico, che certamente è stato essenziale nel contesto della secolarizzazione, ma che chiede di
essere rivisto nel contesto della postsecolarizzazione. Forse, piuttosto che tornare all’Illuminismo, è
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
più opportuno ripartire dall’Illuminismo; anche qui, però, senza semplificare, bensì articolando
l’istanza illuministica in riferimento alle res novae.
Forse oggi va emergendo il bisogno di realizzare non una aprioristica divisione, una separazione,
una opposizione tra religione e laicità, bensì una rilettura del loro rapporto, in modo da permettere
un inedito dialogo interculturale e interreligioso: ciò reclama una laicità che non sia sclerotizzata su
antichi modelli, e una religiosità che non sia attestata su intransigentismi di vecchio e nuovo conio.
Sotto questo profilo ritengo che la laicità debba rifiutare la compromissione notturna e sotterranea,
ma non debba temere il compromesso diurno, trasparente. Al riguardo, la elaborazione della
Costituzione italiana può offrire un modello di laicità dal punto di vista democratico non meno che
da quello religioso. In questa ottica si potrebbe auspicare che credenti e non credenti si ritrovino -in
nome della laicità- a favorire lo sviluppo della democrazia e le sue ragioni, ragioni che in certi casi
possono trovare in una religione motivazione e incentivazione, e in un’altra religione invece rifiuto
o ostacolo. Ecco perché il dibattito è in corso, e ad esso è opportuno che ciascuno dia il suo
contributo nella consapevolezza che la laicità non ha un significato univoco, bensì multivoco: se ne
può parlare in più modi e non equivoci, diceva Aristotele dell’essere, e mi pare che lo si possa
ripetere per la laicità.
C’è allora da chiedersi: la laicità -in tempo di modernità e in tempo di postmodernità, in tempo di
secolarizzazione e in tempo di postsecolarizzazione- è sempre la stessa? Ovvero i valori di cui è
portatrice (cioè libertà e dialogo) sono da declinare diversamente in presenza dei cambiamenti
storici? Pensiamo che un prodotto storico, qual è la laicità, non possa prescindere dalle res novae, e
non è cambiamento di poco conto di fronte alla compresenza delle culture. Tenendo conto di ciò,
l’interrogativo se essere favorevole o contrario alla presenza pubblica delle religioni è forse mal
posto, in quanto la religione è sempre anche culturale, per cui una società multiculturale che non
prendesse in considerazione la religione si priverebbe di un elemento essenziale del pluralismo. Non
solo: in quanto sempre culturale, è preferibile che l’apporto delle religioni sia esplicitato sul piano
sociale, affinché le scelte siano consapevoli.
1. Conclusione
Per concludere e sintetizzare, potremmo condensare la questione della laicità in due constatazioni
storiche e in due interrogativi attuali.
Prima considerazione. La laicità è un “multiproblema”, nel senso che la laicità è un principio
politico, in quanto fondante lo stato moderno, e di conseguenza regolativo dei rapporti tra politica e
religione, cioè, nel concreto, tra Stato e Chiesa; inoltre la laicità è un principio antropologico, in
quanto è costitutivo della persona: della sua dignità (nei confronti del potere) e della sua libertà (di
credere e di non credere); infine, la laicità è un principio epistemologico, in quanto rivendica
l’autonomia delle realtà terrene, e delle forme teoretiche e pratiche. Da tutto ciò deriva che la laicità
è una concezione e una metodologia: un modo d’essere, pensare, agire e fare.
Seconda considerazione. La laicità è un “prodotto storico”, che si afferma nell’età moderna
(dall’Umanesimo al Rinascimento all’Illuminismo) come rivendicazione della specificità dell’uomo
(de hominis dignitate), dello studio della natura (de rerum natura juxta propria principia), della
libertà di pensare (libertas cogitandi), della identità statuale (la Rèpublique) e si accompagna a tutta
una serie di altri valori: dalla libertà alla eguaglianza, alla fratellanza, dalla tolleranza al rispetto,
alla solidarietà che sono i valori della modernità: a radice cristiana ma in ottica secolare.
Primo interrogativo. In quanto prodotto culturale, legato alla modernità e alla secolarizzazione (che
trovano particolare espressione nell’Illuminismo), la laicità come si configura oggi in presenza della
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
postmodernità e della postsecolarizzazione? L’impatto con culture e religioni compresenti obbliga a
“ripensare la laicità”? Pur confermando il valore del principio, come calarlo nella realtà della
globalizzazione?
Secondo interrogativo. In passato la distinzione tra i sostenitori della laicità e i suoi critici ha
coinciso con la distinzione tra “laici e credenti”: tale identificazione vale ancora oggi? O a fare la
differenza è il modo di intendere la religione e la politica?, il loro rapporto? e quindi la laicità?
Queste ambiti (come altri) sono da tenere separati o la teoria delle sfere va rivista, per rispettare la
complessità degli ambiti non meno che quella dell’antropologia?
Alla luce di queste considerazione e di questi interrogativi, vorrei terminare dicendo che il titolo
dell’incontro potrebbe essere letto nel senso che la laicità è un diritto, in quanto senza di essa
religione e democrazia rischiano una deriva. Infatti in ogni religione e in ogni democrazia ci sono
due anime: una dialogica e una ideologica. Per essere dialogiche e non ideologiche, religione e
democrazia debbono riconoscere il principio laicità. Esso finora è stato riconosciuto come principio
della democrazia, non altrettanto da parte di tutte le religioni, per cui è su questo fronte che occorre
intervenire. Ebbene, lo sviluppo della modernità ha visto il cristianesimo recepire questa istanza; si
può ipotizzare che la postmodernità possa vedere l’islam andare in analoga direzione? Non di
guerra allora c’è bisogno ma di cultura, non di scontri ma di incontri, non di condanne ma di
dialogo. Lo aveva capito (giusto settecento anni or sono) Raimondo Lullo, e forse da lui -oltre che
dall’Illuminismo- sarebbe opportuno ripartire.
***
Giancarlo Galeazzi è stato ordinario di Filosofia teoretica e morale al Polo teologico di Ancona
della Università Lateranense. E’ direttore emerito dell’Istituto superiore di scienze religiose di
Ancona. E’ presidente onorario della Società filosofica Italiana di Ancona. E’ direttore della Scuola
di alta formazione etico-politica di Ancona Studioso del pensiero cristiano, ha curato l’edizione
italiana di opere di Jacques Maritain: Per una filosofia dell’educazione (ed. La Scuola), Cultura e
libertà (ed. Boni), La persona umana e l’impegno nella storia (ed. La Locusta); è autore tra l’altro
dei volumi: Personalismo (ed. Bibliografica) e Jacques Maritain un filosofo per il nostro tempo (ed.
Massimo) e ha curato i volumi: Il pensiero politico di Jacques Maritain (ed. Massimo) e Stato
democratico e personalismo (ed. Vita e Pensiero).
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Carlo Rosselli e il mito di “Giustizia e Libertà”
di FRANCESCO POSTORINO
In una fase storica che vede il trionfo del populismo reazionario e la bruciante sconfitta della
narrazione liberal, è più che mai di attualità il socialismo liberale del fondatore di “Giustizia e
Libertà”. Una “terza via” da non confondere con il riformismo contemporaneo propugnato dai
moderati di sinistra.
Non dovrebbe più stupire che lo scenario globale ospiti il trionfo del populismo reazionario e la
bruciante sconfitta della narrazione liberal. Destra e sinistra costituiscono oramai le pedine di un
capitale spregiudicato che trasforma le persone in numeri, oggetti flessibili esposti in un
palcoscenico liberista. Traditi dalle logiche di mercato, i nuovi sfruttati si rifugiano in uno spazio apolitico entro cui l’istinto prevale. E così sale in cattedra l’oscenità di un Trump, applaudita dal
mondo xenofobo e confermata da un proletariato irretito da personaggi in mala fede. La sinistra
moderna è troppo «moderna» per capirlo e, infatti, non ha alcuna intenzione di rivisitare la
globalizzazione neo-liberale. Balbetta un’offerta normativa che continua a fare il gioco del profitto
incentivando le ragioni della disuguaglianza, della discriminazione, della libertà cerimoniale.
Per questo non convincono alcune tesi avanzate da filosofi e politologi che vedono in Carlo Rosselli
un precursore dell’«ulivismo» mondiale. Il giornalista francese Jacques Julliard trova ad esempio
molte affinità ideologiche tra l’eminente anti-fascista italiano e la «terza via» del riformismo
istituito negli anni ’90 (New Democrats di Bill Clinton, New Labour di Tony Blair, «nuovo centro»
di Gerhard Schrӧder ecc.). La verità è un’altra, come peraltro affermano gli studiosi più avvertiti.
Figlio di una scrittrice femminista, Carlo nasce il 16 novembre 1899 a Roma e viene educato in un
ambiente ebreo. Legato agli ideali repubblicani del Risorgimento e allo spirito mazziniano, il
giovane studioso di economia scrive nel ’23 una tesi importante sul sindacalismo, sotto la guida di
Gaetano Salvemini, e inizia a collaborare con la rivista «Critica sociale» di Filippo Turati. A seguito
dell’assassinio di Giacomo Matteotti, Rosselli fonda nel ’25 e nel ‘26 rispettivamente il periodico
clandestino «Non Mollare» e, con Pietro Nenni, la rivista socialista «Il Quarto Stato». Egli, al pari
di Gobetti, rifiuta il socialismo riformista e scruta con simpatia gli sviluppi culturali del laburismo
inglese. Costretto all’esilio sull’isola di Lipari, dopo aver organizzato con altri la fuga del suo amico
Turati, tra il ’28 e il ’29 compone la sua unica grande opera: Socialismo liberale. Scappa a Parigi e
dà alla luce Giustizia e Libertà, un movimento rivoluzionario che riunisce tutte quelle formazioni
repubblicane, socialiste e democratiche intenzionate a rovesciare il fascismo in nome di un
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
«secondo Risorgimento italiano». Si reca in Spagna nel luglio del ’36 per contrastare l’offensiva
franchista. Il 9 giugno del ’37, dopo il suo rientro in Francia, viene assassinato, insieme al fratello
Nello, dal movimento di estrema destra La Cagoule.
Facciamo un passo indietro. Tra il ’19 e il ’20, gli intellettuali Novello Papafava e Mario Missiroli
cercano di capire se vi siano le possibilità ermeneutiche e politiche per un incontro tra il liberalismo
e il socialismo. Missiroli polemizza con il liberalismo ufficiale e consegna la funzione liberale
direttamente nelle mani del movimento socialista, cioè di chi dovrebbe disporre di un sincero stato
d’animo liberale.
In una lettera che invia a Papafava nel giugno del ’22, Rosselli comunica al suo interlocutore il
desiderio di revisionare «in senso liberale» il metodo socialista, e più tardi – in due articoli
pubblicati nel ’23 («Critica sociale») e nel ’24 («La Rivoluzione liberale»), entrambi dal titolo
significativo: Liberalismo socialista – il leader del movimento Giustizia e Libertà, pur prendendo le
distanze da Papafava e dall’originale lettura di Missiroli, distingue il liberalismo come sistema dal
liberalismo come metodo e intende rifondare il rapporto tra libertà e socialità elaborando una nuova
teoria politica.
Influenzato in particolar modo dal volume del socialdemocratico belga Henri de Man, Au delà du
marxisme, Rosselli si sente vicino alla classe dei lavoratori in modo del tutto diverso dal marxismo.
La filosofia marxista, dice Rosselli, è permeata di necessità, determinismo, percorsi unidirezionali a
sfondo economicistico che sviliscono il senso dell’autonomia morale e intellettuale della persona.
Neppure la stagione revisionista lo soddisfa completamente. Occorre trovare un’altra via, svestire i
panni del rigido comunista e abbracciare la speranza degli sfruttati adottando un nuovo lessico
politico e culturale. Il suo Socialismo liberale, la cui prima edizione viene pubblicata in lingua
francese nel ’30, offre una lucida risposta al disagio provocato dalla concezione marxista della
storia e dall’insufficienza liberale. Evitare il marxismo, infatti, non significa per Rosselli
corroborare la falsa verità della dottrina borghese. La borghesia, a suo giudizio, ha compiuto
storicamente un’opera di indubbia validità. Ha sconfitto l’ancien régime, inventato la libertà
religiosa, l’umanesimo e i preziosi principi dell’89, solo che nel corso dell’Ottocento la sua corsa
improntata alla libertà si interrompe. Raggiunto il principio formale che sancisce costituzionalmente
il diritto inviolabile della proprietà privata, il bourgeois smette di lottare. La nuova classe al
comando ha conseguito i suoi obiettivi e non le resta che custodire i frutti disegnando un gelido
sistema al servizio del liberismo economico. Rosselli non ci sta. La sua visione di un’economia
mista a due settori preannuncia una «terza via» certamente da non confondere con il riformismo
contemporaneo propugnato dai moderati di sinistra.
Egli, inoltre, boccia il sistema liberale e accoglie il metodo democratico, l’unico idoneo a garantire
l’ampliamento delle libertà perché incentrato sul rispetto delle regole del gioco. Un patto di
cittadinanza deve pertanto unire diverse anime e consentire a chiunque di vivere una vita veramente
degna di essere vissuta. Questo non è liberalismo, ma tecnica istituzionale quale condizione
necessaria per la vera libertà. Il socialismo è la libertà. Non un «incubo ugualitario», per utilizzare
un’espressione cara a Michael Sandel, piuttosto un tentativo di liberare la libertà in chiave
socialista. La classe borghese è conservatrice, e adesso tocca al «Quarto Stato», tuona Rosselli,
riprendere il paradigma dell’emancipazione affinché non vi siano più individui «liberi di diritto, ma
servi di fatto». L’operaio deve diventare un sui iuris. Solo la cultura socialista, degna erede del
liberalismo moderno, può dar voce agli indifesi, tutelare le vittime del sistema, architettare
un’autentica libertà. Rosselli, quindi, è un socialista perché è un liberale, ed è un democratico in
quanto disprezza per motivi intrinseci la lezione totalitaria del fascismo. Le dittature nascono in
assenza della libertà interiore e quando subentra l’abito servile, quando la verità viene guastata da
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
un’indifferenza già a suo tempo sbeffeggiata da Gramsci. Spirito socialista, metodo democratico e
repubblicanesimo civico costituiscono l’abc della cultura politica e filosofica di Rosselli.
Pare evidente, da questa piccola analisi, la spinta rivoluzionaria della sua opera. Un’anomalia
liberale da non accostare al neo-liberalismo europeo d’ispirazione keynesiana maturato proprio
intorno agli anni ’30, basti pensare a Walter Lippmann, e soprattutto, va ribadito, da non avvicinare
all’attuale centro sinistra, al liberal di oggi, a coloro che non discutono il sistema vigente e si
ritrovano sprovvisti di energie morali e intellettuali. Sono infinite le «comparse» da convertire in
uomini liberi. Migranti, minoranze varie, nuovi proletari, giovani costretti al call center invocano
«l’emancipazione dal morso dei bisogni essenziali». Ecco perché il messaggio di Rosselli continua
a vivere.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Contro le donne: violenza e pregiudizio
di GIANCARLO GALEAZZI
La “fine del maschio” e la crescita di complessità della identità femminile chiedono una nuova
alleanza fra i due generi sessuali, da impostare secondo un modello personocentrico. È questa la
proposta elaborata Giancarlo Galeazzi, ed esposta in questo testo presentato per la prima volta
alla Giornata Mondiale della Filosofia 2016 – Centro “Pergoli” di Falconara Marittima, il 20
novembre 2016.
1. Vocazione e responsabilità della filosofia
Nella Giornata Mondiale della Filosofia indetta dall’UNESCO – che a Falconara Marittima si
celebra da cinque anni, tenendo anche presente la Giornata internazionale indetta dall’ONU per la
eliminazione della violenza sulle donne – torna utile riflettere non solo sulla “vocazione” ma anche
sulla “responsabilità” della filosofia, perché, mentre il primo tema (la vocazione) è tra quelli più
frequentati, il secondo (la responsabilità) appare piuttosto trascurato, eppure costituisce il banco di
prova della stessa vocazione. Infatti, se sganciata dalla responsabilità, la vocazione filosofica finisce
in genere per essere oggetto di una trattazione più o meno retorica, incentrata soprattutto sulle
potenzialità positive della filosofia, la quale invece, come tutte le attività umane, presenta anche
dimensioni negative, su cui occorre riflettere, per avere consapevolezza che ci possono essere, per
così dire, peccati: e non solo di pensiero, ma anche di opere e omissioni. La questione delle donne,
per esempio, lo evidenzia chiaramente sia per la considerazione in cui la donna è stata tenuta dai
filosofi, sia per la esclusione della donna dall’esercizio filosofico: su entrambi i fronti è da rilevare
una precisa responsabilità della filosofia nell’aver contribuito alla emarginazione e alla marginalità
della donna, legittimando certi pregiudizi con argomentazioni che hanno poi rivelato la loro
inconsistenza, e trascurando le argomentazioni che pure alcune pensatrici adducevano per
contestare quei pregiudizi, tra cui in primo luogo quello della misoginia.
Infatti, non sono mancate donne che anche filosoficamente hanno criticato quella considerazione e
che si sono opposte a quella esclusione; donne che meritano il titolo di filosofe non fosse altro che
per la loro capacità di mettere in discussione certi pregiudizi, rispondendo così alla vocazione
propria della filosofia di essere esercizio critico, che porta a diffidare dei luoghi comuni e a
sospettare di concezioni pur consolidate. Non sono mancate filosofe nei secoli, ma soprattutto nel
secolo XX, che può essere definito “il secolo delle filosofe” per il numero e la qualità delle
pensatrici. Prima ancora che questa presenza si facesse così consistente e autorevole non erano
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
mancate voci femminili che si erano levate contro la misoginia diffusa in ogni tempo, contestandola
sul piano razionale con efficaci argomenti.
Bisogna allora riconoscere che in certi casi, nell’arco di quasi 2500 anni, la filosofia ha contribuito
non a sradicare certi pregiudizi, ma addirittura a consolidarli, nella fattispecie presentando una
concezione riduttivistica ed escludente della donna. Il fatto è che anche la filosofia nasce e si
sviluppa come riflessione sull’uomo esercitata dall’uomo: una attività maschile e al maschile pur se
presentata in chiave universale. Si badi: non che i filosofi (almeno alcuni) non abbiano riflettuto
anche sulle donne o che (almeno alcuni) non abbiano accolto donne nelle loro comunità filosofiche:
il fatto da denunciare è che il loro filosofare era prevalentemente dell’uomo e per l’uomo, certo
senza dimenticare che ciò avveniva in un contesto che era patriarcale e maschilista .
1. 2. Un duplice paradosso
Bisogna riconoscere che una tale impostazione - presentata come “antropologica” ma in realtà
“andrologica”- ha comportato una responsabilità che si è rivelata in contrasto con la vocazione
filosofica alla criticità e razionalità. Si deve al movimento femminista e alle filosofe contemporanee
aver denunciato questa contraddizione latente, averla portata alla luce, averla messa in discussione;
in tal modo la contestazione della filosofia “al maschile” o “cripto-maschilista” ha richiamato la
filosofia alla sua vocazione di esercizio della diffidenza o del sospetto nei confronti di impostazioni
date per scontate, magari caratterizzate in senso universale. Rigettando la misoginia come
pregiudizio insostenibile e rivendicando il diritto alla filosofia anche per le donne, la filosofia ha
rinnovato e sta rinnovando il senso della sua responsabilità, rispondendo più adeguatamente alla sua
vocazione logica e dialogica.
Pertanto occorre riconoscere a chiare lettere il debito che la filosofia ha nei confronti del
“movimento delle donne” (femminista e femminile): le ha permesso di collegare il senso della
universalità con le individualità, per cui si è avuta la rivendicazione prima della “eguaglianza”, poi
della “differenza”, infine delle “differenze”. Così la filosofia si è aperta all’imperativo di coniugarsi
sull’universale in ottica plurale, ed è questa a dare significato a quella, in quanto sottrae
l’universalità alla astrattezza. Tuttavia, insieme con il merito di aver messo in discussione
l’impostazione antropologica tradizionale della filosofia (con tutte le conseguenze che questo
comporta oltre l’antropologia), è da rilevare il limite della nuova impostazione, che si è confinata
spesso nella mera rivendicazione (del pensiero femminista) o nella sostanziale ininfluenza (del
pensiero femminile).
Infatti, il femminismo con il superamento della “subordinazione” e del “silenzio” delle donne
sembra concludere (almeno in certe tendenze radicali) nella “scomparsa” della donna in nome di un
“transumanesimo” che va oltre il maschile e il femminile. In altre parole, configurando quella
femminile come questione di genere, il femminismo rischia di dissolvere il genere stesso, per cui si
assiste a un paradosso: che le donne passano dalla “assenza” del passato alla “scomparsa” del
presente (il futuro è già cominciato). Quando non si batte questa strada, l’altra - quella del pensiero
femminile - non sembra sortire effetto migliore, nel senso che il pensiero femminile che si occupa
dei classici problemi della filosofia (a prescindere da questioni di genere) non risulta a ben vedere
influente più di tanto nel dibattito culturale, in quanto quello delle filosofe appare un contributo che,
privo di una sua specificità, non si distingue da quello maschile, che continua a essere dominante e
predominante. Così, la condizione femminile passa (e ancora una volta siamo di fronte a un
paradosso) dalla “afasia” (del passato) alla “ininfluenza” (del presente).
Ecco, dunque, il limite di un movimento e di un pensiero che pure sono meritori per aver
rivoluzionato l’esercizio filosofico e il diritto alla filosofia ma che, nel contempo, hanno finito per
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
creare una situazione caratterizzata da nuovi problemi. Proprio questo mi pare che porti a mettere in
discussione le vecchie e le nuove impostazioni, e a reclamare di fuoriuscire da una “logica di
genere” per aprirsi a una “logica di specie”, nel senso che la riflessione deve muovere dalla specie
umana per poi specificarsi nel genere maschile e femminile, perché è a partire dalla “unità” della
specie umana che si può correttamente porre la questione della “diversità” di genere sessuale. Si
tratta, insomma, di affrontare la questione antropologica superando l’”androcentrismo” non meno
che il “ginecocentrismo”, ovvero superando la gerarchizzazione uomo-donna (primo e secondo
sesso) non meno che la condizione asessuata (il ciborg). A tal fine si può riconoscere oggi un ruolo
importante alla filosofia; anzi, secondo Michela Marzano, “la filosofia è un'arma efficace e potente,
l'unico strumento capace di aiutare le donne a riappropriarsi della propria vita e non permettere più
a nessuno di umiliarle o zittirle".
1. Il tema della violenza
Quanto abbiamo sommariamente detto è tutt’altro che estraneo al tema della violenza contro le
donne, perché tale violenza ha trovato il suo radicamento nel disprezzo per la donna (misoginia) su
cui si esercitava la violenza maschilista, e trova nuova espressione nel risentimento nei confronti
della donna con forme di violenza (femminicidio) conseguenti al maschilismo declinante: cambia la
motivazione, ma non cambia l’esito, quando la donna non è riconosciuta nella sua dignità di
persona.
La violenza dell’uomo - che sia legata alla sua “prepotenza” di ieri o alla sua “impotenza” di oggi è pur sempre conseguente alla concezione “svalutativa” e “proprietaria” che l’uomo ha della donna,
per cui è da tale concezione che bisogna liberarsi, tanto che si accompagni alla alterigia del
maschilismo, quanto che si accompagni alla insicurezza della “fine del maschio” (Hanna Rosi), cioè
quando la pretesa sua superiorità è rigettata teoreticamente e rifiutata praticamente: la inedita
situazione - in cui non è l’uomo a decidere di lasciare la compagna, ma è questa che si vuole
separare da lui - provoca una crisi che si traduce in quell’omicidio particolare che va sotto il nome
di “femminicidio”, cui a volte (non senza significato) si accompagna il suicidio, a conferma della
situazione (per così dire) “irrisolta” che l’uomo sta vivendo.
Il che, lungi dal giustificare la violenza (omicida e suicida), dice tuttavia della “alterazione” in cui
l’uomo si trova oggi. Si badi: non si tratta di psichiatrizzarlo, quasi a trovare attenuanti per il gesto
che si condanna “senza se e senza ma”; si tratta, però, di prendere atto di una situazione inedita che
richiede che si intervenga sull’uomo, in modo che sia in grado di rinnovare la propria immagine di
“uomo”, di riprogettare il proprio stare al mondo nella consapevolezza che sta attraversando un
cambiamento epocale, che lo coinvolge direttamente, per cui, non solo deve prendere le distanze
dalle tradizionali concezioni maschiliste, ma deve anche inventarsi un nuovo modo di rapportarsi
alla donna all’insegna di un atteggiamento fondamentale: il rispetto; l’uomo è chiamato a rispettare
la donna e se stesso in nome della comune dignità di persona; ed è, questa, una conquista da operare
insieme (uomini e donne): solo così è il modo più deciso per dire no alla violenza di genere.
Per rispondere alla nuova situazione due appaiono essere le strade percorribili: quella che dissolve il
maschile e il femminile (transumanesimo) e quella che invece conserva il maschile e il femminile e
li considera aspetti coessenziali dell’essere umano (personalismo), per cui l’uomo e la donna sono
chiamati a elaborare insieme una antropologia integrale (non dimidiata). Lasciato da solo, l’uomo
prima ha preteso di essere superiore, poi ha rivelato di essere disagiato, prima è stato all’insegna
della certezza identitaria, poi immerso nella incertezza identitaria. Lasciata da sola, la donna prima
è stata in una condizione di dipendenza, poi di separatezza, prima in una condizione di
subordinazione, poi di antagonismo. In ogni caso non ci si è liberati dalla violenza maschile sulle
donne.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Da più parti, oggi, si riconosce la necessità di elaborare una antropologia con il concorso del
pensiero teoretico e dell’impegno pratico esercitati da uomini e donne, tenendo ovviamente conto di
quanto è storicamente accaduto. In questo senso si potrebbe parlare della necessità di un
“postfemminismo” che porti non a rinunciare alle conquiste del femminismo, ma a ripensarle nel
contesto unitario della persona umana. Si tratta allora di rinunciare sia al “modello virile”
(contestato da Umberto Galimberti), sia alla “ipotesi del transumanesimo” (sostenuto da Rosi
Braidotti), sia al “narcisismo di genere” (denunciato da Paolo Ercolani), per muovere in direzione di
una “impostazione personocentrica”, che risponda alla duplice esigenza: del rispetto di tutti e di
ciascuno; allora il riconoscimento delle “differenze” (diversità di generi e di generazioni, diversità,
etniche ed etiche, cultuali e culturali) è la condizione per guadagnare una unità articolata.
Infatti, lungo il ‘900, si è scardinata una situazione decisamente ingiusta nei confronti delle donne,
ma non si è nel contempo operato (né da parte degli uomini né da parte delle donne) in modo che
tali modificazioni fossero collocate in un quadro d’insieme da affrontare in modo sistemico, in
modo tale da tenere conto di entrambi i soggetti chiamati a rivedere la loro identità e la loro
relazione. Invece è stata seguita una logica, per così dire, “insulare” da ciascuna delle due parti, per
cui ci si è limitati per un verso alla rivendicazione per abbattere l’ancien régime maschilista, e per
altro verso al contenimento delle varie “ondate” per salvaguardare (pur con qualche modificazione)
lo status quo.
1. Tra natura e cultura
In ogni caso si è ben lontani dall’ipotizzare un nouvel regime personalista, ossia incentrato sulla
persona per elaborare insieme un umanesimo non androcentrico né ginococentrico, bensì
personocentrico, cioè secondo una logica che ponga al centro la “persona” e, guardando a questa,
s’impegni a costruire una “casa comune” che uomini e donne possono abitare in modo inedito con
soddisfazione di entrambi. Così non è stato: è prevalsa una impostazione di opposizione: con le
donne impegnate a cambiare la situazione, e con gli uomini impegnati a conservare l’impianto
tradizionale: la possibilità di intendersi non c’è stata, in quanto - tra l’altro - i paradigmi di
riferimento erano posti come alternativi, appellandosi il femminismo alla “cultura”, e il
maschilismo alla “natura”.
In realtà, la consapevolezza che si deve fare strada è che i due termini non vanno disgiunti, bensì
tenuti insieme; infatti, la persona umana risente tanto della natura quanto della cultura, per cui né
questa né quella possono essere liquidate come inessenziali. Dunque, la separazione tra natura e
cultura (anzi, la loro opposizione, il carattere alternativo loro attribuito) ha finito per produrre
equivoci e fraintendimenti, radicalizzando la posizione “pro natura” o quella “pro cultura”, e magari
leggendo la prima in termini fissisti e la seconda in termini relativistici, laddove entrambe, invece,
vanno intese in senso dinamico evolutivo e reciprocamente influente. E’ con questo spirito che
occorre ripensare la condizione di uomini e di donne, ma non in termini astratti, più o meno
metafisici o essenzialistici, bensì in modo concreto, funzionale.
Per andare in questa direzione, occorre tenere presente tutta una serie di fenomeni, a partire dalla
presenza sempre più diffusa delle donne nei vari campi della conoscenza e della società, pur in
condizione che risulta svantaggiata rispetto agli uomini, e la difficoltà delle donne di oggi di vivere
una identità molto composita, che si potrebbe sintetizzare con la metafora delle borse, per dire che
le donne portano contemporaneamente la “borsa da passeggio”, la “borsa dell’ufficio” e la “borsa
della spesa”.
Il problema pertanto sembra essere quello di andare oltre il femminismo, dopo averlo attraversato,
riconoscendone il valore storico, ma rilevando nel contempo il rischio di una sua chiusura. Da qui la
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
necessità di fuoriuscire da un femminismo all’insegna della separazione e della separatezza, cioè
come “cosa di donne” e “per le donne” che, nell’impegnarsi a favore delle donne, non ha tenuto
conto che certe conquiste avrebbero determinato modificazioni non solo sulle donne, ma anche
sugli uomini e sui loro rapporti con le donne: proprio su questo versante è mancata una specifica
riflessione.
Il fatto è che il femminismo - nei suoi diversi momenti di rivendicazione e di protesta, di attacco e
contrattacco, di denuncia e di orgoglio - è stato pur sempre all’insegna di una lotta quasi
esclusivamente femminile e all’insegna del separatismo nei confronti dell’uomo (del maschio), e
ciò non ha permesso confronti, ma solo scontri, per cui le donne legittimamente puntavano a
cambiare la loro condizione contrassegnata da ineguaglianza e ingiustizia, da illibertà e inequità, e
gli uomini puntavano a conservare privilegi contrabbandati come diritti, magari ammantandoli pure
come doveri, cui non potevano sottrarsi.
1. 5. Un’alleanza antropologica
Per tutto questo Umberto Galimberti ha affermato che “non è sufficiente che le donne entrino nella
storia spinte solo dall’ostinata rivendicazione di ciò di cui finora la storia le ha private. E’
necessario un passo in più. E a compierlo devono essere insieme uomini e donne. Il loro cammino
deve prendere le mosse da una rinuncia, la rinuncia ad assumere l’identità virile come specchio e
modello di ogni altra identità. Si tratta infatti di una identità che gli uomini devono smettere di
rivendicare e le donne di imitare. Nel gioco della ”impotenza”, soprattutto se la “potenza” è più
storico-ideologica che reale, c’è maggior possibilità di dialogo, più traccia di verità”.
Da qui una auspicabile alleanza tra donne e uomini; a questo è necessario arrivare, se si vuole
mettere a frutto i “guadagni storici” del femminismo, evitandone le “verità impazzite”, e soprattutto
se si vuole avviare una inedita opera di revisione delle identità, funzioni e peculiarità femminili e
maschili. Si tratta di un’opera che può essere gestita proficuamente solo se uomini e donne
realizzano una alleanza etica che li impegni in un progetto tale da far superare il monismo del
modello antropologico (identificato con quello maschile) ovvero il dualismo dei modelli
antropologici (femminile vs maschile).
Il problema infatti non è semplicemente “essere uomo” e “essere donna” (l’uno contro l’altra
armati), ma - vi ha richiamato Nadia Fusini - su “come essere donne” e “come essere uomini”, e su
“come essere quella donna che si è” e “come essere quell’uomo che si è”: hic et nunc. Da qui la
necessità di partire da una categoria - quella di fratellanza - che ha trovato applicazione in senso
universale e particolare, in senso patriottico e religioso, ma non (ed è paradossale) tra uomini e
donne: proprio la categoria di fratellanza reclama di coniugare insieme uguaglianza e diversità,
parità e specificità.
Dunque, per superare la chiusura degli uomini e la separatezza delle donne, appare necessaria una
inedita alleanza antropologica tra uomini e donne, finalizzata a far fronte a due crisi di identità
che sono in corso e che sono diversamente connotate: la “complessificazione” di quella femminile
(l’immagine della triplice borsa) e la “fragilizzazione” di quella maschile (nelle diverse situazioni:
maritali e paterne). Infatti, l’odierna identità complessa delle donne rischia di creare loro problemi
di gestione individuale e relazionale, e l’odierna identità confusa degli uomini rischia di creare
inedite forme di violenza nei confronti delle donne e di se stessi. Insomma, negli uomini e nelle
donne la loro identità ha un carattere tutt’altro che lineare, quando non è addirittura contraddittorio,
conseguente al fatto che le modificazioni avvenute si sono “aggiunte” alla precedente condizione
senza tenere conto della necessità di ripensarla alla luce delle sopraggiunte innovazioni.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Forse la categoria, che permetterebbe di impostare correttamente il rapporto uomo-donna, potrebbe
essere quella di “somiglianza”, per dire identità diverse e tuttavia paritarie. Il richiamo alla Bibbia
è scontato: Dio creò la donna, per dare a Adamo un aiuto simile a lui. In Genesi, cioè, troviamo le
categorie di “somiglianza”, che non dice semplicemente “eguaglianza” ma salvaguarda la
“differenza”, e di “aiuto”, che dice la non autosufficienza dell’uomo e il suo bisogno di completarsi
con la donna per cui uomo e donna sono esseri “simili” (diversità nella eguaglianza), chiamati
proprio per questo ad aiutarsi vicendevolmente (riconoscimento nella reciprocità).
Dunque, andare oltre l’uguaglianza e oltre la differenza, nel senso che queste due categorie (che dal
punto di vista storico hanno segnato rispettivamente il primo e il secondo femminismo) non devono
essere abbandonate, ma devono essere assunte come istanze indisgiungibili, che vanno integrate in
un nuovo stile relazionale di tipo solidale fra uomo e donna. C’è dunque bisogno di un nuovo stile
paritetico e simpatetico, che permetta di superare la odierna crisi identitaria dei maschi che produce
in loro un disagio, che non sanno affrontare, per cui le loro compagne sono spesso fatte oggetto di
violenza per l’autonomia comportamentale che esse legittimamente intendono esercitare e alla
quale l’uomo deve essere educato, in modo che alla “identità maschilista” si sostituisca una
“identità maschile” che con la “identità femminile” si riconosca nella comune “identità umana”,
cioè di persone.
Ci sembra, questa, la condizione necessaria, seppure non sufficiente, per superare il fenomeno
denominato con una serie di neologismi: femminicidio (Barbara Spinelli), femmicidio (Cristina
Karadole), ginocidio (Daniela Danna), ecc., ma quello entrato nell’uso è “femminicidio”, per cui
alla violenza maschile di ieri esercitata per un eccesso di identità maschile (maschilismo o
machismo) si è passati alla violenza maschile di oggi esercitata per difetto di identità maschile.
Si tratta di una situazione aggravata da tutta una serie di res novae, tra cui due giocano un ruolo
fondamentale. Anzitutto, la novità delle tipologie familiari, nelle quali l’uomo sempre meno
comprende quale sia il suo ruolo, per cui le nuove figure maritali (il marito sempre “ragazzo”) e
paterne (il padre diventato “mammo”) incidono ulteriormente sulla crisi dei maschi. Inoltre, la
dibattuta questione relativa a genere e sesso e alle preferenze sessuali, che il “politicamente
corretto” chiede di non sindacare, aggiunge ulteriori motivi di difficoltà nella definizione delle
identità personali e della loro traduzione in modalità relazionali.
E’ in questo quadro che vanno collocate le nuove forme di violenza degli uomini (contro le donne e
contro se stessi), e bisognerà intervenire perché non si ripetano, e farlo contestualizzandole al nuovo
quadro socio-culturale, in quanto è su questo che bisogna operare in termini culturali e educazionali,
non meno che politici e religiosi, etici e giuridici. Forse allora si può ipotizzare che, se il
femminismo ha permesso di superare (con nuove legislazioni e nuova mentalità) le tradizionali
forme di violenza del maschio (“padre, padrone e padreterno”), il postfemminismo potrà permettere
(impegnando uomini e donne insieme) a superare le nuove forme di violenza del maschio in crisi di
identitaria come uomo, come compagno, come marito, come padre, perché una tale debolezza
identitaria può tradursi nella violenza nei confronti delle donne e di se stessi.
1. Valori e virtù
Di fronte alla odierna situazione, c’è chi, perpetuando un certo femminismo di rivalsa adotta la
logica del tanto peggio tanto meglio, per dire che gli uomini hanno oggi quello che si meritano, e se
oggi soffrono, soffrano pure: sempre poco in confronto a quanto per millenni hanno fatto soffrire le
donne. Il fatto è che una tale posizione non è valida in sé, giacché la rivalsa non paga, e non è valida
per le conseguenze che sovente porta con sé, cioè il femminicidio. Questo in particolare è un
fenomeno la cui consistenza quantitativa è elevata, tanto che (come è stato rilevato) ne uccide più
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
della mafia. La tragicità di recenti fatti di violenza contro le donne acuisce la necessità di
intervenire in modo culturale e istituzionale, sul piano individuale e sociale, da un punto di vista
legislativo ed etico, educativo e rieducativo.
Tutto ciò richiede che libertà ed eguaglianza siano percepite come valori che valgono per tutti:
tanto per gli uomini, quanto per le donne, e in modo paritetico; uomini e donne sono chiamati a
operare concordemente per la realizzazione di questi valori, superando la logica che chiude la
donna e l’uomo in se stessi: questa concezione “atomistica” o “monadica” della donna e dell’uomo
finisce per isolare il senso di certe conquiste femminili e per produrre delle vere e proprie patologie
maschili che si traducono in comportamenti abnormi. Occorre pertanto che la donna e l’uomo si
aprano a una nuova mentalità che permetta soprattutto all’uomo di pensare e di agire in modo
adulto, “aiutato” in questo dalla società in generale e dalla donna in particolare secondo inedite
modalità relazionali.
Si può allora dire che il primo obiettivo è quello di “ripensare” il quadro nel suo insieme: in
riferimento tanto alla donna quanto all’uomo, e in riferimento al loro rapporto, che va posto
all’insegna della paritaria appartenenza alla specie umana e al paritario esercizio della valenza
umana. Quando si giunge al femminicidio, c’è nell’uomo adulto una regressione “atavica” o
“infantile”, nel senso che si reagisce negando autonomia alla donna, considerata “cosa” di cui
l’uomo può liberamente disporre, “giocattolo” da rompere se non si riesce a disporne a proprio
piacimento.
Si tratta di un lavoro terapeutico e rieducativo da operare nei confronti dei maschi adulti e di un
lavoro educativo e culturale da operare nei confronti dei maschi in età evolutiva. Sotto entrambi i
profili la famiglia e la scuola possono svolgere un ruolo rilevante attraverso un modus vivendi e un
modus cogitandi ispirati alla consapevolezza sociale e sentimentale, tale da abituare a rispettare
tutti e a non discriminare alcuno, e ad affrontare le situazioni della vita, distinguendo tra fortezza
d’animo e forza della violenza. C’è pertanto bisogno di una educazione morale incentrata (come è
stato suggerito da una filosofa quale Laura Boella) sul coraggio e sulla immaginazione, e questa
non è meno importante di quello, anzi lo rende possibile.
Possono aiutare a andare in questa direzione l’esercizio di alcune virtù come la fiducia (nel senso di
fidarsi reciprocamente), l’umiltà (nel senso di essere disponibili a rivedere le proprie posizioni
faticosamente conquistate o tradizionalmente ricevute), la mitezza (nel senso di affrontare le
questioni con spirito di intesa). Sono, queste, alcune “virtù deboli, ma che non sono dei deboli”,
direbbe papa Francesco. E con lui si potrebbero richiamare categorie come quelle di prossimità e
misericordia, a cui solo recentemente si va prestando crescente attenzione: sono categorie che non
hanno solo un valore religioso ma anche laico, e possono favorire un ethos all’insegna della
operosità patica ed empatica, donativa e collaborativa.
Quelle e altre virtù simili potrebbero innovare il rapporto tra donne e uomini impegnandoli a
superare da parte dei maschi i loro pregiudizi contro le donne, e ad esercitare da parte delle donne la
loro nuova condizione in termini di condivisione. Ciò significa che la emancipazione, liberazione o
promozione (che dir si voglia) delle donne deve proseguire, ma non più contro il maschio, bensì
insieme con lui, avendo chiaro che le novità della condizione femminile portano con sé
inevitabilmente novità nella condizione maschile: impegnarsi nelle prime non deve portare a
ignorare le seconde.
1. Un pregiudizio da sradicare
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Siamo d’accordo con Paolo Ercolani, il quale (nel suo recente volume Contro le donne: storia e
critica del più antico pregiudizio) ritiene che il primo passo da compiere sia quello di combattere
la misoginia, “il più antico pregiudizio della storia umana”. La lotta al pregiudizio contro le donne
“significa in qualche modo impegnarsi anche per debellare la secolare vergogna della violenza
psicologica, fisica e sessuale contro le donne”. Tanto più che esso si è insinuato in una parte del
femminismo, quella impegnata a “lavorare per la costruzione di un soggetto umano asessuato, al di
là delle categorie di maschile e femminile”. Invece, secondo Ercolani, “una soluzione post o anti
umana, per una questione radicalmente umana qual è il pregiudizio” contro le donne “non può
rappresentare una via da percorrere”.
Dunque, non è “tramite il superamento delle stesse identità sessuali, quindi attraverso la negazione
e l’annullamento di quella differenza e specificità”, ma con la “riconosciuta piena dignità e
possibilità di esprimere un valore ‘altro’ e indispensabile alla completezza del genere umano”.
Pertanto questo Autore non esita ad affermare che “il superamento del pregiudizio contro le donne
rappresenta il compito fondamentale che oggi si pone di fronte al genere umano”; e l’eliminazione
di (tale) fardello che grava fin dalle origini su più della metà del genere umano, si presenta a noi
come la vera sfida del XXI secolo” (insieme con la “individuazione di un nuovo modello di
economa politica” e con “il ripensamento di uno sviluppo ecosostenibile”).
Si tratta, allora, “prima ancora di dividerci in uomini e donne”, di “riconoscerci tutti, in quanto
esseri umani (universali) e individui (irriducibili)” come esseri che condividono “una condizione
esistenziale di incertezza e tormento, tali da suggerire la comunione delle menti e delle forze,
laddove possibile, piuttosto che il conflitto sterile e autodistruttivo”. Dunque, occorre “fare i conti
fino in fondo con il pregiudizio contro la donna, per provare finalmente a lasciarselo alle spalle,
significa non soltanto liberare metà del genere umano da un fardello vergognoso e miserabile, ma
permettere anche all’altra metà di acquisire una maggiore consapevolezza di cosa vuol dire abitare
questo mondo e questa nostra umana esistenza”.
Tutto ciò (ecco il punto che con Ercolani riteniamo fondamentale) comporta filosoficamente la
necessità di elaborare “una nuova teoria della soggettività umana che possa agevolare il
superamento di contrapposizioni e pregiudizi sessuali”. Per questo riteniamo che la misoginia per
un verso, e il femminismo per l’altro vadano visti come aspetti della questione antropologica. Solo
nell’orizzonte dell’antropologia l’essere contro la donna rivela tutta la sua negatività, così come
l’essere a favore della donna rivela tutta la sua positività, diversamente si cade nel folcloristico
della misoginia ovvero nel rivendicazionismo del femminismo.
La posta in gioco è ben più alta: occorre puntare a “una teoria dell’umano: oltre il narcisismo di
genere”, per usare la efficace espressione che Ercolani mette a titolo dell’ultimo capitolo del suo
libro, finalizzato a “comprendere la differenza tra l’identità maschile e quella femminile, per poi
elaborare una teoria della soggettività umana che le contenga entrambe in termini di assoluta
parità e dignità”.
Così, “tenere fermo e valorizzare il contributo irriducibile che le donne, con le loro caratteristiche
differenti rispetto all’uomo, possono fornire al consesso umano, si rivela come un obiettivo
primario che dobbiamo inserire all’interno di un più ampio progetto di neo-umanesimo, cioè di
resistenza rispetto alla spinta fortissima di istanze (il mercato, la tecnica, certi assolutismi religiosi,
un determinato femminismo post-modernista) che lavorano di fatto per la costruzione di un mondo
post-umano”.
Nell’ottica di questo neo-umanesimo appaiono inadeguate e incomplete tanto la teoria della
“uguaglianza formale” fra uomo e donna, quanto la teoria della “differenza esclusiva” della
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
donna; da qui l’ipotesi di Ercolani di una logica fondata sulla “in-differenza inclusiva”, per dire il
fondamento comune che lega uomini e donne e la differenza che li specifica nel modo di sentire,
pensare e agire.
1. 8. Un’ambivalenza da considerare
Da quanto detto dovrebbe risultare evidente che il superamento della misoginia reclama
certamente la denuncia di questo pregiudizio, della sua insostenibilità, ed è operazione che
Ercolani fa in modo accattivante e documentato nel citato libro che meritatamente sta avendo un
notevole successo editoriale. E, tuttavia, si vorrebbe osservare che la storia delle donne non è
contrassegnata solo dal disprezzo nei loro confronti ma anche da apprezzamento, non solo da
derisione ma anche da valorizzazione, non solo da misconoscimento ma anche da riconoscimento, e
delle due linee è importante che la seconda (seppur minoritaria) sia ricordata, non per dimenticare
la prima (indubbiamente più diffusa), ma per evidenziare che c’è una ambivalenza di
atteggiamento nei riguardi della donna.
Si può acconsentire che la misoginia sia stata prevalente, ma questo non consente che non si faccia
riferimento anche alla considerazione positiva delle donne che pure c’è stata sotto forme diverse in
ogni epoca. E’ bene ricordarlo, perché se si vuole superare la misoginia, può tornare utile muovere
proprio da impostazioni che si sono sottratte alla misoginia o che l’hanno combattuta: sono
impostazioni che, pur minoritarie, ci sono state, e hanno anticipato, pur con toni diversi e magari
senza successo, il pensiero femminista e femminile, i movimenti femministi e femminili, per cui si
può evidenziare la necessità di scegliere se andare in una direzione (femminista) piuttosto che in
un’altra (antifemminista); una responsabilità che le persone e le istituzioni sono chiamate ad
assumersi.
Occorre, quindi, prendere coscienza che il giudizio monoliticamente negativo come anche quello
all’insegna dell’ambivalenza hanno fatto il loro tempo: e, per prendere le distanze da essi, torna
necessario conoscerli come fenomeni storici e teoretici. E se la valutazione negativa sembra ormai
appartenere ad altri tempi, la posizione in cui il positivo e il negativo convivono è a tutt’oggi
presente, e bisognerà con questa misurarsi per non continuare a ferire la dignità della donna e
l’unità del genere umano, come ebbe a dire Giovanni Paolo II nel Giubileo del Duemila.
Emblematico della “ambivalenza” verso la donna è stato proprio l’atteggiamento della Chiesa
cattolica: ricordarlo può servire a immunizzare da questa impostazione, che si muove su un duplice
binario: basti pensare a due figure come Eva e Maria; un’ambivalenza che nel tempo si è
sviluppata, per un verso, attraverso la misoginia fino alla caccia alle streghe e, per altro verso,
mediante il culto mariano fino alla credenza in ripetute apparizioni della Madonna. Dunque,
ambivalente la posizione nei confronti della donna: madre peccatrice dell’umanità (“maledetta
Eva”) e madre immacolata del Redentore (“benedetta Maria”). L’ambivalenza può essere
semplificata ulteriormente attraverso i quattro Vangeli canonici, in cui Gesù rivoluziona
l’atteggiamento nei confronti delle donne, e attraverso il Vangelo di Tommaso (considerato
apocrifo) dove è scritto che Simone Pietro, rivolgendosi ai discepoli che chiedevano informazioni
sulla venuta del Regno di Dio, diceva: “Maria si allontani di mezzo a noi, perché le donne non sono
degne della Vita”.
Tale ambivalenza è presente anche in san Paolo, il quale nella Lettera ai Galati (3, 28) afferma
perentoriamente: “non c’è Giudeo né Greco, né uomo né donna, né schiavo né libero, ma tutti siete
Uno in Cristo Gesù”, ma lo stesso Paolo (nella 1 Lettera ai Corinzi 14, 35) con altrettanta decisione
sostiene: “come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro
permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la Legge” (14, 34) e aggiunge: “se
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti, perché è sconveniente per una
donna parlare in assemblea”. Nella stessa lettera aveva precisato che “l'uomo non deve coprirsi il
capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non
l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo; né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna
per l'uomo. Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza” (11,7).
L’atteggiamento di san Paolo - che si può sintetizzare con le parole della I Lettera a Timoteo (2,
12), in cui sostiene: “la donna impari in silenzio, in piena sottomissione” - torna nei Padri della
Chiesa: da Clemente Alessandrino a Tertulliano, da Origene a sant’Ambrogio, da sant’Agostino a
san Gerolamo, da Oddone da Cluny a san Tommaso d’Aquino.
Ma veniamo a tempi più recenti, e l’ambivalenza si può esemplificare in due papi: Pio IX e
Giovanni XXIII, e in due Concili: il Vaticano I e il Vaticano II. Solo a partire da quest’ultimo si è
determinata una vera e propria svolta verso una considerazione sempre più positiva nei confronti
della donna: infatti si assisterà tanto a una rinnovata attenzione del magistero pontificio per le
donne, quanto a un inedito impegno delle donne filosofe e teologhe.
Così Paolo VI firma il Messaggio alle donne dei Padri conciliari (1965); Giovanni Paolo II è autore
dei principali documenti del rinnovamento: dalla lettera apostolica Mulieris dignitatem (1988) alla
Lettera alle donne (1995), alla preghiera universale della Giornata del perdono: Confessione dei
peccati che hanno ferito la dignità della donna e l’unità del genere umano (2000); Benedetto XVI,
nel ventennale della Mulieris dignitatem, rivolge un discorso ai partecipanti del Convegno “Uomo e
donna” (2008); infine papa Francesco intitola una sua raccolta di scritti, discorsi, omelie La Chiesa
è donna (2016).
In parallelo si è sviluppato tutto un filone teologico al femminile, di cui si sono avute diverse
ricostruzioni e valutazioni: così Lucetta Scaraffia, in dialogo con Giulia Galeotti, parla de La Chiesa
delle donne, e Adriana Valerio in Donne e Chiesa ne fa una storia di genere, e si arriva a chiedere
di andare al di là del “genio femminile”, per dirla con Benedetta Selene Zorzi nell’omonimo libro
dedicato a Donne e genere nella storia della teologia cristiana; così nel volume collettaneo Donne
e teologia, dove si traccia un bilancio di un secolo; o nel volume Teologhe in Europa di Marinella
Perroni e Sandra Mazzolini; o nel volume curato da Maria Agnese Fortuna: Donne e teologia in
Italia; così infine nel volume Teologhe in Italia, dove a cura di Sergio Tanzarella e Anna Corfora
viene presentata una indagine su quella che viene efficacemente definita una tenace minoranza, che
ha denunciato vistose omissioni teologiche.
Infatti si è cominciato a parlare non solo di padri della Chiesa ma anche di madri della Chiesa
(anche se non hanno dato luogo a una “matristica”, rileva Adriana Valerio); non solo di padri del
Concilio ma anche di madri del Concilio (a proposito delle 23 donne “uditrici” al Vaticano II); non
solo di padri del Sinodo (quello recente sulla famiglia) ma anche di madri del Sinodo (quelle poche
che sono state invitate a parteciparvi, magari “dall’ultimo banco”). Ma, soprattutto, non ci sono più
solo dottori della Chiesa bensì anche donne dottori della Chiesa: a partire da Paolo VI e, nel giro
di pochi anni, ne sono state proclamate 4 (Ildegarda di Bingen, Caterina da Siena, Teresa d’Avila e
Teresa di Lisieux), che si aggiungono ai 32 dottori uomini.
Dunque, quella delle teologhe è minoranza certo, ma tenace, e addirittura portatrice di un nuovi
paradigmi. Ed è impostazione che, prima ancora, sono rinvenibili nelle tante filosofe (femministe e
femminili) che caratterizzano il ‘900. Pur nella loro diversità, sono tutte accomunate da una linea di
tendenza: il superamento del paradigma androcentrico. In alternativa si configurano paradigmi
femministi e femminili, paradigmi laici e religiosi, paradigmi escludenti e includenti, paradigmi
della eguaglianza e della differenza, paradigmi dell’assimilazione e delle differenze.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
La semplice elencazione di alcuni dei paradigmi che animano il pensiero delle donne tanto filosofe
quanto teologhe dà una idea del variegato panorama di tale pensiero: della sua ricchezza e della sua
complessità nella sua articolazione diacronica e sincronica, che rende sempre più evidente la
insostenibilità della inferiorità della donna e della sua soggezione: concezioni che appaiono oggi del
tutto risibili da un punto di vista teorico o teoretico, ma che nascostamente continuano ad alimentare
comportamenti e atteggiamenti maschilisti: solo estirpando quel pregiudizio sarà possibile tagliare
le unghie al gatto della violenza dell’uomo sulla donna.
1. 9. Senza concludere
Vorrei terminare (ma senza concludere) richiamando la necessità di fuoriuscire da una logica che
vede le donne monopolizzare la questione femminile: ciò dà luogo a quella che Paolo Ercolani
definisce una “etica della riserva indiana” vale a dire, per usare le parole della filosofa americana
Martha Nussbaum, “la tendenza a ritenere che soltanto chi appartiene a un gruppo
particolarmente oppresso possa scrivere e forse anche leggere correttamente le esperienze di quel
gruppo”.
Siamo invece convinti che la questione femminile è questione antropologica e, quindi non riguarda
solo la donna e non coinvolge solo le donne; questo è accaduto in passato ed è servito a porre in
termini di rottura la questione della donna. Perpetuare oggi quell’atteggiamento significa sottrarlo
alla sua effettiva portata: sia perché le conseguenze del femminismo riguardano non solo la
condizione femminile ma pure quella maschile, sia perché è tempo ormai di responsabilizzare alla
questione anche gli uomini a partire dai pensatori, sia perché risulta ormai opportuno che la
riflessione delle donne sia messa a confronto con il pensiero generale e non solo con quello
femminile e femminista.
Con questa finalità, torna utile ricordare le conquiste del movimento femminista e l’apprezzamento
riscosso dalle filosofe del ‘900, per avviare una riflessione che permetta di ripensare tanto la
condizione femminile quanto la condizione maschile, andando al di là degli stereotipi tradizionali e
aprendo a una visione incentrata sulla “persona” e volta alla sua realizzazione attraverso una
“alleanza” inedita tra uomo e donna: il che reclama una “cultura della collaborazione” per
superare la nuova complessità antropologica, conseguente a inedite forme di fragilità e disagio,
nonché reiterate forme di violenza di genere. Per tutto ciò l’antropologia non può non essere
chiamata in causa, e da molteplici punti di vista, se si vuole inaugurare un ethos umanistico e
umanizzante: tutto ciò richiede una “nuova cultura” (Bianca Gelli).
In tale prospettiva, suona di particolare attualità l’auspicio di Victoria Ocampo, la quale ebbe a
sostenere: “nascerà un’unione, tra l’uomo e la donna, molto più vera, molto più forte, molto più
degna di rispetto. L’unione magnifica di due esseri uguali che si arricchiscono reciprocamente
poiché possiedono ricchezze distinte”. E’, questo, il nuovo traguardo, cui guardare, per cercare di
superare vecchie e nuove forme di violenza contro le donne a partire dal pregiudizio sulla loro
inferiorità nei confronti dell’uomo. Violenza e pregiudizio vanno combattuti, ponendo fine alle
valutazioni negative o ambivalenti che hanno da sempre caratterizzato la storia delle donne: è ormai
tempo di assumere nei loro confronti un atteggiamento univoco: di riconoscimento e di rispetto.
Non devono esserci alternative a questo imperativo.
Bibliografia
Sulla misoginia: Paolo Ercolani, Contro le donne. Storia e critica del più antico pregiudizio,
Marsilio, Venezia 2016; Eraldo Giulianelli, Maledetta Eva. 30 secoli di misoginia religiosa,
Tempesta, Roma 2016; Filippo Maria Battaglia, Stai zitta e va’ in cucina. Breve storia del
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
maschilismo in politica da Togliatti a Grillo, Bollati Boringhieri, Torino 2015; Giovanna Nuvoletti,
Piccolo manuale di misoginia, Corriere della sera, Milano 2014; Michela Marzano, Sii bella e stai
zitta. Perché l’Italia di oggi offende le donne, Mondadori, Milano 2012; Bianca Gelli, Psicologia
della differenza di genere. Soggettività femminili tra vecchi pregiudizi e nuova cultura, Angeli,
Milano 2009; Paolo Orvieto, L’inferiorità della donna nel pensiero moderno, Salerno, Roma 2002;
Jean-Marie Aubert, La donna. Antifemminismo e cristianesimo, Cittadella, Assisi 1976; Aa. Vv.,
Crisi dell’antifemminismo, Mondadori, Milano 1973.
Sulla violenza sulle donne: Barbara Spinelli, Femminicidio. Dalla denuncia sociale al
riconoscimento giuridico internazionale, Franco Angeli, Milano 2008; Cristina Karadole,
Femicidio: la forma più estrema di violenza contro le donne, in “Rivista di Criminologia,
Vittimologia e Sicurezza”, 2012, IV, pp.16-38; Daniela Danna, Ginocidio. La violenza contro le
donne nell’era globale, Elèuthera, Milano 2007.
Sul femminile: Aa. Vv., Sensibili guerriere. Sulla forza femminile, a c. di Federica Giardini,
Jacobelli, Roma 2011 Aa. Vv., Sul femminile. Scritti di antropologia e religione, a c. di Michele
D’Ambra, Città Aperta, Troina 2004; Anna M. Donnarumma, Guardando il mondo con occhi di
donna. Dalla Dichiarazione universale dei Diritti umani (1948) alla Conferenza mondiale delle
donne (1995), EMI, Bologna 1998; Aa. Vv., Che differenza c’è? Fondamenti antropologici e
teologici dell’identità femminile e maschile, a c. di Cettina Militello, SEI, Torino 1996; Aa. Vv., Il
femminile tra potenza e potere, Arlem, Roma 1995; Nadia Fusini, Uomini e donne. Una fratellanza
inquieta, Donzelli, Roma 1995; Angela Ales Bello, Fenomenologia dell’essere umano. Lineamenti
di una filosofia al femminile, Città Nuova, Roma 1992.
Sul femminismo e postfemminismo: Chinamanda N. Adichie, Dovremmo essere tutti femministi,
Einaudi, Torino 2015; Manifesto per un nuovo femminismo, a c. di Maria Grazia Turri, Mumesis,
Milano 2013; Hanna Rosi, La fine del maschio e l’ascesa delle donne, Cavallo di Ferro, 2013;
Valeria Ottonelli, La libertà delle donne. Contro il femminismo moralista, Il Melangolo, Genova
2012; Brigitte Gresy, Breve trattato sul sessismo ordinario. La discriminazione delle donne oggi,
Castelvecchi, Roma 2009; Claudia Mancina, Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista,
Il Mulino, Bologna 2002.
Sulle filosofe del’900: Aa. Vv., Filosofia delle donne, a c. di Nicla Vassallo e Pieranna Garavaso,
Laterza, Roma-Bari 2007; Aa. Vv., La sentinella di Seir. Intellettuali nel ‘900, a c. di Paola Ricci
Sindona, Studium, Roma 2004; Adriana Cavarero - Franco Restaino, Le filosofie femministe, B.
Mondadori, Milano 2002; Maria Camilla Briganti, Amo dunque sono. L’esperienza femminile tra
filosofia e testimonianza, Angeli, Milano 2002; Aa. Vv., Filosofia, ritratti. Corrispondenze, a c. di
Francesca de Vecchi, Tre Lune, Mantova 2001; Chiara Zamboni, La filosofia donna, Demetra,
Verona 1997; Laura Boella, Cuori pensanti, Tre Lune, Mantova 1998; Aa. Vv., Filosofia, donne,
filosofie, atti del convegno internazionale (1992), a cura di Marisa Forcina et al., Milella, Lecce
1994.
Sulle teologhe del ‘900: Teologhe in Italia. Indagine su una tenace minoranza, a cura di Sergio
Tanzarella e Anna Corfora, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2010; Cettina Militello, Volti e storie.
Donne e teologia in Italia, a cura di Maria Agnese Fortuna, Effatà, Cantalupa 2009; Marinella
Perroni e Sandra Mazzolini, Teologhe: in quale Europa?, Effatà, Cantalupa 2008; Aa. Vv., Donne e
teologia. Bilancio di un secolo, a cura di Cettina Militello, EDB, Bologna 2004.
Su filosofia e violenza si vedano: Aa. Vv., Le potenze del filosofare. Logos, tèchne, polemos, a c. di
Laura Sanò, Il Poligrafo, Padova 2007; Giusi Strummiello, Il logos violato. La violenza in filosofia,
Dedalo, Bari 2001.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Sulle filosofe e la violenza: Laura Sanò, Donne e violenza. Filosofia e guerra nel pensiero del ‘900,
postfaz. di Bruna Giacomini, Mimesis, Milano 2012; Valeria Andò, Non violenza e pensiero
femminile. Un dialogo da iniziare, “Senecio”, a c. di Emilio Piccolo e Letizia Lanza, Napoli 2007;
Sara Ruddick, Il pensiero materno. Pacifismo, antimilitarismo, nonviolenza: il pensiero della
differenza per una nuova politica, Red. Como 1993; Aa. Vv., La nonviolenza delle donne, a c. di
Giovanna Providenti, “Quaderni Satyagraha” n. 1.
Sulle donne e il cristianesimo: La donna nel cristianesimo, a cura di Dea Moscarda, Gabrielli, San
Pietro in Cariano 2014; Donna e cristianesimo: ai piedi dell’uomo, “Micromega on line”,
16/9/2014.
Sulle donne e la chiesa: Adriana Valerio, Donne e Chiesa. Una storia di genere, Carocci, Roma
2016; Karl E. Bozzesen, Le madri della Chiesa. Il Medioevo. Risposta matristica alla tradizionale
cultura patriarcale, D’Auria, Napoli 1993; Lucetta Scaraffia, in dialogo con Giulia Galeotti, La
Chiesa delle donne, Città Nuova, Roma 2015; Benedetta Zorzi, Al di là del “genio femminile”.
Donne e genere nella storia della teologia cristiana, Carocci, Roma 2014; Armando Matteo, La
fuga delle quarantenni. Il difficile rapporto delle donne con la Chiesa, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2012; Cettina Militello et al., Paolo e le donne, Cittadella, Assisi 2006.
Sul magistero pontificio sulle donne a partire dal Concilio Vaticano II: Paolo VI, Messaggio alle
donne, 1965; Paolo Bonetti, Paolo VI e le donne e altri temi montiniani, Vivere in, Roma 2009;
Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, lettera enciclica, 1997; La dignità della donna. Scritti di
Giovanni Paolo II sulla questione femminile, a cura di Maria Michela Nicolais, postfaz. di Angela
Ales Bello, Lavoro, Roma 1998; Lettera alle donne, 1995; Confessione dei peccati che hanno ferito
la dignità della donna e l’unità del genere umano, preghiera universale per la Giornata del perdono,
2000; Maria Antonietta Macciocchi, Le donne secondo Wojtyla. Ventinove chiavi di lettura della
“Mulieris dignitatem”, Mondadori, Milano 1992; Lidia Menapace, Il papa chiede perdono. Le
donne glielo accorderanno?, Il Dito e la Luna, Milano 2000; Femminismo cristiano e cultura della
persona. La donna nell’insegnamento di Giovanni Paolo II, Cantagalli, Siena 2012; Benedetto
XVI, Discorso ai partecipanti del convegno “Donna e uomo”, 2008; Papa Francesco, La Chiesa è
donna. Scritti, discorsi, omelie, EDB, Bologna 2016; Lucetta Scaraffia – Giulia Galeotti, Papa
Francesco e le donne, Il sole 24 ore, Milano 2014.
Sulle donne e alcune questioni ecclesiali: Adriana Valerio, Madri del Conciio. Ventitrè donne al
Vaticano II, Carocci, Roma 2012; Marinella Perroni e Hervé Lagrand, Avendo qualcosa da dire.
Teologhe e teologi rileggono il Vaticano II, Paoline, Milano 2014; Cettina Militello, Il sogno del
Concilio, EDB, Bologna 2010; Lucetta Scaraffia, Dall’ultimo banco. La Chiesa, le donne e il
Sinodo, prefaz. di Corrado Augias, Marsilio, Venezia 2016; Simona Segoloni Ruta, Tutta colpa del
Vangelo. Se i cristiani si scoprono femministi, Cittadella, Assisi; Cloe Taddei Ferretti, Anche i
cagnolini. L’ordinazione delle donne nella Chiesa Cattolica, Gabrielli, San Pietro in Cariano 2014.
Sulle donne e il futuro: Aldo Cazzullo, Le donne erediteranno la terra. Il nostro sarà il secolo del
sorpasso, Mondadori, Milano 2016; Paola Diana, La salvezza del mondo. Donne: fattore di
cambiamento del XXI secolo, Castelvecchi, Roma 2016; Myrta Merlino, Madri. Perché saranno
loro a cambiare il nostro Paese, Rizzoli, Milano 2016; Laura Boella, Il coraggio dell’etica. Per una
nuova immaginazione morale, R. Cortina, Milano 2012; Martha Nussbaum Coltivare l’umanità,
Carocci, Roma 1997.
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
Guido Calogero e la “terza persona”
di FRANCESCO POSTORINO
Il trentennale, caduto quest'anno, della morte di uno dei più importanti filosofi italiani del
Novecento, Guido Calogero, può essere l’occasione per ricordare lo spessore della sua ricerca
filosofica e politica, oltre che la sua singolare modernità.
Non tutti possono leggere Guido Calogero. I visitatori occasionali, lo scienziato che cura con
freddezza storiografica le opere altrui e i fanatici di professione farebbero bene a cambiare rotta.
Calogero va vissuto.
A trent’anni dalla morte, avvenuta il 17 aprile del 1986, la sua filosofia continua a esprimere una
vox clamantis in deserto. In un contesto inquinato dal nichilismo e dalla progressiva mercificazione
dell’uomo, andrebbe senz’altro riscoperta la sua innovativa lezione pedagogica. In ogni modo,
come ricorda Serge Audier in Le socialisme libéral, le sue riflessioni anticipano l’etica del discorso
di Karl-Otto Apel, l’etica della discussione di Jürgen Habermas e il metodo dialogico del liberal
Bruce Ackerman. In una recensione pubblicata sull’«Unità» il 23 marzo del ‘97, Stefano
Petrucciani scorge una certa affinità tra il suo liberalsocialismo e l’idea di «libertà positiva»
avanzata in tempi più recenti dall’economista Amartya Sen. E Norberto Bobbio, in una sua
testimonianza, lo accosta al neo-contrattualismo rawlsiano. Per comprendere in profondità il suo
pensiero occorre, tuttavia, rimanere in Italia.
Calogero nasce a Roma nel 1904, dove si laurea a 21 anni in filosofia sotto la guida di Giovanni
Gentile e con una tesi importante dal titolo “I fondamenti della logica aristotelica”. Manterrà
sempre un rapporto di amicizia con il suo maestro e, contrariamente al suo futuro amico Aldo
Capitini, presta giuramento al regime. Nel ’34 diviene titolare della cattedra di Storia della filosofia
alla Normale di Pisa e in seguito insegnerà all’Istituto Magistrale di Firenze. Verso la fine degli
anni ’30, insieme al profeta della nonviolenza e ad altri gruppi liberali e comunisti, avvia una lotta
intensa alla dittatura fascista. Nel ’37 si laurea anche in Giurisprudenza, e con la moglie Maria
Comandini inaugura nel ’47 la prima scuola laica per assistenti sociali.
A partire dalla metà degli anni ’20, elabora un pensiero in stretta sintonia con l’idealismo italiano.
Si definisce, infatti, «figlio spirituale» di Gentile e non cela una forte ammirazione nei confronti di
Benedetto Croce. I suoi primi studi aristotelici mostrano però un allontanamento dall’attualismo
gentiliano e una incompatibilità con l’interpretazione crociana dei «distinti». La filosofia dell’atto
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
denuncia con acume il metodo cartesiano, il dualismo e la dialettica platonica del «pensato», ma a
suo parere ripropone una logica che non tiene conto della pura appercezione, dell’intuizione
intellettuale, della noésis. L’obiettivo di Calogero, sottolinea Évelyne Buissière, è quello di liberare
una volta per tutte il pensiero da ogni presupposto ontologico e gnoseologico.
Lo dirà in maniera chiara nelle sue Lezioni di filosofia maturate negli anni ’40, ove si sostiene che
l’«io» è una soggettività irriducibile, «l’immediato nome del mio sentirmi vivo, del mio esserci al
mondo e del mio volere ciò a cui aspiro». L’«io» è un pronome che non può essere vinto, ed è la
vera storia dell’uomo, lievitata da una libertà trascendentale che non conosce pause e confini.
Nel suo celebre volume La scuola dell’uomo del ’39, adotta una peculiare grammatica diretta a
svegliare le coscienze. L’ingenuo positivismo, la vocazione imperiale, il nozionismo scolastico, il
modello “ordine e disciplina” devono cedere il passo a un altro indirizzo pedagogico. La domanda
socratica, rilanciata il secolo scorso dal filosofo ceco Jan Patočka, deve visitare il cuore e la mente
dell’insegnante. L’opera di chi soffre per ogni forma di povertà e ancora il dramma della verità, che
dovrebbe assalire chiunque e soprattutto chi svolge incarichi di responsabilità costituiscono le armi
essenziali per fronteggiare ogni germe totalitario.
Il fascismo muore nelle anime laiche che non ignorano la vita giusta, la rettitudine intellettuale, gli
ideali di pace. La dittatura, in altri termini, si sconfigge quando si regala un motivo di empatia al
nostro vicino, quando un professore sfugge alla burocrazia e osserva le sfumature di ogni volto,
quando si offre il «tu» con afflato morale e ci si riconosce membri liberi, eguali e razionali sullo
sfondo di uno Stato di diritto.
L’«io», come si è detto, gode di una libertà perenne, ma la sua libertà è asettica, abita in una
insipida trascendenza se non si stupisce nell’ascolto del «tu». Nell’idea di Calogero solo il «tu» può
guarirci dalla nostra solitudine, dalle inquietudini, dalla nostra incomprensione e dal pericolo della
tirannide.
Calogero vuole trasformare la libertà «adiafora» del singolo in una perfetta libertà dal respiro etico.
La tensione problematica fra il soggetto educatore («io») e l’educando («tu») s’innesca allorché il
primo si rende conto che esiste una volontà più importante da salvaguardare, quella dell’altro. La
scelta altruistica dell’«io» non indietreggia, al contrario si irrobustisce, diviene più nitida
disegnando lo spazio culturale entro cui il nuovo pronome (il «tu») proverà a raccontare se stesso, a
narrare la sua biografia, a scegliere finalmente la propria vita senza che un dominus possa
violentarne le aspettative.
Nella sua Scuola dell’uomo, Calogero suggerisce l’importanza del «lui». Non solo l’«io» ma anche
il «tu» appena istituzionalizzato ha un dovere da compiere. La vita non si arresta in un giuoco
dialettico fra due protagonisti, due entità, due culture, in quanto occorre focalizzare l’attenzione
sulla terza voce.
Il dialogo, dirà in un saggio del ’62, rappresenta l’unica verità ineccepibile, mentre ogni logos deve
essere sottoposto a revisione. La «capacità di intendere» è la spinta del divenire, la terapia contro
quel Dasein gettato nel mondo senza un perché. Non basta legittimare il «tu», il tuo vicino di casa,
la tua compagnia, il tuo Paese. Bisogna guardare oltre, lanciare uno sguardo solido nelle terre del
nessuno e scoprire la «terza persona».
Nel primo Manifesto del liberalsocialismo redatto da Calogero e pubblicato nel ’40, vengono ripresi
questi strumenti concettuali. Una buona politica si fonda per l’appunto sull’«eterno riferimento alla
IL RASOIO DI OCCAM – numero 3 – ottobre 2016
terza persona». Il liberalsocialismo è la fervida opportunità di avviare un’opera di riconoscimento a
beneficio del «tu» e del «lui».
Calogero sfida storicamente il liberalismo crociano e il materialismo dialettico. In Difesa del
liberalsocialismo del 1945, scrive ad esempio che Croce enfatizza colpevolmente il valore della
libertà a scapito della giustizia, mentre i discepoli di Marx fanno l’esatto contrario. La sua cultura
liberale, vicina al laburismo inglese, sente la questione sociale a differenza dei liberali puri alla
Kenneth Minogue, ma ripudia l’egualitarismo fazioso. Il suo liberalsocialismo non andrebbe
identificato con il liberalismo sociale di Guido de Ruggiero e neppure con il socialismo liberale di
Carlo Rosselli. Si tratta di una visione politica che intende rimuovere la categoria dei sottoindividui, abbracciando in un unico rapporto dialettico la libertà liberale e quella materiale.
L’impulso religioso che accompagna l’ideologia politica di Capitini viene accolto con riserve.
Calogero riconosce un indubbio valore nell’azione nonviolenta. Anzi, si spinge a tal punto da
condividere la scelta di chi non difende se stesso in nome di un alto principio, ma condanna colui
che non fa nulla per proteggere la propria moglie, il proprio figlio, il proprio padre, il proprio amico
o un estraneo indifeso (il «lui»), qualora le circostanze lo dovessero richiedere. Se il primo
nonviolento è un «eroe», il secondo è un «vigliacco».
Egli fonda nel ‘42 il Partito d’Azione insieme ad altre figure autorevoli quali Piero Calamandrei,
Ugo La Malfa, Tommaso Fiore, Norberto Bobbio e Adolfo Omodeo. L’intenzione è anzitutto quella
di coltivare una terza via tra il liberalismo conservatore e il comunismo ortodosso, ma questo
soggetto politico si spegnerà cinque anni più tardi.
Calogero difenderà fino alla fine la sua filosofia dialogica e riprende in modo critico la concezione
democratica di John Dewey, di cui nel 1959 traduce l’opera A commun Faith. In Le regole della
democrazia e le ragioni del socialismo del ’68, insiste sul valore universale e «comunicativo» della
democrazia, sull’impegno morale in favore della giustizia e sull’identità fra liberalismo e
socialismo.
Il suo è un liberalsocialismo del «tu», del «lui» e mai di se stesso. Il «tu», una volta riconosciuto,
deve proseguire l’opera infaticabile del primo «io». L’«io» e il «tu», quindi, non esauriscono il
linguaggio etico perché c’è sempre un altro pronome non identificato che rivendica con timidezza la
qualifica del sui iuris.
Sono innumerevoli i «lui» sparsi nel Pianeta. Gli sfruttati di ogni colore chiedono tutela e vogliono
il «tu», ma il nostro «io» si addormenta nella contingenza e insegue la retorica delle consuetudini,
per dirla con Carlo Michelstaedter. Il «tu» è facile individuarlo oggi, dato che spesso è figlio di un
meccanismo opportunistico, di un vizio di mercato, di un atto oneroso. Il riconoscimento del nuovo
«tu», lungi dall’alleviare il dolore sociale, è oramai dettato da un circolo perverso che ferisce la
purezza e il dono del gratuito. Il Gott ist tot e l’esaltazione capitalistica dell’esistenza tradiscono la
speranza progressista della scuola dell’uomo e rinviano l’appuntamento con la «terza persona».