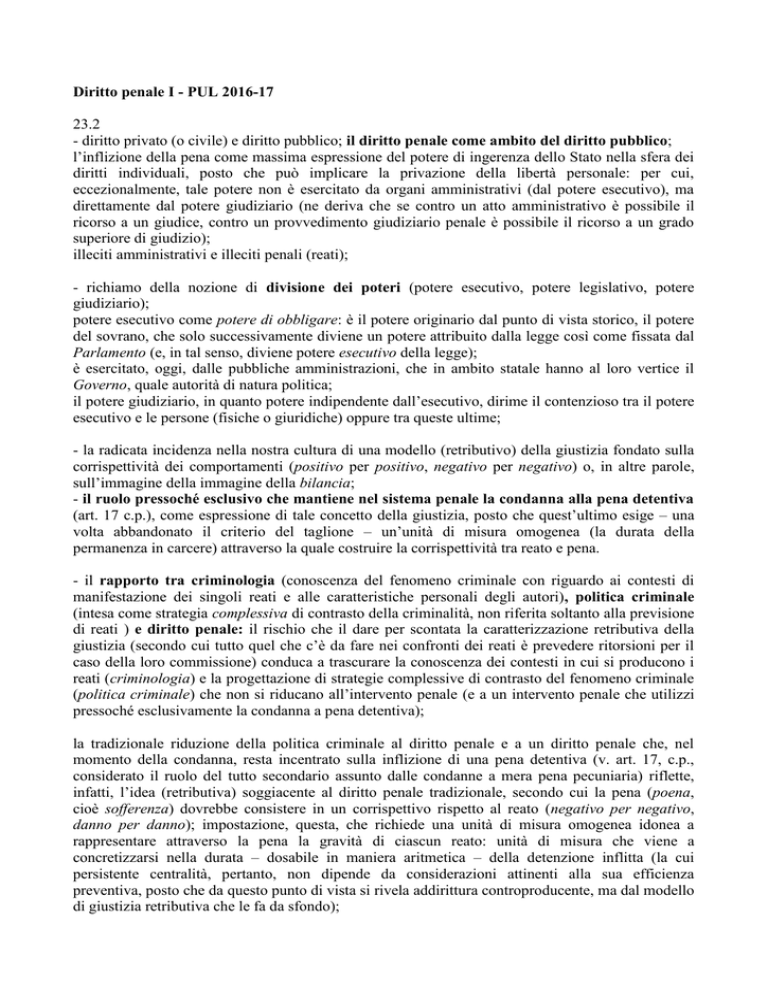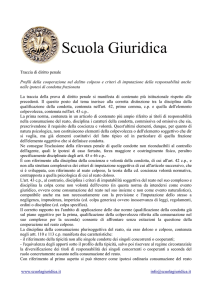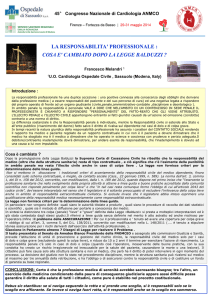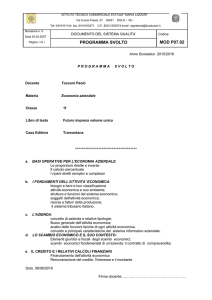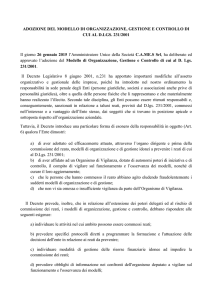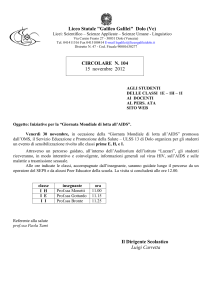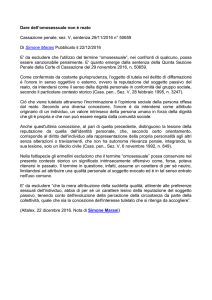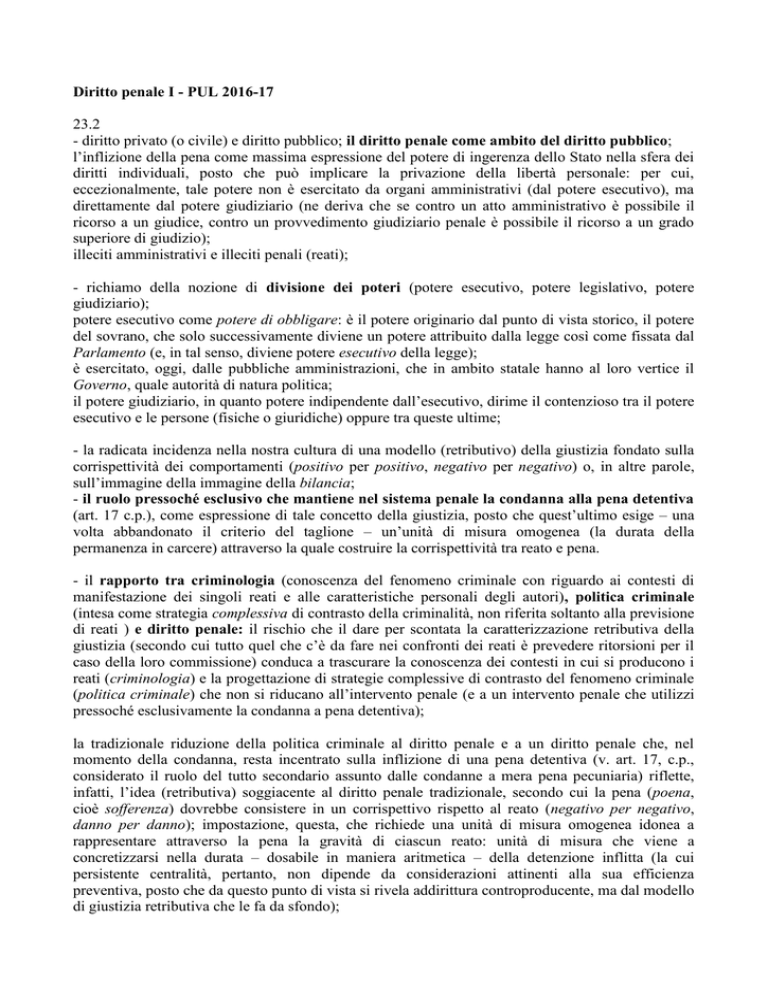
Diritto penale I - PUL 2016-17
23.2
- diritto privato (o civile) e diritto pubblico; il diritto penale come ambito del diritto pubblico;
l’inflizione della pena come massima espressione del potere di ingerenza dello Stato nella sfera dei
diritti individuali, posto che può implicare la privazione della libertà personale: per cui,
eccezionalmente, tale potere non è esercitato da organi amministrativi (dal potere esecutivo), ma
direttamente dal potere giudiziario (ne deriva che se contro un atto amministrativo è possibile il
ricorso a un giudice, contro un provvedimento giudiziario penale è possibile il ricorso a un grado
superiore di giudizio);
illeciti amministrativi e illeciti penali (reati);
- richiamo della nozione di divisione dei poteri (potere esecutivo, potere legislativo, potere
giudiziario);
potere esecutivo come potere di obbligare: è il potere originario dal punto di vista storico, il potere
del sovrano, che solo successivamente diviene un potere attribuito dalla legge così come fissata dal
Parlamento (e, in tal senso, diviene potere esecutivo della legge);
è esercitato, oggi, dalle pubbliche amministrazioni, che in ambito statale hanno al loro vertice il
Governo, quale autorità di natura politica;
il potere giudiziario, in quanto potere indipendente dall’esecutivo, dirime il contenzioso tra il potere
esecutivo e le persone (fisiche o giuridiche) oppure tra queste ultime;
- la radicata incidenza nella nostra cultura di una modello (retributivo) della giustizia fondato sulla
corrispettività dei comportamenti (positivo per positivo, negativo per negativo) o, in altre parole,
sull’immagine della immagine della bilancia;
- il ruolo pressoché esclusivo che mantiene nel sistema penale la condanna alla pena detentiva
(art. 17 c.p.), come espressione di tale concetto della giustizia, posto che quest’ultimo esige – una
volta abbandonato il criterio del taglione – un’unità di misura omogenea (la durata della
permanenza in carcere) attraverso la quale costruire la corrispettività tra reato e pena.
- il rapporto tra criminologia (conoscenza del fenomeno criminale con riguardo ai contesti di
manifestazione dei singoli reati e alle caratteristiche personali degli autori), politica criminale
(intesa come strategia complessiva di contrasto della criminalità, non riferita soltanto alla previsione
di reati ) e diritto penale: il rischio che il dare per scontata la caratterizzazione retributiva della
giustizia (secondo cui tutto quel che c’è da fare nei confronti dei reati è prevedere ritorsioni per il
caso della loro commissione) conduca a trascurare la conoscenza dei contesti in cui si producono i
reati (criminologia) e la progettazione di strategie complessive di contrasto del fenomeno criminale
(politica criminale) che non si riducano all’intervento penale (e a un intervento penale che utilizzi
pressoché esclusivamente la condanna a pena detentiva);
la tradizionale riduzione della politica criminale al diritto penale e a un diritto penale che, nel
momento della condanna, resta incentrato sulla inflizione di una pena detentiva (v. art. 17, c.p.,
considerato il ruolo del tutto secondario assunto dalle condanne a mera pena pecuniaria) riflette,
infatti, l’idea (retributiva) soggiacente al diritto penale tradizionale, secondo cui la pena (poena,
cioè sofferenza) dovrebbe consistere in un corrispettivo rispetto al reato (negativo per negativo,
danno per danno); impostazione, questa, che richiede una unità di misura omogenea idonea a
rappresentare attraverso la pena la gravità di ciascun reato: unità di misura che viene a
concretizzarsi nella durata – dosabile in maniera aritmetica – della detenzione inflitta (la cui
persistente centralità, pertanto, non dipende da considerazioni attinenti alla sua efficienza
preventiva, posto che da questo punto di vista si rivela addirittura controproducente, ma dal modello
di giustizia retributiva che le fa da sfondo);
se ne deduce il fatto che la pena non è intesa, nel momento della condanna, come un progetto,
significativo per il suo destinatario e per il suo rapporto con la persona offesa e con la società, ma,
per l’appunto, come un corrispettivo essenzialmente riferito alla gravità del reato (v. infra il
commento all’art. 133 c.p.): così che solo dopo la sua inflizione si vorrebbe piegare la condanna (v.
infra) ad assumere effetti rieducativi, come richiede l’art. 27, comma 3, Cost.; del resto, il giudice
che condanna non applica la pena sulla base di una conoscenza della personalità dell’imputato,
stante la preclusione di perizie sulla medesima ai sensi dell’art. 220, comma 2, c.p.p. (la portata
garantistica di tale norma, rivolta a evitare che il giudice possa rimanere influenzato da simili
perizie nella valutazione dei fatti e delle responsabilità, potrebbe pur sempre rimanere salvaguardata
ove le perizie di cui s’è detto fossero ammesse solo dopo le conclusioni sulla colpevolezza e,
dunque, ai soli fini della determinazione della pena, secondo prospettiva del c.d. processo bifasico);
- gli effetti di questa situazione sulla tradizionale marginalità sia degli studi criminologici sulle
forme di manifestazione dei reati, sia della progettazione politico-criminale: come se si desse per
scontato che la risposta ai reati consista semplicemente nel prevedere dei corrispettivi sanzionatòri,
così che, ai fini giuridici, quegli studi e quella progettazione risulterebbero sostanzialmente inutili;
il che continua a comportare, soprattutto, una forte disattenzione nei confronti della prevenzione
primaria, attinente al contrasto dei fattori (personali, economici, culturali, ecc.) che favoriscono la
criminalità (v. infra);
- la carenza di una seria progettazione politico-criminale è peraltro favorita, altresì, dalla caduta di
ruolo, cui si assiste da anni non solo in Italia, del potere legislativo rispetto a quello esecutivo e a
quello giudiziario; il sostanziale controllo dei governi sui parlamenti e sulla stessa elaborazione
legislativa riduce, infatti, gli spazi di una progettazione politico-criminale di ampio respiro e di
lungo periodo, quale dovrebbe essere propria dell’iniziativa parlamentare, in favore di proposte
legislative legate a situazioni contingenti e proclivi a perseguire il consenso dell’opinione pubblica
(attraverso letture semplificate del fenomeno criminale da parte del mass-media) per fini elettorali
(il c.d. populismo penale): con ciò trovando incentivo, per esempio, il continuo aumento delle pene
edittali (soprattutto nei minimi, non gestibili dal giudice, così da precludere l’applicabilità della
sospensione condizionale, dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione
domiciliare), come pure il ricorso ai reati colposi di evento, l’esclusione del giudizio di prevalenza
ed equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti o le restrizioni nell’accesso ai c.d. benefici
penitenziari;
- ne deriva, inoltre, il dilatarsi dei casi in cui la descrizione delle condotte penalmente significative
resta alquanto generica o ricorre a concetti-valvola che, di fatto, consegnano la definizione dei
confini di ciò che sia da ritenersi rilevante dal punto di vista penale alla giurisprudenza; ma anche il
dilatarsi dei casi in cui la giurisprudenza tende ad assumere un ruolo di supplenza rispetto al
legislatore, attraverso letture delle norme penali che sembrano oltrepassare i confini
dell’interpretazione, per collocarsi nell’ambito del ricorso all’analogia in malam partem. Con una
palese tensione tra il c.d. diritto vivente giurisprudenziale, da un lato, e i principi di determinatezza
delle fattispecie penali e di riserva di legge (v. infra), dall’altro;
- critica della nozione di giustizia (retributiva) fondata sul concetto di corrispettività, vale a
dire intesa come reciprocità dei comportamenti (come «bilancia»);
il rischio che il suddetto modello della giustizia fornisca un alibi all’agire negativo nei confronti di
chi sia giudicato negativamente (sia esso o meno colpevole);
l’incidenza della medesima nozione di giustizia sul piano storico (per esempio, con riguardo alla
giustificazione della guerra) e nei rapporti sociali: esemplificazioni;
il rischio di un’interpretazione (fallimentare) della vita come continua eliminazione dal nostro
orizzonte delle realtà che giudichiamo negative in quanto ci pongono problemi;
l’alternativa costituita da una giustizia consistente nel rispondere con progetti positivi dinnanzi alle
realtà negative (o alle situazioni personali problematiche);
- la centralità che mantiene nel sistema penale, come già si accennava, la condanna alla pena
detentiva (art. 17 c.p.), come espressione di un concetto di giustizia tuttora incentrato sull’idea di
corrispettività (retribuzione);
- l’immagine alternativa della giustizia che emerge dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, come
agire in modo corrispondente alla dignità umana (al fine di «rimuovere gli ostacoli» che
«impediscono il pieno sviluppo della persona umana»: art. 3, secondo comma): la «dignità sociale»
di ciascuno, e dunque l’atteggiamento richiesto verso ciascun altro, non viene fatto dipendere,
infatti, dal giudizio sulle altrui «condizioni personali e sociali», ma dalla stessa esistenza in vita di
ogni essere umano (art. 3, primo comma) co. 1, quale fondamento del principio di uguaglianza ex
art. 3 Cost.);
l’adempimento, conseguente, dei doveri come presupposto per la sussistenza dei diritti;
- i riflessi controproducenti di una visione retributiva della giustizia con riguardo alla
prevenzione dei reati:
- a) l’indifferenza della visione retributiva rispetto al ruolo centrale che dovrebbe avere l’intervento
sui fattori che favoriscono la criminalità, cioè l’intervento precedente la commissione dei reati
(prevenzione primaria);
la prevenzione primaria nei suoi due livelli:
1) educativo-culturale e politico-sociale (v. infra),
2) relativo alle norme – di settori dell’ordinamento giuridico diverso da quello penale –
specificamente finalizzate a intervenire sui menzionati fattori criminogenetici;
- i motivi delle resistenze constatabili rispetto a un’attuazione efficace della prevenzione primaria,
posto che essa incide su egoismi e interessi diffusi (si pensi all’eliminazione dei paradisi bancari per
ostacolare i traffici della criminalità organizzata, alla tracciabilità dei pagamenti, al ruolo
dell’infedeltà fiscale e della disponibilità di fondi neri, a una buona legge sugli appalti per arginare
la corruzione, all’importanza dei compiti assolti dai servizi sociali, ecc.);
in questo modo, il ricorso al diritto penale tradizionale – che colpisce a posteriori, e solo
sporadicamente (data l’incidenza della c.d. cifra oscura) la tenuta di condotte illecite o la causazione
di eventi offensivi – ha sovente fatto da alibi per la mancata attivazione di interventi idonei a
contrastare gli spazi di praticabilità in concreto delle condotte illecite;
- b) la tradizionale disattenzione del medesimo modello penale al contrasto degli interessi
materiali soggiacenti al reato e, segnatamente, dei profitti conseguiti in modo criminoso
(esemplificazione con riguardo alla confisca dei profitti derivanti da reato, facoltativa ai sensi
dell’art. 240 c.p. e resa obbligatoria solo negli ultimi decenni in determinati ambiti del contrasto
della criminalità organizzata);
c) il nesso tra visione retributiva della giustizia e il modello «negativo» della prevenzione
generale e speciale, che fonda la prevenzione generale sull’intimidazione (o deterrenza) e la
prevenzione speciale sulla neutralizzazione e sull’intimidazione (quali fattori di natura coercitiva);
(si rammenti che la prevenzione generale consiste nel dissuadere la generalità della popolazione
dall’intento di commettere reati e la prevenzione speciale nell’evitare che chi abbia commesso reati
torni a commetterne).
le ragioni dell’inadeguatezza di tale modello:
l’intimidazione, non presupponendo alcuna interiorizzazione del rispetto delle norme, può
funzionare – come può accadere per esempio nel rapporto tra un genitore e un figlio – solo ove
sussista un totale dominio/controllo sui suoi destinatari: ma se tale controllo totale sussistesse,
paradossalmente non vi sarebbe bisogno di pene esemplari (come insegna lo Beccaria), perché già
opererebbe in senso generalpreventivo l’alta probabilità di essere scoperti; in ogni caso, tale
possibilità di controllo totale negli Stati democratici non è possibile e il rischio è che proprio lo
Stato più debole, cioè quello che ha scarse capacità di intercettare le attività criminose, usi la pena
esemplare, ordinariamente nei confronti dei trasgressori più deboli, per nascondere tale debolezza e
riaffermare la sua presenza;
la neutralizzazione apparentemente parrebbe funzionare, mettendo l’agente di reato nella
condizione fisica di non poter nuocere: ma il problema è che se ci si limita a politiche di
neutralizzazione, i posti di lavoro criminale lasciati liberi dai soggetti neutralizzati saranno coperti
da altri soggetti; la criminalità va studiata anche secondo categorie economiche; finché ci sono
opportunità appetibili di trarre beneficio da attività criminose (non adeguatamente contrastate
attraverso la prevenzione primaria), queste verranno percorse e vi sarà chi tenterà di sfruttarle, posto
che la domanda di accesso ad attività criminose lucrative rischia di essere superiore all’offerta:
almeno nella misura in cui non operino nella società forti controspinte culturali nei confronti dei
modelli comportamentali criminosi.
24.2
- la prevenzione generale e speciale intese in senso «positivo», orientate a tenere elevati i livelli
di consenso, cioè di adesione per scelta, al rispetto delle norme, e, dunque, a tenere elevata
l’autorevolezza del messaggio correlato ai precetti penali;
la prevenzione, dunque, dipende soprattutto dalla capacità dell’ordinamento giuridico di ottenere
dai cittadini un’adesione alle sue norme per scelta, e non per timore: in altre parole, non si fonda
tanto su fattori di coazione esterna, fondati sulla forza, bensì, soprattutto, sul consenso;
la contraddittorietà generalpreventiva della pena di morte secondo la riflessione di Cesare Beccaria
(l’inadeguatezza a fungere da criterio orientativo dei comportamenti in sede sociale di una pena
costruita nei suoi contenuti sul modello del reato);
in particolare, la prevenzione speciale positiva in quanto orientata al recupero – secondo la
terminologia dell’art. 27, co. 3, Cost. alla rieducazione – del condannato, cioè a far sì che la
rinuncia a delinquere per il futuro da parte dell’agente di reato dipenda da una scelta personale;
l’incidenza generalpreventiva di un’avvenuta rieducazione, quale fattore di riaffermazione e riconsolidamento dell’autorevolezza della norma violata, derivante, per l’appunto, da un avvenuto
recupero dell’autore di reato, ai sensi dell’art. 27, co. 3, Cost.;
il che corrisponde, del resto, a quanto si evince dalla c.t. teoria delle associazioni differenziali in
E. Sutherland: se è vero che si tende ad agire secondo quanto è approvato nel gruppo in cui si
cerca riconoscimento, il fatto che membri di un gruppo pongano in discussione scelte di tipo
criminoso può divenire «modello» per altri membri;
il problema per cui frequentemente s’è definita in dottrina come prevenzione generale positiva non
già, come s’è illustrato, la prevenzione orientata al consenso, bensì quanto viene proposto dalle
concezioni neo-retributive: il fatto, cioè, per cui la pena dovrebbe soddisfare quel bisogno emotivo
di reazione nei confronti dell’agente di reato che insorgerebbe nei cittadini per continuare a rendere
tabù nella loro psiche il rispetto delle norme trasgredite e, dunque, per reprimere l’impulso a
emulare le condotte criminose (si tratta di un’illustrazione della classica teoria retributiva
utilizzando, in modo discutibile, terminologie di tipo psicoanalitico);
allo scopo di evitare questa confusione terminologica si può descrivere la prevenzione generale
orientata al consenso, secondo la prospettiva sopra illustrata, anche come prevenzione generale
reintegratrice;
- il problema della possibilità di realizzare il consenso su alcuni criteri comportamentali di fondo –
ai fini della prevenzione primaria nel suo primo livello e della prevenzione generale positiva – nelle
società democratiche, pluralistiche e multiculturali;
l’esperienza morale come esperienza tipica e generalizzata degli esseri umani (essa consiste nella
consapevolezza del fatto non ci sono solo questioni rispetto alle quali si tratta di decidere, ma anche
questioni – quelle che di solito riferiamo agli interrogativi sul bene e sul giusto – rispetto alle quali
si tratta di comprendere);
- le cinque critiche logico-razionali nei confronti dell’idea retributiva della giustizia:
1. la non quantificabilità della colpevolezza interiore (possiamo conoscere empiricamente
soltanto i fattori che incidono sull’uso della libertà, non l’uso stesso di quest’ultima);
2. il diritto penale non esaurisce il male presente nella società e, pertanto, non definisce il
confine tra bene e male (l’attribuzione di responsabilità penale non può servire a far sì che la
società si avverta come comunità dei “giusti”, col rischio di utilizzare il condannato come
capro espiatorio del male in essa presente);
3. la visione retributiva trascura il problema della corresponsabilità sociale rispetto ai fattori
che favoriscono la criminalità e, pertanto, il ruolo della prevenzione primaria (solo una
società che non si sente la società dei “giusti” – seconda critica – sarà disponibile ad
assumere i sacrifici necessari –terza critica – per fare prevenzione primaria);
2.3
(prosecuzione)
4. l’inadeguatezza della pena a «cancellare» la realtà del reato e l’improponibilità della visione
(idealistica) hegeliana della pena retributiva come negazione della negazione della legge;
5. l’inesistenza in natura di una pena corrispondente al reato, da considerarsi giusta in sé:
significativamente Hegel segnala la dipendenza materiale della pena retributiva da ciò che
richiede la società in una data epoca storica nei confronti del reato commesso: Hegel, infatti,
considera l’eguaglianza retributiva come meramente ideale (o «di valore»);
ne deriva l’insostenibilità della visione tradizionale secondo cui la pena retributiva, in
quanto pena (ritenuta) giusta, sarebbe in grado di fungere da argine al perseguimento delle
finalità preventive (la garanzia dell’individuo nei confronti della potestà punitiva statuale
dipende, piuttosto, dall’opzione per una prevenzione reintegratrice, piuttosto che
intimidativa e neutralizzativa);
- l’equivoco insito nel pensiero retributivo di Kant (e di Hegel): validità delle premesse: critica
della visione utilitaristica della prevenzione generale e speciale negativa, in quanto orientate a
utilizzare il condannato per fini di intimidazione (esemplarità) e di difesa sociale (neutralizzazione);
inaccettabilità, tuttavia, delle conclusioni di natura retributiva: Kant deriva dalle sue premesse che si
dovrebbe infliggere una pena giusta in quanto non motivata da finalità strumentali di natura
preventiva e ravvisa simile pena, addirittura, nel taglione; non avvertendo che proprio il concepire
la pena come corrispettivo comporta, come s’è visto, un orientamento intimidativo (e
neutralizzativo) della prevenzione; ma altresì non avvertendo che non esiste, come si evince dalla
quinta critica, alcuna pena giusta in sé;
la contraddittorietà, in ogni caso, del concepire, da parte di Kant, l’essere umano come «fine» e
dell’accogliere il taglione come criterio della pena giusta in sé;
si noti che le conclusioni di Kant, forse, sarebbero state diverse ove avesse potuto considerare,
all’epoca in cui scrisse, un’impostazione a sua volta diversa, cioè (come s’è descritto) di natura
positiva, della prevenzione generale e speciale;
- l’incidenza complessa del pensiero della Scuola Positiva, tra ottocento e novecento, quale
corrente antagonista alla concezione retributiva e i profili della sua inaccettabilità;
la visione deterministica del positivismo e la negazione dell’autonomia personale (dunque, della
libertà del volere);
la negazione del concetto di colpevolezza in favore del concetto di pericolosità;
la sostituzione della pena con la misura di sicurezza, secondo il principio «rieducare i rieducabili e
neutralizzare i non rieducabili» (sulla base di un concetto meccanicistico di rieducazione, che riduce
il condannato a oggetto dell’intervento statuale e che sfocia facilmente nella neutralizzazione);
l’utilizzazione delle idee positivistiche da parte dei regimi totalitari;
in particolare, l’approccio di Cesare Lombroso;
la riconoscibilità al positivismo di aver comunque evidenziato l’incidenza di fattori criminogenetici
e l’obiettivo della rieducazione intesa in senso sociale (e non come mera emenda interiore);
le resistenze culturali (anche in Assemblea Costituente) all’accoglimento dell’idea rieducativa,
proprio per il timore dell’apertura al pensiero positivistico e alle ideologie dei paesi totalitari;
- la differenza strutturale tra la prevenzione speciale positiva come sopra illustrata, che valorizza e
non nega l’autonomia (la libertà) individuale, e la concezione rieducativa del positivismo;
potremmo riassumere il ruolo del riferimento alla libertà del volere (all’autonomia della persona)
in ambito penalistico nel modo seguente:
come libertà riferita al passato per giustificare la pena, nella visione retributiva;
come libertà negata nel positivismo;
come libertà riferita al futuro, da riconquistare attraverso nuove scelte personali, nella
prevenzione speciale positiva;
- profili storici dell’approccio al ruolo della pena e del carcere nel secondo dopoguerra: i limiti
di un sistema che si è limitato a ipotizzare una trasformazione in senso rieducativo del carcere,
mantenendone la centralità senza mettere in discussione il modello retributivo della giustizia con
riguardo alla condanna;
- il ruolo dell’ordinamento penitenziario italiano del 1975 (v. infra), che introduce, fra l’altro, l’idea
di una pur contenuta modificabilità della pena, nella durata e nei modi, durante la fase esecutiva;
- il neoconservatorismo penale degli anni ’70-’90, con il connesso revival di impostazioni
retributive e orientate alla deterrenza;
- i segni recenti di apertura alla messa in discussione della modalità tradizionale del condannare, nel
solco di una risposta al reato intesa come «progetto» (o «percorso»), secondo la prospettiva della
giustizia riparativa (restorative justice);
- completiamo, ora, la riflessione sulla giustizia, evidenziando il rapporto fra concezioni della
pena e riferimenti di carattere teologico:
la visione retributiva della giustizia, infatti, ha cercato supporto, oltre che (come s’è visto) nel
pensiero di alcuni importanti filosofi, anche attraverso l’utilizzazione di supposti modelli religiosi:
il che costituisce un equivoco da chiarire:
la lettura corretta, nel contesto storico-culturale, delle pagine veterotestamentarie di natura
legislativa o nelle quali emergono concetti di violenza;
3.3
(prosecuzione)
- la giustizia divina da intendersi, al contrario, nella Bibbia come giustizia salvifica (tzedaka):
sia nell’Antico Testamento (esemplificazioni: i racconti di Adamo e di Caino),
sia nel Nuovo Testamento (la giustizia che si esprime in Gesù come spendita dell’amore dinnanzi al
male, la quale si rivela salvifica nella risurrezione);
l’inutilizzabilità a fini retributivi del riferimento all’inferno, in quanto nozione che indica non una
pena, ma il fallimento (la separazione da Dio) connessa a una chiusura radicale nei confronti della
logica dell’amore, nonostante la disponibilità divina all’accoglienza e al perdono;
illustrazione dei due testi di lettura proposti, a scelta, con riguardo a questa materia: E. Wiesnet,
Pena e retribuzione. La riconciliazione tradita, Giuffré; L. Eusebi, La Chiesa e il problema della
pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica, La Scuola.
si noti il parallelismo che può individuarsi tra la prospettazione biblica di una nozione salvifica
della giustizia non ispirata al modello del corrispettivo e l’immagine della giustizia desumibile dagli
artt. 2 e 3 (v. supra) della Costituzione;
- introduzione al sistema sanzionatorio penale:
- la persistente centralità della pena detentiva (salvo l’ambito aggiuntivo, alternativo o, raramente,
autonomo della pena pecuniaria) in sede di condanna:
sebbene, dunque, l’art. 27, co. 3, Cost. esiga che le pene, sia nella loro definizione legislativa, sia
nella loro applicazione giudiziaria, debbano rispondere all’orientamento rieducativo, la pena
inflitta dal giudice al termine di un processo rimane di fatto concepita quale corrispettivo
aritmetico rispetto al reato commesso; la pena pertanto, in quel momento, non si configura come un
progetto significativo per la persona che dovrà scontarla, né per il suo rapporto con la società e con
l’eventuale vittima;
le stesse condizioni personali dell’imputato rilevano solo se queste ultime siano tali da consentire
l’esclusione dell’imputabilità (o l’attenuante per seminfermità): ove ciò non avvenga, la persona del
condannato, in sostanza, non conta al momento della condanna, stante del resto l’art. 220, co. 2,
c.p.p. (v. infra): né ciò è smentito come subito si vedrà, nonostante le apparenze, dall’art. 133, co. 2,
c.p.;
il nostro sistema sanzionatorio penale si configura dunque, in certo modo, come un sistema a
clessidra: tutti i reati confluiscono nella condanna a una pena detentiva (e/o pecuniaria), salva la
possibilità, solo dopo la condanna, di non applicare in tutto o in parte la condanna stessa nella
forma detentiva (v. infra);
- la determinazione della pena in sede di condanna ai sensi degli artt. 132 (che affida al giudice
una discrezionalità con obbligo di motivazione) e 133 c.p.;
- i due parametri indicati dall’art. 133 c.p. circa la determinazione giudiziaria della pena: la
nozione di gravità del reato (co. 1) e l’ambiguità della nozione di capacità a delinquere (co. 2); il
«compromesso», in tal senso, fra utilizzo di elementi della «Scuola classica» e utilizzo di elementi
della «Scuola positiva»;
- quattro profili critici riferibili all’art. 133 c.p., e in particolare al concetto di capacità a delinquere:
a) indica gli indici da tenere in considerazione, ma non dice in che modo (cioè secondo quali
finalità);
b) non offre strumenti per acquisire dati riguardanti la personalità dell’imputato, come invece
richiederebbe, per molti dei suoi aspetti, il concetto di capacità a delinquere: l’art. 220, co. 2,
c.p.p., infatti, non consente perizie sul carattere e sulla personalità dell’imputato nonché, in
genere, sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche; da cui l’irrilevanza sostanziale
della personalità nel momento di inflizione della pena, salvo che ai fini di un’esclusione
dell’imputabilità (si noti che l’art. 220, co. 2, ha una motivazione garantistica, in quando intende
evitare che il giudice possa rimanere influenzato da simili perizie nella valutazione dei fatti e delle
responsabilità: tale sua finalità, tuttavia, potrebbe pur sempre rimanere salvaguardata ove le perizie
di cui s’è detto fossero ammesse solo dopo le conclusioni sulla colpevolezza e, dunque, ai soli fini
della determinazione della pena, secondo prospettiva del c.d. processo bifasico);
c) di quei dati, comunque, il giudice potrebbe tener conto solo dal punto di vista aritmetico, e non
secondo una logica progettuale (dal che la terminologia invalsa di «commisurazione» della pena):
avrebbe senso, in altre parole, tener conto della personalità e del contesto di vita dell’imputato se il
giudice avesse uno spazio di costruzione della risposta sanzionatoria che investa i suoi contenuti;
d) il concetto di «capacità a delinquere» rischia, infine, di permettere aumenti di pena all’interno
dello spazio edittale in forza di fattori (della personalità, del carattere o dell’ambiente di vita del
soggetto agente) estranei al fatto colpevole: rischia, cioè, di aprire a logiche incostituzionali di c.d.
colpa d’autore;
ne deriva che il giudice, per valutare la colpevolezza ai fini della determinazione della pena, può
utilizzare solo fattori personali o contestuali che abbiano inciso sul fatto commesso e siano
pertinenti rispetto alla responsabilità del soggetto agente nei confronti di quel fatto (si parla in tal
senso di colpevolezza «del fatto»);
potrebbe ammettersi, invece, l’utilizzo di fattori estranei al fatto (per esempio concernenti la salute)
in senso favorevole all’imputato, nella misura in cui ciò non rappresenti una discriminazione, ma
risponda a esigenze di garanzia del principio di uguaglianza inteso in senso sostanziale;
in questo senso, il concetto di capacità a delinquere ai fini della determinazione della pena va inteso
come riferito alla capacità a delinquere che può ritenersi espressa nel fatto di reato, e non come
capacità a delinquere intesa come previsione sulla capacità futura di commettere nuovi reati in base
alle caratteristiche personali del condannato (cioè come pericolosità);
l’intera problematica evidenzia, pertanto, gli intenti repressivi che erano propri del codice Rocco:
volti a permettere l’utilizzo da parte del giudice (anche) di valutazioni – svincolate dal fatto –
inerenti alla personalità del condannato, onde appesantire l’intervento sanzionatorio (al che si
aggiungeva l’applicabilità ulteriore (obbligatoria per i reati non lievi) di una misura di sicurezza da
eseguirsi dopo la pena);
si tratta di intenti repressivi che trovano conferma, sempre attraverso il «compromesso» tra Scuola
classica e Scuola positiva, nel sistema del c.d. doppio binario (v. infra) che consente di aggiungere
alla pena, per il soggetto imputabile ritenuto pericoloso, una misura di sicurezza (sebbene tale
possibilità, come subito diremo, sia oggi utilizzata molto raramente);
resta tuttavia un dato molto importante desumibile dall’art. 133 c.p.: tale norma ha riguardo, oltre
che alla gravità del fatto, soltanto a fattori soggettivamente orientati, concernenti, cioè, la persona
del soggetto giudicato colpevole, mentre non vengono in alcun modo contemplate valutazioni del
giudice riferite alla deterrenza, alla sicurezza sociale o al soddisfacimento di aspettative
sanzionatorie, quale ne sia la provenienza; ciò significa che devono rimanere rigorosamente
escluse valutazioni da parte del giudice, con riguardo alla pena da applicarsi nel caso concreto,
che risultino di carattere generalpreventivo (tali valutazioni, infatti, competono soltanto al
legislatore nel momento in cui definisce le pene edittali, e pur sempre secondo la prospettiva
costituzionale di una prevenzione generale reintegratrice);
9.3
- la determinazione, in sede di condanna, della pena pecuniaria, in rapporto ai problemi che essa
comporta rispetto al principio di uguaglianza ove sia applicata, come nell’ordinamento italiano,
secondo un’entità assoluta; la mitigazione molto parziale del problema attraverso le previsioni degli
artt. 133-bis e -ter c.p.;
- il ruolo delle pene accessorie e la relativa elencazione (art. 19 c.p.), che possono essere applicate
solo in aggiunta a una pena principale (art. 20 c.p.)
- le misure di sicurezza e il c.d. sistema del doppio binario:
i presupposti per l’applicabilità delle misure di sicurezza (le mds personali, detentive o non
detentive, sono indicate all’art. 215 c.p.): commissione di un reato e pericolosità sociale del
soggetto agente (artt. 202 e 203 c.p.), secondo la prospettiva, propria del positivismo, di una misura
tesa a rieducare e, fino a quando non sia venuta meno la pericolosità, a neutralizzare autori di reato
ritenuti pericolosi;
si consideri l’ultimo comma dell’art. 215 c.p.: «quando la legge stabilisce una misura di sicurezza
senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che,
trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia
agricola o ad una casa di lavoro»;
il carattere indeterminato della durata delle misure di sicurezza, secondo la prospettiva propria
del positivismo, fino al venir meno della pericolosità (artt. 207 e 208 c.p.):
l’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52/2014, conv. in l. n. 81/2014, ha tuttavia previsto che «le
misure di sicurezza detentive non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva
prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima», secondo i
criteri di cui all’art. 278 c.p.p.;
- l’ambito applicativo delle misure di sicurezza:
a) la possibilità, secondo il codice del 1930, che la sentenza di condanna disponga, nei confronti di
soggetti imputabili (v. infra),l’applicazione di una misura di sicurezza dopo l’esecuzione della pena
detentiva: o sulla base del giudizio di pericolosità operato dal giudice, o nei casi di pericolosità
presunta ai sensi dell’art. 204 c.p. (si consideri il disposto dell’art. 215, co. 4
l’avvenuta abrogazione dell’art. 204 c.p. e l’estrema rarità attuale del fatto che un giudice usi del
suo potere discrezionale per dichiarare la pericolosità di un condannato, disponendo l’esecuzione
nei suoi confronti, dopo la pena, di una misura di sicurezza (stante l’insostenibilità, in base all’art.
27, co. 3, Cost, di una funzione retributiva della pena e rieducativa della sola misura di sicurezza; e
stante, altresì, l’esigenza di evitare che l’intervento sanzionatorio configuri un bis in idem
sostanziale;
b) l’applicabilità della misura di sicurezza nei confronti dell’autore di reato non imputabile, cioè
non capace di intendere e di volere ai sensi dell’art. 85 c.p. (e pertanto non punibile), che sia
ritenuto dal giudice socialmente pericoloso: il che costituisce l’ambito operativo reale, oggi, delle
misure di sicurezza;
c) l’applicabilità eccezionale, ex art. 202, co. 2, c.p., della misura di sicurezza nei confronti di
soggetti imputabili non autori di reato: artt. 49, co. 4, e 115, co. 2 e 4, c.p. (v. infra);
- le misure di sicurezza detentive per gli adulti non imputabilii:
in particolare, l’art. 222 c.p. prevede[va] nei confronti dell’autore di delitto doloso punibile con
pena detentiva non inferiore a due anni, ove prosciolto per infermità psichica, l’ospedale
psichiatrico giudiziario: l’art. 3-ter, co. 4, d.l. 211/2011, come in seguito ripetutamente
modificato, ha peraltro stabilito che «dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono
chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a
casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al
comma 2 [le c.d. R.E.M.S., Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza], fermo
restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza
indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale».
l’art. 3-ter, comma 4, del d.l. n. 211/2011, prevede peraltro, in conformità a Corte cost. n. 223/
2003, che il giudice può disporre il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (o in una casa di
cura e custodia per i semimputabili ex artt. 221 e 89 c.p.) – ora R.E.M.S. – solo quando «siano
acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure
adeguate e a fare fronte alla pericolosità sociale»;
- la disciplina e l’ambito applicativo della libertà vigilata (artt. 228-230 c.p.);
- le misure di sicurezza detentive per i minorenni (art. 36 d.P.R. 448/1988, in rapporto agli artt.
223 e 228 c.p.): applicabilità delle prescrizioni comportamentali e della permanenza in casa in
luogo della libertà vigilata, e del collocamento in comunità in luogo del riformatorio
giudiziario (cioè di tre dei quattro provvedimenti che fingono anche da misure cautelari, ex artt.
19 ss. d.P.R. 448/1988);
- torniamo dunque alla pena, e al momento della condanna:
il mancato superamento della centralità che assume la pena detentiva, non essendosi addivenuti
a una diversificazione della gamma, limitatissima, delle pene principali;
il momento della condanna, incentrato pertanto sulla pena detentiva (essendo marginale
l’applicazione di una pena pecuniaria non congiunta a quella detentiva), e la possibile
diversificazione successiva – secondo un modello “a clessidra” – della pena detentiva inflitta:
sia attraverso istituti che ne escludono l’esecuzione detentiva, sia attraverso istituti che diversificano
in certa misura l’esecuzione della medesima (introduzione);
la stessa esigenza di ridurre il sovraffollamento penitenziario imposta all’Italia dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo (sentenza Torreggiani, dell’8 gennaio 2013) è stata perseguita agendo
essenzialmente sull’ambito applicativo delle misure alternative (v. infra) e sulla restrizione delle
condizioni di applicabilità della custodia cautelare, piuttosto che attraverso la via più naturale
costituita dall’introduzione di pene principali non detentive;
introduzione schematica alle vicende della pena inflitta in sede di condanna e alle scelte operate
dall’ordinamento penitenziario del 1975 (l. n. 354/1975);
10.3
gli strumenti attraverso i quali lo stesso giudice che condanna può evitare l’esecuzione della
pena detentiva inflitta:
a) la sospensione condizionale (artt. 163-168 c.p.): presupposti, criteri applicativi, effetti, revoca;
il maggior ambito applicativo dell’istituto (condanna detentiva fino a tre anni, invece che fino a due,
per l’autore di reato minorenne);
l’applicabilità della sospensione condizionale anche alle pene accessorie (v. supra);
il ragguaglio fra pena detentiva e pecuniaria ai sensi dell’art. 135 c.p. (250 euro corrispondono a
un giorno di pena detentiva) e la possibilità di sospendere la (sola) pena detentiva entro il limite di
durata previsto anche quando quel limite sarebbe superato a seguito del ragguaglio con la pena
pecuniaria aggiuntiva (art. 163, ultima parte dei commi 1, 2 e 3);
il regime particolarmente favorevole (sospensione per un solo anno) nel caso di condanna a pena
non superiore a un anno e avvenuta riparazione del danno (art. 163, co. 4, c.p.);
b) le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, (artt. 53-58 l. n. 689/1981, legge che ha
previsto, fra l’altro, un ampio provvedimento di depenalizzazione – cioè di trasformazione di illeciti
penali in illeciti amministrativi – e che comprende, inoltre, le norme riguardanti gli illeciti
amministrativi e le relative sanzioni): presupposti, criteri applicativi, revoca;
c) il perdono giudiziale relativo ai soli condannati minorenni (art. 169 c.p., come riformulato
quanto al primo comma dall’art. 19 r.d. n. 1404/1934, istitutivo del Tribunale per i minorenni); si
consideri che l’art. 97 c.p. fissa la soglia di imputabilità del minorenne a quattordici anni e che
l’art. 98, co. 1, c.p. e prevede l’applicazione in favore del medesimo di una attenuante obbligatoria;
gli strumenti che permettono di non eseguire in forma detentiva la pena inflitta nella sentenza di
condanna attraverso la decisione del Tribunale di sorveglianza in merito all’applicabilità, fin
dall’inizio della fase esecutiva, delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio
sociale e della detenzione domiciliare:
- le misure alternative (v. infra) applicabili dal Tribunale di Sorveglianza fin dall’inizio
dell’esecuzione della pena (presupposta la sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656. co. 5,
c.p.p.) o per residui di pena che rientrino dei limiti di applicabilità a esse relativi:
- l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. penit.): presupposti e disciplina (si
consideri l’estensione dell’applicabilità dell’affidamento in prova per pene detentive, o residui di
pena, (da tre) fino a quattro anni, di cui al comma 3-bis dell’art. 47 ord. penit., aggiunto dall’art. 3
d.l. n. 146/2013, conv. in l. n. 10/2014;
si noti che solo nel momento in cui la risposta al reato assume contenuti progettuali attraverso un
programma prescrittivo, come accade nell’affidamento in prova nonché – vedi infra – attraverso la
messa alla prova e le procedure di mediazione penale, può recuperarsi una dimensione riparativa,
o anche riconciliativa, del provvedimento penale nei confronti della persona offesa (cfr. art. 47,
co. 7, ord. penit.; art. 28, co. 2, d.P.R. n. 448/1988), laddove la tradizionale pena detentiva non offre
alla vittima alcunché;
- la detenzione domiciliare (art. 47-ter e ord. penit.), concernente, di regola, la pena detentiva fino
a quattro anni, quando sussistano particolari condizioni di età, salute, genitorialità;
l’esecuzione presso il domicilio, con eccezioni, delle pene detentive (o dei residui di pena) fino a
18 mesi (art. 1 l. n. 199/2010, previsione resa permanente dall’art. 5 d.l. n. 146/2013 conv. in l. n.
10/2014);
artt. 47-quater (detenzione domiciliare e AIDS) e 47-quinquies (ulteriori benefici per le condannate
madri);
- si rammenti che sono eseguibili in regime di semilibertà anche le pene dell’arresto e della
reclusione non superiore a 6 mesi, se non il condannato non è stato ammesso all’affidamento in
prova (art. 50, co. 1, ord. penit.);
- i principi dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975):
a) centralità del trattamento rieducativo individualizzato, avente per fine il reinserimento sociale;
b) possibile flessibilizzazione della pena detentiva in rapporto all’evolversi del trattamento – sia
con riguardo alla durata, sia con riguardo ala modalità di esecuzione – attraverso l’applicabilità
delle misure alternative;
c) istituzione di un servizio sociale relativo all’amministrazione della giustizia, con il compito di
seguire il trattamento in carcere e l’esecuzione delle misure alternative;
d) giurisdizionalizzazione della fase esecutiva attraverso la creazione di un nuovo settore della
magistratura, costituita dal Tribunale di sorveglianza e dal Magistrato di sorveglianza;
e) previsione di forme d’interazione fra carcere e società;
- le norme principali dell’ordinamento penitenziario:
il ruolo del «trattamento» individualizzato e l’obbligo relativo allo studio della personalità (in
contrapposizione al divieto di perizie sulla personalità e sul carattere durante il processo, ai sensi del
già citato art. 220, co. 2, c.p.p.);
si vedano a tal proposito, in particolare, gli artt. 1, primo e ultimo comma, e 13 ord. penit.,
nonché gli artt. 27 (specie per quanto concerne il concetto di «riflessione sulle condotte poste in
essere»), 28 e 29 reg. ord. penit. (d.P.R. n. 230/23000);
l’art. 1 reg. ord. penit. (d.P.R. 230/2000): i fini del trattamento, sia in rapporto ai condannati che
agli indagati o imputati che si trovino in custodia cautelare;
il rapporto fra l’obiettivo della rieducazione/risocializzazione e il presupposto costituito da un
mutamento (interiore) degli atteggiamenti personali del condannato definitivo, come scelta
autonoma che può essere favorita ma non coartata (secondo una prospettiva del tutto diversa,
dunque, da quella della Scuola positiva);
- la necessaria limitazione dei fini del trattamento al mero sostegno degli «interessi umani, culturali
e professionali» con riguardo ai detenuti in stato di custodia cautelare, non potendo questi ultimi
essere considerati colpevoli (v. art. 27, co. 2, Cost.);
gli elementi del trattamento ai sensi dell’art. 15 ord. penit.: istruzione, lavoro, religione, attività
culturali, ricreative e sportive, contatti col mondo esterno e rapporti con la famiglia;
16.3
- la flessibilizzazione della pena in sede esecutiva, attraverso le misure alternative:
a) la liberazione anticipata (art. 54 ord. penit.), in quanto unica misura incidente sulla durata della
pena (si tenga conto della norma temporanea di cui all’art. 4 d.l. n. 146/2013 conv. in l. n. 10/2014
che aveva previsto, con eccezioni, l’estensione per due anni della detrazione di pena da 45 a 75
giorni per semestre: liberazione anticipata speciale);
b) le misure alternative incidenti sulla modalità di esecuzione della pena:
la semilibertà (presupposti e regime: artt. 48 ss. ord. penit.), che di fatto presuppone per lo più la
precedente concessione di permessi premio, quali elementi del trattamento (art. 30-ter ord. penit.);
la liberazione condizionale (artt. 176 ss. c.p.), prevista nel codice penale e qualificata come causa
di estinzione della pena, ma applicata dal Tribunale di Sorveglianza e operante, in concreto, come
una misura alternativa, sulla base del giudizio di sicuro ravvedimento; nella fase di liberazione
condizionale il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata (art. 230, co. 1, n. 2, c.p.);
c) le misure – già citate supra – applicabili dal Tribunale di Sorveglianza fin dall’inizio
dell’esecuzione della pena (affidamento in prova e detenzione domiciliare);
si considerino le condizioni di applicabilità di permessi-premio, lavoro esterno semilibertà e
liberazione condizionale nei confronti del condannato all’ergastolo (artt. 30-ter, co. 4, lett. d; 21,
co. 1; 50, co. 5, ord. penit.; 176, co. 3, c.p.);
art. 17 ord. penit. - partecipazione del mondo “esterno” ad attività in carcere, in base ad
autorizzazione del magistrato di sorveglianza su parere del direttore del carcere;
art. 19 ord. penit. - istruzione;
artt. 20 e 21 ord. penit. - lavoro e lavoro esterno: sull’importanza fondamentale del lavoro ai fini
del trattamento rieducativo e sulla inadeguatezza dell’offerta in tal senso; presupposti e limiti circa
l’ammissione al lavoro esterno;
artt. 30 e 30-ter ord. penit. - permessi e permessi-premio: il ruolo dei permessi-premio nel quadro
del trattamento; presupposti e limiti;
le varie forme del diritto di reclamo – in merito alla violazione di suoi diritti ai sensi dell’art. 69, co.
6, ord. penit. – da parte del detenuto (art. 35 ord. penit.) e, in particolare, il reclamo in sede
giurisdizionale previsto dall’art. 35-bis ord. penit., introdotto con d.l. n. 146/2013, conv. in l. n.
10/2014;
- i compiti della magistratura di sorveglianza: del magistrato di sorveglianza (competente, fra
l’altro, circa l’approvazione e le modifiche del programma di trattamento, la revoca delle misure di
sicurezza, i permessi, i reclami giurisdizionali, la liberazione anticipata: ex artt. 69 e 69-bis ord.
penit.) e del magistrato di sorveglianza (competente circa le misure alternative diverse dalla
liberazione anticipata e la liberazione condizionale, ex art. 70 ord. penit.);
- norme su servizio sociale e UEPE nonché, in particolare, sulle competenze di assistenti sociali ed
educatori (artt. 72, 80, 81, 82 ord. penit.); l’assistente volontario (art. 78 ord. penit.);
- il rapporto complesso tra funzione di aiuto e funzione di controllo (che si esplica attraverso
relazioni all’autorità giudiziaria) degli operatori del servizio sociale (cfr. art. 47, co. 9 e 10, ord.
penit.);
- l’art. 4-bis ord. penit.: presupposti diversificati, in funzione della gravità del reato nonostante
identiche entità di pena, circa l’accesso alle misure alternative, ai permessi-premio e al lavoro
all’esterno;
in particolare, i reati c.d. ostativi di cui al co. 1 di tale norma, che richiedono per l’applicazione dei
benefici penitenziari (tranne la liberazione anticipata), la collaborazione di giustizia, ove tuttora
suscettibile di risultare rilevante: il che muta in radice il ruolo delle misure alternative,
trasformandole in un incentivo per la collaborazione (che, in tal caso, non è semplicemente
incentivata attraverso norme premiali di riduzione della pena, come accade durante il processo, ma
risulta tale per cui la sua assenza produce il venir meno di diritti – l’accesso ai benefici penitenziari
– ordinariamente riconosciuti);
il che si rende drammatico, in particolare, nel caso dell’ergastolo – il c.d. ergastolo ostativo –
poiché l’esclusione dai benefici di cui sopra rende impossibile per l’ergastolano non solo qualsiasi
differenziazione del regime sanzionatorio, ma anche la possibilità stessa di poter pervenire,
attraverso la liberazione condizionale, al fine-pena (si rammenti in proposito che la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo esige che dopo un congruo numero di anni debba essere valutata la
rieducazione dell’ergastolano onde rendere possibile il fine pena);
l’esigenza, pertanto di restituire al Tribunale di Sorveglianza la possibilità di valutare se la mancata
collaborazione (che potrebbe derivare, per esempio, dal timore di ritorsioni nei confronti dei
familiari) costituisca o meno indice di mancata rieducazione
- i problemi connessi all’art. art 41-bis ord. penit., che consente la sospensione per via
amministrativa dell’applicabilità delle norme dell’ordinamento penitenziario che si pongano in
contrasto, per gli autori di gravi reati, con esigenze di sicurezza e di ordine;
la motivazione fondata sull’esigenza di evitare la partecipazione ad attività criminose dall’interno
del carcere e i rischi di un’applicazione troppo estesa, o meramente retributiva, della suddetta
facoltà (che potrebbe paradossalmente cementare, anche in condizione detentiva, la solidarietà tra
appartenenti a grandi associazioni criminose, implicando la rinuncia di fatto a perseguire intenti
rieducativi);
- il sistema penale minorile:
richiamo del già citato art. 98 c.p., che prevede un’attenuante obbligatoria circa la pena applicabile
nei confronti del minorenne imputabile;
- il dPR 448/1988 (processo penale minorile); i principi fondamentali di cui all’art. 1: la finalità
educativa, l’importanza riconosciuta alla personalità del minorenne, l’apertura del processo al
dialogo);
il ruolo esteso all’intera fase processuale dei servizi sociali minorili (art. 6 dPR 448/1988 e artt. 9 ss.
d. lgs. 272/1988;
l’inammissibilità della costituzione della parte civile (art. 10 dPR 448/88);
- le norme fondamentali di cui agli artt. 9 e 28 dPR 448/88:
17.3
(prosecuzione)
l’obbligo di studio della personalità del minorenne (anche senza disporre una perizia in modo
formale), in senso opposto a quanto dispone per gli adulti l’art. 220, co. 2, c.p.p.;
la possibilità per il giudice di disporre durante il processo la messa alla prova del minorenne sulla
base di un programma predisposto dai Servizi sociali minorili (USSM), ai sensi dell’art. 27 delle
norme di attuazione di cui al d.lgs. 272/1989, con estinzione del reato in caso di esito positivo della
prova medesima (art. 29 d.P.R. 448/1988); nel caso, invece, di esito negativo il procedimento
penale prosegue, fini alla sentenza;
con la messa alla prova, dunque, la risposta al reato può concretizzarsi interamente in un progetto,
posto che attraverso di essa si evita di giungere alla determinazione di una pena detentiva come
corrispettivo del reato e, pertanto, si abbandona davvero un’impostazione retributiva della giustizia;
l’assenza di limiti di gravità del reato per l’applicabilità della messa alla prova e la sua durata
ordinaria fino a un anno o fino a tre anni per reati più gravi;
la differenza strutturale della messa alla prova rispetto all’affidamento in prova al servizio sociale in
quanto misura alternativa applicata dopo la sentenza di condanna;
- l’estensione agli adulti (ex art. 5 l. n. 67/2014) della sospensione del procedimento con messa
alla prova, su richiesta dell’imputato (non implica ammissione di colpevolezza), con riguardo a
un ambito limitato di reati (in particolare, reati puniti con pena detentiva non superiore a quattro
anni): artt. 168-bis ss. c.p.; artt. 464-bis ss. c.p.p.; art. 141-bis s. att. c.p.p.;
la problematicità del disposto secondo cui la concessione è subordinate alla prestazione di lavoro di
pubblica utilità;
l’espressa menzione agli artt. 464-bis, co. 4, lett. c) e 141-ter, co. 3, att. c.p.p che il programma di
messa alla prova preveda «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la
persona offesa»;
- il possibile ricorso alla mediazione penale nel sistema penale minorile e la sua importanza quale
nuovo modello riconciliativo della giustizia;
ratio e finalità degli strumenti di giustizia riparativa (restorative justice), anche in rapporto alla
posizione della vittima del reato, la cui esigenza fondamentale sta nel vedere riconosciuta, fatta
verità non solo in senso storico-fattuale sul reato, l’ingiustizia di quanto accaduto: il che trova la
risposta più credibile ove l’addivenire a un tale giudizio possa realizzarsi attraverso lo stesso
soggetto agente;
la mediazione penale consente di discutere secondo verità sul fatto di reato, cioè di rielaborare
quanto accaduto, poiché ciò che viene detto dalle persone che partecipano alla mediazione non è
riferito al giudice (evitandosi di violare in tal modo il principio nemo tenetur se detegere): l’ufficio
di mediazione riferisce al giudice, piuttosto, un giudizio sulla validità della mediazione medesima,
che ordinariamente si conclude con la proposta, da parte dello stesso soggetto ritenuto autore del
reato, di una condotta riparativa (consistente in un impegno personale, e non nel mero risarcimento
del danno);
se con una auspicabile evoluzione in senso prescrittivo delle sanzioni penali, intese come progetto,
può prospettarsi il recupero di un dialogo con l’autore del reato (oggi impossibile) relativamente
alla configurazione della risposta sanzionatoria al reato (ferma la già avvenuta decisione sul fatto e
sulla responsabilità), con la mediazione diviene possibile recuperare la dimensione del dialogo già
nello stesso ambito temporale del processo (nel frattempo sospeso) e relativamente al reato stesso:
anticipandosi la rielaborazione critica del medesimo, ora prevista soltanto in sede di trattamento
penitenziario nella fase esecutiva della pena (v. supra), al momento stesso del processo; il che è
quanto dire anticipare a quel momento il conseguimento degli effetti di prevenzione generale
positiva e di risocializzazione;
sulla la possibilità di una più ampia utilizzazione, per il futuro, della mediazione penale (come
fattore di cui il giudice possa tener conto nel determinare la pena, sia nel tipo che nel quantum,
oppure anche come fattore che possa consentire di non iniziare un processo penale);
- la sentenza di non luogo a procedere in ambito minorile per irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R.
448/1988), anche in rapporto ai problemi concernenti l’obbligo di esercizio dell’azione penale da
parte del pubblico ministero (ex art. 112 Cost.) e l’obbligo di denuncia delle notizie di reato da
parte di pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio (ex artt. 361 e 362 c.p.);
i presupposti della suddetta sentenza: fatto occasionale e tenue, nocumento della celebrazione del
processo rispetto alle esigenze educative del minorenne;
- l’introduzione nel codice penale (dunque, anche con riguardo agli adulti), avvenuta con d.lgs. n.
28/2015, dell’art. 131-bis c.p. che prevede rispetto a un ambito di reati non particolarmente gravi la
non punibilità per particolare tenuità del fatto (riferita alle modalità della condotta e alla
esiguità del danno o del pericolo, ferma la non abitualità del comportamento), limitatamente a reati
per i quali la legge prevede una pena detentiva non superiore a quattro anni;
la differenza rispetto alla non procedibilità di cui all’art. 27 d.P.R. n. 448/1988;
la differenza fra irrilevanza o particolare tenuità del fatto (il reato può sussistere o sussiste) e fatto
inoffensivo (il reato non sussiste): v. infra, con riguardo al principio di offensività;
23.3
- la competenza in materia penale del giudice di pace: principi (art. 2 d.lgs. 274/2000);
l’applicabilità di sole pene non detentive: permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità (con
il consenso del condannato) e pena pecuniaria (artt. 52-54 d.lgs. 274/2000)
- gli strumenti di definizione anticipata del processo:
a) il tentativo di conciliazione finalizzato alla remissione della querela e il possibile ricorso, per tale
fine, alla mediazione penale (art. 29, co. 4); l’espressa previsione del fatto che le dichiarazioni rese
dalle parti nella fase di conciliazione «non possono essere utilizzate in alcun modo ai fini della
deliberazione»;
b) il non luogo a procedere in caso di tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. n. 274/2000): dà luogo a una
improcedibilità come l’art. 27 d.P.R. n. 448/1988, ma con una definizione più complessa dei
presupposti); il problema del ruolo attribuito, in proposito, alla persona offesa;
c) la procedura riparativa (art. 35 d.lgs. n. 274/2000), possibile per qualsiasi reato di competenza
del giudice di pace, quale strumento che potrebbe trovare, in futuro, ambiti di significativa
utilizzazione anche nel diritto penale generale; l’eccessiva caratterizzazione risarcitorio-restitutoria,
piuttosto che riparativa, dei requisiti richiesti dalla norma richiamata e il rischio di un’eccessiva
dipendenza dal parere della persona offesa (cui si aggiunge la genericità dei criteri valutativi
assegnati al giudice);
- l’obbligo del giudice di pace di favorire in ogni caso la conciliazione, ex art. 2, co. 2, d.lgs.
n. 274/2000;
- la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro
vantaggio (d.lgs. n. 231/2001): la ratio della previsione di una responsabilità degli enti con
riguardo agli illeciti penali commessi nel loro interesse o a loro vantaggio e i motivi della sua
configurazione come responsabilità «amministrativa» per reato (art. 1); la strategia intesa a creare
un interesse degli enti ad «autocontrollarsi», onde prevenire la commissione dei suddetti reati; gli
enti cui la normativa risulta applicabile (art. 1);
la competenza, rispetto a simile forma particolare di illecito amministrativo, della magistratura
penale (artt. 34-36);
il ruolo dei «modelli di organizzazione e di gestione» e dell’organo interno di vigilanza (art. 5);
i criteri di responsabilità dell’ente (art. 8);
la possibile esclusione della responsabilità dell’ente e i relativi requisiti: il diverso regime in
rapporto a condotte poste in essere da soggetti “apicali” (si richiede, fra l’altro, la prova da parte
dell’ente che tali soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione) o da soggetti “non apicali” (artt. 6 e 7);
le sanzioni applicabili: art. 9:
la sanzione pecuniaria per quote, applicata in ogni caso, (artt. 10-11) e le ipotesi della sua
riduzione (art. 12);
la particolare temibilità delle sanzioni interdittive, fino alla interdizione dall’esercizio dell’attività
(artt. 13-16);
la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo o del profitto relativi al reato (art. 19);
le disposizioni in materia di delitti tentati (art. 26);
i reati di cui gli enti possono rispondere (artt. 24 ss.);
___________
i principi garantistici del sistema penale:
- il principio di legalità quale fondamentale principio liberal-garantistico che attiene alla tutela del
cittadino nei confronti della potestà punitiva statuale, espresso all’art. 25 Cost., oltre che all’art. 1
c.p., nei suoi profili di
1) riserva di legge, in forza della quale l’introduzione di norme penali è riservata al potere
legislativo, con esclusione sia di atti provenienti dal potere esecutivo (diversamente da quanto
accade negli altri settori del diritto, dove tali atti hanno un ruolo integrativo della legge, secondo la
gerarchia delle fonti), sia di un ruolo creativo del diritto da parte del potere giudiziario: ciò in
quanto, costituendo le sanzioni penali lo strumento di massima ingerenza dei poteri pubblici nella
sfera dei diritti dei cittadini, si vuole che la loro utilizzazione venga vagliata e decisa dall’organo
massimamente rappresentativo dei cittadini stessi;
si consideri come questa impostazione che si rifà alla tradizione illuministica risulti oggi
ampiamente minata sia dalla disponibilità dei parlamenti a farsi interpreti di istanze demagogiche e
di c.d. populismo penale, sia dal marcato svuotamento dell’autonomia dei parlamenti stessi rispetto
al ruolo dominante dei governi, sia dall’attivismo creativo giudiziario (il c.d. diritto vivente), che
tende a debordare rispetto alla funzione meramente interpretativa del diritto, con un ricorso
sostanziale anche a soluzioni di analogia in malam partem (v. infra): attivismo in parte favorito
dalla scarsa qualità e coerenza della odierna legislazione penale, nonché dall’ampio utilizzo, in essa,
di terminologie generiche o c.d. concetti valvola (nonostante il principio di determinatezza: v.
infra);
la natura tendenzialmente assoluta e non meramente relativa della riserva di legge;
il problema delle c.d. norme penali in bianco, attraverso le quali si penalizza la violazione di
provvedimenti provenienti da autorità amministrative o, comunque, si lascia a una fonte secondaria
(cioè non legislativa) la determinazione della condotta rilevante ai fini penali;
il ruolo particolare dei decreti legislativi e dei decreti legge;
24.3
(segue)
2) determinatezza o precisione o tassatività delle fattispecie di reato, in forza della quale ciascun
cittadino dovrebbe essere sempre in grado di individuare, al momento in cui tiene la condotta, il
confine tra ciò che sia da ritenersi lecito o illecito sul piano penale;
esemplificazioni circa fattispecie scarsamente determinate e di dubbia conformità al principio della
riserva di legge (in part., l’art. 650 c.p.);
3) divieto di analogia, espressamente previsto dall’art. 14 preleggi quale eccezione rispetto agli
altri settori del diritto:
la nozione di «leggi penali», come norme incriminatrici o tali da consentire una risposta
sanzionatoria più sfavorevole: la rilevanza di principio del divieto, quale divieto a contenuto
garantistico, nei soli casi in cui l’analogia rilevi in malam partem;
la nozione di «leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi»; il problema
dell’applicabilità per analogia delle cause di giustificazione;
4) irretroattività delle norme incriminatrici e in malam partem;
abrogazione e successione di norme penali (art. 2 c.p.); i problemi connessi al confine fra le due
categorie e alle diverse conseguenze che ne derivano;
gli effetti delle dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale;
il problema inerente alla possibilità di dichiarare incostituzionali norme penali favorevoli (cause
di non punibilità, attenuanti, ecc.), sia in rapporto al rispetto della riserva di legge, sia in rapporto
alla necessaria rilevanza della questione di costituzionalità nel processo a quo; l’ammissibilità della
dichiarazione di incostituzionalità quando la norma di favore (rispetto alla scelta legislativa di
penalizzare in un dato modo un certo fatto illecito) non appaia ragionevole, violando in tal modo il
principio di uguaglianza: cioè quando la sua motivazione non possa essere riferita ad alcuna
esigenza costituzionalmente significativa;
- il diritto penale come espressione particolarmente delicata dei poteri pubblici, in quanto «arma a
doppio taglio» (F. von Lizst), che tutela beni di rilievo giuridico, sacrificando a sua volta beni
giuridici fondamentali, come la libertà personale;
- da questa constatazione deriva la c.d. teoria del “bene giuridico”: teoria di matrice liberalgarantistica, in quanto finalizzata alla selezione dei beni suscettibili di essere tutelati penalmente dal
legislatore:
dovrà trattarsi esclusivamente dei beni fondamentali per la convivenza civile, cioè attinenti, in via
diretta o indiretta, alla salvaguardia dei diritti umani inviolabili e tali che la loro offesa risulti
suscettibile di un accertamento materiale;
la critica operata nei confronti della teoria del bene giuridico da parte dei regimi totalitari: in
particolare, l’inadeguatezza della c.d. concezione metodologica del bene giuridico (diffusa all’epoca
del codice Rocco, nell’ambito del c.d. orientamento tecnico-giuridico), intesa come finalizzata alla
mera catalogazione dei beni, o interessi, che il legislatore abbia scelto di tutelare penalmente;
il tentativo di ancoramento dei suddetti beni fondamentali alla Costituzione, sulla base dell’art. 13,
operato dal prof. Franco Bricola (anche per rendere possibile sollevare la questione di
costituzionalità in rapporto all’utilizzo del diritto penale per la tutela di beni aventi un rango troppo
modesto in rapporto alla libertà personale, bene sul quale la pena, tradizionalmente, incide);
- il rilievo della riflessione sul bene giuridico in rapporto all’accertamento da parte del giudice
dell’offesa del bene tutelato: il principio di “offensività”;
tale principio esprime l’esigenza che il giudice non si limiti, per punire, a constatare l’essersi
verificato un accadimento storico corrispondente ai requisiti di una certa fattispecie di reato, ma
accerti anche l’effettiva offesa, in termini di lesione o messa in pericolo, del bene giuridico che il
legislatore, con quella fattispecie, intendeva tutelare: principio argomentabile in rapporto al rango
della libertà personale in quanto diritto garantito dall’art. 13 Cost. (che non può essere limitata se
non sussistono la lesione o la messa in pericolo di un altro bene paragonabile al suo valore), ma di
cui la dottrina e la giurisprudenza hanno ricercato altresì un appiglio nella legge, facendo leva sul
concetto di inidoneità di cui all’art. 49 c.p. (non punibilità nel caso di reato impossibile), che
sarebbe da intendersi non soltanto come inidoneità materiale a cagionare l’evento in senso
naturalistico (in corrispondenza all’idoneità richiesta dall’art. 56 c.p. ai fini del tentativo), ma anche,
per l’appunto, come inidoneità a ledere il bene giuridico e, dunque, come inoffensività;
- la differenza fra fatto inoffensivo (manca il reato) e fatto tenue, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
introdotto con d.lgs. n. 28/2015 (non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto, oppure non
procedibile (per particolare tenuità nell’ambito dei reati di competenza del giudice di pace, ex art.
35 d.lgs. n. 274/2000, o per irrilevanza in materia penale minorile, ai sensi dell’art. 27 d.P.R.
448/1988): v. supra;
30.3
ripasso e approfondimenti a cura del dr. Sebastiani
31.3 (dr. Sebastiani)
- il principio di sussidiarietà o di extrema ratio del diritto penale:
la teoria del bene giuridico riflette sui beni che, in astratto, potrebbero o meno costituire oggetto di
tutela penale, ma non implica che per la tutela di quei beni (e comunque per ogni modalità di tutela
di quei beni) si debba fare ricorso al diritto penale;
in linea di principio, infatti, il ricorso al diritto penale deve ritenersi ammissibile solo quando altri
strumenti di tutela meno invasivi rispetto ai diritti individuali si manifestino insufficienti: ed è
proprio questa esigenza che risulta espressa dal principio di sussidiarietà o di extrema ratio del
diritto penale;
appare peraltro piuttosto irrealistico – anche per esigenze di organicità e di messaggio del sistema,
come pure per esigenze relative agli strumenti d’indagine – che determinati profili di tutela relativi
a beni fondamentali possano fuoriuscire dall’ambito penale, almeno finché un diritto penale si dia:
più che di extrema ratio del ricorso al diritto penale in quanto tale, pertanto, si dovrà parlare di
extrema ratio (o sussidiarietà) del ricorso alla pena detentiva (potendosi ben ipotizzare, per il
futuro, sanzioni penali non detentive);
- il principio di frammentarietà: indica che non necessariamente il diritto penale tutela tutte le
possibili forme di aggressione di un dato bene; come pure, inoltre, che la sfera di ciò che risulta
penalmente antigiuridico risulta più ristretta rispetto a ciò che risulta antigiuridico rispetto all’intero
ordinamento (sul piano civile, amministrativo, ecc.) e altresì più ristretta, in ogni caso, rispetto a
quanto sia da considerarsi riprovevole sul piano morale (guai se si considerasse riprovevole solo ciò
che è penalmente vietato o che subisce una condanna penale!);
- la “piramide” della politica criminale:
a) i due livelli della “prevenzione primaria”:
1. la dimensione politico-sociale ed educativo culturale (con una riflessione sul ruolo dell’etica e
sulla possibilità di educare nella società pluralistica: in particolare, il senso dell’esperienza morale e
la funzione svolta dalle dichiarazioni dei diritti e dalle Costituzioni);
2. l’intervento giuridico, attraverso norme non penali, sui fattori che favoriscono la criminalità;
b) la fase successiva alla commissione del reato:
3. sanzioni amministrative;
4. sanzioni penali non detentive;
5. sanzioni penali detentive;
anche quando si ritenga che le esigenze preventive richiedano il ricorso alla pena detentiva, si
dovranno comunque percorrere, per la tutela del bene interessato, anche i precedenti gradini della
piramide (il contrasto della criminalità organizzata richiede pur sempre prevenzione primaria, ecc.);
- diritto penale interno e normative europee: effetti restrittivi e dilatativi dell’ambito del
punibile; il ruolo del diritto europeo ai sensi delle limitazioni alla sovranità ammesse dall’art. 12
della Costituzione;
in particolare, la problematicità, in rapporto alla «riserva di legge», degli effetti dilatativi
dell’intervento penale e, segnatamente, delle richieste di penalizzazione nonché delle richieste
sanzionatorie derivanti da atti normativi europei (in particolare, direttive);
- le previsioni in materia penale del Trattato di Lisbona (in part., l’art. 83: vedi materiali didattici
nella pagina web-docente UC): gli ambiti in cui è previsto un potere di intervento del diritto
europeo attraverso direttive, rispetto ad alcune forme di criminalità grave e ad ambiti nei quali si
realizzino provvedimenti di armonizzazione;
- la sentenza Taricco (è riportata anch’essa, con un commento, tra i suddetti materiali didattici)
della Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE, Grande Sezione, 8-9-2015) che, di fatto,
attribuisce al giudice nazionale il potere di disapplicare norme interne relative alla prescrizione dei
reati (art. 157 c.p.) ove non le ritenga nel loro complesso adeguate al dovere degli Stati (desunto, in
particolare, dall’art. 325 TFUE) di prevedere una tutela efficace degli interessi UE (nel caso di
specie rispetto alla prevenzione di delitti di frode tributaria che compromettano il gettito dovuto alla
UE), assegnando in tal modo al giudice poteri aventi, di fatto, natura legislativa; ne deriva la
violazione del divieto di retroattività di una disciplina più sfavorevole, ma soprattutto la violazione
dello stesso principio di divisione dei poteri: questioni sulle quali è stata chiamata a pronunciarsi
la Corte Costituzionale, prospettando la possibilità di far valere i c.d. controlimiti attinenti ai
principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale interno anche nei confronti delle sentenze
della CGUE (cui compete l’interpretazione autentica delle normative UE, quali i Trattati e i
Regolamenti, che hanno efficacia diretta negli ordinamenti dei singoli Stati e sono dunque
immediatamente applicabili dai giudici); la Corte costituzionale s’è pronunciata con ord. n. 24/2017
(essa pure tra i materiali didattici) recependo pienamente, nella sostanza, le riserve sopra enunciate
nei confronti della sentenza Taricco e proponendone, in tal senso, una lettura conforme ai principi
costituzionali italiani e al principio di legalità riconosciuto dall’art. 49 della Carta dei Diritti UE, ma
rimettendo nuovamente la questione per una conferma o smentita di tale lettura alla CGUE, che
dovrà prossimamente pronunciarsi: senza dunque aver attivato (per ora) i c.d. controlimiti.
- il ruolo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e della relativa Corte; il
problema dell’interpretazione delle norme interne secondo la CEDU in base all’interpretazione che
ne dia la CorteEDU e la questione di costituzionalità che si ritiene proponibile in caso di
incompatibilità ai sensi dell’art. 117 Cost. (salvo il principio di resistenza ove quell’interpretazione
risulti incompatibile con principi costituzionali fondamentali);
6.4 conclusioni su corte cost. taricco
- i reati in rapporto al bene giuridico tutelato:
reati di danno, implicanti la lesione del bene giuridico tutelato
reati di pericolo, implicanti una tutela anticipata del bene giuridico tutelato: implicano, infatti,
non già la lesione, ma la messa in pericolo del bene
questi ultimi si distinguono in:
- reati di pericolo concreto, nei quali si richiede al giudice di accertare che si sia effettivamente
determinato un pericolo nel caso concreto per il bene oggetto di tutela;
- reati di pericolo astratto, attraverso i quali il legislatore non richiede al giudice un accertamento
del pericolo, in quanto sussiste una base scientifica adeguata per ritenere che il fatto risulti sempre
pericoloso rispetto al bene tutelato;
- reati di pericolo presunto, da ritenersi incostituzionali perché puniscono sempre un dato fatto
previsto come reato, senza alcuna prova che esso metta effettivamente in pericolo nel caso concreto
il bene tutelato (posto che, invece, la sanzione penale incide certamente su beni fondamentali del
condannato);
esemplificazione in materia di incendio (art. 423 c.p.): tale delitto – con evento naturalistico: v.
infra – posto a tutela della pubblica incolumità (non del patrimonio!) veniva tradizionalmente
utilizzato, con riguardo al secondo comma (incendio di cosa propria), come modello di un reato di
pericolo concreto (in quanto la norma precisa «se dal fatto deriva pericolo per la pubblica
incolumità») e, con riguardo al primo comma (incendio di cosa altrui), come modello di un reato di
pericolo presunto, non essendo esplicitamente richiesta, in esso, alcun accertamento da parte del
giudice circa il determinarsi in concreto di un pericolo;
stante l’incostituzionalità di principio dei reati di pericolo presunto, si è peraltro addivenuti a una
lettura dello stesso art. 423, co. 1, c.p., la quale ravvisa nel cagionare un incendio non un mero
appiccare il fuoco, bensì il produrre un fuoco di caratteristiche tali da manifestarsi oggettivamente
pericoloso per l’incolumità personale: tesi questa fatta propria in due occasioni dalla stessa Corte
costituzionale (n. 286/1974 e n. 71/1979), che ha per l’appunto richiesto, ai fini dello stesso art. 423,
co. 1, c.p., un evento idoneo a creare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità (sebbene
utilizzando l’avverbio potenzialmente, piuttosto che l’avverbio concretamente: tuttavia, una
interpretazione teleologica costituzionalmente orientata conduce a esigere il realizzarsi effettivo del
pericolo);
- i reati in rapporto alla configurazione del fatto tipico:
reati di pura condotta e
reati con evento naturalistico, che possono configurarsi a condotta libera (causalmente orientati) o
a condotta vincolata, cioè descritta dal legislatore;
si noti bene che l’offesa del bene tutelato – da molti definito evento in senso giuridico – deve
sussistere sia con riguardo ai reati con evento naturalistico, sia con riguardo ai reati di pura
condotta;
si noti altresì che la distinzione fra reati di pura condotta e reati con evento naturalistico non
coincide affatto con la distinzione (v. supra) fra reati di danno e reati di pericolo (che attiene al
bene tutelato): posto che possono ben darsi reati con evento naturalistico, come l’incendio (art. 423,
v. supra), che sono reati di pericolo;
reati attivi (o commissivi) e reati omissivi;
tipologie dei reati omissivi:
a) reati omissivi propri (di pura condotta);
b) reati nei quali la norma prevede che l’evento naturalistico sia causato da una condotta omissiva;
c) reati omissivi impropri, che vengono creati dall’art. art. 40, co. 2, c.p., ai sensi del quale non
impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, in rapporto a
singoli reati previsti in forma commissiva;
si consideri il carattere molto problematico dell’art. 40, co. 2, c.p., data la sua genericità: ne
derivano interrogatici in merito alle tipologie di reati cui si riferisce, ai confini dell’obbligo
giuridico di impedire l’evento (derivante da legge o contratto), all’ambito di applicabilità: v. infra
- i reati in rapporto alla catalogazione legislativa
si distinguono in due categorie, che si riconoscono a seconda del tipo di pene previste (v. art. 17
c.p.):
delitti (richiedono il dolo, salvo che sia prevista espressamente l’ipotesi colposa: art. 42, co. 2 c.p.)
e
contravvenzioni (sono sempre punibili sia per dolo che per colpa: art. 42, co. 4, c.p.);
nel codice penale i delitti sono previsti nel libro II, mentre le contravvenzioni nel libro III;
- introduzione alla teoria del reato e ai suoi elementi:
a) fatto tipico, costituito dalla condotta, dall’eventuale evento naturalistico e dagli altri elementi
richiesti dalla norma incriminatrice
la descrizione normativa del fatto tipico deve essere conforme al principio di materialità, cioè
deve riferirsi a fattori (condotte, eventi, stati soggettivi, ecc.) che abbiano una proiezione nel mondo
esterno e risultino suscettibili di accertamento: non può dunque avere per oggetto giudizi morali o
mere condizioni personali, il che condurrebbe a un’inaccettabile (c.d.) colpa d’autore, svincolata
dall’effettiva offesa di beni giuridici;
il fatto tipico si distingue in fatto tipico oggettivo (condotta, causalità, evento, ecc.) e fatto tipico
soggettivo, che è costituito dalla natura dolosa o colposa (v. infra) del fatto medesimo: posto che i
fatti riferibili agli esseri umani, diversamente dai fatti di natura fisico-naturalistica, vengono in
essere ab origine sulla base di una dato soggettivo (v. infra);
b) antigiuridicità penale (che si sostanzia nell’assenza di cause di giustificazione: v. infra);
c) colpevolezza, consistente nella rimproverabilità personale del fatto medesimo (ai cui fini
risultano necessari, come vedremo, il sussistere del dolo o della colpa, l’imputabilità, la
conoscibilità del divieto e l’esigibilità della condotta);
il dolo e la colpa (v. infra), dunque, costituiscono elementi (soggettivi) del fatto tipico (la condotta
penalmente rilevante, come diremo, dev’essere o dolosa o colposa), ma anche presupposto
necessario perché possa muoversi un rimprovero di colpevolezza;
7.4.
- si tratta ora di approfondire i concetti cardine di teoria del reato, muovendo a ritroso – secondo
l’iter accertativo proprio del giudice – dall’evento storicamente verificatosi (abbiamo preso in
considerazione, per semplificare, il modello di un reato con evento naturalistico, ma quanto si dirà
vale, in linea di principio, anche con riguardo all’evento in senso giuridico, cioè all’offesa del bene
tutelato, che deve pur sempre sussistere anche nei reati di pura condotta);
- i profili oggettivi del fatto tipico:
il giudice dovrà verificare, in primo luogo, se l’evento sia stato causato da una condotta
umana: posto che, ovviamente, è solo di tale eventualità che si occupa il diritto penale: dovrà
dunque accertare il sussistere di un nesso di causalità tra l’evento stesso e una tale condotta;
simile problematica, si osservi, riguarderà soprattutto i reati colposi, come dimostra l’esperienza
giurisprudenziale: posto, infatti, che la condotta dolosa mira a immutare, affinché si produca
l’evento, un contesto situazionale nel quale, altrimenti, l’evento stesso pressoché certamente non si
produrrebbe, è quasi impossibile che, ove l’evento si sia prodotto e vi sia stato il dolo di produrlo,
possano esservi dei dubbi sulla causalità della condotta; mentre ove l’evento si sia prodotto, ma
nessuna condotta sia stata prescelta proprio per produrlo (cioè non vi sia dolo intenzionale), può
darsi assai più facilmente il dubbio che l’evento sia stato prodotto, piuttosto che dalla condotta
pericolosa (colposa) che sia stata posta in essere, da qualche altra sequenza causale;
- il nesso di causalità fra condotta ed evento (art. 40, co. 1 c.p.): la definizione secondo la formula
della condicio sine qua non (si può dire che B è stato causato da A ove, senza A, B non si sarebbe
prodotto) e il necessario ricorso in sede probatoria a leggi scientifiche
(si rammenti che la causalità di una condotta omissiva può essere affermata, quando in assenza
dell’omissione, vale a dire ove fosse stato posto in essere il comportamento dovuto, l’evento non si
sarebbe verificato):
la formula summenzionata, tuttavia, costituisce solo la definizione del nesso di causalità, ma non ci
dice nulla circa l’effettivo sussistere di quel nesso; a questo fine sarà necessario, pertanto, disporre
di un criterio idoneo ad accertare che sussistano effettivamente le condizioni indicate dalla condicio
sine qua non, cioè che davvero, eliminato l’antecedente, il conseguente sarebbe venuto meno
(giudizio ipotetico controfattuale); un criterio che è dato, nel nostro caso, dalla riconducibilità
dell’ipotesi causale formulata dal giudice nel caso concreto a regolarità già note, cioè a
generalizzazioni (o leggi scientifiche) che ricolleghino elementi ripetibili dell’antecedente al
verificarsi di elementi ripetibili del conseguente: così da potersi concludere che il conseguente si è
verificato in quanto s’è verificato l’antecedente e che, eliminando quest’ultimo, quel conseguente
non si sarebbe realizzato (modello della sussunzione sotto leggi scientifiche);
peraltro non disponiamo, in molti casi, di leggi scientifiche universali (del tipo “tutte le volte che
A, allora B”), ma di sole leggi statistiche (del tipo “tutte le volte che A, B si verifica in una certa
percentuale di casi); le leggi statistiche, tuttavia, non consentono di raggiungere il necessario livello
di prova oltre ogni ragionevole dubbio del nesso causale: se tra A e B intercorre solo una legge
statistica, A è idoneo a cagionare B ma non è detto che lo abbia cagionato, perché B potrebbe essere
stato prodotto da un antecedente causale diverso (problema della pluralità delle cause); il che
evidenzia, fra l’altro, la non validità a risolvere il problema causale delle vecchie teorie della c.d.
causalità adeguata, fondate sul riscontro della mera idoneità causale della condotta;
dunque, va affermata la tendenziale necessità del ricorso, circa la prova del nesso causale, a leggi
universali, posto che ove la condotta sia legata all’evento da una legge soltanto statistica (meglio,
ove condotta ed evento siano sussumibili sotto una legge meramente statistica), l’evento potrebbe
essere stato prodotto anche da una condotta diversa;
ove nondimeno si utilizzino leggi statistiche (che siano quantomeno espressive di una idoneità
statistica elevata), dovrà di conseguenza escludersi, per conseguire un livello di prova oltre ogni
ragionevole dubbio, che abbia agito una condotta diversa da quella cui si riferisca la legge statistica,
cioè dovrà escludersi qualsiasi eventuale fattore causale alternativo: fine per il quale il giudice potrà
utilizzare due criteri:
quello storico (domandandosi quale dei potenziali fattori causali alternativi si sia effettivamente
verificato)
e quello consistente nella migliore descrizione possibile dell’evento (meglio è descritto l’evento,
più si restringe il ventaglio degli antecedenti causali plausibili);
resta nondimeno l’interrogativo circa l’eventuale sussistere di fattori causali non noti;
la condotta, tuttavia, che s’è provato costituire condicio sine qua non dell’evento ne rappresenta una
condizione necessaria, la quale peraltro, onde produrre l’evento, ha agito nel contesto di altri fattori
causali necessari; si tratta del c.d. problema delle concause, sia di carattere fisico-naturalistico, sia
consistenti, spesso, in altre condotte umane, contemporanee o, soprattutto, antecedenti (fino, per
paradosso, al ruolo pur sempre causale della madre, ma anche del padre…, che ha messo al mondo
l’autore del reato): l’insieme di tutti i fattori necessari per il prodursi di un evento ne individua la
condizione sufficiente, che in termini assoluti non è ricostruibile (bisognerebbe poter spiegare
l’universo fin dalle sue origini…);
a questo punto diventa dunque necessario domandarsi quale sia, nel quadro delle condotte in sé
causali, la condotta penalmente rilevante: la condotta, cioè, che sia da ritenersi rilevante ai fini della
c.d. imputazione oggettiva, comune alla responsabilità per dolo e per colpa:
di questo problema il codice penale si manifesta consapevole all’art. 41 c.p., il cui co. 2 prevede
che «le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità [cioè la rilevanza di condotte causali
pregresse] quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento». Tale norma, tuttavia, ha
suscitato sempre difficoltà interpretative, dato l’utilizzo del concetto, in sé contraddittorio, di cause
da sole sufficienti (essa, del resto, sembra comprensibile solo alla luce di quanto immediatamente
preciseremo nel testo, cioè solo ove venga riferita ai casi in cui l’evento lesivo, pur causalmente
riconducibile alla condotta di un certo soggetto, rappresenti il concretizzarsi di un rischio
radicalmente diverso da quello che tale soggetto abbia attivato: si pensi all’ipotesi in cui A cagioni
il ferimento di B in un incidente stradale senza porlo in pericolo di vita, ma poi B deceda in
ospedale per un incendio, per una trasfusione infetta o per un errore medico);
simile condotta penalmente rilevante non potrà che essere una condotta illecita: non tuttavia una
qualsiasi condotta illecita, bensì una condotta che abbia violato una regola finalizzata a impedire
il verificarsi dell’evento e che, in tal senso, abbia prodotto un rischio non consentito di
causazione dell’evento stesso (per cui l’evento prodottosi risulta rilevante ai fini penali se
costituisce la concretizzazione dello specifico rischio illecito attivato dalla condotta);
ciò vale, come s’è detto, per la forma base del rimprovero soggettivo, cioè per la colpa, ma anche
rispetto al dolo: la volontà soggettiva di produrre un evento in sé rilevante ai fini penali non
rileverebbe ove fosse perseguita – per quanto l’ipotesi costituisca un caso poco realistico –
attivando una condotta del tutto lecita: si pensi all’esempio classico del nipote che, col fine di
vedere morto lo zio ricco da cui vorrebbe ereditare, gli consigli di fare un viaggio in aereo piuttosto
che in treno, per vederlo morto nel caso in cui l’aereo precipiti, come poi, incredibilmente, accade;
- i profili soggettivi del fatto tipico:
dobbiamo constatare, innanzitutto, che le condotte umane hanno una struttura finalistica, in
quanto sono conseguenti a una prospettiva, per l’appunto, finalistica che si fissa nella mente del
soggetto agente (non in termini puramente astratti, ma operativi) e che dell’adozione di tale
condotta è causa;
la condotta umana, in altre parole, viene prescelta dal soggetto agente in quanto ritenuta idonea a
realizzare il fine che si è fissato in termini operativi nella sua mente, cioè a realizzare una data
prospettiva mentale PX,
secondo lo schema PX C X
(prospettiva mentale avente ad oggetto la causazione di X, condotta idonea, risultato oggetto della
prospettiva mentale);
di regola, se disponibile, si sceglierà una condotta che manifesta un’elevata probabilità di
produzione dell’evento;
ciò premesso, ove X coincida con un evento E penalmente rilevante, si avrà responsabilità dolosa:
questo dunque lo schema della responsabilità dolosa (PX=E C X=E)
se invece X non coincide con E, ma E costituisce l’effetto non voluto causato dalla condotta C, la
quale aveva per fine produrre X, ci troveremo nell’ambito di un reato colposo, sempre che C, come
già sappiamo, costituisca una condotta che crea un rischio non consentito della causazione di E,
vale a dire che viola una regola finalizzata a evitare l’evento E):
questo dunque lo schema della responsabilità colposa (PX–>C↓E–>X):
si noti che sono da ricondursi a quest’ultimo schema anche il dolo diretto e il dolo eventuale (v.
infra)
si noti altresì come in questo secondo schema, a differenza del primo, la probabilità di causazione
dell’evento è di regola modesta (tanto più se si tratta di colpa cosciente: v. infra), posto che in esso
la condotta non è stata prescelta per cagionare l’evento;
tutto questo rende percepibili, fin d’ora, le aporie (contraddizioni) riscontrabili (dal punto di vista
della razionalità preventiva e rispetto al principio di colpevolezza) nello schema del reato colposo:
che interviene sul soggetto più sfortunato fra molti trasgressori egualmente rimproverabili, vale a
dire sul solo soggetto la cui condotta sfocia effettivamente nel prodursi dell’evento lesivo; ciò non
può produrre una prevenzione efficace, in quanto il soggetto che agisce farà ampiamente conto,
oltre che sull’incidenza della cifra oscura, sull’alta probabilità di non realizzazione dell’evento
lesivo; ma ciò si pone altresì in contrasto con il principio di colpevolezza (v. infra), dato che non
appare accettabile il fatto per cui, a parità di condotta colpevole, l’assenza di conseguenze penali
(non essendosi verificato l’evento lesivo) o il configurarsi di conseguenze penali talora
drammatiche (ove l’evento lesivo si sia verificato) venga a dipendere dal caso (potrebbe in tal senso
parlarsi di una responsabilità oggettiva mascherata): il problema risultava meno grave fino ad
alcuni anni orsono, perché il reato colposo di evento non conduceva mai, in pratica, a scontare una
pena detentiva: ma oggi – come si vedrà nel corso di diritto penale II – non è più così, posto che il
reato colposo può talora comportare detenzioni di lunga o anche lunghissima durata;
- l’esigenza di operare, piuttosto, un intervento anticipato, riferito alla realizzazione delle
condotte pericolose, attraverso sanzioni amministrative o sanzioni penali non detentive (si
pensi alle sanzioni concernenti la violazione delle norme sulla circolazione stradale o delle
norme intese alla prevenzione degli infortuni sul lavoro); la disfunzionalità a questi fini della
mancanza di un apparato di pene principali non detentive (si consideri che l’alternativa tra
competenza amministrativa oppure penale circa l’accertamento e la sanzione di illeciti non
sanzionati in modo detentivo dipende soprattutto da considerazioni concernenti l’opportunità
dell’affidare o meno alla pubblica amministrazione la gestione di determinati contenziosi,
vale a dire circa la sussistenza o meno della necessità di fare pur sempre affidamento, per
una data materia, ai maggiori poteri di indagine e alla peculiare indipendenza della
magistratura);
- l’ambivalenza del sistema penale – sovente indicata come la schizofrenia del legislatore
penale – che ha sì introdotto talune discipline finalizzate all’intervento diretto sulle condotte
pericolose, ma nel contempo tende a enfatizzare le pena nel caso della produzione di un
evento non voluto, come nelle ipotesi aggravate dell’omicidio colposo o nel caso
dell’omicidio stradale (v. infra): fino a livelli di pena vicini a quelli propri dell’omicidio
doloso;
- alla luce di quanto sin qui s’è detto, può essere utile approfondire schematicamente l’iter
motivazionale complessivo del comportamento umano, vale a dire il concatenarsi delle triadi
prospettiva-condotta-evento;
si noti che ciascuna la catena PX–>C–>X (prospettiva mentale, condotta, evento) costituisce, nel
suo insieme, la condotta (CA) derivante da una prospettiva mentale antecedente (PA) e orientata a un
evento ulteriore (EA), catena questa che, a sua volta, costituisce la condotta CB derivante da una
prospettiva antecedente PB e orientata a un evento ulteriore EB, e così via (a sua volta la condotta C
può essere suddistinta in ulteriori catene del tipo PX–>C–>X, fin quando la condotta non potrà più
essere suddistinta essendo venuta a coincidere con un mero movimento corporeo); tutto questo
secondo il seguente schema:
- si consideri che, talora, la norma penale dà rilievo a prospettive pregresse – alla prospettiva della
prospettiva – quali moventi o motivi (per esempio ai fini di determinate circostanze aggravanti o
attenuanti o ai fini dell’art. 133 c.p.), oppure come fine ulteriore necessario per il configurarsi del
reato (casi di dolo specifico);
la categoria del dolo specifico concerne, in tal senso, i casi in cui la norma penale richiede, per il
configurarsi del fatto tipico, che la condotta risulti finalizzata a un certo scopo ulteriore rispetto alla
causazione dell’evento naturalistico (o rispetto alla condotta, ove si tratti di un reato di pura
condotta);
- la troppo scarsa attenzione dedicata dal diritto penale all’interrogativo circa il perché si determini
una data prospettiva mentale, da perseguirsi secondo un dato progetto causale (per lo più il diritto
penale si limita a ricostruire per esclusione le prospettive mentali che abbiano operato, senza
interrogarsi ulteriormente: salvo solo il caso estremo costituito dall’esclusione dell’imputabilità);
27.4
i profili soggettivi del fatto tipico nel codice penale:
- la coscienza e volontà della condotta ai sensi dell’art. 42, co. 1, c.p., come requisito generale di
tutti i reati: da non confondere con la rappresentazione e la volizione dell’evento (scil., del fatto
tipico), di cui all’art. 43 con riguardo al dolo e alla differenza fra dolo e colpa; il problema della
tendenza a normativizzare tali nozioni con riguardo ad atti inconsapevoli, ma che si suppone che si
sarebbero potuti controllare, nell’ambito del concetto di suitas;
il reato doloso:
- la previsione del possibile realizzarsi dell’evento quale caratteristica sia del dolo che della colpa
con previsione, o cosciente (sussistendo, invece, nella colpa incosciente la mera prevedibilità): si
noti che l’art. 43 c.p. (come anche l’art. 61, n. 3), non parla ai fini della colpa cosciente di (mera)
rappresentazione del rischio, cioè di mera rappresentazione del carattere pericoloso della condotta
(cioè del rischio a essa riferibile), ma di rappresentazione (previsione) dell’evento come possibile
esito della condotta: evento che, dunque, dev’essere stato oggetto di rappresentazione ai fini della
colpa cosciente secondo le caratteristiche concrete essenziali del suo realizzarsi;
- il reato doloso in rapporto a quello colposo (introduzione); le definizioni del reato colposo (o
contro l’intenzione) e del reato doloso (o secondo l’intenzione), nell’art. 43 c.p.;
in particolare, la definizione del dolo nell’art. 43 c.p., fondata sulla rappresentazione e sulla
volizione dell’evento; è la volizione, peraltro, che costituisce elemento caratteristico del dolo, in
quanto la rappresentazione dell’evento, come già si diceva, può essere presente anche nella colpa,
nel qual caso si tratterà di colpa cosciente;
- per valutare se la condotta della quale s’è già comprovata la causalità rispetto al prodursi
dell’evento penalmente significativo risulti dolosa o colposa (o anche caratterizzata da dolo diretto
o da dolo eventuale), vale a dire per accertare l’elemento soggettivo del reato, il giudice dovrà
interrogarsi preliminarmente – come già sappiamo – su quale sia stata la prospettiva mentale (P) che
abbia dato causa alla condotta (C) produttiva dell’evento (E) e dunque, in particolare, se tale
prospettiva abbia avuto per oggetto un evento X qualsiasi (PX) o proprio l’evento E (PE): caso,
quest’ultimo, in cui la condotta potrà dirsi caratterizzata dal dolo intenzionale.
In particolare, pertanto, l’accertamento della volizione (ovvero dell’intenzionalità) nel dolo,
richiederà di prendere in considerazione il nesso causale tra la condotta (C) e la prospettiva (P) che,
per l’appunto le abbia dato causa, tendendo conto del fatto che mentre nell’accertamento del nesso
di causalità tra la condotta (C) e l’evento (E) la condotta stessa costituisce l’antecedente (rispetto
all’evento), nell’accertamento dell’elemento soggettivo la condotta costituisce il conseguente,
rispetto alla prospettiva mentale (P);
come, allora, il giudice potrà accertare quale sia stata la prospettiva (P) che abbia dato causa alla
condotta (C) e, in particolare, se tale prospettiva sia stata proprio quella di cagionare l’evento (E): o,
in altre parole, come dovrà condurre l’accertamento del dolo intenzionale, o del suo non
sussistere?
a tal proposito va segnalata innanzitutto l’inadeguatezza del riferimento generico, circa
l’accertamento del dolo (intenzionale), a massime di esperienza, cioè a regolarità riguardanti il
comportamento umano in rapporto alla presenza di un dato fattore (del tipo: chi ha subìto un torto,
si vendica): regolarità, si noti, che comunque saranno sempre di tipo statistico, stante la capacità di
autodeterminazione degli esseri umani (per cui, a differenza delle leggi scientifiche riscontrabili tra
accadimenti naturalistici, il fatto che una massima di esperienza possa essere smentita in un certo
numero di casi non la falsifica: è contemporaneamente vero, per esempio, sia che vi sono persone le
quali avendo subìto un torto si vendicano, sia che si sono persone le quali avendo subìto un torto
non si vendicano):
il rischio, infatti, è quello di trascurare, facendo riferimento per l’accertamento del dolo a massime
di esperienza (è, in effetti, abbastanza facile reperire massime di esperienza utili all’ipotesi
accusatoria), fattori rilevanti nel caso concreto che le smentiscano; per esempio, se A ha travolto, in
automobile, B e risulta che A avesse subìto in precedenza dei torti da B, si potrebbe essere indotti a
concludere che la condotta di A è stata dolosa, in forza della massima di cui sopra: quando invece
l’attenta considerazione dell’intero contesto situazionale potrebbe condurre a conclusioni diverse;
in realtà, per accertare che proprio una certa prospettiva mentale P abbia dato causa alla condotta C
e, quindi, per accertare il dolo intenzionale (cioè che la prospettiva P fosse proprio quella di
cagionale l’evento E verificatosi), si dovrà escludere ogni diversa prospettiva mentale che possa
plausibilmente aver dato causa alla condotta: il che può avvenire solo attraverso la descrizione più
accurata possibile del contesto in cui la condotta è stata tenuta (meglio, infatti, viene descritto tale
contesto, più si riduce il ventaglio delle prospettive rispetto ad esso plausibili);
si pone, con ciò, una problematica simile a quella già considerata in materia di causalità, con
riguardo alla pluralità delle cause (v. supra): salvo che nel nostro caso, a differenza di quello
richiamato, non sarà utilizzabile, in aggiunta, il criterio storico: circa l’accertamento della causalità
tra condotta ed evento, infatti, si discute di un conseguente (l’evento) e di un antecedente (la
condotta ipotizzata causale) che si sono entrambi verificati, e si tratta di stabile se tra di essi c’è
stato un nesso causale, laddove invece circa l’accertamento del dolo è dato solo il conseguente,
rappresentato dalla condotta, e si tratta di individuare l’antecedente, vale a dire quale prospettiva
mentale abbia dato causa alla condotta stessa);
il reato colposo:
- la responsabilità per colpa richiede che l’evento lesivo prodottosi costituisca la conseguenza non
voluta di una condotta la quale abbia creato il rischio non consentito della sua causazione,
così che il rimprovero di colpa consiste, essenzialmente, nel non aver ottemperato allo standard
comportamentale richiesto, nell’ambito di una certa attività, onde evitare il prodursi dell’evento
offensivo determinatosi;
1) ai fini della colpa occorre peraltro, in primo luogo,
che il soggetto cui venga addebitata l’illiceità della condotta sia un soggetto competente a
contrastare il prodursi dell’evento lesivo nei confronti della persona offesa: un soggetto, dunque,
che possa essere individuato come garante rispetto alla gestione del rischio che si sia risolto a
danno della specifica persona offesa (il datore di lavoro in un’impresa di nettezza urbana, pur
dovendo governare i fattori di rischio derivanti, per i lavoratori, dall’espletamento delle loro
mansioni, non può essere ritenuto competente rispetto al mal funzionamento di un cancello presso
uno dei tanti luoghi di raccolta dei rifiuti, ove ne sia derivato un danno per il lavoratore; e sebbene,
per esempio, fossero presenti in un cantiere fattori di rischio che, in effetti, si sarebbero dovuti
annullare o controllare, ma ciò non può comportare la responsabilità del titolare di quel cantiere
rispetto a danni che si siano prodotti verso chi, poniamo, si sia introdotto nottetempo nel cantiere
stesso, avendo forzato il cancello d’ingresso: esempi, questi, tratti dalla giurisprudenza della
Cassazione);
2) sempre ai fini della colpa, occorre altresì
che l’evento non voluto rilevante sul piano penale costituisca l’effetto, ex art. 43 c.p.,
- o della violazione di una regola finalizzata a evitarlo scritta («inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline»): c.d. colpa specifica;
- oppure della violazione di una regola finalizzata a evitarlo non scritta (negligenza o imprudenza
o imperizia): c.d. colpa generica;
l’evento penalmente rilevante dovrà configurarsi, in tal modo, come effetto della creazione di un
rischio non consentito del suo prodursi, attraverso la violazione di una regola scritta o non scritta
finalizzata a evitarlo;
considerato che una condotta potrà dirsi rischiosa rispetto al prodursi di un evento ove risulti
idonea, secondo un giudizio ex ante, a determinarlo (salvo il problema – v. infra – dell’entità del
rischio rilevante);
ciò premesso, ai fini dell’imputazione soggettiva della colpa risulterà necessario:
2.1. che il rischio dovesse essere percepito e, in particolare, che l’evento dovesse essere preveduto
da parte del soggetto agente, al pari di come l’avrebbe dovuto prevedere (secondo un iter causale
analogo a quello che abbia cagionato l’evento) qualsiasi individuo il quale avesse intrapreso una
condotta come quella di cui si discuta, nelle medesime circostanze e nelle medesime condizioni
soggettive (a parte le inadeguatezze a lui rimproverabili) in cui si sia trovato il soggetto agente:
il primo elemento del rimprovero di colpa, dunque, è dato dal fatto che il soggetto agente avrebbe
dovuto prevedere il verificarsi dell’evento;
2.2. ciò peraltro non risulta sufficiente: occorrerà altresì, affinché quel rischio possa dirsi non
consentito, che il soggetto agente avrebbe dovuto evitare di tenere la condotta: posto che correre
certi livelli di rischio non di rado è permesso dall’ordinamento e, in certi casi, è doveroso (si pensi a
un’operazione chirurgica certamente rischiosa, ma necessaria per cercare di salvare il malato);
non basta dunque, ai fini della colpa, che il possibile verificarsi di un evento offensivo come esito
della tenuta di una data condotta si dovesse prevedere o che, addirittura, sia stato effettivamente
previsto: vi sono molti casi, infatti, nei quali un agire pur implicante rischi è consentito;
in altre parole, non è sufficiente, ai fini del rimprovero di colpa, la prevedibilità dell’evento,
proprio perché il rischio di cui si doveva essere consapevoli potrebbe risultare consentito: per
cui è necessario domandarsi, altresì, se la condotta dovesse o meno essere evitata;
- in questo senso, il rimprovero di colpa consiste nel non aver ottemperato ai criteri
comportamentali richiesti per una certa attività onde evitare che da essa derivino eventi lesivi, vale a
dire nell’aver agito sebbene un dato evento lesivo si dovesse prevedere come conseguenza possibile
della condotta, in un contesto nel quale la condotta avrebbe dovuto essere evitata (sempre che il
soggetto – v. supra – fosse competente rispetto alla gestione del rischio nei confronti della persona
offesa);
il rimprovero di colpa, pertanto, ha contenuto prioritariamente normativo, e non psicologico (come
invece il dolo), consistendo in un giudizio: quello di non aver rispettato lo standard
comportamentale richiesto per una determinata attività (ma si vedano, infra, le considerazioni sulla
c.d. doppia misura della colpa);
2.3. ma come si può rispondere alla domanda se, da parte del soggetto agente, l’evento
dovesse essere preveduto e la condotta dovesse essere evitata?
2.3.1. la risposta è più semplice quando sussista, rispetto alla condotta della quale si discuta, una
regola di diligenza scritta, cioè positivizzata (colpa specifica, cui si riferisce l’art. 43 c.p. avendo
riguardo a leggi, regolamenti, ordini o discipline): regola la quale rende palese il rischio connesso
alla tenuta di una determinata condotta e segnala entro che limiti, o con quali modalità, quest’ultima
possa essere tenuta; in tal caso, infatti, si tratterà di confrontare la condotta posta in essere dal
soggetto agente con quella espressamente richiesta (senza che l’osservanza di quest’ultima esoneri,
peraltro, da eventuali doveri comportamentali ulteriori, suscettibili di rilievo in termini di colpa
generica); appaiono alquanto discutibili, tuttavia, norme cautelari così generiche – come per
esempio l’art. 141, co. 1, d.lgs. n. 285/1982 (cod. strad.) – da rendere praticamente impossibile al
soggetto agente il poter far conto sulla correttezza della propria condotta (si consideri la
problematica interazione tra la norma richiamata – secondo cui «è obbligo del conducente regolare
la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del
veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo [!] per la sicurezza delle persone e delle
cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione» – e le altre norme del cod. strad. che
indicano limiti precisi);
resta aperto, nondimeno, il problema della scarsa determinatezza che caratterizza le fonti della
regola scritta richiamate nell’art. 43 c.p.: il che prospetta una violazione sostanziale, circa la
delimitazione della responsabilità penale colposa anche specifica, del principio di riserva di legge;
2.3.2. l’accertamento è, invece, più problematico quando una regola di diligenza positivizzata non
sia disponibile (colpa generica, cui fa riferimento l’art. 43 c.p. avendo riguardo a negligenza,
imprudenza, imperizia), posto che in tale ipotesi il comportamento dovuto nella situazione concreta
dovrà inevitabilmente essere ricostruito a posteriori dal giudice;
2.3.2.1. a tal fine potrà dirsi, anzitutto, che l’evento doveva essere previsto quando fosse possibile
prevederlo (prevedibilità dell’evento); quando, dunque, fosse prevedibile: ma da parte di chi?
tradizionalmente, a tal proposito, di dice: da parte (dal punto di vista) dell’agente modello (l’ homo
eiusdem professionis vel condicionis), espressione che tuttavia va usata con cautela in quanto
troppo facilmente utilizzabile per riferire il giudizio a un soggetto ideale che sa sempre prevedere
tutto e sa sempre scongiurare qualsiasi evento offensivo; col pericolo che si operi una valutazione
non riferita al contesto situazionale concreto in cui abbia operato il soggetto agente e alle sue reali
condizioni, bensì alla luce di tutto quanto sia stato conosciuto a posteriori e di una regola
comportamentale creata, essa pure, a posteriori dal giudice;
appare dunque necessario precisare che quel giudizio andrà effettuato sulla base delle conoscenze
note e delle prassi comportamentali riconosciute come valide, all’epoca della condotta, nella
cerchia di coloro che svolgono l’attività o la professione della quale si discuta, avendo riguardo
al contesto effettivo in cui abbia agito l’agente concreto e alle sue caratteristiche personali:
escludendo il rilievo dei soli fattori che siano a lui direttamente rimproverabili;
l’espressione agente modello può dunque essere utilizzata solo se intesa come riassuntiva dei
requisiti appena indicati;
non potrà giungersi, peraltro, ad affermare che il giudizio sulla prevedibilità debba essere effettuato
dal punto di vista dell’agente concreto (che potrebbe non esser stato in grado di prevedere l’evento
proprio in ragione di un suo comportamento antidoveroso: si pensi a un medico che da anni non curi
il suo aggiornamento): ove così si affermasse, infatti, verrebbe meno il carattere stesso di giudizio
normativo proprio del rimprovero di colpa, cioè volto a riscontrare l’eventuale contrasto della
condotta con uno standard comportamentale socialmente richiesto;
nel senso descritto, si cerca dunque di avvicinare quanto più possibile il criterio di accertamento
della colpa generica a quello della colpa specifica (si rammenti ciò che s’è detto in rapporto alla
responsabilità medica), onde evitare accertamenti della colpa del tutto indeterminati;
2.3.2.2. si tratterà, poi, di rispondere al quesito circa il sussistere o meno del dovere di evitare la
tenuta della condotta (evitabilità della condotta), vale a dire circa il sussistere o meno, alla luce del
contesto concreto, del dovere di astenersi da una condotta pericolosa, nell’assenza di una regola
scritta;
deve osservarsi che tale giudizio – il quale andrà esso pure effettuato dal punto di vista di cui s’è
detto in rapporto al giudizio di prevedibilità – risulta meno problematico quando rischi e benefici
riguardino il medesimo individuo, potendosi operare in tal caso un bilanciamento fra gli stessi (si
pensi ai rischi e ai benefici prevedibili, per il medesimo paziente, di un difficile intervento
chirurgico);
quel giudizio, invece, risulterà assai più problematico allorquando rischi e benefici riguardino
individui diversi: in quest’ultima ipotesi, infatti, si pone il problema se davvero il criterio della
diligenza riferito alla responsabilità colposa possa consistere nel criterio del c.d. rischio zero, cioè
dalla esclusione ex ante di qualsiasi rischio, benché minimo (il che solleva il problema generale del
rischio minimo significativo ai fini della responsabilità colposa);
a quest’ultimo proposito l’auspicio è che delle esigenze meramente precauzionali si occupi in via
diretta il legislatore, vietando espressamente quelle condotte che, sebbene a rischio statistico (una
tantum) molto basso, si ritenga non debbano essere comunque tenute (sulla base del c.d. principio di
precauzione), data la gravità degli effetti che ne potrebbero derivare; il che vale a maggior ragione
per quelle condotte la cui stessa pericolosità resti dubbia, in quanto non scientificamente provata
pur in presenta di elementi che la rendano plausibile;
2.4. - la corretta ricostruzione della colpa secondo quanto sopra s’è evidenziato (riferendo, cioè, i
giudizi di prevedibilità dell’evento e di evitabilità della condotta al contesto effettivo in cui abbia
agito l’agente concreto, escluso soltanto il rilievo di fattori che siano a lui direttamente
rimproverabili) stempera la problematica comunemente indicata come doppia misura (oggettiva e
soggettiva) della colpa, vale a dire l’esigenza di domandarsi non soltanto se il soggetto agente abbia
disatteso lo standard comportamentale oggettivamente richiesto per una data attività, ma anche se il
medesimo fosse soggettivamente in grado di ottemperare a quello standard nel caso concreto (salva
l’irrilevanza scusante di cause a lui rimproverabili);
3. ciò considerato, deve altresì rilevarsi che
ai fini della responsabilità per colpa non è sufficiente che risulti causale la condotta posta in essere
fisicamente dal soggetto attivo, come richiesto dall’art. 40, co. 1, ma altresì che risulti causale la
violazione della regola finalizzata a evitare l’evento, come richiesto dall’art. 43 c.p. a proposito del
reato colposo: norma la quale richiede – è la c.d. causalità della colpa – che l’evento si sia
verificato «a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline», cioè che l’evento si sia verificato come conseguenza causale
della violazione di una regola – nel primo gruppo di casi non scritta, nel secondo scritta (v.
supra) – finalizzata a evitarlo;
pertanto si potrà dire (applicando la formula della condicio sine qua non) che la causalità di tale
violazione sussiste quando nel caso in cui la violazione non ci fosse stata – cioè nel caso in cui la
regola suddetta fosse stata rispettata – l’evento non si sarebbe verificato;
mentre non sussisterà la causalità della suddetta violazione, e quindi non sussisterà il reato,
quando anche nel caso in cui la violazione non ci fosse stata – cioè anche nel caso in cui la regola
suddetta fosse stata rispettata – l’evento si sarebbe verificato ugualmente: in altre parole quando
l’evento non sarebbe stato evitabile nemmeno tenendo il comportamento doveroso, cioè il
comportamento alternativo lecito; dunque, dovrà accertarsi, attraverso il giudizio controfattuale
tipico della prova relativa alla causalità, se l’evento si sarebbe o meno verificato ove fosse stato
tenuto il comportamento doveroso, cioè il comportamento alternativo lecito;
in altre parole, necessita che sia provata l’evitabilità dell’evento attraverso il rispetto della regola
che il soggetto agente avrebbe dovuto rispettare (in questo caso, dunque, non viene in gioco
l’evitabilità della condotta, di cui supra 2.3.2.2., bensì l’evitabilità dell’evento);
28.4
la prova della causalità penalmente significativa richiederà sempre, in questo senso, un giudizio
controfattuale riferito al comportamento alternativo lecito (non è decisivo il fatto che guidare
un’automobile sia stato causa di una lesione, bensì il fatto che lo sia stato, per esempio, il
superamento del limite di velocità: e ciò lo si potrà affermare ove si provi che, nel caso in cui il
limite fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe prodotto, mentre non lo si potrà affermare nel
caso in cui l’evento si sarebbe prodotto ugualmente anche rispettando quel limite: ad esempio
perché una persona si sia immessa sulla carreggiata immediatamente prima del sopraggiungere di
un’automobile, rendendo vano l’effetto di qualsiasi frenata; del pari, la responsabilità colposa del
medico che pure abbia agito in modo antigiuridico dovrà essere esclusa ove l’evento dannoso per il
paziente si sarebbe prodotto anche se il medico avesse tenuto il comportamento corretto);
non basta, si noti, che sia risultata causale la violazione di una regola qualsiasi, ma necessita che sia
risultata causale la violazione proprio di una regola finalizzata a evitare l’evento: se Tizio
tenendo la sinistra nella guida di un veicolo fa schizzare un sassolino che acceca una persona, la sua
violazione è sì risultata causale, ma non costituisce la violazione di una regola finalizzata a evitare
quel tipo di eventi; se il medico violando il consenso, sebbene rispettando la lex artis (v. supra), ha
operato essendone derivato un danno per il malato ha del pari posto in essere una trasgressione che
è risultata causale, non costituente, tuttavia, la violazione di una regola finalizzata a evitare un
danno alla salute;
si consideri inoltre che, diversamente dai casi in cui una condotta può essere tenuta se si rispettano
certe regole, nei casi in cui una condotta non dev’essere essere mai tenuta (p. es. sparare a una
persona) il giudizio sulla causalità della condotta coincide con il giudizio sulla causalità della colpa:
chiedersi, infatti, che cosa sarebbe avvenuto se si fosse tenuto il comportamento alternativo lecito
coincide, in quel caso, con il chiedersi che cosa sarebbe avvenuto se non si fosse tenuta la condotta
stessa, in quanto sempre illecita;
va peraltro evidenziato un elemento contraddittorio nella ricostruzione della c.d. causalità della
colpa: mentre il giudizio controfattuale nel caso di prova della causalità relativa alla condotta deve
attestare oltre ogni ragionevole dubbio che in assenza della condotta (attiva od omissiva) l’evento
non si sarebbe realizzato, nel giudizio controfattuale relativo al comportamento alternativo lecito in
tema di reati commissivi colposi si è soliti ritenere sufficiente, per affermare la responsabilità per
colpa, il fatto che tenendo il comportamento alternativo lecito vi sarebbe stata una significativa
probabilità di non realizzazione dell’evento offensivo (un indirizzo dottrinale che può considerarsi
particolarmente sensibile ha richiesto il sussistere di una probabilità superiore, per lo meno, al
50%); la razionalità di una simile diversità di valutazione, tuttavia, sfugge: tanto più ove si consideri
che è piuttosto facile descrivere un medesimo comportamento sia come omissivo, sia come
commissivo colposo per mancato rispetto di un certo adempimento (secondo la visione tradizionale,
del resto, finirebbe per essere più garantito nell’ipotesi della causazione di un danno, poniamo, il
medico che abbia omesso in radice di visitare il malato, contravvenendo ai suoi doveri, rispetto al
medico che abbia correttamente visitato il medesimo e, successivamente, abbia attivato la terapia
necessaria, ma compiendo un errore nel corso della sua esecuzione).
si rammenti che l’imputazione del reato per colpa solleva molte ulteriori problematiche particolari;
fra di esse, per esempio:
il tema relativo alla differenziazione delle responsabilità nell’ambito di equipe o di collegi (consigli
di amministrazione, collegi peritali, ecc.;
il tema dell’affidamento che possa essere legittimamente riposto, senza ulteriore verifica, nella
correttezza di comportamenti altrui;
il tema della c.d. colpa di organizzazione, cioè della rilevanza ai fini del prodursi di un evento
offensivo non voluto di carenze organizzative o strutturali a molte del comportamento posto in esse
dal soggetto che abbia tenuto la condotta immediatamente lesiva (si pensi all’inadeguatezza di una
diagnosi medica per la obsolescenza dei macchinari disponibili);
il tema della delega di funzioni, da parte del soggetto titolare di obblighi nell’ambito di una
organizzazione complessa;
- la creazione dottrinale e giurisprudenziale di forme del dolo nelle quali l’evento, in realtà, non è
voluto (non è oggetto di intenzione), con una palese forzatura di quanto previsto dall’art. 43 c.p. e,
in tal modo, del principio costituzionale di legalità (artt. 25 Cost. e 1 c.p.): il conseguente
affiancamento alla figura del dolo quale descritta dal codice (dolo intenzionale) delle figure
ulteriori costituite dal dolo c.d. diretto e dal dolo c.d. eventuale (o indiretto).
- meno problematica risulta la figura del dolo diretto, essendo essa chiaramente caratterizzata da
uno stato psicologico diverso dal dolo intenzionale, ma anche dalla colpa cosciente; il dolo diretto si
caratterizza, infatti, per la certezza oggettiva oltre ogni ragionevole dubbio e per la cognizione
soggettiva nei medesimi termini del realizzarsi dell’evento non voluto (il criterio è quello della
certezza oltre ogni ragionevole dubbio, non quello dell’alta probabilità!);
nel dolo diretto, dunque, il soggetto agente non è semplicemente consapevole di esporre taluno, con
la sua condotta, a un certo rischio (come nella colpa cosciente), ma è pienamente disposto, per
raggiungere lo scopo della sua condotta, a pagare il prezzo costituito dal verificarsi (certo)
dell’evento lesivo in sé non voluto;
- le cose stanno in modo assai diverso per il dolo eventuale, che vorrebbe individuare un elemento
aggiuntivo rispetto alla rappresentazione in termini di possibilità (e non di certezza) di un evento
non voluto propria della colpa cosciente, in modo da far sì che una condotta avente le caratteristiche
di quest’ultima sia punita non a titolo di colpa, ma a titolo di dolo: elemento aggiuntivo la cui
individuazione si è rivelata oltremodo incerta;
l’estensione del dolo alla figura eventuale è nata in giurisprudenza, probabilmente, in quanto non si
voleva limitare la punibilità per alcuni delitti di ambito economico, non puniti con pene
particolarmente elevate, al solo caso del dolo intenzionale: si deve considerare, infatti, che ai sensi
dell’art. 42, co. 2 e 4, c.p. i delitti sono puniti, di regola, solo per dolo, a meno che sia
espressamente prevista la loro punibilità anche per colpa (come accade per omicidio e lesioni),
mentre le contravvenzioni sono sempre punite sia per dolo che per colpa; come già si osservava, in
anni recenti il dolo eventuale è stato utilizzato, tuttavia, anche in rapporto a omicidio e lesioni, con
conseguenze sanzionatorie molto pesanti: tendenza, questa, ora contrastata dalla cit. sentenza della
Cassazione a sezioni unite sul caso ThyssenKrupp (v. infra);
- si consideri che il dolo eventuale non rappresenta una forma diminuita del dolo, ma individua i
requisiti sufficienti per punire a titolo di dolo: così che la definizione del dolo eventuale, nella
misura in cui tale figura viva in giurisprudenza e dottrina, viene a costituire la vera definizione del
dolo, in quanto indica gli elementi bastanti perché un delitto sia punibile per dolo;
- il darsi, anche nel dolo eventuale come nella colpa (e di per sé anche nel dolo diretto), di una
condotta che non è stata prescelta al fine di cagionare l’evento offensivo penalmente rilevante; solo
nel caso di dolo intenzionale, infatti, la condotta è prescelta al fine di cagionare l’evento e, pertanto,
fra quelle che possano avere un’idoneità elevata a conseguire tale scopo (caratterizzandosi dunque
per altro livello di pericolosità): laddove invece nel contesto della colpa (soprattutto) cosciente, ma
anche in quello del dolo eventuale, la condotta che cagiona l’evento non voluto manifesta, di regola,
una modesta idoneità ex ante a cagionarlo, non essendo stata prescelta per quel fine (potrebbe darsi
più facilmente una condotta caratterizzata da un alto livello di pericolosità nella colpa incosciente,
posto che il soggetto che agisce, in tal caso, non è di regola consapevole del rischio che sta
producendo); sono dunque rari i casi qualificati di dolo eventuale in cui davvero sussista una alta
probabilità di causazione dell’evento (sebbene sovente si ravvisi in tale alta probabilità una
caratteristica di tale categoria);
- l’inadeguatezza delle teorie tradizionali della rappresentazione e del consenso a delimitare la
categoria del dolo eventuale:
- la teoria della rappresentazione ha riguardo all’entità probabilistica del rischio di causazione
dell’evento ovvero, di fatto, al giudizio sul tipo di rischio attivato (in termini di riprovevolezza
sociale, ecc.); essa dà luogo a una normativizzazione della responsabilità dolosa o, in altre prole,
alla perdita di qualsiasi differenza qualitativa tra dolo e colpa (la differenza fra dolo e colpa
finirebbe per diventare meramente quantitativa, cioè fondata solo sulla diversa gravità del rischio, e
la definizione del dolo eventuale finirebbe per costituire la vera definizione del dolo: tutto ciò
dimentica che il dolo costituisce uno stato psicologico, mentre la colpa ha natura prioritariamente
normativa, in quanto giudizio di inottemperanza rispetto al comportamento dovuto); le
caratteristiche oggettive del rischio non hanno a che fare con i profili attinenti alla prova
dell’elemento soggettivo e, pertanto, della colpevolezza: un rischio grave, infatti, può essere attivato
sia con dolo, sia con colpa;
- la teoria del consenso ha riguardo a un elemento di approvazione interiore della possibilità che si
determini l’evento offensivo, elemento che si vorrebbe costituire una sorta di analogo della
volizione; la nozione di consenso, tuttavia, risulta inadeguata a individuare uno stato psicologico
effettivo che differenzi il dolo eventuale dalla colpa cosciente, lasciando in tal modo aperta – come
evidenzia la formula classica, a lungo dominante in giurisprudenza, dell’accettazione del rischio –
la più ampia discrezionalità in sede giurisprudenziale (di per sé, tutti coloro che agiscono in colpa
cosciente, accettano di produrre un rischio): così che, pur quanto si dichiari di optare per la teoria
del consenso, onde evitare la critica di appiattire il dolo sull’elemento rappresentativo, si finisce
facilmente per adoperare nel giudizio in concreto valutazioni pur sempre riferite al giudizio sul tipo
di rischio cagionato, cioè riferite, in realtà, alla teoria della rappresentazione;
- si consideri come queste impostazioni abbiano consentito, rispetto all’accertamento dell’elemento
soggettivo, un troppo facile passaggio, attraverso criteri presuntivi od oltremodo discrezionali,
dalla constatazione della colpa incosciente, all’attribuzione della colpa cosciente e, di qui,
all’attribuzione del dolo eventuale (specie ove si ricorra, per quest’ultima categoria, alla nozione
tradizionale di accettazione del rischio); ciò, per quanto riguarda il primo passaggio, in
conseguenza della maggior propensione a logiche presuntive dell’accertamento concernente
l’elemento rappresentativo rispetto a quello concernente l’elemento volitivo: circa la prova
dell’elemento rappresentativo, infatti, appare inevitabile un certo grado di generalizzazione (ferma
in ogni caso la necessità di tener conto di tutti i dati del caso concreto), non potendosi constatare in
via diretta quanto un determinato soggetto si sia rappresentato nella propria mente; circa il secondo
passaggio, in conseguenza dell’incertezza poco sopra illustrata circa confine tra colpa cosciente e
dolo eventuale, che s’è dimostrata aperta a valutazioni giudiziarie assai variegate (si tratterà ora di
verificare se il problema potrà essere almeno in parte circoscritto sulla base degli orientamenti
espressi dalla sentenza delle sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp, di cui subito diremo);
- rimanendo fermo il fatto che la figura del dolo eventuale non ha un riscontro di diritto positivo, in
palese contrasto col principio costituzionale di legalità, e preso atto, nondimeno, che tale figura
sussiste nella prassi giudiziaria penale, deve constatarsi che l’unico stato psicologico davvero
diverso dalla volizione dell’evento (dolo intenzionale) e dalla mera previsione del suo possibile
realizzarsi (colpa cosciente) è quello in cui il soggetto agente è disposto, per realizzare i suoi fini,
non soltanto a produrre un rischio di causazione dell’evento offensivo, ma a produrre l’evento
stesso; ciò si realizza senza dubbio, come già s’è detto, nel caso del dolo c.d. diretto (in cui il
soggetto non agisce al fine di cagionare l’evento offensivo, ma quest’ultimo risulta, oltre ogni
ragionevole dubbio, conseguenza certa della sua condotta e come tale viene rappresentato dal
soggetto che agisce); il medesimo stato psicologico può tuttavia riscontrarsi anche quando
sussistono le condizioni della (prima) formula di Frank (giurista tedesco attivo tra la fine
dell’ottocento e l’inizio del novecento): il soggetto agente era consapevole della pericolosità della
sua condotta, non era certo del verificarsi dell’evento (altrimenti si tratterebbe di dolo diretto),
ma vi sono gli elementi per ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che avrebbe continuato ad
agire anche nel caso in cui fosse stato certo di produrre l’evento offensivo (o, in altre parole,
quando non vi sono elementi i quali possano deporre nel senso che dinnanzi al verificarsi certo
dell’evento egli avrebbe rinunciato a tenere quella condotta; se, dunque, la categoria del dolo
eventuale viene di fatto utilizzata, l’unica definizione che consente di circoscriverne i confini,
limitandone l’ambito applicativo, è quella rappresentata dalla formula di Frank; formula che si
fonda su un giudizio ipotetico controfattuale (come avviene in merito alla causalità), ma è intesa a
cogliere una condizione psicologica reale;
la formula di Frank, valorizzata da una parte della dottrina, è stata utilizzata da Cass. sez. unite 2611-2009, n. 12433, in tema di dolo eventuale e ricettazione (v. infra), nonché da altre sentenze
successive della Cassazione; in senso ampiamente conforme alla medesima impostazione muove,
con ampio apparato argomentativo, Cassazione sez. unite 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp), cit.:
come già si diceva, tale sentenza si oppone molto fermamente ai processi di normativizzazione del
dolo, e, in tal senso, alle impostazioni fondate sulle teorie della rappresentazione e su formule
indeterminate come quelle proprie delle teorie del consenso, ribadendo che il dolo si fonda sul
«momento volitivo»; in tale quadro, essa riconosce il ruolo fondamentale della formula di Frank:
cade tuttavia in un equivoco quando afferma che tale formula non può costituire l’unico indicatore
del dolo eventuale, e ciò poiché non sempre il giudizio controfattuale da essa espresso offrirebbe
risultati evidenti, così che ad essa dovrebbero affiancarsi altri indizi (di cui fornisce
esemplificazioni al n. 51); l’equivoco sta nel fatto che qualsiasi definizione di concetti non
suscettibili di immediata accertabilità empirica necessita di criteri finalizzati a valutare se nel caso
concreto sussistano i requisiti richiesti dalla definizione stessa (come s’è visto anche per la formula
della condicio sine qua non in quanto definizione della causalità, definizione la quale necessita,
perché possa dirsi che ne sussistano i presupposti nel caso concreto, del ricorso al criterio del
riferimento a leggi scientifiche): per cui gli indizi ulteriori di cui parla la sentenza delle Sezioni
Unite non costituiscono affatto indicatori del dolo eventuale che si affiancano alla formula di Frank,
ma criteri cui è necessario fare riferimento per verificare se si realizzino i presupposti di tale
formula in quanto unica possibile definizione del dolo eventuale: cioè per verificare se sussistano
elementi i quali consentano di concludere in modo univoco (oltre ogni ragionevole dubbio, vale a
dire senza l’emergere di alcun fattore il quale deponga in senso contrario) che il soggetto avrebbe
agito anche nella certezza di realizzare l’evento non voluto;
4.5
- la non configurabilità del dolo eventuale nei reati omissivi impropri quanto l’omissione non
abbia avuto un fine dal quale sia derivato il rischio che il soggetto abbia omesso di contrastare
(quando, cioè, il rischio sia insorto indipendentemente dalla condotta omissiva dell’imputato:
esempio del vigile del fuoco che non sia intervenuto in una stanza in fiamme nonostante dovesse o
dei genitori che per motivazioni religiose non si siano attivati per la trasfusione di sangue necessaria
alla sopravvivenza della figlia minorenne); deve, infatti, essere ritenuto requisito minimo del dolo
eventuale – anche nel caso in cui, per ipotesi, sussistano i requisiti di cui alla formula di Frank – il
fatto che il rischio per la persona offesa sia insorto quale costo di un fine perseguito con la sua
condotta dal soggetto agente;
- si consideri infine, circa l’oggetto del dolo, che l’elemento intenzionale di una data fattispecie
criminosa riguarda soltanto – oltre alla volontà di tenere la condotta, ai sensi dell’art. 42, co. 1, c.p.
– l’evento inteso in senso naturalistico (ai sensi dell’art. 43 c.p.) e, quando richiesto, il fine oggetto
del dolo specifico (solo l’evento e tali fini costituiscono, infatti, gli scopi perseguiti attraverso la
condotta):
gli altri elementi della fattispecie (per esempio un’eventuale qualifica soggettiva) e la stessa offesa
del bene tutelato (in termini di danno, o in termini di pericolo) devono invece costituire – anche
quando sussista, nei termini predetti, il dolo intenzionale e affinché si possa parlare di dolo
intenzionale – oggetto di una rappresentazione certa e dunque, potremmo dire, di una
rappresentazione in termini di dolo diretto;
si rammenti che l’offesa del bene tutelato – evento in senso giuridico – deve essere presente anche
nei reati di pura condotta, nei quali il dolo viene tendenzialmente a coincidere con la volontà di
tenere la condotta, ferma restando, peraltro, la necessità che sussista la consapevolezza di offendere,
in tal modo, quel bene;
il problema del configurazione, nel codice Rocco, di forme di responsabilità senza colpevolezza e,
in particolare, di responsabilità oggettiva, cioè fondata sul mero nesso di causalità tra condotta ed
evento, senza dolo né colpa: come si evince dall’art. 42, co. 3, c.p.:
ipotesi, queste, che si fondano sulla logica del c.d. versari in re illicita, secondo la quale ove si sia
voluta, anche a titolo di concorso, la commissione di un reato pur modesto, ogni ulteriore
conseguenza non voluta di quel fatto viene applicata sulla base del solo rapporto causale con la
condotta tenuta dal soggetto agente;
esemplificazioni:
la preterintenzione ex artt. 43 c.p., della quale l’unica fattispecie codicistica è costituita
dall’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);
i delitti aggravati dall’evento: p. es. i delitti di cui agli artt. 572 (maltrattamenti) e 593 (omissione
di soccorso ) c.p.;
le ipotesi di evento diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116 c.p.)…
e di mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti (art. 117 c.p.);
la incostituzionalità della responsabilità senza colpevolezza e, in particolare, della
responsabilità oggettiva è stata affermata con la sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale,
che ha riconosciuto l’operatività nell’ordinamento penale italiano del principio di colpevolezza
ricavandolo dall’art. 27, co. 1. della Costituzione (secondo cui «la responsabilità penale è
personale»):
con tale sentenza, infatti, la Corte costituzionale ha stabilito che la responsabilità personale (cioè
tipica degli esseri umani) è solo la responsabilità colpevole, vale a dire quella che presuppone la
rimproverabilità del soggetto agente,
tale sentenza aveva affrontato un’ipotesi particolare di responsabilità senza colpevolezza, emergente
all’art. 5 c.p., relativo all’errore di diritto su norma penale: norma che prevedeva l’irrilevanza in
ogni caso, secondo il brocardo ignorantia legis non excusat, dell’errore di diritto, anche ove l’errore
non fosse dovuto a colpa e risultasse, pertanto, inevitabile;
così che proprio sulla base della riconosciuta operatività del principio di colpevolezza
nell’ordinamento penale italiano tale sentenza ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 5 c.p., nella
parte in cui precedentemente non escludeva la punibilità ove l’errore risultasse inevitabile
(cioè non colposo): in tal modo violando il principio di colpevolezza;
- dalla sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale deriva altresì, dunque, l’incostituzionalità
delle ipotesi in cui il codice penale prevedeva ipotesi di responsabilità penale senza dolo e senza
colpa, cioè di responsabilità oggettiva, fondate sulla sussistenza del solo nesso di causalità:
tali ipotesi, dunque, dovranno essere re-interpretate, oggi, richiedendo almeno la colpa
(generica) del soggetto agente rispetto alla verificazione dell’evento non voluto, cioè la sua
prevedibilità (dato che il dovere di evitare la tenuta della condotta, trattandosi di una condotta di
base penalmente illecita, deve ritenersi scontato);
così sia nell’omicidio preterintenzionale, sia rispetto agli eventi aggravatori nei delitti aggravati
dall’evento, sia rispetto al reato diverso da quello voluto nelle ipotesi degli artt. 116 e 117 c.p.;
si è resa necessaria, pertanto, una rilettura delle ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nel
codice Rocco in base al principio di colpevolezza, che esige, quantomeno, il sussistere della colpa
in rapporto al prodursi dell’evento non voluto, e dunque, come s’è detto, la sua prevedibilità;
restano, peraltro, tutte le problematicità correlate a quest’ultimo concetto (v. supra): ove in
particolare essa fosse interpretata con prevedibilità in astratto o riferita a livelli statistici minimi si
avrebbe una vera e propria frode delle etichette, con il perdurare di fatto della responsabilità
oggettiva;
- la disciplina dell’errore di fatto (art. 47, co. 1 e 2, c.p.), che scusa purché non sia colposo, nel
qual caso si risponde a titolo di colpa ove il reato colposo sia previsto dalla legge;
ove l’errore sia scusato, residua la responsabilità per un eventuale reato diverso (se p. es. non sono
punito per peculato, in seguito a un errore sulla mia qualifica di pubblico ufficiale, ma sussistono i
requisiti di una appropriazione indebita, ne rispondo;
(si noti che sia l’errore di diritto, sia l’errore di fatto, investono elementi della fattispecie
integratrice, per cui sono entrambi errori sul fatto);
sulla diversa rilevanza dell’errore colposo di diritto (che secondo l’impostazione dominante
lascia sussistere la responsabilità a titolo di dolo) e dell’errore colposo di fatto (punibile solo a
titolo di colpa): la contraddittorietà di questo di questo assetto normativo in rapporto al principio di
colpevolezza, il quale dovrebbe esigere non soltanto che per punire sia necessaria, almeno, la colpa,
ma anche che non si risponda per dolo quando sussista nel soggetto agente la sola colpa (come
avviene nel caso dell’art. 5, ma anche nelle ipotesi, pur reinterpretate nel senso sopra indicato, di cui
agli artt. 116 e 117 c.p.);
- l’errore di diritto su norma extrapenale (art. 47, ult. co., c.p.) cioè su una norma non penale
richiamata dalla fattispecie incriminatrice o su un concetto che trova la sua definizione al di fuori
del codice penale: dinnanzi al disposto dell’art. 47, ult. co., c.p., per cui simile errore risulterebbe
sempre scusabile, la giurisprudenza ha introdotto la distinzione fra norme extrapenali integratrici o
non integratrici della fattispecie penale, ritenendo di poter estende all’errore su una norma ritenuta
integratrice la disciplina di cui all’art. 5 c.p. e, di fatto, giudicando sempre le norme extrapenali
come integratrici (secondo una vera e propria abrogazione di fatto della norma in esame);
la disciplina (analoga a quella concernente l’errore di fatto) in tema di erronea supposizione
dell’esistenza di una causa (nel codice circostanza) di esclusione della pena, ex art. 59, co. 4,
c.p.(il caso Re Cecconi);
la disciplina (implicante essa pure una responsabilità analoga) del c.d. eccesso colposo di cui all’art.
55 c.p., relativo ad alcune cause di giustificazione: la distinzione tra eccesso effettivamente colposo
(p.es., la persona in legittima difesa credeva, per un errore di valutazione del contesto, di reagire in
modo proporzionato) ed eccesso doloso (quella medesima persona era pienamente consapevole di
reagire in modo sproporzionato);
queste normative, che riprendono la disciplina dell’errore di fatto, configurano insieme a
quest’ultima, ipotesi di c.d. colpa impropria;
l’adeguamento al principio di colpevolezza, realizzato nel 1990 per iniziativa espressa del
legislatore, del regime di rilevanza soggettiva delle circostanze aggravanti (art. 59, co. 2, c.p.), le
quali, in precedenza, rilevavano oggettivamente, mentre ora devono risultare conoscibili (rilevano
solo se conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa);
- la permanente rilevanza oggettiva (perché in bonam partem) delle circostanze attenuanti e
delle cause (o circostanze) di esclusione della punibilità: art. 59, co. 1, c.p.);
- la discutibile irrilevanza delle circostanze non solo aggravanti, ma anche attenuanti, ritenute
per errore esistenti (putative): mentre, come già s’è detto, le cause (circostanze) putative (cioè
erroneamente supposte) di esclusione della pena rilevano ai sensi dell’art. 59, co. 4., c.p.).
- aberratio ictus (offesa arrecata a persona diversa da quella voluta) e aberratio delicti (reato
diverso da quello voluto): gli artt. 82 e 83 c.p. in quanto norme che derogano all’applicabilità delle
regole generali nelle ipotesi ivi contemplate;
i profili di responsabilità oggettiva nell’art. 82 c.p. (ai sensi di tale norma il soggetto agente
risponde, poniamo, di un omicidio doloso, piuttosto che del concorso fra un omicidio tentato e un
omicidio colposo);
il significato dell’espressione a titolo di colpa nell’art. 83 c.p. (il codice Rocco riteneva che si
dovesse punire per colpa anche in assenza di una prevedibilità dell’evento non voluto, oggi in
ossequio al principio di colpevolezza quest’ultima dovrebbe comunque sussistere);
la diversa disciplina della aberratio ictus e della aberratio delicti plurilesive, al co. 2 di entrambe le
norme (si consideri che ai fini della aberratio delicti plurilesiva si deve tener conto anche del
tentativo inerente al reato voluto);
- le condizioni oggettive di punibilità (artt. 44 c.p.): possono ritenersi non coperte dal principio di
colpevolezza, e pertanto rilevare oggettivamente (cioè senza essere coperte dal dolo o dalla colpa)
solo se estrinseche al reato, cioè tali che dal loro sussistere o meno non dipenda la lesione del bene
giuridico protetto dal reato cui si riferiscono (in quanto rispondenti a mere valutazioni politicocriminali del legislatore circa l’opportunità di punire);
condizioni che, invece, debbano considerarsi intrinseche al reato (tali, cioè, che dal loro sussistere o
meno dipenda la lesione del bene giuridico protetto) costituiscono a tutti gli effetti elementi della
fattispecie di reato e necessitano, pertanto, di essere coperti dal dolo o dalla colpa, in conformità al
principio di colpevolezza;
esemplificazione con riguardo al ruolo del pubblico scandalo rispetto al delitto di incesto (art. 564
c.p.) e al ruolo della dichiarazione di fallimento con riguardo ai delitti di bancarotta (artt. 216 e 217
l.fall.);
5.5.
- l’imputabilità (artt. 85-98 c.p.): problemi relativi alla definizione e all’accertamento;
l’inadeguatezza di un’interpretazione letterale, che si rivelerebbe oltremodo restrittiva, della
formula di cui all’art. 85 costituita dall’incapacità d’intendere e di volere; il necessario
riferimento al pur problematico concetto di una capacità normale;
in particolare, l’esclusione dell’imputabilità per vizio totale di mente ed età inferiore a
quattordici anni (artt. 88 e 97 c.p.) o inferiore al 18 anni per immaturità (art. 98 c.p.); il carattere
non esaustivo del riferimento esplicito a tali condizioni e l’apertura alla rilevanza di forme
psicotiche gravi; la problematicità dell’accertamento del vizio di mente;
- la non punibilità del soggetto inimputabile autore di reato (per mancanza di colpevolezza), ma
l’applicabilità nei suoi confronti, ove giudicato socialmente pericoloso, di una misura di
sicurezza: v. supra;
l’irrilevanza ai fini della non imputabilità del vizio parziale di mente, che comporta, invece, una
diminuzione di pena (art. 89 c.p.);
l’interpretazione della norma che dichiara irrilevanti ai fini dell’imputabilità gli stati emotivi o
passionali (art. 90 c.p.);
le presunzioni (o finzioni) di imputabilità, concernenti l’ubriachezza e l’assunzione di
stupefacenti (artt. 91-95 c.p.);
- in particolare, l’irrilevanza circa il giudizio sull’imputabilità dell’aver agito in stato di
ubriachezza (o assunzione di stupefacenti) volontaria o colposa (art. 92 c.p.), oppure abituale
(art. 94 c.p.), e il contrasto di tale disciplina con il principio di colpevolezza;
le presunzioni di imputabilità in relazione ai reati colposi (cenni sul rapporto con i reati di
omicidio/lesioni colposi e omicidio stradale con riguardo al problema della guida in stato di
ebbrezza);
- l’esclusione dell’imputabilità per cronica intossicazione (art. 95 c.p.) e nelle ipotesi ben rare di
caso fortuito o forza maggiore (art. 91 c.p.);
- lo stato preordinato di incapacità di intendere e di volere (actio libera in causa: artt. 87 e 92, co. 2,
c.p.);
- sordomutismo (art. 96 c.p.);
- il rilievo onde poter escludere la colpevolezza della discussa categoria rappresentata dalla
inesigibilità (consistente nell’impossibilità di richiedere al soggetto che si trova in una certa
condizione quanto si può richiedere, invece, ad altri soggetti); esemplificazione in rapporto all’art.
384 c.p.;
- l’antigiuridicità come assenza di cause di giustificazione (o scriminanti), le quali rendono lecito
il fatto cui si riferiscono;
cenni sulla questione dell’inquadramento delle cause di giustificazione fra gli elementi del reato;
- la differente ratio delle diverse situazioni di esclusione della punibilità (ovvero, secondo la
terminologia utilizzata dal codice penale, delle diverse circostanze che escludono la pena):
a) cause di giustificazione, le quali rendono il fatto lecito (non antigiuridico), presupponendo una
scelta operata dall’ordinamento giuridico tra beni in conflitto (nel nostro caso, da un lato,
l’onore/reputazione e, dall’altro, l’interesse sociale alla trasparenza della pubblica amministrazione,
all’emergere dei fatti costituenti reato e, in genere, alla libera manifestazione del pensiero);
b) cause di esclusione della colpevolezza, in presenza delle quali il fatto resta illecito, ma si
configura non colpevole, per mancanza di imputabilità del soggetto agente oppure per inesigibilità,
in situazioni particolari, del comportamento ordinariamente richiesto (cfr. l’art. 384 c.p.);
c) cause di non punibilità in senso stretto, in presenza delle quali il fatto resta illecito e colpevole,
ma non è punibile in forza di una valutazione di non opportunità dell’intervento penale in un dato
contesto (cfr. l’art. 649 c.p.);
- la diversa rilevanza delle suddette cause di non punibilità sopra richiamate in rapporto all’art. 119
c.p., concernente il concorso di persone (si applicano rispetto a tutti i concorrenti solo la cause di
non punibilità aventi natura oggettiva);
- la rilevanza oggettiva delle cause di esclusione della punibilità, ex art. 59, co. 1, c.p., e la
disciplina (analoga a quella concernente l’errore di fatto) in tema di erronea supposizione
dell’esistenza di una causa di esclusione della punibilità, ex art. 59, co. 4, c.p. (v. supra);
critica – onde evitare che si violi in malam partem il principio di legalità – dell’opinione (fondata
sull’asserito venir meno, in tali casi, della ratio della non punibilità) secondo cui il co. 1 non
sarebbe applicabile alle cause di esclusione della colpevolezza e il co. 4 non sarebbe applicabile alle
cause di non punibilità in senso stretto;
in particolare,
- la legittima difesa (art. 52 c.p.) rispetto alla condotta in atto di un soggetto aggressore, la quale
dia luogo al pericolo attuale di un’offesa ingiusta nei confronti di un qualsiasi diritto proprio od
altrui, e purché la difesa sia proporzionata all’offesa; sempre che il soggetto sia stato costretto a
commettere il fatto giustificato per la necessità di difendere tale diritto;
si considerino le discutibili modifiche introdotte nell’anno 2006, quanto al requisito della
proporzionalità per il caso di violazione del domicilio, con i commi 2 e 3: modifiche le quali,
tuttavia, non consentono affatto di difendere il domicilio e il patrimonio con le armi, richiedendosi
pur sempre ;
cenno circa l’uso non corretto del concetto di legittima difesa nel n. 2267, relativo alla pena di
morte, del Catechismo della Chiesa cattolica;
- il requisito, comune a legittima difesa e stato di necessità, della proporzione tra quanto si tutela e
quanto si sacrifica;
richiamo della disciplina concernente l’eccesso colposo (art. 55 c.p.): v. supra;
- l’ulteriore requisito dell’inevitabilità altrimenti;
- il problematico inquadramento giuridico dello stato di necessità (art. 54 c.p.), quale norma che
lascia impunita una condotta offensiva posta in essere nei confronti di un soggetto non aggressore,
vale a dire innocente (per cui ha un ambito applicativo più ristretto rispetto alla legittima difesa, in
quanto riferito, salva sempre la proporzionalità, al solo «pericolo attuale di un danno grave alla
persona»):
l’ipotesi nella quale il soggetto attivo agisce per salvare se stesso appare inquadrabile più come
causa di esclusione della colpevolezza che come causa di giustificazione;
diversamente il c.d. soccorso di necessità (che sia realizza in favore di un terzo), specie con
riguardo all’ipotesi della condotta posta in essere privilegiando la tutela di un bene preminente
rispetto a un altro bene entrambi riferibili a una medesima persona (è il caso del medico che agisce
per la salvaguardia della vita o della salute in situazioni nelle quali il paziente non è in grado di
prestare il proprio consenso);
risulta invece delicatissima, e dai confini molto problematici, l’intervento in favore di un terzo, ma a
danno di un altro soggetto: in tal caso colui che agisce, non essendo egli stesso in pericolo, opera
una scelta, quanto alla tutela, fra altri soggetti (di certo l’art. 54 c.p., in simili casi, non potrebbe
applicato senza delimitazioni implicite);
- il consenso dell’avente diritto, rispetto alla compromissione di beni disponibili (art. 50 c.p.);
cenni sulle altre cause di giustificazione di applicabilità generale previste agli artt. 50 ss. c.p.;
- le cause di giustificazione concernenti specifici reati (esemplificazione in riferimento all’art. 596
c.p.):
11.5
- il delitto tentato (art. 56, co. 1, c.p.): la differenza tra tentativo compiuto (la condotta idonea è
stata portata a termine) e tentativo incompiuto (l’esecuzione della condotta ha subito
un’interruzione non spontanea: diversamente, si tratterebbe di desistenza volontaria: v. infra); la
necessità, nel secondo caso, di definire i requisiti minimi perché una condotta che pure non abbia
causato l’evento naturalistico costituente reato risulti, tuttavia, penalmente rilevante: il confronto
con il distinguo tra atti (ancora) preparatori ed atti (già) esecutivi di cui al codice Zanardelli del
1889;
i requisiti del codice vigente fondati sui concetti, da valutarsi ex ante, di:
a) idoneità degli atti, tenuto conto del fatto che se gli atti, nel caso di tentativo incompiuto, fossero
valutati di per sé soli, risulterebbero sempre inidonei: con il delicato problema, dunque, di una loro
considerazione nel contesto in cui sono inseriti e degli sviluppi prevedibili (di per sé soli considerati
quegli atti si dimostrerebbero il più delle volte inidonei);
si evidenzia, comunque, in dottrina che sarà richiesto un pericolo rilevante di realizzazione
dell’evento, in termini non di mera possibilità, ma di probabilità (più probabile che non); si
richiede, in altre parole, una significativa entità del rischio prodotto, secondo una problemativa
invece ampiamente irrisolta, come già si osservava, rispetto al reato colposo);
si tratterà, inoltre, di domandarsi da quale punto di vista vada riguardata l’idoneità: se da quello del
solo soggetto agente (giudizio c.d. a base parziale) oppure da quello di ciò che era già noto ad altri
soggetti e, in particolare, alla vittima (giudizio a c.d. base totale): ciò che poteva risultare idoneo al
soggetto agente, infatti, potrebbe essere già stato reso oggettivamente inidoneo dalla vittima
potenziale, configurando in tal modo un reato impossibile; l’impostazione oggettivistica del codice
e dell’art. 49 c.p. (vedi infra) sembrerebbe orientare in quest’ultimo senso, non accolto, peraltro,
dalla giurisprudenza;
b) direzione non equivoca degli atti (o univocità), tale per cui gli atti siano spiegabili
esclusivamente in rapporto alla produzione dell’evento, senza che residuino altre finalità plausibili
degli stessi; si tratta di un giudizio che andrebbe condotto in base alle caratteristiche oggettive del
contesto di realizzazione della condotta, in modo da evitare che esso si sovrapponga a quello,
successivo, sul dolo;
- la compatibilità del tentativo, ex art. 56 c.p., con soli delitti puniti a titolo di dolo;
- l’incompatibilità con il tentativo, riconosciuta dalla giurisprudenza, del dolo eventuale (stante il
requisito di cui alla definizione normativa, degli atti diretti in modo…: formula che, per sé,
escluderebbe anche il dolo diretto, di cui tuttavia la giurisprudenza invece ha ammesso, talora
estendendone inaccettabilmente i limiti, la compatibilità con dolo eventuale);
- desistenza volontaria, ex art. 56, co. 2, c.p. (differenza con il tentativo incompiuto): la
motivazione premiale della non punibilità;
la differenza con il recesso attivo, ex art. 56, co. 3, c.p. (implicante l’impedimento dell’evento a
seguito di una condotta già completata), che comporta, invece, una diminuzione di pena rispetto a
quella prevista per il tentativo: perplessità di tale differenza circa le scelte sanzionatorie;
la differenza, altresì, con la circostanza attenuante del ravvedimento post delictum di cui all’art. 62
n. 6 c.p.
- il reato impossibile (per inidoneità dell’azione o inesistenza dell’oggetto), ex art. 49, co. 2.
c.p.): non punibilità (salvo che sussistano i presupposti di un reato diverso: co. 3) e applicabilità di
una misura di sicurezza (co. 4), sebbene non si configuri il reato (ipotesi di c.d. quasi reato, al pari
di quanto previsto dall’art. 115 c.p. (v. infra);
la utilizzazione dell’art. 49 c.p. come ancoramento di diritto positivo del principio di offensività (v.
supra), intendendosi in tal senso l’inidoneità come inoffensività rispetto al bene tutelato (posto che
la non punibilità della condotta inidonea nel significato tradizionale è già desumibile, a contrariis,
dall’art. 56 c.p.);
- la non punibilità del reato putativo, cioè erroneamente supposto (art. 49, co. 1, c.p.)
12.5
- il concorso di persone:
reati a concorso eventuale e a concorso necessario (questi ultimi prevedono talora la punibilità di
tutti i concorrenti, come nella corruzione o nell’associazione per delinquere, talora la punibilità di
uno soltanto fra di essi, venendo considerato l’altro come vittima, come nel caso della concussione
o dell’estorsione);
la scelta, discutibile, del codice italiano di punire tutti i concorrenti secondo il medesimo ambito
edittale previsto per il reato commesso (equiparazione dei concorrenti), senza distinzioni edittali
riferite al tipo di apporto (come invece avviene in altri ordinamenti);
il rilievo di c.d. condotte atipiche;
il contributo di natura materiale oppure morale (istigazione);
l’esigenza cardine, per individuare la condotta rilevante ai fini del concorso di persone,
rappresentata dal fatto che essa risulti causale rispetto alla realizzazione in concreto del reato:
- la connessa problematica relativa all’individuazione della condotta partecipativa rilevante; è
necessario, come s’è detto, che essa risulti causale rispetto alla realizzazione in concreto del reato,
stanti i rischi derivanti sotto il profilo del principio di legalità dal prospettare la sufficienza di criteri
meno stringenti fondati sulle nozioni generiche di agevolazione o rinforzo; resta peraltro
problematica la circostanza per cui nel concorso di persone la causalità è riferita al reato così come
realizzatosi hic et nunc, manifestandosi per molti versi dipendente, pertanto, dalla modalità di
descrizione del fatto: ciò in quanto, trattandosi di un reato cui concorrono più persone, il giudizio
controfattuale relativo alla condotta del partecipe non potrà riferirsi all’esclusione tout court del
realizzarsi del fatto medesimo (che potrebbe essere realizzato comunque dagli altri concorrenti), ma
assumerà una forma di questo tipo: senza l’apporto X il fatto non si sarebbe realizzato in quel dato
modo, per cui la risposta viene a dipendere dalla maggiore o minore specificazione descrittiva del
fatto medesimo;
- l’esigenza che la condotta rilevante ai fini del concorso di persone, sebbene possa risultare atipica
(cioè da sola non ricomprensibile in una data fattispecie incriminatrice), abbia pur sempre attivato
un rischio non consentito in relazione al prodursi dell’evento: in altre parole, che essa si configuri
pur sempre, ex ante, come violazione di una regola rivolta ad evitare il prodursi del fatto (al pari di
quanto s’è detto per la condotta nei reati monosoggettivi):
la necessità che sia accertato, in tutti i concorrenti in un delitto doloso, del dolo relativo al
realizzarsi del fatto tipico;
l’attenuante riferita al contributo di minima importanza (art. 114 c.p.), rappresentato da un
contributo ex post pur sempre causale, ma ex ante facilmente sostituibile e tale da non aver
prodotto, già di per sé, un rischio elevato di verificazione dell’evento;
la fattispecie di cooperazione colposa (art. 113 c.p.), che richiede pur sempre, ai fini della
punibilità, una condotta la quale già di per sé costituisca la violazione di una regola cautelare
finalizzata a evitare l’evento;
l’irrilevanza circa il concorso di persone, salve esplicite eccezioni, del mero accordo, ai sensi
dell’art. 115 c.p. (come pure dell’istigazione, ove il reato non sia stato commesso)
in tali casi, come pure in quello dell’istigazione non accolta, è applicabile una misura di sicurezza
(ipotesi di c.d. “quasi reato”, in parallelo con l’art. 49 c.p.);
richiami alla disciplina particolare, già discussa, di cui agli artt.116 e 117 c.p.
- il concorso di reati (artt. 71 ss. c.p.):
unità e pluralità delle condotte: la condotta resta unica, e dunque unico il reato, se i comportamenti
posti in essere si realizzano in un medesimo contesto spazio-temporale (se per esempio Tizio sottrae
più cose materiali da un supermercato caricandole progressivamente su un automezzo);
se tuttavia una medesima condotta provoca più lesioni del bene vita o del bene incolumità si ritiene
da sempre che vengano a configurarsi più reati;
concorso materiale (omogeneo o eterogeneo): più reati con più azioni;
concorso formale (omogeneo o eterogeneo). Più reati posti in essere con un’unica azione;
concorso materiale e reato continuato, ex art. 81, co. 2, c.p.: più reati fra loro collegati da un
“medesimo disegno criminoso”;
ambito di applicabilità del cumulo giuridico (pena per il reato in concreto più grave, aumentabile
dal giudice fino al triplo, purché non si superi il livello del cumulo materiale) e del cumulo
materiale, consistente nella sommatoria – salvi i limiti di cui subito diremo – delle pene (oggi
applicabile al solo concorso materiale non caratterizzato da continuazione); la riforma, in proposito,
attuata con d.l. n. 99/1974 (v. anche infra, in materia di circostanze), che ha esteso la disciplina del
cumulo giuridico anche al reato continuato omogeneo e al concorso formale;
i limiti massimi di pena nel caso di concorso di reati ex artt. 71 ss. c.p.;
il concorso apparente di norme penali e il principio di specialità (art. 15 c.p.);
l’interpretazione del concetto di “stessa materia” di cui all’art. 15 c.p.: norme riferibili – secondo
l’orientamento della dottrina – alla medesima situazione di fatto oppure – in un senso che
ridurrebbe moltissimo la riconoscibilità di un concorso solo apparente – alla tutela del medesimo
bene giuridico);
l’ulteriore criterio giurisprudenziale dell’assorbimento o consunzione, anche in rapporto al c.d.
antefatto o postfatto non punibile.
18.5
- introduzione ai problemi nuovi concernenti la tutela della vita umana:
il bene giuridico vita umana: la nozione di vita dell’individuo umano (e di qualsiasi specie
vivente) quale sequenza esistenziale autonoma, continua e coordinata;
in particolare, il concetto di autonomia come non necessità, per la prosecuzione del percorso
esistenziale, di alcun ulteriore impulso (o stimolo) dall’esterno: la sequenza esistenziale, in altre
parole, procede, dal momento in cui ha inizio, per forza propria e secondo un programma a essa
interno (espresso dall’informazione genetica propria di ciascun individuo, egualmente presente in
ciascuna delle sue cellule fin dalla prima di esse, cioè dallo zigote), potendo essere soltanto
interrotta (per ragioni patologiche o per il venir meno delle condizioni ambientali o di
alimentazione che ne rendono possibile la prosecuzione);
il concetto di continuità indica, a sua volta, che lo svolgersi di tale sequenza è unitario, non può
interrompersi e riprendere, e non consente di individuare stacchi qualitativi;
il concetto di coordinamento attiene invece all’interazione fra le diverse tipologie cellulari e,
dunque, tra i diversi organi, del corpo, assicurata dell’informazione genetica;
la nozione di morte (la fine della vita umana) come cessazione del coordinamento sistemico
dell’organismo, momento identificato, dopo la dinamica cellulare delle primissime fasi della vita
embrionale, nella morte cerebrale (o encefalica) completa (relativa, cioè, sia agli emisferi che al
tronco-encefalo);
la differenza radicale tra la morte cerebrale e le situazioni di coma;
il possibile prelievo di organi, a certe condizioni, dopo la morte cerebrale;
l’evolversi delle cognizioni relative agli stati di minima coscienza e agli stati di coma c.d.
vegetativi;
il sussistere delle suddette condizioni che definiscono il sussistere di una vita individuale dal
momento della fecondazione (o concepimento), con la quale, dunque, si ha l’inizio della vita di un
nuovo essere umano; tale inizio, cioè l’attivarsi della suddetta sequenza, può peraltro realizzarsi
anche altrimenti: si pensi al separarsi in fase precocissima di una cellula o di un piccolo gruppo di
cellule ancor totipotenti (lo sono le prime otto cellule) dall’embrione, con il che prende avvio la vita
di un gemello monozigote; oppure si pensi (pur non essendo eticamente accettabile: v. infra) a un
processo di clonazione;
la vita come uno svolgimento esistenziale unitario dal suo inizio, che non consente di scindere
dimensione biologica (meramente corporea) e una dimensione metabiologica (come se la psiche
fosse una realtà svincolata dal corpo e calata dall’esterno in esso, secondo quanto ritenevano le
antiche impostazioni dualiste (si pensi a Cartesio): in realtà la sequenza esistenziale è unitaria ed
esprime nel corso del tempo sia capacità fisiche che psichiche: alcune si perfezionano solo a una
certa epoca, altre si perdono precocemente (si pensi alla capacità di costruire organi e tessuti in fase
prenatale o alla capacità di elaborazione linguistica nei primi anni di vita);
la tutela giuridica della vita umana prenatale come espressione della tutela dei diritti inviolabili
dell’uomo, che risulta correlata all’esistenza in vita, sulla base degli artt. 2 e 3 della Costituzione
(l’irrilevanza, già richiamata supra, di un giudizio sulle «condizioni personali e sociali» di un
individuo, e dunque sulle capacità o qualità che sia in grado di manifestare in un dato momento
della sua vita, ai fini della sua dignità sociale, cioè del rispetto dei suoi diritti inviolabili nei rapporti
con gli altri);
il rilievo giuridico della vita umana anche prenatale, in base alla Dichiarazione universale dei diritti
del fanciullo (Preambolo, punto 3): «considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica
e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata
protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita»): il fatto, dunque, che un individuo nella parte
iniziale della sua vita non abbia ancor acquisito talune capacità dell’adulto non lo rende minore
nella dignità, ma anzi lo rende titolare di un maggior diritto alla tutela;
le vicende relative alla fase iniziale della vita umana;
la struttura della legge n. 194/1978: premesse e considerazioni generali;
i principi affermati all’art. 1: «lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio», «l’interruzione
volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite»;
il problema, ovviamente, non è dato dalla rinuncia a utilizzare la previsione di una pena detentiva
nei confronti della donna per fini di prevenzione dell’aborto, punto sul quale può esservi
amplissimo consenso; si tratta, piuttosto, di domandarsi se sussista effettivamente un intento di
prevenzione dell’aborto, dato che le relazioni ministeriali annuali sulla legge 194 indicano,
attualmente, un’incidenza di quasi centomila aborti legali per anno, con una somma dal 1968 ad
oggi – in anni passati il numero delle donne in età fertile era assai maggiore di quello attuale – di
quasi sei milioni di interruzioni della gravidanza (si tenga conto di molte interruzioni ripetute la
parte della medesima donna);
la rilevanza delle diverse fasi della vita ai fini del diritto penale:
in particolare, il permanente sussistere di illeciti penali in materia di interruzione della gravidanza e
l’inquadramento delle ipotesi (v. infra) di non punibilità, in quello che, tuttavia, dovrebbe rimanere
un contesto di prevenzione dell’aborto;
i delitti in materia di aborto nella legge n. 194/1978:
art. 17: aborto colposo, punibile solo con riguardo alla condotta di un soggetto diverso dalla madre;
art. 18: interruzione della gravidanza su donna non consenziente;
art. 18, co. 2 e 4: aborto preterintenzionale (si noti, con riguardo al co. 4 concernente l’ipotesi in cui
derivi anche la morte della donna, la disomogeneità sanzionatoria rispetto all’art. 584 c.p.);
art. 19: aborto su donna consenziente, ove sia compiuto al di fuori dei requisiti e delle procedure
che non lo puniscono ai sensi della legge in esame; tale delitto è sanzionato penalmente con la
reclusione nei confronti di chi pratica l’aborto sulla donna e, ora, come illecito amministrativo con
riguardo alla donna (co. 2): la legge in tal caso prevedeva tuttavia, rispetto alla donna, un delitto
punito con la multa fino a euro 51, ma il provvedimento generale di trasformazione in illeciti
amministrativi (cioè di depenalizzazione), salve esplicite eccezioni, dei reati esterni al codice penale
puniti con la sola pena pecuniaria posto in essere dal d.lgs. n. 8/2016 ha fatto sì che questa
trasformazione si realizzasse – senza che il legislatore, è da ritenersi, ne abbia avuto consapevolezza
– anche con riguardo al delitto previsto dall’art. 19, co. 2, con riguardo alla donna: e a questo punto,
stante il criterio di conversione tra pena pecuniaria e sanzione amministrativa previsto dal suddetto
provvedimento, l’illecito risulta sanzionato rispetto alla donna con una sanzione pecuniaria
amministrativa da 5000 a 10000 euro; l’inopportunità, in ogni caso, del fatto che venga prevista,
nell’ipotesi di cui s’è discusso, una sanzione avente natura pecuniaria, la quale finisce per
rappresentare una «monetizzazione» dell’atto abortivo (piuttosto, si preveda un obbligo di altra
natura);
il concepito non solo come oggetto di tutela, ma anche come soggetto di diritti (si veda l’art. 1 l. n.
40/2004, ai sensi del quale «la legge … assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito»: quest’ultimo termine, fra l’altro, esplicita la tutela della vita umana prenatale dal
momento della fecondazione);
le ipotesi di non punibilità:
cenni di carattere comparato: il modello dei «termini», proposto in alcuni contesti soprattutto
anglosassoni (nessuna rilevanza del concepito e totale autodeterminazione entro una certa epoca
della gravidanza) e il modello misto, seguito anche dalla normativa italiana (rilevanza di termini,
requisiti e procedure); una strategia alternativa si sarebbe potuta fondare sulla promozione di un
sistema normativo fortemente orientato all’aiuto nei confronti della donna in gravidanza;
i requisiti rilevanti ai fini della non punibilità, secondo la legge n. 194/1978:
in particolare, la necessità, in ogni caso (a parte le ipotesi molto rare di pericolo per la vita della
donna) del pericolo per la salute fisica o psichica della donna,
derivante (come pericolo serio) da uno dei quattro sotto-requisiti cui la legge attribuisce rilievo nei
primi novanta giorni di gravidanza (v. art. 4 l. n. 194/1978)
oppure, dopo il novantesimo giorno (v. art. 6 l. 194/1978, ed entro il limite di cui subito si dirà),
derivante (come pericolo grave) da «accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti
anomalie o malformazioni del nascituro»;
il limite temporale alla praticabilità legale di un aborto rappresentato dal momento in cui il feto
potrebbe sopravvivere a un parto prematuro (art. 7, co. 3, l. n. 194/1978), possibilità che inizia a
darsi, oggi, dalla ventunesima settimana di gestazione; superata tale soglia, può essere indotto un
parto pretermine nel solo caso di pericolo di vita per la donna, adottando «ogni misura idonea a
salvaguardare la vita del feto»;
- le contraddizioni circa l’inquadramento giuridico delle ipotesi di non punibilità dell’aborto:
inquadramento il quale appare esser stato ricercato, sulla premessa della sentenza n. 27/1975 della
Corte costituzionale (che aveva dichiarato l’incostituzionalità dei reati di aborto previsti nel codice
penale del 1930, nell’ambito dei delitti contro la «integrità e la sanità della stirpe»), attraverso un
riferimento estensivo allo stato di necessità (art. 54 c.p.), in quanto unica norma che consente di non
punire un atto deliberatamente offensivo posto in essere nei confronti di un non aggressore (di qui il
requisito del «pericolo per la salute fisica o psichica»);
dello stato di necessità, tuttavia, manca nel caso in esame (oltre all’attualità del pericolo, problema
secondario) il requisito fondamentale della proporzionalità (v. art. 54 c.p.) fra quanto si sacrifica e
quanto si tutela: non sussistendo proporzione tra il bene vita e il bene salute (nella l. n. 194/1978,
anche «psichica»);
tale problema fu presente alla sentenza n. 27/1975 della Corte costituzionale, che però ebbe a
superarlo proponendo una discriminazione priva di supporto razionale tra il rango del bene vita
prima e dopo la nascita (affermò che il concepito «persona deve ancora diventare»), sulla base di un
riferimento implicito, del tutto improprio, all’art. 1 cod. civ. (concernente l’acquisto dalla nascita
della capacità giuridica): tale norma, infatti, non ha riguardo ai diritti umani inviolabili (che ex artt.
2 e 3 Cost. dipendono dalla mera esistenza in vita di un dato individuo), ma all’insieme dei diritti
diversi da quelli inviolabili, soprattutto di natura patrimoniale;
un orientamento, quest’ultimo, che impone di riflettere sui rischi (constatabili non soltanto con
riguardo alla vita prenatale) di c.d. flessibilizzazione dei diritti inviolabili, suscettibile di minare
l’impianto complessivo, concepito settant’anni orsono, inerente alla tutela intangibile dei diritti
umani;
(si consideri, peraltro, che Corte cost. n. 27/1975 aveva richiesto a fini della non punibilità un
pericolo grave e medicalmente accertato per la vita o la salute della donna, senza menzione della
salute psichica);
- il problematico inquadramento giuridico dello stato di necessità (art. 54 c.p.), quale norma
che lascia impunita una condotta offensiva posta in essere nei confronti di un soggetto non
aggressore, vale a dire innocente (per cui ha un ambito applicativo più ristretto rispetto alla
legittima difesa, in quanto riferito, salva sempre la proporzionalità, al solo «pericolo attuale
di un danno grave alla persona»):
l’ipotesi nella quale il soggetto attivo agisce per salvare se stesso appare inquadrabile più
come causa di esclusione della colpevolezza che come causa di giustificazione;
diversamente il c.d. soccorso di necessità (che sia realizza in favore di un terzo), specie con
riguardo all’ipotesi della condotta posta in essere privilegiando la tutela di un bene
preminente rispetto a un altro bene entrambi riferibili a una medesima persona (è il caso del
medico che agisce per la salvaguardia della vita o della salute in situazioni nelle quali il
paziente non è in grado di prestare il proprio consenso);
risulta invece delicatissima, e dai confini molto problematici, l’intervento in favore di un
terzo, ma a danno di un altro soggetto: in tal caso colui che agisce, non essendo egli stesso in
pericolo, opera una scelta, quanto alla tutela, fra altri soggetti (di certo l’art. 54 c.p., in simili
casi, non potrebbe applicato senza delimitazioni implicite);
il requisito, comune a legittima difesa e stato di necessità, della proporzione tra quanto si
tutela e quanto si sacrifica;
l’ulteriore requisito dell’inevitabilità altrimenti;
- il problema eugenetico, inerente alla utilizzazione per finalità abortive di dati genetici acquisiti
precocemente, a vita già in atto, attraverso la diagnosi prenatale;
l’esigenza che l’enorme incremento della possibilità di acquisizione di dati genetici, anche in
un’epoca esistenziale molto precoce, resti utilizzata per fini terapeutici e non per fini di selezione
(cioè di screening eugenetico);
l’incidenza statistica nient’affatto trascurabile dell’amniocentesi rispetto all’induzione di un aborto
spontaneo;
(v. anche infra, circa la problematica della diagnosi preimpiantatoria su embrioni);
19.5
- il ruolo di prevenzione rispetto all’aborto (prevenzione primaria) che compete al colloquio con
la donna (di cui all’art. 5, co. 1, l. 194/1978), in quanto finalizzato a «rimuovere le cause» che la
porterebbero a interrompere la gravidanza», offrendole «tutti gli aiuti necessari sia durante la
gravidanza sia dopo il parto»;
si tratta, soprattutto, di lasciar percepire alla donna, specie rispetto a messaggi in altro senso, che la
prosecuzione della gravidanza sarebbe comunque stimata (e supportata) dalle istituzioni pubbliche;
come pure di evitare che la donna identifichi emotivamente nell’aborto uno strumento idoneo, per
così dire, a riportare indietro le lancette dell’orologio: consentendole di prendere atto
realisticamente, senza rimozioni, della realtà nuova costituita dalla gravidanza (anche quale
possibile opportunità);
vi è la necessità, inoltre, di offrire aiuto alla donna, da parte degli operatori del consultorio o del
centro socio-sanitario, anche sul piano sociale, con un impegno, fra l’altro, di tipo organizzativo;
va altresì presa in esame l’incidenza, sovente trascurata, di conseguenze psichiche negative
dell’aborto per la donna, rilevabili anche a lunga distanza: come evidenziato, fra l’altro, nella terza
e quarta edizione del Manuale internazionale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM);
si consideri inoltre il diritto fondamentale della donna di poter partorire nell’anonimato, non
assumendo la posizione genitoriale (art. 30, co. 1, d.P.R. 396/2000, ord. stato civile), così che il
bambino – salvo un breve spazio temporale per un eventuale ripensamento – accederà all’adozione;
diritto, questo, che assume esso pure un ruolo di prevenzione dell’aborto;
va anche rimarcato che, nel quadro dell’impegno preventivo, può assumere un ruolo importante la
collaborazione con il volontariato sociale (per esempio, con i Centri di aiuto alla vita): anche per
quanto concerne pur modesti aiuti di carattere economico, previsti a livello istituzionale solo da
alcune regioni;
la finalità preventiva del colloquio, peraltro, finisce per essere depotenziata, di fatto, dalla
possibilità per la donna di potersi rivolgere direttamente a un medico di fiducia (art. 5, co. 2, l.
194/1978), col rischio del venir meno, in tal modo, di qualsiasi effettivo impegno di aiuto alla
donna e di prevenzione dell’aborto (sebbene il medico stesso debba valutare con la donna le
circostanze che la porterebbero a interrompere la gravidanza e a informarla sugli aiuti sociali che
potrebbe ricevere);
cenni sulla posizione del padre del concepito;
- la procedura di accesso all’interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni, sia a seguito di
colloquio presso un consultorio o un centro socio-sanitario, sia a seguito di colloquio presso il
medico di fiducia (artt. 5, co. 3 e 4): il ruolo anche accertativo del medico rispetto alla sussistenza
dei requisiti richiesti dalla legge;
la mancata previsione, non condivisibile, di una specifica fase di colloquio in relazione ai casi in cui
l’interruzione della gravidanza non è punibile dopo il novantesimo giorno: la donna si rivolge
direttamente alla struttura sanitaria, ove devono essere accertati i processi patologici rilevanti e la
loro incidenza in termini di pericolo grave per la salute della donna (art. 7, co. 1, l. n. 194/1978), l.
194/1978;
[è disponibile su questi temi, tra i materiali didattici, il parere del Comitato Nazionale per la
Bioetica, del 2005, sul tema dell’aiuto alla donna in gravidanza]
aborto e donna minorenne, nei primi novanta giorni: normativa e problematiche (art. 12 l. n.
194/1978); il ruolo dei genitori (o del tutore) e la procedura davanti al giudice di pace nel caso di
dissenso; l’esigenza di evitare, peraltro, che la ragazza giovane subisca un’induzione di fatto a
interrompere la gravidanza;
- aborto e donna interdetta (art. 13 l. n. 194/1978).
la non praticabilità, in qualsiasi caso, dell’aborto senza il consenso della donna;(artt. 12, co. 1, e
13, co. 2, l. n. 194/1978);
- l’obiezione di coscienza di cui all’art. 9 l. n. 194/1978 e il suo riferimento a tutte le procedure e
attività «specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza»:
l’interpretazione di tale concetto sulla base della nozione di rilevanza causale; la configurazione da
parte della legge di due categorie distinte a priori – non obiettori e obiettori – tra i medici e gli altri
professionisti sanitari operanti nell’ambito del servizio sanitario pubblico;
la collocazione giuridica dell’obiezione di coscienza: il suo fondamento come diritto
costituzionale (inquadrabile come causa di giustificazione), ove riferita all’intento di non
derogare alla tutela della vita umana o di altri diritti umani inviolabili;
quando l’ordinamento giuridico richieda, per qualsiasi ragione, a chi rivesta un certo ruolo la
disponibilità a tenere condotte lesive di un diritto inviolabile non può obbligare: per cui non
può prevedere l’obbligo di svolgere un’attività implicante quel ruolo ove tale attività abbia
come elemento caratterizzante la possibile tenuta di tali condotte (si pensi alle forze armate);
quando invece si tratti di un’attività o professione (è il caso delle professioni sanitarie) per le
quali la suddetta possibilità non costituisce elemento caratterizzante dovrà sempre
ammettersi l’obiezione di coscienza (il cui diritto, in questo caso, non dipende da una mera
scelta legislativa, ma è desumibile direttamente dalla Costituzione);
- l’aborto farmacologico: il ricorso ospedaliero alla c.d. pillola RU 486: problemi; in particolare, i
rischi a una utilizzazione illegale extraospedaliera;
- l’abortività precoce: la possibile incidenza abortiva precoce della c.d. pillola del giorno dopo e
della pillola dei cinque giorni dopo (e l’analoga incidenza da tempo nota, della spirale o iud),
attraverso l’impedimento dell’annidamento dell’embrione nella parete uterina ove la fecondazione
sia avvenuta; la definizione fuorviante della gravidanza come la fase che va dall’annidamento
dell’embrione nella parete uterina al parto (l’embrione, ovviamente, sussiste dalla fecondazione,
tanto che alla conclusione dell’annidamento già manifesta una struttura a tre foglietti cellulari, con
visibilità delle strutture nervose proprie della c.d. stria primitiva);
- la scarsa informazione sulla rilevazione naturale della fertilità femminile (info, per esempio,
presso il “Centro regolazione naturale della fertilità” della nostra facoltà di Medicina, Roma);
- le problematiche etiche e giuridiche connesse alla generazione umana extracorporea
(fecondazione in vitro) e la l. n. 40/2004 (c.d. procreazione medicalmente assistita);
l’esigenza di considerare, rispetto alle tecniche di fecondazione in vitro,
sia la questione relativa alla tutela dell’embrione fuori dal corpo femminile,
sia la questione in gran parte nuova concernente i “criteri” della generazione umana, rispetto alla
quale emergono esigenze di tutela riferibili a un bene che può essere identificato in alcune
condizioni essenziali di umanità della generazione (si pensi, alle problematiche estreme della
clonazione o della gravidanza artificiale):
a) la possibilità, da alcuni decenni, della generazione e, dunque, del sussistere di embrioni umani
al di fuori del corpo femminile;
la non praticabilità di un proseguimento al di fuori del corpo femminile dell’esistenza degli
embrioni generati in vitro; la necessità, a tal fine, che gli stessi siano trasferiti nell’utero di una
donna e i problemi connessi alle chance minoritarie di annidamento per ciascun tentativo;
il riconoscimento dell’embrione come soggetto di diritti tutelato dal concepimento, ex art. 1,
co.1, l. n. 40/2004 (v. supra);
- la rilevanza penale della vita umana nella fase postnatale attraverso i delitti di omicidio e
infanticidio, durante la gravidanza attraverso i delitti di aborto e nella fase embrionale che sussista
al di fuori del corpo femminile attraverso il divieto della soppressione di embrioni umani previsto
e sanzionato come delitto dall’art. 14, co. 1 e 6, l. n. 40/2004;
b) la necessità di considerare, ben più pressantemente rispetto al passato, il problema costituito dai
criteri di umanità della generazione, posto che le tecniche di fecondazione in vitro estendono in
maniera rilevantissima le modalità attraverso le quali si rende possibile realizzare l’avvio di una
nuova vita umana;
- si rende fra l’altro non eludibile, in tal senso, una riflessione circa le caratteristiche proprie del
procreare umano:
se esso debba identificarsi sempre più col diritto di chiedere, da parte di chiunque (coppia
eterosessuale od omosessuale, persona singola), l’applicazione di una qualsiasi modalità
tecnicamente idonea a generare: quale che sia la provenienza dei gameti, oppure ricorrendo a una
surrogazione di maternità (il c.d. utero in affitto o procreazione per altri), oppure programmando
una selezione precoce tra molti embrioni che si sia deciso di generare (v. infra), oppure attraverso
una clonazione, oppure, tra qualche decennio, attraverso la sostituzione del ruolo gestazionale di
una donna mediante un utero artificiale (ectogenesi), ecc.: e ciò solo in base al fatto che ci si dica
disposti ad accudire il nuovo nato (con ciò sovrapponendosi, fra l’altro, i profili del procreare e
dell’adottare),
oppure se il procreare umano, che pure necessita della dimensione biologica, costituisca in primis,
come riterremmo, un atto relazionale di due persone generanti (necessariamente di sesso diverso),
che le coinvolge (anche nella loro corporeità);
i limiti di un approccio della Corte costituzionale che sembra argomentare, nelle sentenze recenti
sulla legge n. 40/2004, con riguardo prevalente al desiderio del figlio, inquadrato come elemento
del diritto alla salute;
la riflessione della Chiesa cattolica sul legame fra sessualità e generazione;
la distinzione, nella materia in esame, tra quanto è oggetto di regole giuridiche e la riflessione
affidata alla responsabilità di ciascun individuo;
16.5
- l’impianto della legge n. 40/2004, che nella stesura originaria intendeva garantire a ogni embrione
generato (non più di tre per ogni ciclo di stimolazione ovarica) quantomeno la possibilità di
proseguire nel suo iter esistenziale, evitando la generazione di embrioni sovrannumerari (il cui
destino è la morte o la crioconservazione) rispetto a quelli trasferiti in utero e, nel contempo,
evitando stimolazioni ormonali particolarmente pesanti nei confronti della donna; come pure
mantenendo il ricorso alla c.d. procreazione medicalmente assistita (pma) nell’ambito, e attraverso i
gameti, di una coppia stabile, limitatamente al caso di sterilità o infertilità;
- le vicende relative al trasferimento degli embrioni nell’utero della donna; il problema del venir
meno di un’indicazione numerica precisa circa il numero degli embrioni generabili, a seguito della
sent. n. 151/2009 Corte cost. che ha inciso sul testo dell’art. 14, co. 2 (ora tale norma richiede che il
ricorso alla pma non deve «creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente
necessario», essendo venute meno le ulteriori parole «ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre»); pare tuttora deducibile, peraltro, dall’impianto dell’art. 14 la non
programmabilità ex ante della generazione di embrioni destinati alla crioconservazione;
- il problema degli embrioni eventualmente non trasferiti, che, ai sensi della stessa giurisprudenza
della Corte costituzionale, devono essere crioconservati;
- le permanenti preclusioni penalmente sanzionate previste dalla legge n. 40/2004 (si vedano in
particolare gli artt. 12, 13 e 14): accesso non meramente elettivo, finalità procreativa, divieto di
clonazione, di maternità surrogata, ecc.
in particolare, il divieto di ricerca clinica e di sperimentazione a danno dell’embrione (art. 13, co. 2,
l. n. 40/2004);
- l’avvenuta abrogazione del divieto di fecondazione eterologa, con sentenza della Corte cost. n.
162/2014: tecnica attraverso la quale la generazione avviene attraverso i gameti di due soggetti tra i
quali non sussiste una relazione (almeno uno di tali soggetti mette a disposizioni gameti prelevati
dal suo corpo, al di fuori di fuori di una relazione con l’altro soggetto generante);
- la questione della diagnosi preimpiantatoria su embrioni, che implica la generazione di più
embrioni, in un contesto di possibile trasmissione di malattie genetiche, e il successivo prelievo di
cellule ancor totipotenti (come tali suscettibili, fra l’altro, di evolvere in un ulteriore individuo) da
ciascuno degli embrioni generati, onde effettuare uno screening genetico: con successiva esclusione
dal trasferimento in utero, e la conseguente estinzione, degli embrioni con caratteristiche genetiche
indesiderate (si richiamino le considerazioni precedentemente svolte sul problema eugenetico);
l’estrema problematicità etica di una simile procedura, che implica fin dall’inizio la decisione di
generare embrioni destinati a essere esclusi dal procedere nella loro vita, cioè la programmazione a
priori di una selezione fra di essi (simile procedimento, in altre parole, non consente di procreare un
figlio sicuramente sano, bensì opera attraverso la generazione di più embrioni fra i quali si
programma fin dall’inizio una selezione, che avviene a vita già iniziata);
le aperture a tale tecnica (che comporta, peraltro, un numero significativo di falsi positivi e falsi
negativi) desumibili dalle sentenze nn. 96 e 229/2015 Corte cost. (anche in rapporto
all’interpretazione del divieto di selezione eugenetica degli embrioni, previsto dall’art. 13, co. 3b,
legge 40/2004);
la permanente rilevanza che dovrebbe tuttavia mantenere rispetto all’utilizzabilità di tale tecnica il
già citato divieto di ricerca clinica e di sperimentazione a danno di ciascun singolo embrione, di cui
all’art. 13, co. 2, l. 40/2004;
- il rapporto tra medico e paziente e le problematiche del fine-vita:
- la medicina come attività socialmente adeguata e intrinsecamente lecita (non tale, quindi, solo in
funzione di una scriminante), che, peraltro, dev’essere conforme a una serie di requisiti suoi propri
(conformità alla lex artis) e di carattere normativo;
- i fini della medicina in quanto attività non meramente contrattualistica («doveri del medico – ai
sensi dell’art. 3 cod. deont. – sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del
dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona») e
l’impossibilità di considerare il ruolo del medico come meramente esecutivo;
- la permanente dignità del malato anche quando non possa più recuperare condizioni ordinarie di
vita e rappresenti, sul piano economico, un costo per la società;
- il ruolo del consenso rispetto all’attivazione di procedure diagnostiche o terapeutiche;
- la necessità di comprendere il senso delle manifestazioni di volontà del malato nella difficile
condizione psicologica della malattia (tenendo conto, per esempio, di un possibile profilo iniziale di
rimozione dinnanzi alla notizia di una patologia inattesa o di un intento di protesta, attraverso
espressioni di rinuncia alle terapie, nei confronti di un avvertito abbandono);
- la nozione di proporzionalità dell’intervento terapeutico;
- l’inaccettabilità sia del c.d. accanimento terapeutico, sia delle prospettive eutanasiche;
- l’importanza della medicina palliativa, intesa al contrasto della sofferenza;
- la problematica delle dichiarazioni anticipate di trattamento e il ruolo preferibile del concetto di
pianificazione condivisa delle terapie;
- sul rischio che, in nome di un supposto diritto di morire, si favoriscano pressioni dirette o indirette
sui malati non suscettibili di guarigione, e tali da costituire un costo sul piano economico, verso la
rinuncia alle terapie (sovente presentata come scelta dignitosa);
- i malati in condizioni di precarietà esistenziale cronica, ma non terminali, né sostenuti da
interventi medici nelle funzioni vitali: l’inaccettabilità dell’interruzione di idratazione e di
alimentazione, le quali non costituiscono terapie in quanto non contrastano una patologia (posto che
di esse necessitano anche i soggetti sani) e, dunque, non possono essere interrotte come se si
trattasse di terapie sproporzionate;
n.b.: sui temi di ambito biogiuridico sono disponibili tra i materiali didattici alcuni testi liberamente
scaricabili (biog1, biog2, ecc.);
25.5
- le misure di prevenzione e il d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione):
si segnalano gli artt. 1-6, 8, 15, 16, 18-20, 24, 25, 31-34, 67, 71;
le misure di prevenzione come provvedimenti che – diversamente dalle pene e, di regola, dalle
misure di sicurezza – non presuppongono la commissione di un reato;
il problema degli elementi di fatto che siano idonei a costituire un presupposto sufficientemente
determinato per attestare la pericolosità dei destinatari, evitando di sconfinare in giudizi di mero
sospetto o inerenti alla personalità; gli interrogativi correlati di costituzionalità;
le misure di prevenzione personali applicabili dall’autorità amministrativa di polizia (questore):
avviso orale, foglio di via obbligatorio; …e dall’autorità giudiziaria (tribunale): sorveglianza
speciale, divieto ed obbligo di soggiorno;
la distinzione fra misure di prevenzione di carattere personale e di carattere patrimoniale:
l’autonomia, introdotta nel 2009, tra le due categorie; il ruolo, a tale proposito, della legge n.
646/1982 (c.d. Rognoni - La Torre), con finalità di contrasto della criminalità di tipo mafioso;
la confisca come misura di sicurezza patrimoniale, che è considerata, in genere, facoltativa
dall’art. 240, co. 1, c.p. in rapporto al prodotto o al profitto del reato, ma che è stata resa
obbligatoria negli ultimi decenni rispetto a svariate tipologie criminose (p.es., art. 416-bis, co. 7),
anche nella forma per equivalente (p. es. artt. 644, co. 6, c.p.; reati in materia di pubblica
amministrazione), forma la quale necessiterebbe peraltro di una ben maggiore determinatezza;
in particolare, l’inversione dell’onere probatorio ex art. 12-quinquies, co. 2, d.l. n. 306/1992
(conv. con l. n. 356/1992) per chi risulti imputato di determinati delitti circa la legittima
provenienza di beni dei quali abbia la disponibilità in modo sproporzionato rispetto al reddito e alle
attività dichiarati, inversione giudicata costituzionalmente illegittima, in quanto faceva derivare
dalla mancata prova il realizzarsi di un’autonoma fattispecie di reato;
il caso diverso previsto del successivo art. 12-sexies, vigente, il quale fa derivare dalla mancata
prova della legittima provenienza, da parte di cui sia stato condannato per una serie di gravi delitti,
la confisca dei medesimi beni;
…e la confisca come misura di prevenzione (ma si discute sulla sua natura effettiva) prevista
dall’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 (sulla base del previo sequestro di cui all’art. 20, fondato su
sproporzione o su sufficienti indizi della provenienza illecita), che prevede un’analoga inversione
dell’onere probatorio, circa la legittima provenienza dei suddetti, beni rispetto alla persona nei cui
confronti sia instaurato un procedimento di prevenzione;
in sintesi, dunque, si può oggi addivenire, rispetto ai reati gravi richiamati dalla norme suddette, sia
alla confisca (in vari casi anche per equivalente) dei profitti provenienti dai medesimi, ove vi sia
stata condanna, sia, sempre in caso di condanna, alla confisca dei beni di cui il condannato abbia la
disponibilità in modo sproporzionato, nel caso in cui non sia in grado di giustificarne la provenienza
legittima, sia alla confisca degli stessi beni nell’ambito di un procedimento di prevenzione, sempre
nel caso in cui l’interessato non sia in grado di giustificarne la provenienza legittima.
- le circostanze attenuanti e aggravanti del reato;
le tipologie delle circostanze a) frazionarie; b) autonome (mutamento del tipo di pena) o
indipendenti (ambito edittale distinto da quello previsto per il reato base); e le diverse modalità
della loro incidenza in sede di determinazione della pena in senso lato;
le circostanze comuni (artt. 61 e 62 c.p.) e le circostanze riferite a specifiche tipologie di reato;
la dichiarata incostituzionalità (Corte cost. n. 249/2010) dell’art. 61, co. 11-bis, c.p.,
introdotto nel 2008, concernente «l’aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova
illegalmente sul territorio nazionale»;
la reintroduzione, avvenuta con d.lgs.lt. n. 288/1944 (e con le modifiche di cui alla l. n. 251/2005),
delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)
richiami all’art. 59 c.p.: la rilevanza oggettiva delle circostanze attenuanti e l’esigenza della
conoscibilità per le aggravanti; l’irrilevanza dell’erronea supposizione dell’esistenza delle
circostanze sia aggravanti che attenuanti (con effetti, nel secondo caso, sfavorevoli all’imputato);
il concorso di circostanze fra lor omogenee e la problematica introduzione del concetto di
circostanze a effetto speciale (artt. 63 c.p.); l’aumento o la diminuzione frazionaria non
specificamente determinati e i limiti degli aumenti in caso di concorso fra circostanze (artt. 64 ss.
cp.)
il giudizio di prevalenza ed equivalenza fra circostanze eterogenee, ex art. 69 c.p. (concorso di
circostanze aggravanti e attenuanti), e la riforma estensiva di tale regime, con d.l. n. 99/1974, anche
alle circostanze autonome o indipendenti;
negli ultimi anni, tuttavia, si è tornati a precludere tale giudizio, rendendo dunque il regime
sanzionatorio più severo, rispetto a vari reati gravi, in deroga alla regolamentazione generale
prevista dall’art. 69 c.p.;
del pari, si rende da anni manifesta una tendenza all’abuso nella previsione legislativa di circostanze
aggravanti, il cui regime complessivo appare oggi disorganico e quasi ingovernabile (si consideri, a
tal proposito, il ruolo del tutto marginale delle circostanze in altri ordinamenti penali europei);
l’abolizione, con il medesimo d.l. n. 99/1974, degli aumenti obbligatori di pena in caso di recidiva
(art. 99 c.p.); si noti che Corte cost. n. 185/2015 ha fatto cadere il caso di recidiva reiterata
obbligatoria, successivamente reintrodotto, di cui all’art. 99 co. 5. c.p.;
i motivi che rendono comunque discutibile, in rapporto al principio della colpevolezza riferita al
fatto, la rilevanza (pur non obbligatoria) della recidiva circa la determinazione della pena;
si rammenti, in proposito l’altro intervento attuato con il d.l. n. 99/1974 (provvedimento
rivolto, nell’impossibilità di addivenire a una riforma organica del codice penale, ad
ampliare con finalità mitigative, la discrezionalità giudiziaria), vale a dire l’ estensione del
cumulo giuridico al concorso formale e al reato continuato fra reati eterogenei, ex art. 81 c.p.
(v. supra);
l’assimilazione ai delitti circostanziati dei c.d. delitti aggravati dall’evento;
la rilevanza delle circostanze attenuanti e aggravanti nel concorso di persone (art. 118 c.p.).
26.5
- approfondimento circa i problemi che pone la categoria del reato omissivo improprio, ex art. 40,
stante la definizione oltremodo incerta del suo ambito applicativo:
a) le tipologie di reato in cui il reato omissivo improprio sia configurabile (essendo stato concepito,
originariamente, con riguardo ai delitti contro la vita e l’incolumità personale);
b) la sua riferibilità, stando all’impianto originario del codice, ai soli reati con evento naturalistico
nonché, in particolare, ai soli reati che non prevedano specifiche modalità della condotta (a condotta
libera), e la sua non rara applicazione giurisprudenziale anche a reati di pura condotta;
c) la riferibilità originaria del reato omissivo improprio a condotte direttamente impeditive
dell’evento e non al contrasto diretto di un comportamento causale altrui (salvo il caso in cui ciò
costituisca un contenuto esplicito dell’obbligo);
d) la ricostruzione delle fonti dell’obbligo di impedire (sia esso un obbligo di protezione o un
obbligo di controllo): sulle buone ragioni che consigliano di conservare, per ragioni di legalità, il
riferimento alla legge o al contratto e sul rischio, dal medesimo punto di vista, del riferimento
generico a posizioni di garanzia;
e) la non configurabilità di ogni obbligo avente significato di prevenzione come un obbligo di
impedire ai sensi dell’art. 40, co. 2, c.p. (occorre a quest’ultimo fine che quest’ultima finalità
emerga in modo chiaro dalla norma che istituisce l’obbligo: non sarebbe di certo accettabile, infatti,
che la moltiplicazione, negli ultimi anni, dei soggetti cui vengono attribuiti doveri finalizzati a
prevenire finisca per dilatare la sfera applicativa del reato omissivo improprio;
- si consideri, rispetto al punto d), che il passaggio da un approccio formale a un approccio
sostanziale nella lettura di una data fattispecie risulta problematico quando viene a costituire
un’estensione dell’ambito del punibile, in contrasto con il principio di legalità (e in particolare con
la riserva di legge), come accade mediante il passaggio da una definizione delle fonti dell’obbligo
di impedire fondata sulla legge o sul contratto a una definizione fondata su meno precisabili
posizioni di garanzia;
ben diverso è il caso, invece, nel quale il passaggio dall’approccio formale a quello sostanziale
comporti una restrizione in senso garantistico dell’ambito del punibile, come avviene attraverso il
riconoscimento del principio di offensività (v. supra);
esemplificazioni di domante ai fini del colloquio d’esame.