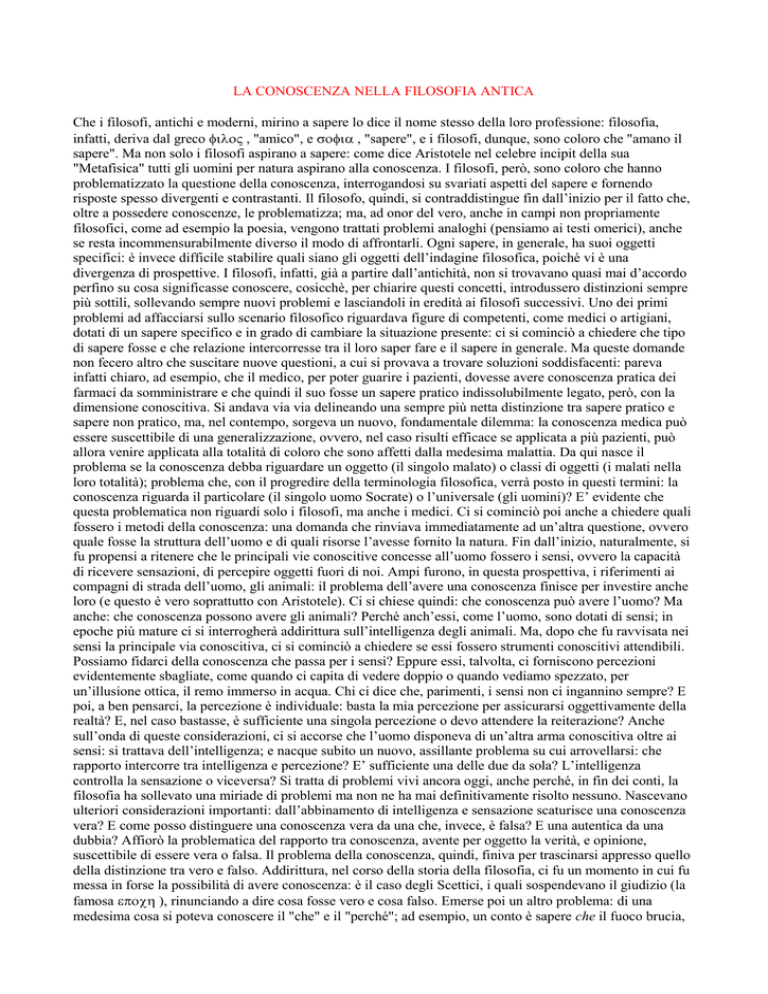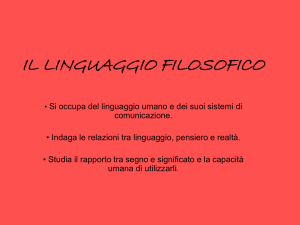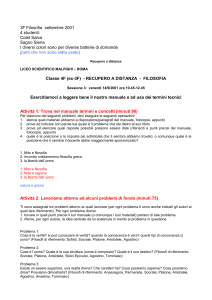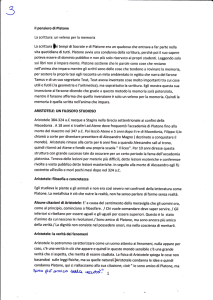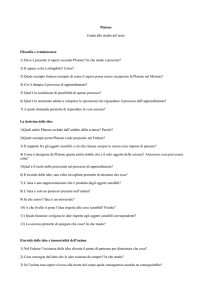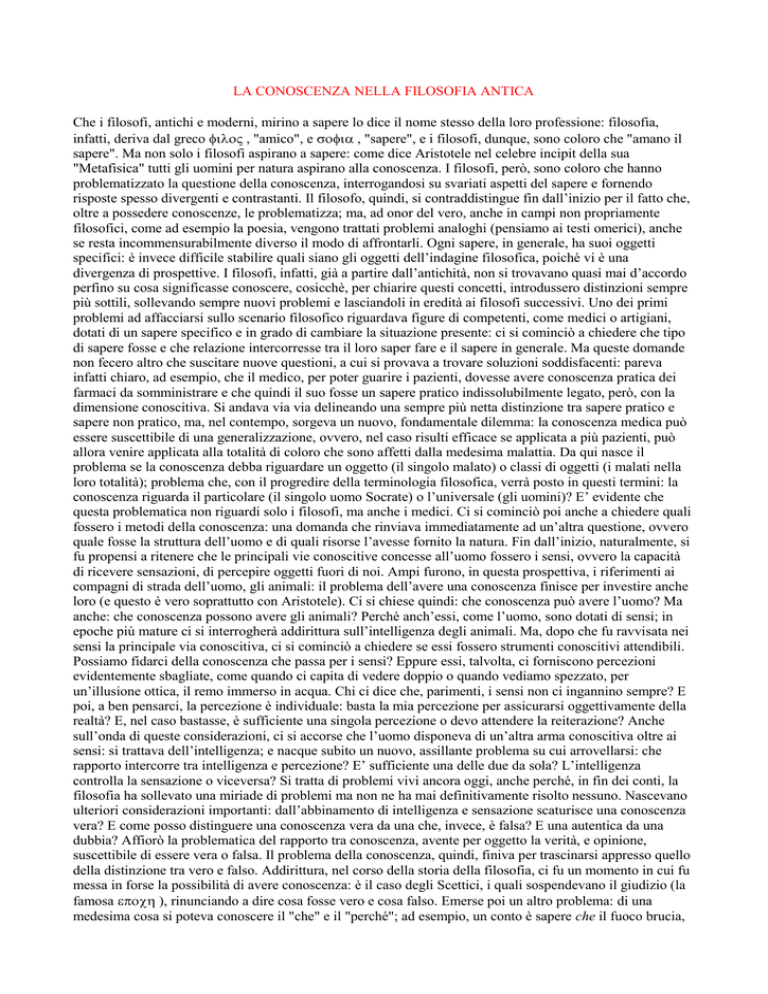
LA CONOSCENZA NELLA FILOSOFIA ANTICA
Che i filosofi, antichi e moderni, mirino a sapere lo dice il nome stesso della loro professione: filosofia,
infatti, deriva dal greco , "amico", e , "sapere", e i filosofi, dunque, sono coloro che "amano il
sapere". Ma non solo i filosofi aspirano a sapere: come dice Aristotele nel celebre incipit della sua
"Metafisica" tutti gli uomini per natura aspirano alla conoscenza. I filosofi, però, sono coloro che hanno
problematizzato la questione della conoscenza, interrogandosi su svariati aspetti del sapere e fornendo
risposte spesso divergenti e contrastanti. Il filosofo, quindi, si contraddistingue fin dall’inizio per il fatto che,
oltre a possedere conoscenze, le problematizza; ma, ad onor del vero, anche in campi non propriamente
filosofici, come ad esempio la poesia, vengono trattati problemi analoghi (pensiamo ai testi omerici), anche
se resta incommensurabilmente diverso il modo di affrontarli. Ogni sapere, in generale, ha suoi oggetti
specifici: è invece difficile stabilire quali siano gli oggetti dell’indagine filosofica, poiché vi è una
divergenza di prospettive. I filosofi, infatti, già a partire dall’antichità, non si trovavano quasi mai d’accordo
perfino su cosa significasse conoscere, cosicchè, per chiarire questi concetti, introdussero distinzioni sempre
più sottili, sollevando sempre nuovi problemi e lasciandoli in eredità ai filosofi successivi. Uno dei primi
problemi ad affacciarsi sullo scenario filosofico riguardava figure di competenti, come medici o artigiani,
dotati di un sapere specifico e in grado di cambiare la situazione presente: ci si cominciò a chiedere che tipo
di sapere fosse e che relazione intercorresse tra il loro saper fare e il sapere in generale. Ma queste domande
non fecero altro che suscitare nuove questioni, a cui si provava a trovare soluzioni soddisfacenti: pareva
infatti chiaro, ad esempio, che il medico, per poter guarire i pazienti, dovesse avere conoscenza pratica dei
farmaci da somministrare e che quindi il suo fosse un sapere pratico indissolubilmente legato, però, con la
dimensione conoscitiva. Si andava via via delineando una sempre più netta distinzione tra sapere pratico e
sapere non pratico, ma, nel contempo, sorgeva un nuovo, fondamentale dilemma: la conoscenza medica può
essere suscettibile di una generalizzazione, ovvero, nel caso risulti efficace se applicata a più pazienti, può
allora venire applicata alla totalità di coloro che sono affetti dalla medesima malattia. Da qui nasce il
problema se la conoscenza debba riguardare un oggetto (il singolo malato) o classi di oggetti (i malati nella
loro totalità); problema che, con il progredire della terminologia filosofica, verrà posto in questi termini: la
conoscenza riguarda il particolare (il singolo uomo Socrate) o l’universale (gli uomini)? E’ evidente che
questa problematica non riguardi solo i filosofi, ma anche i medici. Ci si cominciò poi anche a chiedere quali
fossero i metodi della conoscenza: una domanda che rinviava immediatamente ad un’altra questione, ovvero
quale fosse la struttura dell’uomo e di quali risorse l’avesse fornito la natura. Fin dall’inizio, naturalmente, si
fu propensi a ritenere che le principali vie conoscitive concesse all’uomo fossero i sensi, ovvero la capacità
di ricevere sensazioni, di percepire oggetti fuori di noi. Ampi furono, in questa prospettiva, i riferimenti ai
compagni di strada dell’uomo, gli animali: il problema dell’avere una conoscenza finisce per investire anche
loro (e questo è vero soprattutto con Aristotele). Ci si chiese quindi: che conoscenza può avere l’uomo? Ma
anche: che conoscenza possono avere gli animali? Perché anch’essi, come l’uomo, sono dotati di sensi; in
epoche più mature ci si interrogherà addirittura sull’intelligenza degli animali. Ma, dopo che fu ravvisata nei
sensi la principale via conoscitiva, ci si cominciò a chiedere se essi fossero strumenti conoscitivi attendibili.
Possiamo fidarci della conoscenza che passa per i sensi? Eppure essi, talvolta, ci forniscono percezioni
evidentemente sbagliate, come quando ci capita di vedere doppio o quando vediamo spezzato, per
un’illusione ottica, il remo immerso in acqua. Chi ci dice che, parimenti, i sensi non ci ingannino sempre? E
poi, a ben pensarci, la percezione è individuale: basta la mia percezione per assicurarsi oggettivamente della
realtà? E, nel caso bastasse, è sufficiente una singola percezione o devo attendere la reiterazione? Anche
sull’onda di queste considerazioni, ci si accorse che l’uomo disponeva di un’altra arma conoscitiva oltre ai
sensi: si trattava dell’intelligenza; e nacque subito un nuovo, assillante problema su cui arrovellarsi: che
rapporto intercorre tra intelligenza e percezione? E’ sufficiente una delle due da sola? L’intelligenza
controlla la sensazione o viceversa? Si tratta di problemi vivi ancora oggi, anche perché, in fin dei conti, la
filosofia ha sollevato una miriade di problemi ma non ne ha mai definitivamente risolto nessuno. Nascevano
ulteriori considerazioni importanti: dall’abbinamento di intelligenza e sensazione scaturisce una conoscenza
vera? E come posso distinguere una conoscenza vera da una che, invece, è falsa? E una autentica da una
dubbia? Affiorò la problematica del rapporto tra conoscenza, avente per oggetto la verità, e opinione,
suscettibile di essere vera o falsa. Il problema della conoscenza, quindi, finiva per trascinarsi appresso quello
della distinzione tra vero e falso. Addirittura, nel corso della storia della filosofia, ci fu un momento in cui fu
messa in forse la possibilità di avere conoscenza: è il caso degli Scettici, i quali sospendevano il giudizio (la
famosa ), rinunciando a dire cosa fosse vero e cosa falso. Emerse poi un altro problema: di una
medesima cosa si poteva conoscere il "che" e il "perché"; ad esempio, un conto è sapere che il fuoco brucia,
altra cosa è sapere perché il fuoco brucia. Quale tra le due conoscenze è superiore, quella del che o,
viceversa, quella del perché? Aristotele e Platone sostennero che conoscere il perché delle cose significa
spiegarle, ossia conoscere le cause che le hanno prodotte, con l’inevitabile conseguenza che, la conoscenza
del "che" è assai inferiore. In altri termini, la conoscenza del perché fornisce indicazioni generalizzabili,
grazie alle quali è possibile costruire una scienza. Un altro problema che si dovette presto affrontare fu
questo: per avere una vera conoscenza bastano conoscenze isolate o si deve piuttosto essere in possesso di un
sistema integrato di conoscenze? Questa tematica sarà particolarmente sentita e dibattuta in età ellenistica,
quando gli Stoici, gli Epicurei e gli Scettici provarono a tratteggiare la figura del sapiente: per gli Stoici, ad
esempio, il sapiente sarà colui che detiene tutte le conoscenze possibili, a tal punto che, per loro stessa
ammissione, un vero sapiente non è praticamente mai esistito. Naturalmente, col passare del tempo il sapere
tende sempre più a specializzarsi con l’inevitabile conseguenza che diventa sempre più difficile stabilire chi
sia il filosofo e capire quale sia il linguaggio mediante il quale il filosofo si esprime. Se è vero che ogni storia
ha un suo punto di partenza, bisogna chiarire da dove parta la storia della filosofia: e si può notare come la
questione della conoscenza umana cominci a sorgere in connessione al riconoscimento dell’esistenza di una
conoscenza divina; proprio il rapporto uomo/divinità costituisce il punto di partenza e il problema può
sinteticamente risolversi nella questione se l’uomo disponga o no di una conoscenza in qualche modo
accostabile a quella della divinità. Ovviamente la domanda rimanda all’interrogativo: quale rapporto
intercorre tra le due conoscenze, quella umana e quella divina? Per trovare qualche risposta dobbiamo
rivolgerci soprattutto ai testi poetici: nei poemi omerici, ad esempio, in cui sono spesso menzionati i tecnici,
gli indovini e i medici, i poeti presentano i loro canti come il risultato di un ammaestramento divino; la
divinità, dunque, era posta all’origine della loro espressione, il che significa che i poeti esprimono un sapere
che è a tutti gli effetti divino. Era infatti convinzione comune che la conoscenza fosse assolutamente
impossibile senza l’intervento divino ed è in questa prospettiva che Esiodo e Omero presentano i loro poemi;
in un passo dell’VIII libro dell’Odissea, Odisseo tesse le lodi del cantore Demodoco: " certo Apollo o la
musa figlia di Zeus ti istruirono "; il cantore, solo perché il sapere gli proviene da una fonte superiore, può
cantare ciò che capitò agli Achei a Troia pur senza aver visto coi suoi occhi. Anche l’incipit della Teogonia
esiodea è, sotto questo profilo, particolarmente significativo: " sono le muse che un giorno un bel canto
insegnarono a Esiodo ". Ma - e qui sta la cosa interessante - le muse in Esiodo raccontano anche cose false,
cosicchè sta all’uomo capire gli ammaestramenti divini, evitando di riceverli passivamente; in altri termini, il
messaggio è che non ogni forma di poesia, perché ispirata dalle muse, è autenticamente vera. Si affaccia così,
seppur timidamente, l’idea che la conoscenza umana abbia una sua indipendenza. Si invita il poeta a vigilare
sulla qualità del messaggio trasmesso; fatto sta che per Esiodo egli possiede una conoscenza eccezionale, del
futuro, del presente e del passato, e tende dunque a sfumare nella figura dell’indovino detentore di un sapere
totalizzante. Soffermando la nostra attenzione sul I libro dell’Iliade, a proposito dell’indovino Calcante viene
detto: " conosceva il presente, il futuro e il passato […] l’arte sua di indovino che gli donò Febo Apollo ".
Quella dell’indovino è una figura antica e appartiene, oltre che alla Grecia, anche al vicino Oriente: perfino
ai medici è spesso attribuita la capacità di prevedere il futuro; non a caso, la "prognosi" di cui parla Ippocrate
nel V secolo a.C. era, in origine, una previsione della salute per il paziente. Alcune tavolette babilonesi
contenevano poi elenchi di segni desunti dal mondo animale in base ai quali si potevano formulare previsioni
collegando il segno che si presentava con un evento destinato a verificarsi: ad esempio, troviamo scritto che "
se una lucertola si arrampica sul letto del malato, egli guarirà ". In questa prospettiva, il futuro può essere
predetto a patto che si presentino segni particolari, secondo una formula del tipo: "se x, allora y". Lo stesso
contenuto dei sogni si credeva che fosse indicativo, poiché si riteneva che essi svelassero cose che si
sarebbero verificate in futuro (ancora nel V secolo i medici ippocratei ne tenevano conto). Ma anche gli
artigiani e i medici, dunque, oltre ai poeti, erano detentori di una forma di sapere e, stando a quel che dice
Omero, compivano le loro opere con l’appoggio delle divinità: sempre Omero racconta di un’erba dai poteri
straordinari che poteva essere sradicata solo da una divinità e resa nota ai medici dalla divinità stessa; anche
il sapere dei medici, come quello dei poeti, era dunque concepito come divino. Tuttavia (e qui sta la
differenza rispetto ai poeti) il sapere dei medici e degli artigiani si accompagna al saper fare, al saper
costruire oggetti o produrre la salute. Si continuava a riconoscere che senza l’intervento divino il sapere non
aveva carattere assoluto, riconoscendo in tal senso i limiti della propria conoscenza e constatando che il
sapere umano non avrebbe mai potuto competere con quello divino per vastità e profondità. E dunque dal
confronto con l’alto (Dio) e col basso (gli animali), si intravedeva la possibilità di definire la conoscenza
umana: e tale via comincia ad essere battuta da un pensatore attivo dal VI al V secolo nella Magna Grecia,
Alcmeone di Crotone, che viene solitamente messo in relazione con il pitagorismo. Medico di professione,
era soprattutto mosso dall’esigenza di capire esattamente quale potesse essere la portata della conoscenza
umana. Egli distingueva in modo marcato la conoscenza umana da quella divina, mettendo in luce fin dove
quella umana potesse estendersi. Il sapere divino veniva da Alcmeone qualificato come , ovvero
assoluta certezza; quello umano, dal canto suo, veniva visto come notevolmente meno chiaro. Quelle cose
che per gli uomini risultano invisibili, sono, ad avviso di Alcmeone, perfettamente visibili per gli dèi: il
conoscere umano procede attraverso indizi () o, nel linguaggio medico, sintomi. Si deve dunque
costruire il sapere a partire dai segni, così come il medico parte dai sintomi per diagnosticare la malattia. Per
superare il buio, quindi, non ho bisogno di divinità che mi aiutino, ma piuttosto di sui quali fare
inferenze, passando così dalle cose certe a cose che certe non sono. Questi indizi intorno ai quali edificare la
conoscenza sono essenzialmente coglibili nell’ambito delle sensazioni, cosicchè si parte da ciò che si
presenta ai sensi per arrivare a ciò che ad essi non si presenta; bisogna però spiegare come funziona questo
passaggio e quale è lo strumento che consente di attuare l’inferenza. Ed è qui che entrano in gioco gli
animali: infatti anch’essi hanno percezioni, ma è solo l’uomo a poterle comprendere, ossia "raccogliere e
connettere" ciò che proviene dai singoli organi di senso. Ma ciò non toglie che attraverso quest’operazione di
raccoglimento e connessione dei dati sensoriali l’uomo finisca per costruire una conoscenza inferiore rispetto
a quella divina: " delle cose visibili e delle invisibili solo gli dèi hanno conoscenza certa ( ); gli
uomini possono soltanto congetturare […]. L’uomo differisce dagli altri animali perché esso solo
comprende " (ovvero sa connettere i dati sensoriali). Questa tesi, secondo la quale la conoscenza divina è più
ampia e precisa, è avanzata anche da Senofane di Colofone, che, secondo l’autorevole testimonianza di
Platone, sarebbe stato il capostipite dell’eleatismo. Il punto di partenza della sua riflessione è costituito dalla
critica alle concezioni antropomorfe della divinità, sintetizzabile nei suoi famosi versi: " ma se i buoi, i
cavalli e i leoni avessero le mani, o potessero disegnare con le mani, e fare opere come quelle degli uomini,
raffigurerebbero gli dei, il cavallo simili ai cavalli, il bue ai buoi, e farebbero loro dei corpi come quelli che
ha ciascuno di loro ". E’ facile comprendere perché Platone scorgesse in lui l’archegeta dell’eleatismo:
introducendo una sola divinità, Senofane finiva per proporre quell’unità tanto cara a Parmenide e ai suoi
discepoli. Se è sbagliato propugnare l’antropomorfismo degli dèi, altrettanto sbagliato è, nell’ottica di
Senofane, ritenere che la conoscenza divina sia paragonabile a quella umana: il sapere proprio della divinità
è infatti incommensurabilmente superiore rispetto a quello umano, e gli uomini, nella migliore delle ipotesi,
possono acquisire qualche certezza dopo aver percorso un faticoso itinerario conoscitivo; il tema della
conoscenza come tortuosa via da percorrere sarà ripreso e approfondito da Parmenide stesso. Senofane
dubitava fortemente che la divinità aiutasse gli uomini a conoscere, mettendo in questo modo l’accento sulla
responsabilità umana della conoscenza: senza godere di aiuti divini, l’uomo è responsabile e artefice della
propria conoscenza. Naturalmente, con la maggiore indipendenza dell’umano dal divino aumenta la fragilità
della situazione umana, poiché gli uomini devono agire solo in virtù delle proprie forze, in quanto la divinità
non ha fatto loro alcun dono (né le tecniche né il sapere). La prospettiva è piuttosto simile a quella di
Alcmeone, ma diversa è la soluzione: se per il filosofo di Crotone agli uomini non restava che congetturare,
secondo Senofane, invece, l’unica arma conoscitiva di cui essi dispongano è quella che egli definisce,
introducendo un termine destinato al successo, , l’opinione. La conoscenza umana è, dunque,
essenzialmente opinione, nemmeno congettura; il termine "opinione" suggerisce, tra l’altro, l’idea di una
instabilità del sapere umano, suscettibile di essere vero o falso. Ma Senofane lascia una via per sperare: agli
uomini è infatti concesso di avanzare verso il meglio, verso cioè opinioni migliori: in un frammento, egli
asserisce che " uno, Dio, tra gli dèi e tra gli uomini il più grande, né per aspetto simile ai mortali, né per
intelligenza "; la superiore intelligenza della divinità, ovvero le superiori attività percettive e intellettive che
la contraddistinguono, dice Senofane, sono tali perché coinvolgono la divinità nella sua totalità: gli uomini
con un senso vedono, con un altro gustano, con un altro ancora odono, e così via, mentre la divinità non
presenta, nella sua interezza, distinzioni sensoriali. Ciò non toglie, però, che, pur nella loro notevole
inferiorità, gli uomini possano acquisire conoscenze via via migliori: " non è che in principio gli dèi abbiano
rivelato tutte le cose ai mortali; ma col tempo, ricercando, essi trovano il meglio ". La conseguenza
necessaria di questa riflessione è che, procedendo per opinioni, il sapere umano non potrà mai raggiungere
certezze, ma solo, come abbiamo già detto, opinioni più accreditate di altre: " il certo nessuno mai lo ha
colto, né alcuno ci sarà che lo colga né relativamente agli dèi, né relativamente alle cose di cui parlo "; sotto
questo profilo, anche quando crediamo di dare una definizione esatta di qualcosa, in realtà ci muoviamo
comunque nell’ambito dell’opinione: ciascuno di noi può esprimere a parole nel migliore dei modi ciò che
qualcosa è, ma non per questo può conoscere con certezza, nel suo linguaggio, la cosa stessa. Anche
Parmenide di Elea, maggior esponente dell’eleatismo, si propone di percorrere la via del sapere per
raggiungere una forma di conoscenza quanto più precisa. Per meglio caratterizzare il proprio scopo, egli
ricorreva alla metafora della via da percorrere e da seguire, inserendo questa concezione nei versi del suo
poema ("Sulla natura"): proprio in quest’opera, attribuiva ad una dea il compito di illuminarlo
e di guidarlo nel difficile itinerario che portava alla conoscenza; era anzi proprio l’ausilio della dea che gli
permetteva di raggiungere la meta e, quindi, quella verità che sarebbe stata irraggiungibile percorrendo la via
degli uomini comuni, ossia l’opinione. Come i suoi predecessori poeti, anche Parmenide ha un messaggio da
trasmettere, poiché anche lui è interprete di un’illuminazione divina: il suo poema, dunque, alla pari di quello
dei poeti ispirati dalle muse, contiene una verità divina, di cui il filosofo è portavoce; la grande novità, però,
risiede nel fatto che Parmenide sia protagonista in prima persona e che la vicenda narrata altro non sia se non
il viaggio (in greco ) che l’ha portato a scoprire la verità; la divinità si limita a mostrare al filosofo la
via da seguire ed egli dovrà percorrerla contando esclusivamente sulle proprie forze. Parmenide stesso, in
modo analogo, si limiterà ad indicare agli uomini la via da seguire e spetterà a loro scegliere se percorrerla o
no. Il punto di partenza dell’indagine parmenidea è il rilevamento di un’evidente contraddizione: si vedono
le cose di natura essere e non essere di continuo, ossia in un perenne divenire (ora ci sono, ora non ci sono),
ma è soprattutto nel linguaggio, ancor più che nel mondo fisico, che possiamo rilevare la contraddizione;
sono gli uomini, infatti, a parlare in modo contraddittorio delle cose e finchè questo approccio sbagliato non
sarà superato si resterà nel mondo dell’opinione. La via dell’opinione è, per sua stessa natura, suscettibile di
essere vera oppure falsa (la cosa ora è, ora non è) mentre l’unica via di ricerca che conduce alla verità è
quella che dice che ciò che è è e non può non essere o, al contrario, che ciò che non è non è e non può essere.
La contraddizione appena delineata scaturisce dall’ambito sensoriale, poiché siamo portati a vedere che,
nell’ambito fisico, le cose ora ci sono, ora non ci sono, ovvero sono in costante divenire: la conoscenza
sensibile è, dunque, la via dell’opinione. La vera via del sapere è quella che dice o che una cosa è o che non
è, senza mediazione alcuna: al di là del dire "è" o "non è" non si può dire una terza cosa, secondo quel
principio che in età medioevale sarà formulato come "tertium non datur". Sotto questo profilo, il divenire
altro non è se non un’indebita mescolanza di essere e di non essere: una cosa ora è, ora non è. Va però
precisato che, nei testi che ci sono pervenuti, Parmenide non specifica quale sia il soggetto di "è" e di "non
è", ma, nonostante questa lacuna, il punto cardinale sta nel capire il carattere necessario di questa
disgiunzione. Il filosofo di Elea distingue tra essere, pensiero, linguaggio: si può solo dire e pensare ciò che
è, mentre non si può pensare o dire ciò che non è; pur non precisando il soggetto, Parmenide parla anche di
"ciò che è" e di "ciò che non è", e sostiene che l’unica via percorribile è quella di dire ciò che è, poiché non è
possibile imboccare la seconda strada, cioè dire o non dire ciò che non è. Ma la maggior parte degli uomini
segue una terza via, quella che dice contemporaneamente "è e non è", parlando di nascita e morte e, dunque,
supponendo un’assurdità: che l’essere nasca dal non essere. Uno dei problemi più sentiti (e presente in
qualche misura anche in Parmenide) era rappresentato da come si potesse trarre inferenza dalle cose visibili a
quelle invisibili; all’uomo, infatti, non risulta chiaro come sia fatto il mondo e perché sia fatto così, ma non è
impossibile raggiungere questa forma di sapere: si tratta di andare al di là della molteplicità visibile per
arrivare a cogliere uno o più princìpi capaci di spiegare in modo vero la struttura del mondo. Ed è a questo
tentativo che si possono ricondurre le esperienze dei primi filosofi della storia(Talete, Anassimandro,
Anassimene), i quali andavano alla ricerca di un misterioso ("principio") in grado di rendere conto
della struttura del mondo nella sua infinita molteplicità. Nel I libro della Metafisica, Aristotele presenta
questi pensatori come primi filosofi della storia, distinguendoli dagli scrittori di miti, dai teologi e dai poeti
perché essi per primi hanno investigato sul perché delle cose argomentando in maniera deduttiva. Mentre
Talete e Anassimene muovono alla ricerca di un principio assolutamente fisico (e lo ravvisano,
rispettivamente, nell’acqua e nell’aria), Anassimandro, invece, scorge quest’entità costitutiva primaria da cui
tutte le cose si sono differenziate in un qualcosa di invisibile, non direttamente percepibile, che lui chiama
("infinito"). L’idea, che sarà poi di Parmenide, secondo la quale non tutti gli uomini possono
accedere al sapere era forte in Eraclito da Efeso: la consapevolezza della propria eccezionalità è attestata da
alcuni aneddoti che confermano l’altezzosità di Eraclito, ma anche la sua oscurità espressiva. Aristotele
stigmatizzava il suo stile, considerandolo oracolare e, quindi, indegno di un filosofo: il testo di Eraclito, in
effetti, è molto ambiguo, volutamente ambiguo, poiché, a suo avviso, la verità non doveva essere facile da
comprendere, ma, al contrario, richiedeva grandi sforzi. Esempio tipico di questo linguaggio di difficile
comprensione è il frammento 1, che destò parecchi dubbi perfino in Aristotele: " di questo lógos che è
sempre gli uomini non hanno intelligenza, sia prima di averlo ascoltato sia subito dopo averlo ascoltato […]
". Bastava infatti una virgola a stravolgere il senso dell’intera frase: Eraclito voleva dire "di questo lógos che
è, sempre gli uomini non hanno intelligenza " oppure di questo lógos che è sempre, gli uomini non hanno
intelligenza " ? Altrettanto ambiguo è il frammento 2, in cui troviamo scritto: " bisogna dunque seguire ciò
che è comune. Ma pur essendo questo lógos comune (), la maggior parte degli uomini vive come se
avesse un propria e particolare saggezza "; l’ambiguità sta nel termine "comune", che in greco troviamo
espresso con il termine ; infatti, se significa "comune", significa "con l’intelligenza":
dunque Eralicito forse vuole dire che gli uomini non hanno intelligenza di ciò che è comune, cioè il .
Quest’ultimo termine, del resto, attorno al quale ruota tutta la filosofia di Eraclito, riveste una miriade di
significati tutti compresenti: , infatti, è della stessa famiglia del verbo , che significa "parlare" ma
anche "raccogliere", "contare", "dare conto di"; e in epoche meno antiche passò anche a designare, in ambito
matematico, il "rapporto", la "proporzione". Nella filosofia di Eraclito, il è espressione a livello
linguistico di ciò che le cose sono (ed è appunto quel che troviamo negli insegnamenti di Eraclito stesso), ma
è anche la ragione capace di rendere conto delle cose stesse e dell’ordine dell’universo. E la ragion d’essere
che si esprime in questo è la dialettica tra gli opposti: nelle singole cose, nota Eraclito, sono presenti i
contrari, in costante guerra tra loro; ed egli ci mostra questo conflitto tra opposti in diversi modi: nel
frammento 48 dice che " l'arco ha dunque per nome vita e per opera morte ", in quanto il termine greco che
designa l’arco ( ) è lo stesso che designa la vita; in modo assai simile, nel frammento 60 asserisce che "
una e la stessa è la via all'in sù e la via all'in giù ". Anche Eraclito polemizza contro le opinioni degli
uomini, accusandoli di fermarsi alle cose visibili senza riuscire a gettare uno sguardo all’invisibile e
deridendoli per il fatto che essi prestano fede alla "multiscienza" (), al sapere tanto molteplice
quanto presunto delle cose. A questi uomini sfugge che " la natura ama nascondersi " e che l’armonia
invisibile è migliore di quella visibile; ciononostante, Eraclito non nutre una radicale sfiducia nei sensi, ma,
semplicemente, è convinto che essi, da soli, non siano sufficienti. Ed è per questo che ritiene opportuno
prestare attenzione anche alla situazione in cui versano coloro che usano i sensi come unico mezzo di
conoscenza: " per anime barbare i sensi sono cattivi testimoni ", dove i barbari sono, secondo Eraclito,
coloro che non parlano il greco; essi si fidano dei loro sensi e, in questo modo, non riescono a comunicare
con il . E’ dunque necessario spingersi oltre le barriere dei sensi per raggiungere, mediante le parole, il
significato profondo delle cose stesse: chi, come i barbari, si arresta di fronte alla barriera sensoriale è da
Eraclito accostato a chi è desto ma è come se dormisse (frammento 1: " agli altri uomini rimane celato ciò
che fanno da svegli, allo stesso modo che non sono coscienti di ciò che fanno dormendo "). Quando si entra
in contatto con ciò che è comune, allora si sveglia l’intelligenza e gli uomini si fanno intelligenti: " unico e
comune è il mondo per coloro che sono desti " (frammento 89), mentre nel sogno ciascuno si rinchiude in un
mondo che è solamente suo e a cui gli altri non hanno accesso. Resta ora da chiedersi che cosa si debba fare
per entrare in contatto con il comune: a tal proposito, Eraclito asserisce in modo significativo, nel
frammento 101: " ho indagato me stesso "; solo chi indaga la propria persona, seguendo l’inscrizione
presente sul tempio di Delfi ("conosci te stesso"), può attingere al comune, mentre gli
uomini che non compiono quest’operazione " danno retta agli aedi popolari, si valgono della folla come
maestra "; in quest’ottica, i molti non valgono nulla e a contare davvero sono i pochi. Eraclito se la prende
anche con i sapienti (una delle prime polemiche della storia della filosofia), cui rinfaccia di imbandire una
conoscenza che altro non è se non erudizione: " sapere molte cose ( ) non insegna ad avere
intelligenza: l'avrebbe altrimenti insegnato ad Esiodo, a Pitagora e poi a Senofane e ad Ecateo "
(frammento 40). Ad accomunare la via di ricerca intrapresa da tre filosofi diversissimi tra loro, Democrito,
Anassagora ed Empedocle, è la convinzione che l’uomo possa conoscere a fondo la struttura dell’universo
perché, in ultima istanza, egli è costituito dagli stessi elementi che compongono l’universo stesso: in altri
termini, secondo la convinzione di questi pensatori, la similarità dell’uomo con il mondo gli permette di
conoscerlo. Certo siamo di fronte a tre figure di sapiente non amalgamabili tra loro: vivono tutti a cavallo tra
la prima e la seconda metà del V secolo a.C. Empedocle da Agrigento è, dei tre, il più giovane ma si
configura, per molti aspetti, come il più anziano: è un sapiente eccezionale e la sua raffigurazione se la dà lui
stesso, sostenendo che a conferirgli poteri fuori dal comune è il sapere di cui è detentore. Compose un’opera
intitolata e una dal titolo Purificazioni: non è però ancor oggi chiaro se le Purificazioni fossero
una parte del poema o un’opera indipendente. E del resto le due opere sono
incommensurabilmente diverse: nel Empedocle si attiene al sapere fisico, nelle Purificazioni
disserta di trasmigrazione delle anime e di colpe da scontare nelle reincarnazioni; ci troviamo dunque di
fronte ad un Empedocle fisiologo contrapposto ad un Empedocle mistico. Le Purificazioni, dedicate ai
migliori destinatari, si aprivano così: " o amici, che la grande città presso il biondo Acragante / abitate sul
sommo della rocca, solleciti di opere buone, / porti fidati per gli ospiti, ignari di malvagità, / salve! Io tra
voi come un dio immortale, non più mortale / mi aggiro fra tutti onorato, come si conviene, / cinto di bende e
di corone fiorite. " Affiora chiaramente la concezione che Empedocle ha di se stesso: egli si propone come
un dio immortale e dotato di poteri formidabili, preclusi ai più. La stessa tradizione ci ha descritto
Empedocle come un indovino, profeta, medico, mago ed eroe: si racconta perfino che avrebbe richiamato in
vita una donna che non respirava più da quaranta giorni (Galeno ne farà un caso di isteria più che di
medicina). Eppure c’è un modo per conciliare le vocazioni poetiche, magiche, eroiche e mediche di
Empedocle con la sua attenzione naturalistica: la filosofia così com’egli l’ha concepita l’ha portato a
comprendere la struttura profonda dell’universo, penetrando quell’invisibile inaccessibile agli altri uomini;
con la conseguenza che, secondo il filosofo agrigentino, solamente chi conosce l’universo può intervenire in
termini pratici su di esso. Intorno alla figura di Empedocle circola un pulviscolo di aneddoti che hanno fatto
quasi sfumare nella leggenda il personaggio: per esempio si narra che egli avesse arrestato il soffiare dei
venti portatori di pestilenza ad Agrigento (e per questo fu detto "carceriere dei venti") o che si fosse gettato
nell’Etna per dimostrare la propria immortalità divina. La convinzione di fondo che sta alla base della sua
filosofia è, come abbiamo detto, la credenza che si possa conoscere il mondo perché siamo costituiti dai suoi
stessi elementi: a tal proposito, egli rintraccia quattro "radici" ( ), ovvero quattro elementi
fondamentali che compongono l’universo (acqua, aria, terra, fuoco) e legge il processo conoscitivo in chiave
di attrazione del simile verso il simile. Il simile che è nelle cose riconosce il simile che è in noi, cosicchè il
simile conosce il simile: ciò tuttavia non significa che la conoscenza si risolva in un processo di
assimilazione, quasi come se l’uomo rendesse simili a sé gli oggetti. Viceversa, spiega Empedocle, ciascuno
di noi è dotato di minuscoli pori da cui entrano flussi di materia provenienti dai corpi estranei (per attrazione
del simile sul simile): riusciamo a riconoscere cosa sta fuori di noi perché noi stessi siamo costituiti dai
medesimi quattro elementi. Sorge spontanea la domanda: e con che strumento avviene, concretamente, la
conoscenza? Con i sensi: Empedocle non dubita della loro validità come mezzi gnoseologici, ed è
consapevole che non sia facile cogliere la verità; l'errore più grave che si possa commettere (e che, di fatto, si
è inclini a commettere) è di privilegiare un senso specifico trascurando gli altri: al contrario, tutti e cinque i
sensi hanno pari dignità e ciascuno di essi avvalora ciò che testimoniano gli altri, sicchè tutto il nostro corpo
è coinvolto nella conoscenza, la quale avviene, ad avviso di Empedocle, in tempi molto lunghi e con
difficoltà consistenti. La verità che il pensatore agrigentino vuole trasmettere è racchiusa nelle parole da lui
pronunciate: il suo linguaggio, dunque, è il linguaggio della verità, latore di un messaggio salvifico che
redime dalla colpa originaria che ciascuno di noi sconta nella vita attuale. Ma è assai difficile persuadere la
mente umana, perché essa è infestata da credenze che si fermano al sensibile ed Empedocle in persona prega
Dio affinchè lo liberi da questa prigionia, dalla " follia " in cui sono immersi gli uomini comuni; ed è
appunto per differenziarsi da costoro che egli impiega un linguaggio innovativo. Nella storia della filosofia
antica si fa sempre più strada l’idea che la vera conoscenza attinga alla profondità delle cose, non alla loro
parvenza: in questa prospettiva si muove già, come abbiam visto, Empedocle, ma non è il solo; acccanto a
lui, anche Democrito e Anassagora intraprendono, entrambi nel V secolo a.C., la stessa via. Anassagora ,
proveniente dalla Ionia e, in particolare, dalla città di Clazomene (situata nell’attuale Turchia), riveste
un’importanza particolare perché con lui il pensiero antico sbarca ad Atene, città che, da quel momento per
parecchi secoli, costituirà il fulcro della vita intellettuale. Ad Atene giungeranno pensatori e uomini di
cultura da tutto il mondo: grandi poeti tragici (Sofocle, Euripide), grandi commediografi (Aristofane) e
illustri medici (Ippocrate). Il trasferimento di Anassagora ad Atene segna poi la fine del naturalismo ionico:
da quel momento la filosofia cambia modi e oggetti, abbandonando l’indagine sulla ricerca del principio.
Non bisogna dimenticare che quando Anassagora approda ad Atene, proprio in tale città Socrate stava
cominciando la propria formazione (nel "Fedone", Platone ci riferisce che Socrate ebbe modo di leggere e di
criticare Anassagora). Anassagora, dunque, è l’ultimo ad occuparsi, in senso stretto, di studi della natura,
poiché con Socrate la filosofia cambia oggetti di riflessione e si trasforma in riflessione sui , sui
discorsi e sui valori umani. Anassagora riveste un ruolo di rilievo anche perché fu uno dei primi pensatori
della storia ad essere condannato di empietà (condivideranno una sorte analoga anche Socrate e Protagora)
per le idee rivoluzionarie di cui si faceva portavoce: giusto per addurre un esempio, la sua convinzione che
gli astri fossero costituiti da terra e il sole da fuoco non poteva che suscitare lo sdegno dei benpensanti che
leggevano in essi la presenza divina. Per Empedocle gli elementi costitutivi dell’universo erano di numero
limitato (quattro radici) ed erano abbinati a delle divinità; ora, per Anassagora alla base della realtà non
stanno quattro radici, ma un numero infinito di princìpi , poiché l’infinita varietà della realtà non può
spiegarsi se non postulando una serie infinita di princìpi che, associandosi o disgregandosi, danno origine
alla composizione o alla dissoluzione dei corpi. Anassagora, per rendere più concreto il discorso, ricorreva
ad una metafora di stampo biologico: chiamava "semi" i suoi princìpi, con un evidente riferimento alla
generazione animale e vegetale tramite i semi. Tali semi stanno a principio di ogni generazione, sono infiniti
di numero, ma anche infinitamente divisibili: infatti, dice Anassagora, per quanto li si possa suddividere, non
si arriva mai ad un punto ultimo non ulteriormente divisibile. Anassagora ne traeva la conseguenza che "
tutto è in tutto ": gli uomini mangiano un singolo pezzo di pane e crescono le loro unghie, i loro capelli, ecc.,
perché nel pane stanno nascosti i semi di tutte le cose (quindi anche dei capelli, delle unghie, ecc.); sorge
spontaneo chiedersi perché, stando così le cose, non si vedano tutti i semi ma solo un pezzo di pane. La
risposta di Anassagora è che tutti i semi che costituiscono il mondo sono compresenti nel pezzo di pane, ma
sono invisibili perché troppo piccoli e troppo pochi rispetto ai semi del pane; sicchè vedo questi ultimi
proprio in virtù del fatto che sono in stragrande maggioranza. Questa prospettiva può essere compendiata nel
detto: " , "le cose che appaiono sono uno sguardo sulle cose oscure", con l’idea
che ciò che appare alla vista consente empiricamente di gettare uno sguardo su ciò che non si vede. Il punto
di partenza, anche per Anassagora, resta il visibile: sul piano gnoseologico, questo consente di affermare che
la conoscenza procede per inferenze, ovvero si parla di ciò che non si vede a partire da ciò che invece si
vede. Ma il sapere umano, secondo Anassagora, procede gradualmente e l’esperienza costituisce solo il
primo e il più basso, nonché il più immediato, gradino della scala conoscitiva, gradino sperimentabile con
facilità da tutti quanti; ma al di là di questo livello base si colloca la memoria, formata dal ripetersi delle
esperienze. Essa restringe la conoscenza al solo ambito umano, precludendola a tutti gli altri esseri.
Anassagora, poi, faceva nascere dalla memoria il terzo gradino, quello della (sapienza), in riferimento
alla sua dimensione teorica: la altro non è se non il sapere puro, meramente intellettuale. E al gradino
più alto della sua scala gnoseologica, il pensatore di Clazomene collocava quella che a suo avviso era la
conoscenza superiore a tutte le altre: la , il sapere tecnico. Dopo aver distinto nettamente il sapere
() dal saper fare () in virtù del fatto che la "tecnica" implica il risvolto pratico della conoscenza,
Anassagora predilige il saper fare rispetto al puro e semplice sapere, perché convinto che l’uomo riveli la
propria grandezza conoscitiva quando produce oggetti. Anzi, a rigore, l’applicare ciò che ha appreso
all’attività pratica è ciò che più contraddistingue l’uomo dagli altri animali: la supremazia dell’uomo sul
mondo è, in quest’ottica, determinata dal possesso delle mani. Stando a quel che ci riferisce Aristotele,
Anassagora sostiene che l’uomo è il più intelligente fra gli animali perché è dotato delle mani; dal canto suo,
Aristotele capovolge l’asserto anassagoreo e arriva a dire (in una prospettiva finalistica) che l’uomo ha la
mano perché è il più intelligente fra gli animali. Anche Democrito di Abdera procede in direzione piuttosto
simile ad Anassagora: anche a suo avviso la conoscenza è possibile grazie alla similarità tra l’uomo e gli
oggetti del suo sapere, ed è altresì convinto che la conoscenza giaccia in profondità e sia raggiungibile per
inferenza a partire dal visibile. Democrito è passato alla storia, insieme al suo maestro Leucippo (di cui
sappiam pochissimo), per aver gettato le basi dell’atomismo: con lui, con Anassagora e con Empedocle il
problema della conoscenza diviene un problema assolutamente fisico; infatti, per Empedocle il simile attira il
simile (sento il calore di un oggetto perché il calore è già presente in me), per Anassagora è il dissimile che
conosce il simile (conosco il caldo in virtù del fatto che so cosa sia il freddo, attraverso una compenetrazione
degli opposti); il chiamare in causa l’anima nel processo conoscitivo arriverà solo un po’ di tempo dopo. La
dottrina atomistica, così come viene formulata da Democrito, ha degli sviluppi grazie ad Epicuro e a
Lucrezio, anche se, in realtà, i tratti generali che la contraddistinguono restano pressochè invariati: ciò che
più colpisce di tale dottrina è la sua marcata economicità, grazie alla quale con una sola ipotesi si spiegan
tutti i fenomeni esistenti. Nella ricerca della chiave di lettura della perennità dei movimenti di generazione e
corruzione (evitando però l’inganno eleatico della negazione del divenire), questi tre pensatori (Empedocle,
Democrito, Anassagora) tendono a postulare una molteplicità di princìpi (per questo sono spesso chiamati
"pluralisti") in base ai quali spiegare tali processi di aggregazione e disgregazione: i princìpi considerati da
Empedocle sono le "radici", quelli di Anassagora i "semi" e quelli di Democrito sono gli "atomi",
accomunati dal fatto di essere un "sostrato" (la definizione è di Aristotele) che non muta mai e garantisce in
eterno la generazione e la corruzione. Come si dimostra l’esistenza degli atomi? Osservando le cose che
continuamente divengono sotto ai nostri occhi: nell’aggregarsi e nel disgregarsi costante cui vanno incontro
le cose, ci dovrà pur essere qualcosa che non muta mai, altrimenti le cose e, in generale, il mondo si sarebbe
già disgregato da tempo; questo qualcosa sono, secondo Democrito (e secondo Epicuro, che si avvarrà di
questa dimostrazione) gli atomi (), strutture che non possono essere divise e che quindi sono
totalmente "piene"; essi sono l’ultima parte che resta quando si divide un corpo fino ai suoi elementi di base;
se i "semi" di Anassagora erano infinitamente divisibili, gli atomi democritei non lo sono (Leibniz avrà da
ridire con la nozione così intesa di atomo), perché se lo fossero allora sarebbero composti da parti e quindi
sarebbero soggetti alla corruzione e all’aggregazione. Accanto agli atomi, Democrito introduce la nozione di
"vuoto", che deve necessariamente essere postulato come condizione per il movimento degli atomi: se infatti
tutto fosse "pieno", gli atomi non avrebbero spazio in cui muoversi e l’aggregazione e la disgregazione non
potrebbero avere luogo; ma i sensi ci testimoniano il contrario, per cui è necessario postulare il vuoto. E’
curioso il fatto che, influenzato dall’eleatismo, Democrito chiamasse gli atomi e il vuoto, rispettivamente,
"essere" e "non essere", parlando a livello fisico di ciò che per Parmenide era a livello puramente logico. Gli
atomi non sono infinitamente divisibili, ma sono di numero infinito: il che comporta importantissime
conseguenze; prima fra tutte, il fatto che siano infinitamente aggregabili, ovvero possono dare vita a infinite
combinazioni e, di conseguenza, a infiniti mondi. In secondo luogo, di vuoto se ne parla in due accezioni: c’è
un vuoto esterno (condizione di movimento per gli atomi); ma anche nelle strutture che si formano
dall’aggregarsi degli atomi vi sono parti vuote e ciò è attestato dal fatto che la struttura dei corpi è
suscettibile di trasformazioni: la struttura dell’animale è indubbiamente compatta, eppure cresce (ovvero
assume materia) e invecchia (cede materia), e questo si spiega solo in base al movimento degli atomi
all’interno di questa struttura. Dunque ci deve essere il vuoto anche all’interno dei composti di atomi.
Asserendo che tutto è costituito da atomi, Democrito presuppone la similarità di struttura tra il soggetto
conoscente e l’oggetto conosciuto: tutta la conoscenza, dunque, è riconducibile ad una forma di sensazione e
l’anima stessa è un composto di atomi cosicchè la conoscenza di cui essa è artefice avviene per
aggregazione. Aristotele, nel "De anima", ci riferisce che per Democrito l’intelligenza è legata alla presenza
di atomi ignei nell’anima, caldi e velocissimi e, dunque, idonei per spiegare la velocità del pensiero.
Nell’ottica democritea, non c’è differenza di livelli di conoscenza, tutto è percezione (persino gli oggetti del
pensiero): dal cielo alla terra non ci sono che corpi costituiti da atomi e contenenti il vuoto e che (proprio
perché contenenti il vuoto) emanano gli , le "immagini" delle cose; tali altro non sono se non
atomi che si staccano continuamente dai corpi (Epicuro parla di pulsazione dei corpi stessi) e si rendono così
a noi percepibili. Anche il corpo del soggetto percipiente, infatti, è un aggregato atomico dotato di vuoto o,
meglio, di canali vuoti: gli si incuneano in questi canali vuoti e rispecchiano l’immagine dell’oggetto
rendendolo percepibile: si ha dunque una conoscenza per contatto. Ricapitolando, la conoscenza avviene per
percezione (sensismo gnoseologico) e quest’ultima avviene per contatto attraverso i cinque sensi e, se non ci
fosse il vuoto, la percezione sarebbe dolorosa perché gli colpirebbero i nostri atomi anziché infilarsi
nei canali vuoti. Tuttavia, se i corpi continuano a cedere materia (gli che si staccano), allora ne
consegue che essi sussistono fin tanto che la materia ceduta è bilanciata da quella ricevuta: e la mancanza di
respiro, ovvero la fine del ricambio di atomi, è la prova della fine dell’esistenza del corpo. La legge che vige
nel mondo degli atomisti è il caso, nel senso che non vi è alcuna causa extranaturale capace di governare il
movimento degli atomi: essi si aggregano in maniera puramente casuale (ed è anche per questo che Dante
rinfaccia, nel IV canto dell’Inferno, a Democrito di porre il mondo a caso). Naturalmente sorge spontaneo un
quesito: che cosa mi garantisce che gli mi riportino tale e quale la forma dell’oggetto a cui
provengono? Non potrebbe essere che, nello spazio che percorrono per giungere a me, subiscono una
modificazione? Qui le posizioni degli atomisti divergono: Epicuro pensa che gli ci raggiungano con
velocità pari a quella del pensiero, cosicchè non vi è possibilità di errore. Per Democrito, invece, tutto
cambia: " nulla conosciamo secondo verità perché la verità è nel profondo ", egli afferma; sembra quasi una
professione di scetticismo, ma in realtà non lo è affatto. Infatti, Democrito vuol semplicemente dire che la
verità sono gli atomi e il vuoto e che tutto il resto (il dolce, l’amaro, il caldo, il freddo, ecc) è opinione che, in
quanto tale, è suscettibile di essere vera o di essere falsa e che varia da individuo a individuo. Democrito si
accosta dunque al motto di Anassagora " ": il mondo che mi appare è opinione,
e anche le opinioni si formano in base alla percezione, anche se si fermano alla superficialità, alle qualità
esterne del corpo (caldo, freddo, ecc). In quanto frutto di sensazioni, anche le opinioni hanno un fondo di
verità, anche se l’unica verità degna di essere definita tale è quella che si conosce quando si conoscono il
vuoto e gli atomi. " Non conosciamo nulla che sia invariabile, ma solo aspetti mutevoli ", dice Democrito: e
ne deduce l’esistenza di due forme di conoscenza, una genuina ("legittima", secondo il linguaggio giuridico),
l’altra oscura ("illegittima"): la conoscenza sensibile è oscura, mentre gli oggetti di quella genuina sono
nascosti. Nel V secolo anche i Pitagorici si interrogano sul problema conoscitivo prospettando soluzioni
diversissime da quelle avanzate dai loro contemporanei: anch’essi rinviano ad una struttura profonda delle
cose, costituita però non da semi, da radici o da atomi, ma dai numeri. Filolao di Crotone sostiene che la vera
conoscenza delle cose deriva dal fatto che esse sono esprimibili in numeri: per noi essi sono entità astratte,
ma i Pitagorici ne avevano una concezione fisico-spaziale e li rappresentavano con sassolini. I numeri
consentono di delimitare sezioni spaziali e lassi di tempo, il che significa che le cose stesse hanno numero ed
esso non può essere uno schema arbitrario imposto alle cose, ma, viceversa, sono le cose stesse a manifestare
una forma di numero che le rende conoscibili ed esprimibili: possono essere contate e distinte le une dalle
altre in base alla loro struttura componente elementare. Sono i numeri che conferiscono alle cose forme e
strutture, conoscibili appunto attraverso relazioni numeriche: esse per Filolao si configurano come armonia,
con un evidente richiamo alla musica. La conoscenza, quindi, consiste nella ricerca dei rapporti esistenti
nelle cose, poiché, come dice Filolao, " tutte le cose che si conoscono hanno numero; senza numero non
sarebbe possibile pensare o conoscere alcunchè. […] ma la natura del numero e la sua grande potenza […]
le si vedono anche in tutte le attività degli uomini "; le stesse azioni divine sono numerabili, poiché " nel
numero non penetra menzogna ". Il numero diviene lo strumento di conoscenza della verità: Archita di
Taranto segue la stessa strada di Filolao e in particolare mette in luce la funzione fondamentale del numero
per una nutrita serie di discipline, fra cui troviamo anche l’astronomia e la musica, il che è interessante
perché si tratta della prima attestazione dell’esistenza di scienze "speciali" all’epoca. L’impostazione
matematizzante delle scienze di Archita viene curiosamente ripresa da Platone nella "Repubblica", in cui la
matematica e la musica rivestono un ruolo assolutamente centrale nell’educazione dei giovani; tutte queste
scienze Archita le chiamava "sorelle", perché figlie di un unico padre, il numero. Quest’ultimo costituisce la
chiave d’accesso generale per conoscere le realtà particolari. Ma a quei tempi, accanto ai matematici come i
Pitagorici, troviamo anche parecchi medici: ed è nei trattati ippocratei che il metodo della medicina viene
teorizzato in modo completo; anche i medici, come i filosofi, partono dal visibile, in particolare dai sintomi
delle malattie, e per inferenza sono in grado di risalire, con la sola forza del ragionamento, alle cause
nascoste delle malattie e, in base a ciò, propongono terapie in grado di debellarle. Non tutti, però,
concordavano nell’imputare a cause generali l’origine delle malattie: c’era anche chi restava saldamente
ancorato alla sfera dell’esperienza, senza operare inferenze di alcun tipo; è questo il caso dell’anonimo
autore di un trattato su "La medicina antica" (risalente al 430-415 a.C.). Il pubblico a cui si rivolge questo
autore non è costituito esclusivamente da medici: il messaggio centrale che egli vuole trasmettere è che la
medicina sta assumendo uno statuto ontologico autonomo e di scienza. La medicina può perfezionarsi solo
col tempo e lo scritto si schiera contro ogni medicina "filosofica", che pretende cioè di insegnare il mestiere
ai medici a partire da teorie generali sull’uomo e sul mondo: ciò implica un eccesso di generalità che le rende
inutilizzabili, giacchè i filosofi () non spiegano il rapporto dell’universale col particolare. Non a
caso l’autore etichetta queste teorie come "ipotesi", ossia come supposizioni di come stanno le cose, ipotesi a
partire dalle quali avanzano la pretesa di aver scoperto chiavi di lettura valide per tutti; e l’autore scaglia i
suoi dardi contro Empedocle e contro gli altri pensatori dell’epoca. Il medico, a differenza del filosofo, può
rivendicare di dare il bene reale agli uomini: molto marcato è il senso della scoperta della medicina e della
sua autonomia indiscutibile, la sua capacità di fare scoperte cosicchè anche " il resto nel futuro sarà scoperto
"; non ci si deve, pertanto, fermare alle scoperte fatte, ma bisogna adoperarsi per farne di nuove e questo è
possibile solo se le generazioni future faranno tesoro del sapere accumulato dai loro predecessori. Coi
profani si deve solamente discutere dei mali che affliggono l’uomo e loro stessi: in quest’ottica, è
importantissima l’anamnesi, ovvero la ricostruzione mediante il colloquio col paziente del male passato per
costruire il male presente e l’evoluzione che la malattia avrà nel futuro. Questa metodologia non è propria
solo dei medici: anche gli storici, in una certa misura, partono dalla convinzione che per prevedere il futuro
si debba conoscere bene il passato, perché ciò consente di formulare delle costanti. Ma come è nata la
medicina? E’ un sapere naturalissimo, risponde l’anonimo autore del trattato: il momento in cui uomini
illuminati si interrogarono se chi soffriva dovesse seguire lo stesso regime alimentare di chi era sano fu la
causa scatenante di tale disciplina, nata, in fin dei conti, per la naturalissima esigenza di sopperire alle
malattie dell’uomo, necessità ineliminabili. Il passaggio dallo stato ferino alla civiltà sta, ad avviso
dell’autore, nella scoperta del fuoco e nella cottura dei cibi. Proprio così si scopersero quali cibi erano utili e
quali no: il sapere medico è nato nel momento in cui l’uomo è passato ad uno stato "umano" e al progresso
della condizione umana è legato quello della disciplina medica. Non c’è da meravigliarsi se i primi scopritori
di quest’arte erano visti come divinità, anche se, in realtà, erano uomini che esercitavano una tecnica
tipicamente umana. Ma addirittura per sapere cosa è la natura è necessario partire da studi di medicina: il
medico sa cosa è l’uomo e lo deduce da ciò che l’uomo mangia e beve, studiandone la salute e la condotta di
vita; medico non è, dunque, chi dice che il formaggio è un cibo cattivo, ma chi dice che il formaggio è
cattivo perché genera questi determinati mali. Ma la tematica della ricerca del sapere non è solo in filosofia:
nell’ "Edipo re" vengono posti a confronto alcuni tipi di sapere ed in particolare emerge la congetturalità del
sapere umano: la verità nascosta nell’Edipo è la scoperta di chi è il colpevole dell’ efferato omicidio di Laio,
vecchio re di Tebe, città in cui ora infuria la peste come punizione divina per tale uccisione. All’inizio della
tragedia Edipo si pone, come un detective, sulle orme dell’assassino e presenta la sua ricerca come quella dei
cani sulle orme della selvaggina, mosso dalla responsabilità verso la città e verso i suoi concittadini. Egli
segue indizi nella sua indagine: le testimonianze di chi ha visto o sentito qualcosa dell’accaduto; e chiede
anche il responso dell’indovino Tiresia, detentore di un sapere ispirato dalle divinità: fuor di metafora, ciò
significa che il sapere umano può far appello al sapere divino, capace di padroneggiare tutte le cose. Tiresia
viene invitato a trarre gli auspici dal volo degli uccelli e viene riconosciuta la possibilità di errore della
divinazione, la quale avviene non già in base ad un ragionamento, bensì su diretta ispirazione divina. Tiresia
manifesta una certa paura perché mostra di conoscere gli uomini: e infatti Edipo, dopo aver udito il suo
responso, lo accusa di aver congiurato contro di lui; in questa prospettiva, affiora come la verità porti anche
dei mali. " Aih, trasparente ( ) verità! ", grida Edipo dopo aver appreso di essere stato lui
l’uccisore del padre. Il V secolo a.C. è un’epoca di grande fermento intellettuale, in cui si intensificano i
rapporti con culture diverse da quella greca: protagonisti di questa nuova stagione culturale sono i Sofisti,
che di fronte alla diversità di costumi e tradizioni in cui si imbatte la civiltà greca propongono la relatività
(già presente, in qualche misura, in Senofane), un modo di riconoscere a ciascuna di queste culture
un’autonomia e una dignità. Questo nuovo modo di vedere è anche dovuto al fatto che in questo periodo si
comincia a viaggiare con maggior frequenza e si entra in contatto con nuove culture, pur non mettendo da
parte il greco-centrismo. Anche gli storici rappresentano bene questa nuova fase della storia greca: essi si
basano soprattutto sull’autopsia, trasmettono cioè ciò che han visto loro stessi, ma accanto alla centralità
della vista viene riconosciuta anche l’importanza dell’udito, ossia si presta importanza a ciò che si sente ma
non si è visto. L’abilità dello storico risiede nel ponderare le fonti e le notizie: caso lampante è quello di
Erodoto, le cui "Storie" non sono solo cataloghi di usi e costumi di popoli remoti. In questo scenario si
colloca la figura di Protagora di Abdera, inauguratore della prassi dei viaggi e del movimento sofistico: in
origine il termine "sofista" significa semplicemente "possessore della "; fu da Platone e Aristotele in
poi che assunse una sfumatura negativa, in quanto essi rinfacciavano ai sofisti il fatto che essi vendessero il
sapere come una qualsiasi altra merce. Proprio sulla nozione di relatività era incentrata la più famosa delle
tesi di Protagora, trasmessaci da Platone nel "Teeteto" (dialogo dedicato a cosa significhi conoscere) : "
l’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non
sono ". Questa frase, per l’impiego del termine "sono" e "non sono", sembra inquadrarsi in un contesto
vivamente eleatico, anche se viene prospettato chiaramente il criterio per distinguere l’essere da non essere: è
l’uomo il metro di misura, sicchè Protagora propone un criterio di conoscenza puramente soggettivo. Resta
però da chiedersi che cosa intende il sofista di Abdera per "uomo": egli, probabilmente, non alludeva
all’umanità considerata nel suo insieme, ma al singolo uomo nella sua immediatezza e nella sua soggettività;
tutto questo rimanda, naturalmente, alla soggettività della verità. Sarà vero ciò che a me appare tale;
viceversa, per lui sarà vero ciò che a lui appare tale, e così via. La conoscenza, in questo panorama, si riduce
al sensismo: cosicchè il miele appare dolce a chi è sano, ma amaro agli ammalati. Tuttavia, in questo
groviglio di verità ciascuna diversa dalle altre e ciascuna non meno valida delle altre, Protagora elabora un
criterio per stabilire quale opinione (quella del sano che sente dolce il miele, o quella del malato che lo sente
amaro?) sia migliore: tale criterio è incentrato sull’utilità e si risolve, per tornare all’esempio del miele,
nell’interrogativo se sia migliore l’opinione di chi è malato o di chi è sano. Naturalmente, si risponderà che è
migliore l’opinione del sano, anche se, ad onor del vero, sul piano gnoseologico tutte le opinioni sono
equivalenti: le sensazioni si traducono in conoscenza, cosicchè la mia opinione, la tua, la sua e così via sono
tutte vere, poiché l’uomo è misura di tutte le cose. Contro questa posizione protagorea si schiererà Platone
che, nel Teeteto, smonterà l’argomentazione protagorea facendo notare che, se tutto è vero (come asserisce
Protagora), allora è anche vero che esistono tesi false; e dato che, appunto, tutto è vero, è anche vero che ciò
che dice Protagora è falso. Sempre in ambito sofistico, in quegli anni Gorgia di Lentini giungeva a
conclusioni diametralmente opposte a quelle del collega di Abdera: nel suo scritto "Del non essere", egli
sosteneva che nulla è, se anche fosse non sarebbe conoscibile, se anche fosse conoscibile non sarebbe
comunicabile. La verità, dunque, resta per Gorgia inaccessibile: ne consegue che tutto è falso, e non "tutto è
vero", come invece credeva Protagora. Tutte le proposizioni possono, ad avviso di Gorgia, essere ribaltate
attraverso l’arma del (la parola), equiparato dal pensatore di Lentini ad una forza irresistibile alla pari
del destino dei tragici o della divinità: la parola può tutto. Anche con Gorgia Platone, a cui stava
particolarmente a cuore la possibilità di distinguere il vero dal falso, compie un’operazione simile a quella
operata nei confronti di Protagora: se tutto è falso, cosa ci vieta di pensare che anche ciò che dice Gorgia lo
sia? Ci si è spesso interrogati se Gorgia fosse un nichilista ante litteram o se, piuttosto, volesse esercitarsi
con argomentazioni dialettiche al limite del pensabile. E’ tuttavia certo che l’obiettivo polemico del suo
argomentare fosse l’eleatismo: egli si serve, nelle sue argomentazioni, della dimostrazione per assurdo; in
altri termini, per dimostrare la verità di A, assume per assurdo che sia vero il contrario (non-A) e, a partire da
tale assunzione, si mettono in luce tutte le contraddizioni che ne derivano, a tal punto che si è costretti a
riconoscere la falsità di tale assunto (non-A) e ad ammettere la veridicità della tesi di partenza ad essa
opposta (A). Le tre proposizioni poc’anzi elencate con cui nega la possibilità della conoscenza non è un caso
che ci vengano riportate da uno scettico, Sesto Empirico, nell’opera "Contro i dogmatici". Stando a quanto
da lui riportato, Gorgia avrebbe sostenuto che se le cose pensate non sono esistenti, allora le cose esistenti
non sono pensate: in altri termini, il pensiero non avrebbe un contenuto proprio (poiché ciò che è pensato non
esiste) e, per converso, se ne ricaverebbe che ciò che esiste non è pensato. Alla base di quest’argomentazione
sta una relazione che Gorgia pone: se A è in relazione con B, allora anche B è in relazione con A; se
viceversa A non è in relazione con B, allora anche B non è in relazione con A. Dunque, dato che penso cose
che non esistono (dragoni o uomini volanti), allora ciò significa che il pensato non è in relazione con l’essere
e, per converso, che l’essere non è in relazione col pensato. Ammettendo, infatti, per assurdo l’esistenza delle
cose pensate, ne conseguirebbe che l’uomo che vola o il carro che procede sul mare (tutti oggetti del mio
pensiero) dovrebbero esistere, ma l’esperienza confuta ciò. Se poi dico che il pensiero rispecchia l’esistente,
non si spiega perché nel pensiero trovino cittadinanza anche l’uomo che vola o il carro che procede sul mare.
Il terzo argomento addotto da Gorgia poggia sull’analogia con l’esperienza: giacchè i sensi non
interferiscono tra loro né si smentiscono a vicenda, si può essere spinti a credere che ciò valga anche per il
pensato, cosicchè le cose che né vedo né sento né tocco, ciononostante il pensiero mi attesta che esistono. Ma
in questo modo mi troverei costretto, ancora una volta, ad ammettere l’esistenza dell’uomo che vola e del
carro che procede sul mare. Con Gorgia, quindi, viene per la prima volta messa in discussione la possibilità
di conoscere alcunchè. Come nota acutamente Cicerone, con i Sofisti e con Socrate la filosofia viene
riportata dal cielo alla terra, alla dimensione più squisitamente umana. Proprio con la figura enigmatica di
Socrate ci si trova di fronte ad un problema imbarazzante: egli non ha scritto nulla, ma su di lui son state
scritte intere opere. La testimonianza generalmente più accreditata è quella di Platone, anche se la statura
filosofica di questo pensatore costituisce un nuovo dilemma: nelle opere in cui egli parla di Socrate, come si
fa a distinguere il pensiero effettivamente attribuibile a Socrate da quello invece proprio di Platone? Ci sono
dialoghi platonici, soprattutto quelli più "datati", in cui la figura di Socrate è centralissima e ciò ci induce a
pensare che Platone si limitasse a riportare fedelmente il pensiero del suo maestro; nei dialoghi scritti nella
maturità e nella vecchiaia, invece, la figura di Socrate tende a sfumare e a farsi depositaria del pensiero
platonico. Ma, a monte di questo problema, ci si deve anche chiedere: perché Socrate non ha scritto nulla?
Nel "Fedro", Platone presenta ciò come una libera scelta di Socrate, il quale avrebbe puntato tutte le carte
della filosofia sull’oralità a scapito della scrittura. Socrate, poi, ha scelto di occuparsi esclusivamente di
valori umani, respingendo l’indagine sulla natura tanto cara ai suoi predecessori: sempre nel "Fedro" viene
ampiamente descritto un paesaggio idilliaco e Socrate, di fronte a questo incantevole scenario, dice di voler
tornare in città, poiché gli alberi, a differenza degli uomini, non hanno nulla da insegnargli. Nel "Fedone",
poi, Platone ripercorre l’itinerario culturale di Socrate: da giovane egli si era interessato di natura, finchè non
si era imbattuto nel libro di Anassagora, dal quale era rimasto deluso a tal punto da dover intraprendere una
"seconda navigazione" attraverso la quale fondare la dottrina delle idee. Dall’ "Apologia", scritto platonico
nel quale vengono descritti gli atti del processo in cui è imputato Socrate, quest’ultimo ci viene presentato
come il filosofo del non sapere: egli si professa ignorante e confessa che l’unica cosa di cui è a conoscenza è
la propria ignoranza. Eppure ai suoi amici l’oracolo di Delfi aveva sentenziato che Socrate era l’uomo più
sapiente: proprio a partire da ciò egli aveva avviato la propria indagine, demandando così l’origine della
propria investigazione ad una forza soprannaturale. Questo è particolarmente significativo se teniamo
presente che uno dei capi d’accusa che gravavano su Socrate era l’aver introdotto da parte sua delle divinità
sconosciute. Proprio a partire da questo, Socrate, uomo tra gli uomini, non si era accontentato del responso e
si era voluto accertare che l’oracolo avesse detto la verità. La sua è dunque un’indagine sulla verità cui non
sfuggono neppure le forze divine; il suo è un procedere assolutamente empirico, poiché egli decide di far
visita agli uomini comunemente ritenuti sapienti per constatare se essi davvero lo siano e di quanto più di lui:
l’investigazione, cominciata " contro voglia ", lo porta dai politici (detentori di un sapere competente quale è
l’amministrazione della cosa pubblica), dagli indovini e dagli artigiani; Socrate li sottopone ad esame per
appurare se il loro è un sapere, e non tarda a scoprire che, in realtà, il loro è un sapere settoriale che essi
presentano come totalizzante. Come Socrate stesso dice, nell’ "Apologia", " da parte mia ero consapevole di
non sapere nulla ": egli pone domande e attende le risposte dai suoi interlocutori; il metro di misura è
rappresentato dalla capacità che essi hanno di rispondere senza contraddirsi: è proprio nello scambio di
domande e risposte intentato da Socrate che risiede quella che Platone ha definito "dialettica", ovvero,
letteralmente, "discorso che va di qua e di là" ( + ) . Naturalmente, tutto questo presuppone la
disponibilità degli interlocutori a farsi interrogare: sul concludersi di alcuni dialoghi platonici troviamo gli
interlocutori seccati dalle domande di Socrate, punzecchianti come un tafano, poiché esse mettono in crisi
tutte le convinzioni di cui ciascuno di noi è imbevuto. Socrate, nel formulare le sue domande, adotta un
metodo di carattere generale e universale: egli chiede ai suoi interlocutori "che cosa è x?" ( ;), dove x
sta per il coraggio, l’amore, la virtù, ecc; ma gli interlocutori finiscono per dare sempre a Socrate risposte
particolari, senza mai cogliere l’universale (del coraggio, dell’amore, della virtù, ecc). Ecco perché si tratta
di dialoghi aporetici, che si concludono con un nulla di fatto, irrisolti. Nel "Lachete", ad esempio, tutti
credono di sapere con certezza cosa sia il coraggio, ma Socrate fa notare come le loro siano risposte parziali.
Essi mettono in gioco le loro opinioni e Socrate le dimostra false, poiché è necessario sgombrare il campo da
esse: " solo la verità è inconfutabile ". Così il condottiero Lachete, sicuro di sé, dice che il coraggio è non
indietreggiare mai di fronte ai nemici; ma Socrate gli fa notare come gli Sciiti combattano con una tecnica
consistente nell’indietreggiare a poco a poco; Enea stesso, del resto, viene da Omero presentato come
espertissimo e coraggiosissimo nel combattere indietreggiando. L’interlocutore si vede così costretto a
cambiare opinione e a riconoscere la falsità della propria definizione, dovendo dunque ripartire da zero: ma il
sapere è la scienza, per cui non si può sapere cosa sia il coraggio se non si mostra perché è una scienza che
per oggetto ha le cose temibili e quelle non temibili. La virtù stessa, in questa prospettiva, è la scienza del
bene e del male. La scienza deve dunque possedere un carattere di assoluta certezza, senza ondeggiare tra
vero e falso come fanno le opinioni: ed è proprio su questo che Platone proietta la propria indagine nel suo
scritto "La Repubblica", in cui egli si pone il problema di cosa fare di quelle opinioni vere o, come dice
Platone stesso, "rette". Che esse possano essere distinte dalla scienza vera e propria, Platone lo chiarisce nel
"Teeteto", dialogo in cui mostra come tutto ciò che appare sia una mescolanza di percezione e opinione e
come sia facile sbagliarsi prestando fede ai sensi. Nel tentativo di spiegare ciò, Platone ricorre ad
un’immagine destinata a divenire celebre: paragona l’anima umana ad una tavoletta di cera su cui ciascuno
di noi imprime i segni degli oggetti di cui ha percezione. E’ dunque possibile che, quando scorgiamo in
lontananza una persona qualunque, la si scambi per l’immagine che abbiamo impressa nella nostra
tavoletta/anima di un nostro amico: ne consegue che, in questa prospettiva, l’errore è un errore di
identificazione, e che l’opinione retta è quella che non commette tali errori ed identifica in maniera corretta
l’oggetto percepito. Sempre nel "Teeteto", Platone formula una definizione del pensiero che, per molti versi,
rivela una marcata influenza socratica: il pensiero è, a suo avviso, un dialogo silenzioso, analogo a quello ad
alta voce che Socrate intratteneva coi suoi interlocutori. L’opinione non va dunque intesa come
un’alternativa indecisa: al contrario, essa tenta, al pari della scienza, di rispondere alla domanda "che cosa è
x?", ma (e qui sta la differenza rispetto alla scienza) fornisce risposte suscettibili di essere vere o false. In
altri termini, la differenza tra opinione e scienza risiede nel fatto che solo quest’ultima è in grado di spiegare
le cause per cui è lecito dire che X è Y o che X non è Y. In tal modo si comincia a profilare la possibilità di
capire perché la scienza abbia carattere di stabilità e certezza: essa spiega gli oggetti come derivanti da
determinate cause. Anche nel "Menone" viene da Platone affrontato questo problema: per illustrare il
carattere oscillante delle opinioni, Platone le paragona a delle statue tanto belle da sembrare vive. Averle le
une slegate dalle altre non ha alcun valore, poiché il pregio sta tutto nell’averle legate, in modo tale che si
possano prendere. Le opinioni rette, dunque, stanno "ferme", ovvero rimangono vere, finchè non ricevono
una smentita: si tratta dunque di collegarle attraverso un ragionamento di tipo causale, che le leghi e le
stabilizzi. Sia nel "Menone" sia nel "Fedone" traspare una teoria della conoscenza basata sulla reminescenza
(e legata alla dimostrazione dell’immortalità dell’anima), che porterà Platone a concludere che " conoscere
significa ricordare " (Menone). In quest’ottica, la conoscenza è possibile in virtù del fatto che, prima che
l’anima si incarnasse nel corpo, ha conosciuto cose che, incarnandosi, ha dimenticato: si tratta, per
l’esattezza, di enti (Platone li chiamerà "idee") la cui natura è tale da poterli assumere come criterio di verità;
ne consegue, dunque, che essi devono essere immutabili ed esistenti in maniera indipendente dalle cose
sensibili (le quali cambiano di continuo), il che presuppone che l’anima abbia una vita precedente rispetto al
corpo in cui si trova imprigionata. E’ con queste considerazioni sulle spalle che, nel "Menone", uno schiavo
assolutamente ignorante di matematica e adeguatamente interrogato da Socrate perviene alla risoluzione di
un complesso problema geometrico: ne consegue che lo schiavo conosceva già tale teorema e che Socrate
non ha fatto altro che aiutarlo a ricordarlo; non si tratta, tuttavia, di scienza, ma di opinione, poiché lo
schiavo non è a conoscenza delle cause. E la conoscenza, secondo Platone, deve partire dal mondo sensibile
che ci circonda per portarci a qualcosa che sta al di sopra ma che, in qualche misura, assomiglia ad esso. Per
meglio spiegare questo concetto, Platone si serve, nel "Fedone", di un esempio particolarmente calzante: così
come la lira ricorda a chi è innamorato il proprio amante, anche se questo non è materialmente presente, così
gli oggetti del mondo sensibile ci rimandano alle loro idee. Ne "La repubblica" questo processo conoscitivo è
strettamente connesso alla tematica della formazione del filosofo e si configura, se letto in trasparenza, come
un vero e proprio processo ascensivo. Al filosofo che ha raggiunto un livello supremo di conoscenza teorica
deve, secondo Platone, essere affidato il governo dello Stato, cosicchè nella sua figura finiscono per
coincidere il sapere pratico e quello teoretico. Infatti, solo il filosofo può governare rettamente perché lui
solo conosce l’idea del Bene, a cui ispirarsi per governare. Teoria e prassi non risultano dunque ancora
pienamente distinte in Platone o, almeno, non come in Aristotele. Platone, ne "La Repubblica", descrive il
processo conoscitivo in due modi: uno razionale, l’altro mitologico (il famoso mito della caverna).
Esaminando quello razionale, Socrate dice che la conoscenza umana può essere accostata ad una linea:
immaginiamo di dividere la linea in due parti; da una parte stanno gli oggetti sensibili, conosciuti secondo
l’opinione ( ), dall’altra troviamo gli oggetti intellegibili (le idee), conosciuti dalla scienza (
). Suddividiamo ora la parte dell’opinione in due sottoparti: una dell’immaginazione ( ), l’altra della
credenza ( ). L’immaginazione mi fa conoscere gli oggetti sensibili in modo nebuloso e confuso, e
corrisponde alla conoscenza prima facie che ho del mondo. Nella spiegazione mitologica del processo,
Platone spiega l’immaginazione come l’osservazione che gli uomini incatenati sul fondo della caverna fanno
delle cose che stanno in superficie ma che loro vedono proiettate sul fondo della caverna. La
(credenza) corrisponde invece al momento in cui si esce dalla caverna e si contempla il mondo che sta fuori,
si vede cioè la natura e se ne ha credenza (il che significa che, a differenza di Aristotele, Platone crede che
non possa esistere una scienza della natura, una fisica, giacchè le cose sensibili sono in divenire perenne). La
vera conoscenza, dunque, deve scavalcare il mondo sensibile per spingersi al di là di esso: anche per quel che
riguarda l’ (scienza), avente per oggetto gli enti intellegibili (cioè le idee), la linea si divide in due
parti: da un lato avremo la (pensiero discorsivo), il pensiero che procede passando per tappe. La
ha per oggetti gli enti matematici, che si trovano a metà strada tra il sensibile e le idee, giacchè si
tratta di concetti che però richiedono un supporto sensibile (pensiamo al matematico che dimostra le
proprietà del triangolo disegnandolo); proprio ad essi deve dedicarsi il filosofo appena inizia il suo itinerario.
Le scienze matematiche, però, sono agli occhi di Platone inferiori alla filosofia, poiché, oltre a richiedere
necessariamente l’aiuto di mezzi sensibili (disegni e altro), partono da postulati, assumono cioè le ipotesi
come un qualcosa di vero a monte di ogni dimostrazione. Accanto alla troviamo la (ossia il
"pensare"): con essa non si discorre, ma si fissano e si conoscono le idee e la scienza che ne scaturisce è la
dialettica, secondo la lezione socratica. Il filosofo de "La Repubblica" è il dialettico e i suoi oggetti di studio
sono, appunto, le idee: e il metodo dialettico è nettamente superiore a quello matematico proprio per l’uso
che fa delle ipotesi: non le assume dogmaticamente come postulati (come invece fanno i matematici), ma le
sottopone a discussione, nella convinzione che di esse si possa rendere conto (come faceva Socrate con i suoi
interlocutori): saranno mantenute solo quelle sostenibili, ossia quelle le cui conclusioni non sono in
contraddizione con la definizione di partenza. A differenza della matematica, poi, la dialettica non è più
costretta a ricorrere ad immagini sensibili, ma ragiona soltanto su idee: parte da ipotesi e le assume come una
sorta di pedana per costruire attraverso un procedimento ascensivo il proprio ragionamento ipotetico. Questo
metodo, oltre che ne "La Repubblica", viene formulato anche nel "Fedone" (il che suggerisce che i due
dialoghi possano essere coevi): si apre, però, un problema non da poco; se il dialettico si avvale delle ipotesi
come punto di partenza, allora il suo procedimento dovrà andare avanti all’infinito nel tentativo di dimostrare
ogni ipotesi? No, dice Platone: anzi, l’assunzione di ipotesi e la verificazione delle medesime procede fino a
quello che egli chiama il "principio non ipotetico", la cui esistenza è certa e non necessita di ipotesi. Tale
principio altro non è se non l’idea del Bene, punto culminante del processo conoscitivo ed educativo.
Tuttavia, Platone, ne "La Repubblica", non ci dice in che cosa consista tale idea, ma, ciononostante, ne
chiarisce la funzione in analogia con il sole: Platone dice che il sole sta alle cose sensibili come il Bene sta a
quelle intelligibili. Il sole, da un lato, rende possibile, grazie alla luce che getta, la visibilità (e quindi la
conoscibilità) degli oggetti sensibili e, dall’altro lato, è condizione, grazie al calore che sprigiona, del
costituirsi delle cose e quindi del loro divenire. In analogia, l’idea del Bene è condizione della pensabilità
stessa delle altre idee (l’analogo della luce solare è la verità, una specie di luce intelligibile) e, al tempo
stesso, è condizione dell’essere delle idee (le quali però non divengono, ma eternamente sono). Occorre
tuttavia chiarire che l’idea del Bene non è affatto sullo stesso livello delle altre idee: ancora una volta torna
utile l’analogia col sole; come esso sta al di sopra rispetto alle cose del nostro mondo, così il Bene è
incommensurabilmente al di sopra delle altre idee, che da esso ricevono luminosità ( " è al di là della
sostanza ", dice enigmaticamente Platone). Ma poiché le idee sono ciò di cui le cose sensibili in qualche
modo partecipano, allora conoscere il Bene vorrà dire conoscere ciò che rende buone le cose: il Bene diventa
così la chiave di lettura dell’intera realtà, tant’è che anche il buon uso del sapere dipende dalla conoscenza
dell’idea del Bene. Da tutto ciò emerge come in Platone sia come non mai radicata la distinzione
inconciliabile tra conoscenza sensibile (avente per oggetto le cose materiali) e conoscenza intelligibile
(avente per oggetto le idee), attuabile solo a patto di liberare l’anima dai ceppi che la legano al mondo
sensibile. Con Aristotele si tocca il rovescio della medaglia, anche se alcune acquisizioni platoniche restano
salde: anche per Aristotele la conoscenza è un processo da percorrere a tappe; però egli tende a diminuire la
distanza che in Platone separa i due tipi di conoscenza, intellettuale e sensibile. E il suo tentativo di
rinsaldare quel legame spezzato da Platone va di pari passo con la sua dimostrazione dell’inesistenza di
quelle idee ammesse da Platone e intese come forma delle cose: nella "Metafisica", Aristotele dice che la
forma non può assolutamente essere separata dalla materia, sicchè la forma "uomo" non potrà mai essere
divisa dall’uomo in carne e ossa e fatta sostanza indipendente ("idea"). L’idea è, in altri termini,
semplicemente un’astrazione logica con la quale separo la forma dalla materia, giacchè nella realtà non è mai
possibile trovarle disgiunte, ma ogni cosa è un "sinolo" (, un’unione perfetta e inscindibile di
materia e forma. Il mondo delle idee prospettato da Platone risulta dunque, ad Aristotele, un inutile doppione
che, più che risolvere problemi, ne crea di nuovi, anche perché Platone non è stato realmente in grado di
spiegare come la materia possa acquisire una forma: egli infatti, come dice Aristotele nel I libro della
"Metafisica", non è stato in grado di cogliere la causa del movimento, in virtù della quale si spiega come la
materia acquisisca la forma. Per fare un esempio, Aristotele dice che è grazie al principio del movimento
immesso dall’uomo nella donna che si forma l’embrione. Egli ribadisce che il punto di partenza è costituito
dal mondo della percezione sensibile, il punto di partenza a noi più chiaro: si tratta infatti di quell’ambito che
è a noi più vicino e più noto; così facendo, Aristotele riconosce alla percezione sensibile uno statuto
gnoseologico decisivo. E sempre nel I libro della "Metafisica" egli delinea le tappe del processo conoscitivo
anche sul piano storico, facendo una sorta di storia della civilizzazione umana in cui si mostra come gli
uomini, spinti dall’amore per la conoscenza, sono passati al sapere utile e poi a quello disinteressato; ed è
appunto in questo I libro che troviamo esposte le teorie dei pensatori precedenti ad Aristotele, poiché anche
dai loro errori si possono trarre insegnamenti . Come nota nell’incipit della "Metafisica", la sensazione è
amata dagli uomini; prova di ciò è il fatto che essi amano la vista indipendentemente dall’utilità che ne
possono ricavare. Ma il problema della conoscenza non può essere ristretto al solo ambito umano (e del resto
Aristotele fu iniziatore della zoologia), poiché l’uomo non è il solo essere vivente: proprio l’osservazione
zoologica mette in luce come anche gli altri animali abbiano sensazioni (provano piacere o dolore, caldo o
freddo, ecc), cosicchè per capire a fondo la specificità della conoscenza umana occorre operare un raffronto
con il mondo animale. L’amore per le sensazioni, donato dalla natura, è comune a tutti gli animali: ma solo
in alcuni di essi, a partire dalla sensibilità, si genera la memoria, e questo in base all’esperienza empirica. Si
crea così una discrepanza tra animali dotati di sensibilità e animali dotati di sensibilità e memoria:
quest’ultima altro non è se non la capacità di raccogliere esperienza. Ma, individuata questa prima
differenza, se ne può ricavare un’altra: sono più adatti ad imparare gli animali provvisti di memoria. Ciò non
toglie, tuttavia, che l’ape sia un animale intelligente anche se incapace di imparare: che sia intelligente lo si
evince dal fatto che ogni sua azione è orientata verso un fine preciso, anche se mossa dall’istinto e non dalla
ragione. Ma esistono anche animali capaci di apprendere perché dotati dell’udito, attraverso il quale è
possibile sentire e quindi apprendere gli insegnamenti. Ci sono poi animali aventi la memoria e capaci di
formulare immagini prescindendo dalla presenza fisica dell’oggetto ma partecipano poco all’esperienza. E
l’esperienza nasce dalla memoria, perché è prodotta da molti ricordi della medesima cosa: siamo ora entrati
nel campo strettamente umano; dal sedimentarsi dei ricordi nasce l’esperienza della cosa e dall’esperienza
nasce il livello superiore, la tecnica, intesa come saper fare. Quest’ultima ha luogo dal ripetersi
dell’esperienza: infatti, mentre l’esperienza riguarda conoscenze slegate, la tecnica nasce quando molte
nozioni derivanti dall’esperienza danno luogo ad una sola credenza universale: l’esempio tipico di tecnica
addotto da Aristotele è quello della medicina. Per esperienza posso sapere che un dato farmaco fa bene a più
persone ammalate della stessa malattia, ma ciò riguarda solo casi particolari; la tecnica, invece, si applica a
tutti i casi: il medico sa che un farmaco fa bene a tutte le persone ammalate da quella data malattia. Solo chi
possiede la tecnica ha conoscenza delle cause: il medico, infatti, sa che X cura tutti gli Y e sa anche spiegare
il perché. Un gradino al di sopra della tecnica troviamo la sapienza: essa consiste in quello che i Medioevali
diranno "scire per causas", dove le "causae" in questione sono quattro. Se i pensatori a lui precedenti ne
avevano individuate al massimo due (magari intravedendone una terza), Aristotele spiega, sempre nel I libro
della "Metafisica", che le cause sono quattro e che conoscere per cause significa rispondere alla domanda
"che cosa è x?"; il che vuol dire conoscere l’essenza di quella determinata cosa, cioè che essa è in quanto è
quella determinata cosa. Quattro sono le cause perché quattro sono le domande che esauriscono l’essenza di
una cosa: causa materiale, causa del movimento, causa formale, causa finale. Alla domanda "che cosa è x?"
la risposta più immediata è dire di che cosa è fatto x e nell’indicare la materia di cui è fatto individuo la
causa materiale che l’ha prodotto: così, alla domanda "che cosa è l’uomo?" la causa materiale risponde che
esso è carne e ossa. Con la causa del movimento (detta anche causa efficiente) si spiega da che cosa ha avuto
origine il movimento: ogni cosa, infatti, viene ad essere come effetto di un movimento e Aristotele ritiene di
poter addurre a conferma di ciò esempi desunti sia dall’ambito naturale sia dall’ambito della produzione
umana. Alla domanda "che cosa ha prodotto l’uomo?" si deve rispondere che è stato prodotto dal seme del
genitore, alla domanda "che cosa ha prodotto la casa?" si deve invece rispondere che è stata prodotta dall’arte
del costruttore. Tuttavia non ci si può fermare alla causa materiale e a quella efficiente: ed è per questo che
Aristotele introduce quella formale, alludendo a quel particolare tipo di causa capace di determinare la
materia di una cosa e di individuarla come quella cosa, senza possibilità di confusione. Potrò dunque
chiamare Socrate "uomo" perché la sua è materia individuata da una forma che le compete necessariamente e
che serve da principio di individuazione, poiché individua la materia. La causa formale corrisponde, dunque,
all’essenza della cosa: Socrate è uomo perché la sua materia è individuata dalla forma uomo, che mi
permette di individuare tutti i soggetti della stessa specie. Ma il punto di sutura tra queste tre cause finora
tratteggiate è la quarta ed ultima causa: quella finale, che illustra lo scopo per cui quella determinata cosa è
venuta ad essere così come è. La causa finale risponde quindi alla domanda "perché x è?" o anche "perché x
è venuto ad essere nel modo in cui è?": perché la casa è così come la vediamo? Perché deve servire da riparo
all’uomo e non potrebbe fare ciò se non fosse disposta in quel modo. Perché l’uomo è così? Per svolgere al
meglio quel compito che per natura gli compete, ossia il pensare, ed è per questo che ha la testa in alto, per
poter meglio pensare. E per ciascuna cosa il fine può dirsi realizzato quando l’oggetto si è formato nella
migliore forma possibile per poter assolvere alle sue funzioni; così una casa funziona bene se la sua forma la
mette nelle condizioni di funzionare al meglio. Ne consegue che la causa finale è legata a filo doppio a quella
formale. Che cosa è, però, che mette in moto quel processo per cui alla fine la materia è formata al meglio
per assolvere le sue funzioni? Aristotele risponde che è la causa del movimento, giacchè, da sola, la materia
non potrebbe mai passare da potenza ad atto. Conoscere queste quattro cause significa avere scienza e chi la
possiede è perfettamente distinguibile da chi invece ne è sprovvisto e possiede solo una tecnica, o chi
possiede solo l’esperienza, o ancora chi ha solo sensazioni: mentre infatti la sensazione si ferma al "che"
delle cose e le conosce sempre come particolari, la scienza è in grado di conoscere il "perché" delle cose e,
grazie a ciò, attinge all’universale. Ciò non toglie, tuttavia, che la percezione degli oggetti sia sempre vera:
questo punto è sviluppato da Aristotele nel "De anima", quando dice che la percezione nasce
dall’attualizzazione di una potenzialità. Infatti, ogni singolo organo di senso percepisce secondo verità i suoi
oggetti perché il soggetto percipiente, per effetto dell’azione esterna, passa da soggetto percipiente in
potenza a soggetto percipiente in atto e, nello stesso tempo, l’oggetto passa da oggetto percepito in potenza a
oggetto percepito in atto. Ma il grande limite della sensazione è la sua incapacità a spiegare le cause: in altri
termini, grazie alla sensazione percepisco che il libro è rosso, ma poi sta alla scienza spiegarmi il perché. Il
possessore della scienza è il sapiente () e Aristotele si interroga su come gli uomini siano pervenuti a
questi esiti: la causa scatenante è l’amore per la conoscenza insito in ciascuno di noi, ma il primo movente
che ha indotto gli uomini ad amare l’indagine conoscitiva è stata (e in questo Aristotele è d’accordo con
Platone) la meraviglia (. Essi infatti si meravigliarono dei solstizi o dell’incommensurabilità
della diagonale col lato perché non riuscivano a spiegarsi come fossero possibili tali cose e questo perché
non erano ancora riusciti a comprenderne le cause: è infatti la conoscenza delle cause a sconfiggere la
meraviglia e a portare al sapere. Con la filosofia, l’uomo ha raggiunto un sapere assolutamente
disinteressato, privo di ogni risvolto pratico (a differenza delle tecniche): è quel sapere che Aristotele chiama
("contemplazione") e che riguarda quegli oggetti che, nel VI libro della "Metafisica", identifica con
la matematica, la fisica e la metafisica. Se per il Platone de "La Repubblica" esisteva una sola scienza (quella
del Bene), per Aristotele ne esistono una pluralità, tra loro non reciprocamente riducibili le une alle altre.
Addirittura, Aristotele colloca la fisica ad un livello altissimo, mentre Platone le negava lo statuto di scienza;
e poi Aristotele opera una netta distinzione tra teoria e prassi, tra filosofo e politico, tra scuola e città: tuttavia
sullo sfondo lascia intravedere la possibilità di una conciliazione fra le due parti, dato che l’uomo è sì un
animale razionale, ma anche un animale politico. E’ curioso il fatto che Aristotele non separi radicalmente
chi ama il sapere da chi ama i miti, poiché, a suo avviso, entrambi muovono dalla meraviglia, anche se si
servono di diversi modi di spiegazione (razionale e causale per il filosofo, mitico e irrazionale per l’amante
dei miti). Proprio perché sapere teoretico e dunque non produttivo, la filosofia è fine a se stessa e, quindi,
poiché priva del legame di servitù (infatti, propriamente, non serve a nulla), è il sapere più nobile. E da
questa attività, come Aristotele dice nell’ "Etica Nicomachea", si ricavano piaceri immensi, i più congeniali
alla natura razionale dell’uomo. La filosofia è la sola scienza che può essere divina, perché universale e
perché conosce le cause, cioè conosce oggetti divini. La scienza costituisce dunque il punto più alto della
conoscenza, ma, propriamente, quando si scoprono le cause che cosa si fa? Secondo Aristotele, a tal
proposito, è assolutamente centrale l’impiego della dimostrazione: il filosofo si distingue per parlare in modo
consono alla verità e la conoscenza della causa (che porta alla verità) passa per la dimostrazione; il filosofo
sa dimostrare le cause perché sa costruire ragionamenti concatenati (sillogismi). Il che significa che per
Aristotele possono esserci anche ragionamenti concatenati che non sono dimostrazioni. Il sillogismo,
dunque, è lo strumento () della scienza e il sapiente (come dice Aristotele nell’ "Etica
Nicomachea") è colui che possiede la disposizione apodittica, ovvero la disposizione a dare dimostrazioni: si
tratta di una procedura deduttiva, nel senso che si pongono premesse e si deduce una conclusione ad essa
conseguente. Ed è la qualità delle premesse (che devono essere vere, salde, non dimostrate) a distinguere il
sillogismo dimostrativo da quello non dimostrativo: perno della dimostrazione è il "termine medio", che
consente di stabilire la conclusione. Ma, nota Aristotele memore della lezione socratica, esiste anche il
sillogismo dialettico, una sorta di ragionamento concludente che però assume le premesse in base all’accordo
tra gli interlocutori; si tratta dunque di un ragionamento concludente ma che esula dalla dimostrazione. Per
poter costruire i sillogismi, il filosofo deve partire da princìpi e qui Aristotele ne individua di due tipi, quelli
propri di ogni singola scienza (e che quindi riguardano solamente gli oggetti specifici di quella data scienza)
e quelli comuni a tutte le scienze; ovviamente, ciò significa che non solo la scienza per Aristotele non è una,
ma che addirittura i princìpi che le governano variano da scienza a scienza. Essi però non possono essere
assunti per via dimostrativa, sennò si aprirebbe un processo tendente all’infinito: c’è tuttavia un’altra facoltà
presente in noi che presiede a tali principi; si tratta dell’intelligenza ( ), un atto intellettivo di
adeguazione immediata a tali princìpi. Non c’è scienza se non si conoscono i princìpi dai quali procede la
dimostrazione: alla conoscenza di essi si arriva per via induttiva, cioè dalla sensazione, per lo stesso
cammino che porta dalla percezione alla sapienza. Con la morte di Alessandro Magno (323 a.C.) si fa
convenzionalmente iniziare l’età ellenistica, caratterizzata, sul piano culturale, in primis da forti
contaminazioni frutto del contatto con culture lontane e profondamente diverse da quella greca; spesso
questa nuova età del pensiero è stata letta come decadente, facendo riferimento agli ineguagliati vertici
filosofici raggiunti da Platone e Aristotele. Alessandro Magno si era spinto fino in India e dopo le sue
conquiste nulla fu come prima: Atene perse il titolo di capitale della cultura e la Grecia si avvia a diventare
(nel 146 a.C.) provincia del mondo romano. Sul piano filosofico, lo scenario è dominato da tre correnti di
pensiero principali, affiancate da un pulviscolo di correnti minori: queste tre scuole fondamentali sono lo
Stoicismo, l’Epicureismo e lo Scetticismo, accomunate (come tutte le altre filosofie dell’età ellenistica) dal
disinteresse per la sfera metafisica, tanto cara ai loro predecessori (pensiamo ai sistemi elaborati da Platone e
Aristotele), e da una marcata esigenza di individuare un modello di vita che sia compatibile con le nuove
condizioni socio-economiche in cui versava la Grecia dell’epoca; l’influenza illustre di Platone e Aristotele
permane, anche se, di fatto, questi due pensatori non vengono mai esplicitamente menzionati. Tutte queste
correnti pongono dunque al centro della loro indagine filosofica l’etica, prefiggendosi la formazione del
saggio. Accanto a queste tre grandi scuole ce ne sono molte altre: tra queste, (oltre a quella dei Cinici, dei
Cirenaici seguaci di Aristippo, degli ultimi Megarici, ecc) merita senz’altro di essere ricordata quella degli
Aristotelici (o Peripatetici, dal Peripato, il luogo in cui Aristotele passeggiava filosofeggiando coi suoi
discepoli): emblematica è, a tal proposito, la figura di Stratone di Lampsaco, tra i fondatori della imponente
biblioteca di Alessandria. Ritornando agli sviluppi delle tre scuole che dominano questa fase della cultura
filosofica greca, esse sono accomunate, oltrechè dalla preminenza dell’interesse etico, dalla classificazione
tripartita (già presente nell’Accademia di Platone) della filosofia in etica, fisica, logica. Epicuro dà molto
peso alla logica (detta anche "canonica" perché "canone", ossia criterio della conoscenza) e gli Stoici
distinguono due grandi parti all’interno della logica: la gnoseologia e la teoria dei discorsi. L’espressione
"scienza della logica" è di loro conio, poiché per Aristotele la logica era "analitica": se poi la teoria epicurea
è monolitica e non subisce variazioni di rilievo nel tempo, quella stoica è, al contrario, una filosofia "in fieri",
soggetta a continue trasformazioni: a testimonianza della stabilità della dottrina epicurea si può ricordare
come Diogene di Enoanda, nel II secolo d.C., fa incidere su una pietra nella sua città il verbo di Epicuro così
come era secoli addietro. Ed è curioso come Epicuro polemizzi aspramente contro i poeti (a suo avviso
mistificatori) e come il più grande divulgatore della filosofia epicurea presso i Latini, Lucrezio, scriva in
versi. Epicuro, poi, sceglie in modo significativo di insegnare in un giardino fuori Atene, lontano dalle
burrascose vicende politiche della città; gli Stoici , viceversa, hanno la loro sede nel "portico dipinto" nel
cuore di Atene: lo stoico Crisippo paragona la filosofia ad un orto in cui la logica costituisce le mura che
demarcano i confini, la fisica rappresenta gli alberi che crescono nell’orto e l’etica costituisce i frutti che
pendono dagli alberi; dalla metafora, si evince come la filosofia abbia per Crisippo confini limitati (un orto
chiuso) e sia difesa dall’esterno da un muro (la logica); centrale è (alla pari degli alberi in un orto),
evidentemente, la fisica, alla quale è strettamente connessa l’etica: non ci possono infatti essere i frutti se non
ci sono gli alberi, il che significa che per raggiungere la felicità occorre partire dalla conoscenza della natura.
Con un’altra metafora alquanto efficace, gli Stoici accostano il sapere filosofico ad un uovo, il cui guscio è
costituito dalla logica (quindi essa ha funzione difensiva, come nel caso del muro), l’albume dalla fisica, il
tuorlo dall’etica. Tuttavia, a Posidonio, uno Stoico della cosiddetta "media Stoà", queste metafore non
piacevano perché non rendevano sufficientemente conto dei rapporti reciproci tra le tre scienze: a suo avviso,
è meglio accostare la filosofia ad un organismo, in cui forte è la vivacità fra le parti; le ossa sono costituite
dalla logica, il sangue e la carne sono rappresentate dalla fisica e l’anima dall’etica. La filosofia, così intesa,
si configura come un sapere organico e retto da una fortissima unità, che per gli Stoici ruota attorno al
, la ragione che permea ogni realtà. Nel gli Stoici vedevano convergere tre valenze: esso è principio di
verità (e quindi legato alla logica, con la quale si formulano le leggi del conoscere, del pensare, del parlare),
è un principio dell’essere delle cose (e dunque connesso alla fisica e allo studio che essa conduce sulla
natura), è il principio del fine e del dover essere dell’uomo come ente di natura (e dunque è connesso
all’etica). La teoria della conoscenza compete, secondo gli Stoici, alla logica: essa permette di cogliere il
insito nelle cose, cioè ce le fa conoscere, pensare e dire nella loro verità; anche per Epicuro la logica è
fondamentale, perché fissa il criterio di verità: la sensazione è, secondo lui, la base della conoscenza. Epicuro
elimina la logica come filosofia del linguaggio e se ne interessa solo nella misura in cui essa studia il criterio
di verità. Sia gli Epicurei sia gli Stoici sono sensisti ed Epicuro arriva a concordare, per quel che riguarda la
conoscenza, validità assoluta ai sensi. Il suo canone di conoscenza si sviluppa in tre punti che corrispondono
alle tre parti della filosofia: la logica (legata alle sensazioni), la prolessi (legata alla fisica), le affezioni
(legate all’etica); egli critica le tendenze scetticheggianti che sospendono il giudizio sulla validità delle
sensazioni e le proclamano aleatorie: fa notare come, propriamente, non possa esserci pensiero se non ci
sono le sensazioni. Questo emerge benissimo nella nozione di prolessi ( dal greco ,
"prendo prima") o anticipazione: per prolessi Epicuro intende l’anticipazione di qualcosa che non mi si è
ancora presentato ai sensi (quando ad esempio penso ad una persona senza poterla percepire); se la
conoscenza passa per le sensazioni, come può pensare senza percepire? Tutto si spiega proprio perché,
secondo Epicuro, l’anticipazione si verifica quando ho avuto sensazione almeno una volta di quella
determinata cosa, cosicchè (permanendo essa nella mia memoria) posso pensarla senza effettivamente
percepirla (perché l’avevo già percepita prima). Ma come si dimostra che tutte le sensazioni sono vere? La
sensazione, secondo Epicuro, è un’affezione, un in cui subisco qualcosa dall’esterno: ne consegue
necessariamente che l’affezione deve rispecchiare fedelmente la cosa percepita. Ma, allora, come nascono gli
errori e le illusioni dei sensi? Epicuro dice che neppure nel caso delle illusioni dei sensi si può parlare di
percezioni errate: è la precipitazione del giudizio, cosicchè si dice che un determinato oggetto tondo è
quadrato prima che la sensazione ci abbia sconfessato: il pensiero è fondato sulla sensazione, e non
viceversa. Anche per gli Stoici la sensazione è importante, ma, a loro avviso, non basta: occorre che il dato
della sensazione sia rappresentabile dal pensiero; non basta il dato del senso, ci vuole il pensiero. La
sensazione si accompagna alla (che in Aristotele, nel "De anima", era una facoltà dell’anima che
permette la formazione di ), ossia la rappresentazione dell’oggetto. E poi la sensazione per gli
Stoici è un’impressione provocata dall’oggetto sui nostri organi sensoriali: come il suggello lascia
un’impronta sulla cera (secondo la lezione platonica del "Teeteto"), come un foglio di carta pulita è adatto
per copiare uno scritto, così i nostri organi di senso ricevono le impressioni. Tuttavia, la concezione
dell’anima è simile a quella di Epicuro: l’impressione lasciata dagli oggetti è un’impressione corporea perché
l’anima stessa è corporea; se per Epicuro essa era un composto atomico, per gli Stoici ha natura aeriforme e
le impressioni ne modificano la struttura proprio come (dice Crisippo) l’aria è in grado di ricevere molte e
contrastanti percussioni; Crisippo parlava anche, in maniera più raffinata, di alterazioni qualitative, come se
l’anima cambiasse stato quando riceve impressioni. Bisogna però chiedersi quali rappresentazioni possano
essere ritenute con certezza vere: secondo gli Stoici, questa attività di rappresentazione si articola in due
momenti distinti; in un primo momento, infatti, riceviamo passivamente affezioni dall’esterno, poi il
soggetto reagisce attivamente ad esse con l’ "assenso", cioè acconsentendo, approvando ciò che si è
passivamente ricevuto dall’esterno; questa approvazione avviene mediante il che è nella nostra anima
e la differenza tra una rappresentazione falsa e una vera è che solo a quella vera si può e si deve dare il
proprio "assenso". Ma, dicono gli Stoici, di fronte alle rappresentazioni possiamo reagire o dando l’assenso,
o non dandolo, o sospendendolo: e proprio nel riconoscere questa libertà di giudizio gli Stoici garantiscono,
in una certa misura, una forma di libertà all’uomo; se, infatti, non possiamo scegliere se avere o meno
rappresentazioni, ciononostante possiamo scegliere come reagire ad esse, concedendo o negando il nostro
assenso. Particolarmente importante è la sospensione dell’assenso (), che costituirà il perno della
filosofia scettica e sarà destinata ad avere vita lunga nella storia della filosofia. Nel momento in cui do
l’assenso ad una rappresentazione, l’impressione diventa apprensione, nel senso che ci si appropria della
rappresentazione e questo emerge chiaramente nell’uso che gli Stoici fanno della parola
("appensione", l’afferrare la rappresentazione); la rappresentazione diventa, in tal modo, "rappresentazione
comprensiva" (o "catalettica"). Ma non tutte le rappresentazioni sono attendibili: solamente quelle che
presentano evidenza e sono riconducibili alla realtà. Per illustrare questo procedimento conoscitivo, Zenone
usava un’immagine alquanto efficace: la mano aperta rappresenta l’immagine, curvando le dita si ha
l’assenso, stringendole e chiudendo il pugno si ha poi la comprensione e, infine, accostando la mano sinistra
e afferrando il pugno si ha la scienza, intesa come sistema integrato di comprensioni catalettiche. Tuttavia, di
rappresentazioni ce ne sono di due tipi: quelle che colgono immediatamente la realtà (comprensione
catalettica), e quelle che la colgono con qualche difficoltà (comprensione non catalettica); solo la
comprensione catalettica è, per gli Stoici, determinata dall’esistente, conforme all’esistente e impressa
nell’anima. Ed è solo quando c’è la presenza effettiva dell’oggetto che l’assenso è fortissimo, quasi come se
(per usare un’immagine impiegata dagli Stoici) venisse strappato per i capelli: gli Scettici osservavano
invece come di fatto nessuna rappresentazione si presentasse con caratteri tali da meritare, senza possibilità
di equivoci, il nostro assenso (pensiamo ai sogni, quanto ci appaiono veri!). Detto questo, per gli Stoici la
conoscenza non si esaurisce nell’ambito della sensazione (come invece è per Epicuro): l’attività del pensiero
che crea concetti rivela un’attività intellettiva autonoma dalle sensazioni, anche se non del tutto sganciata da
esse. Ogni atto intellettivo (e gli Stoici designano l’atto intellettivo con la parola , di forte sapore
platonico) deriva da una sensazione, ma ciò avviene o per contatto (relazione diretta) o non per contatto
(relazione non diretta) ed è facile capire come il pensiero possa svolgere autonomamente la sua attività: o per
evidenza o per analogia o per somiglianza o per aggregazione. Per evidenza sensoriale sento il dolce,
l’amaro, ecc; non per evidenza, ma per passaggio da cose evidenti creo concetti per composizione
(componendo il concetto di uomo e quello di cavallo creo l’ippocentauro), per somiglianza (dall’uomo
Socrate in carne e ossa creo il concetto di Socrate), per analogia (per analogia verso l’aumento dell’uomo
creo il concetto di ciclope, verso la diminuzione dell’uomo creo uomini nani). E sia gli Stoici sia Epicuro
insistevano tanto sulle operazioni del pensiero per polemizzare contro l’innatismo, secondo il quale le
nozioni universali preesistono; gli Stoici, in opposizione a questa tesi, ammettevano che gli universali (le
"prolessi" di Epicuro) fossero "connaturate" agli uomini, come se l’uomo nascesse con una predisposizione
alla formazione di questi concetti perché è l’unico essere a possedere la ragione: in particolare, gli Stoici
parlavano di concetti "connaturati" in riferimento alla morale e, soprattutto, all’innata disposizione dell’uomo
alla virtù; infatti, poiché l’uomo è anima, cioè ragione, egli vive secondo ragione e vivere ragione vuol dire
vivere secondo natura, ossia secondo virtù. Ma in quegli stessi anni compariva sullo scenario filosofico una
figura inequivocabilmente nuova, destinata a diventare il fondatore dello Scetticismo : si tratta di Pirrone
originario di Elide (nato circa nel 360 a.C.); egli avrebbe cominciato la sua attività filosofica ancor prima
della fondazione della scuola stoica ed epicurea e avrebbe preso parte alla spedizione di Alessandro Magno
in India, entrando così in contatto con i maghi e con i gimnosofisti; da questi avrebbe appreso il tipo di
saggezza da lui professato. Come Socrate, Pirrone scelse di non scrivere nulla, poiché convinto di non avere
nulla da affidare allo scritto e che altri potessero apprendere: ed è per questo che egli non fondò alcuna
scuola e gettò le basi dello scetticismo; dal punto di vista di Pirrone e degli Scettici tutte le filosofie
costituiscono un blocco unico, poiché pretendono di avere qualcosa da insegnare; si tratta, per di più, di un
blocco dogmatico, dottrinario. In contrapposizione a tutto questo, gli Scettici non hanno dogmi e non hanno
persone a cui trasmettere le proprie verità, proprio perché non ne possiede. Dalle testimonianze di cui
disponiamo, possiamo ipotizzare che anche la filosofia scettica abbia attraversato delle sue fasi: l’immediato
successore di Pirrone, Timone, ha composto in versi delle critiche indirizzate agli altri filosofi; la tradizione,
poi, testimonia che anche due platonici come Carneade e Arcesilao avrebbero aderito allo Scetticismo. Dopo
di che, si perdono le tracce della filosofia scettica, fino al II secolo d.C., quando ad abbracciare la causa
scettica fu Sesto Empirico (detto "Empirico" perché appartenente alla setta medica degli "Empirici"), il quale
si scatenò in un’accesa critica "Contro i dogmatici" e tratteggiò la figura del "filosofo pirroniano", facendo in
tal modo di Pirrone un modello da seguire. Stando a quanto dice Diogene Laerzio nelle "Vite dei filosofi",
Pirrone avrebbe desunto dallo Stoicismo i princìpi della (letteralmente "incomprensibilità") e
dell’ ("sospensione di giudizio"), mentre, attenendoci alla testimonianza di Sesto, Pirrone avrebbe
cominciato da solo, senza influenze, la propria attività filosofica. L’opposizione allo Stoicismo appare
tuttavia evidente: se gli Stoici parlano di "rappresentazione comprensiva", Pirrone nega invece la
rappresentabilità (e quindi la comprensibilità) delle cose: la sua è una non-gnoseologia. Gli Scettici vengono
così definiti dal termine greco , che vuol dire "ricerca", "indagine" sulla natura delle cose per
stabilire cosa esse siano: nella sua ricerca, però, lo scettico scopre che le cose sono incomprensibili per due
ordini di ragioni. In primo luogo per il fatto che tutte le cose appaiono diversamente a chi le osserva in
condizioni diverse, in secondo luogo per il fatto che sulle stesse cose si può riscontrare che gli uomini hanno
pareri contrastanti, spesso addirittura opposti (c’è, ad esempio, chi dice che tutto è costituito da atomi, chi da
elementi, e così via). Lo scettico, tuttavia, non si limita a dire che le cose sono inconoscibili (poiché questo
sarebbe un dogmatismo), ma ritiene che si debba sospendere il giudizio ( ): egli, cioè, non afferma né
nega che le cose siano comprensibili e scopre che dalla sospensione del giudizio scaturisce una felicità
irresistibile, sconosciuta a chi si ferma al dogmatismo. Secondo Timone, in particolare, occorre chiedersi tre
cose per essere felici: a) quale è la natura delle cose? b) come ci si deve disporre nei confronti di esse? c)
cosa risulterà a coloro che si trovano in questa disposizione? Come Timone stesso asserisce, le cose sono
ugualmente indifferenti, immisurabili, indiscriminabili e perciò le nostre sensazioni e opinioni possono
essere vere e false, poiché non disponiamo di criteri per distinguere le differenze tra le cose. Di fronte a
quest’assoluta mancanza di certezze e verità, Carneade e Arcesilao (rivelando in ciò la loro ascendenza
platonica) ovviavano, rispettivamente, con la nozione di ("probabile") e con quella di
("ragionevole"): ma per Pirrone, invece, " si deve vivere senza opinioni, senza inclinazioni, senza agitazioni
", poiché il seguire le opinioni ci turba; occorre, piuttosto, dire che " ogni cosa è non più di quanto non è ".
Ne derivano l’ ("il non pronunciarsi") e l’ ("assenza di turbamenti"). Ma, in questa
prospettiva, come conduce lo scettico la propria esistenza? Come dice Sesto Empirico, lo scettico è uomo tra
gli uomini, sospende il giudizio ma dà assenso alle rappresentazioni naturali (la fame, la sete, ecc), non ha
maestri ma impara come tutti gli altri uomini a leggere e a scrivere perché ciò è utile nella vita quotidiana; in
altri termini, lo scettico si adatta alle condizioni comuni, vive seguendo i fenomeni, senza dar valori: non
dice, ad esempio, che il miele è dolce, ma che sembra tale. Qualche secolo più avanti, Plotino cercherà di
porre nuovamente al centro della discussione filosofica il platonismo, scivolato per molto tempo nell’oblio:
secondo Plotino, non è l’anima ad essere nel corpo, ma, al contrario, è il corpo ad essere nell’anima; a suo
avviso, perché sia possibile la riunificazione con quell’unico principio da cui tutto deriva, non occorre la
ragione, ma, piuttosto, la mistica o, come la chiama Plotino, l’ "estasi". Si tratta, cioè, di staccarsi dal mondo
fisico, di rientrare in sé (ossia di riappropriarsi della propria anima) e di ricongiungersi all’ Uno, principio da
cui ogni cosa proviene. Con Plotino il mondo perde definitivamente la sua autonomia: l’uomo stesso è solo
anima, anzi, è anima separata dal corpo, poiché è come se in ciascuno di noi vi fossero tre persone diverse.
Infatti, la prima persona è costituita dalla nostra anima considerata nella sua tangenza con l’intelletto, la
seconda è rappresentata dall’anima come pensiero discorsivo e, infine, la terza è l’anima che vivifica il corpo
terreno. Sullo sfondo di queste riflessioni, vi è la distinzione aristotelica (presente nel "De anima") delle
funzioni dell’anima: e, secondo Plotino, il nostro vero io è soprattutto quello della seconda persona, ossia
l’anima come pensiero discorsivo, capace di tendere verso il meglio (la prima persona) o verso il peggio (la
terza persona). In tale prospettiva, l’uomo altro non è se non un’anima che si serve di un corpo, il quale, a
sua volta, non è che un’anima "caduta": ne consegue che l’anima, non solo è slegata dal corpo (secondo
l’insegnamento platonico), ma, addirittura, è strettamente congiunta all’assoluto. Nell’ambito gnoseologico,
l’anima, essendo incorporea e dunque incapace di concepire alcunchè, può solo agire, mai subire, giacchè ciò
che è incorporeo non è suscettibile di subire azioni: e allora la sensazione va intesa come azione del corpo
esterno sul corpo percipiente ma, in questi termini, in virtù del rapporto tra anima e corpo, sembra che
l’anima subisca, in qualche modo, l’influenza degli oggetti, cosa che abbiamo poc’anzi detto impossibile. Per
evitare di incappare in questa contraddizione, Plotino ricorre ad una scaltrezza di sapore stoico, distinguendo
tra sensazione esteriore (che è l’affezione e l’impronta che i corpi producono sui corpi stessi, poiché,
stoicamente, sussiste una simpatia universale che lega ogni cosa) e percezione sensitiva (che è l’attività
dell’anima in senso stretto: un atto conoscitivo che coglie l’impressione e l’affezione corporea
appropriandosene). In altri termini, secondo Plotino, il nostro corpo subisce passivamente un’affezione e,
dopo ciò, l’anima cattura tale affezione corporea e, successivamente, riesce a giudicarla; in particolare,
nell’impressione sensoriale l’anima riesce a vedere l’orma delle forme intelligibili e, quindi, la stessa
sensazione altro non è se non contemplazione dell’intelligibile nel sensibile; in tale ottica, le sensazioni
possono anche, di fatto, essere definite come "pensieri oscuri". Se non ci fosse l’anima superiore che ha
nozione degli "intelligibili puri", non potrebbe nemmeno esserci la sensazione. Plotino attribuisce all’anima
anche la capacità di immaginare e memorizzare, riconoscendo invece nel corpo uno strumento di impaccio a
queste due attività: prova ne è, secondo Plotino, il ricordo delle dottrine scientifiche, che col corpo non
hanno nulla a che fare. E occorre notare come, propriamente, solo l’anima sia dotata di memoria (in quanto
solo essa è legata alla temporalità): l’Uno e l’intelletto ne sono sprovvisti. Da sottolineare è la distinzione che
Plotino opera tra memoria e reminescenza: quest’ultima è un richiamare alla memoria, un conservare
perennemente nell’anima ciò che le è connaturato. Non c’è da stupirsi che, nella prospettiva plotiniana, la più
alta attività conoscitiva dell’anima risieda nel pensiero che coglie le idee (intese non più alla maniera
platonica, come enti a sé stanti, ma come "mente" di Dio). L’obiettivo cui ciascuno di noi deve aspirare sta
nel cogliere l’Uno e identificarsi con esso attraverso l’estasi, distaccandosi cioè dal corpo: è solo
quest’ultimo, infatti, a patire le affezioni e solo l’anima (che da esse è immune) può capacitarsi che il corpo è
in preda ad esse.
(Autunno 2002, corso tenuto dalla professoressa Luciana Repici, Università di Torino)
INDIETRO
La filosofia e i suoi eroi
LA FISICA DEI GRECI
Un’ampia panoramica sulle dottrine fisiche dei Greci ci è fornita da quella sorta di manuale di storia della
filosofia che è il libro primo della Metafisica di Aristotele: dopo essersi rapidamente richiamato alla dottrina
delle quattro cause (materiale, formale, efficiente, finale) – la sola che, a suo avviso, possa rendere conto del
reale in maniera esauriente - già ampiamente trattata nella Fisica, lo Stagirita guarda indietro ai suoi
predecessori per vedere a quante e a quali cause essi siano pervenuti nel tentativo di render conto della realtà
indagata. Questa ricognizione delle dottrine formulate da chi è venuto prima è un procedimento che
Aristotele impiega con incredibile frequenza all’interno dei suoi scritti e affonda le sue radici nella
convinzione che il sapere non nasca ex novo, come per magia, ma debba essere invece il frutto di un percorso
comune e metatemporale, al quale contribuiscono anche i filosofi del passato. Ecco perché "dobbiamo
prendere in esame anche coloro che prima di noi hanno affrontato lo studio degli esseri e hanno filosofato
intorno alla realtà. E’ chiaro, infatti, che anch’essi parlano di certi principi e di certe cause. Ora, il rifarsi
ad essi sarà certo di vantaggio alla presente trattazione: infatti, o troveremo qualche altro genere di causa,
oppure acquisiremo più salda credenza nelle cause di cui ora s’è detto" (Metafisica, 983 b). In realtà,
nessuno dei predecessori si è spinto ad individuare addirittura quattro cause – nota con orgoglio Aristotele -,
ma anzi, nella maggior parte dei casi, si sono arrestati a una o due (in pochi ne hanno intraviste tre), dando di
conseguenza una spiegazione parziale e non del tutto esauriente del reale. A questo proposito, Aristotele
concentra la propria indagine innanzitutto sui filosofi che hanno individuato esclusivamente la causa
materiale: ancor prima di fare nomi, egli introduce i caratteri comuni di questi autori che si sono arrestati alla
causa materiale (intesa come "ciò di cui tutti gli enti sono costituiti"), senza scorgerne altre. Ad avviso di
costoro, per conoscere le cose è sufficiente individuare la causa materiale, concepita come "elemento e
principio degli enti" (dove "elemento" è l’ingrediente materiale componente le varie realtà, principio – in
greco – è ciò che viene prima in senso cronologico e logico e dà origine alla realtà): sotto questo
profilo, l’intera ricerca svolta dai primi filosofi è per Aristotele volta al rinvenimento dell’ da cui tutte
le cose sono venute ad essere. Nella veste di storico della filosofia, dunque, Aristotele proietta la propria
indagine sulle coste dell’Asia Minore (attuale Turchia) e, più precisamente, nella città di Mileto, ove furono
operativi Talete, Anassimandro e Anassimene, che lo Stagirita non esita a definire come "fisiologi"
(), riservando a se stesso il più alto titolo di "fisico" (). L’iniziatore della ricerca dell’
pare essere stato Talete, figura non priva di connotazioni leggendarie (ben presto sul suo conto fiorirono
miriadi di aneddoti): egli muove dalla convinzione che l’, ovvero il principio da cui tutto deriva, sia
l’acqua. Dalla convinzione secondo cui l’acqua sarebbe alla base di ogni realtà, Talete avrebbe addirittura
fatto conseguire la tesi – che a noi non può strappare un sorriso – secondo cui la Terra stessa galleggerebbe
sull’acqua e si troverebbe pertanto in un equilibrio precario. Aristotele, con la curiosità filosofica che lo
contraddistingue, prova anche a domandarsi come possa essere la concezione propria di Talete dell’acqua
come causa materiale: pur in assenza di certezze (il che è testimoniato dal "forse" che Aristotele premette
alla propria constatazione), non si può escludere che Talete sia addivenuto alle sue note conclusioni partendo
dall’osservazione che l’umido sta alla base di ogni cosa - perfino del caldo – e che i semi stessi, da cui nasce
la vita, sono anch’essi umidi. Da ciò ben si evince come Talete si basasse, nel proprio procedere filosofico,
soprattutto sull’osservazione diretta dei fenomeni. Aristotele sembra anche suggerire, in certa misura, che
Talete, nella formulazione delle proprie tesi, tenesse conto di quella tradizione mitica – cantata nei poemi di
Omero e di Esiodo – in cui Oceano e Teti non erano che i progenitori del mondo: in questo senso, Talete
avrebbe sostenuto la stessa tesi dei poeti, ma da essi si sarebbe differenziato per aver dismesso la veste
teologica e mitica e per aver indossato quella ipercritica della filosofia. Fare di Talete un razionalista
nell’accezione moderna – affermatasi da Cartesio in poi – sarebbe però sbagliato, anche perché su di lui
influiscono concezioni animistiche che lo inducono a ritenere vivo il magnete – perché capace di muoversi in
presenza del ferro – o ad affermare enigmaticamente che "tutto è pieno di dei" (frase facilmente convertibile
in: "tutto è pieno d’acqua"). Anche se Aristotele trascura questo aspetto, noi possiamo tentare di spiegare
l’importanza da Talete concordata all’acqua facendo riferimento alla particolare zona in cui egli è vissuto:
Mileto era una città marinara, in cui l’acqua era di fondamentale importanza per i traffici e, dunque, per la
sopravvivenza dei suoi cittadini. Una domanda destinata a restare senza risposta è se Talete abbia avuto
discepoli e, in tal caso, se Anassimandro rientrasse nella sua cerchia. Pare assai improbabile (anche se non
escludibile) che ciò sia possibile, anche perché nel VII secolo a.C. non abbiamo testimonianze sull’esistenza
del rapporto di discepolato: non è tuttavia da escludersi che Anassimandro abbia conosciuto e frequentato
Talete. Anassimandro compie in sede filosofica un passo decisivo: accantona la poesia e scrive – primo nella
storia – un’opera in prosa, tramandataci con l’usuale titolo di Sulla natura (); ciò non toglie,
tuttavia, che lo stile prosastico da lui impiegato non concedesse ampi margini ad un linguaggio immaginifico
e poetico, volto ad accattivarsi l’attenzione dei lettori. Ma, oltre alle questioni di ordine stilistico, la grande
innovazione apportata da Anassimandro risiede nell’aver individuato l’ non già in un qualcosa di
materiale ed empiricamente constatabile (al pari dell’acqua di Talete), bensì una realtà soprasensibile, forse
in base al ragionamento che l’ non può essere una sola delle entità visibili, ma piuttosto un qualcosa da
cui tutte scaturiscano. Per questa via, Anassimandro passa dal visibile all’invisibile. Tale invisibile è
da lui ravvisato nell’, ovvero – letteralmente – in "ciò che non ha limiti" (). Questo
"illimitato" trova una sua collocazione fisica alla periferia di un universo sferico al cui centro è posizionata la
Terra, dotata di forma cilindrica ed equidistante dalla periferia (essa è dunque in perfetto equilibrio nella sua
immobilità, senza bisogno di alcun sostegno, nemmeno dell’acqua supposta da Talete). Dall’ si
generano in primis le "qualità contrarie" (caldo/freddo, secco/umido, ecc), ossia gli elementi, giacchè alla
natura di ciascun elemento corrisponde una data qualità (così al fuoco corrisponde il caldo, all’acqua il
freddo, ecc). In questo senso, allora, l’ manca, oltre che di limiti, anche di qualità: proprio da questo
sostrato aqualitativo nascono i quattro elementi costituenti la realtà. Non è un caso che, nell’universo, ogni
cosa sia dotata di limiti precisi: dalla realtà illimitata () nascono tutte le cose e ciascuna di esse
diventa col nascere il limite di tutte le altre (tant’è che nel definirla non facciamo che distinguerla dalle altre).
Nell’unico frammento di Anassimandro conservatosi fino a noi il limite è descritto in termini di , ossia
di violenza e di prevaricazione delle cose fra loro, una sorta di ingiustizia di cui le cose pagano il fio con la
distruzione (al che provvede il processo del nascere e del perire): "principio delle cose che sono è
l’illimitato… donde le cose che sono hanno la generazione, e là hanno anche il dissolvimento secondo la
necessità. Infatti esse pagano l’una all’altra la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del
tempo". Sulla scia di Talete, Anassimandro fa leva sul senso comune, spiegando l’ingiustizia cosmica
attraverso le ingiustizie che patiamo quotidianamente. Con Anassimene (VI secolo a.C.), invece, la filosofia
in terra di Ionia compie un passo indietro: anch’egli autore di un’opera in prosa intitolata Sulla natura
(), abbandona l’indagine "astratta" intrapresa da Anassimandro e torna alla ricerca di un unico
principio materiale, che egli individua non già nell’acqua, bensì nell’aria. Quanto anche la sua sia una
filosofia del senso comune lo si può facilmente arguire dall’importanza rivestita dall’aria per la nostra vita, in
particolare per la respirazione: secondo Anassimene, l’aria opera a livello cosmico come a livello umano,
cosicché essa dà origine e tiene in vita tanto gli uomini quanto l’universo nel suo insieme. Per spiegare il
processo di derivazione degli elementi (terra, acqua, fuoco) dall’aria, egli fa riferimento a due processi
contrari: la rarefazione e la condensazione. L’acqua riscaldata, infatti, si trasforma in aria, e così via. In
questa maniera, le trasformazioni del mondo vengono spiegate come trasformazioni dell’aria, giacchè tutte le
cose costituenti l’universo non sono che aria in un diverso grado di densità. I filosofi ionici, a rigore, non si
esauriscono nella triade Talete/Anassimandro/Anassimene: anche Eraclito di Efeso rientra in certo modo nel
loro novero. Vissuto ad Efeso a cavallo tra VI e V secolo a.C., egli è foriero, in ambito fisico, di una tesi
assai originale. A suo avviso, il mondo non è il prodotto di una divinità o di un ordinamento di tipo umano,
bensì risponde ad un unico ed eterno ordine universale (il ) costituente e fondante l’essenza del cosmo:
tale ordine universale viene da Eraclito identificato nel "fuoco sempre vivente", sicchè la sua può essere a
ragione qualificata come una cosmologia del fuoco (). Si tratta, al pari dell’acqua di Talete e dell’aria di
Anassimene, di un principio di natura materiale: è un fuoco sempre vivente, tale da non perire mai ma da
andare tuttavia incontro ad una vicenda che consente ad Eraclito di spiegare il processo di generazione e
corruzione. Aristotele – che pure non fa mistero della difficoltà di decifrare Eraclito – sbaglia interpretazione
nel momento in cui classifica il filosofo di Efeso come mero ricercatore dell’unico , giacchè il fuoco
(pur essendo materiale) non dev’essere qui inteso come un unico principio, ma piuttosto come un qualcosa a
cui riferirsi per analogia; in altri termini, il fuoco è per Eraclito l’emblema di ciò che accade a livello
cosmico, ove ogni cosa muta incessantemente, ora nascendo, ora perendo, proprio come il fuoco
alternativamente si accende e si spegne. Il Sole stesso (contenente fuoco) – egli nota – brilla di giorno e si
spegne di notte. Tale concezione si riverbera in maniera netta sulla visione che Eraclito ha del mondo: esso
risulta essere una totalità ordinata (e "non un mucchio") la cui vicenda è scandita secondo momenti che si
ripetono sempre uguali. Il divenire universale implica un passaggio tra opposti (nascere/perire) da cui
traggono origine tutti gli altri (sonno/veglia, malattia/salute, ecc): sicchè ciascuno di esse deve perire
affinché possa nascere il suo opposto; ciò significa, allora, che gli opposti non sono se non momenti tra loro
in guerra. Quest’ultima è l’essenza intima della realtà o, per dirla con Eraclito, "è padre di tutte le cose":
l’universo, così inteso, è un insieme di contrari in guerra reciproca, ma esso risulta non già dal caotico
guerreggiare de medesimi, bensì dall’armonica unità dei contrari, compresenti in ogni cosa. La guerra tra gli
opposti non esprime, allora, una prevaricazione di ciascuna cosa su tutte le altre (come credeva
Anassimandro), ma è anzi la legge regolante il cosmo e che può essere compendiata nell’espressione
scolastica di coincidentia oppositorum. In questo senso, sbaglia quella tradizione stereotipata che ci presenta
Eraclito esclusivamente come il "filosofo del divenire" (tale etichetta meglio si attaglia al suo discepolo
Cratilo): egli è sì il filosofo del divenire, ma ancora di più quello della coincidenza degli opposti. Pertanto,
quando egli dice che "negli stessi fiumi scendiamo e non scendiamo, siamo e non siamo" sta suggerendoci
ancora una volta l’armonica unità dei contrari, per cui si è e insieme non si è immersi nelle acque. Dalle
coste dell’Asia Minore saltiamo ora a quelle dell’Italia meridionale e, più precisamente, della Calabria: la
scena si sposta in concomitanza con una figura anch’essa nativa della Ionia ma poi trasferitasi a Crotone per
via dei dissensi col tiranno Policrate; questa figura ai confini con la leggenda è quella di Pitagora di Samo,
fondatore della prima scuola filosofica che la storia ricordi. In realtà, più che di una scuola, si tratta di una
comunità filosofica, religiosa e politica (in certo senso si può anche parlare di "setta" religiosa) i cui membri
conducevano vita comune e venivano iniziati. Le vicende della comunità – il cui orientamento politico era
decisamente aristocratico – e di Pitagora si concludono quando Crotone diviene sede di una rivolta
democratica che porta alla distruzione della scuola e alla dispersione dei suoi membri. Tratto saliente dei
Pitagorici è il marcato ascetismo a cui essi fanno capo: la pratica di non mangiare carni (la commedia greca
ce li rappresenta ironicamente come dei morti di fame) e la credenza (di marca orfica) nella trasmigrazione
delle anime e nelle loro espiazioni di colpe sono i pilastri della vita pitagorica; con loro prende via la
tradizione del corpo come tomba dell’anima destinata – attraverso Platone prima e attraverso il cristianesimo
dopo – a segnare in maniera indelebile la cultura occidentale. La cosa curiosa è che Pitagora ci è presentato
come politico, come etico, come fisico e come matematico: insomma, come una figura a trecentosessanta
gradi. Nel primo libro della Metafisica, Aristotele attribuisce ai Pitagorici la dottrina per cui i numeri
costituiscono l’essenza di tutte le cose, tant’è che per lo Stagirita essi rientrano tra i primi indagatori della
natura, sebbene non rinvengano l’ in un unico principio, ma in una miriade di principi (i numeri); il che
fa di loro non già dei monisti, bensì dei pluralisti. Tuttavia non è chiaro a quali Pitagorici faccia riferimento
Aristotele (a quelli originari o a quelli a lui contemporanei?): pare difficile che egli alluda ai primi, anche
perché la tradizione attesta che il nucleo originario dei loro insegnamenti fosse rigorosamente impartito per
via orale e, come se ciò non bastasse, i destinatari erano tenuti al silenzio; solo più tardi, con Filolao di
Crotone e Archita (IV secolo a.C. quasi), i Pitagorici mettono per iscritto le loro dottrine ed è dunque
presumibile che ad essi alluda Aristotele. Dire che i numeri costituiscono l’essenza delle cose equivale a dire
che ne sono la forma: essi sono cioè quel che fa sì che le cose siano quel che sono. Per effettuare i calcolo, i
Pitagorici ricorrevano a pietruzze tramite le quali rappresentavano visivamente i numeri (una pietra
rappresentava l’uno, due pietre il due, e così via), con l’inevitabile conseguenza che mancava lo zero; in virtù
di questa concezione figurata dei numeri, essi erano inoltre in grado di rappresentare le cose: ad esempio,
quattro pietruzze rappresentavano il quadrato, tre il triangolo, e così via. Da ciò segue che la forma delle cose
può essere espressa in rapporti numerici, cosicché la forma non è mai casuale, ma sempre ordinata: ne risulta
un universo matematizzato, ove i rapporti tra le parti sono esprimibili numericamente, con la conseguenza
che il mondo stesso è perfettamente conoscibile in forza del fatto che "i numeri non mentono mai" (Filolao).
Avvalendosi dei numeri, i Pitagorici spiegavano perfino i concetti astratti: così la giustizia è espressa dal 4 e
dal 9, che sono i quadrati del primo numero pari e del primo dispari (l’1 non è né pari né dispari: è il
parimpari, nel senso che, aggiunto ad un pari, lo rende dispari, e viceversa), il 5 esprime il matrimonio (3+2,
dove 3 è il sesso maschile, 2 il femminile). Naturalmente questa mistica dei numeri esula completamente
dalla scienza impiegata per investigare numericamente il cosmo. Stando ad Aristotele, i Pitagorici avrebbero
spiegato col loro impianto numerico anche l’organizzazione del cielo: il 10 è, per loro, il numero sacro su cui
giurare, poiché è la "tetrattide" () compendiante in sé l’universo (l’1 è il punto, il 2 la linea, il 3 la
superficie, il 4 il solido: 1+2+3+4=10). Ed è su tale base "mistica" che innestano la loro teoria astronomica:
l’universo è organizzato intorno al fuoco centrale, accostato metaforicamente al focolare della casa o a quello
del tempio. Attorno al fuoco ruotano terra, luna e tutti gli altri pianeti fino al cielo delle stelle fisse: in questo
modo, però, si arriva solo fino a nove pianeti ed è proprio per arrivare a dieci (la tetrattide) che essi
aggiungono una anti-Terra, situata tra fuoco e Terra. La cosa forse più interessante, nel discorso pitagorico, è
che per la prima volta nella storia la Terra non occupa il centro dell’universo. I Pitagorici erano altresì
convinti che dai cieli provenisse una musica che solo pochi eletti potevano percepire. La presa di posizione
di Parmenide e della scuola eleatica che a lui fa capo segna un punto di svolta decisivo nell’indagine sulla
natura. Fondatore di una scuola filosofica sulla costa campana a sud di Salerno (a Elea, poi Velia),
Parmenide compone il suo poema Sulla natura in esametri, il metro tipico dell’epica, benché lo scritto
parmenideo di poesia –oltre alla forma – non possegga nulla. Il protagonista del poema è, significativamente,
Parmenide stesso, che in prima persona narra di un viaggio avvenuto sotto la guida di una divinità che
l’avrebbe portato a varcare la porta che separa la luce dalle tenebre; qui egli avrebbe ricevuto dalla dea
l’insegnamento che intende comunicare agli altri uomini. Il nucleo del poema è dunque il contenuto del
messaggio divino, che fin dall’inizio (fr.1) riguarda ciò che può essere pensato e detto, ovvero l’oggetto
autentico del pensiero quale può essere espresso nel linguaggio. Rispetto ai predecessori – che muovevano
pressoché sempre da ciò che cadeva sotto gli occhi di tutti -, Parmenide cambia rotta e parte non già
dall’empiria per giungere all’invisibile, bensì da ciò che ai sensi sfugge per poi spiegare ciò che sotto di essi
cade. E il punto d’avvio è costituito da ciò che può essere autenticamente pensato e detto (si tratta quindi di
un punto di partenza logico/gnoseologico); in particolare, questo punto di vista è incentrato su quello che, da
Aristotele in poi, è passato alla storia come "opposizione di contraddizione", ove l’opposizione sussiste tra
l’essere e il non-essere. La dea illumina Parmenide su ciò che si può pensare e dire (l’essere), di contro a ciò
che né si può pensare né si può dire (il non-essere). E ciò che si può autenticamente pensare e dire è solo ciò
che è, mentre ciò che non è non può essere pensato e detto, poiché pensare ciò che non è equivale per
Parmenide a non pensare niente, dire ciò che non è equivale a non dir nulla. Ciò implica, allora, una netta
indistinzione tra logica e ontologia. In base a questi presupposti, la dea addita a Parmenide la via della verità,
quella che dice che "solo ciò che è può essere pensato e detto"; la via da non seguire (perché porta al falso) è
quella opposta, la via di ciò che non è e che non può essere pensato e detto. Dopo aver succintamente
delineato i capisaldi logici della riflessione parmenidea, analizziamo ora la sua speculazione in sede fisica: in
opposizione alla via della verità – la sola realmente percorribile -, gli uomini comuni imboccano una terza
via pericolosissima, la via dell’opinione; è una via ancora più insidiosa rispetto a quella falsa che dice che ciò
che non è può essere pensato e detto, giacchè la via opinativa non è che la pseudoconoscenza che trae origine
dal mondo empirico sensorialmente conosciuto. I sensi, infatti, illudono gli uomini, facendo loro credere che
le cose divengano incessantemente (tale era stato l’errore di Eraclito e di Cratilo), in una continua vicenda di
essere e non-essere, per cui le cose non sono sempre state né sempre saranno, bensì ora sono, domani non
sono. Ne nasce l’illusione che l’essere e il non-essere si implichino continuamente a vicenda, là dove la via
della verità asserisce che essi si elidono mutuamente. Connessa al divenire è l’idea della molteplicità e del
movimento: in questo senso, il mondo appare come una molteplicità di cose in movimento costante e – cosa
ancor più grave – gli uomini finiscono per credere che questa sia la via della verità. Con Parmenide è per la
prima volta sistematizzata la distinzione tra conoscenza sensibile (svuotata di significato e meramente
doxastica) e conoscenza intelligibile (l’unica vera), distinzione destinata a non essere mai più persa di vista
nella tradizione successiva. Si tratta di una posizione che svaluta massimamente la fisica e il mondo naturale,
inteso come sede dell’inganno: le cose di natura divengono, nascono (cioè vengono ad essere dal non essere)
e muoiono (passano cioè dall’essere al non essere); la natura è dunque da Parmenide destituita di ogni
fondamento e, con essa, è messa al bando la nozione di molteplicità e di movimento. In questa maniera, la
riflessione parmenidea sfocia in un monismo radicale, per cui dell’essere si parla in un unico senso ed è
nettamente esclusa l’eventualità del divenire, della molteplicità e del moto. Con tale esclusione, Parmenide si
pone al di fuori del novero degli indagatori della natura e – per dirla con Aristotele – egli ha fatto ricerche di
altro genere. Ma la posizione da lui maturata costituisce un insormontabile ostacolo per le altre, poiché pone
i successori nella necessità di contravvenire il suo divieto (solo ciò che è è pensabile e dicibile): per
riabilitare la natura come realtà in senso pieno e per di più come realtà indagabile scientificamente, i
successori di Parmenide (i cosiddetti "pluralisti") dovranno riabilitare innanzitutto le nozioni di movimento e
di molteplicità; compito reso ulteriormente difficile dal fatto che i discepoli di Parmenide – Zenone e
Melisso – elaborano una congerie di argomentazioni inoppugnabili in difesa delle tesi del maestro: i
"pluralisti" si troveranno dunque nella difficile situazione di dover aprire una guerra su più fronti (fisico,
ontologico, logico). Aristotele ci riferisce che i pensatori immediatamente successivi a Parmenide – anch’essi
etichettati come - sono diversi dai naturalisti ionici poiché, a differenza di questi, assumono alla
base della realtà una pluralità di principi, in antitesi al monismo parmenideo: con questi "pluralisti" (così
detti perché spiegano la realtà con una pluralità di principi), dell’essere si parla finalmente in molti sensi,
benché essi restino saldamente legati ad una concezione dell’essere come materia. Dunque, pur
distinguendosi dagli Ionici per l’assunzione di una pluralità di principi (e non di uno solo), i "pluralisti"
restano vicini ai loro predecessori ionici nella misura in cui continuano a ritenere di natura materiale i
principi costitutivi della realtà. I personaggi più importanti della schiera pluralista sono essenzialmente tre:
Empedocle di Agrigento, Anassagora di Clazomene, Democrito di Abdera. Il primo di essi – Empedocle –,
operativo all’inizio del V secolo ad Agrigento, presenta ancora i tratti dell’antico sapiente che stende in versi
la propria opera e che si occupa di tutto (di medicina, di fisica, di religione, ecc). Discendente da nobile
famiglia, Empedocle sceglie di scrivere in versi perché ai suoi tempi la poesia era un’autorità da tutti
riconosciuta, che tendeva a meglio diffondersi rispetto alla prosa; a differenza di Parmenide, che dalla poesia
aveva ereditato esclusivamente la forma, Empedocle ne assume anche il linguaggio altisonante e roboante,
tant’è che Aristotele lo considera l’inventore della retorica. C’è un alone di mistero che circonda le sue
opere: il suo scritto principale – intitolato Sulla natura – è affiancato da un altro scritto, tradizionalmente
noto come Purificazioni. Il mistero risiede nel fatto che le due opere trattino di cose diversissime tra loro, a
tal punto da far dubitare dell’autentica paternità di Empedocle: il Sulla natura è un’opera sensu stricto fisica,
mentre dalle Purificazioni traspaiono palesemente influenze pitagoriche ed orfiche, nella misura in cui
Empedocle propugna l’immortalità dell’anima (che nel Sulla natura era detta mortale) e la metempsicosi. Le
due opere, pertanto, ci restituiscono un Empedocle diverso e, paradossalmente, antitetico. Il mistero si
infittisce nel momento in cui ci si chiede se le Purificazioni siano un’opera autonoma o, piuttosto, una parte
integrante del Sulla natura. E, in quest’ultimo caso, occorre anche domandarsi in quale parte del Sulla natura
debbano essere collocate (all’inizio? alla fine?). Misterioso è anche il fatto che Aristotele sembri conoscere
solamente l’Empedocle del Sulla natura e che mai menzioni le Purificazioni (che non conoscesse tale opera
pare assai difficile, data la straordinaria erudizione che lo caratterizza). Messo in luce il "giallo" intorno alla
figura di Empedocle, proviamo ora a ricostruirne la fisica, alla luce di quanto egli stesso ci ha lasciato nel suo
poema Sulla natura: qui, egli spiega la formazione del mondo a partire dall’empiria, ovvero da quel mondo
in continuo fieri tanto aborrito da Parmenide. Occorre trovare a fondamento della realtà una pluralità di
principi aventi caratteristiche tali da rispettare le norme fissate da Parmenide per il suo essere: unicità (se
l’essere fosse molteplice, sarebbe uno e non sarebbe uno, cioè sarebbe e non sarebbe), immobilità (se l’essere
fosse in moto, ora sarebbe qui e ora non sarebbe qui, cioè sarebbe e non sarebbe), eternità (se l’essere fosse
generato, verrebbe ad essere mentre prima non era). Se si vuole fondare con certezza la realtà spiegandone il
divenire e salvando i fenomeni (presupposto a cui tutti i "pluralisti" restano fedeli) senza trasgredire le norme
parmenidee, occorre rinvenire più principi aventi tutti le caratteristiche dell’essere parmenideo. Debbono
essere molti, poiché altrimenti non si spiegherebbero le molte facce in cui il reale si presenta. Empedocle
ritiene di aver individuato i principi in quattro elementi: l’acqua, l’aria, la terra e il fuoco. Tali principi
vengono da lui denominati radici (), a sottolineare come essi facciano nascere la realtà e le
conferiscano stabilità. Poste a fondamento del reale le quattro "radici", Empedocle arriva a divinizzarle, cosa
che può sembrare strana soprattutto se riferita alla terra, che rappresenta il basso. Esse sono all’origine della
corruzione e della generazione, pur essendo esse stesse sottratte a tali processi: le cose che cadono sotto i
nostri sensi nascono e muoiono non già nel senso che passino dal non essere all’essere e viceversa, bensì nel
senso che siano il frutto dell’aggregazione (nascita) e della disgregazione (morte) delle quattro radici, le
quali sono però eterne, immutabili, immobili. L’intera realtà – ivi compresi gli dei e l’anima – rientrano in
tale processo di aggregazione e corruzione; solamente le quattro radici (corrispondenti all’essere
parmenideo) ne restano fuori. Ciascun aggregato è il prodotto della combinazione delle radici, con la
conseguenza che il fondamento della realtà è una struttura invisibile soggiacente a quella visibile e tale da
spiegarla. Aristotele nota sagacemente che nella ricerca delle cause Empedocle compie un gran passo avanti,
distinguendo per la prima volta tra la causa materiale e quella efficiente (detta "causa del movimento"):
infatti, per spiegare come le quattro radici possano combinarsi e separarsi, Empedocle fa riferimento ad altre
due cause, da lui chiamate Amore e Odio. Sicchè la generazione delle cose nasce dall’unione delle quattro
radici in forza dell’azione dell’Amore, mentre la disgregazione è il frutto dell’agire dell’Odio. In questo
senso, la cosmologia empedoclea non è che la proiezione sul mondo delle regole (l’odio e l’amore) stanti alla
base dei rapporti umani. Amore e Odio agiscono dunque come causa del movimento delle quattro radici, ma
non è in alcun caso possibile – nota Aristotele – attribuire ad essi la funzione di cause formali e finali: infatti,
non agiscono in vista di un qualche fine, ma il loro processo è anzi, in certo senso, retto dal caso; in realtà
Empedocle, alla parola "caso", preferisce "armonia": il processo messo in moto da Amore e Odio è sì
casuale, ma tale da creare un’armonia. Il cosmo stesso si configura agli occhi di Empedocle come una totalità
ordinata, giacchè soggetto ad una vicenda ciclica che attraversa varie fasi: dapprima prevale l’Amore e le
quattro radici si trovano commiste fra loro; poi subentra l’Odio che, introducendo divisioni, permette la
nascita dei viventi; in seguito l’Odio prevale e le quattro radici sono del tutto divise. A questo punto, termina
il ciclo e riprende da capo. Si tratta di una vicenda ciclica non scandita da divinità, ma autoregolantesi. Con
la figura di Anassagora di Clazomene la filosofia sbarca ad Atene (462 a.C.) e da questo momento per i due
secoli venturi la città dell’Attica resterà il fulcro della vita intellettuale della Grecia, fino a che il primato
passerà – in età ellenistica – ad Alessandria d’Egitto. Quando Anassagora giunge ad Atene, trova una città
magnifica, che sta vivendo sotto Pericle i suoi anni più splendidi sul piano culturale (è in quest’epoca che vi
operano Sofocle, Euripide, Erodoto e Fidia). Raggiunta Atene, la filosofia muta volto: il naturalismo ionico
subisce un’autentica trasfigurazione e lo stesso naturalismo anassagoreo è accusato di empietà, con un
processo analogo a quello che vedrà successivamente coinvolti Protagora e Socrate. Proprio in Socrate il
naturalismo di cui Anassagora si fa portavoce troverà un ostacolo insormontabile nella propria diffusione.
Anche Anassagora, al pari di Empedocle, si interroga sulla costituzione del mondo in termini pluralistici
(facendo cioè riferimento a principi molteplici stanti alla base della realtà e tali da spiegarne la molteplicità).
Se Empedocle era ricorso a quattro "radici", Anassagora è invece convinto che a rendere conto del mondo
possano essere un’infinità di principi infinitamente divisibili: è questa l’unica maniera per spiegare l’infinita
varietà in cui si articola il reale. Anch’egli, come Empedocle, ricorre ad un referente di tipo biologico: i
principi primi sono da lui detti "semi" () di tutte le cose, ad evidenziarne la funzione (i semi sono
in natura ciò da cui tutto nasce). Dunque anche Anassagora innalza a livello cosmico la realtà
quotidianamente esperita. Aristotele, quando parla dei "semi" anassagorei, li etichetta come "omeomerie",
ovvero come "parti simili" (), a sottolineare come essi siano a loro volta composti da
un’infinità di parti simili fra loro. Dal combinarsi dei semi, nascono i vari composti che cadono sotto i nostri
sensi: ciascuno di tali composti è una mescolanza di tutti gli infiniti semi, cosicché Anassagora può a ragion
veduta asserire che "tutto è in tutto". In ogni oggetto ci sono tutti gli infiniti semi, ma non in egual quantità:
anzi, l’oggetto è quel che è in forza della prevalenza numerica di determinati semi (il pane è tale perché in
esso i semi di pane sono in netta maggioranza su tutti gli altri infiniti semi, che pure sono presenti). Tuttavia
noi percepiamo sempre e solo i composti, mai i semi di per sé: non meno delle radici empedoclee, i semi
anassagorei rappresentano la struttura profonda del reale visibile ai soli occhi della mente. E dagli oggetti
visibili – che nascono dall’aggregazione dei semi – noi muoviamo per conoscere intellettualmente i semi: per
meglio chiarire questo punto nodale, Anassagora adduce l’esempio dell’alimentazione. Quando mangiamo il
pane, noi cresciamo in parti diverse (carni, peli, unghie, capelli, ecc), poiché nel pezzo di pane che ingeriamo
sono compresenti tutti gli infiniti semi (anche della carne, del sangue, delle unghie, ecc); sicchè, mangiando
il pane, stiamo non di meno mangiando anche la carne, il sangue, le unghie, ecc. Questo spiega il celebre
frammento di Anassagora secondo cui "", che in italiano suona: "il visibile è
uno sguardo lanciato sull’invisibile"; le cose che cadono sotto i nostri sensi rimandano ai semi costituenti il
reale. Non è chiaro se Anassagora riconosca la possibilità dell’esistenza di infiniti mondi, benché tale
possibilità sia pienamente compatibile con l’infinità dei semi. Anche per lui, i processi del divenire
dipendono dall’aggregazione e dalla disgregazione dei semi (per questa via, il problema eleatico è aggirato):
stando così le cose, quale causa mette in movimento, in origine, i processi del divenire? Se Empedocle aveva
mobilitato l’Amore e l’Odio, Anassagora scomoda un solo principio e sostiene che, nell’indistinzione
() originaria dei semi, è il (Intelligenza) a porre ordine; esso è un principio intelligente che mette
in moto i semi. In sintonia con la tradizione a lui precedente, Anassagora individua un principio
caratterizzante la vita umana (l’intelligenza) e lo assume come ordinatore del tutto. Platone prima e
Aristotele dopo notano con entusiasmo la novità introdotta da Anassagora: per la prima volta compare sulla
scena, come principio in grado di spiegare il mondo, un’Intelligenza ordinatrice. Pur non asserendo in alcun
luogo che l’Intelligenza sia separata, egli insiste nel sottolineare come essa sia comandante assoluto della
materia senza a sua volta essere comandata. Aristotele precisa che non ci si deve far trarre in inganno dalla
terminologia anassagorea e credere che, parlando di Intelligenza, questi abbia introdotto una causa finale o
formale: l’Intelligenza, infatti, non forma le cose in vista di alcun fine; prova ne è – nota Aristotele – che le
cose determinate si formino per mera prevalenza quantitativa, ovvero secondo un criterio accidentale. Ciò
non toglie, tuttavia, che Anassagora, pur non essendo stato così lungimirante da cogliere la causa finale
(l’Intelligenza è e resta una causa efficiente), paia ad Aristotele "un sobrio in mezzo a degli ubriachi",
giacchè egli solo ha identificato il principio ordinatore del cosmo in un’Intelligenza; questa – prosegue lo
Stagirita – è stata da Anassagora impiegata come il deus ex machina, il Dio calato in scena dai tragediografi
per sciogliere i nodi della vicenda. Con Diogene di Apollonia (metà del V secolo a.C. circa), la filosofia pare
bruscamente far marcia indietro verso le posizioni elaborate dai naturalisti ionici e oramai superate dai
"pluralisti": Diogene, infatti, è convinto che la realtà quale ci appare possa essere spiegata scomodando un
solo principio e per di più di ordine materiale. In sintonia con Anassimene, egli ritiene che tale principio
possa essere ravvisato nell’aria, il che – nota Diogene – risulta particolarmente evidente se prestiamo
attenzione a quanta importanza abbia l’aria per la vita. Ma gli insegnamenti di Anassagora – che forse
Diogene ebbe modo di conoscere – non sono passati invano: Diogene, infatti, identifica l’ nell’aria
(cosa che fa di lui, in certo senso, uno "Ionico in ritardo"), ma poi conferisce a tale principio
quell’intelligenza che Anassagora aveva attribuito al . L’aria è dunque un principio dotato di
intelligenza tale da agire in maniera finalistica (e qui sta la grande novità apportata da Diogene),
organizzando le cose nel miglior modo possibile. In virtù dell’aria e delle sue qualità è poi possibile
distinguere una pluralità di fasce climatiche nel mondo, le quali influenzano in maniera necessitante il
carattere degli individui che in esse vivono: in ciò risiede quello che potremmo definire come "determinismo
ambientale" di Diogene. Gli uomini che conducono la loro esistenza in zone particolarmente arieggiate e
secche – è questo il caso dei Greci – riveleranno una particolare acutezza d’ingegno, mentre quelli che
vivono là dove l’aria è umida e pesante, risulteranno più tardi e meno svegli. Un determinismo ambientale
affine a quello emerso in Diogene di Apollonia ritorna nello scritto medico – appartenente al corpo
ippocratico - intitolato Arie, acque, luoghi: il medico deve prestare particolare attenzione ai luoghi, all’aria e
all’acqua che caratterizzano l’ambiente giacchè egli deve scientemente tenerne conto nella prescrizione delle
diete e nella diagnosi delle malattie (che trovano nell’aria uno dei principali veicoli di trasmissione). Il
messaggio che emerge dallo scritto è che le arie, le acque e i luoghi condizionano in maniera imprescindibile
la costituzione umana, sia nel bene sia nel male, cosicché il buon medico dovrà conoscere in maniera
adeguata l’ambiente circostante per poter così meglio svolgere la sua attività terapeutica. In questa
prospettiva, l’autore dello scritto si lancia in un’autentica fisiognomica ambientale, facendo corrispondere a
determinati individui determinati territori (ad esempio, chi è nato in zone boscose presenterà specifiche
caratteristiche, e così via); tale corrispondenza si riverbera anche sui popoli: in particolare, l’autore di Arie,
acque, luoghi instaura un raffronto tra i Greci e gli Orientali, notando come questi ultimi – poiché viventi in
zone calde e secche – siano generalmente indolenti e pigri e, in forza di ciò, facilmente governati da tiranni.
Al contrario, il clima solare e felice dei Greci fa sì ch’essi siano particolarmente briosi e agguerriti, pronti al
pensiero come all’abbattimento delle tirannidi. Stante l’indiscutibile necessità della natura, resta però un
interstizio in cui può inserirsi la libertà umana: tale è l’istituzione politica (), grazie alla quale l’uomo
può liberamente ritagliarsi uno spazio d’azione i cui confini non possono essere varcati dall’agire
necessitante della natura. Così, le popolazioni orientali sono rette da grandi dispotismi e il coopera a
renderle militarmente inette (manca del tutto l’interesse a ribellarsi alla tirannide); sull’altro versante, il clima
e l’ambiente greco sottopongono l’uomo a cambiamenti rapidi, come rapido dev’essere il pensiero: e le
istituzioni politiche presso di loro in uso non fanno che cooperare col clima controbilanciandone la necessità.
Lo spazio riservato dall’autore dello scritto al è parecchio, tant’è che egli arriva addirittura a
riconoscere come il possa diventare una seconda natura: per chiarire questo punto, egli adduce
l’esempio della popolazione dei Macrocefali, presso la quale era segno di prestigio avere la testa schiacciata;
per questo motivo, la testa dei bambini veniva schiacciata, cosicché – nota l’autore dello scritto -, a furia di
schiacciarla, le generazioni future sarebbero nate già con la testa schiacciata. In questo senso, il può
perfino trionfare sulla : anzi, e sono per l’autore ippocratico due entità combinatisi fra
loro. I Sofisti, dal canto loro, tendono a leggerle piuttosto come due realtà opponentisi. Anche l’atomismo si
configura come teoria "pluralistica" che si propone di spiegare il cosmo senza trasgredire le prescrizioni
parmenidee: l’iniziatore della corrente atomistica sembra essere stato Leucippo, figura che per noi non è che
un nome, visto la scarsissima quantità di materiale sul suo conto che possediamo; ben di più sappiamo sul
suo collega Democrito di Abdera, il quale scrisse – come i Sofisti – una miriade di opere sui più svariati
argomenti, benché di esse non ci siano giunti che frammenti. Anche Democrito, come già Anassagora,
assume come struttura della realtà invisibile ad occhio nudo un’infinità di principi, ancorché questi non siano
infinitamente divisibili: se infatti tutto fosse divisibile all’infinito, allora il mondo avrebbe dovuto cessare di
essere già da tempo. I principi primi della realtà come li intende Democrito debbono essere pieni e privi di
parti: tali sono quelli che egli definisce , ovvero – letteralmente - "corpi non ulteriormente
tagliabili", costituenti la struttura profonda del reale. Questi "atomi", per potersi muovere e per consentire la
generazione e la corruzione dei composti, devono avere uno spazio entro cui muoversi ed è per questa
ragione che Democrito introduce come secondo principio il vuoto (), condizione imprescindibile
del moto atomico. Gli stessi aggregati non sono che unioni di atomi e vuoto: il che è provato dal fatto che,
consumandosi, i corpi cedono atomi e, perché ciò possa avvenire, dev’esserci il vuoto. Con terminologia
eleatica, Democrito chiama gli atomi e il vuoto rispettivamente "essere" e "non essere"; egli asserisce poi –
riprendendo l’antitesi sofistica - che la conoscenza intellettuale (avente come oggetto gli atomi e il vuoto) è
(secondo natura), mentre quella degli aggregati è (secondo convenzione). Sicchè
secondo natura conosciamo gli atomi e il vuoto, secondo convenzione il bianco, il profumato, ecc. Le cose
che costantemente esperiamo non sono dunque la verità, ma mera parvenza. Essendo gli atomi infiniti,
infiniti saranno anche i mondi che dalla loro aggregazione trarranno origine, cosicché Democrito può
relativizzare la vita che conduciamo sul nostro e può inoltre evitare di far ricorso a cause extra-materiali.
Incarnando in sé l’essere parmenideo (ed essendo dunque immutabili, eterni, incorruttibili), gli atomi come si
distinguono fra loro? Per Empedocle e Anassagora, i principi si differenziano qualitativamente, il che tra
l’altro spiega perché i corpi composti presentino qualità; per Democrito invece – stando a quel che riferisce
Aristotele – gli atomi si differenziano fra loro per caratteristiche quantitative. Per far luce su questo punto
della dottrina democritea, Aristotele esemplifica servendosi delle lettere dell’alfabeto, che egli chiama
: e sono anche gli "elementi", con la conseguenza che gli atomi sono un po’ come le
lettere dell’alfabeto e il mondo che ne risulta si presenta come una sorta di libro le cui lettere sono gli atomi.
Per forma () gli atomi si distinguono fra loro come la A si distingue dalla N; per ordine ()
come AN da NA; per posizione () come Z da N. Si tratta evidentemente di differenze puramente
geometriche, con caratteristiche misurabili. Tuttavia Democrito si spingeva oltre: pare infatti che, poste
queste tre differenze di base, egli asserisse che gli atomi sono dotati di un numero incalcolabile di differenze,
a tal punto che egli finisce col riconoscere – il che gli costerà la derisione da parte dei suoi avversari –
l’esistenza di atomi di forma uncinata. Il problema cui Democrito è chiamato a rispondere è che, se gli atomi
sono quantitativamente connotati, come si spiega che poi noi percepiamo qualitativamente i composti?
Perché se la rosa non è che un aggregato di quantità noi la percepiamo rossa, profumata, ecc? Per render
conto di ciò, Democrito spiega le qualità come epifenomeni delle quantità, cosicché il bianco deriverebbe da
un assetto casuale dato dall’unione di atomi: la rosa non è che un aggregato di atomi quantitativamente
connotati che però, colpendo i nostri organi di senso, generano impressioni qualitative (il profumo, il colore
rosso, ecc). Un altro problema su cui Democrito deve affaticarsi riguarda la natura stessa degli atomi: se essi
sono corpi invisibili e indivisibili, allora non avranno parti e saranno come enti geometrici; ma allora come è
possibile ch’essi, privi di parti, si aggreghino e formino corpi divisibili costituiti da parti? Come possono
muoversi? Democrito sostiene che gli atomi sono ab aeterno dotati di moto (il che implica il vuoto in eterno)
e, più precisamente, si muovono in qualunque direzione senza tregua, con la conseguenza che possono
casualmente incontrarsi e aggregarsi (ciò nel caso in cui le forme siano compatibili, come ad esempio quando
si incontrano atomi ad uncino e atomi ad anello). A regolare il moto degli atomi non è una forza esterna o un
adivinità: l’unica legge (se in questo caso di legge si può parlare) regolante il loro movimento è il caso, non
già nel senso ch’essi si muovano senza causa, bensì nel senso che il loro è un moto spontaneo, scevro di
finalità e non extra-naturale: è un moto che tiene conto della legge per cui il simile attira il simile. Tutto
risponde ad una ragione e ad una ferrea necessità. Oltre a negare la causa finale, l’atomismo nega quella
efficiente – nota Aristotele -, giacchè per Democrito essa non è se non una proprietà della materia. Con
Democrito si esauriscono le filosofie della natura del V secolo a.C. prima di Platone. Mentre Anassagora e
Democrito erano attivi, già operava ad Atene quella nuova figura di filosofo che è Socrate, che dalla città
attica mai si allontanò. La prima difficoltà che s’incontra nel ricostruire il suo pensiero risiede nel fatto che
egli non ha scritto nulla, benché le opere su di lui siano assai numerose. Nel 423 a.C., il commediografo
Aristofane mette in scena Le nuvole, un’indiavolata commedia al cui centro è proprio la figura di Socrate
(quella di Aristofane è la testimonianza più antica su Socrate), sebbene trasfigurata dalle esigenze comiche
proprie dell’opera. Stando a quel che dice il suo allievo Platone, Socrate sceglie volutamente di non scrivere
e di occuparsi di valori umani anziché di fisica; le conoscenze naturalistiche, infatti, hanno ben poco da
insegnare e così egli si esprime nel Fedro (230 d): "a me piace apprendere, ma la campagna e gli alberi non
vogliono insegnarmi nulla, a differenza degli uomini della città". Sempre nel Fedro (274 b e seguenti) è
spiegata – con il mito di Theuth - la scelta socratica di non affidare alla scrittura il proprio messaggio
filosofico: la vera filosofia è quella orale, attuatesi dialogicamente nella pratica della domanda e della
risposta, mentre lo scritto è "un bronzo percosso", ovvero un bronzo che, colpito, dà sempre lo stesso suono.
La testimonianza di Platone (peraltro avvalorata da Senofonte, anch’egli discepolo di Socrate) parrebbe
dunque diametralmente opposta a quella di Aristofane: ne Le nuvole, infatti, Socrate ci è presentato non già
come il filosofo dei valori umani, che antepone gli uomini alla natura (Fedro) e che attacca su più fronti i
sofisti (Sofista, Teeteto, Apologia, ecc), bensì – e qui sta l’aspetto paradossale – come un naturalista che
identifica le nuvole in divinità! In forza di ciò, Socrate è messo in scena all’interno di una cesta (il
"pensatoio") sospesa a mezz’aria ed è addirittura tratteggiato come un venditore di sapere, capace di far
trionfare il Discorso ingiusto su quello Giusto; in altri termini, il Socrate che Aristofane propone è un
naturalista empio e assai vicino alla sofistica. E del resto questa era l’immagine che doveva far maggior
presa sull’animo degli Ateniesi, se è vero che nell’Apologia Socrate ravvisa nelle "antiche accuse" (quelle
appunto mossegli sulla scena da Aristofane) l’origine delle sue disavventure giudiziarie. Stando così le cose,
parrebbe che la posizione socratica sia alquanto prossima a quella anassagorea, in quanto entrambe incentrate
sull’indagine naturalistica, quando in realtà Platone non fa che ripeterci che Socrate mai si interessò di fisica.
La lontananza tra le intenzioni animanti il pensiero di Socrate e quello di Anassagora sono ancora meglio
lumeggiate nel Fedone platonico, ambientato nelle ore che precedono la morte di Socrate: in quest’opera
sull’immortalità dell’anima, il filosofo ateniese narra il proprio itinerario intellettuale a partire dai suoi
iniziali interessamenti per le ricerche naturalistiche, che presto avrebbe abbandonato per dedicarsi a
trecentosessanta gradi all’uomo e ai suoi valori. A quell’epoca risale la sua attenzione per il pensiero di
Anassagora: ma, dopo essersi procurato e aver letto il suo scritto Sulla natura, si sentì profondamente
insoddisfatto, giacché Anassagora si limitava ad indicare la causa materiale e quella efficiente, trascurando
del tutto quella finale, ossia la "causa del bene e del meglio". Fu allora che Socrate si accorse della necessità
di dover intraprendere quella seconda navigazione () che l’avrebbe fatto approdare ai lidi
delle Idee (nel Fedone ancora chiamate ), capaci di render conto delle cose in maniera teleologica. Se
dinanzi alla domanda "perché Socrate è seduto in carcere anziché essere in fuga?" Anassagora risponde
scomodando solamente la causa materiale e quella efficiente, asserendo che il suo corpo ha assunto una
posizione seduta anziché retta e in fuga, Socrate risponde invece che c’è una causa del bene e del meglio che
esula dalla materia di cui Socrate è costituito e che riguarda piuttosto la sua anima: in altri termini, fuggire ed
evadere dal carcere sarebbe per l’anima il male peggiore. Ripercorrendo in maniera sintetica l’iter
intellettuale di Socrate, non sfugge come egli, partito da interessi naturalistici (anche perché, prima di lui,
non v’era stata pressoché alcuna filosofia che non fosse naturalistica), muti assai in fretta interessi,
dedicandosi a ricerche di altro genere. Ciò, tra l’altro, spiega perché nella Repubblica Platone non annoveri
la fisica tra le scienze componenti il curriculum del filosofo, riservando invece un posto privilegiato alla
matematica, alla geometria, alla stereometria, all’astronomia e alla musica. La fisica appartiene secondo
Platone e Socrate all’ambito della conoscenza doxastica, poiché i suoi oggetti sono – secondo
l’insegnamento di Cratilo e di Eraclito – sempre in divenire, mai afferrabili pienamente dalla mente umana.
Tuttavia anche Platone, che col maestro Socrate condivide l’avversione per la fisica, ci prende di sorpresa
quando, all’interno della sua vastissima produzione, dedica alla filosofia della natura un dialogo di
fondamentale importanza come il Timeo: Platone ormai anziano torna sui suoi passi e riabilita quella fisica
cui in gioventù aveva negato lo statuto di scienza e fa ciò forse in virtù delle discussioni tenute
nell’Accademia. Il Timeo è un dialogo in cui Socrate si è ormai ritirato dalla scena: il protagonista, Timeo di
Locri, è esperto di matematica e, forse, di medicina. Anche l’esposizione è mutata: all’arioso dialogo
costruito sulla prassi del "botta e risposta", Platone ha ormai sostituito una forma dialogica più pesante, in cui
si procede per ampi brani espositivi intervallati da brevi risposte. Tutto ciò non deve però indurci a credere
che egli smentisca se stesso e confuti quanto detto negli anni passati: prova ne è il fatto che le dottrine
cosmologiche del Timeo sono esposte sotto forma di mito; questo perché il mito – come è noto – riveste in
Platone una valenza fortemente pedagogica, ma anche perché egli sente la necessità di restar fedele al suo
pensiero precedente, incentrato sulla convinzione che del mondo fisico non sia dato avere certezze. In
sostanza, quel che Platone ci propone nel Timeo – che sarà l’opera privilegiata, in età medievale, dalla
cosiddetta "Scuola di Chartres" - è un’ulteriore riflessione sul rapporto intercorrente tra le Idee e il mondo,
tema già al centro del Parmenide. Poiché gli oggetti sensibili sono in perpetuo divenire, di essi sarà possibile
non già l’, bensì la : sicchè l’opera stessa si configura, più che come trattato di fisica, come
racconto immaginifico di come le cose possono essere venute ad essere. Al cuore del Timeo è la figura
chiave del Demiurgo, il divino artigiano che ordina il mondo: il ricorso alla figura di un tecnico permette a
Platone di chiarire fin dall’inizio come Egli operi su di una materia che Gli preesiste e che dunque non è il
frutto di una Sua creazione. In questo senso, si può dire che il Demiurgo si limita a conferire la forma ad una
materia autonomamente esistente: per questa via, è messa al bando ogni prospettiva creazionistica, il che
dovrebbe far ricredere i vari pensatori che hanno letto nel Timeo un’anticipazione delle tesi cristiane. La
negazione della prospettiva creazionistica chiarisce poi a quali cause Platone ricorra per spiegare il mondo:
in primo luogo ci sarà la materia (quella che Aristotele definisce causa materiale) e, accanto ad essa,
impersonificata dal Demiurgo, la causa efficiente (Egli infatti trae le cose dalla materia). Ma, trattandosi di
un artigiano divino, Egli non può che disporre le cose nel miglior modo possibile, cosicché ciascuna di esse è
orientata al meglio: in questo senso, sono introdotte la causa finale e quella formale. Le cause mobilitate da
Platone - il Demiurgo e la materia – paiono però difficilmente conciliabili fra loro (come del resto
inconciliabili sono il corporeo e l’incorporeo). Il Demiurgo agisce conferendo forma ad una materia che,
originariamente, non ne ha una e che anzi si presenta come altamente caotica: il Suo agire è
significativamente raffrontato da Platone a quello dei legnaioli che mettono ordine nella catasta di legna. Ne
risulta – per dirla con Leibniz – il migliore dei mondi possibili, proprio perché frutto dell’azione di un
principio divino intelligente. Per di più, come tutti gli artigiani, il Demiurgo lavora la materia avendo in
mente un preciso modello a cui ispirarsi: tale modello non è se non l’intelligibile mondo delle Idee, cosicché
Egli opera sulla materia cercando di trasferire in essa il più fedelmente possibile le Idee. Ne nasce sì il
migliore dei mondi possibili, ma non è un mondo perfetto in assoluto: la materia, infatti, costituisce un
insuperabile limite all’agire divino del Demiurgo, giacchè essa mai si lascia interamente "dominare" (la
metafora bellica è di Aristotele); in maniera immaginifica, Platone dice che la materia non si lascia
"persuadere", metafora che ritorna nella Repubblica, allorché si parla di anima razionale e di anima
irrazionale. Resta ora da chiedersi perché il Demiurgo generi il mondo: Platone risponde che ciò avviene
perché l’artigiano divino è buono e "in chi è buono non nasce mai nessuna invidia. […] Volle che tutte le
cose si generassero simili a Lui, per quanto potevano". In altri termini, nel Demiurgo troviamo quella "causa
del bene e del meglio" che Socrate non era riuscito a rinvenire nel testo di Anassagora. Il mondo sarà allora
provvidenzialmente ordinato, ovvero retto fin da principio dalla divina provvidenza di un’intelligenza che lo
rende ordinato e tale lo mantiene: nulla è lasciato al caso, dal cielo fino alle viscere della terra. La metafora
impiegata da Platone per illustrare il rapporto tra il Demiurgo e il mondo che ne deriva è particolarmente
chiarificante: in quanto "Padre" del mondo, il divino artigiano è ad esso legato da un rapporto d’amore affine
a quello che lega il padre al figlio. L’opera ordinatrice esplicata dal Demiurgo già si manifesta nella forma
che Egli impone ai quattro elementi costitutivi della realtà (elementi che Platone, in sintonia con Empedocle,
ravvisa nella terra, nell’acqua, nell’aria e nel fuoco): la prima determinazione d’ordine della materia consiste
nel qualificarla nei quattro elementi con qualità (caldo, freddo, secco, umido); la forma dei quattro elementi è
a sua volta ridotta ad una figura geometrica elementare: il triangolo, il quale, formando poliedri, dà la
struttura matematizzante dell’universo. Ne consegue allora che l’universo fisico rinvia ad una struttura di
tipo geometrico sempre identica: in questo modo, la matematica è e resta (ciò era già vero nei Pitagorici e
nella Repubblica, dove le scienze matematiche rinviano al mondo delle Idee) il vero strumento per conoscere
il mondo. Così concepito, l’universo è una struttura ordinata perfettamente conoscibile, in cui tutto si ripete
immutabile e regolare. L’ordine trova un suo primo garante nel moto immutabile e regolare degli astri, da
Platone considerati come divinità (il che ha indotto alcuni interpreti a parlare di teologia astrale in Platone):
il tempo che scandisce le vicende fisiche è misurato in base al moto degli astri ed è perciò "immagine mobile
dell’eternità". Il mondo sensibile, che si presenta come un’opera d’arte, essendo generato ha un corpo (a
differenza dell’incorporeo mondo delle Idee) e quest’ultimo è unico (come unico è il mondo delle Idee) e – a
differenza di quel che credeva Democrito - disposto nella forma migliore di tutte: la sfera, in cui tutti i punti
sulla circonferenza sono equidistanti dal centro. Dal fatto che sia dotato di corpo, Platone inferisce che il
mondo possegga anche un’anima, inferenza avvalorata dal fatto che esso è popolato da esseri dotati di anima
(una proprietà delle parti deve di necessità appartenere anche al tutto). Ma se quest’opera d’arte che è il
mondo possiede l’anima, allora dovrà possedere l’anima migliore in assoluto: quella intellettiva. Il mondo si
configurerà allora come un immenso vivente () che si muove in maniera ordinata, perché diretto dallo
stesso principio razionale che governa l’uomo, con la cui descrizione il Timeo si chiude. Il fatto stesso che
l’uomo – unico tra i viventi – abbia posizione eretta è indizio della preminenza in lui della testa, che è qui da
Platone accostata all’acropoli, costituente il cuore pulsante della città. L’uomo dipende dunque dall’alto e, a
rimarcare ciò, la natura ha provvisto a separare in maniera netta in lui la testa dal resto del corpo attraverso il
collo. Con questi presupposti, Platone dà anche una spiegazione delle malattie: esse sono sì frutto di una
cattiva disposizione del corpo, ma risentono anche di una cattiva educazione (il che rivela un recupero da
parte di Platone della tematica cara a Socrate dell’analogia tra malattia dell’anima e ignoranza). L’opera si
chiude con un’esortazione rivolta agli uomini a diventare come la divinità, poiché l’eliminazione
dell’ignoranza porta a migliori reincarnazioni. Il Timeo platonico è il bersaglio polemico in riferimento al
quale Aristotele matura la propria filosofia della natura: nello studio della fisica rientrano, secondo lo
Stagirita, anche lo studio degli animali e perfino quello dell’anima, cosicché non stupisce se la maggior parte
dei suoi scritti possono essere considerati scritti di fisica. Il problema preliminare che egli si pone è se la
fisica debba oppure no essere ascritta tra le scienze: il fatto che egli si ponga un tale problema adombra una
volontà di confronto con Platone e con la sua negazione dello statuto di scienza all’indagine sulla natura. Se
per Platone una sola è la scienza (quella del Bene) e da essa derivano gerarchicamente tutte le altre forme di
sapere, Aristotele, dal canto suo, ci fornisce una completa classificazione delle scienze (Metafisica, VI) in
teoretiche, pratiche, poietiche. Teoretiche sono quelle che hanno a che fare con la pura teoria, pratiche sono
invece quelle concernenti la prassi (la politica e l’atica) e, infine, poietiche sono quelle finalizzate alla
produzione di oggetti (ad esempio, la tragedia). Sicchè nell’ambito delle scienze teoretiche Aristotele fa
rientrare la metafisica ("filosofia prima"), la matematica e la fisica ("filosofia seconda"): non solo la fisica è
una scienza, ma addirittura essa appartiene alle scienze supreme, quelle che debbono essere amate e
perseguite in quanto tali, senza secondi fini. Ciò evidentemente rivoluziona il quadro tracciato da Platone, in
cui la fisica non era nemmeno degna di essere una scienza. Le tre scienze teoretiche ravvisate da Aristotele
studiano in tre maniere distinte l’essere: la matematica studia l’essere privo di movimento, la fisica studia
l’essere in movimento, la metafisica studia l’essere in quanto essere e coincide (Metafisica, XII) con la
teologia. Per Platone, proprio perché rivolta alle cose transeunti, la fisica non può assurgere al grado di
scienza: ciò non vale per Aristotele, ad avviso del quale è possibile studiare le cose nel loro divenire. Ciò non
toglie, però, che la fisica – a differenza della metafisica, che studia l’essere in quanto tale – sia una scienza
particolare, giacché si occupa solo dell’essere in movimento e, perciò, difetta di universalità: oltre ad
occuparsi dei corpi terreni, caratterizzati dall’essere passeggeri e non eterni, Aristotele fa rientrare nel campo
d’indagine della fisica anche lo studio dei corpi celesti. Con quest’operazione, egli pone l’astronomia come
scienza fisica e non come scienza matematica (quale era per Platone), poiché gli astri sono anch’essi corpi in
movimento, benché – a differenza dei corpi terrestri – non siano soggetti al divenire, ma esistenti sempre e
necessariamente. Ne segue che gli orizzonti della fisica finiscono per spaziare dalla terra al cielo. Il confine
tra il mondo terrestre – popolato dai corpi in divenire – e quello celeste – popolato dai corpi eterni – è
segnato dalla luna, che divide appunto il mondo sublunare da quello sopralunare. Le scienze teoretiche
riguardano cose esistenti necessariamente, ma all’interno della fisica è ritagliato uno spazio anche per i corpi
passeggeri e non eterni: le pietre, gli uomini e gli animali possono infatti non esistere e, in ogni caso, sono
perituri; essi tuttavia rispondono ad una modalità dell’essere che è (per lo più), per cui gli
uomini invecchiando diventano per lo più canuti. Nell’ambito del mondo fisico terrestre, allora, pur non
valendo la necessità assoluta, ciò non di meno vale la necessità condizionale, tale per cui, se si verifica una
tale condizione, si verifica un tale effetto (ad esempio: se invecchio, mi vengono i capelli bianchi). Sicchè i
corpi del mondo fisico di questa terra presenta caratteristiche fluttuanti (il colore degli occhi, dei capelli,
l’altezza, ecc), con l’inevitabile conseguenza che, a differenza della matematica, la conoscenza fisica non
potrà mai essere esatta né potrà fare ricorso a dimostrazioni analitico/deduttive (Platone riduce invece nel
Timeo gli elementi fisici a enti geometrici matematicamente studiabili). La fisica difetta dunque di
universalità, di esattezza e di necessità: come ogni altra conoscenza, anche quella fisica procede per cause e
quali siano tali cause Aristotele lo spiega nel II libro della Fisica, per poi riprenderlo nel I della Metafisica:
le quattro cause che egli individua non sono che le risposte da fornire quando ci si interroga sulla natura di
qualche cosa e tale dottrina è evidentemente dedotta dall’osservazione diretta dei corpi: osservandoli, si nota
infatti che essi rispondono a quattro diversi punti di vista, ovvero risultano dalla convergenza di quattro
cause. Infatti, le cose hanno una materia, sono prodotte da qualcuno, sono tali perché hanno una forma che le
individua e hanno uno scopo per il quale sono venute ad essere: qui in sintonia con Platone, Aristotele crede
che la struttura eretta sia stata data all’uomo affinché egli possa contemplare le realtà superne; ma Aristotele
non dimentica che le cose hanno anche una materia che le condiziona: così l’uomo può stare in piedi perché
possiede calore e il calore tende appunto verso l’alto. La materia e la forma non sono – secondo Aristotele –
separabili l’una dall’altra, col che egli si distingue nettamente dalla posizione platonica, per cui le forme
() sarebbero radicalmente distinte dalla materia (); inoltre l’assetto fisico di ogni cosa è tale perché
deve rispondere ad un dato fine e la forma è quella che è perché è stata organizzata in vista di tale fine. Solo
chi conosce tutte e quattro le cause delle cose può essere insignito del titolo di (fisico), giacchè egli
solo è in grado di indicare di che cosa le cose sono fatte, a quale fine tendono, quale forma hanno, che cosa le
ha messe in moto. Abbiamo detto che Aristotele innalza lo studio della natura al livello di scienza: ma che
cosa intende esattamente per natura? Non si tratta di una specie di griglia che si sovrappone dall’esterno alle
cose che sono. La natura non è che l’insieme di tutte quelle cose che avvengono naturalmente. Esiste dunque
una causa finale e divina – quale era il Demiurgo del Timeo – che fabbrica le cose in vista di un determinato
fine? Secondo Aristotele tale eventualità è da escludersi per due ragioni: nel II libro della Fisica, egli
asserisce espressamente che la natura non è divina e paragona la sua attività a quella tecnica; tuttavia, a
differenza della tecnica divina (che è infallibile), la tecnica umana è soggetta a fallire: similmente, in natura
non tutto avviene in maniera perfetta. Come il grammatico può commettere errori o come il medico può
prescrivere farmaci inadeguati, così la natura può parimenti compiere errori, benché il suo agire sia sempre e
comunque orientato al meglio: tale principio viene da Aristotele dedotto a partire dalla biologia, dove si
registrano casi di veri e propri mostri (ad esempio esseri con parti mancanti o in sovrappiù) e devianze dalla
norma della natura che vuole che gli uomini nascano per lo più in un certo modo. La possibilità dell’errore
della natura è resa possibile dal fatto che si tratta di un ambito di cose materiali e, come abbiamo poc’anzi
detto, la materia non sempre si lascia dominare dalla forma, a volte le oppone resistenza (tale è ad esempio il
caso della mano con quattro dita anziché cinque). Si può dunque legittimamente affermare che "il caso
rientra nel novero delle cause", intendendo con ciò dire che anche quel che accade per caso ha pur sempre
una sua causa, anche se l’effetto risulta derivare da una causa diversa da quella in forza della quale
solitamente accade: ossia avviene per accidente (). Può dunque accidentalmente
accadere che, nel corso della generazione, la materia non si lasci plasmare e ne nasca un mostro. L’individuo
di sesso femminile è esso stesso agli occhi di Aristotele un caso di errore della natura, un mostro prodotto dal
caso: agendo sul sangue mestruale, il seme maschile forma la materia ed è a questo punto che può verificarsi
la devianza; nascere femmina è, appunto, una devianza, ma si tratta pur sempre di una "mostruosità
necessaria" al fine di perpetuare la specie. Il fatto stesso che i figli non siano mai del tutto uguali ai genitori,
ma da essi si distinguano per altezza, colore dei capelli, degli occhi, ecc, testimonia l’accidentalità del
processo. Abbiamo detto che per Aristotele la fisica è scienza teoretica dei corpi dotati di movimento: resta
però da chiarire che cosa egli intenda per movimento (). Movimento è passaggio da potenza ad atto
di corpi che possono muoversi e nel movimento rientra anche la nozione di mutamento (), poiché
il greco significa appunto sia movimento sia mutamento. Se il movimento riguarda lo spostamento
nello spazio da un luogo ad un altro, il mutamento riguarda invece l’essere stesso delle cose che sono e, a tal
proposito, Aristotele distingue quattro diversi tipi di mutamento: a) il mutamento più ovvio è quello di luogo,
consistente nello spostarsi da un luogo ad un altro; b) il mutamento della sostanza è quello consistente nella
generazione e nella corruzione (ovvero il venire ad essere o il cessare di essere delle sostanze): è in questo
contesto che Aristotele risolve finalmente in via definitiva l’aporia eleatica del divenire fisico: venire ad
essere mentre prima non si era non significa – egli nota – passare dal non essere all’essere, ma significa
piuttosto passare dallo stato potenziale dell’essere in potenza a quello attuale dell’essere in atto; c) il
mutamento quantitativo interessa anch’esso la sostanza, ma esclusivamente rispetto alle proprietà che essa
presenta (una data sostanza può crescere o diminuire in quantità); d) infine, il mutamento qualitativo
interessa – come quello quantitativo – le proprietà della sostanza (e non la sostanza in se stessa), in
particolare le sue qualità (ad esempio, i capelli che da neri che erano passano ad essere bianchi; oppure
Socrate che diventa musico). Come si può facilmente notare, ciò che contraddistingue il mutamento
quantitativo è il fatto che esso avviene nello spazio, giacchè la sostanza – accrescendo o diminuendo –
occupa spazio. Tuttavia, accanto al movimento spaziale, ve n’è anche uno locale, caratterizzato da un’unica
direzione: o dal basso verso l’alto, o viceversa. Ciò vale per il mondo sublunare, poiché i corpi di quello
sopralunare sono invece dotati di moto semplice (ovvero circolare: spuntano e tramontano sempre nel
medesimo punto) in forza della particolare materia che li costituisce: si tratta non già dei quattro elementi
empedoclei che stanno alla base dei corpi sublunari, bensì di quella materia incorruttibile che Aristotele
chiama etere. Agli occhi di Aristotele, i corpi si distinguono in semplici e in composti, ed entrambe le
categorie cadono nel campo d’indagine della fisica: alla base di tutti i corpi che popolano il mondo sublunare
stanno i quattro elementi individuati da Empedocle: a tal proposito, Aristotele rigetta tanto gli atomi di
Democrito quanto i solidi del Timeo platonico. Se infatti alla base dei corpi fossero gli atomi, allora i corpi
risulterebbero meri insiemi di punti, cosicché potrebbero disgregarsi in qualsiasi momento. Platone compie
innegabilmente un passo avanti quando assume come elementi i solidi scomponibili, ma ciononostante la sua
proposta resta insufficiente poiché i solidi non sono in grado di subire alcunché né di aggregarsi per dare
composti. Solo Empedocle, ravvisando nell’acqua, nella terra, nel fuoco e nell’aria i quattro elementi stanti
alla base del reale ha colto la verità: tali quattro elementi, infatti, rendono perfettamente conto e del divenire
e dell’aggregarsi dei corpi, giacchè si tratta di elementi divisibili in parti che mantengono lo stesso nome
dell’elemento di partenza (ogni parte di terra è sempre terra, e così via). Inoltre essi sono elementi primi nel
senso che non sono composti da altri, possono subire affezioni e trasformazioni reciproche (l’acqua che
passa allo stato aeriforme), accrescere, diminuire, mutare luogo. Non stupisce pertanto che Aristotele dedichi
buona parte della Fisica al loro studio. Tuttavia sbaglia Empedocle nella misura in cui li concepisce come
principi (e non come meri elementi), giacché, così facendo, egli finisce per riconoscerli come eterni: ma da
ciò che è eterno non può in alcun caso nascere il mutevole e il transeunte, ovvero tutto ciò che popola questo
mondo. I quattro elementi rappresentano per Aristotele materia in un determinato stato (allo stato di terra, di
acqua, di fuoco, di aria) e presuppongono un sostrato potenziale comune da cui vengono ad essere per effetto
di fattori ambientali come il caldo e il freddo. Tale sostrato materiale non esiste indipendentemente da essi:
di per sé, i quattro elementi non sono eterni; eterna è invece la loro vicenda di trasformazione, poiché
eternamente si trasformano l’uno nell’altro. Dal moto dei corpi semplici dipende direttamente anche l’assetto
di del mondo terrestre, risultante costituito in base alla disposizione dei quattro elementi stessi (la cui
disposizione è legata alle caratteristiche fisiche di ciascun elemento). Il mondo sublunare (di natura sferica,
che è la migliore tra quelle possibili) viene così a configurarsi come una serie di cerchi concentrici al cui
centro sta l’elemento più pesante (la terra) e alla periferia quello più leggero (il fuoco), con in mezzo l’acqua
e – più leggera – l’aria. In base a tale disposizione si spiegano anche i moti che si verificano nel mondo
sublunare, che possono essere moti secondo natura () e moti violenti (): una pietra lasciata cadere
tende a muoversi di un moto naturale verso il basso, ma se la scagliamo verso l’alto essa procede per un
tratto in direzione opposta al suo luogo naturale (muovendosi con un moto contro natura), fino a che non
avrà esaurito la spinta e ricadrà a terra. I corpi celesti, invece, si muovono di moto circolare. La luna segna il
confine tra i due mondi (sublunare e sopralunare), ma tra essi non c’è separazione netta: c’è anzi una zona
intermedia in cui si situano i fattori meteorologici, che sono da Aristotele spiegati con le vicissitudini cui
vanno incontro i quattro elementi. Pur verificandosi una tantum (il terremoto o l’arcobaleno non accadono
certo quotidianamente), sono fenomeni dotati di una loro spiegazione razionale facente capo ai quattro
elementi: sono secondo Aristotele causati dal particolare moto del Sole, il quale avvicinandosi o
allontanandosi dalla Terra fa sì che gli elementi si trasformino e diano vita alle stelle cadenti, alle comete,
ecc. Aristotele parla a più riprese del moto solare come causa dei moti sublunari: egli si guarda bene dal
parlare di "calore" o di "luce" del Sole, giacché ciò significherebbe ammettere che anch’esso – stante al di
sopra della luna – è costituito dai quattro elementi. Ne segue allora che il garante della vicenda ciclica del
mondo sublunare (il Sole) è esso stesso sopralunare, e dunque dotato di moto circolare e perfetto. Gli
individui sublunari che popolano il nostro mondo (uomini, animali, piante) sono mortali come individui
(poiché costituiti dai quattro elementi), ma eterno è il loro processo di generazione e corruzione, cosicché il
singolo uomo è perituro, ma la specie umana è eterna (l’atto stesso con cui si ama e ci si riproduce non è che
un anelito all’eternità). I corpi celesti non si muovono però tutti allo stesso modo: ciascuno di essi descrive
nel suo tragitto una sfera e l’insieme complessivo di tali sfere dà un insieme concentrico che ha al suo centro
la Terra stessa (in ciò risiede il geocentrismo aristotelico). Come la Terra occupa il centro del mondo, così la
periferia è occupata dal "cielo delle stelle fisse", che chiude l’estremità del mondo. Le stelle fisse hanno
moto eterno, circolare e semplice: via via che dall’alto si scende verso la luna, i moti dei pianeti presentano
sempre maggiori irregolarità (tali sono appunto i moti apparenti) di velocità e di regradazioni. Per rendere
conto di essi, Aristotele ricorre a più espedienti e argomentazioni teoriche: il problema che più di ogni altro
lo interessa è che ciascuno di tali corpi celesti ha anche più d’un solo moto, cosicché diventa difficile
spiegare quale realmente sia la causa prima che sta alla base di tali moti. In tale ottica, Aristotele si domanda
perfino se gli astri abbiano un’anima – giacchè l’anima, come insegnava Platone stesso, è principio del
movimento – e, nel rispondere negativamente, egli chiude definitivamente i conti col Timeo, nel quale si
affermava esplicitamente che i pianeti fossero animati, intelligenti e divini. Pur negando l’anima ai corpi
celesti, resta intatto il problema riguardante la causa del loro moto: quale è il principio motore che mette in
movimento i corpi celesti? Nel XII libro della Metafisica, Aristotele propone ben due diverse possibili
risoluzioni del problema: dapprima egli riconosce che ogni sfera ha un proprio motore dotato di determinate
caratteristiche: deve essere una sostanza - sennò non può causare il moto di un’altra sostanza -, deve essere
anteriore al corpo mosso e deve muovere sempre – altrimenti non può causare l’immutabile e perenne moto
degli astri -, deve essere atto puro, giacchè se fosse potenza potrebbe ora muovere, ora no. Ma se è solo atto
ed esclude la potenza, allora esclude anche il movimento e il mutamento (che della potenza sono tipici): sarà
allora un motore immobile, che muove senza essere mosso. Dopo aver esposto questa teoria secondo la quale
molteplici sarebbero i motori immobili (uno per ogni sfera), Aristotele – appena un capitolo dopo – cambia
radicalmente prospettiva e riconosce esplicitamente la possibilità di un motore immobile unico per tutte le
sfere celesti. Questo primo motore immobile, in quanto privo di potenza, è anche privo di materia ed è da
Aristotele identificato con la divinità. Da ciò segue una struttura gerarchica del cosmo, poiché dall’unico
motore immobile "si dirama" l’intero universo: la metafora del diramarsi è impiegata da Aristotele anche in
sede biologica per spiegare il rapporto tra le vene e il cuore, che è un rapporto di unione tale per cui le vene
si diramano dal corpo senza distaccarsene; similmente, il motore immobile non è staccato dal mondo, e
l’universo stesso non è che una totalità in movimento incessante. L’identificazione del motore immobile con
la divinità non implica tuttavia un rapporto provvidenziale tra quest’ultima e il mondo, come invece era nel
Timeo: il dio di Aristotele, lungi dall’organizzare provvidenzialmente il mondo, sta fermo ed è causa finale
del moto del "primo mobile", ovvero del "cielo delle stelle fisse", che a lui tende come al proprio fine. In
accordo col libro XII della Metafisica, Aristotele sostiene nel libro VIII della Fisica che il motore immobile
deve essere presupposto come causa in grado di spiegare il moto del mondo: la divinità muove il mondo
stando ferma, ovvero causa il moto dell’universo come causa finale (giacché, se fosse causa efficiente,
sarebbe essa stessa in movimento), poiché a lei tende – come l’amante verso l’oggetto amato – il "primo
cielo". Ma se la divinità è immobile, in che cosa consiste la sua attività? Essendo il pensiero la migliore
attività in assoluto, la divinità non farà altro che pensare (essa è, in questo senso, la proiezione a livello
cosmico del filosofo) e, più precisamente, non farà altro che pensare a se stessa, poiché, se pensasse ad altro,
ritornerebbe quella nozione di potenza che abbiamo bandito dalla sfera divina: dio è per Aristotele
("pensiero di pensiero"). In netta opposizione all’atomismo e alla sua infinità dei mondi,
Aristotele difende a spada tratta l’unicità del mondo: il mondo è uno ed eterno, assolutamente incorruttibile
(l’errore del Timeo è ravvisato nell’aver posto il mondo come generato e, insieme, eterno, senza tener conto
che il generato è necessariamente perituro). In difesa dell’unicità del mondo, Aristotele dice – nel De caelo –
che, se ci fossero altri mondi, essi sarebbero necessariamente costituiti dagli stessi quattro elementi che
formano il nostro; ma allora tali elementi tenderebbero a disporsi nei luoghi naturali del nostro mondo,
cosicché se ne deve concludere che tutta la materia è già contenuta nel nostro unico mondo.
L’età che si apre dopo la morte di Aristotele (322 a.C.) è particolarmente significativa sia sul piano storico
sia su quello culturale, in quanto i confini della Grecia si estendono fino all’India e sono gettate le basi delle
future scienze: questa nuova epoca, definita da Droysen come "Ellenismo", vede come suo genio protettore,
nel bene e nel male, Alessandro Magno, con le cui strepitose conquiste il mondo greco arriva in terre remote;
Atene perde il proprio predominio politico e culturale, mentre Pergamo e, soprattutto, Alessandria d’Egitto
vengono assumendo un peso sempre maggiore per la cultura del tempo. Ad Alessandria, sotto i Tolomei, è
fondata l’importante biblioteca che finisce per diventare il tempio dell’intera cultura greca; ad essa fu
affiancato il celebre museo (letteralmente: "casa delle Muse"), circondato da incantevoli giardini. Che ne, è
in quest’era così complessa, dei filosofi? La tradizione vuole che alcuni Aristotelici (Demetrio del Falero e
Stratone di Lampsaco) fossero attivi nella fondazione dell’imponente biblioteca alessandrina, cosa che ci
aiuta a capire come quest’epoca, più di qualsiasi altra, fosse un’epoca di filosofi e, sotto questo profilo,
Atene resta ancora il principale polo di attrazione filosofica (ancorché ormai nessun filosofo sia ateniese). In
breve tempo l’attività del filosofo viene sempre più istituzionalizzandosi all’interno di scuole rette da
scolarchi (è questo il caso tipico degli Stoici e degli Epicurei). Anche l’Accademia platonica e il Peritato
aristotelico erano scuole di questo genere e tali restano anche in età ellenistica, entrando spesso in conflitto
con le nuove scuole e coi modelli da essi prospettati: particolarmente curiosa è la situazione che si vive nel
Peritato, ove gli scritti autentici di Aristotele sono del tutto scivolati nell’oblio, a tal punto da non essere
nemmeno più citati dai Peripatetici stessi. Anche gli esponenti delle cosiddette scuole "socratiche minori"
(Cinismo, scuola cirenaica, Megarici) continuano ad essere attivi: il caso più emblematico è probabilmente
quello di Diogene di Sinope, il quale porta alle estreme conseguenze gli insegnamenti cinici di Antistene. In
forza delle grandi conquiste militari compiute da Alessandro Magno, la viene a tramontare e, con essa,
tramontano i suoi valori: l’uomo greco non trova più nel rassicurante baricentro dell’ cittadina un
sostegno morale, ma, proiettato in un nuovo mondo dalle sterminate dimensioni, dove convivono fra loro i
costumi più diversi, egli prova un profondo senso di smarrimento e di insicurezza; ben si capisce allora
perché le filosofie ellenistiche si configurino essenzialmente come filosofie morali, non già nel senso che la
sfera gnoseologica venga trascurata, bensì nel senso che essa è subordinata all’etica. Tutte le correnti
filosofiche di quest’epoca mirano alla formazione del vero sapiente. Abbiamo parlato finora di "scuole"
filosofiche: in realtà, accanto ad esse, si formano correnti di pensiero che rigettano completamente
l’istituzionalizzazione in scuole: è il caso dello Scetticismo, che – in virtù delle sue stesse premesse – non
fonda scuole né annovera maestri, in quanto elemento portante di questa corrente di pensiero è
l’impossibilità della formazione di un sapere certo. Nel 306 a.C. Epicuro fonda la sua scuola in Atene: la
scelta del luogo e del modo di concepirla sono del tutto innovativi. Egli opta per la periferia della città
(anziché per il centro), ovvero per una zona lontana dalla città e dai suoi travagli. Questa scuola "periferica"
era dotata di un giardino () e Giardino fu chiamata la scuola stessa: l’immagine che di essa ci offrono
le fonti è quella di una comunità di individui (uomini e donne) legati dall’amicizia alla ricerca della felicità.
In ambito fisico, Epicuro riprende l’atomismo democriteo, apportando però ad esso delle innovazioni di
rilievo: anche per lui atomi e vuoto sono i principi costitutivi della realtà, benché non vengano più connotati
in termini eleatici come "essere" e "non-essere" ma semplicemente come le parti ultime in cui si
scompongono i corpi. Il vuoto è assunto – in perfetta sintonia con Democrito – come condizione
imprescindibile di quei moti degli atomi che danno l’aggregazione e la disgregazione dei corpi, anch’essi a
loro volta formati da atomi e vuoto (altrimenti non se ne spiegherebbe il nascere e il perire). Tuttavia, se per
Democrito gli atomi – in quanto privi di peso - si muovevano nel vuoto in tutte le direzioni, Epicuro, dal
canto suo, attribuisce ad essi peso, forse in base all’osservazione di Aristotele secondo cui, se i corpi hanno
peso, allora devono averlo anche gli atomi che dei corpi sono i costituenti. Ma se hanno peso, gli atomi non
si muovono a caso, bensì tendono ad andare dall’alto verso il basso secondo linee parallele: ma come
possono essi allora aggregarsi se si muovono lungo linee parallele tali per cui non possono incontrarsi? Nei
testi di Epicuro conservati (le tre epistole riportate da Diogene Laerzio in Vite dei filosofi, X) non è
prospettata alcuna soluzione a questo problema: ma dal De rerum natura di Lucrezio e dalle opere degli
avversari dell’epicureismo (Cicerone e Plutarco) sappiamo che Epicuro avrebbe escogitato un rimedio, la
"deviazione" (clinamen in latino, in greco) degli atomi dalla linea retta. In quest’ottica, gli
atomi si aggregherebbero perché dotati della spontanea capacità di deviare dalla traiettoria del loro
movimento e, dunque, di incontrarsi. Si tratta di una capacità costitutiva e spontanea degli atomi: può cioè
casualmente verificarsi che essi devino e che diano vita – in questo e negli infiniti altri mondi – agli
aggregati. Dire che si tratta di una capacità innata negli atomi equivale ad escludere ogni causa esterna agli
atomi stessa (è dunque negata la causa finale e, con essa, quella divina). Ne emerge un universo
meccanicistico e antifinalistico, fortemente antiplatonico e antiaristotelico. Oltrechè in ambito fisico, la
dottrina della deviazione" ha importanti conseguenze anche in sede morale: se infatti tutto accadesse secondo
necessità, allora il libero arbitrio sarebbe spento, tanto più che l’anima stessa non è che un aggregato di atomi
(ancorché di atomi ignei e sferici); ma, stando così le cose, non avrebbe più alcun senso l’etica. Ma la
capacità spontanea di deviare interessa anche gli atomi dell’anima e in ciò risiede la facoltà di scegliere
comportamenti che deviano dalla necessità, fermo restando che qualunque atto intellettivo muove da uno
stimolo esterno. Epicuro si spingeva più in là: anche gli dei – non solo l’anima – non sfuggono alle leggi
atomiche, cosicché anch’essi non sono se non aggregati di atomi e vuoto. Ciò attirò ben presto su di lui
l’accusa di ateismo, benché Epicuro precisasse nella Lettera a Meneceo che ateo non è chi rinnega gli dei del
volgo, ma chi agli dei applica le opinioni del volgo, prima fra tutte quella secondo cui essi agirebbero
provvidenzialmente nel mondo. Che gli dei esistano è provato dal fatto che tutti gli uomini lo credano
(argomento del consensus omnium): ma ciò non autorizza a credere che gli dei intervengano nel mondo e,
per di più, in maniera provvidenziale, poiché altrimenti non si spiegherebbe il male che attanaglia il mondo
stesso (negarlo è andare contro alla più banale delle esperienze). Di fronte al male, se gli dei intervengono e
non lo rimuovono è o 1) perché non vogliono, o 2) perché non possono, o 3) perché né possono né vogliono:
ma nel primo caso si tratterebbe di dei invidiosi, nel secondo di dei impotenti, nel terzo di dei impotenti e
invidiosi, tutte caratteristiche che non si attagliano alla divinità. Si dovrà allora riconoscere che gli dei ci
sono ma non intervengono nel nostro mondo (in netta antitesi con quanto, in quel torno di anni, sostenevano
gli Stoici e con quanto già sosteneva Platone nel Timeo). Come per Aristotele, anche per Epicuro la teologia
rientra a pieno titolo nella fisica, giacchè per il filosofo del gli dei sono materiali: come possono
allora essi essere immortali? Che abbiano forma umana è evidente, poiché – in quanto perfetti – debbono
avere la forma migliore, ovvero quella con struttura atomica meglio organizzata: tale è appunto la forma
umana. Gli uomini, tuttavia, sono perituri, ossia soggetti alla disgregazione atomica, cosicché la divinità, per
essere eterna, dovrà avere un continuo risarcimento di materia, tale da non potersi mai disgregare: ciò
garantisce la loro immortalità. In quanto corporei, poi, gli dei occupano spazio: Epicuro elegge a loro dimora
gli intervalli (gli intermundia di Lucrezio) che separano tra loro gli infiniti mondi. Dicevamo che il primo
argomento in favore dell’esistenza degli dei è dato dal consenso di tutti gli uomini circa la loro esistenza:
però esso non è il solo. Secondo Epicuro, infatti, anche la conoscenza che abbiamo degli dei è percettiva,
poiché anche da essi provengono (immagini) percettibili non già agli organi di senso, bensì – per la
loro sottigliezza – alla mente stessa. Al pari di Democrito, Epicuro assume un’infinità di atomi, il che spiega
anche l’infinitezza del vuoto (per poter contenere infiniti atomi deve necessariamente essere anch’esso
infinito). In rottura con Democrito, però, Epicuro nega che gli atomi abbiano un numero infinito di forme,
giacchè, se così fosse, si potrebbero ammettere atomi grandi quanto il mondo e dunque essi sarebbero visibili
ad occhio nudo (il che contrasta palesemente con la nozione di atomo): il numero delle forme degli atomi,
allora, sarà non infinito, ma incalcolabile. Anche Epicuro deve render conto di come i corpi si distinguano
qualitativamente tra loro: anche a suo avviso – come già per Democrito – le caratteristiche qualitative sono
un epifenomeno dell’assetto assunto dagli atomi nel formare un corpo; DEmocrito riteneva però che le
qualità fossero un fatto di convenzione e che solo atomi e vuoto fossero un fatto di natura, cosicché per lui le
qualità erano fluttuanti e mai stabilmente oggettive (da ciò seguiva l’incertezza della conoscenza sensibile).
Per Epicuro questa è una via pericolosa, giacchè porta a dubitare della conoscenza che abbiamo e fa
scricchiolare ogni sistema filosofico: per far fronte a ciò, egli asserisce che le qualità sono sì epifenomeno,
ma che vi sono qualità essenziali dei corpi e qualità accidentali; ci sono cioè qualità senza le quali il corpo
non è concepibile (ad esempio la statura eretta dell’uomo) e altre che sono accessorie e transeunti (il colore
dei capelli o degli occhi). Anche le qualità sono percepite insieme ai corpi e, dunque, non si deve dubitare di
esse. Anch’esse provengono dagli , i quali riportano informazioni certe, giacchè si muovono con
velocità istantanea, uguale a quella del pensiero: Epicuro dice che sono "equiveloci" poiché si muovo o nel
vuoto. Ciò garantisce un incrollabile criterio di verità, identificato nella sensazione. Meccanicismo e
sensismo sono dunque le due componenti fondamentali della filosofia epicurea, mentre la logica non
contribuisce al raggiungimento della felicità, intesa come piacere. L’epicureismo si diffuse in Italia
soprattutto a Napoli, ove ad Ercolano si sono rinvenuti numerosi papiri che ci hanno restituito frammenti del
Sulla natura (), l’opera fondamentale di Epicuro, in 37 libri. A Roma il verbo epicureo trovò
maggiori resistenze nella sua diffusione, in quanto il suo motto "vivi appartato"mal si
attagliava alla vita romana, per la quale la politica era irrinunciabile. Nel II secolo d.C., Diogene di Enoanda
fa scolpire su pietra la filosofia di Epicuro – venerato dai suoi successori come un dio – e la espone nel
portico della città di Enoanda. Ben diversa è la posizione degli Stoici: Zenone di Cizio (una località dell’isola
di Cipro) giunge ad Atene e, con l’appoggio di personalità di rilievo, riesce a fondarvi una scuola filosofica,
la ovvero il "portico pitturato", situato nel cuore di Atene e costellato dalle pitture
raffiguranti la battaglia di Maratona. Il fatto stesso che Zenone elegga a sede della propria scuola il cuore
pulsante della città già sottolinea una radicale differenza rispetto ad Epicuro e al suo Giardino: la filosofia
stoica, anziché chiudersi in se stessa e rivolgersi ad una ristretta cerchia di amici, intende diffondere il
proprio messaggio (non scevro da elementi politici) su ampia scala, tant’è che caratteristica portante dello
stoicismo è il cosmopolitismo. L’attività di Zenone non passò inosservata e, alla sua morte, fu emanato un
editto col quale egli era riconosciuto come modello di vita per gli Ateniesi. Lo stoicismo avrà lunga vita,
attraverserà tre fasi distinte (antico, medio e nuovo stoicismo) e, a differenza dell’epicureismo, troverà un
fertile terreno di diffusione anche a Roma: ciò si spiega anche col fatto che lo stoicismo può qualificarsi
come una filosofia in fieri, sempre soggetta a innovazioni e a mutamenti introdotti dai vari filosofi stoici. Il
corpo delle dottrine della scuola stoica è sì dogmatico, ma le teorie venivano discusse e modificate di autore
in autore: così Panezio di Rodi – che rese lo stoicismo funzionale alla civitas romana – rigetterà la dottrina
dell’ e attenuerà il rigorismo morale, ormai divenuto obsoleto. Data la struttura istituzionalizzata
della Stoà, le fonti ci trasmettono solo in parte teorie abbinate a personalità singole: per lo più parlano
genericamente di "Stoici", senza operare distinzioni e far nomi precisi. Il punto focale del pensiero stoico è la
nozione di , che è in primo luogo la "ragione" delle cose e, dunque, l’oggetto della fisica (che studia
appunto le cose che sono); ma è anche la "ragione" esplicitata nel ragionamento e, in quanto tale, è
oggetto della logica (che studia come le cose sono espresse e conosciute). Infine il , in quanto principio
di comportamento, sarà oggetto di studio dell’etica. Se per Epicuro sussisteva tra le varie parti della filosofia
un rapporto progressivo, per gli Stoici, al contrario, esse formano un tutto organico, cosicché essi possono
paragonare le varie parti ad un campo o ad un vivente o, ancora, ad un uovo. C’è chi sostiene che la filosofia
è un campo in cui il muro di cinta è dato dalla logica, la terra dalla fisica e i frutti dall’etica: sicchè la logica
esplica una funzione meramente difensiva, la fisica costituisce il "terreno" su cui seminare i frutti, che son
dati dall’etica (il che testimonia la sua indiscutibile preminenza). Per Crisippo di Soli, invece, l’egemonia
spetta non già all’etica, bensì alla fisica e, in particolare, alla teologia. Posidonio di Apamea rigetta
l’immagine della filosofia come un campo, poiché a suo avviso essa mal rivela il rapporto intercorrente tra le
parti: per lui, al contrario, la filosofia è un vivente, le cui ossa son date dalla logica, la carne dalla fisica e
l’anima dall’etica. Da quest’immagine ben emerge il rapporto inscindibile tra le parti in funzione del tutto,
benché l’etica (in quanto anima) sia in posizione di spicco. L’accento posto da Posidonio sull’importanza
della totalità organicamente connessa ci aiuta anche a capire perché la figura del sapiente stoicamente inteso
possegga tutto il sapere, non singole parti di esso: chi sa molto ma non tutto si trova per gli stoici sullo stesso
piano di chi non sa nulla, poiché chi è distante da Atene 5 km non è in Atene come chi da essa è distante
1000 km. Diventare sapienti in senso stoico è un traguardo umanamente irraggiungibile: i veri sapienti dicono gli stoici – sono più unici che rari; Seneca dice che il vero sapiente nasce – al pari della fenice – ogni
cinquecento anni e Crisippo sostiene che esso è raro quanto i parti di una mula. Del resto gli stoici si
ritenevano filosofi ma non sapienti. L’idea dell’inattuabilità della piena conoscenza è di matrice socratica
(pensiamo al Fedro), e gli Stoici non fanno che portarla all’ennesima potenza: la filosofia viene pertanto a
configurarsi come ricerca e amore di un sapere che mai può essere raggiunto. La fisica è, al pari di quella
logica che per Aristotele era soltanto un della scienza, è conoscenza causale della generazione delle
cose che sono. Gli Stoici distinguono – sulla scorta di Aristotele – tra "elementi" (i quattro elementi - aria,
acqua, terra, fuoco -, ovvero specificazioni della materia) e "principi" (Dio e la materia): tutte le cose
vengono ad essere perché formate dalla materia e da un principio divino, mentre gli elementi non sono se
non gli ingredienti materiali che compongono ogni cosa. Le cause che spiegano la costituzione delle cose
sono cause materiali (i quattro elementi già individuati da Empedocle), ma il dio stoico è causa razionale e
divina che – come il Demiurgo platonico – agisce direttamente sul reale, cosicché le cose non sono frutto del
caso: anche per gli Stoici, come già per Platone, questo è il migliore dei mondi possibili. In dio essi fanno
convergere le altre tre cause individuate da Aristotele: dio è causa efficiente, finale e formale del mondo, al
quale conferisce la miglior forma possibile agendo provvidenzialmente. La natura imperfetta di cui parlava
Aristotele agli Stoici non basta: a loro avviso, infatti, la natura è il volto rivelato di Dio e, in quanto tale, non
può che essere perfetta. Se per Platone dio e la materia restano due realtà assolutamente distinte (e anzi la
materia si oppone all’agire divino), gli stoici, sull’altro versante, sostengono che dio e materia non si
distinguono per la loro natura: essi sono entrambi corporei – dicono gli stoici -, poiché altrimenti non si
spiegherebbe l’intervento di dio sul mondo (solo un corpo può agire sul corporeo). Di qui scaturisce la
posizione materialistica e immanentistica degli stoici, ad avviso dei quali dio è presente nella realtà materiale
delle cose. La materia, che per Platone si configurava come recalcitrante a dio, è per gli stoici caratterizzata
dalla presenza di dio, per cui il mondo in cui viviamo non solo è il migliore tra i possibili, ma è anche
perfetto in maniera assoluta, giacché interamente padroneggiato da dio. Memori della terminologia
aristotelica, gli stoici chiamano "principio passivo" la materia e "principio attivo" dio: quest’ultimo – da
identificarsi col , ovvero con la ragione universale – agisce sulla materia e fa venire ad essere ogni
cosa; la prima azione da lui compiuta consiste, in particolare, nel trasformare la materia in qualcosa di
preciso e determinato, ossia nei quattro elementi (che sono appunto materia in un preciso stato). Gli stoici
qualificano la materia come "principio passivo" perché essa è tale da subire l’azione del principio attivo,
anch’esso corporeo. Tutte le cose saranno dunque materiali, unioni inscindibili di materia e forma: esse
avranno la forma migliore proprio perché dio interviene in esse dall’interno: in ciò consiste il panteismo
stoico. Il mondo che ne risulta è una totalità perfettamente compiuta e razionale, dove è giustificata perfino la
presenza del male: Crisippo asserisce che il rapporto bene/male è equivalente a quello luce/ombra: come non
si capirebbe che cosa è la luce se non vi fosse anche l’ombra, così non si capirebbe che cosa è il bene se non
vi fosse anche il male. Non è un caso che il principio divino ammesso dagli stoici sia unico: quelli che gli
uomini chiamano "dei" non sono che manifestazioni dell’unica divinità. Ben si capisce perché il vivere
virtuosamente sia l’uniformarsi alla ragione, che è nell’uomo una scintilla del universale: vivere
secondo virtù significa vivere secondo ragione, e vivere secondo ragione vuol dire vivere secondo natura,
poiché la natura è divina. Gli stoici assimilano dio ad un fuoco, a sottolineare la sua capacità di dare la vita
(solo ciò che è caldo può godere di tale capacità); in quanto dotato di vita, tale fuoco accoglie al proprio
interno un corpo capace di raffreddare: è quello che gli stoici chiamano , un corpo di natura
aeriforme (Seneca lo chiama spiritus) in grado di vivificare la materia conferendole forma e qualità (rende
cioè la materia secca, umida, ecc). Pertanto tutta la realtà è permeata da questo soffio caldo che dà la vita e,
proprio perché aeriforme, è presente ovunque nella realtà. In questo sistema, l’uomo occupa un posto
privilegiato, in quanto unico essere dotato per natura di ragione: sicchè egli è l’essere che più si avvicina alla
divinità, a tal punto che c’è tra loro parentela. Se Platone (Leggi, X) considerava l’uomo come minuscola
particella dell’universo, gli stoici, dal canto loro, asseriscono che "l’intero mondo è città di dio e degli
uomini" (Crisippo). Ma il mondo, in quanto nato, non è eterno: esso è corruttibile e, dunque, destinato a
perire, anche perché andrà incontro ad una conflagrazione universale () legata a quello stesso
fuoco che l’ha generato. Il mondo poi rinasce, giacchè si tratta di una vicenda ciclica, e il mondo nuovo
rinasce tale e quale quello perito (nel nuovo mondo vi sarà lo stesso Socrate, lo stesso Platone, ecc), poiché,
se rinascesse diverso, non sarebbe perfetto o perfetto non sarebbe stato quello precedente. La presenza del
assicura il , la tensione che tiene in equilibrio il mondo e le cose che lo costellano. In quanto
retto da questa tensione, il mondo è una sorta di gigantesco vivente dato dalla compresenza di un corpo e di
un’anima che lo tiene insieme (e per gli stoici l’anima è ). Ne segue dunque che il mondo è retto
nelle sue parti da simpatia (): le parti sono cioè connesse da un vincolo tale per cui, al
modificarsi di una parte, anche le altre si modificano. Ciò giustifica la divinazione, ossia la lettura del futuro
sulla base dei segni del presente: il fatto che dio ci lasci sapere in anticipo quel che accadrà non fa che
avvalorare la tesi che lo vuole buono. I filosofi che definiranno se stessi come Scettici non elaborano alcuna
filosofia della natura, poiché a loro avviso non c'é alcuna rappresentazione che non possa essere falsa,
cosicché, se il sapiente dà il suo assenso a una rappresentazione, opinerà; ma é proprio del sapiente non
opinare; dunque il sapiente sospenderà il suo assenso.
Corso tenuto presso l'Università di Torino dalla professoressa Luciana Repici nell'autunno 2003
INDIETRO