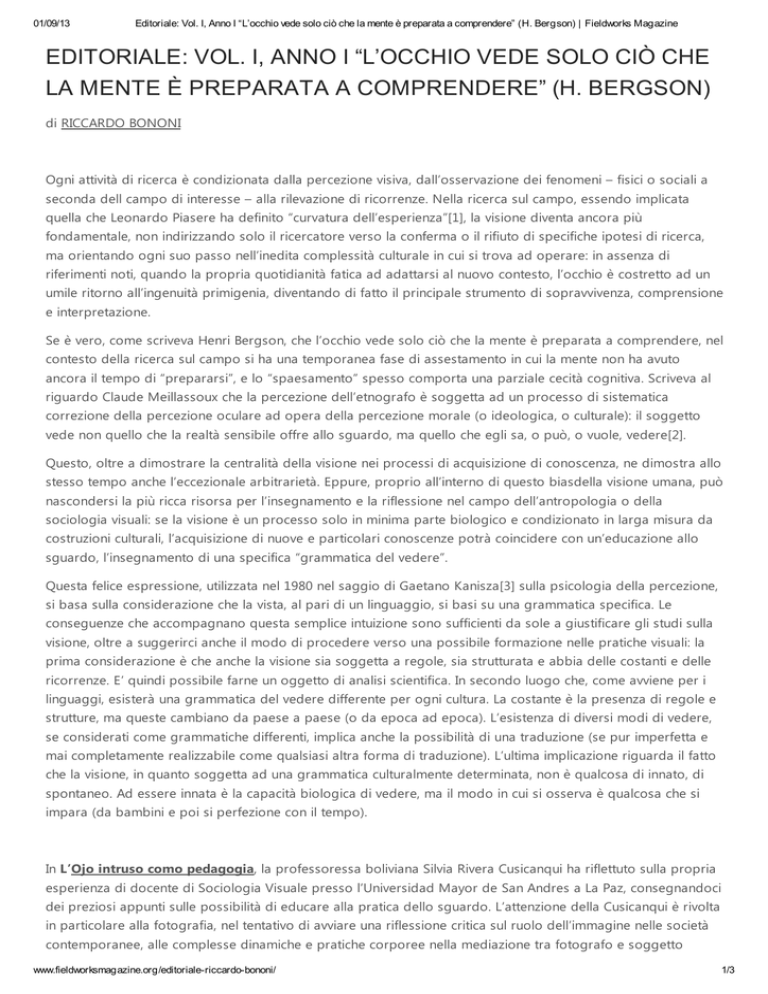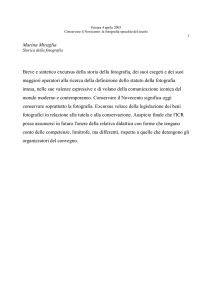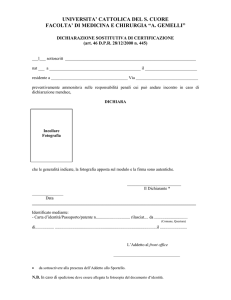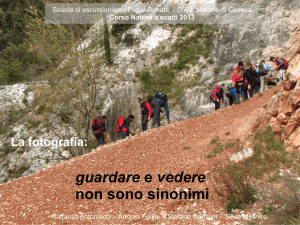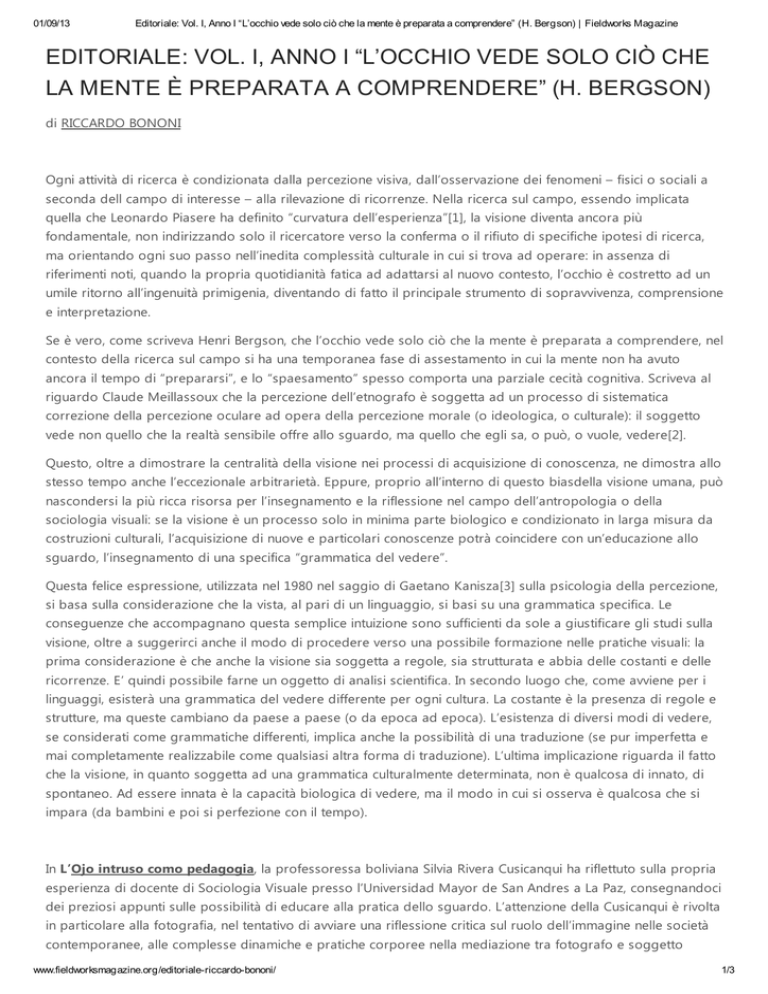
01/09/13
Editoriale: Vol. I, Anno I “L’occhio vede solo ciò che la mente è preparata a comprendere” (H. Bergson) | Fieldworks Magazine
EDITORIALE: VOL. I, ANNO I “L’OCCHIO VEDE SOLO CIÒ CHE
LA MENTE È PREPARATA A COMPRENDERE” (H. BERGSON)
di RICCARDO BONONI
Ogni attività di ricerca è condizionata dalla percezione visiva, dall’osservazione dei fenomeni – fisici o sociali a
seconda dell campo di interesse – alla rilevazione di ricorrenze. Nella ricerca sul campo, essendo implicata
quella che Leonardo Piasere ha definito “curvatura dell’esperienza”[1], la visione diventa ancora più
fondamentale, non indirizzando solo il ricercatore verso la conferma o il rifiuto di specifiche ipotesi di ricerca,
ma orientando ogni suo passo nell’inedita complessità culturale in cui si trova ad operare: in assenza di
riferimenti noti, quando la propria quotidianità fatica ad adattarsi al nuovo contesto, l’occhio è costretto ad un
umile ritorno all’ingenuità primigenia, diventando di fatto il principale strumento di sopravvivenza, comprensione
e interpretazione.
Se è vero, come scriveva Henri Bergson, che l’occhio vede solo ciò che la mente è preparata a comprendere, nel
contesto della ricerca sul campo si ha una temporanea fase di assestamento in cui la mente non ha avuto
ancora il tempo di “prepararsi”, e lo “spaesamento” spesso comporta una parziale cecità cognitiva. Scriveva al
riguardo Claude Meillassoux che la percezione dell’etnografo è soggetta ad un processo di sistematica
correzione della percezione oculare ad opera della percezione morale (o ideologica, o culturale): il soggetto
vede non quello che la realtà sensibile offre allo sguardo, ma quello che egli sa, o può, o vuole, vedere[2].
Questo, oltre a dimostrare la centralità della visione nei processi di acquisizione di conoscenza, ne dimostra allo
stesso tempo anche l’eccezionale arbitrarietà. Eppure, proprio all’interno di questo biasdella visione umana, può
nascondersi la più ricca risorsa per l’insegnamento e la riflessione nel campo dell’antropologia o della
sociologia visuali: se la visione è un processo solo in minima parte biologico e condizionato in larga misura da
costruzioni culturali, l’acquisizione di nuove e particolari conoscenze potrà coincidere con un’educazione allo
sguardo, l’insegnamento di una specifica “grammatica del vedere”.
Questa felice espressione, utilizzata nel 1980 nel saggio di Gaetano Kanisza[3] sulla psicologia della percezione,
si basa sulla considerazione che la vista, al pari di un linguaggio, si basi su una grammatica specifica. Le
conseguenze che accompagnano questa semplice intuizione sono sufficienti da sole a giustificare gli studi sulla
visione, oltre a suggerirci anche il modo di procedere verso una possibile formazione nelle pratiche visuali: la
prima considerazione è che anche la visione sia soggetta a regole, sia strutturata e abbia delle costanti e delle
ricorrenze. E’ quindi possibile farne un oggetto di analisi scientifica. In secondo luogo che, come avviene per i
linguaggi, esisterà una grammatica del vedere differente per ogni cultura. La costante è la presenza di regole e
strutture, ma queste cambiano da paese a paese (o da epoca ad epoca). L’esistenza di diversi modi di vedere,
se considerati come grammatiche differenti, implica anche la possibilità di una traduzione (se pur imperfetta e
mai completamente realizzabile come qualsiasi altra forma di traduzione). L’ultima implicazione riguarda il fatto
che la visione, in quanto soggetta ad una grammatica culturalmente determinata, non è qualcosa di innato, di
spontaneo. Ad essere innata è la capacità biologica di vedere, ma il modo in cui si osserva è qualcosa che si
impara (da bambini e poi si perfezione con il tempo).
In L’Ojo intruso como pedagogia, la professoressa boliviana Silvia Rivera Cusicanqui ha riflettuto sulla propria
esperienza di docente di Sociologia Visuale presso l’Universidad Mayor de San Andres a La Paz, consegnandoci
dei preziosi appunti sulle possibilità di educare alla pratica dello sguardo. L’attenzione della Cusicanqui è rivolta
in particolare alla fotografia, nel tentativo di avviare una riflessione critica sul ruolo dell’immagine nelle società
contemporanee, alle complesse dinamiche e pratiche corporee nella mediazione tra fotografo e soggetto
www.fieldworksmagazine.org/editoriale-riccardo-bononi/
1/3
01/09/13
Editoriale: Vol. I, Anno I “L’occhio vede solo ciò che la mente è preparata a comprendere” (H. Bergson) | Fieldworks Magazine
ritratto, nel tentativo di andare al di là della semplice testimonianza o della mera sperimentazione estetica.
Sull’arbitrarietà della fotografia si pone anche la riflessione di Viviana Bosello in Raccontare la guerra
attraverso la fotografia: l’estetica del conflitto nella fotografia di reportage, in cui vengono analizzati gli
scatti di tre grandi fotografi di guerra: David C. Turnley, Ivo Saglietti e Lars Lindqvist. L’analisi cerca di portare a
galla una tendenza, diffusa in ogni pratica fotografica, di raccontare il mondo secondo strategie visive
specifiche: esisteranno quindi guerre raccontate dalle immagini degli scontri, dai soldati o dalle vittime. Altri
conflitti invece raggiungono l’immaginario collettivo attraverso le immagini delle conseguenze, i profili dei
palazzi sventrati, i profughi, la povertà. Alcune guerre sono rappresentate dagli sguardi provati degli anziani,
altre ancora dalle vittime più indifese, i bambini.
Proprio un fotografo di reportage aprirà la nostra sezione dedicata ai saggi fotografici: Alessandro Rampazzo,
con Egitto, la guerra è il proseguimento della politica con altri mezzi, ci racconta attraverso i suoi scatti una
visione e un’interpretazione inedita sulla storia recente della politica egiziana. L’intenzione di fondo è chiara sin
dalle parole di Von Clausewitz richiamate dal titolo, l’esistenza, cioè, di una continuità di fondo tra la politica e la
guerra, tra i tempi di pace e quelli degli scontri o, nel caso specifico egiziano, tra l’espressione di preferenza
espressa nei seggi elettorali e quella urlata invece nelle piazze del Cairo: due forme tra loro non totalmente
discrete di partecipazione attiva alla vita politica da parte dei cittadini egiziani, caratterizzate a fasi alterne da
moti di iconofilia e di iconoclastia.
Se i saggi precedenti introducono e criticizzano usi specifici della fotografia (la pedagogia e la ricerca nel
campo della sociologia visuale, la fotografia di guerra e il photoreportage), sfatando il mito di un medium
fotografico “neutrale”, con La fotografia come mezzo di conoscenza ed interpretazione del mondo:
intervista a Francesco Cito (di Riccardo Bononi), si comincia ad indagare invece la figura del fotografo,
dell’occhio dietro alla macchina fotografica. La video-intervista ad uno dei più grandi protagonisti del fotogiornalismo italiano è illuminante soprattutto per quanto riguarda il prodotto fotografico, che viene ridotto
nell’esperienza di Francesco Cito “alla parte meno importante di tutto il processo fotografico”, composto
principalmente dalla curiosità verso il mondo, dall’osservazione, dall’interazione partecipativa con i soggetti che
si intendono ritrarre e, soprattutto, dalla comprensione dei fenomeni che il fotografo si trova a dover
interpretare ben prima di cominciare a scattare la prima fotografia. L’esperienza fotografica è quindi descritta
dalle vivide parole del fotografo come “un processo di conoscenza”, del quale allo spettatore comune non
giunge altro che una minima parte.
Notevolmente più introspettivo è invece l’approccio del fotografo montenegrino Andrija Lekic, intervistato dalla
prof.ssa Francesca Bottacin in La fotografia post-strutturalista: Londra, Parigi e il Giappone dopo
Fukushima: anche per Lekic la fotografia è un processo di conoscenza ma, a causa dell’autoreferenzialità che
ogni autorialità comporta, la fotografia racconta prima di ogni altra cosa il fotografo, la sua percezione e
particolare interpretazione del mondo. L’atto stesso di fotografare è un modo quindi per comprendere meglio
se stessi. La fotografia di Andrija Lekic, intesa da Francesca Bottacin come una forma d’arte, è stata quindi
analizzata cercando di comprendere come una coerenza di fondo tra forma e sostanza convivano in scatti
apparentemente molto diversi, dalla devastazione dei paesaggi giapponesi post-Fukushima alla desolazione del
paesaggio (questa volta umano) dei clochard parigini.
La doppia funzione della fotografia, intesa come traccia fisica o documento riguardante i soggetti ritratti, ma
anche come testimonianza della cultura di appartenenza e delle intenzioni di chi ha scattato le fotografie, è
indagata da Vera Osgnach in Il ritratto come maschera: le immagini storiche del Kenya dall’Archivio
Fotografico dei missionari della Consolata: grazie alla raccolta di scatti effettuati in Kenya da Filippo Perlo tra
il 1902 e il 1925 sono descritti i radicali mutamenti avvenuti nel Paese in seguito all’arrivo dei primi missionari. La
fotografia in questo caso non è semplice testimonianza del cambiamento, ma ne è addirittura un mezzo: le
pose, i ritratti, l’uso didascalico della fotografia prevalentemente a scopo di educazione religiosa o di prova dei
progressi ottenuti da restituire in patria, rappresentano una serie di meccanismi di addomesticamento delle
www.fieldworksmagazine.org/editoriale-riccardo-bononi/
2/3
01/09/13
Editoriale: Vol. I, Anno I “L’occhio vede solo ciò che la mente è preparata a comprendere” (H. Bergson) | Fieldworks Magazine
pratiche corporee da parte del potere coloniale, una forma di ritratto (che ricorda da vicino quello di Dorian
Gray) in cui i kenyioti, considerati personaggi più che esseri umani, vengono fatti sempre più assomigliare nella
propria quotidianità a quelle maschere vuote in posa di fronte alla macchina fotografica. Una parte consistente
del corpus fotografico messo a disposizione dall’archivio storico dei Missionari della Consolata, e pubblicato
qui per la prima volta in Kenya 1902 – 1925: diario di un’evangelizzazione nelle foto di Filippo Perlo,
costituirà anche il materiale del secondo photo-essay della rivista, una sorta di diario visuale
dell’incontro/scontro storico tra due culture agli antipodi.
Con La Senso-poiesi nell’istituzione totalizzante: esperienza di campo in una casa circondariale
italiana Valentina Rizzo ha condiviso una parte del proprio percorso di ricerca lavorando con i giovani detenuti,
in particolare concentrandosi sulle sfumature che il termine “percepire” assume in un contesto chiuso ed
autoreferenziale come quello carcerario. Vedere, ascoltare, toccare assumono all’interno del carcere delle
valenze del tutto particolari, assumendo le sfumature proprie della monotonia, della coercizione e della
privazione. Il ruolo centrale dei sensi nella costruzione identitaria di un individuo fa sì che l’identità del detenuto
sia costruita per difetto, con un processo sottrattivo: in condizioni di prigionia, ad esempio, non si impara a
vedere il mondo diversamente, ma si impara a vederlo meno, contestualmente ad una prograssiva chiusura
delle architetture cosiddette “totalizzanti”.
Con l’ultimo articolo di questo primo numero dedicato al visuale, Note sul genere documentario: la realtà è
talmente inverosimile che per renderla verosimile è necessario mescolarla a qualche menzogna, Toni
Andreetta (docente di Teoria e pratica del documentario presso l’Università di Padova) introduce sezione della
rivista, quella dedicata al materiale audiovisivo, alle video-interviste e ai documentari: attraverso un’analisi
storica del genere documentario è rappresentato uno dei suoi caratteri più centrali (e ancora maggiormente
quando esiste un carattere di scientificità, come nel caso del documentario etnografico), il rapporto con la
verosimiglianza dei contenuti e l’artificialità che ogni forma espressiva possiede.
Il primo documentario presentato dalla rivista è un ottimo esempio di storia vera, girata con l’intima
partecipazione e il coinvolgimento attivo del videomaker, ma caratterizzato da un approccio stilistico e
interpretativo personalissimo: in Filioque di Enrico Mazzi, mentre le riprese “naturali” della steadycam spingono
ad immedesimarsi con i personaggi e le situazioni, l’autore è sempre presente, ricordandoci che anche il
documentario più realistico è in fondo una finzione narrativa frutto di continue scelte personali. Enrico Mazzi ha
inseguito la propria viva curiosità per raccontarci la storia della “generazione perduta” serba, cresciuta tra le
guerre e il conflitto con i genitori: se i padri hanno sviluppato un convinto ateismo con il socialismo di Tito, i figli
riscoprono ora la religione ortodossa, spinti da un crescente nazionalismo romantico. Ne deriva un contrasto
generazionale (opposto a quello che ha ad esempio caratterizzato l’Italia del dopoguerra) in cui i figli scappano
di casa, dai propri genitori “senza Dio”, per prendere i voti.
NOTE
[1] Piasere parla di curvatura dell’esperienza in riferimento al viaggio nella pratica etnografica, il progressivo
allontanamento da sistemi di riferimento noti che consente il distacco necessario ad un’analisi dall’“esterno”. In:
Leonardo Piasere, L’etnografo imperfetto, 2002 Laterza.
[2] Claude Melliassuox, “La vita dei mostri. Le immagini dell’Altro nella letteratura antropologica”, in: Ugo Fabietti
(a cura di), Il sapere dell’antropologia. Pensare, comprendere, descrivere l’Altro, 1993 Mursia, pp. 114-115.
[3] Gaetano Kanizsa, Grammatica del Vedere. Saggi su percezione e gestalt, 1980 il Mulino.
www.fieldworksmagazine.org/editoriale-riccardo-bononi/
3/3