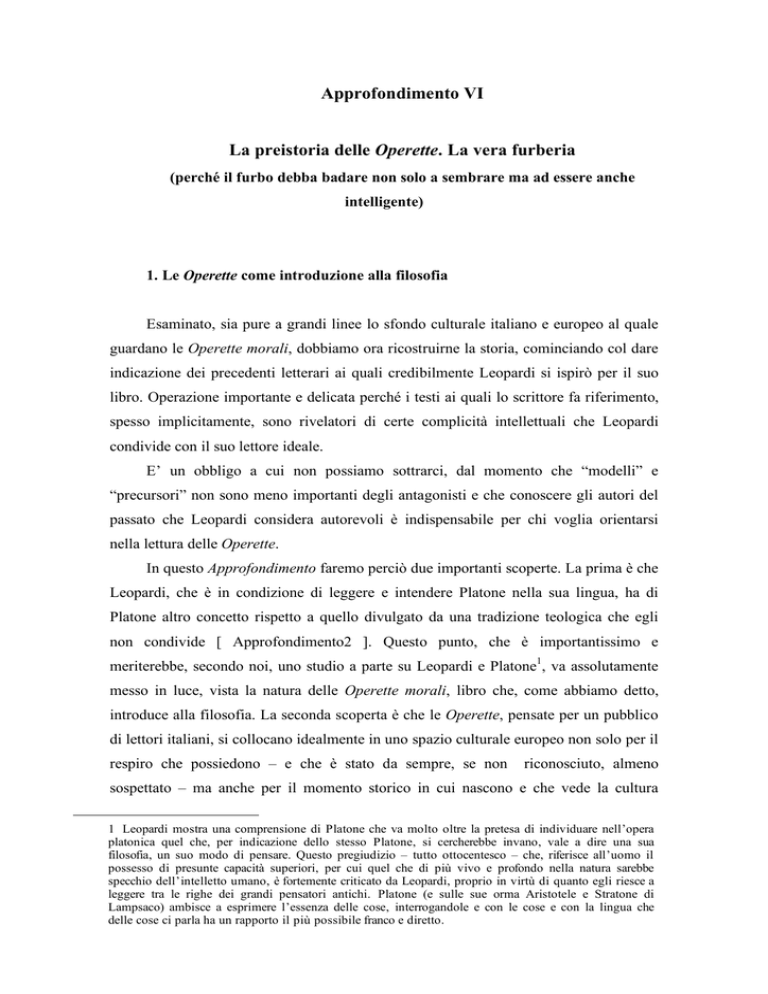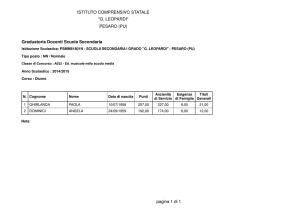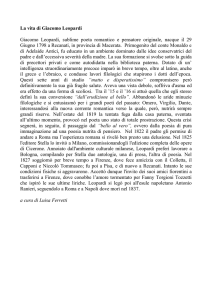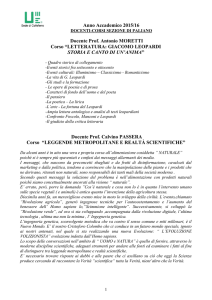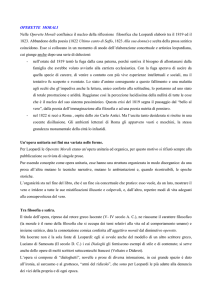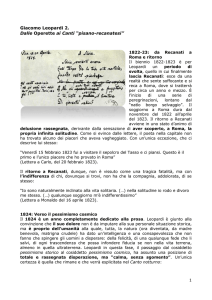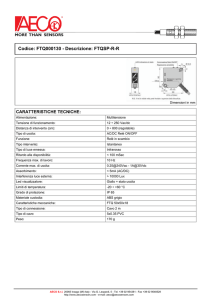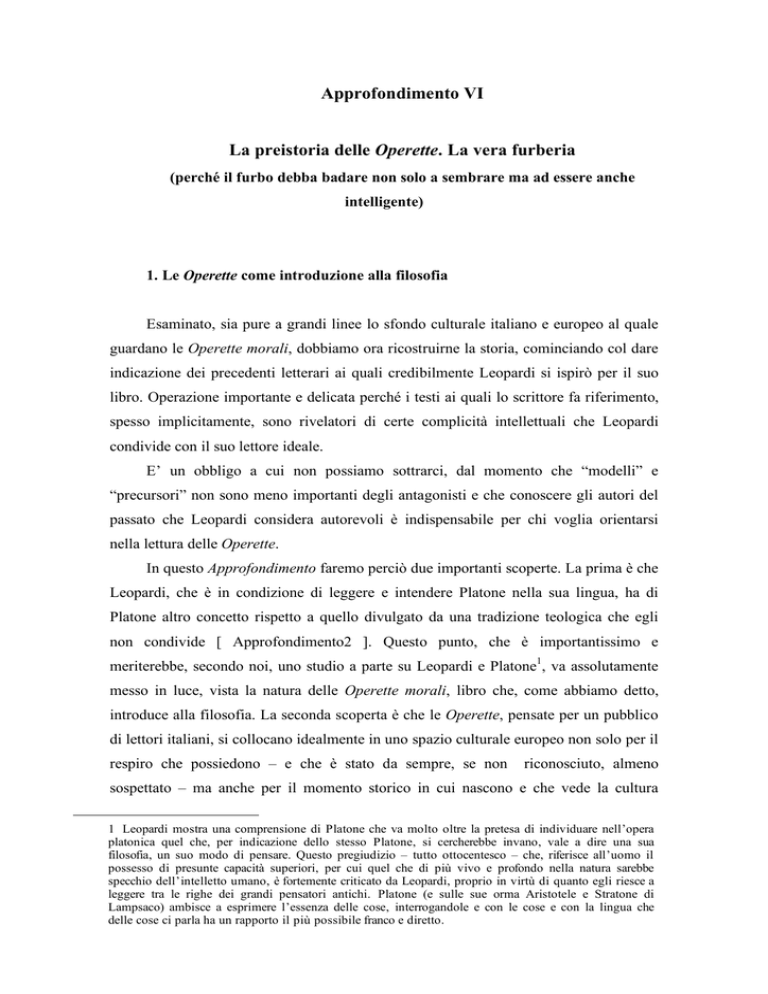
Approfondimento VI
La preistoria delle Operette. La vera furberia
(perché il furbo debba badare non solo a sembrare ma ad essere anche
intelligente)
1. Le Operette come introduzione alla filosofia
Esaminato, sia pure a grandi linee lo sfondo culturale italiano e europeo al quale
guardano le Operette morali, dobbiamo ora ricostruirne la storia, cominciando col dare
indicazione dei precedenti letterari ai quali credibilmente Leopardi si ispirò per il suo
libro. Operazione importante e delicata perché i testi ai quali lo scrittore fa riferimento,
spesso implicitamente, sono rivelatori di certe complicità intellettuali che Leopardi
condivide con il suo lettore ideale.
E’ un obbligo a cui non possiamo sottrarci, dal momento che “modelli” e
“precursori” non sono meno importanti degli antagonisti e che conoscere gli autori del
passato che Leopardi considera autorevoli è indispensabile per chi voglia orientarsi
nella lettura delle Operette.
In questo Approfondimento faremo perciò due importanti scoperte. La prima è che
Leopardi, che è in condizione di leggere e intendere Platone nella sua lingua, ha di
Platone altro concetto rispetto a quello divulgato da una tradizione teologica che egli
non condivide [ Approfondimento2 ]. Questo punto, che è importantissimo e
meriterebbe, secondo noi, uno studio a parte su Leopardi e Platone1, va assolutamente
messo in luce, vista la natura delle Operette morali, libro che, come abbiamo detto,
introduce alla filosofia. La seconda scoperta è che le Operette, pensate per un pubblico
di lettori italiani, si collocano idealmente in uno spazio culturale europeo non solo per il
respiro che possiedono – e che è stato da sempre, se non
riconosciuto, almeno
sospettato – ma anche per il momento storico in cui nascono e che vede la cultura
1 Leopardi mostra una comprensione di Platone che va molto oltre la pretesa di individuare nell’opera
platonica quel che, per indicazione dello stesso Platone, si cercherebbe invano, vale a dire una sua
filosofia, un suo modo di pensare. Questo pregiudizio – tutto ottocentesco – che, riferisce all’uomo il
possesso di presunte capacità superiori, per cui quel che di più vivo e profondo nella natura sarebbe
specchio dell’intelletto umano, è fortemente criticato da Leopardi, proprio in virtù di quanto egli riesce a
leggere tra le righe dei grandi pensatori antichi. Platone (e sulle sue orma Aristotele e Stratone di
Lampsaco) ambisce a esprimere l’essenza delle cose, interrogandole e con le cose e con la lingua che
delle cose ci parla ha un rapporto il più possibile franco e diretto.
italiana al centro di una critica che il romanticismo rivolge a quanto sa di accademia e
che trova in Italia la sua culla. Ci riferiamo all’archeologia, alle grandi raccolte d’arte
dei privati, nonché alla tradizione umanistica, le cui espressioni artistiche e letterarie
vengono tacciate di cortigianeria. Ci riferiamo al rischio, per la verità ancora lontano in
quei tempi del venir meno del viaggio di studio in Italia, meta oggi desiderata sempre
più per il clima che non per i suoi tesori culturali. Anche di qui gli evidenti rimandi a
tutto un complesso di opere e di autori, specialmente francesi e inglesi, che Leopardi
evidentemente conosce assai bene e che della cultura umanistica avevano saputo far
tesoro.
Di tutto questo gli Italiani potranno rendersi più facilmente conto se qualcuno darà
loro gli strumenti necessari ad avviare un discorso critico sulla loro storia, sul loro
presente, sulla loro cultura. Questo è l’ufficio della filosofia e a questo ufficio Leopardi
cerca di dar forma.
2. Quel che il lettore deve sapere
In una lettera al Giordani del 4 settembre 1820 Leopardi accenna a “certe prosette
satiriche” nelle quali alcuni commentatori, fra i quali Natalino Sapegno, Ugo Dotti e
Gino Tellini, hanno voluto vedere “l’antefatto” delle Operette morali2. Sebbene sia da
ritenere assai complesso l’iter della gestazione dell’opera, quelle “prosette satiriche”
sono certamente importanti, in quanto sicuramente anticipano alcuni aspetti del
capolavoro leopardiano, nel quale, come spesso succede per i capolavori, vanno
idealmente a confluire le esperienze precedenti che appaiono preparatorie all’opera
maggiore.
E’ in effetti più che sensato interrogarsi sulla gestazione delle Operette morali
che, per il respiro, il metodo e le strategie comunicative, non possono essere considerate
altro che un frutto maturo, parte desunto da modelli precedenti, parte da insuccessi
altrui, parte però anche risultato di esperienze fatte dallo stesso scrittore. E in questo
caso noi risaliremmo ancora più indietro rispetto alle “prosette satiriche”, fino a riferirci,
se non a tutte, ad alcune almeno delle Dissertazioni filosofiche scritte da Leopardi sulla
soglia dell’adolescenza. Tra queste ci pare doveroso ricordare la Dissertazione sopra
2 . Cfr. U. Dotti, Lo sguardo sul mondo, Laterza, Bari 1995, pp. 7-8; G. Tellini, Leopardi, op. cit. pp.
136-144.
l’anima delle bestie e la Dissertazione sopra la Felicità. A cui aggiungiamo il Dialogo
sopra un moderno libro intitolato “Analisi delle idee ad uso della gioventù”, che ci pare
preannunci alla lontana il Dialogo del Galantuomo e del Mondo, che i critici pongono a
margine delle Operette.
Le giovanili Dissertazioni filosofiche sono brevi prose, niente affatto satiriche,
risalenti agli anni compresi tra il 1811 e il ’12, dalla cui lettura emerge però il dato di
una viva attenzione che il giovanissimo scrittore aveva già rivolto ad alcune questioni:
se veramente l’uomo debba considerarsi migliore degli altri esseri viventi; se sia più di
loro felice; se egli possa ricavare qualche utile dal progresso civile e culturale.
E’ certo comunque che, rispetto a queste primissime prove, senz’altro interessanti
per gli studiosi, le Operette si caratterizzano per un’assai più matura riflessione che, alla
luce degli studi condotti, Leopardi è in condizione di proporre al suo lettore nel pieno di
una conseguita maturità intellettuale. I classici, a cominciare proprio dai classici del
pensiero filosofico, sono ormai da lui assorbiti e di Cicerone, di Agostino, di Tommaso
d’Aquino, citato nelle Operette per un aneddoto che lo riguarda, Leopardi non sente
neanche più il bisogno di parlare. Lo scrittore è ormai in grado di stabilire delle
complicità intellettuali con il suo lettore ed è nella condizione di chiedergli, quando il
lettore voglia intender bene ciò che lui ha da dirgli, di andare alle fonti, che sono
innanzitutto Platone, Aristotele, Luciano, Teofrasto, Senofonte, Sallustio, Virgilio,
Locke, Cartesio e, tra i moderni, la folta schiera degli Enciclopedisti. Sicché, come
vedremo, ci sono nel Leopardi delle Operette dei silenzi estremamente significativi, che
in parte giustificano l’indicazione da lui stesso data circa la vena ironico-satirica della
sua opera, in parte sorvolano su ciò che bisogna conoscere. Ed è questo il punto più
difficile per il lettore d’oggi perché nel frattempo sono intervenute non poche modifiche
rispetto a quello che all’epoca di Leopardi costituiva il necessario bagaglio di
conoscenze per chi volesse occuparsi di questioni filosofiche.
Cominceremo perciò col dare alcune indicazioni circa quegli aspetti che più
immediatamente pongono la filosofia leopardiana in relazione con tradizioni precedenti
a cui Leopardi si riconduce nelle Operette.
3. Il platonismo leopardiano
Partendo, come è giusto che sia da titolo del libro di Leopardi, va detto che già
prima di lui, diversi altri autori avevano raccolto alcune loro prose sotto il titolo di
Operette morali. Si tratta di riflessioni attorno a vari temi. Può anzi dirsi che quello
delle “operette morali” era stato un genere di trattatistica filosofica piuttosto fortunato. I
più noti, tra coloro che con questo genere s’erano in passato cimentati, erano stati
Pandolfo Collenuccio (1444-1504), Girolamo Muzio (1496-1576), Giambattista Gelli
(1498-1563), Scipione Ammirato (1531-1601) e va detto che sotto il titolo di Operette
morali si leggevano all’epoca di Leopardi anche scritti di Seneca e di Plutarco, per
tacere di non poche Operette morali e religiose che risultano essere state scritte da una
molteplicità di autori nel corso del Sei e Settecento.
Ignorando queste ultime e tralasciando i classici antichi, si tratta per lo più di
scritti che appartengono all’età del Rinascimento. Sotto il titolo generico di operette
morali, si raccolgono pensieri, discorsi e dialoghi dedicati prevalentemente (ma non
esclusivamente) al tema dell’amore platonico. Questo tema non è estraneo alla
sensibilità leopardiana e senz’altro si incontra con il tema dell’amicizia e di quel tipo di
affinità spirituale che unisce l’allievo al maestro. Molti dei dialoghi delle Operette
vedono interloquire tra loro maestri e allievi, dove il maestro può anche essere un
fantasma, che, opportunamente rievocato dal passato, interviene in soccorso a un
discepolo in un momento di smarrimento intellettuale. In questo senso le leopardiane
Operette morali non escono dal solco della tradizione, ma, almeno secondo quanto a noi
pare, la interpretano.
Per Leopardi il maestro è platonicamente un punto di luce. Questa luce, talvolta
resa fioca per la distanza temporale, acquista peraltro una particolare vivezza man mano
che, interrogando meglio il passato, si intende la lezione che dai vari Copernico, Tasso e
Parini e, per loro tramite, dai grandi pensatori del mondo antico tra i quali Platone
occupa sicuramente un posto di primissimo piano.
Abbiamo parlato delle ombre, dei fantasmi che popolano questi dialoghi
leopardiani, simili a ben guardare alle Nuvole di Aristofane. Essi sono un po’ come le
idee socratiche, intese secondo un garbato distacco, in un modo che consente di mutare
in auto-ironia l’ironia socratica. Qui va pure fatto presente che la cultura filosofica di
Leopardi si uniforma ai criteri interpretativi dettati dagli “ideologi” francesi, che sulle
idee hanno creato teorie a cui si riconducono tutti i maggiori pensatori del primo
Ottocento. Ora per gli “ideologi” le idee hanno una loro precisa connotazione. Tanto per
cominciare esse costituiscono lo scenario nel quale si muove la mente umana.
Comunque ciò accada, è innegabile che alla nostra considerazione si presentino come
irrinunciabili e imprescindibili alcune idee a cui la mente si vincola più che a qualsiasi
impressione possa al momento suscitarne e risvegliarne la curiosità. Il passato insomma
ha una sua evidenza e come memoria, ricordo, rimembranza è ombra presente.
Leopardianamente è per lo più dolore, il piacere essendo qualcosa che precariamente
interrompe uno stato di pena o di indifferenza.
Si aggiunga che Leopardi, ateo per quanto lo si voglia intendere, è un ateo
particolare che crede nell’anima. Comunque la si intenda, materiale o immateriale,
mortale o immortale, l’anima è qualcosa che Leopardi sente. Questo ne fa un platonico
che, ascoltando le voci di una saggezza antica, si interroga sul senso di parole – idee che
vengono da un remoto passato. I testimoni di questo passato sono gli autori dei libri che
leggiamo, i portatori di idee che regolano la nostra vita attuale.
Si dirà che questo è un platonismo atipico, diverso da quel che comunemente si
intende per platonismo. E’ vero, del resto, più che non sulla Repubblica o sul Timeo, il
platonismo leopardiano sembra poggiare su altri dialoghi platonici, a cominciare dal
Simposio e dal Fedro, per arrivare al Teeteto. A questo proposito appare veramente
strano come non sia stata colta la relazione di un luogo peraltro citatissimo dello
Zibaldone con una passo non meno noto del Teeteto. Ci riferiamo al celebre passo nel
quale Leopardi sostiene che “chi non ha o non ha mai avuto immaginazione,
sentimento, capacità di entusiasmo, di eroismo, d’illusioni vive e grandi, di forti e varie
passioni, chi non conosce l’immenso sistema del bello, chi non legge o non sente, o non
ha mai letto o sentito i poeti, non può assolutamente essere un grande, vero e perfetto
filosofo”3. Ai nostri occhi questo passo riecheggia, magari rielaborandolo, quella battuta
con cui Socrate, rivolgendosi a Teeteto gli rivela: “…è proprio del filosofo questo che tu
provi, di esser pieno di meraviglia; né altro cominciamento ha il filosofare che
questo…”4.
Ci pare ovvio che l’immaginazione, il sentimento, la capacità di entusiasmo e tutte
le qualità che nel dialogo platonico emergono come caratteristiche del personaggio di
Teeteto, concorrano a creare uno stato d’animo in cui la meraviglia, la sorpresa, lo
stupore, inducono nel filosofo quelle domande che, esigendo una risposta, danno inizio
a una ricerca che ha l’aspetto di una caccia alla verità, nella quale l’opportunità che
concretamente si offre è, leopardianamente, mettere a nudo qualche menzogna.
Il punto veramente interessante è che, anticipando in parte teorie di là da venire,
3 . Zibaldone [1833]
4 . Platone, Teeteto [155 d]
Leopardi non intende per platonismo una codificata teoria filosofica, fondata magari su
un sistema che poggia sul mondo iperuranio, modello del mondo delle cose sensibili,
quanto piuttosto un sistema di ricerca che poggia sul dialogo e sull’arte dialettica. Ma è
questo un punto su cui torneremo più avanti, quando avremo occasione di parlare di
Leopardi lettore degli antichi, che agli antichi si rivolge leggendoli dai testi originali e
senza il filtro di interpretazioni date da altri. Per il momento ci sembra opportuno
richiamare alcuni passi delle Operette da cui emerge in che senso le idee – ombre che
abitano le pagine dell’opera leopardiana possano riportarci a Platone, il quale oltre a
essere filosofo, fu anche scrittore e, da scrittore, seppe far rivivere personaggi da tempo
scomparsi e celebri nella loro epoca.
4. Aspetti letterari marginali al platonismo leopardiano
Abbiamo già parlato del tono particolarmente suadente di alcuni dialoghi
leopardiani dicendo che “gli interlocutori di questi dialoghi, i personaggi di Leopardi,
spesso dotati di grande fantasia, parlano come padri premurosi verso i loro figli e, nella
veste di figli, interrogano i padri per sapere”. Aggiungiamo che i “padri” (con ciò
intendendo le figure che, come all’inizio osservavamo, si pongono con atteggiamento
paterno) spesso rispondono con una naturalezza che rasenta l’ingenuità, come Colombo
che non ritiene di dover nascondere a Gutierrez i propri dubbi circa l’esito del viaggio
intrapreso per raggiungere le Indie passando l’Oceano Pacifico. E’ questo un tratto che
accomuna, sul piano dell’espressione letteraria i dialoghi di Leopardi a quelli di Platone.
Il Socrate di Platone ha spesso come una sollecitudine affettuosa nei confronti dei
discepoli e degli amici, specie quando ad essi partecipa alcune sue emozioni.
Narrativamente il Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez è veramente
bello. Il lettore conosce già la fine della storia e sa che l’America verrà scoperta, ma è
invitato a riflettere su come in realtà vanno certe cose. I due grandi uomini, alla vigilia
di un evento che cambia la storia, rivelano con filosofica serenità come nulla di grande e
di importante possa farsi a questo mondo, senza affrontare incertezze e rischi, “di modo
che” Colombo “in sostanza ha posto la sua vita e quella dei suoi compagni, in sul
fondamento di una semplice opinione speculativa”, come insinua, con anglosassone
flemma, il buon Gutierrez5.
Invece di rispondere che no, Colombo ammette di fronte a questa conclusioneinsinuazione di Gutierrez, suo secondo, la sua apparente leggerezza, ma pone con
franchezza lo stesso Gutierrez di fronte all’alternativa che sarebbe per tutti loro derivata
se Colombo non si fosse affidato alla sua “opinione speculativa” o come oggi diremmo
a una sua certa teoria e dice solennemente:
Se al presente tu, ed io, e tutti i nostri compagni, non fossimo in su queste navi, in mezzo di questo
mare, in questa solitudine incognita, in istato incerto e rischioso quanto si voglia; in quale altra
condizione di vita ci troveremmo essere? In che saremmo occupati? In che modo passeremmo questi
giorni? Forse più lietamente? O non saremmo in qualche maggior travaglio o sollecitudine, ovvero pieni
di noia? Che vuol dire uno stato libero da incertezza e pericolo? Se contento e felice, quello è da preferire
a qualunque altro, se tedioso e misero, non veggo a quale altro stato non sia da posporre. Io non voglio
ricordare la gloria e l’utilità che porteremo, succedendo l’impresa conforme alla speranza. Quando altro
frutto non ci venga da questa navigazione, a me pare che ella ci sia profittevolissima in quanto che per un
tempo essa ci tiene liberi dalla noia, ci fa cara la vita, ci fa pregevoli molte cose che altrimenti non
avremmo in considerazione6.
Qui apriamo una parentesi che ci pare comunque doverosa. Noi, diversamente da
Leopardi, andiamo al cinema. Ora, l’essere spettatori abituali di spettacoli
cinematografici ci fa d’intuito pensare come impossibile, cinematograficamente
parlando, un dialogo del genere tra Colombo e Gutierrez sulla tolda della nave, mentre
l’equipaggio che cova la ribellione contro il capo, riposa sotto coperta. Il fatto, a
pensarci meglio, è che il cinema troppo presto si è piegato ad offrire agli spettatori una
realtà scontata invece che riflessa e ha perciò imposto l’immagine (retorica) dell’eroe
che è sistematicamente solo di fronte alla grandezza dell’impresa da compiere. Da
questo punto di vista il cinema, specie quello d’azione, poco ci ha insegnato circa la
psicologia di certi personaggi che, come i grandi esploratori e navigatori, vissero
d’avventura. Sicché potrebbe sembrare al lettore d’oggi che il dialogo manchi di
realismo. In realtà che il capitano metta a parte delle sue verità il suo secondo è da
sempre una regola d’oro della navigazione. E il secondo, che trovi un capitano del
genere, deve considerarsi fortunato, perché non ha altro che da apprendere da lui. Da
questo punto di vista la scena, chiudendo la parentesi che abbiamo voluto aprire,
potrebbe cinematograficamente caricarsi di una ironica levità nei confronti
dell’equipaggio che solo alla vigilia della fine ha scoperto di avere corso il rischio di
inseguire
le
chimere
del
capitano.
Quanto
a
Gutierrez,
ne
uscirebbe
cinematograficamente un tipo freddo alla David Niven, disposto a capire per
autocontrollo più di quel che un essere umano sia disposto normalmente a capire.
5 . O. M., Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
6 . Ivi.
D’altro canto, non ha alternative, sapendo a quali rischi lo esporrebbe un difficile, lungo
estenuante viaggio di ritorno, con la difficoltà di spiegare al re di Spagna le ragioni
dell’insuccesso.
Cinema a parte, resta lo spunto narrativo con cui i personaggi – fantasmi abitano,
come Colombo e Gutierrez in un indefinito spazio tempo, pacatamente ragionando di
cose assai gravi nel buio di una notte in cui la caravella solca il pelo dell’acqua scura di
un Oceano di cui essi non conoscono neanche la profondità.
5. La paideia
Chiusa dunque questa parentesi e tornando al platonismo leopardiano, va
osservato che, una volta che si sia usciti dalla metafora marinaresca, si intende che il
rapporto tra Colombo e Gutierrez è sostanzialmente il rapporto il tra maestro e l’allievo.
Si capisce che l’ideale platonico della paideia è rispettato nel senso che quando l’allievo
giunge a capire, qualunque cosa capisca, il maestro deve rispettare quello che è il sapere
che l’altro ha guadagnato o sta per guadagnare. E’ quello il momento magico,
filosoficamente parlando, del dialogo. E’ in quel punto che l’allievo fa lo sforzo di porsi
al livello del maestro e il maestro deve amarlo, perché vuol dire che ha deciso di
seguirlo nel suo amore per la filosofia.
La stessa cosa va detta del Plotino leopardiano. Plotino, sollecito nei riguardi di
Porfirio, è un buon maestro che non può e non deve ignorare i meriti dell’allievo. Perciò
ascolta quel che il suo allievo ha da dirgli e riconosce le sue ragioni, anzi ammira la
capacità di Porfirio ad addentrarsi in questioni così complesse e non gli dà torto, perché
non può dargli torto. Ascolta l'intelligente “tirata” di Porfirio sulla vera posizione di
Platone, contestando la legittimità di un'interpretazione letterale di un passo del Fedro
nel quale – secondo Porfirio – Platone ragionerebbe di una vita dopo la morte
“acciocché gli uomini, entrati in dubbio o in sospetto circa lo stato loro dopo la morte;
per quella incertezza, e per timore di pene e calamità futura, si ritenessero nella vita dal
fare ingiustizia e dalle altre male opere”. Interpretazione plausibile, se non corretta, alla
quale il maestro non potrà opporre valide obiezioni.
La difficoltà che pone la lettura del dialogo è proprio qui: l’amore del maestro al
discepolo vieta che il maestro rimproveri ipocritamente l’allievo, proibendogli di fare
quel che alla coscienza dell’allievo si mostra giusto fare, tanto più che Porfirio non ha
fatto nient'altro che far affiorare alla propria coscienza quelle stesse considerazioni che,
in forma di mito, il lettore delle Operette aveva già trovato nella Storia del genere
umano. A Plotino non resta altro che sconsigliare Porfirio dall’attuare il suo proposito
suicida, appellandosi all’affetto, al piacere della conversazione di cui priverebbe i suoi
amici, qualora decidesse veramente di darsi la morte. Questa risposta, che può sembrare
una caduta sul piano morale, costituisce al contrario il punto più alto del dialogo.
Plotino ha capito che il male che affligge l’allievo è un filosofico disgusto della vita, il
fastidio di dover accettare i ricatti della quotidiana esistenza; l’avere inteso che l’uomo
si inganna da solo. Gli fa perciò intendere che la corda della filosofica sensibilità
potrebbe condurlo a nuove emozioni, e che lui è forse solo all’inizio di un percorso
filosofico. Infatti il taedium vitae logora naturalmente l’anima del filosofo e per vincerlo
non resta altra possibilità se non quella di rifugiarsi nuovamente nella filosofia, che è
quanto sia lui che Porfirio hanno appena fatto, sfiorando delle verità, di cui potrebbero
in altra occasione tornare a ragionare insieme, forse più profondamente. Ciò però non
significa altro che indicare l’unica via possibile alla sublimazione, che non consiste
nell’accecare il proprio intelletto, ma nell’addentrarsi sempre più nelle questioni
filosofiche. L’esplorare senza paura e liberamente la realtà del male di vivere è l’unica
medicina possibile che allo stesso male di vivere la filosofia (cioè il pensiero, la cultura)
possa suggerire. Col che ci pare sia chiarito un po’ meglio che cosa sia il “liquore
generoso” nel quale Tasso può andare a inseguire il suo Genio familiare. Il filosofo ha
bisogno di un certo visionarismo per poter procedere nelle sue analisi. Ma questo
visionarismo, che può anche essere sollecitato da stati di momentanea eccitazione, non
va confuso con forme di delirio, non è annebbiamento, torpore, ma immaginazione che,
destata, ci aiuta a soffermare la nostra attenzione su cose mai prima notate.
Apparentemente antiplatonico, per certe sue posizioni apertamente scettiche, il
pensiero di Leopardi si salda invece benissimo a quello di Platone.
E’ Leopardi a scrivere nello Zibaldone in data 16 settembre 1821:
Il sistema di Platone delle idee preesistenti alle cose, esistenti per se, eterne, necessarie,
indipendenti dalle cose e da Dio: non solo non è chimerico, bizzarro, capriccioso, arbitrario, fantastico,
ma tale che fa meraviglia come un antico sia potuto giungere all’ultimo fondo dell’astrazione, e vedere
sin dove necessariamente conduceva la nostra opinione intorno all’essenza delle cose e nostra, alla natura
astratta del bello e del brutto, buono e cattivo, vero e falso 7.
E tralasciamo le lodi sperticate dirette allo scrittore Platone, che si trovano
disseminate qua e là nello Zibaldone, lodi che sono comunque spia di un apprezzamento
che certamente non va solo all’abilità del retore. Esse infatti ci dicono come per
7 . G. Leopardi, Zibaldone [1712-1713]
Leopardi Platone avesse individuato strategie comunicative che imponevano a tratti
l’innalzarsi della lingua a livelli diversi dal comune, a tenere quel tono uniforme, calmo,
tipico del discorso suadente, che poco a poco ti porta a delle verità che si pongono da
sole e con un’immediatezza che fa lo stile della sincerità. Ed è questo il tono che nelle
Operette morali Leopardi si studia di tenere a sua volta.
6. Leopardi e gli scrittori moderni
Leopardi è platonico, secondo noi, anche per il tramite di Petrarca. Ci riferiamo al
Petrarca dei Trionfi e del Secretum. L’ambizione generosa, tipica dello spirito nobile
che nel mondo antico era essenzialmente lo spirito libero, è gravemente frustrata nei
giorni nostri. Questo tema è a dir poco centrale alle Operette morali, nel senso che ci
pare costituirne un assunto iniziale a cui, grado a grado lo scrittore porta il suo lettore
con argomenti sempre più serrati e con esempi sempre più eloquenti, svelando, errore
dopo errore, gli equivoci della morale corrente. E’ nel Parini che uno dei nodi principali
si scioglie.
Come abbiamo già visto nel secondo capitolo, in questa sorta di discorso di un
maestro al suo allievo la gloria è negata, ma va a questo punto chiarito che la sua
negazione vale anche l’appassionata difesa della cultura classica che, legittimando la
gloria, l’aveva anche resa possibile. Tutto il ragionamento che si contiene in questa
operetta leopardiana potrebbe apparire ispirato a quella volgarità di giudizio per cui un
“buon padre di famiglia” del nostro tempo sconsiglia al proprio figlio di studiar
filosofia. In realtà essa è la denuncia di questa volgarità e della viltà intellettuale con cui
si combina. Sono ben altri infatti i termini e i toni con cui il “buon padre di famiglia”
esorta il figlio a seguire altra strada che non quella degli studi filosofici. Non gli pone
davanti il poeticissimo deserto rappresentato dall’indifferenza, e perfino dal disprezzo
altrui, perché, diffidando delle sue capacità di coinvolgimento, ha paura che il giovane
accetti con entusiasmo qualsiasi sfida, per poi buttarsi a capofitto nell’impresa, come i
giovani del resto tendono a fare. Gli canta perciò le lodi della vita quotidiana, la poesia
del guadagno e dell’arricchimento. Usa insomma il “buon padre di famiglia” ben altro
linguaggio e ben altra retorica da quella che Leopardi mette in bocca al suo Parini. Da
questo punto di vista l’operetta contiene un’ineffabile (e assai poetica) ironia nei
confronti dei valori morali correnti nell’età di Leopardi (e della nostra). Leggendola,
chiunque non sopporti la viltà intellettuale dell’ipocrisia, finisce con l’invidiare
quell’oscuro allievo a cui Parini si rivolge, mettendolo alla prova per vedere se abbia o
non abbia la stoffa del vero filosofo.
Da questo punto di vista ha ragione Luigi Blasucci a dire che
è sempre valida l’osservazione del De Sanctis nel suo saggio su Schopenhauer e Leopardi:
“Leopardi produce l’effetto contrario a quello che si propone… Chiama illusioni l’amore, la gloria, la
virtù e te ne accende in petto un desiderio inesausto”. Solo bisogna aggiungere che è proprio questo
l’effetto che Leopardi si propone8
Detto secondo noi benissimo. E’ infatti nel mondo presente che si rende
necessario allo scrittore riscattare la propria credibilità e, per bocca di Parini, “si delinea
un’acutissima diagnosi sulla sorte della letteratura nella moderna civiltà di massa, che
con i suoi meccanismi produttivi manipola e sovverte i valori più autentici.”9. E con
questo siamo a quanto già dicevamo circa il rapporto di Leopardi con il nuovo mondo
della borghesia emergente, che, con l’Ottocento, si avvia, come classe media, a
garantirsi quei privilegi di cui sarà sempre più gelosa. E qui il sospetto che la vocazione
antiborghese che la cultura italiana ha rivendicato tanto a destra quanto a sinistra, ci sia
stato un che di esteriore, di letterario, con una sostanziale adesione da parte di parecchi
intellettuali e scrittori ai modelli di vita suggeriti dalla disprezzata borghesia. Con la
possibile eccezione di Dino Campana, di Vincenzo Cardarelli, di Ettore Majorana e di
pochi altri, l’intellettuale italiano ha preferito adattarsi alla logica dei premi, della
carriera e delle onorificenze. Il fatto stesso che un drappello di appena dodici professori
universitari si rifiutasse nel 1931 di giurare fedeltà al fascismo dimostra come in Italia le
generose ambizioni fossero, a cento anni ormai dalla seconda edizione delle Operette
morali, un lontano ricordo del passato. Col che non vogliamo dire, con una fin troppo
evidente distorsione dei fatti, che Leopardi fosse antifascista, magari ante litteram.
Troveremmo di pessimo gusto un’affermazione del genere. Ci pare però che quel
giuramento, a sentire molti di coloro che lo fecero, fu, oltre che insincero, dettato da
puro opportunismo, da paura, dal timore di creare scandalo e di essere additati come
traditori della patria e nemici pubblici. Timori che avrebbero fatto sorridere di
compatimento quel Parini che nel suo omonimo dialogo Leopardi volle celebrare.
8 . L. Blasucci, Le ragioni storiche della satira leopardiana, in R. Ceserani – L. De Federicis, Il
materiale e l’immaginario. Manuale e laboratorio di letteratura, vol. IV, Società e cultura della
borghesia in ascesa, Loescher, Torino 1993, p. 1162.
9 . G. Tellini, Leopardi op. cit. p. 151.
7. Il modello di Luciano (e di altri)
La massima parte delle “prose” che compongono le Operette morali sono dialoghi
tra vivi e morti, personaggi del passato, figure della mitologia classica. Sicuramente c’è
la traccia dell’opera di Luciano di Samosata, come anche quella di Traiano Boccalini,
autore dei Ragguagli di Parnaso, di Alessandro Verri e delle sue Notti romane, nelle
quali si muovono le ombre degli antichi. Ma ci sono anche alcuni Dialoghi dei morti
che, proprio sull’esempio di Luciano, avevano scritto Nicolas Boileau (1636 – 1711),
Bernard de Fontenelle (1657-1757), François Fénelon (1651 – 1715) e Jean d’Alembert
(1717 – 1783), senza citare Voltaire. Ora, mentre i dialoghi di Fénelon (autore assai
letto e celebrato ancora all’epoca di Leopardi) sono tra ombre di scrittori e filosofi
scomparsi ma tra loro contemporanei, è Bernard de Fontenelle ad avere l’idea di mettere
a confronto fra loro Augusto e Pietro Aretino, Socrate e Montaigne, ovvero – fatto per
noi assai importante – Stratone di Lampsaco e Raffaello. Stratone è infatti una delle
maschere filosofiche che appaiono nelle ultime pagine delle Operette. Ci sarebbe da
domandarsi se non fosse proprio leggendo Fontenelle che Leopardi ebbe l’idea di
ragionare su questo antico filosofo aristotelico, campione di un materialismo integrale.
A parte gli scrittori francesi, ci pare doveroso ricordare anche la già citata
Battaglia dei libri di Jonathan Swift, dove si pongono a confronto i libri moderni e i
libri antichi, che è quanto dire l’età moderna e quella antica, col che siamo nel pieno
dell’argomento delle Operette morali10. Ma vanno anche aggiunti Senofonte, i cui
Moralia diedero ispirazione perfino al titolo e il Canto di Circe di Giordano Bruno, che
Leopardi tenne quasi certamente presente nello scrivere il Dialogo della Natura e di
un’Anima, ma di cui ci pare di trovare più di un’eco in molte delle Operette morali11. E’
nel Canto di Circe, pochissimo conosciuto all’epoca di Leopardi (e quasi certamente
ignorato dall’occhiuta censura che non vide riferimenti ad autori pericolosi) che Circe,
rivolgendosi alla figlia Moeri, alla quale spiega che molti uomini sono in realtà bestie
10
Senza contare che, stando a Giovanni Papini, Algarotti, studioso noto a Leopardi, oltre a citare spesso
Swift, “lo chiamava il moderno Luciano”, giudizio che difficilmente avrebbe potuto sfuggire
all’attenzione di Leopardi (Cfr. G. Papini, Stroncature, p. 322).
11
. Ci riferiamo al Copernico ma anche alle operette che immediatamente precedono e seguono
il Copernico, cioè il Dialogo di Timandro e di Oleandro, il Diaologo di Plotino e di Porfirio, nonché
le ultime due con cui il libro si chiude, vale a dire il Dialogo di un venditore di almanacchi e di un
passeggere e il Dialogo di Tritano e di un amico.
con aspetto di uomini, e invocando le forze della natura, dice: “La stessa madre natura
non ci ha tratto in inganno? Ho detto madre o matrigna? Alla verità nulla dev’essere più
odioso della falsità stessa….”12. Sono spunti preziosi per il Leopardi delle Operette che
intende porre i suoi lettori di fronte alla loro verità, partendo proprio dall’aspetto morale
e cercando di suscitare sdegno e disgusto per la viltà. Bruno è per noi importante anche
come via alternativa al cartesianesimo. Se Cartesio infatti desume non pochi argomenti
da Bruno, a cominciare dal dubbio che da metodico diviene iperbolico, dal dubbio
iperbolico “esce” con la fatidica sentenza che “Dio non può ingannarmi”. Mago e
alchimista, oltre che filosofo, Bruno avrebbe avuto qualcosa da obiettare e non
sappiamo dire se l’obiezione che Leopardi alla fine avanza contro la congettura
cartesiana gli fosse da Bruno ispirata. E’ certo che Leopardi trova possibile che l’uomo
possa ingannarsi lui stesso circa Dio. Leopardi sa oltretutto, per essere stato educato a
conoscere tutti i principi informatori della religione cattolica, che tale possibilità era
stata tenuta in considerazione dai primi cristiani. In quell’epoca, che assiste alla fioritura
della grande filosofia stoica, gran parte della cultura teologica si contiene in quella che
noi vorremmo chiamare “bolla gnostica”, per significare una via di ricerca speculativa
che non è propriamente filosofica né propriamente religiosa, consistendo in una
manipolazione dei simboli per esplorare il pensiero simbolico, visto come altro rispetto
al pensiero razionale. C’è chi ha accostato Leopardi allo gnosticismo. A noi non pare
che in Leopardi ci fosse più che qualche curiosità nei confronti di questo pur importante
indirizzo di pensiero, ma ci diciamo certi della sua tendenza a restare nel solco di un
razionalismo di marca illuministica, così compatibile con le sue esigenze di filologo. Da
questo punto di vista saremmo tentati di affermare che alla fine lo gnosticismo diventa
semmai per lui un mezzo per recuperare il platonismo e, attraverso il platonismo, un
senso del divino decisamente più pagano che cristiano, del tipo che era venuto
riaffiorando nel corso del Rinascimento.
A prescindere da Bruno, e sempre restando al tardo Rinascimento, da Traiano
Boccalini può avere avvio un certo tono graffiante rivolto all’attualità, una certa ironia.
Va però detto che nelle Operette è assai più seria e convinta, a tratti struggente, la
nostalgia del mondo antico. La ragione è facile: per Boccalini si trattava di ironizzare
sul mondo delle Accademie che pretendeva di porsi sotto la tutela della classicità, poco
curandosi che questa fosse ridotta a cifra, a pura convenzionalità, interessandosi gli
12
. G. Bruno, Il Canto di Circe, Atanòr, Roma 1978, p. 10.
“accademici” di cose assai più meschine e di assai più immediato interesse13. Una
posizione che offrirà a Leopardi qualche spunto interessante, ma non va dimenticato che
per l’autore delle Operette morali si tratta di denunciare l’abbandono di un progetto che,
inaugurato dagli umanisti del Quattrocento, avrebbe dovuto portare al recupero del
mondo spirituale e intellettuale degli antichi fino a porre l’uomo nella condizione di
vivere come i vari Cicerone e Platone, non più prigioniero di certi fantasmi e paure che
la viltà dei tempi ha invece diffuso fra gli uomini.
Che questo potesse essere il progetto di Leopardi ci pare indirettamente
confermato da quel che osserva Vincenzo Gioberti, il quale ebbe a scrivere:
Da Dante fino al Manzoni le lettere e le scienze italiane furono coltivate e promosse fuori
dell'inspirazione cristiana, eziandio dagli scrittori religiosi, come Tasso, Vico, ecc. La prova si é che, da
Dante e dal Manzoni in fuora, non v'ha in Italia un grande scrittore o filosofo che abbia trattato ex
professo di dottrina religiosa per difenderla o per combatterla […] Questo deviamento comincia col
Petrarca e col Boccaccio, e si stende fino al Leopardi, che n'è la più viva e più compita espressione. Tutto
questo ciclo religioso è schiettamente pagano, e il Leopardi oggidì non è, come può parere a prima fronte,
un discepolo della filosofia francese del secolo XVIII, ma, come Machiavelli, della filosofia romana e
greca. Leopardi é piuttosto discepolo di Democrito e di Stratone di Lampsaco, che del Condillac o
14
dell'Holbach; la sua incredulità è piuttosto anteriore al cristianesimo, ex-cristiana, che anticristiana..
Giudizio, secondo noi, sereno e maturo che dovrebbe far riflettere sul perché tanti
che si avventurarono a scrivere su Leopardi con minore cognizione dei fatti e senza una
conoscenza diretta della persona (che invece ebbe Gioberti), non ne abbiano poi tenuto
alcun conto.
8. La viltà dei moderni
Per noi l’indicazione di Gioberti è addirittura preziosa perché utile a capire quale
fosse l’origina della concezione leopardiana dell’uomo, del mondo e della storia. Al
delinearsi di tale concezione che ci sembra domini l’orizzonte spirituale delle Operette
morali concorsero secondo noi alcuni fatti contingenti che, appartenendo però al clima
culturale dell’epoca in cui Leopardi visse, resero secondo noi urgente agli occhi del
filosofo il bisogno di definire una sua posizione. Sicuramente importanti furono
l’esperienza fatta a Roma da un lato, dall’altro anche la pubblicazione della Storia di
13
T. Boccalini, A chi legge, in Ragguagli di Parnaso
14
V. Gioberti, Pensieri, Vol. II Botta, Torino 1860 (a cura di G. Massari), p. 709
Sismondi e le polemiche che attorno ad essa sorsero. La prima, imposta da qualcosa che
era assai più che non una moda, addirittura un obbligo nella formazione di qualsiasi
intellettuale, produsse notoriamente nello scrittore una cocente delusione che gli fece
avvertire, secondo noi, necessario il chiarirsi di una sua posizione circa il dibattito che
attorno all’opera del Sismondi era nato.
In breve Sismondi, studioso svizzero nato a Ginevra nel 1773 e morto nel 1842,
aveva avanzato la tesi che il cattolicesimo avesse contribuito a “guastare” lo spirito
degli Italiani, privandoli delle virtù proprie delle antiche stirpi di Roma15. Una tale
teoria offriva alla cultura tedesca estro per l’idea che la fiaccola della civiltà dovesse
passare da un popolo all’altro e, compiutasi ormai la parabola dei popoli latini, poteva
prepararsi l’ascesa del popolo germanico vivificato dallo spirito luterano. Ovviamente i
romantici italiani cercheranno di dare una risposta appropriata alle tesi di Sismondi,
cercando, nella moderazione che ne caratterizzò lo spirito, di conciliare i vari punti di
vista senza inimicarsi i tedeschi impegnati a rivendicare l’indipendenza nei confronti
dell’Austria. Non c’è dubbio poi che la questione fosse particolarmente urgente per gli
intellettuali milanesi. Sudditi dell’Imperatore d’Austria, sapevano come il romanticismo
tedesco mirasse a sfaldare l’Impero nel nome del principio di nazionalità, mortificato
col Congresso di Vienna. Dar torto a un movimento culturale che mirava a emancipare i
popoli germanici dalla soggezione a quell’Impero non sarebbe stato saggio. Non
stupisce allora che proprio i milanesi studiassero una risposta da dare più nei fatti che
nelle parole. Perciò nasce nel il gruppo del “Conciliatore” con un programma volto a
un “romanticismo” sui generis che diplomaticamente accoglie la ventata di
rinnovamento che viene dalla Germania, ignorando l’anti-italianità di alcuni romantici
tedeschi e rimandando ad altra occasione un chiarimento circa la tesi di Sismondi che
era per di più marginale all’ampio contesto della ricerca da lui condotta. Pur tuttavia
quella tesi non poteva passare inosservata, per le implicazioni politiche che poteva
avere, la volta che, sulla base di essa, si fosse convenuto di abbandonare l’Italia al suo
destino isolandola dal resto delle nazioni europee. In questo quadro, mentre Leopardi
concorderà sostanzialmente con Sismondi, prendendo le distanze dal moderatismo
cattolico che costituì il nucleo principale della cosiddetta “rivoluzione d’Italia”16,
Alessandro Manzoni, capofila del romanticismo lombardo, scriverà, con l’aiuto di
15
S. de’ Sismondi,
16
significativamente ripresa da Alessandro Manzoni, il quale progettò per un suo scritto il titolo La
Rivoluzione Francese del 1789 e la Rivoluzione Italiana del 1859 (Cfr. A. Manzoni, Dell’Indipendenza
dell’Italia, a cura di Fausto Ghisalberti, Casa del Manzoni, Milano 1947).
.L’espression
Rosmini, le Osservazioni sulla morale cattolica e certamente anche il giobertiano Del
primato morale e civile degli Italiani si va ad ascrivere nel quadro delle polemiche sorte
attorno alla tesi di Sismondi.
Leopardi un po’ condivide, un po’ approfondisce questa tesi, portandola a
conseguenze estreme. Si tratta di un aspetto che ci pare fin qui poco indagato del
pensiero di Leopardi17. Prescindendo infatti dalla professione di ateismo che qua e là
appare in trasparenza nell’opera dello scrittore, ci sono osservazioni sulla morale
cattolica e quindi sugli effetti che la dottrina cristiana ha sull’ethos popolare, che
sembrano essere piuttosto note di antropologia culturale, in margine a quella che
nell’Ottocento si chiamava ancora teologia morale. Su questa materia Leopardi è lucido
e spietato interprete di esigenze morali insoddisfatte, di promesse non realizzate. Da un
lato la religione cattolica accende nell’uomo un forte desiderio di elevarsi con la mente
e con lo spirito, dall’altro nega all’intelletto umano qualunque capacità di penetrare il
mistero, l’unica via rimanendo quella della Rivelazione. In sintesi ci pare sia questo il
percorso seguito da Leopardi, il quale negli anni dal ’15 al ’23 passa, come sostiene
Cesare Galimberti “da una posizione cattolico-illuminata all’abbandono della fede
religiosa e al rifiuto di una ragione che, appena superi quel grado di facoltà ‘naturale’
che l’uomo ha in comune con gli altri animali, è all’origine dei tanto più funesti errori
“artifiziali”, “barbarizzanti”, fino alla scoperta di una linea negativa della filosofia
moderna”18, dove vale la pena ricordare che la filosofia moderna è da Leopardi vista
come originata dalla cultura cristiana.
Torna qui l’inattuabilità di un percorso mistico, essendo ormai la Rivelazione,
almeno per il mondo cattolico, intesa come fatto storico realmente accaduto. Secondo
noi proprio l’impossibilità di relativizzare e problematizzare il concetto di realtà,
diversamente da quel che sarebbe accaduto nel mondo tedesco (dove comunque
l’operazione si compì non senza difficoltà da parte dell’ hegelismo), suggerì a Leopardi
altro percorso da seguire. Spiegare che la realtà, intuitivamente intesa, è essa stessa un
mito è impossibile a un popolo, che come quello italiano, è orgoglioso della propria
furbizia. Il furbo infatti accetta che la propria intelligenza complessiva e profonda delle
cose possa subire uno scacco; quel che in fondo desidera non venga messa in dubbio è
la sua capacità di intendere l’inganno che ora e qui lo minaccia. Le ragioni del sempre e
17
. Ci riferiamo a un senso di italianità assai vivo in Leopardi che, pur incontrandosi col
patriottismo romantico, da questo poi differisce in quanto le sue basi sono nella difesa di una storia di cui il
popolo italiano è, senza saperlo, ricco. Ci pare fosse questo lo spirito che animava già il famoso Discorso
di un italiano
18
C. Galimberti,
le questioni di metafisica lo spaventano ed è perciò naturalmente incline alla logica del
miracolo. Queste cose Leopardi le ha capite e non è per rispondere alla moda romantica
che si interessa della mentalità degli italiani, ma perché sa che gli italiani sono il suo
pubblico, quelli ai quali il suo discorso si rivolge. Tutto questo comporta l’assenza di
qualsiasi dialogo con la cultura tedesca che, dalla tradizione luterana, potrà ancora
problematizzare la nozione di realtà traducendola in quella della hegeliana coscienza
infelice, che, nel soffrire, dà ancora senso al fatto che si sia abbracciata una fede. Per il
cattolico invece la Rivelazione è, diversamente che per il luterano, un fatto che si crede
o non si crede vero, la cui verità non si risolve nell’interiorità dei singoli che nel gruppo,
nella nazione e nella tradizione nazionale si identificano. Il cattolico che crede alla
Rivelazione, vi vede un fatto irreversibile e certo, per quanto miracoloso, nel quale
risulta estremamente difficile trovare il senso di una scelta di coscienza. E’ l’evidente
fondamento della vita, fatto più ancora che epocale cosmologico, tutt’al più
trasfigurazione del mondo e dell’uomo come l’idealismo nostrano cercherà di
affermare. Chi preferisce non crederci sente del tutto paradossalmente di compiere una
scelta che non è solo intellettuale, ma è anche e soprattutto morale. In questo e non in
altro consiste il leopardismo: nell’ostinazione con cui si difende la libertà di pensare,
esigenza che la Chiesa cattolica, qualche anno dopo, fallito il tentativo di liberalizzarsi,
metterà completamente in parentesi, svelando il volto più terribile del dio cristiano, cioè
la richiesta dell’obbedienza per l’obbedienza. Sia fatta la volontà di Dio che è poi un
paganissimo motto che resuscita l’antica divinità del Fato. Il pontificato di Pio IX, con il
Sillabo, non avrebbe fatto altro che completare il tracciato di questa parabola.
Va detto, per chiarezza, che il cattolicesimo verso cui si dirigono le critiche di
Leopardi è il cattolicesimo nato dal Concilio di Trento. Questo cattolicesimo è dominato
da preoccupazioni di tipo politico non meno di quanto lo fosse il Luteranesimo. Non
meno del Luteranesimo poi, il cattolicesimo riformato (o controriformato) guarda con
attenzione a come gestire il rapporto col popolo dei fedeli, proponendosi come fattore di
coesione e di unione da una lato e come strumento di governo dall’altro. E il governo è
quello che viene esercitato dai principi cattolici, tra i quali figura anche e prima di tutti
il papa. Vogliamo dire che man mano che lo Stato nazionale viene a configurarsi come
creatura del mondo moderno, oscurando progressivamente quel che resta dell’impero
che i Carolingi avevano restaurato, il potere temporale del papa acquista contorni
sempre meno sfumati. Fin tanto che l’imperatore ha una qualche credibilità, il potere
temporale della monarchia papale può intendersi come funzionale allo scopo di
cooperare, al pari di quanto fanno gli altri monarchi, a rendere funzionale gli apparati
del sistema feudale, perfino al tempo della lotta per le investiture. Apertasi ufficialmente
la crisi dell’impero (che in crisi era in realtà da lunghissimo tempo), cioè, grosso modo,
dopo Carlo V, quando i principali Stati nazionali hanno una loro sovranità e
indipendenza, anche il papa è posto davanti alla possibilità di usare la religione, al modo
in cui fanno gli altri principi, come instrumentum regni, per dirla al modo di
Machiavelli. Intendere tutto ciò come una sorta di incidente necessario alla
sopravvivenza stessa e del papato e della religione cattolica è quanto in sostanza fece
Terenzio Mamiani, come dimostra l’ultima opera da lui scritta e rimasta peraltro
incompiuta. Ci riferiamo a Del Papato nei tre ultimi secoli. Compendio storico-critico,
apparso nel 1885, subito dopo la morte dell’autore, per i tipi dei Fratelli Treves. La
posizione di Mamiani è peraltro antitetica a quella di Leopardi, il quale è piuttosto
propenso a notare come i costi della sopravvivenza vuoi del papato vuoi della religione
cattolica siano poi pagati da quei sudditi del papa che prendano a cuore il messaggio
evangelico e si trovino a dovere da un lato obbedire a un capo spirituale e dall’altro a
un’autorità temporale, che, per scopi politici, forza le ragioni stesse della fede. Queste
temporalità si fa anche più evidente nel progressivo perfezionarsi della macchina
amministrativa e burocratica dello Stato e qui non va taciuto che gli Stati della Chiesa
costituirono, nel bene e nel male, fino ad almeno tutto il Seicento uno dei modelli di
maggiore efficienza. Di qui il bisogno d’essere machiavellici, condannando tuttavia
formalmente ogni teoria politica ispirata ai principi del machiavellismo. E anche questo
piace assai poco a Leopardi.
Aggiungiamo, terminando il paragrafo, che queste cose fanno parte della
“preistoria” delle Operette morali, che non vanno lette come un attacco alla religione
cattolica, quanto piuttosto come una critica a quanti vivono con superficialità la propria
vita sia sul piano della formazione di una coscienza politica, sia su quello di una
dimensione spirituale e intellettuale, al punto di non vedere i molti problemi solo
superficialmente risolti. Di qui quelli che Mario Fubini chiamò i concetti-miti delle
Operette morali, la Felicità, Il Piacere, La Noia, il Dolore e la Natura19 e che a noi
sembrano un semplice espediente narrativo, specie dove tali concetti trovano il modo
d’essere personificati e i patiti della “furbizia” sono messi in condizione di riconoscere
la propria sostanziale “ingenuità”.
19
M. Fubini,
9. Gli obblighi morali della furbizia
Che le Operette siano caratterizzate da toni ironici e sarcastici e che costituiscano
un’opera satirica è per noi fuori di ogni dubbio. L’intento è dichiaratamente satirico e
l’oggetto della satira è l’uomo; non l’uomo con i suoi eterni difetti, quale, per esempio
era apparso a Orazio, ma l’uomo dei tempi nei quali lo scrittore vive. Gran parte del
senso della storia che ha Leopardi, come filosofo, si contiene nel concetto che egli ha
della contemporaneità. Non è questa, si badi, una categoria storiografica. Semmai la
contemporaneità è in Leopardi promossa a un ruolo categoriale da alcuni fatti
contingenti nei quali si sostanzia la crisi che segna il passaggio dall’Ottocento al
Novecento. Dicevamo anche prima di un nuovo tipo di umanità che si profila negli
spazi della vita pubblica, al tempo in cui vive Leopardi. Tale umanità ha alcuni
indiscutibili meriti, che consistono innanzitutto nel sapersi disbrigare nelle questioni che
riguardano la vita di tutti i giorni. E’ interessante, a questo riguardo, quel che Leopardi
scrive nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, circa la funzione
che la nozione dell’onore svolge nelle società moderne dei paesi europei e d’America.
E’ facile intuire come Leopardi intendesse, in quel suo scritto, far leva proprio su questo
senso dell’onore di cui difetterebbe ai suoi occhi il popolo italiano, per scuotere le
coscienze dal torpore in cui si trovano. E’ fuori discussione il fatto che Leopardi
attribuisca agli italiani una perspicacia che oscilla tra l’intelligenza e la furbizia, qualità
che sicuramente egli apprezza. Già nello Zibaldone Leopardi annotava in data 5
febbraio 1821:
Non è veramente furbo chi non teme, o presume e confida con certezza, di non poter essere
ingannato, trappolato ec.: perché non conosce dunque e non apprezza a dovere le forze della sua stessa
furberia. E per la stessa ragione non è sommo in veruna professione chi non è modesto; e la modestia, e lo
stimarsi da non molto, e il credere intimamente e sinceramente di non aver conseguito tutto quel merito
che si potrebbe e dovrebbe conseguire, questi dico sono segni distintivi dell’uomo grande, o certo sono
qualità inseparabili da lui...20.
L’italiano dell’Ottocento è furbo, ma ha poche opportunità di manifestare il
proprio talento e la furbizia si volge spesso contro di lui, alimentando proprio il timore
di poter essere ingannato. Anche questa è l’origine del poco conto che gli italiani fanno
del proprio onore e della propria onorabilità, come lo stesso Leopardi osserva nel
ricordato Discorso sui costumi degli italiani.
20
Zibaldone [612]
Questo punto ha una sua importanza e merita d’essere un po’ meglio discusso.
Leopardi non dispone degli strumenti di cui oggi può disporre chi intenda condurre,
utilizzando più inchieste con relativa modulistica studiata e realizzata allo scopo, una
ricerca circa l’esistenza di una mentalità diffusa. Ha diretta esperienza di quel che vede
e ascolta nelle “conversazioni”, cioè nei salotti in cui ha libero accesso. Non c’è dubbio
che la classe dirigente dell’Ottocento fosse, su questo piano, lo specchio fedele di una
sorta di coscienza nazionale. La stessa linea politica seguita nel corso dell’Ottocento
dimostra che incertezza del futuro e scarsa fiducia nelle proprie risorse fosse a
fondamento di molti degli errori anche politici che la classe dirigente compì
immediatamente prima e immediatamente dopo l’unità. Se si eccettua quello di Cavour,
che ebbe talento di diplomatico oltre che di politico, i governi che a quello di Cavour
successero furono dominati dal tentativo di accordare fra loro tendenze opposte, di
fondere ambizioni contrastanti, esercitando come Marco Minghetti, Umberto Rattazzi e
Agostino Depretis l’antica virtù italica della furberia. La furberia tipica, come abbiamo
illustrato, del Venditore d’almanacchi, che arriva a far finta di non intendere quel che
tuttavia ha inteso, non basta a una società di furbi per la soluzione dei non pochi
problemi collettivi.
L’esser furbi e l’obbligo di far intendere all’interlocutore di esserlo abbastanza
emerge con una certa insistenza nei dialoghi leopardiani, che tengono a dare prova di
quel “machiavellismo sociale” che, secondo Leopardi, domina nei salotti romantici. E’
questo un aspetto che conferisce ai dialoghi che si leggono nelle Operette morali una
certa teatralità insolita in un libro di filosofia e che sicuramente non piacque a Benedetto
Croce. E’ in fondo il tratto che più accomuna, sul piano dello stile, Leopardi figlio a
Leopardi padre e va detto che l’accostamento delle Operette ai Dialoghetti, non manca
di fondamento, specie per quanto riguarda la lingua e l’affabilità di alcuni personaggi.
La differenza è che le Operette hanno poco di ameno, perfino quando il tono si fa
leggero, come è del resto normale che sia in un libro in cui si trattano temi filosofici,
non di attualità politica. Resta la teatralità che si esprime in frasi e toni rituali che sanno
di convenevoli, ma è al tempo stesso una potenzialità poco esplorata delle Operette. Ci
riferiamo a un a lettura un po’ troppo composta e letteraria di un testo in cui l’agire dei
personaggi, la foggia dei loro abiti, l’atteggiamento che hanno l’uno verso l’altro
costituiscono dettagli significativi. Pensiamo, ad esempio, a Tristano e all’Amico, così
caricaturalmente ottocentesco al punto che non basta che il lettore se li immagini
comodamente seduti in poltrona. Anche per questo le più famose tra le Operette sono
quelle in cui la drammaticità (nel senso proprio e originario del termine) si fa evidente,
come nel Copernico o come nel Dialogo della Natura e di un Islandese. La maestà della
Natura risuona nel discorso che la Natura rivolge all’uomo, sgomento e attonito per
l’incontro del tutto imprevisto. Quando però la situazione drammatica non è tanto
evidente, come nel caso del Dialogo di Tristano e di un Amico, chi legge dovrebbe
figurarsi un conversare alquanto convenzionale e insincero e capire che il personaggio
dell’amico è un tipo diffidente. E’ un fatto che, alle volte, i personaggi di Leopardi
ribadiscono con tale insistenza ciascuno le proprie ragioni da far capire che non danno
molto ascolto l’uno all’altro, come se non parlassero tra loro, ma facessero piuttosto a
gara per attirare ognuno l’attenzione del pubblico, come nel caso di Timandro ed
Oleandro o di Tristano e l’amico. C’è qui l’aspetto debole della “furbizia” come obbligo
sociale, aspetto di cui ci pare Leopardi fosse pienamente consapevole, il quale ragionava
in questo senso di machiavellismo.
Il fatto è che c’è un senso del bene comune e della ricchezza comune che difetta
facilmente al furbo, vittima della stessa arte d’arrangiarsi che in fretta ha dovuto
apprendere per sopravvivere. Nella sua paura di non essere e di non apparire abbastanza
intelligente e di cadere nel discredito degli altri, il furbo non si eleva volentieri al di
sopra di un’intelligenza mediamente riconosciuta per tale. Gli manca il coraggio
necessario per porsi criticamente di fronte ai problemi reali dell’esistenza e finisce col
cullarsi nelle sue illusioni e nei suoi sogni. A questo punto la furberia gli si rivolge
contro. Il coraggio di cui egli difetta è infatti essenziale di fronte all’autorità, comunque
questa si presenti, nella veste di genitore, di guida spirituale, di maestro, di libro scritto
da chi ne sa più di lui. Invece è normale che una certa spavalderia si mostri ai fratelli, ai
commilitoni, ai compagni di classe, a coloro con cui in genere condividiamo le nostre
esperienze. E’ qui che si fa a gara fra chi è più furbo e più capace di intendere le cose.
Chi poi si spinge a mettere in difficoltà la persona che detiene l’autorità farebbe bene a
sapere che spesso, per una sorta di furberia tutto sommato ingenua, sarà lasciato solo a
regolare i suoi conti con l’autorità. Stanno qui i limiti morali di una furbizia che si
ostina a non trasformarsi in intelligenza sistematica delle cose. Sul piano di una
coerenza morale è proprio a chi si espone che dovremmo manifestare solidarietà. Solo
così saremmo furbi fino in fondo, mostrando d’aver capito tutto quel che c’è da capire.
Se Tersite, che s’è fatto coraggio, avesse trovato la solidarietà dei suoi compagni, si
sarebbe innalzato al grado d’eroe perché, oltre al desiderio di farsi notare, avrebbe
mostrato di saper interpretare un pensiero condiviso, denunciando anche la superficiale
e parziale visione dei fatti dei capi dell’assemblea. Non avendo tenuto in conto la
possibilità che, al momento della protesta, venisse meno la solidarietà dei compagni,
agisce da sciocco che dà retta a qualunque brusio di malcontento e, cedendo alla vanità,
pensa di far bella figura entrando in polemica con Ulisse, che ha capito perfettamente
con chi ha a che fare e non esita a maltrattarlo e a castigarlo. Ulisse infatti è furbo per
davvero e sa che, se non si comportasse così, perderebbe la credibilità da parte dei suoi
uomini.
Tutto ciò nasce dal fatto che l’autorità ci inganna o per interesse, o per una sorta di
affettuosa sollecitudine, la stessa che suggerisce a Plotino una qualche prudenza
nell’accettare i ragionamenti di Porfirio, ai quali peraltro si arrenderà alla fine del
dialogo, ammettendo le vere ragioni per cui sconsiglia al discepolo il suicidio,
dicendogli:
Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme; non ricusiamo di portare quella parte che il
destino ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. Sì bene attendiamo a tenerci compagnia l’un l’altro; e
andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente; per compiere nel miglior modo
questa fatica della vita21.
E qui, al solito, si sono notati, da parte dei lettori, gli accenti di un esasperato e
totale pessimismo, non invece le sottili strategie dialettiche con cui Porfirio si è
mostrato degno del maestro che avrebbe dovuto a sua volta convincerlo del contrario.
Non si nota l’onestà intellettuale dei due interlocutori, l’agilità mentale che porta
Plotino a riconoscere senza difficoltà che l’allievo ha colto nel segno e sa pensare per
conto proprio, senza più bisogno di una guida. Né si coglie un altro aspetto, che cioè il
dialogo, pur invitando a non considerare colpevole un suicida, rispettandone al contrario
i sentimenti e il mondo morale, è però tutt’altro che un’incitazione al suicidio. Si
capisce benissimo che Porfirio desisterà dal suo intento proprio per essere stato inteso
dal suo maestro che lo porta a discettare filosoficamente circa un tema che presenta non
poche difficoltà, specie per un “moderno”. Sicché quella di Plotino è un’esortazione ad
andare avanti, visto che l’allievo è ormai a buon punto della sua ricerca. Insomma torna
qui l’invito a imparare dagli antichi, che nel ragionare delle cose, vi ficcano dentro lo
sguardo senza girarci inutilmente attorno, come fanno i “moderni”. Un “moderno” si
scontra infatti, da filosofo, col tabù del suicidio: l’etica cristiana lo fa talmente soggetto
all’autorità di Dio da non potere più disporre della propria vita, infatti questa non gli
appartiene, perché, come argomentano i teologi confessionali, essa è “dono” divino.
Questo gli impedisce di filosofare, col distacco e la serenità del saggio, su un fatto
21
. O. M., Dialogo di Plotino e di Porfirio
probabilmente del tutto naturale, col risultato che quella del suicidio può perfino
diventare una sorta di ossessione, perché nessuno spiega al moderno come il desiderio
di staccarsi dal mondo sia parte integrante della vocazione al filosofare e che chi si
confronta col senso della morte è filosofo, se è vero quel che dice Montaigne, cioè che
“filosofare è approssimarsi alla morte”22.
Leopardi queste cose le conosce perché appartengono al suo vissuto, come
dimostra una sua lettera al Giordani, di cui riportiamo un passo significativo.
10. Oltre il “pessimismo”
Senza voler qualificare “ottimistica” la prospettiva di Leopardi, il fatto indica
quanto si sia esagerato sul “pessimismo” quale chiave di volta del pensiero
leopardiano23. Quantomeno non si tratta di un ingenuo pessimismo esistenziale, ma di
una complessa costruzione filosofica che seguita la tradizione dell’illuminismo
voltairiano e che nulla ha a che fare con una presunta costituzionale infelicità della
persona, fatta oggetto di un’ipocrita commiserazione, autentico specchio delle povertà
morali che, come abbiamo visto, dominavano la scena del mondo contemporaneo a
Leopardi. Il quale è furbo per dote naturale, ed essendo intelligente per obbligo
professionale, capisce profondamente queste cose e, pur criticandole con una feroce
ironia, si guarda dall’attaccare esplicitamente le persone che ne sono vittime.
La furbizia è un valore che normalmente il filosofo disprezza, specialmente fuori
d’Italia. Che Leopardi al contrario mostri di farne conto ci pare estremamente
significativo. L’Italia della sua epoca è composta in gran parte di poveri analfabeti, per i
quali la furbizia, quando c’è, è un’ancora di salvezza. Il povero, se è ingenuo,
soccombe; se è furbo se la cava. La persona semplicemente furba, che non conosca le
buone maniere, che appaia piuttosto ignorante, può divertire ma più spesso appare prima
o poi volgare, egoista, sordida, meschina specialmente a chi, conducendo una vita assai
diversa dalla sua, colga questi tratti come costitutivi di una personalità che tende a
sopraffare, ad approfittare al punto che spesso arriva a mancare di dignità.
Dicendo peraltro che la furbizia è un valore, abbiamo voluto dire che in alcune
parti del mondo la furbizia si insegna e non solo appartiene a un costume, ma nei fatti è
rispettata e apprezzata, nonostante a parole trovi chi la compatisce o la disprezza. Per
22
23
. M. de Montaigne, Essais, Livre Premier, Chapitre XX, Que philosopher c’est apprendre à mourir
. G. Papini
dirla in termini ottocenteschi, potrebbe sostenersi che fosse un valore diffuso nel popolo
italiano; per dirla nei termini divulgati dal marxismo, potremmo sostenere che si tratti di
un aspetto della cultura proletaria e il fatto che il borghese lo colga come disvalore
potrebbe essere visto come comprovante delle tensioni di classe che tra Ottocento e
Novecento hanno diviso proletariato e borghesia.
Volendo individuare una terza via alle due descritte, che consenta fra l’altro di
restare più aderenti allo spirito della ricerca condotta da Leopardi, possiamo dire che
agli occhi dello scrittore questa virtù presuntamente volgare ha consentito per secoli alle
classi dirigenti di risolvere tanti problemi. E questo va pubblicamente riconosciuto,
finendola una volta per tutte con le ipocrisie di una cultura che ufficialmente condanna
Machiavelli, ma poi fa sistematico ricorso ai suoi insegnamenti perfino all’interno dei
salotti, nei quali, come abbiamo visto Leopardi vede muovere le pedine dei giochi
“importanti”. Di questa che è al tempo stesso una debolezza e una risorsa dell’essere
umano Leopardi sente il bisogno di ragionare come di una cosa naturale e desidera che
quanti la praticano si pongano seriamente di fronte ala realtà della vita morale che ad
essi appartiene.
Il bisogno di una furbizia palese viene meno di fronte alla possibilità e alla
capacità di tutelare i propri diritti con l’ appellarsi all’autorità della legge. Il rispetto
delle regole e la morale del conformismo conducono infatti a praticare una specie più
facile di astuzia da parte di chi si trovi a godere di certi privilegi legati a uno status
sociale. Leopardi fa appena in tempo a intravedere le prime manifestazioni di quello che
nel secondo Ottocento sarà lo snobismo borghese giocato ai danni dei ceti popolari.
Eppure, come atteggiamento mentale, esso ha già fatto la sua apparizione. Per esempio,
nei Promessi sposi Manzoni scrive:
Chi forma poi la massa, e quasi il materiale del tumulto, è un miscuglio accidentale d'uomini, che,
più o meno, per gradazioni indefinite, tengono dell'uno e dell'altro estremo: un po' riscaldati, un po' furbi,
un po' inclinati a una certa giustizia, come l'intendon loro, un po' vogliosi di vederne qualcheduna grossa,
pronti alla ferocia e alla misericordia, a detestare e ad adorare, secondo che si presenti l'occasione di
provar con pienezza l'uno o l'altro sentimento; avidi ogni momento di sapere, di credere qualche cosa
grossa, bisognosi di gridare, d'applaudire a qualcheduno, o d'urlargli dietro24.
Giustamente Tommaso Di Salvo osserva, a proposito dell’episodio dei Promessi
sposi in cui avviene l’arresto di Renzo a opera del notaio che si presenta all’osteria la
mattina dopo che incautamente Renzo ha esposto le sue teorie politiche a un poliziotto,
che “l’episodio si incentra sul tema della furbizia, fortemente ironizzata dal Manzoni ed
24
.A. Manzoni, I promessi sposi, cap. XIII
avvertita come sostanzialmente immorale e disonesta”25.
Noi concordiamo col giudizio di Manzoni che è severo nei confronti di un tratto
che è nell’Italia dell’epoca caratteristico del profilo morale delle classi subalterne, dove
i padri invitano esplicitamente i figli a “farsi furbi”.
Il contrasto tra l’opinione di Manzoni e quella di Leopardi non va sottovalutato,
specie tenendo presente come le Operette morali si pongano come percorso alternativo
a quello tracciato dai Promessi sposi. Qui va chiarito che, per quanto ciascuno dei due
scrittori lavorasse all’insaputa dell’altro, gli ambienti letterari avevano creato attorno
all’una e all’altra delle due opere un clima di attesa che le aveva rese già leggendarie,
con ampie anticipazioni circa lo spirito che animava e l’una e l’altra. Né va dimenticato
come Leopardi fosse pronto a porsi in antitesi al partito manzoniano, progetto che viene
successivamente meno dopo l’incontro dei due al Gabinetto Viesseux26.
Per Manzoni l’astuzia ha insomma una sua miseria, perché risponde a un fine
immediato che spesso consiste nella deliberata intenzione di ingannare qualcuno. E’
vero peraltro che possono distinguersi proprio alla luce dell’episodio dell’arresto di
Renzo più sopra ricordato una furbizia attiva e una passiva e, se la prima ha un che di
malvagio, la seconda ha appena quel po’ di malizia che ci aiuta a sospettare della
persona che vuole il nostro danno. Quest’ultima furbizia è legittima agli occhi dello
stesso Manzoni e consente a Renzo di trovare la via della fuga e della salvezza.
Anche questo spiega come alla fine il frontale contrasto tra Leopardi e Manzoni
non ci fu, sebbene essi fossero campioni di due mentalità decisamente in conflitto l’una
con l’altra. E’ da supporre che l’uno e l’altro dei due si rendesse conto delle strategie
complesse che ne guidavano i passi nel comunicare ciascuno col suo pubblico.
La provvidenza è del resto la grande assente delle Operette morali. Invocata nei
Promessi sposi, dove sembra costituire il grande mito nel quale si contengono le
immagini che della loro epoca hanno i personaggi del romanzo, la provvidenza non
trova spazio nella filosofia leopardiana. Il Cantico del gallo silvestre e il Dialogo della
Natura e di un Islandese non lasciano dubbi in proposito.
Concludendo, va fatto presente quale sia il valore anche morale, oltre che
intellettuale, che Leopardi riferisce alla furbizia. Intanto va ribadito quanto già detto
circa quel che dobbiamo qui intendere per furbizia. Si tratta di una dote nativa che la
.
25
T. Di Salvo, intervento critico, in A. Manzoni, I promessi sposi (a cura di T. Di Salvo),
Zanichelli, Bologna 1987, p. 324.
.
26
L’incontro avvenne
cultura antica celebrò nel personaggio di Ulisse e che consiste nel saper trovare la via
più breve per superare un ostacolo. A questa dote non si associa necessariamente una
malizia maggiore di quella che sia strettamente necessaria allo scopo. In altri termini
non dobbiamo pensare a una sorta di apologia della furbizia invocata come criterio di
vita. La furbizia serve e trova un suo giusto impiego quando altre risorse non
soccorrono. Da questo punto di vista è un vero e proprio contraltare del
provvidenzialismo e costituisce una preziosa risorsa tutta umana alla sopravvivenza.
Tanto vale guardarla un po’ più da vicino, senza trarne ragione di scandalo o di
vergogna.
L’insegnamento che dalle Operette morali ci viene è, a conti fatti, che dobbiamo
con coraggio e onestà guardare nella coscienza di un popolo che, alla ricerca di una sua
identità, può trovarla soltanto per il tramite di chi ne sappia raccontare la storia, da
questa facendo emergere quanto appartiene all’indole più autentica e vera di quel
popolo.
La cosa data senz’altro l’opera leopardiana che del resto, come abbiamo indicato
fin dall’inizio, era nata con questo scopo in quella fase storico-culturale avvertito come
mportante. Il fatto che oggi non sia così e che manchi l’urgenza di dare agli italiani un
loro profilo culturale ben definito non toglie che la questione mantenga una sua
attualità. Cittadini europei, in Europa dobbiamo sforzarci di portare un contributo che
consiste nel saper dire di che cosa siamo ricchi e di che cosa siamo poveri, magari
scoprendo che la storia degli altri popoli che abitano l’Europa non è poi tanto diversa
dalla nostra e che soprattutto non abbiamo più bisogno di raccontare quello che
avremmo voluto essere e non eravamo capaci di essere come un romanticismo, a nostro
modo di vedere male inteso e male utilizzato, indusse a fare alla nuova classe dirigente
del nostro Paese.