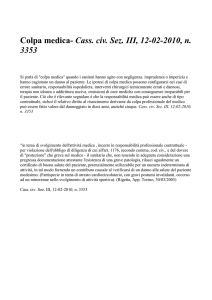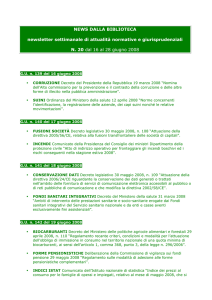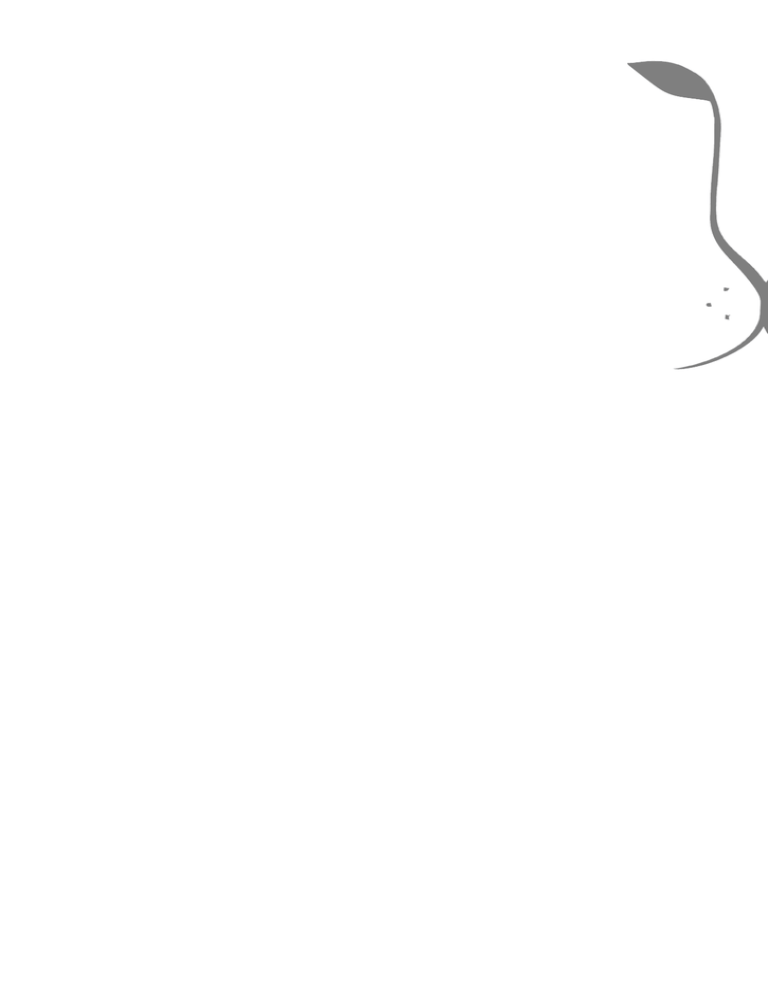
Gazzetta
F O R E N S E
Bimestrale
Anno 6 – Novembre-Dicembre 2012
direttore responsabile
Roberto Dante Cogliandro
comitato di direzione
Almerina bove
Corrado d’ambrosio
Alessandro jazzetti
redazione
capo redattore
Mario de Bellis
redazione gazzetta forense
Valeria D’Antò, Melania DuratuRo, Anna Eliseo
editore
Denaro Libri Srl, presso la Mostra d'Oltremare, viale Kennedy, 54 – 80125 Napoli
proprietario
Associazione: Nemo plus iuris
comitato di redazione
Andrea Alberico
Giuseppe amarelli
Antonio ArdituRO
Clelia Buccico
Carlo Buonauro
Sergio Carlino
Raffaele Cantone
Matteo D’Auria
Domenico De Carlo
Mario de Bellis
Andrea Dello Russo
Clelia iasevoli
Rita Lombardi
Raffaele Manfrellotti
Catello MARESCA
Giuseppina MAROTTA
Daniele Marrama
Raffaele MICILLO
Maria Pia Nastri
Giuseppe Pedersoli
Angelo Pignatelli
Ermanno Restucci
Francesco Romanelli
Raffaele Rossi
Angelo Scala
Gaetano scuotto
Mariano Valente
comitato scientifico
Fernando Bocchini
Antonio Buonajuto
Aurelio Cernigliaro
Lorenzo Chieffi
Giuseppe Ferraro
Gennaro MARASCA
Antonio Panico
Giuseppe Riccio
Giuseppe Tesauro
Renato Vuosi
n. registraz. tribunale
N. 21 del 13/03/2007
finito di stampare da
360o ‑ Roma – nel gennaio del 2013
SOMMARIO
Editoriale
[ A cura di Roberto Dante Cogliandro ]
Diritto e procedura civile
Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile
9
Giuseppe Ferraro
Il nuovo rito speciale per le cause di licenziamento.
Legge 28 giugno 2012 n. 92, art. 1, commi 47-68
23
Umberto Lauro
Il sovraindebitamento dei soggetti economici e del consumatore
nel D.L. N. 212/2011, (conv. nella L. 10/2012)
30
Corrado d’Ambrosio
L’ordinanza ex art. 789 c.p.c.: natura del provvedimento ed impugnazione esperibile
39
Nota a Cass. civ., sez. Un. 02 ottobre 2012, n. 16727
Ermanno Restucci
Rassegna di legittimità [A cura di Corrado d’Ambrosio]
48
Rassegna di merito [A cura di Mario De Bellis e Daniela Iossa]
50
In evidenza
Corte di Cassazione, sezione III, 27 novembre 2012, n. 20984
[Nota redazionale a cura di Pietro Sorrentino]
Corte di Cassazione, Sezione III, 20 aprile 2012, n. 6273
[Nota redazionale a cura di Fabrizia Sabbatini]
52
57
Diritto e procedura penale
Il principio della domanda cautelare: gravi indizi di colpevolezza
e fumus commissi delicti*
63
Maria Antonietta Troncone
Brevi riflessioni dalle prospettive ìdi riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari
69
Rossella Catena
Dialogo tra la Corte Edu e le Corti nazionali sul valore dell’overruling giurisprudenziale
84
Vittorio Sabato Ambrosio
I contrasti risolti dalle Sezioni unite penali
A cura di Angelo Pignatelli
88
Rassegna di legittimità [
Rassegna di merito [
A cura di Alessandro Jazzetti e Andrea Alberico ]
A cura di Alessandro Jazzetti e Giuseppina Marotta ]
91
94
Diritto amministrativo
L’evoluzione dello spoils system al vaglio della Corte Costituzionale
101
Gli appalti pubblici e p.m.i. tra specialità reale ed apparente
107
Almerina Bove
Pasquale Di Lieto
Rassegna di giurisprudenza sul Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 114
(d.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss. mm.)
A cura di Almerina Bove
Diritto tributario
Un’analisi critica del nuovo istituto del reclamo nel processo tributario
119
Clelia Buccico
Diritto internazionale
Rassegna di diritto comunitario
121
A cura di Francesco Romanelli
Questioni
[ A cura di Mariano Valente ]
Può il dies a quo del termine di prescrizione per la proposizione dell’azione risarcitoria
dei danni derivanti da emotrasfusioni individuarsi nella data della prima diagnosi
del contagio? / Elisa Asprone
Se ed entro che limiti sia configurabile il reato di omissione o ritardo
di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale
non tenga un comportamento di totale indifferenza dinanzi alla richiesta
di un privato, ma attivi iniziative per la definizione della pratica
di cui quest’ultimo sia stato messo a conoscenza. / Anna Sofia Sellitto
147
150
Se ed in che limiti è legittima l’esclusione dall’esame di Stato del candidato sorpreso
a copiare da un telefono cellulare palmare. / Anna Laura Magliulo e Mary Musto 153
Recensioni
Scritti in onore di Massimo Di Lauro
AA.VV., Cedam 2012
Federico Baffi
157
Gazzetta
F O R E N S E
●
La Riforma forense
a due velocità
● Roberto Dante Cogliandro
Notaio
n o v e m b r e • d i c e m b r e
2 0 1 2
5
Il Natale 2012 ha portato agli avvocati italiani la tanto
attesa legge di riforma forense. Trattasi di una sorta di legge
quadro che per come è stata modulata necessiterà di circa due
anni per essere attuata. Infatti il nostro legislatore dando seguito al durissimo scontro avutosi nelle relative commissioni
parlamentari ha rimesso con deleghe ad hoc ad apposito decreti attuativi da farsi di concerto con il Consiglio Nazionale
Forense o con la Cassa Nazionale di previdenza. Il Parlamento in sostanza ha sposato il classico metodo utilizzato in materia lavoristica dove la concertazione con il mondo sindacale
ha costituito la regola degli ultimi cinquanta anni, salvo rare
eccezioni.
Dunque nella sostanza saranno decreti legislativi, ministeriali o regolamenti che daranno forma nei prossimi mesi al
cantiere aperto della tanto attesa riforma forense.
Sensa volerci addentrare nei vari aspetti ci preme solo
sottolineare come in tema di esame di stato dove ci si aspettava da subito una qualche novità tutto è stato rimandato ad
apposita delega che sarà poi il ministero della giustizia di
concerto con il CNF a dover attuare. Un aspetto questo della
riforma che si spera possa delinearsi anche prima dei due anni
visto che è ormai diventato indecente e poco rispettoso dei
tanti candidati la modalità di correzione che prevede l’incrocio
delle corti d’appello.
Aspettiamo silenti speranzosi che il futuro dei giovani con
corsisti sia legato alla meritocrazia e non più alla mera alea
come è stato fino ad oggi. Ne vale il prestigio di una categoria
di cui sempre il nostro paese è andato fiero.
Diritto e procedura civile
Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile
9
Giuseppe Ferraro
Il nuovo rito speciale per le cause di licenziamento.
Legge 28 giugno 2012 n. 92, art. 1, commi 47-68
23
Umberto Lauro
Il sovraindebitamento dei soggetti economici e del consumatore
nel D.L. N. 212/2011, (conv. nella L. 10/2012)
30
Corrado d’Ambrosio
L’ordinanza ex art. 789 c.p.c.: natura del provvedimento ed impugnazione esperibile
39
Nota a Cass. civ., sez. Un. 02 ottobre 2012, n. 16727
Ermanno Restucci
Rassegna di legittimità [A cura di Corrado d’Ambrosio]
48
Rassegna di merito [A cura di Mario De Bellis e Daniela Iossa]
50
Corte di Cassazione, sezione III, 27 novembre 2012, n. 20984
[Nota redazionale a cura di Pietro Sorrentino]
Corte di Cassazione, Sezione III, 20 aprile 2012, n. 6273
[Nota redazionale a cura di Fabrizia Sabbatini]
52
57
civile
In evidenza
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
●
Flessibilità in entrata:
nuovi e vecchi modelli
di lavoro flessibile*
● Giuseppe Ferraro
Professore di Diritto del Lavoro presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”
2 0 1 2
9
Sommario: 1. Premessa. – 2. Il contratto a tempo determinato acausale. – 3. Il rinvio alla contrattazione collettiva. – 4. I
nuovi termini connessi al contratto a tempo determinato. – 5.
L’interpretazione autentica del comma 5, art. 32, legge n.
183/2010, sull’indennità risarcitoria. – 6. Il contratto di somministrazione. – 7. La portata delle innovazioni sul lavoro a
termine nel settore pubblico. – 8. Le modifiche alla disciplina
del contratto a progetto. – 9. Gli equivoci storici sulla parasubordinazione. – 10. L’apparato sanzionatorio sul contratto
a progetto. – 11. Il regime transitorio. – 12. Le altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo. – 13. Il meccanismo
delle presunzioni e le implicazioni giuridiche. – 14. Le aree
soggettive esonerate. – 15. La fattispecie di lavoro autonomo
economicamente dipendente. – 16. Le novità in materia di
associazione in partecipazione. – 17. Considerazioni di sintesi sulle varie forme di lavoro prestato a favore di terzi. – 18.
Le tecniche normative per imporre il modello dominante. –
19. I dubbi di costituzionalità per violazione dei tipi legali.
– 20. L’equilibrio tra le varie forme di flessibilità. – 21. Le
soluzioni prescelte nel quadro delle varie proposte dottrinali
e legislative.
1. Premessa
Vorrei chiarire subito che non intendo occuparmi in termini generali, e per così dire filosofici, della problematica
generale della flessibilità, né tantomeno delle diverse teorie
economiche che ormai da tempo si confrontano sul tema specifico con riferimento ad un sistema economico sempre più
competitivo ed integrato a livello internazionale oltre che afflitto da una crisi epocale. Neppure mi occuperò delle varie
forme in cui la flessibilità si realizza all’interno dei sistemi
produttivi (flessibilità in entrata, in uscita, numerica, organizzativa e/o funzionale, salariale, previdenziale) di cui mi sono
ampiamente interessato in altri contesti1. Mi limito a ribadire
convinzioni radicate sul modo, a mio avviso incongruo, in cui
la flessibilità è stata declinata nel nostro paese, principalmente incentrata sulla proliferazione di una molteplicità di modelli contrattuali nella prospettiva angusta di andare a scovare
microscopiche opportunità di lavoro anziché provare a costituire un solido tessuto di relazioni produttive integrato da
un’adeguata rete di protezioni sociali. In realtà questa politica,
di stampo marcatamente neoliberista, che incontra ampie
assonanze in ambito internazionale, non solo ha favorito una
drammatica segmentazione del mercato del lavoro, ma ha
indotto le imprese a scaricare i rischi e le turbolenze della
dura competizione internazionale prevalentemente sul fattore
lavoro, in una rincorsa inarrestabile alle condizioni sempre più
vantaggiose, impedendo così quel rinnovamento tecnologico
e produttivo che sarebbe stato indispensabile. I risultati drammatici, e ormai irreversibili – ove si pensi all’ampia platea di
precariato ingestibile sul piano previdenziale – di una tale
politica sono sotto gli occhi di tutti e non è necessario ulteriormente indugiarvi.
*
Relazione presentata al Convegno Nazionale AGI, Ancona, 26/27 ottobre 2012,
su “Nuove regole dopo la legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro”.
1 Per una panoramica ad ampio raggio vedi i due volumi a cura di M. Cinelli-G.
Ferraro, Lavoro, competitività, welfare, Torino, 2008, 2009, con molti contributi. V. pure da ultimo P. Tullini, Proposte di revisione della disciplina del
lavoro flessibile, dattiloscritto; e il volume di P. Ichino, Inchiesta sul lavoro,
Milano, 2012, anche per le varie proposte legislative.
civile
Gazzetta
10
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
Neppure mi occuperò del concetto di flexicurity, così
come emerso a livello comunitario, quale possibile risposta ai
processi di frammentazione e di impoverimento dei mercati
nazionali del lavoro con l’obiettivo ambizioso di compensare
l’ampia flessibilità nella selezione e gestione dei rapporti di
lavoro con una maggiore protezione sul mercato del lavoro.
Di qui l’invocazione mitologica di modelli scandinavi, oleograficamente rappresentati, neppure del tutto aderenti alla
realtà, e comunque non meccanicamente esportabili in quanto legati a tradizioni ed esperienze endogene ai vari paesi (per
non dire che anche quelle esperienze sono entrate in forte
tensione nell’ultima drammatica congiuntura economica).
È significativo che nei più recenti documenti comunitari
su Europa 2020 emerga nitidamente un ripensamento di
queste formule salvifiche nella consapevolezza che occorrono
politiche ben più ampie ed integrate per perseguire concretamente l’obiettivo prioritario di un 75% di occupati nel 2020
per i cittadini compresi nella fascia di età 20/64 anni (oggi al
69%) con particolare attenzione ai giovani, donne ed immigrati. Siamo evidentemente nel pieno di una nuova stagione
progettuale che cerca di andare oltre le tradizionali politiche
di flexicurity e che, a parte le consuete declinazioni retoriche
su un’auspicata crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva”,
sembra orientata a contrastare le segmentazioni e le sperequazioni prodotte dalle politiche liberistiche degli ultimi anni 2.
Mi soffermerò invece sugli interventi normativi che sono
stati realizzati dalla riforma Fornero3 , con particolare riferimento a tre categorie di rapporti, vale a dire quelli a tempo
determinato, comprensivi del contratto di somministrazione,
quelli di matrice autonoma, categoria arricchitasi da una
pervasiva regolamentazione dei soggetti possessori di partita
iva, e infine quelli di stampo associativo (in altra sede ho
considerato anche i rapporti con finalità formative e quelli che
ruotano sul regime dell’orario di lavoro, tra cui in primis il
part-time e il lavoro intermittente).
Nell’ambito di tali istituti mi concentrerò esclusivamente
sugli aspetti salienti delle novità legislative, ovvero su quei
profili sui quali vanno addensandosi maggiori incertezze interpretative, per poi alla fine provare a trarre qualche essenziale considerazione di sintesi.
2. Il contratto a tempo determinato acausale.
La principale novità relativa al contratto a tempo determinato non è certo costituita dalla premessa contenuta nel
comma 9, dell’art. 1 (divenuto 01 nell’assetto del decreto legi-
2Su tale profilo da ultimo L. Zoppoli, La flexicurity dell’Unione Europea:
contenuti e implicazioni della riforma del marcato de lavoro in Italia, in
W.P.CSDLE “Massimo D’Antonia”.it – 142/2012; ma v. pure in termini più
generali D. Natali-G. Bonoli, The Politics of the new welfare state, in The
New Welfare State in Europe, 2009, ora in www.italialavoro.it, marzo 2011;
F.R. Pizzuti, Rapporto sullo Stato Sociale. La “Grande crisi del 2008” e il
welfare state, Milano, 2010; S. Spreafico, Lavoro e welfare, Milano, 2010.
3 Per un primo commento a caldo si vedano M. Fezzi-F. Scarpelli (a cura di),
Guida alla riforma Fornero, in Quad. wiki-labour.it, 2012; A. Vallebona, La
riforma del lavoro 2012, Torino, 2012; M. Magnani-M. Tiraboschi (a cura
di), La nuova riforma del lavoro, Milano, 2012; F. Carinci-M. Miscione (a
cura di), Commentario alla Riforma Fornero, Milano, 2012; G. Falasca (a
cura di), Guida pratica riforma del lavoro, Milano, 2012. Per profili specialistici v. pure F. Carinci, E tu lavorerai come apprendista, in Quaderni ADL,
Padova, 2012, e V. Speziale, La riforna del contratto a termine nella legge 28
giugno 2012, n. 92, in WCSDLE Massimo D’Antona.it, n. 153/2012, purtroppo letto dopo la stesura della relazione.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
slativo 6 settembre 2001, n. 368), secondo cui il contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la “forma comune” di rapporto di lavoro, espressione alquanto ritualistica e non priva di una certa retorica. La principale
novità è rappresentata dall’inserimento del comma 1-bis
nell’art. 1 del decreto n. 368, in virtù del quale le ragioni
imprenditoriali giustificatrici del contratto a termine non
sono richieste “nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra
un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansioni, sia nella forma del
contratto a tempo determinato sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato (…)”.
L’innovazione, come si vede estesa al primo contratto di
somministrazione4 , è per così dire storica, tranchant e densa di
implicazioni, giacché viene sostanzialmente consentita la possibilità di stipulare un primo contratto a termine, ovvero di
somministrazione a tempo determinato, in piena libertà contenutistica sia pure con il vincolo della forma scritta. Per previsione espressa questo specifico contratto non è prorogabile
neppure nell’ipotesi in cui sia stato sottoscritto per un periodo
inferiore a 12 mesi (art. 4, comma 2-bis), e persino, a mio avviso, nell’ipotesi in cui la proroga fosse giustificata da ragioni
tecniche, organizzative e produttive, che non potrebbero agganciarsi a un precedente contratto privo di motivazione5.
Si può subito dire che l’acausalità del primo contratto
costituisce il maggior contributo dato alla deflazione del
contenzioso giudiziario. Qualcosa di analogo era già previsto
nella precedente legislazione, ma in ambiti settoriali e ristretti e sulla base di una prefigurazione normativa dei presupposti giustificativi (v. in part. art. 2, d.lgs. n. 368/2001). Ora
invece l’acquisita possibile acausalità del primo contratto diventa un criterio ordinatore dell’istituto di carattere generale.
Peraltro una disciplina ancora più favorevole è stata da ultimo
introdotta dall’art. 28 del cd. decreto sviluppo bis (decreto
legislativo n. 179/2012), con riferimento alle imprese innovative start-up, con riferimento alle quali contratti a termine
acausali possono essere stipulati da un minimo di 6 mesi ad
un massimo di 36 mesi (con possibilità di prosecuzione sino
a 48 mesi con procedura speciale) a partire dalla costituzione
delle imprese, rinnovabili più volte, anche in continuità, senza che si determini l’effetto conversione e senza neppure dovere corrispondere il contributo addizionale di 1,4% della
retribuzione imponibile, a conferma di un trend univoco che
va consolidandosi.
L’interpretazione del comma 1-bis ha già destato molti
problemi interpretativi, a me pare che quello più rilevante
4 Novità peraltro già contenuta nel recente decreto 2 marzo 2012, n. 24, attuativo della direttiva 2008/104-CE, relativo al lavoro tramite agenzia in virtù del
quale la nuova formulazione dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003
prevede che il ricorso alla somministrazione possa essere svincolato da qualsiasi causale qualora il contratto di somministrazione contempli l’utilizzo di lavoratori disoccupati da almeno sei mesi, di percettori di ammortizzatori sociali,
anche in deroga, da almeno sei mesi, di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del regolamento CE n. 800/2008 (art. 20, comma 5-ter, d.lgs.
n. 276 del 2003, introdotto dall’art. 4, d.lgs. n. 24 del 2012).
5 Contra la prevalente dottrina: v. per tutti A. Vallebona, La riforma, cit., p. 17
ss, per un’opinione analoga a quella espressa nel testo v. G. Falasca, La riforma
del lavoro, Milano, 2012, p. 13.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
riguardi l’interpretazione del concetto di “primo rapporto a
tempo determinato”.
Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la disposizione rilevi anche con riferimento a contratti sottoscritti prima
dell’entrata in vigore della legge, e su ciò non avrei dubbi in
mancanza di una disciplina transitoria, ma la questione più
importante consiste nello stabilire se vanno considerati anche
i contratti precedentemente stipulati, come ad esempio contratti formativi, a progetto, o addirittura contratti a tempo
indeterminato precedentemente risolti e successivamente sostituiti da un contratto a termine. Sul punto sarei orientato a
ritenere che qualsiasi precedente rapporto negoziale avente ad
oggetto prestazioni di lavoro intercorse tra il datore di lavoro
e il lavoratore “per lo svolgimento di qualunque tipo di mansioni” precluda la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato essendo la norma evidentemente ispirata
dalla finalità di elasticizzare/incentivare un primo contratto
quando sia espressione di una relazione totalmente innovativa
(su tale interpretazione sembra orientata la circ. Ministeriale
n. 4 del 18 luglio 2012 6). Tuttavia devo anche precisare che la
formula letterale adoperata non è del tutto conforme all’interpretazione fornita, visto che si fa riferimento esplicito al
“primo rapporto a tempo determinato” che indica una figura contrattuale ormai assolutamente tipizzata (v. intitolazione
del d.lgs. n. 368/2001).
3. Il rinvio alla contrattazione collettiva.
La soluzione prospettata dal legislatore viene posta in alternativa ad una procedura negoziale più complessa che può perseguire finalità in parte analoghe. Infatti i contratti collettivi
stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta, a livello
confederale o di categoria, ovvero in via delegata, a livelli decentrati, che in luogo dell’ipotesi innanzi illustrata il requisito
di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione
a tempo determinato o la missione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo giustificato dalle
ragioni di cui all’art. 5, comma 3, nel limite complessivo del 6%
del totale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva. In altri
termini il legislatore delega alla contrattazione collettiva espletata a livello più qualificato la facoltà di prefigurare ipotesi alternative per la sottoscrizione di contratti a termine acausali sia
pure nel limite percentuale del 6% e in presenza di esigenze
socio-produttive tassativamente indicate.
Si è rimarcata l’originalità tecnica della soluzione adottata in cui il legislatore regolamenta una determinata attività
organizzativa in termini alquanto concessivi per le esigenze
dell’impresa per poi lasciare spazio alla contrattazione collettiva per introdurre soluzioni difformi, sia pure nei limiti
quantitativi legislativamente delineati.
La formula è indubbiamente inusitata e tuttavia ritenuta
assai poco allettante per le imprese in presenza di una dispo-
6 L’introduzione del primo contratto a tempo determinato “acausale” è infatti
anche finalizzato ad una migliore verifica delle attitudini e capacità del lavoratore in relazione all’inserimento nello specifico contesto lavorativo; pertanto non
appare coerente con la ratio normativa estendere il regime semplificato in relazione a rapporti in qualche modo già “sperimentati”. Ciò a maggior ragione
vale per la stipula di contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro con cui si è intrattenuto un precedente rapporto a tempo indeterminato.
2 0 1 2
11
sizione così agevole come quella contenuta nell’art. 1, comma
1-bis, non essendo chiaro quale possa essere l’interesse delle
organizzazioni imprenditoriali a incanalarsi in una complessa trattativa che potrebbe soltanto ridurre il margine di operatività delle imprese, oltretutto assoggettandolo a una delicata verifica giudiziaria sulle ragioni sostanziali specificate
nella lett. h) del comma 9. In realtà i vantaggi ci sono se si
considera l’ampiezza del margine di manovra attribuito all’autonomia collettiva, che potrebbe ad esempio prorogare il
termine di 12 mesi addirittura equiparandolo a quello consentito per le aziende in start-up e persino prevedere progressive proroghe e rinnovi acausali. L’unico dato invalicabile è la
percentuale del 6% per unità produttiva, che può apparire
effettivamente troppo bassa rispetto all’ampio margine di
manovra riservato all’autonomia collettiva, ma occorre pure
considerare che la percentuale viene rapportata ad ogni struttura produttiva con elementi di autonomia organizzativa.
Mi astengo dall’affrontare analiticamente alcune delicate
questioni che investono l’attuale “quadro” sindacale: in primis
se gli accordi richiamati devono essere sottoscritti da tutti i
sindacati rappresentativi o è possibile conseguire lo stesso
risultato con accordi separati, in secondo luogo se l’accordo
ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti interessati, e in particolare nei confronti del singolo imprenditore
eventualmente non aderente all’associazione stipulante il
quale potrebbe prediligere la soluzione legale. Per mia consolidata convinzione, per la risposta ad entrambi i quesiti occorre rapportarsi strettamente all’Accordo interconfederale
del 28 luglio 2011 per il ruolo preminente che assolvono tali
accordi nella regolazione dell’attività contrattuale, e quindi
gli accordi dovranno essere tendenzialmente unitari e vincolanti per tutti ove espressione della volontà maggioritaria dei
soggetti rappresentati7. A mio avviso, in termini generali, la
regola maggioritaria si prospetta giuridicamente vincolante
in tutti i casi in cui la contrattazione collettiva – integrativa,
derogatoria o sostitutiva – trova giustificazione in un’espressa
delega legislativa8 .
Incidentalmente merita pure di essere evidenziata la scelta
legislativa di prendere nettamente le distanze dall’art. 8 del
decreto n. 138 (conv. in L. n. 148), sui contratti di prossimità,
nella parte in cui riconosce anche alla contrattazione decentrata di regolare i contratti a termine privi di motivazione se
all’uopo delegata dalla contrattazione di livello superiore. La
scelta è densa di implicazioni, anche perché ribadita nelle
successive disposizioni, giacché consente di recuperare il sistema di relazioni sindacali nella sua tradizionale organicità
come risultante dagli accordi interconfederali e dai contratti
collettivi nazionali. Al contempo lascia intendere che quella
norma ha costituito una mera deviazione estemporanea da un
assetto più o meno regolato e consolidato, da inquadrare
pertanto in un’ottica di assoluta eccezionalità, come già riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 221 del
2012 9 , sia pure da un’angolazione peculiare.
7 Contra V. Speziale, La riforma, cit., p. 12 ss.
8 Sulla tormentata problematica vedi l’ampio dibattito tenutosi nel corso del
Convegno AGI 2011, ora riportato nel volume a cura di F.M. Putaturo Donati, Diritto del lavoro anno zero, Napoli, 2012, sp. p. 3 ss.
9 “Ciò significa che l’effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera
in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad altri. Inoltre, trat-
civile
Gazzetta
12
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
4. I nuovi termini connessi al contratto a tempo determinato.
La disciplina in esame interviene pure su tre profili regolati dalla legislazione in materia, che attengono in qualche
modo alla disciplina dei termini. Innanzitutto ha ampliato la
moratoria prevista dall’art. 5 del comma 2, portandola a 30
giorni, nel caso di contratto a termine inferiore a 6 mesi, e a
50 giorni, nel caso di contratto superiore a 6 mesi. Al contempo ha previsto che nelle ipotesi richiamate il datore di lavoro
ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego, entro la
scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto
continuerà oltre tale termine indicando altresì la durata della
prosecuzione.
Qui è evidente la trasfigurazione della ratio originaria
della norma, che essendo stata introdotta per consentire un
margine di tolleranza per eventuali “distrazioni” nella fase di
ultimazione dei contratti a termine, per una sorta di eterogenesi dei fini, viene a configurarsi come una forma surrettizia
di proroga del contratto non sottoposta alla specifica disciplina di cui all’art. 4.
Ci si è chiesto se tale termine di dilazione si applichi anche
al primo contratto a termine acausale, e la mia opinione in
proposito è decisamente negativa, visto che viene precisato
categoricamente che tale rapporto non può avere una durata
superiore a 12 mesi e non può essere oggetto di proroga10 .
D’altro canto già con riferimento alla disposizione di cui
all’art. 4-bis, che considera a tempo indeterminato il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore quando siano stati superati complessivamente 36 mesi “compresivi di proroghe e
rinnovi”, avevo espresso analoga opinione negativa, che è
stata decisamente smentita da una circolare ministeriale prontamente recettiva della soluzione perorata da alcune organizzazioni imprenditoriali.
La seconda novità attiene invece all’intervallo che deve
necessariamente intercorrere tra un contratto a tempo determinato e un altro, che è stato portato da 10 giorni a 60, per i
contratti con meno di 6 mesi, e da 20 giorni a 90, per i contratti superiore a 6 mesi (art. 1, comma 9, lett. g). La norma
è stata fortemente stigmatizzata dalle OO.SS. imprenditoriali che hanno visto preclusa la facoltà per le imprese di un
rinnovo ravvicinato dei contratti a termine, come solitamente
avviene (talora senza alcuna effettiva soluzione di continuità).
Eppure la norma ha una sua intima coerenza e va a compensare la novità introdotta con il comma 1-bis concentrando i
profili regolatori sui contratti successivi al primo, in quanto
suscettibili di favorire un uso improprio dei contratti a termine e a volte veri e propri abusi, in conformità del resto alle
indicazioni contenute nella Direttiva 99/70/CE 11 . D’altra parte già è prefigurato, nella lett. h), comma 9, art. 1, la possibilità di introdurre deroghe collettive a tali termini per ipotesi
meritevoli di considerazione in quanto connesse all’attivazione di innovativi processi produttivi.
Il terzo termine che viene ritoccato è quello che attiene all’impugnazione dei contratti a termine illegittimi, con
tandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre
i casi e i tempi in essa considerati (art. 14, disp. legge in generale)”.
10 In termini coincidenti con diverse argomentazioni G. Falasca, La riforma, cit.,
p. 13.
11 Su cui per tutte v. da ultimo l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea 12
novembre 2010, e la sentenza C-586/10 del 26 gennaio 2012.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
la previsione per cui, ove si faccia questione della nullità del
termine apposto al contratto, il termine per impugnare è fissato in 120 giorni decorrenti dalla cessazione del medesimo
contratto, mentre il termine per il deposito del ricorso in
cancelleria viene fissato in 180 giorni. A parte la riduzione
complessiva dei termini disponibili (da 330 a 300), la norma
ha una sua razionalità nel consentire un maggiore tempus
deliberandi da parte del lavoratore prima di impugnare un
contratto a termine che potrebbe precludergli un rinnovo, e
va strettamente a raccordarsi con l’allungamento dei termini
di intervallo tra un contratto e l’altro. Sicché, scaduti i 90
giorni, il lavoratore ha 30 giorni residui (per qualcuno insufficienti) per valutare se gli conviene impugnare il contratto
precedentemente stipulato12.
5. L’interpretazione autentica del comma 5, art. 32, legge n.
183/2010, sull’indennità risarcitoria.
Risolutiva in gran parte di ogni questione interpretativa,
risulta infine la disposizione contenuta nel comma 13, che,
sulla scorta della più recente giurisprudenza di Cassazione13
e della recente pronunzia della Corte cost. n. 303/2011, ha
ribadito che l’indennità forfettaria prevista dal comma 5
dell’art. 32, L. n. 183, “ristora per intero il pregiudizio subìto
dal lavoratore comprese le conseguenze retributive e contributive, relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. È
evidente la volontà di fare piazza pulita delle interpretazioni,
a volte molto analitiche e sagaci, prospettate da una parte
della giurisprudenza volte a rendere la norma originaria maggiormente coerente con i principi di diritto civile in materia
di risarcimento dei danni, oltreché con la direttiva comunitaria, e tuttavia la Corte costituzionale si è sin troppo ampiamente dilungata a dimostrare i vantaggi connessi a tale soluzione normativa - che sarebbe addirittura migliorativa per i
lavoratori rispetto al regime preesistente e a quanto avviene
per situazioni affini – con l’intento malcelato di non lasciare
margini per ulteriori sospetti di incostituzionalità.
Si è pure segnalato che il legislatore - non è chiaro con
quale consapevolezza - parla di pronuncia del provvedimento
con il quale il Giudice abbia ordinato la “ricostituzione” del
rapporto di lavoro, lasciando intendere che la declaratoria
della nullità del termine produce un effetto costitutivo ex
novo del rapporto di lavoro, il che dovrebbe ormai precludere la possibilità di considerare il contratto a tempo indeterminato sin dalle origini e di rivendicare l’intero trattamento da
mora credendi nel frattempo maturato14 . È il caso di rimarca-
12 È inutile aggiungere che su questo doppio termine di decadenza si vanno ad
addensare notevoli problematiche già esaminate con riferimento all’art. 32
della legge n. 183/2010.
13 V. Cass. 31 gennaio 2012, n. 1409, Cass. 31 gennaio 2012, n. 2011, Cass. 29
febbraio 2012, n. 3056, e da ultimo Cass. n. 14996/2012, che ha descritto
l’indennità in questione come una sorta di penale, con carattere forfettario,
comprensiva di ogni danno – ivi comprese differenze retributive e scatti di anzianità – derivante dalla nullità del termine.
14 Sul punto v. A. Vallebona, La riforma, p. 22, secondo cui “In questo periodo
il rapporto non esiste, come risulta dalla espressa esclusione dell’obbligo contributivo e dalla parola “ricostituzione”. Non decorre, dunque, alcuna anzianità ad alcun titolo. Si tratta di una invalidità speciale con efficacia ex nunc, a
prescindere da oziose diatribe sulla natura dichiarativa o costitutiva della sentenza”.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
re che l’allontanamento dalle regole del diritto civile sembra
divenire sempre più marcato15 .
6. Il contratto di somministrazione.
Tra le righe dell’articolato normativo sommariamente
analizzato traspare una evidente tendenza alla parziale assimilazione del contratto a termine al contratto di somministrazione stipulato tra l’agenzia e l’impresa utilizzatrice16 . Ciò
avviene anzitutto con riferimento alla previsione che consente anche in questo caso di stipulare un primo contratto acausale, già introdotta per ipotesi tipizzate, ma ancor più per
quanto concerne la previsione secondo cui i periodi di missione si computano nel periodo massimo di 36 mesi ove svolti tra
i medesimi soggetti e con mansioni equivalenti.
La disposizione è importante perché preclude un uso alternato di contratti a termine e contratti di somministrazione,
come in precedenza avveniva specie per evitare il superamento dei 36 mesi, anche se restano notevoli problemi interpretativi connessi alla diversa disciplina del contratto a termine
rispetto a quello di somministrazione. Nonostante qualche
imprecisione terminologica, il legislatore si riferisce al contratto commerciale di somministrazione tra agenzia e utilizzatore e non a quello intercorrente tra agenzia e lavoratore che
risulta integralmente regolato dalla disciplina speciale come
integrata da ultimo dal d.lgs. 2 marzo 2012, n. 24, attuativo
della direttiva 2008/104/CE 17. Si discute, ad esempio, se un
primo contratto di somministrazione seguito da uno a termine debba entrare nel cumulo e se è possibile stipulare un
contratto di somministrazione una volta scaduti i 36 mesi. Su
quest’ultimo profilo si è decisamente espressa in senso favorevole la circ. ministeriale innanzi citata, allorquando ha ritenuto che il periodo massimo di 36 mesi rappresenta un limite alla stipulazione dei contratti a tempo determinato e non
al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne conseguirebbe
che “raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque
15 V. tuttavia da ultimo ord. del Tribunale di Napoli, dr. Coppola, 13 giugno 2012,
di rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per
violazione dell’art. 47 della “Carta” e dell’art. 6 CEDU.
16 Sulla somministrazione vedi i più recenti contributi: M.T. Carinci, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e
subappalto, trasferimento d’azienda e di ramo, Torino, II, 2010; M. Lamberti,
La somministrazione di manodopera in R. Pessi (a cura di), Codice commentato del lavoro, Torino, 2011, p. 429 ss.; O. Mazzotta, La somministrazione
di lavoro tramite agenzia, in A. Vallebona (a cura di), I contratti di lavoro, I,
Torino, 2009, p. 937 ss.
17 In merito alle condizioni di liceità della somministrazione a tempo determinato,
la giurisprudenza di merito è prevalentemente orientata a ritenere che le ragioni sottese alla somministrazione a termine, non diversamente dal contratto a
tempo determinato, debbano essere oggettive, di natura temporanea e debbano
altresì essere debitamente specificate nel contratto di somministrazione di lavoro, ritenendosi, pertanto, non sufficiente la mera e pedissequa riproduzione
della formula normativa di cui all’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003; in
mancanza di specificazione delle predette ragioni, i lavoratori vanno considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto utilizzatore, trovando applicazione l’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, che disciplina la somministrazione irregolare, e cioè la somministrazione posta in essere al di fuori dei
limiti e delle condizioni previste dalla legge: cfr. ex multis App. Torino, 2 marzo 2011, n. 126, in Boll. Adapt, 2011, 27, in www.csmb.unimore.it; Trib. Padova, 1 aprile 2010, in Guida Lav., 2010, 35, p. 55 ss.; Trib. Monza, 27 ottobre 2009, in Riv. crit. dir. lav., 2009, p. 984; Trib. Milano, 5 maggio 2009, n.
1902, in Guida lav., 2009, 28, p. 38; Trib. Milano, 26 gennaio 2009, in Riv.
crit. dir. lav., 3009, p. 414, con nt. di A Vescovini, Somministrazione di lavoro: requisiti formali e sostanziali e applicabilità dell’art. 18 SL; ma v. da ultimo
Cass. 21 febbraio 2012, n. 2521, con riferimento all’impiego del lavoro somministrato per “punte di intensa attività”.
2 0 1 2
13
ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo
stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento
dei 36 mesi”. L’interpretazione della circolare non convince
affatto e non sembra coerente con quanto stabilito dalla lett.
i) del comma 9, che vuole postulare una totale fungibilità ai
fini indicati dei contratti a termine e di quelli di missione.
Anche in questo caso il Ministero sembra avere compreso con
ritardo le implicazioni della disciplina che andava ad introdurre.
Restano notevoli differenze tra le due fattispecie contrattuali e relative regolamentazioni giuridiche, che dovrebbero
indurre ad escludere che i nuovi termini di impugnativa, stragiudiziale e giudiziale, siano applicabili anche al contratto di
somministrazione, ovvero che allo stesso possa essere esteso
il risarcimento forfettario dei danni di cui al comma 5 dell’art.
32, L. n. 183/2010, contrariamente a quanto ritenuto da una
pur argomentata giurisprudenza che troverà ora nuovi stimoli nella parziale assimilazione degli istituti18 .
Rimane pure da approfondire il confronto, in un’ottica
utilitaristica, tra il contratto a termine e quello di somministrazione, che a prima vista sembra decisamente avvantaggiare il secondo modello negoziale che rimane una forma di impiego più vantaggiosa ed elastica per le imprese, anche una
volta gravato della maggiorazione contributiva dell’1,4% ed
esteso il principio di parità di trattamento con i dipendenti
dell’utilizzatore anche ai lavoratori svantaggiati (art. 1, comma
10, lett. a e c). È decisiva la circostanza che non operano né il
vincolo di 36 mesi, né le pause tra un contratto e l’altro19.
7. La portata delle innovazioni sul lavoro a termine nel settore
pubblico.
La disciplina innanzi riportata si applica anche all’impiego pubblico in virtù del rinvio contenuto nel comma 2 dell’art.
36, d.lgs. n. 165, sia pure nei limiti di compatibilità con la
disciplina di settore. È chiaro che la acausalità del primo
contratto a termine non può trovare applicazione nel settore
dovendo i contratti rispondere ad “esigenze temporanee ed
eccezionali” e neppure è consentito estendere quelle parti
delle disposizioni richiamate che contemplano la costituzione
giudiziale di un contratto a tempo indeterminato.
Anche il risarcimento dei danni risponde a parametri diversi da quelli prefigurati dall’art. 32, comma 5, come interpretato dalla norma innanzi richiamata (comma 13), e ciò
anzitutto perché nel caso di specie il risarcimento dei danni è
prioritariamente sostitutivo dell’impossibilità di convertire o
stabilizzare i relativi contratti pur in presenza di violazioni
legislative. Ciò nondimeno alcuni riflessi della nuova normativa si registreranno anche nel settore pubblico, per quanto
concerne, ad esempio, gli intervalli tra un contratto e l’altro
che, ove violati, possono incidere nel calcolo del risarcimento
del danno.
civile
Gazzetta
18 Ma v. contra, sia pure con un incidenter tantum, Corte cost. n. 303/2001, allorquando osserva che “Altro ancora, infine, è la somministrazione irregolare
di manodopera, quando un imprenditore fornisce personale ad un altro al di
fuori delle ipotesi consentite dalla legge”. Opinione da condividere in ragione
della specialità delle due discipline e dei corrispondenti regimi sanzionatori, su
cui v. già art. 22, decreto n. 276.
19 Così A. Vallebona, op. cit., p. 25.
14
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
8. Le modifiche alla disciplina del contratto a progetto.
Altrettanto dense di implicazioni sono le modifiche introdotte alla disciplina del lavoro a progetto, con riferimento
alla quale viene integralmente sostituito il comma 1 dell’art.
61 per stabilire che, salvo determinate categorie tipizzate
(agenti, rappresentanti e lavoratori di call-center), i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione di cui all’art. 409,
n. 3, c.p.c., “devono essere riconducibili a uno o più progetti
specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore”. In altri termini il legislatore, dopo
avere ribadito la disciplina ormai speciale riservata ai callcenter outbound, ha eliminato dalla formula originaria il
riferimento “ai programmi di lavoro o fasi di essi”, per poi
aggiungere che “il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere
in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente”, così come il progetto non può comportare lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi e ripetitivi”.
Com’è facile ricostruire, il legislatore ha voluto sancire la
netta appartenenza dei contratti a progetto alla categoria dei
contratti d’opera regolati dal codice civile eliminando ogni
equivoco e approssimazione che aveva contraddistinto la
precedente regolamentazione. Per dare coerenza a tale disegno, ha prefigurato una rete a maglie così strette da rendere
francamente problematica la stipula di contratti a progetto
per così dire ineccepibili.
Vediamo di percorrere le varie tappe di questa regolamentazione. La nuova normativa conferma che il contratto a progetto ha ad oggetto una collaborazione coordinata e continuativa a cui va aggiunto, con finalità evidentemente antifraudolenza, un elemento additivo rappresentato da un progetto
specifico. Questo, non solo deve essere specifico, e quindi avere un adeguato livello di individualità nel contesto produttivo,
ma deve essere anche collegato a un determinato risultato finale. Il che sembra alludere alla necessità che vi sia un raccordo
teleologico del segmento produttivo affidato al collaboratore
con la più ampia attività produttiva perseguita dall’impresa.
Ma tutto ciò non è stato ritenuto ancora sufficiente per il legislatore, giacché ha richiesto che: a) il progetto non possa esaurirsi in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente; b) deve armonicamente coordinarsi con l’organizzazione di quest’ultimo; c) deve prescindere da una mera rilevazione del tempo impiegato; e d) non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
Non ci si trova soltanto in presenza di una formula ormai
cervellotica, espressione di un confuso eclettismo concettuale,
ma di una formula nella quale si annidano evidenti contraddizioni. Come si è lucidamente chiarito in dottrina 20 , l’individuazione di un progetto non ha valenza qualificativa, né sul
piano della organizzazione del lavoro, né in punto di distinzione tra lavoro subordinato e quello autonomo, come del
resto ci ricorda un’antica elaborazione dottrinale risalente a
Barassi 21 , tant’è vero che il legislatore innesta il progetto su
20 A. Perulli, Opinioni sul lavoro a progetto, in Dir. lav. rel. ind., 2006, n. 2;
Id., Lavoro autonomo e dipendenza economica, oggi in Riv. giur. lav., 2003,
1, p. 221.
21 Ma v. pure per tutti, R. Scognamiglio, Lavoro subordinato, I Diritto del lavoro, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1990.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
una collaborazione coordinata, che allude evidentemente a
modalità di lavoro diverse da quelle del lavoro dipendente
(salvo a tralasciare la tormentata distinzione tra coordinamento e direzione). Il progetto prescinde dal tempo impiegato,
che rimane un elemento estraneo alla fattispecie, ma può
tradursi in “compiti” lavorativi basta che non siano meramente esecutivi e ripetitivi, e tuttavia la rilevanza del tempo impiegato riaffiora implicitamente nei criteri di parametrazione
del corrispettivo, il quale va determinato “in ogni caso sulla
base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle
mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati”
(minimi, com’è noto, determinati in base al tempo della prestazione). Anche la qualità professionale dei compiti delegati
al prestatore è un elemento estraneo alla connotazione di un
lavoro autonomo ed aggiunge piuttosto un ulteriore elemento
di restringimento del progetto, per nulla ragionevole secondo
taluni 22 .
Come se non bastassero i limiti evocati, il legislatore preclude che il progetto possa tradursi in una mera riproduzione
dell’oggetto sociale. Qui è evidente il forte condizionamento
da esperienze specifiche, più volte stigmatizzate dalla magistratura del lavoro, quali in particolare quelle riconducibili ai
call-center, esperienza generalizzata senza rendersi conto
della complessità della problematica che si andava a suscitare
e dei conseguenti margini di incertezza che ne sarebbero derivati. È banale osservare che l’oggetto sociale di una società
di persone o di capitali è solitamente talmente vasto ed eterogeneo da rendere quanto meno complicato mantenerlo del
tutto estraneo nella redazione di un progetto.
Sul punto la fantasia degli interpreti si è sbizzarrita. Alcuni ritengono che il legislatore si sia voluto in realtà riferire
all’attività principale, ovvero al core business dell’impresa,
altri che abbia semplicemente voluto impedire che il contratto
a progetto replicasse integralmente l’oggetto sociale. Quest’ultima interpretazione mi sembra avvicinarsi a una lettura più
pertinente del dato normativo. Tuttavia non posso nascondere la convinzione che la pratica operativa prenderà con ogni
probabilità due strade alquanto difformi: o indurrà a una
semplificazione della formula con sano pragmatismo (che
dovrà tuttavia sempre superare il difficile vaglio giudiziario),
o produrrà un effetto di scoramento riducendo fortemente il
ricorso a tale fattispecie. Non escludo neppure che quest’ultimo sia l’obiettivo perseguito dal legislatore quando si è così
accanito su un elemento sostanzialmente estrinseco alle caratteristiche qualificanti del lavoro coordinato e continuativo,
caratteristiche che pure vengono disordinatamente evocate
quando si chiede di specificare “le forme di coordinamento
del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione,
anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni
caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia
né l’esecuzione dell’obbligazione lavorativa” (art. 62, comma
1, lett. d).
9. Gli equivoci storici sulla parasubordinazione. In realtà sul tema specifico pesano alcuni equivoci ormai
incancreniti. La diffusione delle collaborazioni coordinate e
continuative negli anni ’80 e ’90 è stata parallela allo svilup-
22 A. Vallebona, op. cit., p. 31.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
po del sistema economico e all’introduzione di nuove tecnologie, specie in alcuni settori, che hanno lasciato affiorare
innovative professionalità e modalità di lavoro non consuete
rispetto a quelle tradizionali in quanto non riconducibili alla
dimensione spazio-temporale di un’impresa fordista e taylorista. Di qui, sulle scarne previsioni contenute nell’art. 409, n.
3, c.p.c., surrettiziamente integrate dalla disciplina fiscale e
previdenziale (v. in part. art. 34, legge 21 novembre 2000, n.
342, cd. “collegato fiscale alla Finanziaria 2001”), è andata
progressivamente a delinearsi una categoria, o area contrattuale, alquanto eterogenea con la connessa esigenza di una
regolamentazione specialistica in quanto contraddistinta da
esigenze di protezione sempre più affini a quelle che hanno
ispirato l’originaria legislazione del lavoro dipendente 23 .
Su questo processo in itinere è intervenuta drasticamente
la riforma Biagi che con un’indebita semplificazione ha introdotto la fattispecie del contratto a progetto da rapportare
strettamente al contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. che
in alcun modo contemplava l’ipotesi di una reiterazione continuativa di prestazioni d’opera. Quando poi ci si è resi conto
che una tale impostazione poteva risultare eccessivamente
restrittiva, si è introdotto anche il riferimento al “programma
di lavoro o fase di essa”, espressione interpretata con molta
disinvoltura da alcune importanti circolari ministeriali 24 . Senonché la magistratura del lavoro, in via assolutamente prevalente, ha mostrato di non volere assecondare questo percorso ondivago ed ha applicato con grande rigore la normativa
esistente richiedendo come elemento essenziale di validità del
relativo contratto la sussistenza di uno specifico progetto.
Oggi il legislatore, sulla scorta di tale elaborazione, ha
voluto recuperare la matrice originaria della relativa fattispecie, ma ha in tal modo inevitabilmente dovuto “scaricare” una
vasta area di relazioni lavorative che si nascondevano dietro
quella incongrua figura e che ora viene ineluttabilmente indirizzata nell’area del lavoro dipendente.
La contraddizione di fondo appena ricostruita riaffiora
nella regolamentazione dell’istituto, che va sempre più rapportandosi all’analoga disciplina del lavoro dipendente. Sicché
il compenso del collaboratore viene sempre più demandato
alla contrattazione collettiva di settore, ovvero a quella inerente “alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati”. E la stessa logica ispira sostanzialmente la disciplina
in materia di risoluzione del rapporto (v. art. 22, lett. e, che
sostituisce il comma 2 dell’art. 67), in virtù della quale le
parti possono recedere prima della scadenza del termine soltanto per giusta causa, con effetti quindi alquanto difformi
da quelli contemplati dagli artt. 2227 e 2237 c.c. (anche perché viene aggiunta una fattispecie tipica di risoluzione, alquanto ermetica, che si registra allorquando “siano emersi
obiettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore
tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto”).
Persino il collaboratore può recedere prima della scadenza del
termine con preavviso soltanto ove tale facoltà sia prevista dal
contratto individuale.
23 Certamente le collaborazioni coordinate e continuative hanno avuto successo
anche per il vantaggio competitivo che comportavano rispetto ai contratti di
lavoro dipendente, ma questo è un profilo distinto da affrontare con un adeguato apparato sanzionatorio.
24 Per tutte v. circ. n. 1 del 28 gennaio 2004.
2 0 1 2
15
Tutto ciò lascia chiaramente trasparire la convinzione che
nella pratica attuativa i contratti a progetto non sono altro
che una mistificazione che va decisamente contrastata.
10. L’apparato sanzionatorio sul contratto a progetto. La matrice ideologica della disciplina revisionata affiora
ancora più nitidamente dalle prescrizioni di carattere sanzionatorio. La norma cardine rimane l’art. 69 intitolato “divieto
di rapporti di collaborazione coordinanti e continuativi atipici e conversione del contratto”, integrato da alcune modifiche che si raccordano alla diversa configurazione dell’istituto. La norma esordisce precisando che i rapporti di collaborazione continuativa instaurati senza l’individuazione di uno
specifico progetto ai sensi dell’art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
sin dalla data di costituzione. Disposizione questa che va ora
integrata con quanto stabilito dal comma 24 dell’art. 1, secondo cui l’art. 69, comma 1, “si interpreta” nel senso che
l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del relativo rapporto, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
A questo riguardo occorre appena precisare che il comma
1 dell’art. 62, lett. b), non si limita a richiedere la “individuazione” del progetto bensì la “descrizione” dello stesso “con
l’individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”. Prescrizione che se
per un verso si raccorda a quanto stabilito dall’art. 61, allorché
richiede che i progetti siano specifici, consentirebbe anche di
mantenere distinta l’individuazione del progetto, rilevante ai
fini della validità del relativo contratto, dalla analitica descrizione dello stesso, rilevante a fini probatori.
Diverso è il tenore della disposizione di cui al comma 2,
che riguarda l’ipotesi in cui il contratto a progetto, ritualmente stipulato per iscritto e correttamente individuato all’atto
della costituzione del rapporto, sia venuto ad atteggiarsi come
un contratto di lavoro subordinato che il giudice andrà a
trasformare in un rapporto subordinato “corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti”. Qui il
margine valutativo del giudice è ben più esteso potendo sia
stabilire la data in cui il contratto cambia natura giuridica,
sia individuare la tipologia entro cui va inquadrato.
Una novità di rilievo viene poi inserita nel secondo capoverso del comma 2, con la prescrizione secondo cui “salvo
prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di
costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell’impresa committente” (salve le
prestazioni di elevata professionalità individuate dalla contrattazione collettiva).
La prescrizione colpisce innanzitutto per la sua latitudine
in quanto investe anche le collaborazioni coordinante e continuative per le quali non occorre la prefigurazione di un
progetto e si presenta altresì oltremodo impegnativa nel momento in cui introduce una presunzione legale, sia pure iuris
tantum, per il caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta
con modalità analoghe alle attività svolte dai dipendenti
dell’impresa.
civile
Gazzetta
16
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
La norma è densa di problematicità già per l’aggettivazione
adoperata e imposta a letture molto soggettivistiche. Sul piano
operativo è alquanto frequente che le modalità di lavoro siano
analoghe tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi allorquando siano impiegati in uno stesso settore, anche perché alcune modalità esplicative della prestazione possono essere parzialmente coincidenti, come conferma la diffusa applicazione del
metodo cd. tipologico adottato per la qualificazione della fattispecie, che si fonda sulla combinazione di una serie di elementi
indiziari variabile da fattispecie a fattispecie. Sotto altro profilo
potrebbe darsi il caso che i dipendenti dell’impresa siano impiegati con modalità organizzative affini a quelle dei lavoratori
autonomi, com’è frequente in alcuni settori (della rappresentanza commerciale, ad esempio), senza che ciò pregiudichi la volontà negoziale di costituire un contratto di lavoro subordinato. A
quel punto non si comprende perché quella mera assimilazione
debba costituire la premessa di un’operazione presuntiva. Tutto
ciò induce ad un uso prudente del dato normativo, che dovrebbe
assumere una valenza meramente processuale, nei termini che il
collaboratore dovrà individuare e provare in giudizio analoghe
modalità di lavoro, autonome o subordinate che siano, mentre
il committente dovrà dedurre e provare che quelle modalità di
lavoro sono perfettamente compatibili con la configurazione di
un lavoro autonomo, sia nella forma della collaborazione continuativa, sia del contratto a progetto25.
11. Il regime transitorio.
È importante infine segnalare, per chiudere questo profilo di indagine, che le disposizioni innovative innanzi esaminate (in particolare commi 23 e 24), si applicano ai contratti
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge. Il che determina la coesistenza di due modelli di contratto a progetto, la cui disciplina è sensibilmente differenziata in ragione di un dato meramente temporale (prima o dopo
del 18 luglio). Differenza peraltro accentuata dalla norma
interpretativa dell’art. 69, comma 1 (comma 24) - nel senso
che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce
elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione
la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato – che pure sembra
applicarsi soltanto ai nuovi rapporti. Il che indurrebbe a ritenere che prima dell’entrata in vigore della riforma l’individuazione di uno specifico progetto non avrebbe costituito un
elemento essenziale di validità del rapporto con le conseguenze innanzi richiamate, come in qualche modo ha ritenuto la
famosa circ. ministeriale del 2004.
Così ricostruita la normativa intertemporale, balza subito
all’evidenza non solo un delicato interrogativo sulla facoltà
del legislatore di far operare una norma meramente interpretativa soltanto da una data convenzionale, ma ancor più una
questione di legittimità di regimi giuridici differenziati con
riferimento a situazioni fattuali eguali.
25 Scarsa attenzione in questa sede merita infine il comma 3 dell’art. 69, che riproduce una formula successivamente generalizzata dall’art. 30, comma 1,
legge n. 183/2010, volta a delimitare l’indagine di merito del giudice sulle
scelte organizzative che competono all’imprenditore, ma che qui sembra assumere una portata abbastanza delimitata e cioè quella di rendere incensurabile
la scelta imprenditoriale di ricorrere al lavoro autonomo anziché a quello subordinato.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
12. Le altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo.
La regolamentazione del contratto a progetto si arricchisce
di una normativa relativa alle “altre prestazioni lavorative
rese in regime di lavoro autonomo” (v. comma 26, art. 1, che
aggiunge l’art. 69-bis nel decreto n. 276/2003), che in realtà
riguarda una categoria (se mai si può definire tale) quanto mai
variegata e distinta, vale a dire quella dei soggetti possessori
di partita iva impegnati in un’attività lavorativa. In questi
casi le prestazioni fornite sono presuntivamente considerate
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando
ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata
complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione,
anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo
centro di imputazione di interessi costituisca più dell’80% dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una
delle sedi del committente.
Ciascuno dei presupposti individuati suscita delicate questioni interpretative 26 . I primi due dati, di matrice quantitativa, sono problematici per la loro corretta determinazione.
Quello connesso alla durata di otto mesi nell’arco di due anni,
che vorrebbe evocare una relazione continuativa, è incerto
proprio in merito a tale profilo, giacché non è chiaro se le
singole prestazioni devono avere almeno un minimo di consequenzialità temporale ovvero di coerenza interna. Inoltre si
pone l’interrogativo se ci si riferisca all’anno solare o all’anno
calendariale. Probabilmente il legislatore vuole riferirsi a un
biennio mobile che va ricostruito a ritroso: allorquando si
sono cumulate prestazioni per un periodo di otto mesi nei due
anni pregressi scatta uno dei presupposti indicati.
Il secondo presupposto può essere ricostruito solo a consuntivo e sulla base di dati di cui dispone esclusivamente il
prestatore. Per aggirare l’ostacolo si è richiesto un attestato
da parte del prestatore all’atto della costituzione del rapporto,
che rappresenta una mera correzione pragmatica tutt’altro che
rassicurante, giacché l’attestato può indicare un dato meramente previsionale tale da non impedire che si concretizzi la
percentuale indicata se si incrementa la collaborazione con un
unico committente e/o si riducono altre collaborazioni. Né
sembra consentito attenersi ai dati contabili precedenti il periodo in cui la prestazione viene fornita, come pure si è suggerito, vanificando tale soluzione la finalità protettiva della
norma, che vuole proteggere il collaboratore soltanto quando
si venga concretamente a trovarsi in una condizione di effettiva subalternità economica.
Altrettanto problematico è il terzo presupposto incentrato
sulla sussistenza di una postazione fissa. A leggere l’espressione in termini letterali verrebbe da pensare ad uno spazio fisico di cui il collaboratore può disporre (assegnazione ad una
scrivania, attribuzione di un computer, postazione di lavoro
su un impianto, etc.). Interpretata la formula in tempi così
rigoristi non si vede che attinenza possa avere con un’attività
prestata da un lavoratore con partita iva, che difficilmente
26 Per un esame alquanto analitico si rinvia a G. Bubbola e altri, Le partite iva,
in M. Magnani-M. Tiraboschi (a cura di), La nuova riforma cit., p. 168 ss.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
contempla un radicamento organico all’interno di una struttura logistica predeterminata, e piuttosto la postazione fissa
può essere indice di uno stato di subordinazione in quanto
evocativa di un inserimento organico all’interno dell’azienda.
Per dare un senso alla disposizione si deve ritenere che si sia
adoperata una formula allusiva di un qualche collegamento
fisico o materiale con l’azienda committente in termini che
rinviano ad una continuità o permanenza delle relazioni lavorative. Sotto questa angolazione il criterio si traduce in un
dato integrativo/specificativo di quello della continuità temporale reso così più pregnante.
13. Il meccanismo delle presunzioni e le implicazioni giuridiche. Superati i vari problemi interpretativi, l’aspetto più impegnativo è connesso alle conseguenze giuridiche che se ne vorrebbero trarre dall’inquadrare prestazioni (ipoteticamente) episodiche e scollegate nell’ambito di un programma organico di
collaborazione continuativa. L’obiettivo, appena abbozzato,
è quello di aggiungere un surplus di tutele rispetto a quelle
(inconsistenti) prefigurate dalla disciplina sulle prestazioni
d’opera. L’obiettivo si presenta tuttavia alquanto incerto e
contorto nella sua realizzazione.
Ed invero, una volta inquadrate le poliedriche prestazioni
nell’ambito di un disegno organico di collaborazione continuativa, si pone l’esigenza di ricondurre la fattispecie nella
disciplina specifica prevista per tale categoria di rapporti,
come risultante dalle modifiche introdotte, e quindi di individuare anzitutto un programma specifico nei termini richiesti dall’art. 61, legge n. 276. Il quale, nella maggior parte dei
casi, sarà inesistente o almeno di difficile individuazione, non
essendo prevedibile che nell’ambito di prestazioni episodiche,
ancorché reiterate, le parti si facciano carico, non solo di individuare un progetto, ma addirittura di formalizzarlo e
strutturarlo nei termini prescritti dall’attuale disciplina sulle
collaborazioni coordinate. Ciò ha indotto i primi interpreti a
ritenere che la prescrizione normativa sottintende in realtà
una finzione giuridica, ovvero un vero e proprio escamotage
per ricondurre questi rapporti nella fattispecie del lavoro subordinato, realizzando così una doppia trasfigurazione del
rapporto originario 27. L’ipotesi non sembra attendibile già per
l’immagine che trasmette di un legislatore furbesco che si
prende gioco delle formule adoperate. In realtà, a mio avviso,
la lettura proposta nasce da un’interpolazione di norme e
istituti che devono rimanere distinti. La norma in esame si
limita, e non è poco, a ricondurre prestazioni d’opera episodiche nell’ambito di una collaborazione unitaria in quanto
prestazioni più o meno continuative con un unico committente e con modalità esplicative quantomeno sospette. Una volta
postulata tale presunzione non è affatto richiesto un progetto
nei termini previsti dall’art. 61. Ciò vuol dire, in altri termini,
che quella indicata dal legislatore costituisce un’ipotesi che si
aggiunge a quelle già prefigurate in cui le collaborazioni coordinate e continuative non richiedono un progetto (in quanto esplicitamente o implicitamente escluso dalla disciplina
27 Della “trappola” della doppia presunzione parlano meccanicamente tutti i
primi commentatori dopo le riflessioni di A. Vallebona, cit.; v. per tutti G.
Bubbola-F. Pasquini-D. Venturi, Le partite iva, p. 178 ss., in M. Magnani-M.
Tiraboschi (a cura di), La nuova riforma cit., Milano, 2012; A. Casotti-M.R.
Gheido, Collaborati, in La riforma, cit., p. 30 ss.
2 0 1 2
17
specifica). Sicché la presunzione si esaurisce nel ritenere che
quelle prestazioni sono riconducibili ad una collaborazione
coordinata e continuativa e potrà essere contraddetta dalla
dimostrazione che in realtà non sussistono neppure i requisiti tipici della collaborazione coordinata perché, ad esempio,
la prestazione è resa con la più ampia autonomia organizzativa, con l’apporto di collaboratori, con un elevato contenuto
professionale, etc. Diversamente occorrerebbe ritenere che una
volta realizzatasi la doppia presunzione, e ricondotte quindi
le prestazioni fornite nell’ambito di un rapporto di lavoro
subordinato (in mancanza di un programma), il committente
dovrebbe ribaltare una doppia presunzione, che cioè non
sussistono i requisiti del lavoro subordinato e neppure quelli
della collaborazione coordinata.
La predetta ricostruzione evidentemente non esclude che
il prestatore possa rivendicare la natura subordinata delle
prestazioni effettuate ma ciò solo se ne sussistano gli elementi costituitivi o caratterizzanti e non già sulla base di una
mera presunzione.
14. Le aree soggettive esonerate.
La complessità della disciplina esaminata non finisce qui
giacché il legislatore, dopo avere enunciato un criterio molto
stringente per contrastare il ricorso alle false partite iva, resosi conto della portata tranchant dell’innovazione, ne delimita marcatamente l’ambito soggettivo di operatività escludendo il meccanismo presuntivo in tre ipotesi alquanto rilevanti 28 . E cioè allorquando: a) la prestazione lavorativa sia
connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite
attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità
tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non
inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del
versamento dei contributi previdenziali (sulla base della circ.
INPS 3 febbraio 2012, n. 20, il minimo contributivo ammonta a € 14.930,00, e dunque il reddito di riferimento per la non
operatività per la presunzione legale è pari a € 18.662,50); c)
con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio
di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede
l’iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruolo o elenchi professionali qualificati e detta
specifici requisiti e condizioni 29.
Tralasciamo la maggior parte dei problemi interpretativi
connessi alle singole ipotesi per appena rilevare che la formula sub a) è troppo ampia ed equivoca per una pratica applicazione – che saranno mai le “competenze teoriche” che si aggiungono alle “capacità tecnico-pratiche”? - l’ipotesi sub b)
potrebbe rappresentare un dato del tutto artificiale rimesso
anche in questo caso all’iniziativa esclusiva del collaboratore;
e l’ipotesi (che abbiamo arbitrariamente numerato) sub c) è
civile
Gazzetta
28 Per un più analitico approfondimento, specie per il profilo “professionale”, v.
per tutti G. Bubbola, F. Pasquini, D. Venturi, Le partite iva, cit., p. 174 ss.
29 Sul significato dell’esclusione delle attività professionali dall’area del lavoro
subordinato, ci sia consentito richiamare M. Magnani, Lavoro autonomo e
riforma dei servizi professionali alla luce delle disposizioni comunitarie, già G.
Ferraro, Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, ora in Dir. lav. rel. ind.,
1998, III, p. 79; ma v. pure M. Marazza, La crisi dell’egualitarismo sessantottino nella società del lavoro borghese. La subordinazione attenuata dell’epoca
post industriale, in Arg. dir. lav., 2007, nn. 4 e 5, p. 928 ss.
18
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
contraddittoria con le finalità protettive, tanto più ove si consideri l’estensione della formula adoperata. Infatti in questo
caso, a differenza di quanto avviene con riferimento al comma
3 dell’art. 61, il legislatore esclude dalla tutela speciale, non
solo coloro che sono iscritti ad un ordine professionale, ma
anche genericamente gli appartenenti ad “appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali qualificati”, vale a dire che
si riferisce a una categoria al momento indefinita in tumultuosa espansione per poi rimettere (fortunatamente) ad un decreto ministeriale la ricognizione delle predette attività.
15. La fattispecie di lavoro autonomo economicamente dipendente.
Più interessante è invece segnalare che secondo un’opinione ampiamente accreditata il legislatore avrebbe voluto introdurre nel nostro ordinamento giuridico la fattispecie del lavoro autonomo economicamente dipendente riferibile a quei
soggetti che traggono il proprio reddito da lavoro da un’unica
committenza o almeno da un rapporto preminente. Figura che
affiora ripetutamente in documenti comunitari, dopo essere
stata ampiamente approfondita dalla dottrina giuridica, specie
d’oltralpe, e che trova realizzazione in alcuni testi normativi
di paesi comunitari, tra cui in particolare nell’ordinamento
spagnolo, oltre ad essere presente in alcuni progetti di legge
nazionali sia pure con diverse sfumature30 . Si tratta tuttavia di
una fattispecie lavorativa ancora alquanto indistinta in quanto contrassegnata da elementi di tipo socio-economico che
segnalano uno stato di subalternità di fatto di alcuni lavoratori autonomi rispetto al committente, indipendentemente dalle
modalità e condizioni di lavoro. Dell’approssimazione della
formula dà ampiamente conto l’innovazione legislativa, che
mischia elementi di tipo quantitativo, confusamente determinabili, con elementi strutturali, quale la postazione fissa, non
rilevabili in testi legislativi che si occupano della stessa categoria. Inoltre, nonostante la prescrizione categorica – che suona
come un manifesto ideologico volto a contrastare il ricorso
fittizio a partite iva, secondo i suggerimenti di una rumoreggiante dottrina, che pure, secondo taluni, avrebbe travisato i
dati Inps di iscrizione alla gestione separata – la sua portata
pratica risulta molto circoscritta se si considerano, da una
parte, le ampie esclusioni, e, da un’altra parte, la genericità del
relativo regime protettivo, a tralasciare qualche fugace riferimento al regime previdenziale31 (v. art. 69-bis, comma 5).
30 V. Commissione Europea 2006, Libro Verde dal titolo Modernizzare il diritto
del lavoro per rispondere alle sfide del ventunesimo secolo; v. pure Commissione Europea 2007, Risultati della consultazione pubblica sul Libro Verde. Su
tale problematica ci sia consentito rinviare a G. Ferraro, Il caso italiano: prospettive di attuazione del Libro verde della Commissione europea, “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”, in Dir. rel.
ind., 2007, 4/XVII, p. 1013 ss. La definizione più completa di lavoro
autonomo economicamente dipendente è contenuta nel tit. III dello
Statuto sul lavoro autonomo spagnolo, Ley Estatuto del Trabajo Autònomo, 11 luglio 2007, su cui v. O. Razzolini, lavoro economicamente
dipendente e requisiti quantitativi nei progetti di legge nazionali e nell’ordinamento spagnolo, in Dir. lav. rel. ind., 2011, p. 631 ss. Una fattispecie pressoché
analoga è rintracciabile nella bozza di articolato elaborata da T. Treu destinata
ad aggiungersi al d.d.l. n. 2145 del 2010 in materia del lavoro autonomo.
Inoltre la stessa nozione affiora più volte nel d.d.l. n. 1873 del 2009 promosso
da P. Ichino che la inquadra in una più ampia revisione della fattispecie del
lavoro subordinato.
31 Qualche fugace cenno va infine riservato, sia al comma 5 dell’art. 69-bis che
rende esplicito il principale effetto connesso alla descritta presunzione, nel
senso che gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
16. Le novità in materia di associazione in partecipazione.
Poco spazio resta per riflettere sulle modifiche introdotte
alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro,
anch’esse additate come pratica in gran parte elusiva di lavoro subordinato, eppure sulla base di una sottovalutazione
dell’istituto e delle sue potenzialità, che avrebbe potuto coonestare una forma tipica di lavoro associativo da affiancare a
quelle con finalità mutualistiche.
Il comma 28 dell’art. 1, che integra l’art. 2549 c.c. con un
comma aggiuntivo, stabilisce anzitutto un limite numerico di
tre unità lavorative per gli addetti ad una medesima attività,
a meno che gli associati non siano legati all’associante da
rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo. La trasgressione di tale divieto è quanto
mai severa giacché il rapporto di tutti gli associati (il cui apporto consista anche in una prestazione di lavoro) viene
considerato di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In questo modo la disposizione normativa finisce per riservare l’ambito soggettivo di applicazione delle associazioni
con apporto di lavoro soltanto alle ridotte attività produttive
(a quelle minuscole, secondo una certa interpretazione), e a
quelle costituite in ambito familiare.
È inutile dire che anche su tale disciplina si addensano
molte incertezze interpretative. Il principale quesito su cui si
sono indirizzati gli interpreti consiste nello stabilire che cosa
debba intendersi per una “medesima attività”. Per elasticizzare la formula si è ritenuto che attività poliedriche possano
consentire di replicare il numero di tre associati, specie allorquando l’azienda presenti più sedi distinte. Ma l’interpretazione rimane incerta e anche rischiosa ove si considerino le
implicazioni sanzionatorie che ne potrebbero derivare.
Le maggiori censure sono indirizzate nei confronti della
sanzione prefigurata, quanto mai drastica al punto da determinare, nel caso di superamento delle tre unità, la trasformazione di tutti i rapporti di associazione in rapporto di lavoro
subordinato. L’effetto coercitivo sull’autonomia negoziale
pone effettivamente delicate questioni di compatibilità costituzionale in quanto rapporti di lavoro subordinato potrebbero essere costituiti sulla base di dati meramente quantitativi
totalmente estranei alla definizione della fattispecie, e quindi
indipendentemente dalla volontà delle parti e a prescindere
dalle modalità esplicative della prestazione.
Sostanzialmente conforme invece a orientamenti giurisprudenziali più o meno consolidati è quanto prevede il comma 30, là dove introduce una mera presunzione di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con riferimento ai rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
allorquando non vi sia stata un’effettiva partecipazione agli
utili, ovvero la consegna del rendiconto previsto dall’art. 2552
c.c. 32 . Peraltro la stessa presunzione viene estesa all’ipotesi in
Inps vengono posti a carico per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore (il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei
relativi obblighi di pagamento, ha il diritto di rivalsa nei confronti del committente), sia alla disciplina transitoria, che estende la presunzione di cui al comma
1 dell’art. 69-bis ai soli rapporti instaurati successivamente l’entrata in vigore
della legge, mentre per i rapporti in corso si prevede un periodo di adeguamento da realizzarsi nell’arco di dodici mesi.
32 In adesione a un autorevole indirizzo dottrinale, la partecipazione alle perdite non
è configurabile a carico dell’associato che apporti il godimento di un bene oppure una prestazione d’opera. Diversamente orientata è invece Cass. 21 febbraio
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
cui l’apporto di lavoro non presenti requisiti di cui all’art.
6-bis, comma 2, lett. a) - e cioè non sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio
concreto di attività - con l’intento palese di restringere ulteriormente l’utilizzazione dello specifico contratto.
Il rigore della disciplina trova conferma pure nella disposizione di carattere transitorio (comma 29) che fa salvi, sino
alla loro cessazione, esclusivamente i contratti già costituiti
alla data di entrata in vigore della legge allorquando siano
stati certificati.
17. Considerazioni di sintesi sulle varie forme di lavoro prestato a
favore di terzi. Volendo trarre alcune considerazioni di sintesi, in termini
un po’ impressionisti, va anzitutto evidenziata la scelta del
legislatore di rivalutare il contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato rilanciandolo come figura “dominante”,
o addirittura egemonica, suscettibile di esercitare una notevole forza attrattiva rispetto ad altre fattispecie di impiego
della manodopera. Sotto questo profilo la scelta legislativa si
collega idealmente alle indicazioni che già emergevano nella
Finanziaria del 2006 e nella L. n. 247/2007 – che recepiva in
buona parte i contenuti di un importante Protocollo di intesa
sindacale del 23 luglio 2007, denso di contenuti quanto sfortunato per la sua fugace applicazione – che pure cercava di
invertire la tendenza ormai insostenibile alla segmentazione
e disarticolazione dei rapporti di lavoro con tutti i drammatici costi economici e sociali che vi sono connessi.
L’operazione di allargamento non è neutrale sul piano
dogmatico, comporta un sottile mutamento della fattispecie
classica, o meglio del tipo legale descritto nell’art. 2094 c.c.,
in una direzione proiettata a recepire condizioni di lavoro
diverse da quelle tradizionali: meno eterodirette e controllate,
più elastiche sul piano organizzativo, e anche temporalmente
flessibili e discontinue. Si può dire che ne esce una fattispecie
di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualche modo dilatata sul piano soggettivo e oggettivo rispetto a quella
descritta dalla normativa civilistica, in quanto imperniata su
una concezione della subordinazione meno tecnico-funzionale e con più marcati connotati socio-economici, pure giuridicamente rilevanti, in conformità del resto ad un’importante
pronunzia della Corte cost. - che continuamente affiora nel
dibattito scientifico - che aveva puntualmente delineato un
concetto di subordinazione incentrato sulla doppia alienità
del lavoratore rispetto ai mezzi di produzione e al risultato
perseguito (sent. Corte cost. n. 30/1996).
A fianco di questa fattispecie intrinsecamente revisionata,
che attrae molte figure di lavoro autonomo e associato, viene
abbozzata, o forse meglio vagamente evocata, una figura di
lavoro autonomo economicamente dipendente 33 , ma in posizione assolutamente ancillare e residuale, ovverosia in termini così striminziti e densi di equivoci da lasciare fortemente
2012, n. 2496, a cui si rinvia pure per una dimostrazione del forte condizionamento che la giurisprudenza ha esercitato sul un processo legislativo in esame.
33 È un po’ la proposta di P. Ichino interpretata liberamente: v. Inchiesta sul lavoro cit., sp. p. 55 ss.
2 0 1 2
19
perplessi sull’utilità dell’innovazione. Se ce ne fosse stato bisogno, è questa la migliore conferma che quel fantasma che
aleggia sul diritto del lavoro in Europa è privo di consistenza
sul piano scientifico e rischia soltanto di introdurre elementi
di confusione nella distinzione classica tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.
Dall’area della protezione lavoristica viene sostanzialmente espunta l’ampia categoria del lavoro per così dire professionale, peraltro ricostruito in termini sempre più estensivi, come
può desumersi dall’art. 69-bis, comma 3 (art. 1, comma 26, n.
3), a nulla rilevando l’interpretazione autentica dell’art. 69,
comma 3, a proposito delle professioni intellettuali esonerate
dalla necessità di un progetto, che recepisce un’interpretazione
francamente scontata. L’operazione complessiva non è affatto
trascurabile già per la sua ampia portata soggettiva. Essa è
chiaramente ispirata da una serie di giudizi o pregiudizi di
ampia divulgazione: che l’attività professionale trovi la sua
collocazione naturale nell’ambito dei vari contratti di lavoro
autonomo; che essa sia di per sé intrinsecamente qualificata;
che la sua protezione sia demandata alle regole e alle iniziative
della singola corporazione che ne governa l’iscrizione e le condizioni di impiego anche sotto il profilo previdenziale.
Non ritengo di potere mettere in discussione in questa
sede alcuni di tali giudizi o pregiudizi, mi limito ad osservare
che si pongono oggettivamente in contraddizione con l’obiettivo di proteggere alcune manifestazioni di lavoro autonomo
economicamente dipendente che nella pratica operativa riguardano in modo preminente il lavoro intellettuale più o meno
qualificato. Tutto ciò è del resto il riflesso di un’altra scelta che
traspare dal testo di riforma allorquando postula una simmetria ricostruttiva secondo la quale il lavoro manuale, o per
meglio dire comportante lo svolgimento di compiti esecutivi
o ripetitivi (art. 61, comma 1), o comunque non adeguatamente qualificati (art. 69-bis, comma 3, art. 1, comma 30), andrebbe comunque incanalato nella fattispecie del lavoro dipendente, là dove il lavoro intellettuale dovrebbe orbitare
nell’area del lavoro autonomo (sempreché il contenuto completo delle prestazioni sia riconducibile alle attività per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi).
All’interno del lavoro subordinato si registra altresì un
certo rimescolamento delle carte, specie per quanto concerne
il peso inusitato che viene ad assumere il primo contratto di
lavoro a termine (anche nella forma delle missioni) che, essendo ormai acausale, finisce per essere dotato, nonostante l’incremento della contribuzione, di grande appeal per i datori di
lavoro, quale canale preferibile di ingresso e di sperimentazione di nuovi rapporti, al punto da mettere in ombra altre
forme di impiego pure molto enfatizzate, in primis l’apprendistato. In presenza di un contratto così “facile” non si comprende che interesse possano avere le imprese, se non per
autentiche esigenze formative o per avvantaggiarsi di incentivazioni varie, a invischiarsi in contratti di apprendistato,
ancora abbastanza burocratici, con una formazione spesso
dispersiva, esasperatamente contesa tra Regioni e Governo
centrale, e oltretutto con il rischio sempre incombente di un
drastico intervento della magistratura.
Anche una tale operazione non è priva di riflessi sul piano
dogmatico e ricostruttivo inducendo a ridimensionare ampiamente il dibattito sulla necessità o meno della temporaneità
delle esigenze che devono contraddistinguere il contratto a
civile
Gazzetta
20
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
termine34 . Il contratto a termine è ovviamente temporaneo,
ma le esigenze per le quali viene sottoscritto possono ormai
essere le più eterogenee, finanche stabili o organiche, o, come
dice il legislatore, ordinarie, atteso che non è più consentito
sindacare le ragioni per le quali viene adoperato. Ciò vuol
dire che le istanze di tutela si trasferiscono prevalentemente
sulla disposizione che stabilisce un limite temporale complessivo oltre il quale non è lecito protrarre rapporti a tempo determinato, con tutti i rischi che una tale tecnica comporta di
favorire un ampio turnover della manodopera e persino “il
ritorno” al lavoro sommerso.
Rispetto all’ampliamento dell’area della subordinazione si
registra un parallelo restringimento dell’area del lavoro autonomo, riservato ormai a una enclave di rapporti abbastanza
tipizzati per i quali è possibile prefigurare preventivamente un
progetto con risultato finale più o meno conforme al modello
tradizionale del contratto d’opera. Peraltro la formulazione di
un contratto a progetto è divenuta così sofisticata, anche da
un punto di vista redazionale, da renderla istintivamente
poco attraente, tanto più ove si considerino i costi progressivamente crescenti che persino sul piano fiscale e contributivo
si andranno ad allineare a quelli del lavoro dipendente. Certamente restano ancora alcune convenienze economiche e di
flessibilità organizzativa, connesse prevalentemente all’esonero dal TFR e a una maggiore elasticità di risoluzione del
rapporto, ma sono differenze che si vanno progressivamente
erodendo, ove si consideri, tra l’altro, l’elasticizzazione del
regime dei licenziamenti individuali, i vincoli tariffari allineati a quelli del lavoro dipendente e i costi che occorre mettere
in bilancio per un probabile contenzioso del lavoro. Secondo
la stessa logica ispiratrice, il legislatore manifesta una forte
diffidenza nei confronti di tutte le forme di collaborazione
continuativa estranee ai due principali modelli standard (lavoro subordinato e progetto), ad iniziare dalle prestazioni dei
possessori di partita iva, sino alle collaborazioni coordinate
e continuative, e ancora con riferimento alle figure, più o
meno articolate, di rapporti associativi. Qui emerge nitidamente il disegno di indirizzare quanto più è possibile questi
rapporti sotto l’egida della subordinazione.
18. Le tecniche normative per imporre il modello dominante.
In questa prospettiva il legislatore opera attraverso due
tecniche congiunte: una più soft e l’altra più coercitiva. In
alcuni casi prefigura una presunzione legale relativa di subordinazione in presenza di alcuni elementi indiziari che dovrebbero consentire di dissimulare l’autenticità dei rapporti di
lavoro sottostanti 35 . È quanto avviene, ad esempio, con riferi-
34 Sulla temporaneità v. per tutte Cass. n. 10033/2010 che, con riferimento alle
recenti innovazioni legislative, ritiene che varrebbero solo “ad escludere che
l’apposizione del termine sia consentita solo in presenza di circostanze connotate da eccezionalità e imprevedibilità”.
35 Non saprei fino a che punto è pertinente il riferimento al meccanismo delle
presunzioni, se tali devono considerarsi le conseguenze che la legge o il giudice
trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto (art. 2727 c.c.). Nei casi richiamati i fatti noti sarebbero le modalità di lavoro dalle quali si vorrebbe
trarre la conseguenza che le parti hanno in realtà voluto stipulare un contratto
di lavoro subordinato. In realtà l’obiettivo che traspare non è tanto di individuare la reale volontà negoziale e neppure di ricostruire l’autenticità della relazione giuridica instaurata tra le parti, semmai dissimulando un contratto simulato, quanto di convogliare determinati rapporti ambivalenti, o per così dire
border line, nell’area della subordinazione. Pertanto più pertinente è ritenere
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
mento al contratto di lavoro a progetto, allorché presenta
modalità esplicative analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti impegnati nella stessa impresa (art. 69, comma 2, d.lgs.
n. 276/2003), ovvero per quanto concerne, in forme più contorte, le partite iva (art. 69-bis, comma 1, decreto cit.), che
vengono di fatto ricondotte nell’area della subordinazione,
secondo taluni, oppure delle collaborazioni coordinate e continuative, secondo altri, o ancora con riguardo alle associazioni in partecipazione in cui non vi sia un’effettiva partecipazione agli utili da parte dell’associato, ovvero non venga
consegnato il rendiconto (ovvero in cui la qualificazione professionale del prestatore sia di livello medio-basso) (art. 1,
comma 30, legge cit.).
Ma il legislatore adopera anche un’altra tecnica più coercitiva qualificando direttamente come rapporti di lavoro subordinato alcune relazioni lavorative che non presentano i
requisiti e le condizioni prescritte dalla legge, e ciò a prescindere totalmente dalle modalità esplicative del rapporto e
persino dalla dichiarata o sottostante volontà delle parti. È
quanto avviene, ad esempio, con riferimento al contratto di
apprendistato, nell’ipotesi in cui l’impresa non abbia stabilizzato una certa percentuale di apprendisti impiegati negli ultimi 36 mesi (v. ora comma 3-bis, art. 2, d.lgs. n. 167/2011),
oppure con riferimento ai rapporti di associazione in partecipazione allorquando sia stato superato il numero di contratti
consentiti per una medesima attività (v. comma aggiunto
all’art. 2549 c.c.) (ma si potrebbe includervi anche il comma
1 dell’art. 69, per il caso di mancata indicazione di uno specifico progetto).
È evidente che questa legislazione è ispirata da una finalità
antifraudolenta risultando fortemente influenzata dalla campagna mediatica sui rapporti mascherati di lavoro subordinato, e tuttavia ci sarebbe molto da riflettere sulla sagacia di una
tecnica legislativa così fortemente condizionata da fenomeni
patologici, a volte di dimensioni meno esasperate di quelle che
si suppongono (è il caso delle partite iva). Si potrebbe pensare
che altro è individuare rimedi sanzionatori per perseguire
frodi ed illeciti, altro è configurare istituti che siano corrispondenti alle effettive esigenze della società civile e del mondo
della produzione. Le distorsioni di una tale impostazione metodologica affiorano nitidamente, ad esempio, nella previsione
che incrementa il periodo successivo alla cessazione del contratto a termine al contempo prevedendo una sollecita comunicazione agli Uffici del lavoro, che modifica la ratio originaria
della disposizione, di consentire una tolleranza per mere distrazioni, e di fatto autorizza una proroga del contratto a
termine al di fuori della disciplina specifica (art. 5, comma
2-bis, d.lgs. n. 368/2011). Lo stesso può dirsi per l’analoga
previsione in materia di lavoro intermittente ove l’impiego
variabile del lavoratore va comunicato sin dal primo giorno,
per evitare un uso strumentale della fattispecie, con il rischio
che il legislatore abbia voluto regolare un mero meccanismo di inversione
dell’onere della prova, in virtù della quale il collaboratore indicherà gli elementi indiziari richiamati dal legislatore e il datore o committente, oltre a contrastarli, chiederà di provare che quegli elementi sono perfettamente compatibili
con il tipo legale prescelto. Sulla portata delle presunzioni nella qualificazione
delle fattispecie lavorative v. L. Nogler, Sulla inutilità delle prescrizioni legali
relative in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1997,
1, p. 312.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
però di comprometterne la funzione organizzativa e la naturale flessibilità (art. 35, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003).
19. I dubbi di costituzionalità per violazione dei tipi legali.
Peraltro una normativa così congegnata fa affiorare naturalmente sospetti di compatibilità con l’assetto istituzionale
segnatamente là dove “spinge” (o meglio impone) verso un
modello dominante. In questa prospettiva si è invocato da
taluni la teorica della indisponibilità del tipo legale, così come
teorizzata da due famose pronunzie della Corte costituzionale (nn. 121/1993, 115/1994), e dopo alcuni accenni da parte
di qualche autorevole autore 36 , tutti i primi commentatori si
sono affrettati a replicare lo stesso dubbio di illegittimità. Ma
il rilievo non è affatto pertinente. Il principio legale di indisponibilità del tipo è invocabile con riferimento alla fattispecie del lavoro subordinato allorquando il legislatore, in presenza di requisiti fattuali tipici della subordinazione, pretende
di sottrarre determinate categorie di rapporti dal loro naturale assetto disciplinare per applicare una regolamentazione
ad essi in parte estranea 37. Se ciò è vero non è invocabile l’argomentazione inversa. In linea di principio il legislatore può
sempre disciplinare, con una tutela supplementare, determinati rapporti di lavoro autonomo là dove presentino modalità
esplicative affini a quelle del lavoro dipendente, così come può
dilatare il tipo legale “contratto di lavoro subordinato” sino
a comprendervi modalità e forme di impiego originariamente
non considerate in quanto non rigidamente subalterne ed
etero dirette. In questi casi non è censurabile la prospettiva di
politica del diritto perseguita, rientrante nella piena discrezionalità del legislatore, ma semmai la tecnica adoperata in
presenza di una disciplina protettiva che ancora orbita su una
fattispecie tipica che viene ora implicitamente dilatata.
Piuttosto nella casistica richiamata può porsi un problema
di legittimità costituzionale per il marcato condizionamento
della connessa libertà/diritto al lavoro e della connessa libertà di impresa, costituzionalmente garantiti (artt. 2, 3, 4, 35,
41 Cost.), oltre a essere la scelta legislativa sempre sindacabile sotto il profilo della razionalità, specie allorquando dia
luogo a disparità di trattamento tra situazioni equivalenti,
ovvero a uniformità di trattamento tra situazioni eterogenee.
In questa valutazione il Giudice costituzionale non potrebbe
prescindere da un esame complessivo del testo di legge, degli
obiettivi concretamente perseguiti, e dei complessi meccanismi di compensazione tra i vari istituti 38 .
36 A. Vallebona, La riforma, cit., pp. 31 ss. e 36 ss.; P. Tosi, L’associazione in
partecipazione, in F. Carinci-M. Miscione, Commentario, cit., p. 142 ss.
37 In altri termini i Giudici costituzionali hanno sostanzialmente censurato l’impropria sottrazione alla disciplina del lavoro dipendente di rapporti che presentano i requisiti della subordinazione sul presupposto che un tale regime peculiare di tutela trova fondamento nel testo costituzionale il quale avrebbe in
qualche modo costituzionalizzato lo status di lavoratore dipendente connettendovi intrinsecamente un determinato apparato di tutela con esso indissolubile.
38 Qualche fugace riflessione va pure riservata alla disciplina transitoria, anch’essa in qualche misura inusitata in quanto declinata istituto per istituto, con alcune contraddizioni interne che la espongono a sospetti di irragionevolezza. Per
richiamare i casi più eloquenti, basta considerare il comma 18 dell’art. 1, che
applica le innovazioni sull’apprendistato “esclusivamente con riferimento alle
assunzioni con decorrenza dall’1.1.2013”, oppure alla disciplina sul lavoro
intermittente, per cui i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore
della legge, non compatibili con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di
produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
(comma 22), ed ancora l’omologa norma sui contratti a progetto, che applica
2 0 1 2
21
20. L’equilibrio tra le varie forme di flessibilità. Il consolidamento di un modello dominante nell’impiego
della manodopera segna il parallelo declino del lavoro autonomo nelle sue molte sfaccettature (almeno come “utilizzato”
nel nostro paese), e si raccorda ad analoghe tendenze rilevabili nei più evoluti sistemi industriali dell’Unione Europea (in
primis Germania e Francia), nei quali tuttavia una semplificazione dei modelli di impiego si connette intimamente a una
più accentuata flessibilità oraria, organizzativa, professionale e persino salariale 39. Sotto questo profilo il testo di riforma
è sfuggente e anzi potrebbe apparire addirittura in controtendenza, ove si consideri l’ennesimo ritocco delle clausole elastiche e flessibili nel lavoro a tempo parziale ed alcune rigidità introdotte nel lavoro intermittente 40 . Eppure le varie forme
di flessibilità andrebbero opportunamente integrate e dosate
per evitare effetti contraddittori e persino in qualche caso un
sovraccarico di rigidità a causa di norme non più attuali o
addirittura controproducenti, come può ritenersi in materia
di ius variandi e mobilità professionale, la cui disciplina è
ormai travolta dalle nuove tecnologie e dai processi permanenti di ristrutturazione aziendale.
21. Le soluzioni prescelte nel quadro delle varie proposte dottrinali e legislative.
Voglio in conclusione provare, sia pure sinteticamente, a
raccordare le novità legislative con l’ampio dibattito giuridico
e sociale che lo ha anticipato e in qualche modo preparato.
Con riferimento al lavoro autonomo, può dirsi che il legislatore non ha tenuto conto delle proposte variamente articolate volte a configurare una figura autonoma di collaborazione continuativa, e ciò a dire un tertium genus da collocare
in un ambito intermedio tra lavoro subordinato e lavoro autonomo con un proprio specifico statuto protettivo. E neppure ha coltivato l’idea di ripensare globalmente l’apparato di
le disposizioni più innovative – e tale viene considerata persino l’interpretazione autentica dell’art. 69, comma 1 – “ai contratti di collaborazione stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” (comma 25).
Viceversa per i possessori di partita iva il legislatore contempla una disposizione più gradualista applicando il meccanismo presuntivo, ivi compresa la disposizione dell’art. 69, comma 1, ai rapporti instaurati successivamente all’entrata
in vigore della legge, là dove per i rapporti in corso è previsto un periodo di
adeguamento di 12 mesi. Ancora diversa è la regolamentazione relativa alle
associazioni in partecipazione, la cui disciplina, pur molto pervasiva, è immediatamente operativa, con esclusiva salvezza dei contratti certificati ai sensi
dell’art. 75, decreto n. 276, che continuano ad operare sino alla loro naturale
scadenza (e cioè in molti casi a tempo indeterminato).
La logica che ispira un simile percorso regolamentare non è immediatamente
intellegibile, se non ipotizzando che il legislatore abbia voluto colpire in termini più perentori i contratti, o pseudo contratti, che destano maggiore allarme
sociale per la diffusa convinzione di mascherare rapporti di lavoro subordinato.
Indipendentemente dalla fondatezza di tale ipotesi, colpisce una vistosa difformità di trattamento di casi affini, che verrà ampiamente stigmatizzata da coloro che vorranno colpire il testo legislativo con eccezioni di costituzionalità.
39 Su questi aspetti v. G. Ianniruberto, La flessibilità nello svolgimento del
rapporto di lavoro, in Mass. giur. lav., 2009, 6, 412.
40 In particolare l’art. 1, comma 20, lett. b), modificando l’art. 3, comma 9, d.lgs.
n. 61/2000, interviene in materia di consenso scritto del dipendente all’introduzione delle clausole flessibili ed elastiche nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto introducendo, a favore di alcune tipologie di lavoratori che abbiano già manifestato il consenso alla suddetta clausola, la facoltà di
revocare la precedente manifestazione di volontà. Come si è rilevato (P. RauseiL. Scolastici, Il lavoro a tempo parziale in M. Magnani-T. Tiraboschi, La
nuova riforma cit., p. 139 ss.), la regolamentazione dell’istituto continua a subire alterne modifiche anche alquanto contraddittorie ove si consideri che la
legge di stabilità 2012, in linea con la direttiva 97/81-CEE, sembrava orientata
ad una semplificazione nell’utilizzo delle clausole in questione.
civile
Gazzetta
22
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
tutela del lavoro a favore di terzi costruendo un sistema protettivo a strati concentrici con una tutela di carattere generale che va progressivamente ad accentuarsi e a specializzarsi in
relazione all’accrescersi delle manifestazioni di dipendenza.
Il legislatore ha invece preferito da una parte dilatare la
categoria del lavoro subordinato assecondando orientamenti
maggioritari della giurisprudenza del lavoro, e da un’altra
parte ha “captato” qualche generica indicazione volta a prefigurare un apparato minimalistico di tutela con riferimento
al lavoro autonomo economicamente dipendente, anche se ha
poi proceduto in una dimensione sostanzialmente marginale
e tra le molte incertezze evidenziate.
Con riferimento al lavoro subordinato, non sono state
granché seguite le varie proposte, anche legislative, insistentemente reclamizzate negli ultimi anni volte a configurare un
contratto unico di lavoro dipendente secondo analoghe esperienze d’oltralpe, contraddistinto cioè da una maggiore flessibilità nei primi anni del rapporto e dall’attribuzione progressiva di tutele sempre più rassicuranti. Anche se alcuni ritengono41 ,
ma impropriamente, che qualcosa di analogo sarebbe rintracciabile nel restyling del contratto di apprendistato, e tuttavia
l’idoneità di questa fattispecie contrattuale a svolgere un ruolo
preminente nel reclutamento della manodopera, specie giovanile, va ancora tutta verificata sul piano applicativo.
Persino sul tema della flexicurity il legislatore sembra
sfuggente. Dopo avere enunciato grandi propositi di volere
contrastare il precariato e superare i vari dualismi che contraddistinguono il mercato del lavoro in Italia, in un quadro
di tutele universalistiche dispiegate prevalentemente sul terreno della sicurezza sociale, il legislatore ha finito per operare
in un’ottica sostanzialmente conservativa con alcuni ritocchi
alla legislazione precedente senza neppure abbozzare una
vera rete di protezione sociale delle situazioni più instabili e
precarie. Basterebbe pensare alla inconsistenza della mini
Aspi, riservata ai rapporti più fragili, ovvero alla “una tantum” per i parasubordinati, istituti che sostanzialmente replicano esperienze già preesistenti42 . Insomma il legislatore ha
preferito operare prevalentemente su un terreno alquanto
collaudato, consolidando alcuni indirizzi giurisprudenziali e
puntando sulla progressiva estensione del contratto di lavoro
subordinato attraverso un meccanismo combinato di tecniche
sanzionatorie e incentivazioni economiche e giuridiche. In
questo modo ha indubbiamente ampliato i confini della subordinazione inglobando condizioni soggettive in qualche
modo limitrofi, ma ha lasciato al di fuori dell’area protetta
ampie schiere di lavoratori precari e marginali che continuano
ad orbitare in un’area di instabilità e di incertezza. Il che farebbe pensare che il tradizionale dualismo del mercato del
lavoro italiano, tanto deprecato, anziché essere stato superato,
sia stato diversamente ridisegnato.
41 Così M. Tiraboschi, in molteplici interventi sul tema, v. per tutti L’apprendistato come ipotesi di contratto prevalente, in M. Magnani-M. Tiraboschi (a
cura di), La nuova riforma, cit., p. 116 ss. Per un’opinione critica v. F. Carinci,
E tu lavorerai, cit., passim.
42 Amplius M. Cinelli, Gli interventi 2011-2012 di riforma delle pensioni e degli
ammortizzatori sociali: riflessi sul sistema del welfare, relazione AGI 2012,
dattiloscritto, sp. p. 33 ss.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
Abstract
Il saggio esamina le principali novità della recente riforma
del mercato del lavoro con riferimento alle tipologie contrattuali che risultano significativamente modificate nella prospettiva di superare la segmentazione e conseguente precarizzazione dei rapporti di lavoro.
L’Autore si sofferma in particolare sul contratto a termine,
rinnovato con la previsione di un primo contratto acausale,
sui contratti di lavoro autonomo, resi sempre più difficili
quando si muovono su una linea di confine con il lavoro dipendente, e sui rapporti di stampo associativo, anch’essi
profondamente revisionati in una prospettiva restrittiva.
Dopo avere esaminato i punti più problematici di ciascun
istituto, l’Autore si sofferma sulle tecniche attraverso cui il
legislatore è orientato a rendere “dominante” il contratto di
lavoro a tempo indeterminato e parallelamente a restringere
l’ambito soggettivo del lavoro autonomo.
Nell’esame complessivo emergono scelte di politica del
diritto, in parte ampiamente condivise, che pure faranno
emergere notevoli dubbi di illegittimità costituzionale.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
●
Il nuovo rito speciale per
le cause di licenziamento.
Legge 28 giugno 2012 n. 92,
art. 1, commi 47-68
● Umberto Lauro
Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale
di Torre Annunziata
2 0 1 2
23
Sommario: 1. Ambito di applicazione – 1.2. Le fattispecie
relative alla qualificazione dei rapporti di lavoro. – 1.3. Le
altre domande promosse congiuntamente alla domanda principale. – 2. Il nuovo rito speciale: La fase sommaria. – 2.1.
Caratteri. Forma e contenuto dell’atto introduttivo. Giudice
competente. Instaurazione del contraddittorio. – 2.2 Il procedimento. – 2.3. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza. – 2.4.
Rapporti con l’articolo 700 c.p.c. – 2.5. Alcune problematiche
in tema di oneri probatori ed allegatori. – 2.6. Provvedimenti in caso di ricorso proposto relativamente a licenziamento
non ricompreso nell’ambito di applicabilità della norma o di
ricorso ricomprendente domande diverse non proponibili. –
2.7. Domanda riconvenzionale o di chiamata in garanzia o
verso altri soggetti cui la causa è ritenuta comune. – 3. La
fase del giudizio di opposizione. Forma introduttiva e termini. Contenuto del ricorso. – 3.1. Il giudizio di opposizione.
– 3.2. Il procedimento. – 3.3. La decisione della causa. – 4.
Reclamo innanzi alla Corte d’Appello e ricorso per Cassazione. – 5. Disposizioni generali.
1. Ambito di applicazione (art. 1, commi 47, 48, 67).
La nuova disciplina processuale, in tema di licenziamenti,
trova applicazione, secondo l’espressa previsione del comma
67, limitatamente alle controversie instaurate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge e, quindi, alle controversie instaurate dal 18.07.2012.
Individuato l’ambito di applicazione temporale, deve poi
rilevarsi in relazione a quello materiale, che la riforma riguarda come espressamente dispone il comma 47, “le controversie
aventi ad oggetto l’impugnativa di licenziamenti soggetti alla
disciplina dettata dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, e
successive modificazioni, anche quando devono essere risolte
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.
La procedura speciale riguarda solo le cause aventi ad
oggetto le ipotesi di licenziamenti individuali sottoposti alla
disciplina dettata dall’articolo 18 legge 20.5.1970 e successive
modifiche (occorre considerare quindi la versione attuale
dell’articolo introdotta dalla stessa legge, vedi precedente
comma 42), con l’aggiunta, di non semplice interpretazione,
che tanto vale “anche se devono essere risolte questioni attinenti alla qualifica del rapporto”.
Resta pertanto ininfluente (sotto il profilo processuale) la
data del licenziamento, il cui rilievo rimane circoscritto alla
disciplina sostanziale applicabile alla fattispecie (“tempus
regit actum”).
Più particolarmente, avuto riguardo al nuovo articolo 18,
il rito speciale certamente si applica nel caso di:
Lavoro subordinato (a tempo indeterminato) in cui si prospetti la risoluzione del rapporto per:
• licenziamento discriminatorio o orale (senza limiti dimensionali);
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
licenziamento per motivi procedurali (con i limiti dimensionali noti);
• licenziamento del dirigente in violazione art. 18 comma 1
come modificato;
• licenziamento in concomitanza di matrimonio (art. 35
decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, codice pari opportunità);
civile
Gazzetta
24
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
l• licenziamento in violazione divieti art. 54, commi 1, 6, 7,
9 t.u. disposizioni legislative in materia di tutela della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001 n. 1517;
• licenziamenti collettivi.
È, invero, decisivo il richiamo all’applicabilità del regime
sanzionatorio previsto dall’articolo 18 operato dal terzo comma dell’art. 5 legge n. 223 del 1991, come modificato dall’art.
1, comma 46 legge n. 92/2012.
• licenziamento operato nell’ambito del rapporto di impiego
pubblico contrattualizzato.
Al rapporto in questione trova invero applicazione l’articolo 18 in virtù del rinvio operato dall’articolo 51 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per il quale “la legge 20
maggio 1970 n. 300 si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti” (vedi Cass. civ.
05.11.2011 n. 160).
Restano, invece, escluse ipotesi come quelle aventi ad
oggetto:
• licenziamenti individuali assistiti da stabilità obbligatoria
quando per l’applicazione dell’articolo 18 rilevi il requisito dimensionale (vedi sopra), a meno che la tutela obbligatoria non sia richiesta in via gradata rispetto a quella
reintegratoria.
In quest’ultimo caso, secondo l’opinione più accreditata e
convincente, il rito speciale trova applicazione per un effetto
di trascinamento operato dalla domanda principale su quella
subordinata.
le controversie in cui si deduca l’illegittima apposizione
del termine e se ne chieda il riconoscimento con conversione
del contratto a tempo in contratto a tempo indeterminato.
Non può negarsi al giudice il potere di qualificare la domanda e di considerare quindi che in queste controversie “si
tratta di valutare la illegittimità dell’apposizione, che non si
equipara ontologicamente ad un licenziamento, trattandosi di
considerare il termine apposto tamquam non esset e di considerare ex tunc il contratto come a tempo indeterminato.
Ciò non tanto perché le relative controversie non involgano una questione di qualificazione in senso lato del rapporto,
quanto piuttosto perché il petitum principale non è l’impugnativa di un licenziamento (fatto rilevante in un contratto a
prestazioni corrispettive nel momento funzionale del sinallagma, ossia a rapporto sussistente), ma l’illegittima apposizione
del termine (fatto rilevante nel momento genetico del sinallagma, ossia al momento della stipulazione del contratto e
all’inizio del rapporto).
D’altro canto, la Cassazione ha più volte ribadito che
nell’ipotesi di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato, e di comunicazione al lavoratore, da parte
del datore di lavoro, della conseguente disdetta, non sono
applicabili né la norma di cui all’art. 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, né quella di cui all’art.18 della legge 20 maggio
1970, n.300, ancorché la conversione del rapporto a termine
in rapporto a tempo indeterminato dia egualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato. infatti,
mentre la tutela prevista dall’art. 18 cit. attiene ad una fattispecie tipica, disciplinata dal legislatore con riferimento al
recesso del datore di lavoro, e presuppone l’esercizio della
relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
di determinare l’estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale
il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunichi la scadenza del termine, sia pure
invalidamente apposto, al dipendente, sicché lo svolgimento
delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla (cfr. Cass. S.U. sentenza n.
14381 del 08/10/2002; conforme Cass. n.8352 del 26/05/2003;
n.11699 del 30/07/2003; n.4615 del 06/03/2004; n.8734 del
07/05/2004; n.7966 del 05/04/2006; n.8294 del 10/04/2006;
n.20858 del 27/10/2005; n.8903 del 13/04/2007; n.7979 del
27/03/2008; n.6010 del 12/03/2009; n.12011 del 25/05/2009;
contra Cass. n. 9360 del 10/09/2010 secondo cui “quando il
rapporto di lavoro a tempo determinato viene qualificato
come rapporto a tempo indeterminato, l’atto con il quale il
datore di lavoro comunica la scadenza del termine integra
nella sostanza un licenziamento”).
Costituisce eccezione alla regola generale l’ipotesi in cui,
in coincidenza con la scadenza del termine, che si assume illegittimamente apposto, il datore di lavoro non si limiti a
comunicare la scadenza medesima, ma irroghi un vero e proprio licenziamento, nel presupposto dell’intervenuta conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo
indeterminato (Cass. 14.07.2003 n. 11017).
1.2. Le fattispecie relative alla qualificazione dei rapporti di
lavoro
Come si é anticipato, relativamente alle fattispecie alle
quali trova applicazione il nuovo rito (quelle in precedenza
elencate), quest’ultimo risulta applicabile “anche quando
devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del
rapporto di lavoro”.
Già per la sua collocazione, nell’ambito della disposizione
dettata dal comma 47, posta immediatamente dopo l’indicazione delle controversie alle quali la riforma si applica, l’inciso sembra riferibile ai soli casi in cui non vi sia disputa sulle
parti del rapporto di lavoro, essendone in contestazione soltanto la qualificazione.
A conferma di ciò, può aggiungersi, poi, che anche la
“ratio” della riforma orienta per un’interpretazione rigorosa
ed atta ad escludere un eccessivo allargamento della procedura, evitando, in tal modo, di vanificare l’obiettivo perseguito
dal legislatore, che ha inteso creare, nell’ambito di un rito
speciale, un processo ancor più speciale, obbligatorio ed a
cognizione estremamente sommaria, al fine di permettere la
rapida risoluzione di alcune controversie particolarmente
sentite e ritenute meritevoli di una corsia preferenziale, anche
a discapito di altre pure importanti.
Quindi, nell’individuare la portata dell’inciso, occorre
tener presente che la questione principale da risolvere, in via
sommaria e celere, resta pur sempre quella della “legittimità
o meno del licenziamento contestato”, con riferimento al
quale va stabilito ciò che, in via eccezionale, è trattabile,
contemporaneamente, in aggiunta ad esso.
In considerazione di tanto, l’ampliamento del campo di
applicazione della procedura speciale, per la necessità di qualificazione del rapporto, va limitato ai soli casi in cui:
si contesti, dalla parte ricorrente, la natura autonoma o
parasubordinata che il rapporto formalmente presenta e si
sostenga la sussistenza, nella realtà fattuale, di un rapporto
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
di lavoro subordinato (di cui si chieda il riconoscimento), con
conseguente impugnativa, quale licenziamento, della comunicazione di cessazione del rapporto, attuata anche con comportamento concludente.
Rientrano, poi, oltre al caso del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, anche quelli in cui si contesti la
genuinità di un rapporto di agenzia o di natura associativa
(associazione in partecipazione, impresa familiare).
Resterebbero esclusi, invece, i casi in cui è in contestazione la stessa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
(lavoro a nero) ed, altresì, quelli in cui il rapporto, formalmente, non intercorra tra le parti in causa e si, richieda, per
dimostrarlo, l’espletamento di preliminari accertamenti, spesso complessi e difficoltosi, incompatibili con l’estrema sommarietà del rito (si pensi a casi di dedotta simulazione, interposizione)
D’altra parte, a chi ritiene che la scelta precedente penalizzi le situazioni più disagiate, può obiettarsi che queste situazioni restano affidate pur sempre al rito speciale del lavoro e
che, quindi, già ab initio, possono essere trattate con la speditezza necessaria ed espletando tutta l’attività istruttoria necessaria a dimostrare l’eventuale fondatezza della domanda.
Nelle ipotesi consentite, va escluso che la parte la quale
agisca per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro
subordinato, al fine di poter chiedere anche il riconoscimento
dell’illegittimità del licenziamento, possa pretendere di trattare congiuntamente domande di differenza paga, ricostruzione carriera, come pure nei primi commenti si è, da alcuni,
sostenuto.
1.3. Le altre domande promosse congiuntamente alla domanda principale.
Per completare la trattazione relativa all’ambito di applicazione della riforma deve ancora rilevarsi che vanno, inoltre,
incluse, ex comma 48, le altre domande promosse congiuntamente (alla principale) e fondate sugli stessi fatti costitutivi
anche se idonei a legittimare richieste diverse.
Deve, quindi, trattarsi di fatti costitutivi identici, cioe’
sovrapponibili, e non meramente connessi.
Valgono, anche in questo caso, le considerazioni precedentemente svolte con riferimento alla necessità di interpretare
in modo rigoroso ogni formula che comporti ampliamento
della procedura.
Conseguentemente, per le ragioni già esposte, le domande
aggiuntive proponibili devono ritenersi solo quelle fondate
sugli stessi fatti costitutivi tipici della domanda relativa all’impugnativa del licenziamento (esistenza rapporto e sua risoluzione).
L’area rimane, conseguentemente, circoscritta a tutte le
domande diverse dalla impugnativa del recesso ma che dallo
stesso possano nascere (preavviso, t.f.r., risarcimento danno
per licenziamento ingiurioso o discriminatorio, risarcimento
danno biologico per licenziamento costituente atto di mobbing).
L’impostazione scelta, evitando di ampliare eccessivamente l’ambito di applicazione della riforma, consente di non
depotenziarne l’efficacia ed appare quella più rispondente
alla volontà del legislatore che (in controtendenza alla semplificazione dei riti in precedenza attuata con il decreto legislativo 01.09.2011, n. 150) ha introdotto, nella materia de
2 0 1 2
25
qua, una procedura obbligatoria e sommaria per assicurare
una risoluzione estremamente rapida ai contrasti esistenti tra
le parti, affermando, peraltro, che tutto ciò deve essere assicurato senza oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione.
2. Il nuovo rito speciale. A) La fase sommaria (art. 1, comma 48-50)
Il nuovo rito presenta una struttura bifasica, la prima,
introduttiva della lite, obbligatoria ed a cognizione estremamente sommaria, la seconda, quella della opposizione, solo
eventuale ed a cognizione spedita, ma piena.
2.1. Caratteri. Forma e contenuto dell’atto introduttivo.
Giudice competente. Instaurazione del contraddittorio (art.
1, comma 48)
Le controversie indicate dal comma 47 si propongono con
ricorso al giudice del lavoro (territorialmente competente ex
art. 413). Il ricorso deve possedere i requisiti di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile (e non dell’articolo 414).
Non possono essere proposte domande diverse (da quelle
previste dal comma 47) salvo che esse siano fondate sugli
stessi fatti costitutivi (vedi sopra 1.3). Depositato il ricorso, il
giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti, non oltre
40 giorni dal deposito (termine non perentorio, ma tendenzialmente da rispettarsi), assegnando al ricorrente un termine
per la notifica (anche mediante p.e.c.) non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza ed assegnando al resistente,
per la costituzione, un termine non inferiore a cinque giorni
prima della udienza. Le parti debbono produrre i documenti
depositandoli in cancelleria in duplice copia.
Resta evidenziato chiaramente e immediatamente il carattere obbligatorio ed estremamente sommario della procedura.
L’obbligatorietà emerge, in modo netto, dalla lettura della norma, la quale, usando l’espressione “si propongono”, non
lascia margini di discrezionalità alla parte ricorrente in ordine alla scelta del rito.
D’altra parte, nell’esegesi della norma, bisogna considerare che la scelta del rito non può essere lasciata alla mera volontà del ricorrente (normalmente il lavoratore), anche perché
le parti del processo sono due e l’interesse del datore di lavoro
a risolvere ogni incertezza sulla correttezza della risoluzione
del rapporto in modo particolarmente celere non può essere
completamente trascurato.
Per l’obbligatorietà del rito, orientano, poi, la “ratio” della
riforma e “la previsione dell’obbligo di vigilanza” sull’osservanza della procedura stessa da parte del capo dell’Ufficio.
Il ricorso deve presentare il contenuto previsto dall’articolo 125 e non quello, più articolato, richiesto dall’articolo 414,
che torna in rilievo solo nella fase dell’opposizione.
I termini (40, 25, 5) non sono perentori, fatta eccezione,
a mio giudizio di quello di notifica alla parte convenuta, da
considerarsi, inoltre, termine libero, attesa la sua natura di
termine di comparizione.
Se ciò è esatto, la sua inosservanza comporta la nullità della notifica, con necessità di rinotifica in caso di mancata costituzione o di fissazione nuova udienza, nel caso di eccezione.
In ordine al termine di costituzione del convenuto, l’assenza di perentorietà emerge dalla diversa formulazione della
norma rispetto all’articolo 416 e dal suo mancato richiamo.
La notifica può avvenire anche attraverso posta elettronica certificata (p.e.c.)
civile
Gazzetta
26
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
Davvero di ardua comprensione (alcuni l’hanno definita
bizzarra), infine, è la disposizione secondo cui i documenti
vanno depositati in doppia copia.
2.2 Il procedimento (art.1, comma 49).
Il giudice, sentite le parti, ed omessa ogni formalita’ non
essenziale al contraddittorio, procede, nel modo che ritiene
piu’ opportuno, agli atti istruttori indispensabili (tra quelli)
proposti dalle parti o anche ammessi d’ufficio ai sensi dell’articolo 421 c.p.c. ed, all’esito, provvede con ordinanza immediatamente esecutiva all’accoglimento o al rigetto della domanda.
La norma ricalca, quanto al procedimento, l’articolo 669
sexies c.p.c. E costituisce ulteriore conferma dell’estrema sommarietà della cognizione che caratterizza questa prima fase.
E’ sufficiente evidenziare:
La prevista esclusione di ogni formalità non essenziale al
contradditorio.
La piena libertà nelle modalità di assunzione dei soli atti
istruttori ritenuti indispensabili, tra quelli richiesti dalle parti o anche ammessi d’ufficio ex articolo 421 c.p.c. (ovviamente sempre nell’ambito dei fatti allegati).
Resta attuale il problema della compatibilità dell’articolo
421 c.p.c. con il principio costituzionale di terzietà del giudice posto dall’articolo 111 costituzione.
La sommarietà della procedura, almeno secondo alcuni,
escluderebbe, in questa fase, la possibilità’ di compiere determinati atti istruttori, ritenuti incompatibili per la loro oggettiva complessità (consulenza tecnica, verificazione scrittura
privata, querela di falso) e non permetterebbe, inoltre, il ricorso alla prova delegata.
Il problema effettivamente si pone.
Va però rilevato che la mera negazione della possibilità di
espletare alcuni atti istruttori, fondata sull’asserita loro complessità, ritenuta ostativa in radice, finirebbe, in molti casi,
con il rendere superflua la fase sommaria ed indispensabile,
per l’incompletezza del primo accertamento, quella della opposizione, aumentando i carichi di lavoro ed allungando i
tempi di definizione del giudizio, anche quando evitabile.
Si pensi all’ipotesi in cui si contesti la legittimità di un recesso giustificato dalla sopravvenuta inidoneità del lavoratore
allo svolgimento dei compiti propri della sua qualifica o ancora a quella di un licenziamento fondato su una lettera ingiuriosa spedita dal dipendente al proprio datore di lavoro.
Nel caso in cui il ricorrente neghi la dedotta inidoneità ed
in quello in cui disconosca la propria sottoscrizione, perché
impedire al giudice la possibilità di un accertamento dell’unica
circostanza rispettivamente rilevante al fine della decisione?
Una soluzione ragionevole, rispettosa del dato formale e di
quello sostanziale, potrebbe ritenersi quella secondo cui accertamenti del genere di quelli precedentemente indicati, quando
indispensabili alla decisione, vadano svolti, senza superflui
formalismi propri della cognizione ordinaria, nei modi che il
giudice ritiene più opportuni e celeri, come espressamente la
normativa speciale consente la norma in questa fase sommaria
(e, per la verità, anche in quella di opposizione).
Così, ad esempio, una consulenza medica o grafologica
potrebbero essere espletate senza l’osservanza di tutte le forme
dettate dagli articoli 191-197 o dall’articolo 214 e seguenti
c.p.c.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
Sull’inapplicabilità della prova delegata si concorda, risultando la soluzione giustificata dalla sommarietà del rito e riguardando la limitazione solo le modalità di assunzione dell’atto.
La sommarietà del rito non impone la decisione in un’unica udienza, risultando possibile, se necessario, la definizione
della causa all’esito di altre udienza, purché fissate in tempi
contenuti.
La decisione è riservabile, non essendo prevista la motivazione contestuale nemmeno per la fase di opposizione.
Nel caso di mancata opposizione dell’ordinanza, appare
preferibile l’opinione secondo cui la stessa passa in cosa giudicata, tenuto conto del fatto che l’opposizione diventa inammissibile se non proposta nel termine perentorio previsto.
2.3. L’Efficacia esecutiva dell’ordinanza. (art. 1, comma 50)
Per espressa previsione di legge l’efficacia esecutiva dell’ordinanza non può essere sospesa o revocata fino alla sentenza
con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma dei
commi 51 e seguenti (51-57).
2.4. Rapporti con l’art. 700 c.p.c.
L’opinione largamente prevalente, almeno in giurisprudenza, ritiene che la procedura speciale ideata dalla riforma per
le controversie relative all’impugnativa di licenziamento, nella stessa rientranti, abbia determinato il venir meno della
possibilità di ricorrere alla procedura cautelare ex articolo
700 c.p.c..
Nell’ambito di questa opinione, qualora venga presentato
un ricorso ex art. 700, alcuni ritengono che debba esserne
pronunciata l’inammissibilità, i più, invece, che il giudice
debba procedere alla trasformazione del rito.
Si ritiene che la natura non cautelare della procedura
sommaria (generale e obbligatoria) e la sua diversa struttura
orientano per la sopravvivenza della procedura cautelare,
anche se limitatamente a casi di “eccezionale periculum”,
tale, quindi, da imporre un provvedimento in tempi ristrettissimi, se non addirittura con decreto.
Di tal che, nel caso di proposizione, pure dopo il
18.07.2012, di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., il giudice ha l’obbligo di esaminarlo ed, eventualmente, di rigettarlo, preliminarmente, per carenza di “periculum in mora”.
Non sembrano corrette, per le ragioni esposte, né la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità, né la proposta
attività di trasformazione del rito.
2.5. Alcune problematiche in tema di oneri probatori ed allegatori.
Prima di passare all’esame della fase dell’opposizione,
giova, sia pur sommariamente, farsi carico dell’esame di alcune questioni di ricorrente attualità
La prima riguarda il requisito dimensionale, talvolta necessario per attrarre la fattispecie nell’ambito dell’articolo 18
riformato.
In ordine all’applicabilità della procedura speciale, sembra
corretto ritenere che il ricorrente debba, al più, solo allegarne
l’esistenza, continuando la prova a gravare sul datore (cfr., ex
plurimis, Cass. S.U. 10.01.2006 n. 141; Cass. sez. lav.
27.01.2011 n. 1925).
Se l’assenza del requisito emerge già dallo stesso ricorso
sono percorribili due soluzioni, da assumersi, comunque,
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
sempre all’esito dell’udienza di comparizione: declaratoria di
inammissibilità della domanda o trasformazione del rito.
Se l’assenza del requisito emerge solo in sede di comparizione o all’esito della cognizione sommaria sono percorribili due
soluzioni: rigetto della domanda o trasformazione del rito.
La seconda questione riguarda il caso in cui la parte chieda la reintegra ed in subordine l’applicazione della tutela
obbligatoria.
È preferibile l’opinione secondo cui la domanda di reintegra (sempre se corretta) attrae quella subordinata di riassunzione, esercitando su di essa un effetto di trascinamento e
imponendo al giudice, nel caso di infondatezza della domanda principale, la valutazione di quella subordinata.
Non appare condivisibile l’opinione di chi sostiene l’inammissibilità della domanda subordinata.
La terza problematica riguarda l’onere della prova della
giusta causa e/o del giustificato motivo.
Nel silenzio della legge, non v’è motivo per discostarsi
dalla previsione dell’art. 5 legge n. 604 del 1996, che lo pone
a carico del datore di lavoro.
2.6. Provvedimenti in caso di ricorso proposto relativamente a licenziamento non ricompreso nell’ambito di applicabilità della norma o di ricorso ricomprendente domande diverse non proponibili.
Nel primo caso, nel silenzio della legge, due sono le possibili soluzioni, sempre da adottarsi all’esito dell’udienza di
comparizione:
• ordinanza di inammissibilità della domanda o di conversione del rito (426, 427 c.p.c. o decreto semplificazioni,
articolo 4).
Nel secondo caso, nel silenzio della legge, due sono le
possibili soluzioni, sempre da adottarsi all’esito dell’udienza
di comparizione:
• ordinanza di inammissibilità parziale oppure separazione
delle domande non proponibili e conversione del rito (426,
427 c.p.c. o decreto semplificazioni, articolo 4).
Ragioni di celerità e di economia processuale, in aggiunta
all’esigenza di assicurare una tutela effettiva agli interessi
delle parti, orienterebbero per la separazione.
Lascia, però, riflettere il silenzio del legislatore, che, al
contrario, nel diverso caso di domanda riconvenzionale mal
proposta si è esplicitamente espresso per la separazione.
2.7. Domanda riconvenzionale o di chiamata in garanzia o
verso altri soggetti cui la causa è ritenuta comune.
La legge ne ammette espressamente la proponibilità solo
nella fase eventuale dell’opposizione.
Non sembra esserci, in questo caso, valida alternativa
all’ordinanza di inammissibilità.
3. B) La fase del giudizio di opposizione (art. 1, commi
51-57). Forma introduttiva e termini. Contenuto del ricorso.
L’opposizione avverso l’ordinanza di cui al comma 49 va
proposta, innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento, con ricorso da depositare, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla sua notifica o dalla sua comunicazione se anteriore.
Il ricorso deve presentare i requisiti di cui all’articolo 414
c.p.c.
2 0 1 2
27
Nell’atto, non possono essere proposte domande diverse
da quelle previste dall’articolo 47, salvo che siano fondate
sugli stessi fatti costitutivi o che siano proposte nei confronti
di soggetti ai quali la causa è comune o dai quali si intenda
essere garantiti.
Il giudice, con decreto, fissa l’udienza di discussione (comparizione nella fase sommaria) non oltre i successivi giorni 60,
assegnando all’opposto il termine di giorni 10 prima dell’udienza per costituirsi.
La fase eventuale dell’opposizione si introduce, quindi,
con ricorso innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento.
La prima problematica che si pone, fonte di grande incertezza e di vivaci discussioni, è quella intesa a stabilire se il
giudice che ha trattato la fase sommaria possa conoscere anche
di quella dell’opposizione o se sussista incompatibilità.
Dopo un’iniziale prevalenza della tesi dell’incompatibilità,
dottrina e giurisprudenza appaiono divise.
Entrambe le tesi sono fondate su argomenti suggestivi,
degni di rilievo e di grande valore, anche se quella dell’inesistenza incompatibilità risulta a chi scrive più convincente.
Più particolarmente, la tesi della insussistenza della incompatibilità fa leva:
– sul silenzio del legislatore, che, al contrario, soprattutto
negli ultimi anni, quando ha ravvisato l’incompatibilità lo
ha espressamente enunciato (vedi reclamo, opposizione a
precetto ex art. 618, secondo comma c.p.c. (nella versione
introdotta dall’art. 186 bis disp. att. c.p.c.), rinvio dopo
annullamento cassazione ex art. 383 c.p.c.);
– sulla stessa “ratio” della riforma legislativa, che ha inteso
accelerare i tempi di definizione delle controversie in esame, (tempi) che, viceversa, subirebbero inevitabili rallentamenti dal cambio di giudice, con ripercussioni negative
sul rispetto del principio della ragionevole durata del
processo e sulla stessa funzionalità di molti uffici;
– sulla qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio non d’impugnazione, privo di effetto devolutivo. Ciò
è dimostrato, in via diretta, dalla possibilità di proporre
nuove domande (comma 51), dalla possibilità di estendere
il contraddittorio ad altri soggetti dai quali si vuole essere
garantiti o ai quali si ritiene la causa comune (comma 53),
dalla proponibilità, solo in questa fase, di domanda riconvenzionale (comma 56); e come dimostrano, in via indiretta, la previsione di un ricorso più strutturato rispetto a
quello introduttivo della fase sommaria (125 e 414: si
pensi alla prevista articolazione dei mezzi di prova solo
per la seconda fase), la possibilità di approfondimento
della cognizione anche attraverso il previsto ampliamento
dei mezzi istruttori (il giudice ammette non solo quelli
“indispensabili”, ma anche quelli solo “rilevanti”).
– sull’assenza di ogni pregiudizio per le parti, garantite, nei
loro diritti, dai mezzi di impugnazione (due gradi);
– sull’inesistenza di ogni nullità derivante da un vizio di costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.), qui non ricorrente.
Tutto ciò rende, secondo l’opinione in esame, inappropriato il riferimento, alla fattispecie de qua, della sentenza Corte
Costituzionale intervenuta sull’articolo 28.
A sostegno dell’insussistenza dell’incompatibilità sono
indicate anche altre ragioni di carattere pragmatico, quali
quella:
civile
Gazzetta
28
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
- del probabile effetto deflattivo conseguente alla trattazione del giudizio da parte dello stesso giudice;
- delle difficoltà di funzionamento degli uffici di piccole
dimensioni;
- dell’assoluta mancanza di risorse aggiuntive.
Ora, se è indubbiamente vero che inconvenienti pratici
(difficoltà di funzionamento della riforma nei piccoli tribunali, mancanza di risorse aggiuntive, effetto deflattivo) non
costituiscono argomentazioni giuridiche, e vero pure però che
tali “inconvenienti”, unitamente ai profili in diritto relativi
all’assenza di effetto devolutivo e della ratio della riforma
(argomenti 2 e 3), possono senz’altro contribuire a valorizzare e spiegare il silenzio del legislatore sull’inesistenza dell’incompatibilità (argomento 1), orientando l’interprete a ritenere che il predetto silenzio non sia stato neutro e casuale, ma,
al contrario, sia stato conseguenza di una scelta ponderata e
ragionata, effettuata, peraltro, nella consapevolezza del precedente intervento della Consulta in tema di articolo 28.
La tesi della sussistenza della incompatibilità si fonda
sulle considerazioni già svolte dalla Corte Costituzionale con
la sentenza con cui ha affrontato l’analoga tematica con riferimento al procedimento ex art. 28 statuto lavoratori (sentenza n. 387/1999, richiamata anche dal CSM nel parere sulla
riforma espresso il 17 maggio 2012).
La corte ha evidenziato che le insopprimibili esigenze di
imparzialità del giudice sono risolvibili nel processo civile attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione, con particolare riferimento alla previsione dell’art. 51, numero 4, c.p.c..
La norma ha riguardo all’ipotesi in cui il giudice abbia
conosciuto la causa, come magistrato, in “altro grado del
processo”.
Secondo la Corte Costituzionale, la norma deve ricomprendere - con una interpretazione conforme a costituzione
- anche l’ipotesi della fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata (per la peculiarità del giudizio di opposizione di cui si discute) da pronuncia che attiene al medesimo
oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell’azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario.
Tali considerazioni vengono applicate, mutatis mutandis,
anche al giudizio di opposizione oggetto di esame nella presente sede, in cui viene registrato un carattere impugnatorio.
3.1. Il giudizio di opposizione.
Il giudizio di opposizione ricalca quello ordinario di lavoro anche se, ovviamente, sorge in modo diverso, stante la sua
natura di giudizio di opposizione.
Da ciò una prima riflessione: in caso di omessa o tempestiva notifica del ricorso e decreto, trova applicazione la giurisprudenza di legittimità relativa alla omessa notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo ed alla conseguente improcedibilità dell’opposizione (salvo remissione in termine) (Cass.
S.U. 30.07.2008 n. 20604).
Non possono essere proposte poi domande diverse da
quelle previste dall’articolo 47 salvo che:
- siano fondate sugli stessi fatti costitutivi (e sul punto si
rinvia a quanto in precedenza osservato);
- siano proposte nei confronti di soggetti ai quali la causa
é comune o dai quali si intenda essere garantiti.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
Si pensi all’ipotesi disciplinata dall’articolo 2112 c.c.: caso
in cui la domanda di ricostituzione del rapporto e/o risarcitoria, formulata nella fase sommaria, nei confronti del datore
di lavoro, venga, poi, estesa nei confronti del cessionario.
Si pensi alla chiamata di terzo ex art. 106 c.p.c., possibile,
ad esempio, in materia di appalto o sub-appalto con estensione del contraddittorio – a seconda di come era stata formulata la domanda nella prima fase – nei confronti dell’appaltatore o dell’appaltante.
Si pensi alla chiamata in garanzia svolta dal datore di lavoro opponente.
3.2 Il procedimento (commi 52-57).
L’opponente deve notificare il ricorso (anche mediante
p.e.c.) in un termine non inferiore a trenta giorni prima della
data di costituzione dell’opposto (dieci giorni prima dell’udienza come si desume dal comma successivo)
Una differenza di non poco rilievo riguarda i termini di
notifica, calcolati non piu’ sull’udienza di discussione, ma su
quelli di costituzione del convenuto (60, 30, 10).
L’opposto deve costituirsi in giudizio con memoria depositata nel termine previsto dall’art. 416 c.p.c., pena la verificazione delle decadenze ivi previste. Se l’opposto intende
chiamare un terzo in garanzia deve formulare la richiesta
nella stessa memoria
Nel caso di chiamata in causa ex articolo 102, comma
secondo, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza nel
termine di sessanta giorni e dispone che, a cura delle parti, al
chiamato in causa siano notificati atto di opposizione, memoria di costituzione e provvedimento osservati i termini di cui
al comma 52 (per il notificante non oltre trenta giorni prima
della data di costituzione del chiamato)
Il terzo chiamato in causa deve costituirsi non meno di
dieci giorni prima dell’udienza, depositando memoria a norma
di quanto previsto dal comma 52 (per l’opposto).
Qualora la domanda riconvenzionale non e’ fondata su
fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
La domanda riconvenzionale e’ possibile solo nei ristretti
limiti previsti e non comporta lo spostamento di udienza.
Nel caso di separazione, secondo l’interpretazione che
appare preferibile, il giudice ordina alla cancelleria di formare un nuovo fascicolo (se di lavoro) o di trasmettere gli atti
alla presidenza (se non di lavoro)
Il giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non
indispensabile al contraddittorio, procede, nel modo che ritiene più opportuno all’assunzione degli atti di istruzione
ammissibili e rilevanti (fase sommaria: indispensabili) proposti dalle parti ed anche di quelli ammessi ai sensi dell’articolo
421 c.p.c. e decide la causa con sentenza (ordinanza, nella
fase sommaria) di accoglimento o di rigetto, concedendo alle
parti, se opportuno (quindi anche d’ufficio) termine per note
fino a dieci giorni prima dell’udienza fissata per la discussione. la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione. la sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Richiamando quanto già affermato durante la disamina
della trattazione della fase sommaria, va qui rilevato che i
mezzi istruttori sono quelli ammissibili e rilevanti, a differen-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
za di fase sommaria, in cui l’attività istruttoria è solo quella
indispensabile.
Al termine dell’attività istruttoria il termine per il deposito di note illustrative può essere concesso anche d’ufficio.
3.3. La decisione della causa.
Diversamente dal rito lavoro ordinario nel quale la decisione trova la sua disciplina nell’articolo 429 c.p.c., nel rito
speciale lavoro, la causa va riservata a sentenza come nel rito
civile, con deposito nei dieci giorni successivi.
La decisione contestuale resta pur sempre possibile.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce
titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
4. Reclamo innanzi alla Corte d’Appello e ricorso per Cassazione.
La sentenza che decide il giudizio è reclamabile innanzi
alla Corte d’Appello, avverso la cui decisione è proponibile
ricorso per Cassazione.
Il giudizio di reclamo è disciplinato dai commi 58-61 e
quello di cassazione dai commi 62-64, cui si rinvia, risultando
il presente contributo destinato precipuamente all’esame delle
problematiche poste dal giudizio di primo grado, per l’impatto immediato delle stesse sulla trattazione dei processi di lavoro aventi ad oggetto l’impugnativa di un licenziamento.
In via estremamente sintetica può comunque osservarsi che:
1. Il reclamo innanzi alla Corte d’appello va proposto con
ricorso nel termine di decadenza di trenta giorni, che decorre
dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. In
mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si
applica l’articolo 327 del codice di procedura civile.
2. La corte fissa con decreto l’udienza di discussione nei
successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai
commi 51, 52 e 53.
3. Alla prima udienza, la corte può sospendere l’efficacia
della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi (prognosi
sulla fondatezza del gravame).
4. In tale fase non sono ammessi nuovi mezzi di prova o
documenti, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga
indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri
di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa
non imputabile.
5. La corte d’appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ri-
2 0 1 2
29
tiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede
con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note
difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione.
6. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione.
7. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore.
In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza
si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile
La sospensione dell’efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d’appello, che provvede a norma del comma 60.
La Corte fissa l’udienza di discussione non oltre sei mesi
dalla proposizione del ricorso.
5. Disposizioni generali.
Per la trattazione delle controversie in esame debbono essere previste particolari giorni nel calendario delle udienze.
La norma orienta, in primis, per la fissazione di udienze
aggiuntive.
In caso di reali e documentate difficoltà, sembra, comunque, sufficiente anche la riserva di specifici segmenti nell’ambito delle udienze già fissate anche per la trattazione di altre
controversie.
La procedura si applica alle controversie instaurate a
partire dalla data di entrata in vigore della legge (rileva quindi non la data del licenziamento, ma quella di deposito del
ricorso).
Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’osservanza della
norma.
Dalla riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.
La riforma, quindi, deve essere attuata senza gravare sul
bilancio dello Stato.
E tanto non richiede particolari commenti, essendo diventata tale clausola di chiusura, già da qualche anno, una costante del modus operandi del legislatore.
Come dire, “nulla di nuovo sotto il cielo”.
Occorre, purtroppo, attrezzarsi a “friggere il pesce con
l’acqua”, riuscendo in quello che non ritiene possibile la proverbiale saggezza popolare.
civile
Gazzetta
30
D i r i t t o
●
Il sovraindebitamento
dei soggetti economici
e del consumatore
nel D.L. N. 212/2011,
(conv. nella L. 10/2012)
● Corrado d’Ambrosio
Magistrato presso il Tribunale di Napoli
e
p r o c e d u r a
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
Sommario: 1. Il breve esperimento di una normativa diversificata per il consumatore e l’imprenditore non fallibile.
- 1.1. (segue) Il ritorno ad una disciplina unitaria. - 2. Le
differenze con il testo dell’art. 7 l. n. 3/2012 e le conseguenze
sotto il profilo interpretativo. - 3. Il contenuto dell’accordo.
- 4. L’avvio del procedimento. - 4.1. (segue) La preparazione
della proposta e la fase di avvio del procedimento. - 5. L’ammissione e l’anticipazione degli effetti protettivi. - 6. Il raggiungimento dell’accordo. - 7. L’omologazione dell’accordo.
- 8. L’esecuzione dell’accordo. - 9. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo. - 10. Gli organismi di composizione della
crisi. - 11. Disposizioni transitorie e finali.
1. Il breve esperimento di una normativa diversificata
per il consumatore e l’imprenditore non fallibile.
L’art. 1, d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 ha avuto un periodo
di vigenza di soli sessanta giorni, dal 23 dicembre 2011 al 20
febbraio 2012.
Invero tale norma, unitamente all’intero procedimento di
composizione della crisi da sovraindebitamento, è stata soppressa in sede di conversione del decreto, nella l. 17 febbraio
2012, n. 10.
Peraltro, il suo contenuto è stato riversato pressoché integralmente all’interno dell’art. 6, l. n. 3/2012, in vigore dal 29
febbraio 2012, in un testo restrittivo la cui ratio, quanto alla
disposizione de qua, è all’origine anche della travagliata storia
legislativa dell’insolvenza civile.
Il risultato finale è che la procedura di sovraindebitamento, introdotta con urgenza nel nostro ordinamento in data 23
dicembre 2011, ha avuto una limitata vigenza (di 60 giorni)
fino al 20 febbraio 2012, non essendo più operativa nel periodo che va dal 21 febbraio 2012 al 28 febbraio 2012, ed infine
riprendendo – è il caso di dirlo – ad esistere a far data solo dal
29 febbraio 2012, con alcune modificazioni rispetto all’originaria previsione del decreto legge1.
Nell’esame delle differenze di formulazione tra l’art. 1 del
d.l. n. 212/2011 e l’art. 6, l. n. 3/2012, al fine di controllare se
possano dar luogo – relativamente a procedure iniziate sotto
la vigenza dell’abrogato d.l. n. 212 – ad una disciplina differente, oppure se sia possibile senz’altro riportarsi all’art. 6, si
anticipa che questa soluzione, di piena continuità per le procedure inaugurate sotto la vigenza del d.l. n. 212/2011, e
sempre che si ritengano rispettati i canoni interpretativi sulla
consecuzione di efficacia della norma abrogata con la nuova
parte, appare preferirsi.
Infatti, al di là della lieve modifica delle rubriche, il punto
nevralgico sembra ridursi al significato del sovraindebitamento del consumatore, come categoria autonoma rispetto al sovraindebitamento del comune debitore.
Nell’art. 1 – parimenti norma programmatica al pari
dell’art. 6 della l. n. 3/2012 – viene disegnato il quadro della
procedura di sovraindebitamento: in essa è dato al debitore
concludere un accordo con i creditori; lo scopo è il superamento delle situazioni di sovraindebitamento (cui porre rimedio);
la destinatarietà soggettiva non viene affrontata in modo diretto, ma in relazione al tipo di sovraindebitamento (mentre
1M. FERRO, Il sovra indebitamento del non fallibile: la doppia soggettività, in
Sovraindebitamento e usura, a cura di M. FERRO, Milano, 2012, p. 332.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
l’art. 6 anticipa coloro che possono tipologicamente fruirne,
relativamente alle situazioni non soggette né assoggettabili
alle vigenti procedure concorsuali, poi specificate dall’art. 7,
l. n. 3/2012, e qui dall’art. 2 del d.l. n. 212/2011); infine, il
sovraindebitamento è positivamente definito2.
2 0 1 2
31
Ed anzi, va sottolineato che già la duplicazione in sede
definitoria aveva destato perplessità, costruita com’era su una
nozione di rilevanza (il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all’inadempimento di obbligazioni contratte dal
consumatore) che avrebbe costretto l’interprete ad individuare una massa separata di obbligazioni di fonte consumeristica,
qui per offrire base oggettiva all’ingresso nella procedura,
permettendo al giudice sia il riscontro di tale eziologia, sia la
qualificazione soggettiva (consumatore) dell’istante.
Allegare tale requisito oggettivo era dunque necessario
anche al fine di canalizzare la domanda verso un ambito di
controllo che la preservasse da una censura di inammissibilità in quanto proveniente da un imprenditore assoggettabile a
fallimento o concordato preventivo.
In ogni caso, il sovraindebitamento considerato lasciava
aperta la questione circa il possibile utilizzo della procedura
anche da parte del soggetto fallibile, che tuttavia tentasse la
riorganizzazione dei debiti estranei all’attività di impresa.
Ma, al di là della qualificazione, la chiusura all’accesso,
precisamente statuita dall’art. 2, co. 2, lett. a), rendeva inutile l’interrogativo, e di conseguenza poco chiara l’utilità stessa
della norma de qua, ridotta ad enunciazione tipologica, e
semmai, idonea solo ad orientare il richiamo a scelte designative riservate alle fasi successive (ad esempio, la nomina del
liquidatore di competenza giudiziale).
Altre modifiche o semplificazioni testuali non sembrano
particolarmente decisive: non la prontezza che dovrebbe connotare la liquidabilità del patrimonio come termine di raffronto per affermare l’insolvenza cd. patrimoniale o statica,
qualità non prevista nel d.l. n. 212/2011, ed invece rimessa
nella l. n. 3/20124.
1.1. (segue) Il ritorno ad una disciplina unitaria.
L’abrogata parte del d. l. n. 212/2011, tutti i primi 11 articoli, si rivolgeva dunque, distinguendone le crisi risanabili (o
rimediabili), sia ai consumatori (cioè quei soggetti, cui il legislatore ha dedicato particolare attenzione con il d. lgs n. 206/2005,
cd. Codice del consumo), sia, più in generale, ai debitori ( cioè
alle persone fisiche o enti collettivi non soggetti alle vigenti
procedure concorsuali) in stato di sovraindebitamento; questa
la lettera dell’art. 1, co. 2, lett. a) e b) , d.l. n. 212/2011.
A tali soggetti, unitariamente considerati, veniva data la
possibilità di proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi previsti dal successivo art. 10,
un accordo concernente la ristrutturazione dei debiti, sulla
base di un piano economico-finanziario a prima vista assai
più dettagliato rispetto alla previsione del p.d.l. Centaro (poi
trasfusosi in l. n. 3/2012), purchè non avessero fatto ricorso,
nei precedenti tre anni, alle procedure di composizione della
crisi da sovraindebitamento.
Nella l. n. 3/2012 – sopravvissuta alla vicenda sovrappositiva delle due riforme – scompare ogni riferimento al sovraindebitamento del consumatore.
Anche se, va notato, la prima dottrina non ha mancato di
precisare che il rinvio all’adempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, definito ai sensi del cd. Codice del
consumo, non avrebbe potuto significare il rinvio al solo
consumatore in chiave tecnica, restandone altrimenti esclusi,
ad es., i professionisti, che non sono in senso stretto consumatori né imprenditori3.
L’intento del legislatore era infatti divenuto, medio tempore, quello di regolare tale materia con una disciplina ad hoc
in sede di conversione del d.l. n. 212/2011.
E conseguentemente, la Commissione giustizia del Senato
aveva approvato, in sede referente, un disegno di legge di
conversione che recava, in allegato, una dettagliata disciplina
del sovraindebitamento del consumatore unita ad una nuova
modificazione della disciplina del sovraindebitamento del
debitore non soggetto alle procedure concorsuali, contenuta
nella l. n. 3/2012.
Tale disciplina (A.C. n. 4933) è stata, alfine e integralmente, soppressa su rilievo pressoché unanime della Commissione
Giustizia della Camera dei Deputati, la quale ha deciso di
ritornare alla vecchia struttura dell’originario p.d.l. Centaro
al fine di evitare - si legge nei lavori preparatori - una duplicazione delle norme regolatrici della materia, con le conseguenti difficoltà applicative.
Va, invero, riconosciuto che nulla osta a considerare,
nella nozione di debitore di cui all’art. 6 della l. n. 3/2012, sia
il debitore-consumatore dell’abrogato art. 1 del d.l. n.
212/2011, sia ogni altra figura, quale reveniente dalla lett. a)
del co. 2 dell’articolo 1, l. n. 10/2012.
2. Le differenze con il testo dell’art. 7 l. n. 3/2012 e le conseguenze
sotto il profilo interpretativo.
Anche l’art. 2. d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 ha avuto un
periodo di vigenza di soli sessanta giorni, dal 23 dicembre
2011 al 20 febbraio 2012, ed è stata soppressa in sede di
conversione del decreto nella l. 17 febbraio 2012, n. 10.
Peraltro, il suo contenuto è stato riversato, pressoché integralmente, all’interno dell’art. 7, l. n. 3/2012, in vigore dal 29
febbraio 2012, con alcune piccole modifiche terminologiche.
Più precisamente, l’art. 2, l. n. 10/2012 differisce dall’art.
7, l. n. 3/2012 per le seguenti peculiarità:
• la parola “scadenze” di cui al secondo periodo del co. 1
(«Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento») è sostituita con la parola “termini” («Il piano prevede
i termini e le modalità di pagamento»);
• non figura la parola “anche” nel terzo periodo del co. 1
(«Il piano può prevedere…» anziché «Il piano può anche
prevedere…»);
• il co. 2, lett. a), riporta la frase «vigenti procedure concorsuali» anziché quella, più restrittiva, di «procedure previste dall’art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni»;
• il co. 2, lett. b), riporta, nella parte finale, le parole «da
sovraindebitamento», non più presenti nella formulazione
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4M. FABIANI, La gestione del sovra indebitamento del debitore “non fallibile”
(d.l. n. 212/2911), www.ilcaso.it, 2012, 1-21.
civile
Gazzetta
32
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
della norma di cui all’art. 7, co. 2, lett. b)5.
Non ha un grande significato sostanziale la sostituzione
della parola “scadenze” con la parola “termini”.
In effetti, l’utilizzo della parola “scadenze” accentua la
connotazione temporale delle previsioni del piano, rendendo
palese come il legislatore voglia che il piano sia sufficientemente specifico con riferimento alle date in cui il debitore
effettuerà i vari adempimenti, che potranno essere anche dilazionati nel tempo.
L’utilizzo della parola “termini” (dal significato non univocamente riferibile all’aspetto temporale), unita alla parola
“modalità”, invece, compone un’endiadi dal significato sostanzialmente unico, spostando l’attenzione dell’interprete più
sull’aspetto tipologico degli adempimenti che sulla tempistica.
Neppure merita particolare attenzione la piccola differenza, su indicata, data dalla parola “anche”: in entrambi i casi,
infatti, il legislatore consente al debitore di procedere alla liquidazione del patrimonio a mezzo trust, e tale modalità liquidatoria non può che ritenersi alternativa alla liquidazione
autonoma da parte del debitore, ovvero a mezzo nomina di
un liquidatore giudiziale (necessitata solo in caso di beni pignorati ai sensi dell’art. 8, co. 1.)6.
Qualche parola in più meritano le modifiche più sopra
indicate, sub 3 e 4.
Cominciando dalla prima, l’art. 2, co. 2, lett. a), afferma
che la proposta formulata dal debitore è ammissibile allorquando il debitore non è assoggettabile alle vigenti procedure
concorsuali.
A differenza che per l’art. 7, co. 2, lett. a), l. n. 3/2012, per
il quale il debitore non deve essere assoggettabile alle procedure previste dall’art. 1 l.f., non si pone il problema di verificare se vi siano procedure concorsuali escluse dalla previsione
normativa, atteso che il riferimento deve ritenersi omnicomprensivo e riguarda, dunque, non solo il fallimento ed il
concordato preventivo (art. 1 l.f.), ma anche la liquidazione
coatta amministrativa (art. 194 ss. L.f.) e l’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi (d. lgs n. 270/99,
d,l. n. 347/2003, conv. In l. n. 39/2004).
Per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione dei
debiti, indipendentemente dalla loro qualificazione come
procedure concorsuali, l’art. 182-bis l.f. si rivolge espressamente all’«imprenditore in stato di crisi», figura ritenuta, in
dottrina7 ed in giurisprudenza8, coincidente, sotto il profilo
soggettivo, con quella dell’imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento o a concordato preventivo (almeno fino
all’estensione di tale forma di accordi anche agli imprenditori agricoli ad opera dell’art. 23, co. 43, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 111/2011).
5G. M. NONNO, Il presupposto soggettivo di ammissibilità e il contenuto del
piano, in Sovraindebitamento e usura, a cura di M. FERRO, op. cit., p. 337.
6M. FABIANI, La gestione del sovra indebitamento del debitore non fallibile,
op. cit., pp. 13-14.
7S. AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in A. JORIO- M.
FABIANI, (diretto da) Il nuovo Diritto Fallimentare, 2010, 1137-1175; M.
FERRO, Sub art. 182-bis, in M. FERRO, (a cura di) , La legge fallimentare, II
edizione, Padova, 2011, 2111-2153; C. FISCHETTI, Osservazioni in tema di
accordi di ristrutturazione dei deviti, D. f., 2010, II, 503-525; A. PATTI, Crisi
di impresa e ruolo del giudice, Milano, 2009; V. ZANICHELLI, I concordati
giudiziali, Torino, 2010.
8Trib. Palermo, 27 marzo 2009, D. f., 2010, II, 503.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
Circa, infine, il c.d. requisito di meritevolezza, questo
viene individuato dall’art. 2. co. 2, lett. b), nel non avere il
debitore fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla <<procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento>>.
La procedura cui il debitore non deve avere fatto ricorso
nel triennio antecedente viene individuata in questa sede con
maggiore precisione rispetto alla omologa norma dell’art. 7.
co. 2, lett. b) , l. n. 3/2012, laddove la soppressione delle parole <<da sovraindebitamento>> potrebbe far ipotizzare un
riferimento anche ad altre procedure di composizione della
crisi, quali il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
3. Il contenuto dell’accordo.
L’art. 3 l. n. 10/2012 presenta solo due differenze rispetto
all’art. 8 l. n. 3/2012.
La prima riguarda il richiamo, quale possibile contenuto
della proposta di composizione, della cessione di “crediti”
futuri, in luogo della cessione di “redditi” futuri, poi prevista
dalla legge predetta.
Si tratta di differenza del tutto irrilevante, sia perché i
redditi futuri sono una sottospecie di crediti futuri, sia perché
le ampie possibilità di modulazione del contenuto della proposta consentono certamente, anche nelle fattispecie soggette
alla sola legge Centaro, la previsione della cessione di crediti
futuri non consistenti, in senso stretto, in redditi, ovverosia
in entrate costanti e ripetitive, di medesima origine e maturazione futura.
La difformità del testo è dunque priva di rilevanza alcuna.
Rispetto alla moratoria di un anno nel pagamento dei
creditori estranei, il d.l. non prevedeva, quale requisito necessario introdotto con la legge Centaro, quello della nomina di
un liquidatore.
Il requisito necessario richiesto dalla legge costituisce
un’opportuna forma di maggiore garanzia introdotta al fine
di consentire un migliore controllo esterno rispetto all’ipotesi, di una certa delicatezza, della moratoria nel pagamento dei
creditori estranei9.
4. L’avvio del procedimento.
Anche l’art. 4, d. l. n. 212/2011, ha avuto un periodo di
vigenza di soli sessanta giorni, ed anch’esso è stato soppresso
in sede di conversione del decreto nella l. n. 10/2012.
Peraltro, il suo contenuto è stato riversato pressoché integralmente all’interno dell’art. 9, l. n. 3/2012.
Nell’esame delle differenze di formulazione tra l’art. 4, l.
n. 10/2012, e l’art. 9, l. n. 3/2012, al fine di controllare se
possano dar luogo – relativamente a procedure iniziate sotto
la vigenza dell’abrogato d.l. n. 212 – ad una disciplina differente, oppure se sia possibile senz’altro riportarsi all’art. 9, si
anticipa che questa soluzione, di piena continuità per le procedure inaugurate sotto la vigenza del d. l. n. 212/2011, e
sempre che si ritengano rispettati i canoni interpretativi sulla
consecuzione di efficacia della norma abrogata con la nuova,
appare preferirsi.
Infatti, non sussiste alcuna modifica delle rubriche: il si-
9 R. BELLE’, Il contenuto dell’accordo, in Sovraindebitamento e usura, a cura di
M. FERRO, op. cit., p. 340.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
gnificato del sovraindebitamento del consumatore, come categoria autonoma rispetto al sovraindebitamento del comune
debitore, pare assorbibile nell’unitario profilo soggettivo di
cui al nuovo art. 6, l. n. 3/2012, e dunque, anche la disposizione di cui all’art. 4. l. n. 10/2012 può permettere di riscontrare l’effetto sui procedimenti in precedenza avviati10.
Al di là di procedimenti peraltro promossi sotto la vigenza del d.l. n. 212/2011, e non conclusi con l’omologazione
alla sopra menzionata scadenza del decreto legge, va valutato
se un procedimento iniziato in precedenza, e nel corso del
quale sia stato raccolto il consenso dei creditori, possa sottrarsi alla decadenza, per mancata conversione del d.l.
L’impressione è che una salvezza degli effetti non sia agevole, nonostante un’astrattamente ipotizzabile possibilità di
un’atecnica riassunzione degli atti di nuovo avanti al Tribunale, ma sotto la vigenza della l. n. 3/2012.
Ciò, peraltro, presupporrebbe che, con la caducazione del
d.l. n. 212/2011, il procedimento avviato fosse entrato solo in
uno stato di quiescenza, il che sembra escluso dalle conseguenze più gravi della mancata approvazione.
4.1. (segue) La preparazione della proposta e la fase di avvio
del procedimento.
L’art. 4, l. n. 10/2012 esprime, almeno quanto alla fondamentale prima parte ( i primi due commi), una sostanziale
identità con l’art. 9 della l. n. 3/2012.
L’unica modifica concerne l’equiparazione dell’aggettivo
“principale” dalla sede, parimenti indicata, accanto alla residenza del debitore, come il criterio di collegamento per la
determinazione della competenza territoriale.
Si tratta di un elemento, maggiormente adesivo al lessico
fallimentaristico (art. 9 l.f.), ma tutto sommato recuperabile
anche nella l. n. 3/2012 come una lettura storica, volta ad
orientare la selezione della competenza secondo criteri univoci ed antielusivi.
Tutti i documenti che sono richiesti a corredo del ricorso,
per il resto, coincidono con quelli elencati nell’art. 9, l. n.
3/2012.
Di maggior spessore, invece, è la portata del deposito cui
è tenuto il debitore-imprenditore: il co. 5, oltre a riprodurre,
senza distinzioni tra tipologie di impresa (se piccola o agricola, o non piccola e commerciale), l’obbligo di deposito delle
scritture contabili, consente in alternativa, e dunque per il
medesimo periodo triennale, la produzione degli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell’art. 14, co. 10, della l. n.
183/2011, oltre ad una dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale11.
Si tratta di una modalità introdotta ai fini di semplificazione dei rapporti fra imprese e fisco, disponendo il cit. comma che «I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori
autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti
interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto
bancari alla tenuta delle scritture contabili».
La dichiarazione di conformità, a prima vista, sembrerebbe operare per tali estratti conto, a meno di intendere la copia
10M. FERRO, L’avvio del procedimento, in Sovraindebitamento e usura, a cura
di M. FERRO, op. cit., p. 342.
11 Ibidem., p. 343.
2 0 1 2
33
(con cui si attesta la predetta conformità all’originale) valida
anche per le scritture contabili, in tal caso fungendo l’onere di
deposito, siccome riferito ad un documento non originale.
Tale ultima disposizione, sugli estratti conto, non è stata
replicata in modo espresso nell’art. 9 della l. n. 3/2012, anche
se la sua vigenza generale non potrebbe, a prima vista, evitare di riflettersi altresì sul corredo informativo richiesto a chi
voglia accedere alla procedura entrata in vigore dal 29 febbraio 2012, trattandosi di requisito esterno alla legge speciale, ed essendo non immaginabile che un imprenditore o lavoratore autonomo che vogliano tentare tale percorso ristrutturativi, debbano optare per la tenuta formale delle scritture
contabili solo a tal fine.
Tale tesi, tuttavia, è resa più ardua dall’abrogazione del
cit. art. 14, co. 10, della l. n. 183/2011, disposta, con effetto
dal 2 marzo 2012, con l’art. 8, co. 11, del d.l. n. 16/201212.
5. L’ammissione e l’anticipazione degli effetti protettivi.
L’art. 5, d.l. n. 212/2011 ha avuto anch’esso un breve periodo di vigenza, ed anch’esso è stato soppresso in sede di
conversione del decreto nella l. n. 10/2012.
Peraltro, il suo contenuto è stato riversato pressoché integralmente all’interno dell’art. 10, l. n. 3/2012, con alcune
piccole e scarsamente significative modifiche terminologiche.
Le differenze terminologiche cui si accennava consistono:
• nell’assenza, nell’art. 5, co. 1, dell’avverbio “immediatamente”, inserito, invece, nell’art. 10, l. n. 3/2012, e riferito alla fissazione dell’udienza con decreto;
• nell’assenza, alla fine del medesimo co. 1, delle parole «del
presente articolo»;
• nella mancata specificazione, nel co. 6 dell’art. 10, l. n.
3/2012, che «il Tribunale provvede in composizione monocratica», presente, invece, nell’art. 5 qui in esame;
La differenza sub b) si riduce a una mera precisazione
priva di qualsiasi concreta rilevanza (essendo evidente che il
richiamo di un comma senza ulteriori specificazioni vada riferito al medesimo articolo).
Anche la differenza sub c) si riduce, in sostanza, ad una
semplice variazione stilistica, giacchè l’inciso riferito alla
composizione del Tribunale e non riprodotto nell’art. 10, l. n.
3/2012 si rivelava ridondante alla luce del periodo immediatamente successivo (rimasto immutato), secondo cui del collegio investito del reclamo non può fare parte il giudice che
ha emesso il provvedimento, dal quale (oltre che dal riferimento “al giudice”, anziché “al Tribunale” contenuto nei
commi precedenti) era chiaramente evincibile la composizione monocratica dell’organo giudiziale di prima istanza.
La differenza sub a), pur maggiormente significativa, è
tuttavia marginale, in considerazione della genericità dell’avverbio aggiunto dalla l. n. 3/2012, che vale più a indicare
programmaticamente un’esigenza di celerità procedurale, che
a fissare un termine all’attività giudiziale.
L’avverbio “immediatamente”, comunque, sottolinea la
sommarietà e la base esclusivamente documentale dell’accertamento preliminare richiesto al fine della emanazione del
decreto (già peraltro evincibile dal complessivo impianto
normativo e dallo stesso contenuto del provvedimento da
12 Ibidem., p. 344.
civile
Gazzetta
34
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
emettere, contenente disposizioni meramente ordinatorie ed
esecutive).
Esso, inoltre, appare formalmente ostativo al compimento
di qualsiasi attività diversa dalla valutazione dei presupposti
per l’emanazione del decreto, rendendo maggiormente incerto se, in particolare, possa essere concesso al debitore un
termine per integrare il piano o la documentazione prodotta
unitamente al ricorso13.
6. Il raggiungimento dell’accordo.
Anche l’art. 6, d.l. n. 212/2011, ha vissuto vicende analoghe a quelle esaminate ex ante (breve periodo di vigenza,
soppressione, in sede di conversione del d.l., con la l. n.
10/2012).
In primo luogo, al sovraindebitamento del consumatore
viene riservata una disciplina speciale, in particolare sotto il
profilo del consenso del ceto creditorio necessario al raggiungimento dell’accordo14.
In effetti, il testo del co. 2 dell’art. 6, l. n. 10/2012, è sostanzialmente identico al co. 2 dell’art. 11, l. n. 3/2012, salva
13F. S. Filocamo, L’ammissione e l’anticipazione degli effetti protettivi, in Sovraindebitamento e usura, a cura di M. Ferro, op. cit., p. 346.
14La necessità di elaborare uno statuto speciale del consumatore è sta­ta avvertita
nella legislazione europea sin dagli anni ottanta [v. direttive n. 87/102/CEE, n.
93/13/CEE e n. 2008/48/CEE rispettivamente in tema di credito al consumo,
clausole abusive e contratti di credito ai con­sumatori], per essere poi recepita
nel nostro ordinamento a partire dagli anni novanta [1. n. 142/1992 sul credito al consumo] e culminare nella sistematica elaborazione del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). Quanto alla condizione di inadempimento del
consumatore, essa è stata prevalentemente trattata dal legislatore italiano con
riferimento ai rap­porti tra consumatore, finanziatore e fornitore, nell’ambito
del credito al consumo. La sempre maggiore diffusione del credito al consumo
(oltre che per l’acquisto dell’abitazione) e il preoccupante aggravarsi dell’indebitamento delle famiglie (sia pure in termini meno al­larmanti e sotto la media,
rispetto ai restanti paesi europei), ha dunque reso via via ingiustificabile l’assoluta esclusione del consumatore dalle procedure concorsuali, venendo progressivamente meno il presupposto di un minor impatto della sua insolvenza, in
termini di allarme sociale. Il tema si è fatto ancora più pressante dopo l’introduzione nel nostro ordi­namento, con il decreto correttivo, dell’istituto dell’esdebitazione, sem­pre meno spiegabilmente riservata all’imprenditore fallibile, sia
pure al ricorrere di determinate condizioni, peraltro di recente interpretate
esten­sivamente dal massimo organo giurisdizionale [C s.u. 24214/11].
Nel nostro ordinamento, la sproporzione dei mezzi di tutela a dispo­sizione
delle due grandi categorie di creditori, tipiche del sistema duale di gestione
dell’insolvenza, appare evidente sol che si consideri come l’imprenditore commerciale fallibile ha a disposizione ben quattro stru­menti di risoluzione della
crisi, quali i piani attestati di risanamento (art. 67, lett. d), l.f.), gli accordi di
ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.), il concordato preventivo (artt. 160
ss. l.f.) e la transazione fiscale (art. 182-terl.f.), potendosi inoltre giovare, all’interno del fallimento, del con­cordato fallimentare (artt. 124 ss. l.f.) e dell’esdebitazione (artt. 142 ss. l.f.). Al contrario, il debitore civile, e con lui il consumatore, sino ai recenti interventi legislativi non potevano che subire, atomisticamente, le iniziative esecutive individuali dei creditori, senza poter contare su
una chance di reorganization del proprio patrimonio e dei propri debiti, stati­
camente consegnati alla relativa responsabilità, ex art. 2740 c.c.: una si­tuazione
motivatamente ritenuta al limite del sospetto di incostituzionali­tà. Seguendo
perciò l’esempio degli altri ordinamenti, primo fra tutti quello anglosassone, il
legislatore italiano ha avvertito l’esigenza di intervenire attraverso l’allestimento di una procedura più snella e duttile rispetto alle classiche procedure concorsuali, tale comun­que da fornire adeguata tutela all’indebitamento del debitore
civile-consumatore. Al riguardo si è sostenuto che la qualità di consumatore
non costituirebbe un particolare requisito soggettivo di accesso alla pro­cedura,
essendo solo funzionale ad intercettare varie misure agevolative rispetto ai restanti soggetti sovraindebitati, tra le quali, appunto, l’abbas­samento dal 70 al
50 per cento della percentuale di crediti necessaria per l’omologazione dell’accordo In altri termini, quella del consumatore non sarebbe una autonoma categoria, ai fini della procedu­ra, bensì una figura soggettiva compresa - analogamente a quella del pro­fessionista e unitamente a quella dell’imprenditore non
sottoponibile alle procedure concorsuali per ragioni dimensionali - all’interno
dell’unica categoria del debitore civile. L. Panzani, Composizione delle crisi da
sovra indebitamento, NDS, 2012, 9-31.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
l’aggiunta di una seconda parte, per cui «Nei casi di sovraindebitamento del consumatore, ai fini dell’omologazione è
sufficiente che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti».
Semmai, il problema ulteriore che potrebbe porsi è connesso al riscontro della qualità di consumatore che determina
l’abbassamento della percentuale di consensi necessaria ai
fini dell’omologazione dell’accordo.
Non sembra al riguardo potersi ipotizzare altro che una
verifica rimessa, in prima battuta, all’organismo di composizione della crisi, la quale potrà verosimilmente aprire una
fase incidentale istruttoria di carattere interlocutorio, prima
di riassumere i risultati dell’accordo nella relazione da trasmettere al giudice.
Ovviamente, sarà poi l’organo giudiziale a dover controllare, in via definitiva, il raggiungimento dell’accordo, ivi
compresa la verifica sulla effettiva qualità di consumatore del
debitore sovraindebitato15.
A tal fine soccorrerà, evidentemente, la definizione normativa contenuta nel Codice del Consumo.
L’orientamento prevalente, avallato dalla giurisprudenza
comunitaria, costituzionale e di legittimità16, considera consumatore solo la persona fisica che agisca per soddisfare esigenze di vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta, con esclusione degli
scopi anche solo connessi all’esercizio della sua attività, o
prodromici all’esercizio futuro dell’attività, o solo parzialmente privatistici, con esclusione anche di piccoli imprenditori o
artigiani, se agiscono per ragioni legate alla loro attività.
La seconda, lieve differenza tra i testi delle due norme a
confronto è contenuta nell’ultimo comma, laddove, in luogo
dei pagamenti previsti in favore delle agenzie fiscali, sono
collocati quelli dovuti, più genericamente, alle amministrazioni pubbliche.
La riferita sostituzione appare riconducibile alla volontà
di generalizzare la categoria dei crediti pubblici, al di là di
quelli gestiti dalle sole agenzie fiscali, al tempo stesso valorizzando l’oggetto di quelli invece propri degli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
A tali due ampie categorie di soggetti, dunque, è destinata quella tutela speciale di favore che prevede la sanzione
della revoca di diritto dell’accordo in caso di mancato pagamento integrale dei relativi debiti entro 90 giorni dalle scadenze previste.
Il dies a quo di decorrenza del termine suddetto è da riferire ragionevolmente alle scadenze riformulate con l’accordo
ovvero, in casso di mancata adesione delle amministrazioni
pubbliche, alla nuova scadenza imposta dalla moratoria annuale di cui all’art. 3, co. 4, d.l.
Occorre peraltro dare conto di un’altra posizione esegetica,
che riconduce alla medesima previsione una automatica quali-
15 P. Vella, La formazione dell’accordo e i suoi effetti, in Sovraindebitamento e
usura, a cura di M. Ferro, op. cit., p. 351.
16 Corte Giust. UE 22 novembre 2001, n. 541, G.civ., 2002,1, 3; Corte Giust. UE
20 gennaio 2005, n. 464, www.dejure.giuffre.it, G.civ., 2002,1, 3; Corte cost.
22 novembre 2002, n. 469, G.cost., 2002, 6; Cass. s.u. 18 novembre 2011, n.
24214, Fall, 2012, 33; Cass. 10 agosto 2004, n. 15475, G.civ.Mass., 2004, 7-8;
Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208, Ilciv., 2009, 2, 34; Cass. 4 novembre 2011,
n. 22931 e n. 22932, Fall., 2012, 169; Trib. Roma, 20 ottobre 1999, G.civ.,
2000,1,2117.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
ficazione dei creditori interessati come estranei non solo all’accordo, ma anche all’applicazione della misura della moratoria
annuale che ad essi altrimenti competerebbe, in forza della
specialità del diverso termine trimestrale qui contemplato.
Si tratta di una opzione ermeneutica forse eccessivamente
rigorosa ed eccentrica, se si considera che nessuna disposizione dell’art. 3 consente di ritenere pacifica l’esclusione di8
detti crediti dalla moratoria annuale ivi prevista, sia pure nel
rispetto delle condizioni poste dal co. 4, tra le quali vi è la
significativa esclusione dei crediti impignorabili.
Occorre poi considerare che la prima lettura consente, per
un verso, di agevolare il debitore nella programmazione delle
risorse necessarie ai fini del raggiungimento dell’accordo (che
non vanno con siffatta immediatezza destinate ai cre3ditori
pubblici), per altro verso di rafforzare la tutela di quei crediti,
in ragione dell’interesse pubblico ad essi sotteso, non potendo
il debitore confidare nella mancata impugnazione dell’accordo, per risoluzione, da parte degli enti interessati, stante
l’automatismo della sanzione, prevista in termini di revoca di
diritto medesima.
Al contrario, la lettura ritenuta recessiva avrebbe anche il
difetto di aggravare la mancanza di misure fiscali di favore
per la procedura17.
7. L’omologazione dell’accordo.
Anche l’art. 7. d.l. n. 212/2011 – che ha un contenuto
sostanzialmente analogo all’art. 12 della l. n. 3/2012 – ha
avuto un periodo di vigenza di soli sessanta giorni, essendo
stato soppresso in sede di conversione del d.l. de quo nella l.
n. 10/2012.
Il co. 1 dell’art. 7, l. n. 10/2012 presenta, quale unica
differenza rispetto al corrispondente comma dell’art. 12, l. n.
3/2012, la mancata indicazione dell’aggettivo “eventuali” che
qualifica il sostantivo “contestazioni” nella seconda norma,
ma, in realtà, trattasi di differenza meramente formale.
Una puntualizzazione si rende, tuttavia, opportuna in
tema di controllo del giudice, di ufficio o a seguito di contestazioni da parte del creditore o del debitore, in tema di perfezionamento dell’accordo.
Il d.l. n. 212/2011 era rivolto sia in generale al debitore in
stato di sovraindebitamento, sia, in particolare, al consumatore come definito con il d. lgs n. 206/2005.
Per il consumatore, l’art. 6, co. 2, secondo periodo, aveva
previsto, quale norma agevolativa, che, ai fini dell’omologazione, fosse sufficiente l’accordo raggiunto con creditori
rappresentanti almeno il 50% dei crediti ( in luogo del 70%,
necessario per il debitore comune).
Nel sistema di cui al d.l. de quo, è evidente allora che il
controllo del giudice in sede di omologazione, sia d’ufficio,
sia a seguito di contestazioni, era soggetto a dilatarsi ogni
volta in cui l’accordo avesse raggiunto una percentuale di
consensi inferiore al 70%, ma almeno del 50%18.
La qualità soggettiva del creditore, se consumatore o comune insolvente civile, non emerge in modo qualificante
nella fase antecedente l’omologa, ma si concretizza al momen-
2 0 1 2
35
to del perfezionamento dell’accordo e, pertanto, era destinata
ad essere scrutinata solo in tale fase.
Lo stesso organismo di composizione della crisi ne avrebbe dovuto tenere conto in sede di relazione ai sensi del co. 1
della norma de qua.
Uno scrutinio preventivo della qualità di consumatore, in
ogni caso da replicare in sede di omologa, si sarebbe posto
nell’ambito di una visione meramente contrattualistica della
procedura sotto il profilo dell’accertamento in ordine alla
regolarità del pagamento dei creditori estranei, intesi alla
stregua di creditori non consenzienti.
Il consumatore avrebbe dovuto già in sede di proposta
presentare un piano idoneo a garantire non già il regolare
pagamento del 30% dei crediti, ma del 50%, ovvero di quella
potenziale quota di creditori non consenzienti ma, tuttavia,
non impeditivi all’omologazione dell’accordo.
La trasformazione, per questa via, della norma di cui
all’art. 6, co. 2, secondo periodo, da norma di favore in norma
di sfavore, costituisce una delle aporie della lettura non concorsuale della procedura di sovraindebitamento.
Il co. 3 dell’art. 7 non presenta alcuna differenza, né di
forma né di sostanza, rispetto al corrispondente comma
dell’art. 12, l. n. 3/2012.
Il co. 4, periodi secondo e terzo, dell’art. 7 recita: «L’accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è
chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli artt.
737 ss. C.p.c.».
Tale formulazione appare del tutto equivalente a quella
adottata dall’art. 12, l. n. 3/2012 («L’accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con
ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
737 ss. c.p.c.»).
Il co. 5 dell’art. 7 non presenta alcuna differenza rispetto
al corrispondente comma dell’art. 12, l. n. 3/2012.
Deve solo rilevarsi che la norma in oggetto deve coordinarsi con l’art. 4, che recita al co. 3: «Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi
tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e
per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai
sensi dell’art. 14, co. 10, l. n. 183/2011, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale».
Alla luce di tale disposizione, non più riprodotta nella
corrispondente norma di cui all’art. 9, co. 3, ove il debitore
(con qualche disarmonia rispetto al rilievo che, trattandosi di
condizione di ammissibilità per espressa previsione dell’art.
2, co. 2, lett. a), il relativo onere probatorio dovrebbe considerarsi a carico di chi propone la domanda ai sensi dell’art.
2697 c.c. ) avesse legittimamente adottato il sistema documentale semplificato di cui all’art. 14, co. 10, l. n. 183/2011,
sarebbe stato arduo per il giudice verificare lo sforamento dei
parametri a) e b) dell’art. 1 l.f.
La possibile divaricazione fra l’accertamento in ordine al
requisito soggettivo di accesso alla procedura di insolvenza e
a quella fallimentare sarebbe stata evidente19.
8. L’esecuzione dell’accordo.
Anche per l’art. 8, d.l. n. 212/2011 vale il medesimo iter
17 Ibidem., p. 353.
18 R. D’amora e G. Minutoli, L’omologazione dell’accordo, in Sovraindebitamento e usura, a cura di M. Ferro, op. cit., p. 356.
19 Ibidem., p. 357.
civile
Gazzetta
36
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
di tutte le altre norme: breve vigenza; soppressione in sede di
conversione del d.l. nella l. n. 10/2012.
Peraltro, il suo contenuto è sostanzialmente analogo
all’art. 13 della l. n. 3/2012, con alcune piccole modifiche
terminologiche.
Va evidenziato che le due norme differiscono solo al co. 1,
perché nell’art. 8:
- non v’è alcun cenno al potere di proposta dell’organismo
di composizione della crisi quanto alla nomina del liquidatore;
- non vi è il richiamo all’art. 28 l.f. quanto ai requisiti soggettivi di tale ultima figura.
Per ciò che concerne il profilo sub a), il mancato riferimento all’organismo comporta solo che il potere di sollecitazione
al giudice compete, oltrechè a quest’ultimo, a chiunque vi
abbia interesse, sia esso il debitore o un creditore.
Il mancato rinvio all’art. 28 l.f. (norma, com’è noto, che
disciplina i requisiti per la nomina a curatore fallimentare)
comporta, in astratto, una piena (ma non opportuna) libertà
di scelta del liquidatore tra qualsiasi figura professionale, pur
se la disposizione fallimentaristica ben può trovare eguale
applicazione analogica, tanto più appropriata, ove si pensi che
essa non individua soltanto le categorie (avvocati, commercialisti, ragionieri, esperti in gestione d’impresa) e i soggetti, anche
collettivi (società tra professionisti, studi associati) nel cui
ambito nominare il curatore, ma anche le cause di incompatibilità, dirette a garantire una posizione di obiettività e di indipendenza del liquidatore, al riparo da conflitti di interesse20.
9. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo.
L’art. 9, d.l. n. 212/2011 ha avuto anch’esso un breve periodo di vigenza (60 gg.), ed il suo contenuto è stato riversato
pressoché integralmente all’interno dell’art. 14, l. n. 3/2012.
Nel breve periodo di vigenza è improbabile che la norma
possa avere trovato applicazione, presupponendo essa la già
avvenuta omologazione di un accordo di composizione della
crisi da sovraindebitamento.
Le differenze rispetto all’art. 14, l. n. 3/2012 consistono:
nel termine “obbligazioni” (anziché “obblighi” come
nell’art. 14) cui il co. 2 riferisce il non regolare adempimento
rilevante ai fini della risoluzione dell’accordo;
nella previsione (assente nell’art. 14) al co.3, della rilevabilità d’ufficio della decadenza dall’azione da risoluzione;
nella previsione (assente nell’art. 14) della composizione
monocratica del Tribunale.
Trattasi, in realtà, di differenze che non incidono né sull’impianto generale della norma., ma che comportano marginali
conseguenze (essenzialmente di carattere procedurale)21.
L’utilizzazione del termine “obbligazioni” in luogo di
“obblighi” (espressione, quest’ultima, peraltro ancora presente nell’art. 137 l.f., che costituisce il comune modello normativo dell’art. 9, l. n. 10/2012 e dell’art. 14, l. n. 3/2012) risponde, verosimilmente, all’intenzione di limitare l’ambito
degli inadempimenti rilevanti ai fini della risoluzione a quelli
20G. Minutoli e R. D’amora, La fase esecutiva dell’accordo, in Sovraindebitamento e usura, a cura di M. Ferro, op. cit., p. 360.
21F. S. Filocamo e P. Vella, L’annullamento e la risoluzione dell’accordo, in
Sovraindebitamento e usura, a cura di M. Ferro, op. cit., p. 362.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
concernenti i pagamenti (o le diverse forme di soddisfazione)
dei crediti previsti dall’accordo, con esclusione, pertanto, di
quelli relativi ad attività o comportamenti accessori (come, ad
esempio, le modalità liquidatorie o le eventuali limitazioni
all’accesso, da parte del debitore, al credito al consumo).
Ciò, peraltro, non sembra offrire argomenti decisivi in
ordine alla soluzione della questione (emersa in sede di interpretazione dell’art. 137 l.f.) concernente la possibilità o meno
di valutazione della gravità dell’inadempimento per escluderne la rilevanza laddove esso si riveli di scarsa importanza rispetto all’interesse dei creditori.
Ben più significativa, in questa prospettiva, è, invero, la
natura negoziale dell’accordo, che avrebbe potuto suggerire
al legislatore l’adozione di diverse formule definitorie della
fattispecie di risoluzione, come avvenuto in materia di concordato preventivo con la riscrittura dell’art. 186 l.f. ad opera
del d.lgs n. 169/2007.
La previsione della rilevabilità d’ufficio della decadenza
dall’azione di risoluzione esercitata oltre l’anno dall’ultimo
adempimento previsto dall’accordo pare rispondere più ad un
generico favor debitoris (in particolare del consumatore) o ad
esigenze di stabilità dell’accordo, che alla constatazione normativa dell’indisponibilità delle situazioni giuridiche coinvolte dalla risoluzione dell’accordo, non sembrando, al contrario,
dubitabile la loro disponibilità (che comporterebbe, in mancanza della previsione in esame, la necessità di specifica eccezione di parte per l’operatività concreta della decadenza ex
art. 2969 c.c.).
Invero, altrove la esigenza di tutela di interessi pubblici o
collettivi, ha condotto lo stesso legislatore a sacrificare la
stabilità dell’accordo, prevedendone la revoca o la risoluzione
di diritto (artt. 6, co. 5 e 7, co. 5 d.l.).
E tale stabilità è, inoltre, compromessa anche dalla mancanza di qualsiasi termine decadenziale (pur imposto dall’art.
138 l.f.) per l’esercizio dell’azione di annullamento dell’accordo, pur potendosi qui immaginare che la diversa scelta non
sia frutto di una svista del legislatore, ma il portato di un
maggior disvalore attribuito alle fattispecie di annullamento
dell’accordo, rispetto alla sua risoluzione22.
La previsione della composizione monocratica del Tribunale risponde al modulo procedimentale generale adottato dal
d.l. per conciliare il rinvio al rito camerale (che per regola
generale posta dall’art. 50-bis c.p.c. comporta la collegialità
dell’organo decidente) con l’esigenza di non appesantire eccessivamente l’attività degli affari giudiziari di primo grado
(sgravando, nel contempo, dei corrispondenti giudizi di reclamo le Corti d’Appello).
Scelta che risulta, peraltro, sostanzialmente confermata
dalla l. n. 3/2012, laddove questa, pur non facendo diretto
riferimento alla composizione monocratica dell’organo giudiziale di prima istanza, affida il reclamo al Tribunale in composizione collegiale, con previsione di incompatibilità del
giudice che ha pronunciato il decreto reclamato.
Tuttavia, l’art. 9 in esame, nulla prevede in punto di reclamo.
Avrebbe potuto, pertanto, porsi il dubbio se i reclami
contro i decreti definitori dei procedimenti di annullamento
22 Ibidem., p. 363.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
o risoluzione dell’accordo fossero devoluti allo stesso Tribunale in composizione collegiale (come l’art. 739 c.p.c. prevede
con riferimento ai decreti del giudice tutelare), ovvero alla
Corte d’Appello (come prevede, in linea generale, lo stesso art.
739 c.p.c.).
La questione assume valenza esclusivamente teorica, data
la soppressione della norma e la sua improbabile applicazione
concreta nel breve periodo di vigenza della stessa.
Essa, comunque, non ha ragione di porsi alla luce dell’art.
14, l. n. 3/2012, che si limita a rinviare alle norme sul rito
camerale, senza introdurre deroghe in punto di composizione
dell’organo giudicante.
10. Gli organismi di composizione della crisi.
L’art. 10, d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 contiene l’intera
disciplina de­dicata alla costituzione, alla organizzazione ed
ai compiti degli organi­smi di composizione della crisi.
Anch’ esso ha avuto un periodo di vigenza di soli sessanta
giorni, dal 23 dicembre 2011 al 20 febbraio 2012, essendo
stato soppresso in sede di conversione del decreto nella 1. 17
febbraio 2012, n. 10.
Il suo contenuto è stato riversato pressoché integralmente
in tre diverse disposizioni (artt. 15, 16 e 17) della 1. n. 3/2012,
in vigore dal 29 febbraio 2012.
Nel breve periodo di vigenza, è assai difficile che la norma
possa avere trovato applicazione, in mancanza della normativa secondaria da essa stessa prevista ed in presenza di specifica norma tran­sitoria (l’art. 11, d.l. n. 212/2011) che attribuiva i compiti e le funzioni degli organismi di composizione
della crisi a professionisti o società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.f. o a notai, nominati dal
presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
Le differenze più rilevanti riscontrabili dal confronto tra
l’art. 10 in esame e le corrispondenti norme della 1. n. 3/2012
sono costituite, a par­te alcune variazioni terminologiche di
nessun rilievo, dal fatto che il pri­mo non contiene alcun riferimento ai regolamenti di procedura, non vie­ta espressamente la percezione di compensi, rimborsi o indennità da par­te
dei componenti degli organismi, e differenzia la indennità
spettante a questi ultimi (previa determinazione ministeriale)
in base alla natura del debitore che vi si rivolge, dimezzandola in caso di consumatore23.
Per il resto, l’art. 10, sul piano organizzativo prevede
(come l’art. 15, 1. n. 3/2012) che gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, possano essere costituiti, con adeguate garanzie di indipen­denza e professionalità
(ma con le risorse umane, strumentali e finanzia­rie già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli­ca),
da enti pubblici, e debbano essere iscritti in apposito registro
presso il Ministero della giustizia, il quale dovrà adottare, a
tale scopo, un rego­lamento che determini i requisiti, i criteri
e le modalità di iscrizione nel registro, le modalità di formazione e revisione del registro e quelle di iscrizione, sospensione e cancellazione, nonché le indennità che i soggetti che accedono alla procedura dovranno corrispondere all’organismo
di composizione della crisi.
23F. S. Filocamo, Gli organismi di composizione della crisi, in Sovraindebitamento e usura, a cura di M. FERRO, op. cit., p. 366.
2 0 1 2
37
La norma, inoltre, concede il diritto di iscrizione nel registro, a sem­plice domanda, agli organismi di mediazione costituiti presso le CCIAA, ai segretariati sociali per l’informazione e consulenza al singolo, e ai nu­clei familiari ed agli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti
ed esperti contabili.
L’art. 10 delinea poi (come l’art. 17,1. n. 3/2012) le funzioni degli or­ganismi con una sorta di clausola aperta, che
conferisce loro il compito di assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al
raggiungimento dell’accordo, e all’esecuzione dello stesso,
nonché con il richiamo alle specifiche disposizioni che prevedono le attività procedurali degli OCC, e con la specificazione dei compiti attestativi (concernenti la veridicità dei dati
esposti nella proposta e nei do­cumenti allegati, la fattibilità
del piano ed il raggiungimento della mag­gioranza dei consensi), ed esecutivi (concernenti la pubblicità della pro­posta e
dell’accorso e le comunicazioni disposte dal giudice).
Inoltre, è opportuno rilevare che la assenza di una norma
analoga all’art. 16, l. n. 3/2012 non appare in alcun modo significativa, e che la dimidiazione dell’indennità dovuta all’OCC
da parte del consumatore, trova ragione nella particolare atten­
zione riservata a quest’ultimo dal d.l., che differenzia alcuni
snodi pro­cedurali a seconda che il sovraindebitamento colpisca
un consumatore o un professionista-imprenditore.
Quanto all’assenza del divieto di percezione di compensi
a qualsiasi titolo da parte dei componenti degli organismi di
composizione della cri­si (i quali non sono menzionati da alcuna disposizione del d.l., che non contiene le sanzioni penali previste, anche a carico dei componenti, dall’art. 19, 1. n.
3/2012), non è chiaro se ciò risponda all’intento di ricondurre esclusivamente agli organismi l’intera attività svolta, ovvero a quello di non vincolare la nor­mativa secondaria in ordine alla disciplina dei rapporti tra organismi e propri componenti, consentendo anche il frazionamento della indennità in
caso di delega esterna delle funzioni 24.
11. Disposizioni transitorie e finali.
Anche l’art. 11, d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 è stato soppresso in sede di conversione del decreto nella 1. 17 febbraio
2012, n. 10.
Poiché esso ha avuto un suo periodo di vigenza che, seppure limitato a soli sessanta giorni, potrebbe avere dato luogo
all’instaurarsi di procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento (e alla loro necessaria conclusione quanto meno con l’omologa­zione, posto che, ai sensi dell’art. 77
Cost., le norme di un decreto legge non convertito perdono
efficacia ex tunc, e la legge di conversione n. 10/2012 non
contiene alcuna disposizione che fa salvi gli effetti degli atti
posti in essere in esecuzione delle norme soppresse), appare
comunque opportuno esaminare la norma, ponendo in luce
la sua differente portata rispetto all’art. 20, l. n. 3/2012.
In realtà, l’art. 11 è l’omologo dell’art. 20, co. 2,1. n.
3/2012; con la particolarità che:
- si fa espresso riferimento, oltre che ai professionisti, anche
alle so­cietà tra professionisti, non nominate nell’art. 20;
- non vi è alcun riferimento alle finalità sociali della proce-
24 Ibidem., p. 367.
civile
Gazzetta
38
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
dura tra i criteri guida per la determinazione delle tariffe
dei professionisti da parte del Ministero della giustizia;
- vi è l’espressa previsione (aliena all’art. 20, co. 2) che le
indennità previste dalla tariffa di cui all’emanando decreto ministeriale vanno ri­dotte della metà nel caso in cui il
debitore sia un consumatore ai sensi dell’art. 1, co. 2,
lett.b)25.
L’espressa considerazione delle società di professionisti tra
i soggetti che possono svolgere i compiti e le funzioni degli
organismi di composi­zione della crisi costituisce, in realtà,
una previsione sovrabbondante sot­to il profilo della tecnica
legislativa.
Invero, già l’indicazione dei profes­sionisti aventi i requisiti di cui all’art. 28 l.f. era sicuramente inclusiva non solo
delle società tra professionisti, ma anche degli studi
professiona­li associati 26.
Ne consegue che tale precisazione è priva di autonoma
va­lenza interpretativa.
Maggiore pregnanza avrebbero avuto le disposizioni sub
b) e c), in quanto attinenti entrambe alla concreta determinazione delle tariffe dei professionisti.
La prima si rivolgeva al Ministro della giustizia, indicando
che, nella concreta determinazione delle tariffe, l’emanando
decreto si sarebbe dovuto attenere unicamente al valore della
procedura, e non anche alle finalità sociali dalla stessa perseguite, come vuole oggi l’art. 20, co. 2, 1. n. 3/2012; la seconda si applica­va, invece, in sede di liquidazione del compenso,
che veniva dimezzato nel caso in cui la procedura di composizione della crisi riguardasse un debitore-consumatore.
Peraltro, dette norme hanno perso la loro effica­cia a seguito della soppressione, in sede di conversione, del decreto
legge, e della mancata tempestiva emanazione del decreto
ministeriale contenen­te la tariffa applicabile.
Residua il problema di stabilire come possa essere determinato il com­penso dei professionisti che abbiano svolto i
compiti e le funzioni degli organismi di composizione della
crisi in assenza dell’emanazione del de­creto ministeriale e
nella vigenza del d.l. n. 212/2011.
In proposito, oc­corre distinguere l’attività svolta in epoca
successiva al 24 gennaio 2012 da quella antecedente.
Invero, a partire da tale data, l’art. 9, co. 1, d.l. n. 1/2012
ha abolito le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico, quanto meno con riferimento agli avvocati e ai
commercialisti (per i notai la questione è discussa), cosicché
l’unico parametro di riferimento non può che essere un generico ricorso al criterio equitativo. Per il periodo che va dal 23
dicembre 2011 al 23 gennaio 2012, invece, operano senza alcun
dubbio le tariffe professionali inerenti ai rispettivi ordini.
A soli fini di completezza espositiva, si segnala che l’art.
11 d.l. n. 212/2011, a dispetto della rubrica, non prevedeva
affatto la transitorietà dell’affidamento dei compiti e delle
funzioni degli organismi di composi­zione della crisi ai professionisti e ai notai.
25G. M. Nonno, Disposizioni transitorie e finali, in Sovraindebitamento e usura,
a cura di M. Ferro, op. cit., p. 370.
26I primi, legittimi solo a seguito dell’abrogazione dell’art. 2, l. n. 1815/1939 da
parte dell’art. 24, co. 1,1. n. 266/1997; i secondi, già ri­conosciuti dall’art. 1,1.
n. 1815/1939], giusta la chiara indicazione di cui al medesimo art. 28, co. 1,
lett. b).
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
Invero, la provvisorietà delle funzioni da questi esercitate
si ricava, nell’omologo art. 20, l. n. 3/2012, solo dal tenore
let­terale del co. 1, che recita: «Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che
il presente capo attribuisce agli organismi di composizione
della crisi di cui all’articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai
medesimi».
Sono proprio le parole «in via esclusiva» ad avvalorare la
tesi per la quale il ruolo dei soggetti indicati dal successivo co.
2 è destinato a cessare, per quanto non sia indicata specificamente una data finale27.
27G. Petrelli, Liberalizzazioni, tariffe professionali e tariffa notarile, www.gaetanopetrelli.it, 2012.
Gazzetta
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
●
39
CASSAZIONE CIV., sez. Un., 02 ottobre 2012, n. 16727
Nota a Cass. civ.,
sez. Un. 02 ottobre 2012, n. 16727
● Ermanno Restucci
Avvocato
Divisione giudiziale – Progetto di divisione – Contestazioni – Pronuncia – Dichiarazione di esecutività del progetto – Impugnazione
(mezzo di) – Appello
L’ordinanza che, ai sensi dello art. 789 cpc, dichiara esecutivo il progetto di divisione in presenza di contestazioni ha
natura di sentenza e va impugnata con l’appello.
Cass. civ., sez. Un., 02 ottobre 2012, n. 16727
(Omissis)
Svolgimento del processo
Il giudice istruttore del Tribunale di Tortona, con ordinanza pronunciata all’udienza del 14 giugno 2005, fissata ai
sensi dell’art. 789 c.p.c., comma 1, all’esito di giudizio di scioglimento di comunione immobiliare, ha rigettato l’istanza del
difensore della convenuta B.B., di revoca del precedente provvedimento di reiezione delle richieste istruttorie, ha quindi
proceduto all’estrazione a sorte di una delle tre soluzioni individuate dal CTU, ed ha, infine, assegnato i lotti ai singoli
condividenti, dichiarando l’esecutività del progetto approvato
e dando le ulteriori necessarie disposizioni.
Avverso tale ordinanza, B.B. ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7, denunciandone la nullità
per violazione e falsa applicazione di norme, con riferimento
all’art. 789 c.p.c., comma 3, avendo il giudice istruttore adottato l’ordinanza dichiarativa dell’esecutività del progetto di
divisione, malgrado non sussistesse il presupposto della mancanza di contestazioni.
Hanno resistito con controricorso Ba.Fi., P. L. in B. e M.M.
in B., i quali hanno concluso per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell’avanzato ricorso.
Assegnato il ricorso alla Seconda Sezione, il collegio designato, con ordinanza interlocutoria n. 13701 del 2011, ha
rimesso gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni unite al fine della decisione sulla questione
di massima di particolare importanza, concernente l’individuazione dell’effettivo regime di impugnabilità dell’ordinanza
emessa ai sensi dell’art. 789 c.p.c., comma 3, malgrado la
presenza di contestazioni o di altri impedimenti processuali.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso, la B. ha denunciato la
nullità della suddetta ordinanza oltre che del procedimento
per violazione e falsa applicazione di norme con riferimento
all’art. 789 c.p.c., comma 3, avendo il designato giudice istruttore adottato l’ordinanza dichiarativa dell’esecutività del
progetto di divisione, malgrado non sussistesse il presupposto
della mancanza di contestazioni.
2. Come già riferito, la Seconda Sezione Civile ha ritenuto
che la decisione del ricorso involgesse la questione di massima di
particolare importanza se lo strumento di impugnazione esperibile avverso l’ordinanza emessa dal giudice istruttore ai sensi
dell’art. 789 c.p.c., comma 3, malgrado la presenza di contestazioni o di altri impedimenti processuali, sia l’appello o il ricorso
straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..
L’ordinanza interlocutoria ha ricordato come, alla luce
dell’art. 789 cod. proc. civ., comma 3 una volta tenutasi l’udienza di discussione del progetto di divisione, questo possa essere
dichiarato esecutivo dal giudice unicamente ove non siano
civile
L’ordinanza ex art. 789 c.p.c.:
natura del provvedimento
ed impugnazione esperibile
2 0 1 2
40
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
sorte al riguardo contestazioni tra i condividenti, il tutto con
ordinanza qualificata espressamente come “non impugnabile”;
laddove, in caso di contestazioni, il giudice deve altrimenti
astenersi dal rendere un simile provvedimento e provvedere a
norma dell’art. 187 cod. proc. civ., decidendo con sentenza
all’esito della necessaria trattazione della causa.
La medesima ordinanza ha poi osservato che, fino all’anno 2009, la giurisprudenza della Corte - essendo chiamata a
decidere controversie iniziate prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 51 del 1998, con conseguente necessaria composizione collegiale del Tribunale nelle cause di scioglimento
delle comunioni immobiliari - fosse ferma nel ritenere ricorribile in cassazione, ex art. 111 Cost., in assenza di altri
sperimentabili mezzi di impugnazione, l’ordinanza del giudice istruttore che avesse dichiarato esecutivo un progetto divisionale in presenza di contestazioni delle parti, assumendo la
portata decisoria di una simile pronuncia, incidente in maniera abnorme sui diritti delle parti (vengono all’uopo richiamate Cass. n. 2913 del 1997;
Cass. n. 1012 del 1980; Cass. n. 6491 del 1987; Cass. n.
1778 del 1988; Cass. n. 4273 del 1995; Cass. n. 21064 del
2006; Cass. n. 9312 del 2009).
Ha ancora rilevato che, con sentenza n. 4245 del 2010,
della medesima Seconda Sezione Civile - resa a proposito
della correlata fattispecie dell’ordinanza di vendita di immobili di cui all’art. 788 cod. proc. civ. - è stato affermato che a
norma dell’art. 50-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 19
febbraio 1998, n. 51, il procedimento di scioglimento della
comunione è trattato e deciso dal Tribunale in composizione
monocratica, non rientrando tra quelli per i quali è prevista
riserva di collegialità; pertanto, ove il giudice istruttore provveda con ordinanza sulla vendita e sorgano contestazioni al
riguardo, il relativo provvedimento è pronunciato da un organo avente in ogni caso potere decisorio e pur non avendo la
forma di sentenza di cui all’art. 788 cod. proc. civ., comma 2
ne ha comunque il contenuto, onde lo strumento di impugnazione esperibile avverso di esso è l’appello, e non il ricorso
straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..
Ha evidenziato come nella motivazione della medesima
sentenza si ponga in risalto la vigente monocraticità della
cognizione del Tribunale in ogni fase del giudizio di divisione,
di tal che l’ordinanza del giudice istruttore, comunque pronunciata ai sensi dell’art. 789 cod. proc. civ., non può più
presentare alcun connotato di abnormità (come tale legittimante il ricorso ex art. 111 Cost.), in quanto proveniente
dall’organo giurisdizionale munito di potere decisorio in materia, sicchè l’errore giudiziale nella forma dell’atto (che, per il
suo contenuto, postulerebbe l’emissione di una sentenza) sarebbe denunciabile, in virtù del principio di prevalenza della
sostanza sulla forma, coi mezzi di impugnazione ordinari.
Nella ordinanza si riferisce altresì che il detto nuovo indirizzo è stato condiviso da altre tre pronunce della Seconda
Sezione civile, sia con riguardo all’ordinanza resa in presenza
di contrasto sulla necessità della vendita, nel caso di cui all’art.
788 c.p.c., commi 1 e 2 (Cass. n. 23840 del 2010), sia, più
specificamente, con riferimento all’ordinanza adottata ai
sensi dell’art. 789 c.p.c., comma 3, in difetto dei suoi presupposti, come tale da considerarsi avente il contenuto decisorio
della sentenza (Cass. n. 22663 del 2010 e, da ultimo, Cass. n.
7665 del 2011), pervenendosi, quindi, all’enucleazione del
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
conseguente principio generale in base al quale la decisione
che risolve le contestazioni circa il diritto alla divisione, i
criteri o le modalità della sua attuazione (tenuto conto della
modifica legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 51 del 1998, che
ha sottratto la divisione giudiziale dal novero delle cause devolute alla decisione del tribunale in composizione collegiale),
anche se assunta con ordinanza, è impugnabile con l’appello.
Nell’ordinanza interlocutoria si ricorda anche quell’orientamento secondo cui l’ordinanza pronunciata dal giudice
istruttore ai sensi dell’art. 789 c.p.c., comma 3, in difetto dei
presupposti di sostanza (presenza di contestazioni o mancanza dell’accordo delle parti) e/o di forma (irritualità del procedimento o viziata formazione dell’accordo), non sarebbe
giammai impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, in quanto pur sempre priva di definitività e di decisorietà, essendo piuttosto aggredibile, in quanto provvedimento
inesistente, con un’actio nullitatis (Cass. n. 10995 del 2004;
Cass. n. 2913 1997).
Esaurita la ricognizione degli orientamenti in materia,
l’ordinanza interlocutoria ha quindi ravvisato la necessità
della rimessione alle Sezioni Unite della questione di massima
di particolare importanza attinente all’individuazione del
regime di impugnabilità dell’ordinanza emessa ai sensi
dell’art. 789 c.p.c., comma 3, malgrado la presenza di contestazioni o di altri impedimenti processuali, anche al fine di
chiarire quali possano essere gli effetti della eventuale adesione all’orientamento instaurato a far tempo dalla citata sentenza n. 4245 del 2010 sui ricorsi per cassazione pendenti. In
proposito, ha evidenziato la necessità che si tenga conto del
temperamento - dalla stessa giurisprudenza ormai solidamente apprestato in tutte le fattispecie in cui sia questione di
stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di
sentenza, per individuare il mezzo d’impugnazione correttamente esperibile - al c.d. principio di prevalenza della sostanza sulla forma mediante applicazione del parallelo principio
c.d. di “apparenza e affidabilità”, il quale preserva un adeguato rilievo pure alla qualificazione data dal giudice all’azione
proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere
dalla sua esattezza: di tal che occorre di volta in volta accertare se l’adozione da parte del giudice di merito di una determinata forma de provvedimento decisorio sia stata o meno il
risultato di una consapevole scelta, ancorchè non esplicitata
con motivazione ad hoc, in quanto tale desumibile da un’indagine sugli atti nonchè sulle concrete modalità con le quali
si è svolto il procedimento (Cass., S.U, n. 390 del 2011).
3. Il Collegio ritiene che la questione debba essere esaminata e risolta alla luce delle peculiarità del giudizio di divisione.
Invero, nel codice, e più in generale nell’ordinamento
italiano, sono presenti numerosissimi casi nei quali è prevista
l’adozione di una ordinanza e non sempre tale ordinanza
viene definita come non impugnabile. Una soluzione che
avesse la pretesa di essere valida per ogni ipotesi in cui è prevista l’adozione di un’ordinanza a determinate condizioni e la
stessa venga emessa pur in difetto delle condizioni previste,
correrebbe il rischio di omologare situazioni che presentano
disomogeneità di struttura e di disciplina o di creare comunque disarmonie di sistema.
E’ dunque alla luce delle peculiarità del giudizio di divisione che va condotto l’esame ai fini di stabilire quale sia il
rimedio nei confronti di un’ordinanza ex art. 789 c.p.c., com-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
ma 3, che, pur prevedendosi espressamente che possa essere
emessa solo in mancanza di contestazioni, sia invece adottata
quando una parte abbia invece sollevato contestazioni.
3.1. Secondo l’impostazione strutturale codicistica del
procedimento di scioglimento delle comunioni (non rientrante
nell’ambito dei giudizi sottoposti a riserva di collegialità secondo l’elencazione ora riportata nell’art. 50-bis cod. proc.
civ.), è possibile che esso, una volta introdotto nelle forme tipiche del giudizio di cognizione ordinaria, possa svolgersi ed
essere definito in modo diverso, anche con forme non contenziose, in dipendenza del differente atteggiamento che tutti i
condividenti possono eventualmente assumere al suo interno.
Alla stregua dell’art. 785 cod. proc. civ., infatti, mentre il
ricorso alle forme proprie del processo (contenzioso) di cognizione è da ritenersi riservato all’eventualità in cui insorgano
contestazioni sul diritto alla dedotta divisione (o, anche, sui
criteri e sulle modalità concrete della sua attuazione), deve
ritenersi possibile pervenire ad una divisione concordata
quando non sorgano contestazioni sul suddetto diritto. In
particolare, una volta risolta positivamente (nel modo contenzioso o in quello non contenzioso) l’eventuale questione sulla
sussistenza del diritto all’ottenimento dello scioglimento della comunione, la conseguente direzione della fase (assimilabile, per certi versi, a quella conclusiva del procedimento di
espropriazione forzata) relativa alle operazioni di divisione
può (art. 786 cod. proc. civ.) essere assunta direttamente
dallo stesso giudice istruttore oppure può essere delegata dal
medesimo ad un notaio (e ciò può avvenire anche una volta
che le stesse operazioni siano già iniziate), che provvede agli
ulteriori incombenti contemplati dagli artt. 790 e 791 cod.
proc. civ. In questo quadro, il giudice istruttore è tenuto a
predisporre un progetto di divisione che viene depositato in
cancelleria con la contestuale fissazione dell’udienza per la
sua discussione, ordinando la comparizione delle parti condividenti oltre che dei creditori intervenuti.
Peraltro, prima di far luogo all’approntamento del suddetto progetto, può rendersi necessario procedere alla vendita di
uno o più cespiti mobiliari facenti parte del patrimonio da
dividere e, per tali ipotesi, gli artt. 787 e 788 cod. proc. civ.
prevedono che occorre procedere alle vendite con le forme
della vendita forzata qualora non sorga controversia sulla
necessità della vendita, mentre, nel caso contrario, la vendita
deve essere obbligatoriamente disposta con sentenza dell’organo decidente.
Una volta superati questi ostacoli e tenutasi l’udienza di
discussione del progetto predisposto da giudice istruttore,
l’art. 789 cod. proc. civ. sancisce, al comma 3, che se non
sorgono contestazioni, lo stesso progetto viene dichiarato
esecutivo con ordinanza (qualificata esplicitamente come
“non impugnabile”) dal medesimo giudice, il quale, contestualmente, emana e disposizioni attuative necessarie per
l’estrazione a sorte dei lotti, alla stregua di quanto previsto
dal citato art. 789, u.c. (a cui si correlano l’art. 195 disp. att.
cod. proc. civ. e l’art. 729 cod. civ.).
Nel caso in cui vengano prospettate contestazioni, lo
stesso giudice è tenuto a provvedere a norma dell’art. 187 cod.
proc. civ. e, quindi, a definire il giudizio mediante la c.d. soluzione contenziosa.
4. Appare opportuno prendere dapprima in considerazione
la natura dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 789 c.p.c.,
2 0 1 2
41
comma 3, ed effettivamente resa in assenza di contestazioni, con
l’avvertenza che la esposizione delle posizioni espresse dalla
giurisprudenza di questa Corte avverrà accomunando, stante la
evidente analogia delle disposizioni che li prevedono, il procedimento finalizzato alla vendita di immobili, di cui all’art. 788
cod. proc. civ., e quello volto all’approvazione del progetto divisionale, disciplinato dal successivo art. 789 cod. proc. civ..
4.1. L’ordinanza del giudice istruttore ex art. 789 c.p.c.,
comma 3, emessa per mancanza di contestazioni sul progetto
divisionale, si ritiene non impugnabile perchè la sua pronuncia
presuppone un comportamento processuale dei condividenti
che non determina l’insorgenza della lite; tale ordinanza che
dichiara esecutivo il progetto di divisione, pertanto, limitandosi a prendere atto dell’esistenza di un accordo delle parti in
ordine al suddetto progetto emergente dal loro comportamento processuale risulta priva di contenuto decisorio, con conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art.
111 Cost. (Cass. S.U. n. 4273 del 1995; Cass. n. 2913 del 1997;
Cass. n. 8820 del 1998; Cass. n. 7121 del 2001;
Cass. n. 23464 del 2004; Cass. n. 10798 del 2009).
Non muta la conclusione circa la non decisorietà dell’ordinanza prevista dall’art. 789 c.p.c., comma 3, la configurazione della stessa (del pari, seppur minoritariamente, ritenuta
in giurisprudenza: Cass. n. 289 del 1978; Cass. n. 3262 del
1987) quale esito di una struttura non contrattualistica, ma
processualistica, che, cioè, ricollega l’effetto tipico divisorio
non solo alla significativa condotta delle parti, quanto anche
essenzialmente al provvedimento ricognitivo finale del giudice istruttore: è invero innegabile che l’art. 789, comma 3 diversifica la natura dell’intervento giudiziale sulla base
dell’eventuale insorgenza di contestazioni, queste sole postulando l’esercizio di un concreto potere decisorio procedimentalizzato nelle forme proprie di cui all’art. 187 cod. proc. civ.
(in tal senso, Cass., S.U., n. 2317 del 1995, cit.).
In altre pronunce, si è esclusa la decisorietà della ordinanza e quindi l’ammissibilità del ricorso straordinario, sul rilievo che le decisioni sulle contestazioni sono riservate ex lege al
collegio (Cass. n. 6838 del 2003).
In una recente pronuncia, successiva all’ordinanza interlocutoria, si è esclusa la decisorietà dell’ordinanza emessa ai
sensi dell’art. 789 c.p.c., comma 3, in una ipotesi in cui il
giudice istruttore, pur dando atto che erano sorte “contestazioni relative all’assegnazione dei lotti”, aveva non di meno
dichiarato esecutivo il progetto di divisione, fissando l’udienza per l’estrazione a sorte dei lotti. La Corte, con riguardo a
tale fattispecie, ha però evidenziato che le contestazioni insorte unicamente in relazione alla assegnazione dei lotti, non
impedivano l’esecutività del progetto divisionale, significando
accettazione della divisione come proposta; da ciò la non decisorietà del provvedimento di fissazione dell’udienza per
procedere al sorteggio, e quindi la non assoggettabilità a ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 14331 del 2011).
Da ultimo, giova rilevare che la negazione della natura
decisoria del provvedimento tipico previsto dall’art. 789 c.p.c.,
comma 3, nella impostazione originaria del codice di rito,
poteva senz’altro desumersi anche dalla originaria ripartizione dei poteri tra l’organo a cui era affidata esclusivamente
l’istruzione della causa e quello decidente, potendo soltanto
quest’ultimo emettere provvedimenti aventi forma e sostanza
di sentenza.
civile
Gazzetta
42
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
4.2. Diverso è il discorso nel caso in cui l’ordinanza venga
emessa in presenza di contestazioni. In tali casi, l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte ammette il ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost..
In una delle pronunce nelle quali la questione del rimedio
impugnatorio - e anzi della stessa praticabilità di un rimedio
impugnatorio - è stata esaminata più approfonditamente
(Cass. n. 21064 del 2006), si è osservato che ove l’ordinanza
in questione risulti emessa in presenza di contestazioni e
quindi senza i presupposti che ne legittimano la pronuncia,
essa assume natura decisoria, in quanto incide, sia pure in
maniera abnorme, sui diritti delle parti nel giudizio di divisione, e riveste altresì natura definitiva, attesa l’assenza, secondo l’ordinamento processuale, di meccanismi idonei a
consentire il riesame del provvedimento, sia nell’ulteriore
svolgimento del procedimento, sia in sede di impugnazione;
di qui pertanto la sua ricorribilità per Cassazione ex art. 111
Cost., essendo tale ricorso straordinario applicabile ad ogni
provvedimento a carattere decisorio, intendendosi come tale
qualsiasi provvedimento che, indipendentemente dalla sua
veste formale, sia idoneo ad incidere definitivamente sulle
situazioni giuridiche soggettive. Invero, l’assenza di un consenso di tutte le parti sul progetto di divisione non può essere
equiparato - quanto ai suoi effetti ed alla conseguente tutela
in proposito esperibile - alla mancata conclusione di un accordo su di un piano meramente privatistico, posto che la contestazione al progetto divisionale di una o più parti (...) si verifica ed acquista rilievo nell’ambito di un giudizio pendente tra
tutti i condividenti, con la conseguenza che il mancato accordo tra questi ultimi sul suddetto progetto in tanto assume
rilievo sotto il profilo giuridico in quanto il giudice pronunci
l’ordinanza ex art. 789 c.p.c., comma 3, pur in assenza dei
presupposti di legge. In questo caso nasce l’esigenza di configurare uno strumento di tutela nei confronti di un provvedimento che, nel dichiarare esecutivo il progetto divisionale al
di fuori delle ipotesi in cui ciè è consentito, si rivela comunque
idoneo ad incidere sui diritti dei condividenti determinando,
con efficacia vincolante per tutti gli interessati, le porzioni dei
beni in comune assegnati a ciascuno di essi (nello stesso senso,
oltre a Cass. n. 9305 del 1993; Cass. n. 14575 del 2004, richiamate nella sentenza del 2006, vedi Cass. n. 1012 del 1980;
Cass. n. 6491 del 1987; Cass. n. 1778 del 1988; Cass. n. 7708
del 1990; Cass. n. 9247 del 1993; Cass., S.U., n. 2317 del
1995; Cass. n. 1818 del 1996; Cass. n. 1572 del 2000; Cass.
n. 9312 del 2009; e, da ultimo, Cass. n. 11853 dei 2011).
In tale pronuncia emerge, invero, la specificità del procedimento di scioglimento delle comunioni: il provvedimento
ex art. 789 c.p.c., comma 3, adottato nell’osservanza delle
condizioni stabilite da detta norma, e segnatamente in assenza di contestazioni, è, secondo quanto espressamente previsto
dal legislatore, non impugnabile perchè non decisorio. Il medesimo provvedimento, adottato in presenza di contestazioni
di alcuno dei soggetti legittimati, assume invece carattere
decisorio, ed è quindi suscettibile di impugnazione con l’unico rimedio ipotizzabile nei confronti di un provvedimento che
assuma natura decisoria e che sia anche definitivo, non essendo prevista altra sede nell’ambito della quale ottenere una
revisione dello stesso.
Nelle pronunce richiamate si evidenzia l’abnormità dell’ordinanza dichiarativa di esecutività del progetto di divisione
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
in presenza di contestazioni. Ad esempio, nella sentenza n.
4032 del 1980 si rileva il contenuto anomalo di una simile
ordinanza; nella sentenza n. 6491 del 1987 si qualifica l’ordinanza come provvedimento decisorio abnorme; nella sentenza n. 21064 del 2006, si sottolinea come il provvedimento,
adottato in presenza di contestazioni con la forma dell’ordinanza, ha natura decisoria, incidendo, sia pure in maniera
abnorme, sui diritti delle parti.
Nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 2317 del 1995,
tuttavia, si è escluso che la decisorietà dell’ordinanza, emanata in assenza dei suoi presupposti, anche quando non insorgano contestazioni, derivi dalla abnormità che la inficerebbe,
per essere essa del tutto estranea allo schema dell’art. 789 cod.
proc. civ., come pure è stato affermato in alcune sentenze
(Cass. n. 8800 del 1993; Cass. n. 3612 del 1987; Cass. n. 4464
del 1978). Infatti, si è rilevato che il concetto di abnormità di
un provvedimento giurisdizionale è diverso da quello di decisorieta, per cui un provvedimento anomalo non è necessariamente anche decisorio, e il difetto dei presupposti richiesti per
l’emanazione dell’ordinanza, anche se dedotto dalle parti
mediante le contestazioni, si risolve in un semplice vizio processuale (in ipotesi costituito dalla violazione dei precetti che
impongono al giudice istruttore di rimettere la causa al collegio, ai sensi dell’art. 187 cod. proc. civ.; di disporre l’integrazione del contraddittorio; di citare la parte dell’udienza di
discussione del progetto ecc...), non ponendosi il provvedimento in contrasto insanabile con i principi generali dell’ordinamento, e non sussistendo, quindi, la condizione essenziale perchè si possa ravvisare l’abnormità.
In sostanza, perchè possa assumersi la natura decisoria
dell’ordinanza ex art. 789 c.p.c., comma 3, si deve verificare
che vi sia stata una specifica contestazione e che su di essa il
giudice istruttore abbia deliberato, sia pure non con una
espressa pronuncia, ma per implicito, presupponendo pure la
mera emanazione dell’ordinanza dichiarativa dell’esecutività
dei progetto divisorio il rigetto della contestazione. La decisorieta dell’ordinanza del giudice istruttore sarà dunque
ravvisabile ove la stessa esprima un provvedimento idoneo a
passare in giudicato, in quanto contenente un accertamento
dei diritti dei condividenti che possa far stato fra di essi, e non
solo per effetto di una sua abnormità.
4.3. Il riferimento all’abnormità che, come rilevato, non
assume carattere risolutivo ai fini della ammissibilità del ricorso straordinario è invece valorizzato in modo particolare
da un orientamento, minoritario nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di divisione ereditaria, non è
impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ex
art. 111 Cost., l’ordinanza pronunciata dal giudice istruttore
ai sensi dell’art. 789 c.p.c., comma 3, in quanto la stessa non
solo non è definitiva ma non ha neppure natura decisoria
anche quando, essendo emessa in difetto dei presupposti di
sostanza (presenza di contestazioni o mancanza dell’accordo
delle parti) e/o di forma (irritualità del procedimento o viziata formazione dell’accordo), si risolve in un provvedimento
abnorme e, perciò, inesistente, nei cui confronti è esperibile
l’actio nullitatis, che non è un mezzo di gravame ma un’ordinaria azione di accertamento per la declaratoria di inefficacia
dei provvedimenti adottati dagli organi giurisdizionali al di
fuori delle loro attribuzioni (Cass. n. 10995 del 2004; in senso analogo, Cass, n. 2913 del 1997).
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
4.4. Più recente è invece l’orientamento che predica l’appellabilità dell’ordinanza ex art. 788 o 789 cod. proc. civ.,
emessa in presenza di contestazioni.
Come già accennato, tale orientamento prende le mosse
dalla modifica ordinamentale, per effetto della quale le controversie divisorie non sono soggette a riserva di collegialità
e rientrano, quindi, nelle attribuzioni del Tribunale monocratico. Non vi è più quindi alcuna divergenza, sotto il profilo
della composizione sempre monocratica dell’organo decidente, tra la pronuncia del giudice istruttore ove non sia sorta
controversia sulla necessità della vendita o sul progetto di
divisione, e quella resa dal giudice monocratico ove siano
sorte contestazioni al riguardo. Tale modifica ordinamentale
fa venir meno irrimediabilmente l’astratta qualificazione di
abnormità dell’ordinanza resa dal giudice istruttore in presenza di contestazioni: trattandosi di provvedimento che rivela
un contenuto sostanziale di sentenza, in forza del principio
della c.d. prevalenza della sostanza sulla forma, detta ordinanza sarà appellabile, e quindi non ricorribile per cassazione
ex art. 111 Cost., analogamente a quanto si afferma pacificamente in tema di ordinanza di convalida di licenza o di sfratto emessa fuori dai presupposti previsti di legge.
Alla luce di tale ultimo orientamento, può allora affermarsi che l’ordinanza del giudice istruttore, ex art. 789 c.p.c.,
comma 3, emessa in assenza dei presupposti legittimanti (e,
in particolare, in presenza di contestazioni dei condividenti,
sulle quali il giudice abbia, sia pur soltanto implicitamente,
deliberato, senza invitare le parti a precisare le conclusioni a
norma dell’art. 187 cod. proc. civ. e rimettere la causa in decisione) ha indubbiamente sempre natura sostanziale di sentenza. La fattispecie processuale non può più dirsi caratterizzata da carenza assoluta di potere del giudice istruttore, ma
individua unicamente un provvedimento reso in mancanza
delle condizioni di legge.
Seppure il giudice istruttore pronunci l’ordinanza sull’erroneo presupposto del difetto di contestazioni, il provvedimento risulterà appunto avere tale natura sostanziale di sentenza, sostituendosi alla statuizione conclusiva riservata
all’esito della normale fase decisoria disciplinata dall’art. 187
cod. proc. civ. per l’ordinario processo di cognizione.
Si deve peraltro rilevare che un’opzione nel senso dell’appellabilità era già stata espressa da Cass. n. 2913 del 1997,
nella quale si è affermato che, escluso il carattere decisorio
dell’ordinanza ex art. 789, quando essa viene emessa nel rispetto dell’iter processuale previsto, il problema della sua
natura si pone quando tale ordinanza viene emessa al di fuori delle previsioni di legge, per esempio in presenza di contestazioni delle parti (...)e si è ritenuto che il problema debba
essere affrontato distinguendo dagli altri, il caso in cui il G.I.,
in presenza di contestazioni, invece di rimettere la causa al
collegio, come prescritto dall’art. 789 cod. proc. civ., comma
3 si pronuncia su di esse. In tale ipotesi, nella quale il G. I.
pronunciandosi sul contrasto delle parti viene a dar vita ad
un progetto diverso da quello predisposto, nel senso che è la
decisione del giudice che prende il posto di quello, l’ordinanza ex art. 789 cod. proc. civ., viene ad assumere natura di
sentenza ed in quanto tale non può che essere impugnata con
i normali mezzi di impugnazione (appello ecc). Negli altri
casi, invece (nei quali le contestazioni non vengono esaminate o nel caso di contumacia dei condividenti ai quali non è
2 0 1 2
43
stata comunicata l’udienza di discussione) l’ordinanza ex art.
789 cod. proc. civ. non può avere natura decisoria, in quanto
dichiara esecutiva una proposta di accordo, ma non un accordo, che non è venuto ad esistenza, vuoi perchè i condividenti
contumaci non sono stati messi in grado di conoscere il progetto e quindi non può presumersi esistente alcun consenso
da parte loro; vuoi perchè esistono contestazioni che di per sè
escludono l’accordo. In questi casi l’ordinanza del G.I. non
può costituire un provvedimento idoneo a passare in giudicato, in quanto non contiene un accertamento dei diritti dei
condividenti che possa far stato fra di essi, essendo possibile,
in mancanza di un titolo, ottenere in sede di cognizione la
declaratoria della mancata formazione dell’accordo divisionale attraverso la proposizione dell’acro nullitatis o delle
azioni in genere poste a tutela dei negozi giuridici.
5. Esaurita l’illustrazione delle posizioni espresse dalla
giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame, il
Collegio ritiene che il contrasto debba essere risolto nel senso
della appellabilità della ordinanza emessa dal giudice monocratico, ai sensi dell’art. 789 c.p.c., comma 3, allorquando
difetti il presupposto della mancanza di contestazioni da
parte dei condividenti sul progetto di divisione oggetto della
dichiarazione di esecutività con la detta ordinanza.
Inducono a tale conclusione le seguenti considerazioni.
5.1. In primo luogo, il rilievo che nella disciplina dell’art.
789 c.p.c., comma 3, viene ipotizzata una doppia via di definizione del giudizio: la prima, caratterizzata dall’assenza di
contestazioni, è costituita dall’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di divisione; la seconda, che postula la formalizzazione di contestazioni, è costituita dalla sentenza che
definisce il giudizio sulle dette contestazioni. Orbene, nella
logica della citata disposizione, l’ordinanza che, in presenza
di contestazioni, dichiari esecutivo il progetto divisionale
sostituisce la sentenza che dovrebbe essere pronunciata per la
risoluzione delle proposte contestazioni. In questa funzione
oggettivamente sostitutiva della sentenza, si deve individuare
la ragione della necessità di consentire avverso l’ordinanza il
medesimo rimedio impugnatorio che sarebbe stato proponibile ne caso in cui la decisione sulle contestazioni fosse stata
adottata con sentenza. Non si deve infatti sottovalutare il rilievo che, una volta che le contestazioni siano state formalizzate, l’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto divisionale contiene comunque una decisione sulle stesse. E ciò, sia nel
caso in cui vi sia una esplicita pronuncia di rigetto della contestazione; sia nel caso in cui si voglia ritenere che il giudice
abbia implicitamente rigettato la contestazione; sia infine nel
caso in cui si voglia ipotizzare che il giudice abbia solamente
omesso di provvedere. Ne consegue che, avendo l’ordinanza
in ogni caso un contenuto decisorio quanto alle contestazioni,
il rimedio più appropriato non potrebbe essere altro che quello che sarebbe stato esperibile ove la medesima decisione
fosse stata assunta all’esito della trattazione secondo quanto
disposto dall’art. 187 cod. proc. civ., e quindi con sentenza.
Non solo esigenze di ordine sistematico, ma anche evidenti ragioni di delimitazione dei tempi dei procedimenti di divisione, impongono quindi considerare il provvedimento adottato in assenza delle condizioni di cui all’art. 789, e segnatamente - per quanto ai fini della presente questione rileva - in
presenza di contestazioni, assoggettabile al rimedio dell’appello.
civile
Gazzetta
44
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
5.2. Tale soluzione in passato non è stata accolta dalla
giurisprudenza di questa Corte, essendosi piuttosto preferito
ritenere l’ordinanza emessa in presenza di contestazioni alla
stregua di un provvedimento abnorme e quindi non appellabile, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111
Cost..
Come ben evidenziato nella sentenza n. 4245 del 2010 (e
nelle successive che ne hanno condiviso l’impostazione), a
seguito del venir meno della dualità, nelle controversie di
scioglimento di comunioni, tra giudice istruttore e collegio,
rientrando tali controversie nelle attribuzioni del giudice
monocratico, è venuto meno quell’elemento che aveva indotto
a qualificare il provvedimento adottato dall’istruttore in presenza di contestazioni in termini di abnormità e a predicarne,
quindi, la ricorribilità ai sensi dell’art. 111 Cost., per questo
aspetto.
Indubbiamente, se il giudice monocratico può decidere in
ordine alle contestazioni, non essendo più necessario rimettere la causa ai collegio per la decisione sulle stesse, viene
meno l’abnormità del provvedimento, sotto il profilo della
assenta carenza di potestà decisoria in capo ai giudice che lo
ha adottato, e se il provvedimento adottato nella forma dell’ordinanza ha un contenuto decisorio sui diritti soggettivi delle
parti, veicolati dalla formulazione delle contestazioni, non
appare dubbio che ad esso ben possa riconoscersi natura sostanziale di sentenza, assoggettabile, in forza dell’applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma,
all’ordinario rimedio impugnatolo dell’appello.
5.3. Appare peraltro opportuno ricordare che, come prima
evidenziato, già in una pronuncia del 1997 si era predicata
l’appellabilità del provvedimento adottato dal giudice istruttore sul rilievo che, decidendo sulle contestazioni, quel provvedimento avrebbe sostituito un nuovo progetto a quello già
predisposto. Da ciò può desumersi il dubbio sulla effettiva
configurabilità dell’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 789
c.p.c., comma 3, in presenza di contestazioni come provvedimento abnorme, anche nel periodo antecedente alla istituzione del giudice unico di primo grado.
I Collegio ritiene opportuno rilevare che la soluzione allora ipotizzata avrebbe meritato migliore sorte, come del resto
prospettato da parte della dottrina, nel senso di affermare già
nel precedente ordinamento processuale la appellabilità
dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 789, comma 3, pur in
presenza di contestazioni.
Invero, anche in un contesto in cui il procedimento di
scioglimento di comunioni si articolava tra giudice istruttore
e collegio, l’adozione da parte del giudice istruttore di un
provvedimento avente contenuto decisorio, sostitutivo della
sentenza, avrebbe dovuto indurre a ritenere quel provvedimento appellabile, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Ove infatti si faccia applicazione di tale principio, proprio ragioni di certezza devono
indurre a considerare il provvedimento non rispondente al
modello legislativo per il suo contenuto effettivo, e non già
per la sua forma, ai fini della individuazione del regime impugnatorio praticabile.
Ne consegue che, ove in un provvedimento giudiziario
adottato al di fuori dello schema legale tipico si individui la
natura di sentenza, e ove quindi si ritenga che il provvedimento “anomalo” abbia sostituito quello che tipicamente avrebbe
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
dovuto essere adottato per poter emettere quella determinata
pronuncia giurisdizionale, ciò non di meno la valutazione del
giudice della impugnazione, individuato secondo l’efficacia
sostanziale del provvedimento impugnato, dovrebbe avvenire
avendo riguardo ai requisiti formali del provvedimento per
come adottato e non già a quelli che avrebbe dovuto avere ove,
oltre alla sostanza, avesse avuto la forma della sentenza. Solo
in tal modo, invero, si può coniugare l’esperibilità di un rimedio procedimentale con l’obiettivo di assicurare la ragionevole durata del procedimento in cui il provvedimento impugnato è stato adottato.
Se infatti il regime impugnatorio del provvedimento non
rispondente al modello legale tipico deve essere individuato
solo avendo riguardo alla sostanza, tuttavia i suoi requisiti
formali devono continuare ad essere regolati dalla disciplina
propria del tipo di provvedimento adottato, ancorchè erroneamente, dal giudice.
In altri termini, e focalizzando l’attenzione sulla ordinanza con la quale viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione in presenza di contestazioni, ove alla stessa si riconosca
natura ed efficacia di sentenza, in quanto decisoria in ordine
alle contestazioni e quindi ai diritti delle parti, il regime impugnatorio non avrebbe potuto essere altro che quello dell’appello anche prima della modifica ordinamentale cui Cass. n.
4245 del 2010 ha ancorato il mutamento giurisprudenziale.
5.4. Non appare invece convincente il rimedio ipotizzato
dall’ordinamento minoritario che predica la proponibilità
avverso il provvedimento adottato dal giudice istruttore in
presenza di contestazioni dell’actio nullitatis.
Tale orientamento, invero, nel prospettare tra l’altro la
tesi che gli eventuali vizi del provvedimento divisionale si rifletterebbero in vizi del negozio divisorio, come tale invalidamente accertato e reso esecutivo dal giudice istruttore, tende
a valutare tale vicenda essenzialmente sotto il profilo del
mancato accordo dei condividenti in ordine al progetto divisionale; in tal modo, però, trascura di considerare che l’assenza di un consenso di tutte le parti non può essere equiparato
- quanto ai suoi effetti e alla conseguente tutela esperibile alla mancata conclusione di un accordo su di un piano meramente privatistico, posto che la contestazione al progetto divisionale di una o più parti si verifica e acquista rilievo
nell’ambito di un giudizio pendente tra tutti i condividenti. Il
mancato accordo tra questi ultimi sul suddetto progetto,
pertanto, in tanto assume rilievo sotto il profilo giuridico in
quanto il giudice istruttore pronunci l’ordinanza ex art. 789
c.p.c., comma 3, pur in assenza dei presupposti di legge; di
qui l’esigenza di configurare uno strumento di tutela nei confronti di un provvedimento che, nel dichiarare esecutivo il
progetto divisionale al di fuori delie ipotesi in cui ciè è consentito, si riveli comunque idoneo ad incidere sui diritti dei
condividenti determinando, con efficacia vincolante per tutti
gli interessati, le porzioni dei beni in comune assegnati a
ciascuno di essi (così Cass. n. 21064 del 2006, cit.).
Del resto, pur nelle pronunce in cui si afferma che la c.d.
inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da
un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, possa
essere fatta valere non con il ricorso per cassazione ex art. 111
Cost., comma 7, bensì, in ogni tempo, mediante un’azione di
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
accertamento negativo (actio nullitatis), si riconosce tuttavia
che tali vizi possano essere fatti valere tempestivamente con i
normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l’interesse della
parte ad una espressa rimozione dell’atto processuale viziato,
anche se materialmente esistente; interesse che coincide con
quello del sistema che tende ad espellere dall’ordinamento i
provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante
il ricorso nell’interesse della legge, di cui all’art. 363 cod. proc.
civ. (Cass. n. 27428 del 2009; Cass. n. 10784 del 1999).
Pertanto, quand’anche volesse predicarsi la proponibilità
dell’actio nuliitatis, ciò non precluderebbe la proposizione del
rimedio impugnatorio da individuarsi in base alla natura
sostanziale dell’atto oggetto di impugnazione.
6. Il Collegio esclude che alla soluzione del contrasto nel
senso della appellabilità della ordinanza ex art. 789 c.p.c.,
comma 3, emessa in presenza di contestazione, osti il principio di recente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui
®in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed
altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per
prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime
impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 - che ha deciso la
controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice,
ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali
si è in concreto svolto il relativo procedimento.
(Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte
territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione a decreto
ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili,
reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 30 nonostante
detta sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso) (Cass., S.U., n. 390 del 2011).
In primo luogo, deve osservarsi che il principio, pur essendo sorretto da una motivazione che potrebbe estendersi ad ogni
ipotesi di scissione o di non coincidenza tra forma del provvedimento e contenuto legale tipico del provvedimento adottato,
è stato affermato in relazione ad un procedimento che non
presenta, nella sua disciplina positiva, la previsione espressa di
una alternativa data dalla presenza o meno delle contestazioni
ad opera dei condividenti sul progetto di divisione.
Il procedimento di scioglimento di comunioni presenta,
nel quadro dei procedimenti speciali di cui al quarto libro del
codice, particolarità tali che suggeriscono la opportunità di
individuare soluzioni che siano appropriate alla specificità del
procedimento.
Nel giudizio di scioglimento di comunioni - e l’aspetto
appare particolarmente rilevante -, peraltro, per il profilo
concernente specificamente la formulazione di contestazioni
al progetto di divisione predisposto dal giudice o dall’ausiliario, non si pone un problema di tutela dell’affidamento della
parte in relazione al rimedio impugnatorio esperibile alla luce
della forma del provvedimento adottato dal giudice. Invero,
la parte che ha formulato la contestazione è consapevole di
aver sollecitato al giudice un accertamento su diritti; accertamento che, nella disciplina del codice, dovrebbe avvenire seguendo le prescrizioni dell’art. 187 cod. proc. civ. La parte
interessata è dunque pienamente in grado di comprendere che
2 0 1 2
45
il giudice, pronunciando l’ordinanza, o ha esaminato espressamente le contestazioni e le ha rigettate, adottando quindi
un provvedimento di contenuto decisorio; ovvero ha implicitamente esaminato e rigettato le contestazioni stesse, così
adottando ancora un provvedimento decisorio; ovvero ancora ha omesso di provvedere sulle contestazioni; ma anche in
questo caso, la parte è in grado di comprendere che il provvedimento non per questo cessa di avere efficacia decisoria,
essendo il provvedimento affetto da un error in procedendo,
suscettibile di rimedio da parte del giudice dell’impugnazione
ritualmente investito. Il giudice di appello, invero, a fronte
della deduzione della omessa pronuncia sulle contestazioni
ben potrà decidere nel merito sulle stesse, senza che sia necessario rimettere la causa al primo giudice, non versandosi in
alcuna delle ipotesi di cui all’art. 354 cod. proc. civ..
In sostanza, posto che la natura decisoria del provvedimento è pienamente e agevolmente riconoscibile dalla parte
che ha proposto una contestazione e che la ha vista rigettata
ovvero non esaminata, e che si è quindi in presenza di un
provvedimento sostitutivo della sentenza che quelle decisioni
avrebbe dovuto assumere, il rimedio impugnatorio che in
siffatta situazione si impone è l’appello; e ciò anche in vista di
un contenimento dei tempi di definizione del procedimento di
divisione.
Non è privo di rilievo, del resto, che in materia si è affermato il principio per cui in materia di scioglimento di comunioni, qualora il giudice istruttore abbia dichiarato esecutivo
il progetto di divisione pur in presenza di contestazioni, non
ha interesse a proporre il ricorso straordinario per cassazione
di cui all’art. 111 Cost. il condividente che all’udienza di discussione prevista dall’art. 789 cod. proc. civ. non abbia sollevato contestazioni al progetto di divisione (Cass. n. 11328
del 2003). Trattasi di principio affermato nell’ambito
dell’orientamento maggioritario, dal quale si desume però che
solo la parte che ha proposto le contestazioni, e che ha quindi percezione immediata e diretta della natura decisoria e in
ipotesi lesiva di un suo diritto, ha interesse a dolersi della reiezione delle stesse. Ove dunque si coniughi la consapevolezza
della natura decisoria del provvedimento e la consapevolezza
che quel tipo di statuizione a-vrebbe potuto essere adottata
solo con sentenza, si deve concludere che la parte interessata
a far valere il vizio è del tutto in grado di comprendere che il
rimedio esperibile non può essere altro che l’appello.
7. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di
diritto:
L’ordinanza che, ai sensi dell’art. 789 c.p.c., comma 3,
dichiara esecutivo il progetto di divisione in presenza di contestazioni ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con
l’appello.
8. Alla stregua di tale principio, il ricorso dovrebbe essere
dichiarato inammissibile.
Deve tuttavia rilevarsi che il ricorso stesso è stato proposto
ne 2005, allorquando nella giurisprudenza di questa Corte
era maggioritario l’orientamento secondo cui avverso l’ordinanza di cui all’art. 789 c.p.c., comma 3, emessa in presenza
di contestazioni, avendo contenuto decisorio e non essendo
altrimenti impugnabile, era proponibile il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost.
Invero, a parte l’isolata affermazione contenuta nella
motivazione di Cass. n. 2913 del 1997, solo a seguito della
civile
Gazzetta
46
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
sentenza n. 4245 del 2010 è venuto ad emersione il diverso
orientamento nel senso dell’appellabilità di un simile provvedimento, pur se tale interpretazione ha tratto alimento da una
modifica normativa del 1998.
Ciò comporta che, come chiarito da queste Sezioni Unite
nella sentenza n. 15144 del 2011, il ricorso può essere scrutinato nel merito, non essendo necessario disporre alcuna altra
attività idonea a raggiungere l’effetto di evitare un pregiudizio
alla parte che abbia fatto ragionevole affidamento sul precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
9. Nel merito, il ricorso è fondato.
Dallo stesso provvedimento impugnato emerge che la
parte ricorrente aveva sollecitato la revoca di una precedente
ordinanza reiettiva delle istanze istruttorie da essa proposte,
al fine di dimostrare l’intervenuta usucapione di alcuni dei
beni oggetto di divisione, e quindi la fondatezza della propria
domanda riconvenzionale.
Tanto basta per escludere che il giudice monocratico potesse procedere alla dichiarazione di esecutività dei progetto
di divisione, omettendo di valutare la fondatezza o no della
proposta domanda riconvenzionale.
10. Il prevedimento impugnato deve quindi essere cassato,
con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Tortona, in diversa composizione.
Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
(Omissis)
• • • Nota a sentenza
La decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite sopra
riportata scioglie il nodo relativo alla individuazione dello
strumento di impugnazione avverso l’ordinanza (emessa a
mente dell’art. 789 cpc) che dichiara esecutivo il progetto di
divisione anche in presenza di contestazioni.
La pronunzia ha preso spunto dal quesito posto dalla
ordinanza interlocutoria della seconda sezione n. 13701 del
2011 che – rilevando nella vicenda una questione di massima
di particolare importanza – ha imposto la decisione delle
Sezioni Unite.
L’ordinanza in questione – nel rimettere gli atti – ripercorre lo stato della giurisprudenza precedente alla decisione in
commento, sottolineando che, fino all’anno 2009, la giurisprudenza della Corte era ferma nel ritenere che lo strumento
di impugnazione andava individuato nel ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., ritenendo che la ordinanza avesse natura decisoria in quanto incidente in maniera abnorme sui diritti delle parti (cfr., ad esempio, Cass. n. 2913 del 1977 e, da
ultimo, Cass. n. 9312 del 2009).
Dalla lettura dell’ordinanza si evince pure che in opposizione a tale orientamento, a partire dall’anno 2010, la Suprema Corte aveva affermato che con la riforma del 1998 il
procedimento di scioglimento della comunione è trattato e
deciso dal Tribunale in composizione monocratica, per cui il
provvedimento ex art. 789 c.p.c., pur non avendo la forma di
sentenza, ne ha comunque il contenuto; con il corollario che
il mezzo di impugnazione andava individuato nell’appello e
non nel ricorso straordinario per Cassazione di cui allo art.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
111 Cost., non ravvisandosi nel provvedimento alcun connotato di abnormità denunciabile con il rimedio predetto.
Tale ultimo orientamento, riferisce l’ordinanza di rimessione, aveva trovato la propria definitiva adozione anche in
recenti decisioni della Corte (cfr. Cass. n. 7665/2011).
L’ordinanza di rimessione completa lo stato della giurisprudenza non mancando di sottolineare come la Suprema
Corte aveva ritenuto, in taluni casi, aggredibile il provvedimento ex art. 789 cpc con un’actio nullitatis, trattandosi di
decisione priva di definitività e di decisorietà.
In estrema sintesi la Suprema Corte:
• fino all’anno 2009 riteneva impugnabile l’ordinanza con
il ricorso ex art. 111 Cost.;
• dall’anno 2010 riteneva l’appello il mezzo di impugnazione;
• in qualche circostanza riteneva esperibile l’actio nullitatis.
Anche per dirimere la questione in ordine ai numerosi
ricorsi per Cassazione pendenti, la Seconda Sezione Civile
aveva ritenuto di rimettere la questione alla decisione delle
Sezioni Unite.
La decisione assunta dall’organo supremo, nella sua massima espressione, individua definitivamente nell’appello il rimedio di impugnazione dell’ordinanza ex art. 789 cpc resa in
presenza di contestazioni.
Per giungere a tale decisione, la Suprema Corte ha, dapprima, qualificato il giudizio di divisione quale procedimento
speciale del codice di rito, poiché lo stesso può svolgersi ed
essere definito in maniera diversa a seconda dello atteggiamento che le parti del giudizio intendono assumere, prestandosi il procedimento a più fasi solo eventuali.
La decisione, poi, passa all’esame della natura dell’ordinanza ex art. 789 cpc.
Ritiene la Suprema Corte, con ragionamento pienamente
condivisibile, che il provvedimento reso in mancanza di contestazioni, non sia impugnabile perché privo di contenuto
decisorio in quanto emesso sull’ accordo delle parti del quale
il Giudice si limita a prendere atto. In proposito, le decisioni
assunte sono molteplici: Cass., Sez. Un. n. 4273/1995, Cass.
n.10798/2009.
Diversa è la questione dell’ordinanza emessa anche in
presenza di contestazioni per le quali occorre verificare la
natura del provvedimento emesso dal Giudice.
La Suprema Corte ha ritenuto che la ordinanza che dichiara esecutivo il progetto divisionale sostituisca la sentenza che
il giudice dovrebbe pronunziare per la risoluzione delle controversie, per cui il rimedio tipico per la impugnazione è
quello dell’appello, poiché va evidenziato che una volta che le
contestazioni siano state formalizzate, l’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto divisionale contiene comunque una
decisione sulle stesse.
La decisione in esame non manca di sottolineare che in
passato tale soluzione non era stata accolta dalla giurisprudenza della Corte, poiché si riteneva l’ordinanza ex art. 789
cpc un provvedimento abnorme e quindi non appellabile.
Sottolinea la Suprema Corte che (come evidenziato nella
sentenza 4245 del 2010) a seguito del venir meno della dualità (in tema di giudizio di scioglimento della comunione) tra
giudice istruttore e collegio, se il giudice monocratico può
decidere in ordine alle contestazioni, viene meno la abnormità del provvedimento che, pur adottato nelle forme della ordinanza, ha un contenuto decisorio incidente sui diritti sog-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
gettivi delle parti, per cui allo stesso può riconoscersi natura
di sentenza assoggettabile “ in forza del principio di prevalenza della sostanza sulla forma” al rimedio impugnatorio
dell’appello.
In realtà tale principio era stato già adottato in una pronunzia del 1997, per cui il dubbio sul regime impugnatorio
era sorto tempo addietro e la dottrina predicava l’applicazione dello stesso.
La decisione esclude pure l’applicabilità dell’actio nullitatis
quale regime impugnatorio dell’ordinanza, poiché i vizi del
provvedimento possono essere fatti valere tempestivamente
con i normali mezzi di impugnazione ove ne ricorra l’interesse
della parte; in ogni caso, anche quando volesse farsi valere la
proponibilità dell’actio nullitatis, ciò non escluderebbe la
proposizione del rimedio impugnatorio da individuare in base
alla natura sostanziale dell’atto oggetto di impugnazione.
Alla convinzione della Suprema Corte a sezione Unite in
ordine al rimedio impugnatorio non osta il principio affermato dalle stesse sezioni unite ( cfr Cass. 11/01/2011 n. 390)
laddove si sottolinea che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per somme relative a prestazioni professionali, il mezzo di impugnazione va individuato in base alla forma
del provvedimento adottato; e ciò in quanto tale ultimo principio è stato adottato in con riferimento ad un procedimento
la cui disciplina non contiene una alternativa di pronunzia
quanto alla insorgenza o meno delle contestazioni delle parti.
D’altra parte, ritiene la Corte, il procedimento di divisione presenta peculiarità proprie tali da suggerire la opportu-
2 0 1 2
47
nità di individuare uno specifico mezzo impugnatorio dell’ordinanza.
La Corte svolge un ragionamento lineare e condivisibile:
la parte interessata alla rimozione del provvedimento è quella che ha proposto le contestazioni ( rigettate esplicitamente
o implicitamente o sulle quali non si è provveduto ) e che ha
la piena consapevolezza della natura del provvedimento che
non può essere che decisorio e quindi sostitutivo della sentenza e come tale impugnabile solo con l’appello.
La decisione in esame ha rappresentato una importante
risoluzione della problematica che ha definitivamente posto
fine alla vicenda tra la scelta del rimedio, oggi sicuramente
più facile ed anche veloce.
Occorre sottolineare come la dottrina (cfr. per una ottima,
recente ed aggiornata ricostruzione R. Lombardi, in Judicium) aveva ritenuto indispensabile tale intervento, anche in
considerazione che già in alcune pronunzie la stessa Corte
aveva fatto cenno alla appellabilità (addirittura sin dalla 1801
del 1965 e nella più recente decisione del 1997 pure richiamata dalla Sezioni Unite), anche al fine di evitare l’abuso del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., utilizzato per lamentare ogni vizio della ordinanza.
La stessa dottrina (cfr. Lombardi, in Contributo allo
studio del giudizio divisorio, Napoli 2009), pienamente condivisibile, dottrina, aveva già da tempo ritenuto necessario e
sollecitato, nell’ambito del giudizio divisorio, l’applicazione
del principio della prevalenza della sostanza sulla forma al
fine di addivenire alla soluzione del problema.
civile
Gazzetta
48
D i r i t t o
●
Rassegna di legittimità
●
A cura di
Corrado d’Ambrosio
Magistrato presso il Tribunale di Napoli
e
p r o c e d u r a
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
Contratti – Azione di risoluzione – Rilevabilità d’ufficio della nullità – Ammissibilità
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le S.U.
hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice
del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o
emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione,
deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la
forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda.
Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”.
Cassazione civ., sez. un, 4 settembre 2012. n. 14828
Pres. Vittoria, Est. D'Ascola
Contratto preliminare – Esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita immobiliare – Sottoscrizione del contratto da
parte di entrambi i coniugi in comunione legale – Necessità – Esclusione – Sussistenza del consenso – Sufficienza – Conseguenze in
caso di mancanza del consenso
Ai fini dell’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione
del contratto da parte di entrambi i coniugi in comunione
legale ma è sufficiente il consenso dell’altro coniuge e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai
sensi dell’art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale di
buona fede e dell’affidamento, nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla data di trascrizione.
Cassazione civ., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12923
Pres. Schettino, Est. Proto
Danni civili – Nascita indesiderata di minore malformato – Omessa informazione da parte del medico circa più efficaci accertamenti diagnostici prenatali – Responsabilità – Soggetti danneggiati
Il risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata, scaturente dall’errore del medico che, non rilevando malformazioni congenite del concepito, impedisca alla madre l’esercizio del
diritto di interruzione della gravidanza, spetta non solo ai genitori del bimbo nato malformato, ma anche ai suoi fratelli.
Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante
l'esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a
quello in concreto prescelto, impedendole così di accertare
l'esistenza d'una una malformazione congenita del concepito,
quest’ultimo, ancorché privo di soggettività giuridica fino al
momento della nascita, una volta venuto ad esistenza ha diritto, fondato sugli art. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., ad essere risarcito da parte del sanitario del danno consistente nell’essere nato non sano, rappresentato dell'interesse ad alleviare la
propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità.
Cassazione civ., sez. III, 02 ottobre 2012, n. 16754
Pres. Amatucci, Est. Travaglino
Disciplinare magistrati – Obbligo di astensione – Interesse proprio
o di un prossimo congiunto – Sussistenza dell'obbligo – Mera facoltà di astensione ex art. 51 c.p.c. – Abrogazione – Limiti
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’obbligo di astensione del magistrato, rilevante in sede disciplinare, sussiste, per
effetto dell’art. 323 c.p., in tutti i casi nei quali ricorra un
F O R E N S E
s e t t e m b r e • o t t o b r e
interesse, anche di natura non patrimoniale, proprio del
magistrato o di un suo prossimo congiunto, e che, pertanto,
in tal caso, con riferimento al giudice civile, la facoltà di
astenersi per gravi ragioni di convenienza ex art. 51 cod.
proc. civ. deve ritenersi abrogata per incompatibilità e sostituita dal corrispondente obbligo.
Cassazione civ., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19704
Pres. Preden, Est. Segreto
Espropriazione immobiliare – Sopravvenuto accertamento, dopo
la vendita, dell’inesistenza del titolo posto a base dell'esecuzione
– Idoneità ad incidere sull'avvenuta aggiudicazione – Condizioni
– Conseguenze
Le sezioni unite, pronunciando a norma dell’art. 363,
terzo comma, c.p.c. su questione di particolare importanza,
a composizione di contrasto di giurisprudenza hanno affermato il seguente principio di diritto: “il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare
l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto
dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel
corso della procedura espropriativa in conformità alle regole
che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che
sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell’esecutato di far
proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento
dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la
normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.
Cassazione civ., sez. un., 28 novembre 2012 n. 21110
Pres. Preden, Est. Rordorf
Responsabilità civile – Responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. –
Scuola – Applicabilità – Limiti
Gli obblighi di sorveglianza e di tutela a carico dell’istituto scolastico sussistono solo a partire dal momento in cui
l’allievo entra nella scuola, mentre quanto accade prima di
tale momento, ancorché in prossimità della scuola stessa, può
ricevere tutela, ricorrendone le condizioni, solo ai sensi
dell’art. 2051 c.c. (Fattispecie in tema di caduta di una bambina sui gradini esterni di una scuola, sdrucciolevoli ed instabili).
Cassazione civ., sez. III, 06 novembre 2012, n. 19160
Pres. Massera, Est. Amendola
2 0 1 2
49
Risarcimento danni – Consenso informato – Requisiti – Onere
della prova – Criteri
In materia di consenso informato, la S.C. ha precisato i
seguenti princìpi: 1) non può esservi un consenso tacito per
facta concludentia; 2) la qualità personale del soggetto da
informare (nella specie, medico) non fa venire meno l’obbligo di informazione; 3) l’onere della prova con riguardo
all’avvenuta illustrazione delle possibili conseguenze dannose della terapia spetta al medico, una volta dedotto dal paziente il relativo inadempimento.
Cassazione civ., sez. III, 27 novembre 2012, n. 20984
Pres. Petti, Est. Vivaldi
Società in accomandita semplice – Patto fra i soci di trasformazione in s.r.l. – Eseguibilità in forma specifica – Esclusione
Il contratto preliminare di trasformazione di una società
in accomandita semplice in società a responsabilità limitata,
stipulato tra i soci, è insuscettibile di esecuzione in forma
specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., in quanto esso prelude
non ad un contratto definitivo, ma ad un atto unilaterale
interno all’organismo societario, e, pertanto, il giudice sarebbe chiamato non già a decidere sul contrasto tra le parti,
ma a sostituirsi alla stessa decisione interna societaria e
all’indefettibile procedimento di cui agli art. 2500 e 2500-ter
c.c.
Cassazione civ., sez. I, 02 agosto 2012, n. 13904
Pres. Plenteda, Est. Ceccherini
Vendita – Vizi della cosa – Assunzione dell'obbligo di eliminazione – Sorgere del corrispondente diritto – Prescrizione ordinaria
- Configurabilità – Azioni quanti minoris e risolutoria – Permanenza della prescrizione ex art. 1495 cod. civ. – Sussistenza
Le Sezioni unite hanno stabilito, nell’interpretare l’art.
1495 c.c., che l’impegno del venditore all’ eliminazione dei
vizi della cosa, accettato dal compratore, comporta il sorgere del corrispondente diritto, soggetto alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto rimangono soggetti alla prescrizione
annuale, dalla norma specificamente prevista.
Cassazione civ., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19702
Pres. Preden, Est. Bucciante
civile
Gazzetta
50
D i r i t t o
●
Rassegna di merito
●
A cura di
Mario De Bellis e Daniela Iossa
Avvocati
e
p r o c e d u r a
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
Filiazione naturale – Obbligo di mantenimento – Decorrenza –
Criteri di quantificazione.
L’obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da
entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa
della filiazione naturale, collegandosi allo “status” genitoriale,
sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere
esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione
di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la
corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli
artt. 148 e 261 c.c. da interpretarsi però alla luce del regime
delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c. Pertanto,
il “quantum” dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell’importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto
l’ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del
complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente
soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi
di ciascun genitore quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né
infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha
diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
Trib. Napoli, Sez. I, sentenza 18 settembre 2012.
Giud. A.Scognamiglio.
Lesione di legittima – Azione di riduzione – Presupposti di ammissibilità.
In tema di esercizio dell’azione di riduzione di cui all’art.
546 c.c., il legittimario pretermesso è chiamato alla successione per la morte del “de cuius”, potendo acquistare i suoi
diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione. Pertanto, la condizione della preventiva accettazione dell’eredità
con beneficio d’inventario stabilita dall’art. 564, comma 1
c.c., per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per
il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per
disposizione testamentaria o per delazione ab intestato) e non
anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.
Condizione fondamentale per chiedere la riduzione delle
donazioni o delle disposizioni lesive della porzione di legittima è soltanto quella di essere tra le persone indicate dall’art.
557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre
la condizione stabilita dall’art. 564, comma 1 c.c., della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario,
vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la
qualità di erede. Infatti, il legittimario totalmente pretermesso dall’eredità, che impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius” a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in
veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza
del positivo esercizio dell’azione di riduzione.
Trib. Napoli, Sez. VI , sentenza 20 settembre 2012.
Giud. Est. A. Quaranta.
Locazione della cosa comune – Consenso di un solo comproprietario – Validità del contratto – Poteri di amministrazione della
cosa comune – Limiti.
F O R E N S E
s e t t e m b r e • o t t o b r e
1. In presenza di un contratto di locazione stipulato da
uno solo dei comproprietari, il consenso degli altri comproprietari alla conclusione del contratto si presume sì, per
l’effetto, che ancorché il singolo comproprietario abbia violato i limiti del proprio potere di amministrazione, omettendo di informare gli altri delle propria intenzione di locare la
cosa comune o, comunque, totalmente prescindendo dalla
intenzione di costoro il contratto sorge validamente, dovendosi presumere il ricordato consenso all’atto da parte degli
altri titolari del diritto dominicale. Con quindi l’ulteriore
conseguenza che in tanto può opporsi, da parte del comproprietario, la inopponibilità a lui del contratto concluso
dall’altro comproprietario in violazione degli artt. 1105 e
1108 c.c., in quanto lo stesso deduca e dimostri di avere
manifestato, al terzo e all’altro comproprietario, il proprio
dissenso rispetto al contratto che quest’ultimo stava per
concludere.
2. In tema di comproprietà, vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, e attesa la comunanza d’interessi tra tutti i contitolari
del bene medesimo, si presume il consenso di ciascuno all’iniziativa volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si
deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il
dissenso della maggioranza degli altri comproprietari.
Trib. Napoli, Sez. IX, sentenza 17 settembre 2012.
Giud. E. Di Vaio.
Obbligazioni pecuniarie – Svalutazione del credito, per effetto
della svalutazione della moneta - Presunzione del maggior danno
ex art. 1224 c.c.
Nelle obbligazioni pecuniarie, in mancanza di discipline
particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui
all’art. 1224, comma 2 c.c, (rispetto a quello già coperto dagli
interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è riconoscibile in via presuntiva, per il creditore
che ne chieda il risarcimento - dovendo ritenersi superata
l’esigenza di inquadrare il credito in una delle categorie a suo
tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere
2 0 1 2
51
dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato
per ogni anno ai sensi del primo comma dell’art. 1284 cc.
Trib. Napoli, Sez. X, sentenza 21 settembre 2012.
Giud. C. d’Ambrosio.
Prestazione di opera professionale a favore di una Pubblica Amministrazione – Riferibilità alla P.A. dell’attività posta in essere
– Presupposti sostanziali – Totale astrazione del compenso pattuito – Criteri di determinazione.
1. A norma del comma 3 dell’art. 23 D.L n. 66 del 1989,
a tutte le amministrazioni ivi indicate l’effettuazione di qualunque spesa è consentita esclusivamente se sussistano la
deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge,
divenuta (o dichiarata) esecutiva, nonché l’impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio.
La disciplina in esame configura un rapporto contrattuale
unicamente tra il terzo contraente ed il funzionario o l’amministratore che ha autorizzato l’esecuzione delle prestazioni,
tale da rendere meramente apparente l’acquisizione di beni e
servizi all’ente locale. Ne consegue la scissione del rapporto
di immedesimazione organica tra agente e Pubblica Amministrazione, in virtù della quale l’ente locale rimane estraneo
agli impegni di spesa assunti, così, da non consentire neppure di invocare il parametro dell’art. 28 Cost., il quale, nel
configurare la responsabilità della Pubblica Amministrazione
accanto a quella dei funzionari, presuppone in via di principio che l’attività posta in essere sia alla stessa riferibile.
2. Nel caso in cui il compenso per le prestazioni professionali non fosse stato liberamente pattuito, alla stregua
della garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di
determinazione prevista dal citato art. 2233, si deve attribuire rilevanza - in ordine successivo e gradato - alle tariffe e
agli usi o, in mancanza di entrambi, alla determinazione del
giudice.
Trib.Napoli, Sez. X, sentenza 19 settembre 2012.
Giud. L. Trapani.
civile
Gazzetta
52
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
In evidenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, 27 novembre 2012, n.
20984
Responsabilità medica – Dovere di informazione del paziente –
Qualità del paziente – Irrilevanza – Modalità di informazione –
Qualità del paziente – Rilevanza.
La finalità dell’informazione che il medico è tenuto a dare
è quella di assicurare il diritto all’autodeterminazione del
paziente, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione medica. È, quindi, evidente l’irrilevanza della qualità
del paziente al fine di escluderne la doverosità. La qualità del
paziente potrà, invece, incidere sulle modalità di informazione – informazione che si sostanzia in spiegazioni dettagliate
ed adeguate al livello culturale del paziente – con l’adozione
di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato
soggettivo e che, nel caso di paziente-medico, potrà essere
parametrata alle sue conoscenze scientifiche in materia”. [1]
Svolgimento del processo
S.G. convenne, davanti al tribunale di Novara, l’azienda
ospedaliera “(omissis)”, struttura ove egli stesso prestava la
propria attività in qualità di medico radiologo, chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni per lesioni ossee da patologia articolare femorale, e per i gravi postumi delle stesse, subiti
quale diretta conseguenza della terapia cortisonica somministratagli per la cura di un’encefalite post-vaccinica e post-influenzale. In particolare, egli non era stato reso edotto dei rischi
della terapia allo stesso somministrata che prevedeva, in letteratura, larghi margini di complicanze articolari, quale quella in
concreto insorta, non essendo, perciò, stato messo nelle condizioni di prestare il prescritto consenso informato. Il tribunale,
con sentenza del 6.11.2003, accoglieva la domanda.
Gazzetta
F O R E N S E
Affermava, a tal fine, che la mancata prestazione del consenso al trattamento da parte del paziente, non adeguatamente informato, costituiva autonoma fonte di responsabilità,
restando irrilevanti la correttezza od adeguatezza tecnica
delle cure prestate.
A diversa conclusione pervenne la Corte d’Appello di
Torino che, con sentenza in data 11.12.2006, accolse l’appello proposto dalla Regione Piemonte, Gestione Liquidatoria
USL XX ed, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò
la domanda.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi
S.G. .
Resiste con controricorso la Regione Piemonte, Gestione
Liquidatoria USL XX.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli art. 2, 13 e 32 Costituzione nonché art.
29 codice deontologico in relazione all’art. 360 n. 3 C.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione degli art. 2697 C.c. e difetto di motivazione in
relazione all’art. 360 nn. 3 e 5.
Con il terzo motivo si denuncia la omessa violazione e/o
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e/o decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
I motivi, per l’intima connessione delle censure con gli
stessi proposte, che involgono, sotto diversi profili, la questione del consenso informato, sono trattati congiuntamente.
Essi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.
In prima battuta, va sgombrato il campo dal profilo relativo
alla sussistenza del nesso di causalità.
La Corte di merito, in proposito, ha accertato ed affermato -con ciò rigettando le censure sul punto mosse dall’appellante Regione Piemonte, Gestione Liquidatoria USL XX – che
“Il ctu, sia a verbale, sia nelle sue note integrative in sede di
Nota redazionale a cura di Pietro Sorrentino
(1) La sentenza in esame affronta uno dei problemi più dibattuti in materia di
responsabilità medica, quello del consenso informato. Il consenso informato è
l’espressione dell’accettazione volontaria o del rifiuto da parte dell’interessato
ad un trattamento proposto dal medico. È l’unica manifestazione di volontà
che autorizza un qualsiasi atto medico e può essere revocato in qualsiasi momento, costituendo così la base del principio di autodeterminazione del paziente (App. Milano Sez. I, 19 agosto 2011). Il consenso è valido solo se il paziente riceve da parte del medico una informazione completa, professionale e
dettagliata: altrimenti detto il paziente deve essere messo in condizione di capire e quindi di accettare, rifiutare o ancora interrompere un trattamento (Cass.
16.10.2007 n. 21748). In Italia manca una legislazione specifica sul consenso
informato, che è stato accolto nell’ordinamento giuridico italiano con riferimento all’art. 13 della Costituzione, che afferma l’inviolabilità della libertà
personale (intesa anche come libertà fisica e morale), nonché all’art. 32, che
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, fissando il principio
secondo cui nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario contro
la sua volontà, se tale trattamento non è previsto come obbligatorio ‘per disposizione di legge’. Il Codice italiano di deontologia medica ha riconosciuto
nel 1989 come doveri del medico quello di informare il paziente e quello di
ottenere il consenso all’atto medico. L’art. 32 recita che «il medico non deve
intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del
consenso informato del paziente». Lo stesso articolo ricorda che il consenso
deve essere «espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in
cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le
possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una
manifestazione inequivoca della volontà della persona». La mancata richiesta
del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità per il medico anche
quando l’intervento abbia esito positivo. Infatti il paziente potrebbe sempre
obiettare di non essere stato messo in condizione di effettuare le proprie scelte,
per cui «il medico risponde dei danni conseguenti alla violazione, per negligen-
c i v i l e
za, del dovere di informazione del paziente sui possibili esiti dell’intervento
chirurgico, al quale egli è tenuto in ogni caso». La Suprema Corte, nel caso in
esame, si è occupata di due aspetti particolari afferenti il consenso informato
ovvero quello della rilevanza delle qualità personali del paziente al fine della
corretta formazione del consenso stesso e quello del soggetto sui cui ricada
l’onere della prova circa il mancato o l’avvenuto adempimento dell’obbligo di
informazione. La vicenda processuale può essere così riassunta: S.G. convenne,
davanti al tribunale di Novara, l’azienda ospedaliera (omissis) , struttura ove
egli stesso prestava la propria attività in qualità di medico radiologo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per lesioni ossee da patologia articolare femorale, e per i gravi postumi delle stesse, subiti quale diretta conseguenza della terapia cortisonica somministratagli per la cura di un’encefalite
post-vaccinica e post-influenzale. In particolare, egli non era stato reso edotto
dei rischi della terapia allo stesso somministrata che prevedeva, in letteratura,
larghi margini di complicanze articolari, quale quella in concreto insorta, non
essendo, perciò, stato messo nelle condizioni di prestare il prescritto consenso
informato. Il tribunale, con sentenza del 6.11.2003, accoglieva la domanda.
A diversa conclusione pervenne la Corte d’Appello di Torino che, con sentenza in data 11.12.2006, accolse l’appello proposto dalla Regione Piemonte. ed,
in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda. Il sig. S.G. ha
proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello ribaltando completamente le enunciazioni di principio
su cui la corte di merito aveva fondato la propria decisione.
Principi pacifici nella giurisprudenza della Suprema Corte sono i seguenti: il
consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del
trattamento sanitario; senza il consenso informato l’intervento del medico è
– al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui
ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente. Il diritto al consenso informato, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario (Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.07.2011 n° 16543). La mancanza della richiesta
del consenso informato per la esecuzione di un intervento chirurgico, la quale
va sempre e comunque fatta, a meno che non si tratti di caso di urgenza o di
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
2 0 1 2
53
chiarimenti, ha indicato, seppure in termini di verosimiglianza, da considerarsi elevata, la riconducibilità della patologia
articolare femorale, e le conseguenze permanenti residuate
dalla stessa, al trattamento cortisonico, indicando quest’ultimo tra le più frequenti cause, di natura iatrogena, di tale
patologia, segnalate ed evidenziate in letteratura”.
Aggiungendo che “le restanti cause note della patologia in
questione tra cui quelle di natura traumatica, o conseguenti
a patologie vascolari e del metabolismo, ovvero l’alcolismo,
sono da ritenere escluse del tutto nella fattispecie, come risulta incontestato”.
Precisando: “Restano le c.d. cause di natura “idiopatica”,
che, in specie, sono da ritenere, del tutto verosimilmente,
anch’esse escluse, proprio per l’antecedente e significativa
presenza del trattamento cortisonico, che è invece indicato
come causa nota, frequente, specifica e diretta della patologia
in questione, dovendo pertanto confermarsi il giudizio del ctu,
in termini di elevata verosimiglianza del nesso causale”.
Ed ha chiarito questo aspetto: “Vi è stata, infatti, una
necrosi asettica iatrogena a seguito di trattamento con farmaci cortisonici come in specie si è verificato, essendo verosimilmente la complicanza in questione ascrivibile a detta e nota
specifica origine anziché alle altre descritte dal ctu, in relazione alla precedente somministrazione dei cortisonici, ed
essendo, invece, assenti o comunque non accertati, gli altri
descritti fattori di rischio”.
Concludendo, in relazione alla sussistenza del nesso di
causalità: “Il quadro probatorio è pertanto del tutto univoco
e non smentito né indebolito da elementi di segno contrario
che ne denotino l’intrinseca contraddittorietà, ben integrando
esso, pertanto, la prova piena e positiva del nesso di causalità,
non ricorrendo, invece, la diversa ipotesi, invocata dall’appellante, dell’insufficienza del quadro probatorio”.
La Corte di merito ha, quindi, convalidato le conclusioni
cui era pervenuta con l’ulteriore precisazione: “Né, d’altronde,
può considerarsi significativo il lasso di tempo, non breve, di
tre anni, intercorso tra il trattamento farmacologico e l’evento patologico, in assenza di alcun altro fattore che si sia autonomamente inserito nella suddetta concatenazione clinica, sì
da determinare il sorgere di un’autonoma serie causale, collegabile eziologicamente, in tale stesso arco di tempo, alla
malattia articolare. Né, d’altronde, in proposito, sussistono
minori limiti temporali noti, contenuti, necessariamente, in
un arco di tempo inferiore, per la possibilità di sviluppo della
malattia femorale, dovendo pertanto considerarsi l’insorgere
della stessa, anche a distanza di tempo, compatibile col quadro
eziologico su delineato”.
Questo punto della decisione non è stato colpito da alcuna
censura; con la sua conseguente, attuale incontrovertibilità in
questa sede.
Passiamo, ora, ad esaminare la questione centrale nell’impianto della sentenza impugnata: quella del consenso informato, delle sue caratteristiche e dei corollari in tema di
eventuale inadempimento e risarcimento del danno.
Le proposizioni argomentative che hanno condotto la
Corte di merito a negare la responsabilità della struttura sanitaria, escludendo la doverosità di un risarcimento dei danni,
sono le seguenti:
a) In tema di consenso informato non può escludersi la
rilevanza della qualità rivestita dal paziente – medico anch’egli,
in qualità di radiologo, presso la stessa struttura sanitaria in
cui era stato ricoverato “ai fini di ritenere raggiunta la prova
della sua consapevole adesione al trattamento, pur in assenza….di una dichiarazione scritta, ai fini di ritenere acquisito”.
E ciò “potendo ben presumersi che, al di là delle comunicazioni protocollari, il caso clinico, in specie, anche per il suo intrinseco interesse, sia stato ampiamente discusso e approfondito, con lo stesso paziente, allorché uscito dalla fase critica,
trattamento sanitario obbligatorio, costituisce inosservanza del diritto inviolabile dell’uomo a vedere tutelato il suo diritto alla salute con dignità propria
dell’essere persona. anche in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano derivate conseguenze dannose, qualora tale intervento non sia stato preceduto da adeguata
informazione, l’inadempimento dell’obbligo informativo assume una valenza
causale sui danni subiti dal paziente (Cass. civ. Sez. III, 28 luglio 2011, n.
16543). In realtà parte della giurisprudenza ritiene che in materia di responsabilità medica, la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per
le non imprevedibili conseguenze dell’intervento chirurgico eseguito correttamente, nel rispetto delle regole dell’arte, tuttavia effettuato senza la preventiva
informazione del paziente in ordine ai suoi possibili effetti pregiudizievoli e,
dunque, effettuato in assenza di un consenso consapevolmente prestato, richiede necessariamente di accertare che il medesimo paziente, se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi a tale intervento (App. Napoli Sez. III, 30-06-2011). Tuttavia la giurisprudenza della Corte di Cassazione
ha sempre rifiutato una simile impostazione e da ultima con l’esaminata sent.
20984/2012 ha tenuto di ribadire che “La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all’adempimento dell’obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del
trattamento cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi – in conseguenza
dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa – di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente”.
Dunque se tutto quanto appena detto è pacifico lo è altrettanto affermare la
completa irrilevanza delle qualità personali del paziente (in questo caso l’esercizio della professione di radiologo) ai fini della responsabilità medica del sanitario. Il personale sanitario, desumendo che il paziente del caso in questione,
poiché medico radiologo della stessa struttura in cui fu operato e quindi probabilmente in possesso di conoscenze mediche tali da renderlo consapevole dei
rischi del trattamento, hanno semplicemente presunto il consenso. La Corte di
Cassazione, analizzando la questione, ha ribadito che il consenso presunto è
del tutto inammissibile. Il personale medico deve sempre e comunque informare con completezza il paziente circa i rischi del trattamento. Vi deve sempre
essere una manifestazione esterna di un consenso informato, scritta oppure
orale, ed è solo in questo secondo caso che diviene possibile provare, con prova
testimoniale o con altro mezzo di prova, la sussistenza di un consenso informato che si era in ogni caso già manifestato all’esterno. A nulla rileva neanche il
richiamo all’art. 29 del Codice di Deontologia medica, che la Corte d’Appello
ha fatto per escludere la responsabilità del personale medico “il consenso – e la
relativa corretta informazione – deve essere riferito al livello di cultura ed alle
capacità di discernimento del soggetto”. Infatti tale articolo influisce semplicemente sulle modalità di informazione che, nel caso di paziente-medico, potrà
essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche in materia, ma non permette che tale informazione possa essere ritenuta superflua data la presunzione di
consapevolezza che discende da tali conoscenze.
Ulteriore argomento che la Corte d’Appello ha utilizzato per escludere la responsabilità del personale sanitario è la circostanza che il paziente non sia riuscito a dimostrare di “non avere affatto ricevuto, o comunque acquisito una
sufficiente conoscenza dei rischi cui era esposto ed una tale prova incombeva
all’attore”. Tuttavia anche questa tesi è in palese contrasto con la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione secondo cui la responsabilità professionale del medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell’allegazione, da
parte del paziente, dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico gravato dell’onere della prova di aver adempiuto all’obbligazione (Cass. civ.
Sez. III, 19 maggio 2011, n. 11005, Cass. Civ. 09 febbraio 2010 n.2847). In
perfetto accordo con tale impostazione, anche in questo caso, la Suprema
Corte ha ribadito che “l’intervento stesso del medico, anche solo in funzione
diagnostica, determini l’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Con
la conseguenza che, una volta effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto,
l’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento – al
fine di ottenere il necessario consenso all’esecuzione della prestazione terapeutica – costituisce un’obbligazione, il cui adempimento deve essere provato
dalla parte che l’altra affermi inadempiente. Dunque, dal medico a fronte
dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente”.
civile
Gazzetta
54
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
dai medici della struttura nonché colleghi di lavoro del S. “.
b) Il codice di deontologia medica (art. 29) prevede che il
consenso – e la relativa corretta informazione – debba essere
riferito “al livello di cultura ed alle capacità di discernimento
del soggetto”. “E se tale principio vale di certo a tutelare il
paziente digiuno di ogni nozione medica, verso il quale l’attenzione, anche sul piano della scelta di un linguaggio e di
singoli termini lessicali, chiari e comprensibili, deve essere
massima, tale esigenza non può ugualmente ravvisarsi qualora il paziente sia invece particolarmente edotto della materia,
ovvero quando, come in specie, ricorrano specifiche circostanze di fatto che rafforzino la presunzione di una sua adesione
consapevole al trattamento clinico, indipendentemente da
comunicazioni formali”.
Ed in questo senso “….pertanto, il grado di acquisita conoscenza e consapevolezza deve essere, in concreto, e non
solo in termini di linguaggio usato per comunicare, effettivamente parametrato al grado delle conoscenze del paziente in
esame, alle quali, in specie, si aggiunge, quale fonte indiretta
di piena consapevolezza del trattamento clinico-farmacologico, e delle sue implicazioni, l’appartenenza del dr. S. al qualificato contesto professionale della struttura ospedaliera da
cui il medesimo dipendeva, quale radiologo, avendo in fatto
egli un rapporto diretto con i propri medici curanti, dei quali era anche collega di lavoro”.
c) L’attore non ha provato di “non avere affatto ricevuto,
o comunque acquisito una sufficiente conoscenza dei rischi
cui era esposto” ed una tale prova incombeva all’attore. In tal
modo non era stata adeguatamente superata “la presunzione
logicamente derivante da tale contesto, nei termini di una
maggiore ampiezza conoscitiva, dovuta allo scambio di informazioni tra colleghi sul peculiare ed interessante caso clinico
di un’infezione meningea contratta, a seguito della somministrazione di un vaccino antinfluenzale, da un medico e collega di lavoro”.
d) Ricorrevano, nella specie, una serie di elementi che “sia
in via diretta che presuntiva, tale conoscenza e consapevolezza (relative alla particolarità del caso clinico ed alla specificità della terapia praticata al paziente) dovevano, invece, far
ritenere in concreto, acquisita proprio in relazione a tale qualificato stato soggettivo del paziente e al contesto umano e
professionale in cui il medesimo si trovava inserito, allorché
contrasse la malattia e fu curato presso la stessa struttura da
cui dipendeva”.
Ulteriore elemento, dal quale era consentito inferire un
ulteriore elemento di consapevolezza del paziente era rappresentato dalla circostanza che la stessa moglie del S. “era un
medico dipendente dello stesso ospedale di Omissis, avendo
avuto, pertanto, modo di interloquire, anche al di fuori del
linguaggio ufficiale e protocollare, con i colleghi di lavoro,
circa le terapie più idonee da somministrare al singolare paziente, nonché, proprio coniuge”.
e) Anche la complicanza iatrogena, “proprio perché non
anomala né imprevedibile (come definita dal ctu), e in concreto verificatasi, ben poteva, più che presumibilmente rientrare
tra le specifiche conoscenze del dr. S., che, peraltro, quale
radiologo, aveva sicuramente, per specifica competenza, piena contezza delle più diverse patologie articolari, fra cui
quella femorale che lo aveva colpito, nonché, necessariamente delle loro cause scatenanti, specie se, come emerso dalla
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
ctu, clinicamente frequenti”.
Tali elementi sono stati giudicati dalla Corte di merito
“tutti univoci, sotto un elevato profilo presuntivo, e non contraddetti da fattori di segno opposto, concreti, o anch’ essi
presunti, e idonei di per sé a far ritenere in concreto acquisita
da parte del dr. S. , detta conoscenza e consapevolezza del
rischio clinico legato al trattamento”. A questi, la Corte di
merito ha ritenuto di affiancarne ulteriori definiti “di natura
oggettiva ed anch’essi univocamente in grado di attestare,
unitamente ai primi, tale raggiunta consapevolezza ed accettazione del trattamenti praticato”.
Tali sono definite le “chiari ed esaustive annotazioni sulla
cartella clinica, all’atto delle dimissioni”, cartella clinica che
“oltre al dosaggio scalare del farmaco, nelle settimane successive, elemento indicativo di per sé, e in special modo ad un
medico, della portata precauzionale e prudenziale della prescrizione, volta ad evitare i rischi di complicanze, specie in
relazione alla natura cortisonica del farmaco in esame, conteneva anche la raccomandazione al paziente di sottoporsi a
visita di controllo, per determinare le scelte terapeutiche e la
posologia successiva, anche in tal caso contribuendo, tale
precisa indicazione terapeutica, a rafforzare la consapevolezza circa l’esigenza di monitorare le fasi successive del processo di convalescenza e di guarigione, non scontata, e necessitante di controlli”.
Un tale percorso argomentativo non può essere seguito,
né le implicazioni che la Corte di merito ne ha fatto scaturire,
sono condivisibili.
Queste le ragioni.
Sono principi ormai acquisiti nella giurisprudenza della
Corte di cassazione i seguenti.
Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario.
Senza il consenso informato l’intervento del medico è – al
di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente.
Il consenso informato ha come correlato la facoltà, non
solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell’eventualità, di rifiutare la terapia e di
decidere consapevolmente di interromperla; e ciò in tutte le
fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass.
16.10.2007 n. 21748).
Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008, sub n. 4 del Considerato in diritto) il
consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico,
si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova
fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost.,
i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è
inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso
informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all’adempimento dell’obbligo di informazione in ordine
alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia
sottoposto b) dal verificarsi – in conseguenza dell’esecuzione
del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di cau-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
salità con essa – di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.
Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, se
il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.
Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il
paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato
messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con
una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e
psichica (v. anche Cass. 28.7.2011 n. 16543).
In ordine alle modalità e caratteri del consenso, è stato
affermato che il consenso deve essere, anzitutto, personale:
deve, cioè provenire dal paziente, (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente);
deve poi essere specifico e esplicito (Cass. 23.5.2001 n. 7027);
inoltre reale ed effettivo; ciò che vuoi significare che non è
consentito il consenso presunto; ed, ancora, nei casi in cui ciò
sia possibile, anche attuale (v. per le relative implicazioni Cass.
16.10.2007 n. 21748). Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere “informato”, dovendo
basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico.
Se questi sono i principi che si applicano in materia di
consenso informato, è di tutta evidenza che le indicazioni
fornite sul punto dalla Corte di merito, in quanto sostanzialmente fondate soltanto su argomenti di natura presuntiva, non
possano essere seguite.
La sentenza impugnata confonde il consenso presunto con
la prova di un consenso reale ed effettivo.
Si ha consenso presunto – come tale inammissibile – nel
caso in cui si ritiene che il soggetto in quel dato contesto situazionale avrebbe sicuramente dato il consenso se gli fosse
stato richiesto.
Si ha, invece, prova mediante indizi del consenso prestato
quando realmente in un certo momento temporalmente definito c’è stata effettiva richiesta ed effettiva prestazione del
consenso. Solo che la prova di tale consenso viene data, non
attraverso un documento scritto, ma attraverso testimonianze ed indizi (si faccia il caso che il documento con cui il paziente prestava il suo consenso è andato distrutto).
A scanso di equivoci va aggiunto che – dati i valori in
gioco – non esiste un consenso tacito per facta concludentia.
Il consenso deve tradursi in una manifestazione di volontà effettiva e reale.
È la prova del consenso che – in caso di impossibilità di
prova documentale – può essere fornita con altri mezzi.
Come dire che il consenso informato non richiede la prova scritta ad substantiam, ma richiede comunque una manifestazione reale, cioè concretamente avvenuta hic et nunc.
Chiariti i termini giuridici della questione, si nota subito
come molti degli argomenti della sentenza impugnata siano
irrilevanti.
In sostanza, l’argomento principale della sentenza può
essere stilizzato come segue: il paziente era un medico, quindi
aveva le cognizioni scientifiche necessarie per rendersi conto
del trattamento cui veniva sottoposto; faceva parte della stessa struttura ospedaliera e quindi aveva un contatto frequente
con i medici curanti; ora, se docilmente si è sottoposto alla
cura, questo vuoi dire che era d’accordo; cioè si è sottoposto
2 0 1 2
55
cura, questo vuoi dire che era d’accordo; cioè si è sottoposto
volontariamente alla terapia nella consapevolezza (derivante
dalle sue cognizioni mediche) dei rischi della stessa.
L’argomento è all’evidenza irrilevante perché -anche se
fondato- ci porterebbe direttamente al consenso presunto.
Infatti, l’argomento non dimostra che effettivamente vi fu
una richiesta di consenso e una prestazione di consenso.
L’argomento dimostra soltanto che i medici hanno, in
buona fede, presunto che il paziente fosse d’accordo.
Ma la legge richiede ben altri e più rigorosi requisiti.
In questa prospettiva si appalesano irrilevanti ulteriori
argomenti.
In particolare, è privo di consistenza il riferimento all’art.
29 del codice di deontologia medica (art. 29) che prevede che
il consenso – e la relativa corretta informazione – debba essere riferito “al livello di cultura ed alle capacità di discernimento del soggetto”, poiché al medico, in questo caso, non si
contesta la violazione del codice deontologico, quanto l’avere
“operato” in assenza di un consenso informato.
Può, quindi, sostenersi che, pur non essendovi violazione
del codice deontologico, sussiste, invece responsabilità medica; e ciò proprio perché i due ordinamenti agiscono su piani
diversi: l’uno disciplinare, l’altro civilistico.
A questo punto, ci si deve domandare se questo assetto di
regole e di condotte muti in considerazione della qualità del
paziente che deve fornire il consenso; ciò che vorrebbe dire che
i principi si atteggiano diversamente, pervenendo perfino ad
escludere rilevanza causale alla mancanza di consenso informato in caso di paziente “medico”. La risposta è negativa.
La finalità dell’informazione che il medico è tenuto a dare
è quella di assicurare il diritto all’autodeterminazione del
paziente, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione medica (v. anche Cass. 9.2.2010, n. 2847). È, quindi,
evidente l’irrilevanza della qualità del paziente al fine di escluderne la doverosità.
La qualità del paziente potrà, invece, incidere sulle modalità di informazione – informazione che si sostanzia in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente – con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo
particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente-medico,
potrà essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche in
materia.
E ciò in particolare nel caso in esame, se – come risulta
non contestato – la complicanza iatrogena dovuta al trattamento cortisonico e causatrice della necrosi delle due teste del
femore – era da considerarsi frequente in caso di trattamenti
del genere.
In tal modo, il paziente sarebbe stato in grado di scegliere
se proseguire o meno la terapia indicata, od, eventualmente,
preferire un farmaco diverso, di minore durata e con un dosaggio più contenuto.
Erra, pertanto, la Corte di merito quando, sotto questo
profilo, afferma non potersi escludere “la rilevanza della
qualità rivestita dal paziente – medico anch’egli, in qualità di
radiologo, presso la stessa struttura sanitaria in cui era stato
ricoverato” ai fini di ritenere raggiunta la prova della sua
consapevole adesione al trattamento, pur in assenza…. di una
dichiarazione scritta”; e su tale base presume “che, al di là
delle comunicazioni protocollari, il caso clinico, in specie,
anche per il suo intrinseco interesse, sia stato ampiamente
civile
Gazzetta
56
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
discusso e approfondito, con lo stesso paziente, allorché uscito dalla fase critica, dai medici della struttura nonché colleghi
di lavoro del S. “.
Ma il ragionamento presuntivo – di cui si è già detto –
parte da un fatto noto per ritenere raggiunta la prova di
quello ignoto.
Ciò che difetta, nella specie, è la notorietà di quello considerato noto, che si basa, anch’esso, su di una presunzione;
come visto, due presunzioni ininfluenti al fine di ritenere
prestato il richiesto consenso alla terapia adottata.
Ancora, non sono condivisibili le argomentazioni – di cui
la Corte di merito fa largo uso nelle sue considerazioni – basate sui principi della “consapevolezza e la conoscenza”, che
sono soltanto conseguenza di un consenso, ma non l’essenza
stessa del consenso.
Sono, quindi, le modalità – ossia il quomodo delle informazioni che il medico deve fornire – che possono variare in
considerazione del grado di conoscenze specifiche del paziente; il consenso, però, non può essere presunto, ma deve essere
effettivo.
A questo punto, l’ulteriore passo da effettuare è stabilire
a chi incomba l’onore di provare l’avvenuto od il mancato
adempimento dell’obbligo di informazione.
Sotto questo profilo, è ormai principio incontestato che
l’intervento stesso del medico, anche solo in funzione diagnostica, determini l’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale.
Con la conseguenza che, una volta effettuata la diagnosi
in esecuzione del contratto, l’illustrazione al paziente delle
conseguenze della terapia o dell’intervento – al fine di ottenere il necessario consenso all’esecuzione della prestazione terapeutica – costituisce un’obbligazione, il cui adempimento deve
essere provato dalla parte che l’altra affermi inadempiente.
Dunque, dal medico a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente (v. anche (Cass. 9.2.2010 n.
16543; Cass. 9.2.2010 n. 2847).
Erra, pertanto, la Corte di merito quando afferma che
l’attore non ha provato di “non avere affatto ricevuto, o comunque acquisito una sufficiente conoscenza dei rischi cui era
esposto ed una tale prova incombeva all’attore”; con ciò onerando di una tale prova – oltretutto negativa e contraria al
principio di vicinanza alla prova di cui all’art. 24 Cost. – il
paziente.
Questi gli snodi argomentativi che la Corte di merito ha
in modo erroneo trattato e che l’hanno condotta ad una conclusione non in linea con i principi enunciati.
Alla luce degli stessi, il giudice del rinvio dovrà esaminare
la vicenda in questione.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
Alcuni corollari.
Corollario di quanto fin qui detto è che il rispetto dell’autodeterminazione del paziente – che è ciò che si vuole tutelare,
con il conseguente risarcimento del danno per mancato consenso – deve essere valutato in concreto, tenendo presenti le
reali possibilità di scelta che si ponevano di fronte al paziente,
nel caso in cui fosse stato adeguatamente informato.
A ciò consegue che la rilevanza causale del mancato consenso sussiste soltanto quando una tale disinformazione abbia
comportato una scelta terapeutica che, altrimenti, sarebbe
stata, con alta probabilità, rifiutata o modificata dal paziente
stesso (v. anche Cass. 13.7.2010 n. 16394; Cass. 9.2.2010 n.
2847).
Ciò vuoi dire che l’inadempimento rilevante nell’ambito
dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno, nelle obbligazioni così dette di comportamento, non è qualunque
inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Il che comporta: a) da un lato, la necessità, per la parte
istante, di allegare un inadempimento, per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
b) che la sussistenza del nesso eziologico va indagata, non
solo in relazione al rapporto di consequenzialità tra intervento o terapia adottata e pregiudizio della salute, ma – ove sia
allegata la violazione del consenso informato – anche in relazione al rapporto tra attività omissiva del medico, per non
aver informato il paziente, ed esecuzione dell’intervento o
adozione di una determinata terapia.
Sempre nell’ottica che il diritto all’autodeterminazione è
diverso dal diritto alla salute (Cass. 13.7.2010 n. 16394; Cass.
9.2.2010 n. 2847; Cass.11.5.2009 n. 10741; Cass. 3.9.2007
n. 18513); con la conseguenza di un risarcimento fondato su
diverso titolo in ipotesi di violazione del primo, ma non del
secondo.
La risarcibilità del danno da lesione della salute, che si
verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell’intervento
medico necessario o della terapia adottata, entrambi correttamente eseguiti, ma senza la preventiva informazione del
paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli, dunque,
in assenza di un consenso consapevolmente prestato, richiede
l’accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento o quella terapia se fosse stato adeguatamente
informato.
Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza è cassata, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
(Omissis)
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
In evidenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TERZA, 20 aprile
2012, n. 6273.
Irrisarcibilità del danno tanatologico – Intrasmissibilità iure hereditatis – Risarcimento del danno biologico in caso di apprezzabile lasso di tempo fra lesioni e morte – Funzione reintegrativa e
riparativa del risarcimento del danno.
In caso di lesione dell’integrità fisica con esito letale, il
danno tanatologico, inteso come consapevolezza dell’imminente fine della vita, non può essere riconosciuto ove la vittima non abbia sofferto alcun dolore di natura psichica,
stante la natura non sanzionatoria, ma riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno. Va invece riconosciuto il
danno biologico consistente nella lesione in sé e per sé dell’integrità psico-fisica, per il tempo intercorso tra l’insorgenza
delle lesioni ed il successivo decesso [1].
(Omissis)
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 15.2.2002 B.L., anche in
nome e per conto del figlio minore Z.T., conveniva in giudizio
R.R. e la S.p.a. Augusta Assicurazioni per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di
un incidente stradale verificatosi il (Omissis) nel corso del
quale suo marito Z.R. aveva subito gravissime lesioni personali, che ne avevano poi determinato la morte, quando, a
bordo del proprio motociclo Vespa Piaggio 125, mentre ne
stava effettuando il sorpasso a sinistra, era stato investito
dall’auto condotta dal proprietario R.R. che si era spostata
improvvisamente da destra a sinistra senza adeguata segnalazione. In esito al giudizio il Tribunale di Trieste, ritenuto il
pari concorso di colpe dei conducenti, condannava i convenu-
57
ti a pagare in favore dell’attrice la somma di Euro 82.094,80
ed in favore di Z.T. la somma di Euro 114.459, 78 oltre interessi del 2% dal 6.10.07 alla sentenza. Avverso tale decisione
proponevano appello, principale la Spa Augusta Assicurazioni, ed incidentale la B.. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Trieste con sentenza depositata in data 12 dicembre 2009
accoglieva parzialmente entrambi gli appelli, rigettava la
domanda di danno patrimoniale da lucro cessante, condannava i convenuti al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale per ciascun familiare superstite, della somma di
Euro 150.000,00 con detrazione degli acconti versati da
scomputarsi dalla cifra globale oltre interessi nella misura
indicata nella sentenza dal sinistro al saldo. Avverso la detta
sentenza la B. anche in nome e per conto del figlio minore ha
quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro
motivi ed illustrato da memoria difensiva. Resiste con controricorso la Augusta Assicurazioni Spa.
Motivi della decisione
Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione e
falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 1916 c.c., la
ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui
la Corte di Appello ha esaminato ed accolto il motivo di appello con cui l’Augusta aveva lamentato infondatamente che il
danno patrimoniale subito dai danneggiati non doveva essere
risarcito in quanto l’Inail aveva palesato l’intenzione di avvalersi della surroga prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 28.
Ed invero il motivo - così scrive la ricorrente - non avrebbe dovuto essere considerato ammissibile in quanto, contrariamente all’interpretazione datane dalla Corte, l’Augusta non
aveva proposto un’eccezione formale nel primo atto difensivo
del giudizio di primo grado, essendosi invece limitata a portare a conoscenza dei giudici la circostanza della ricezione
della comunicazione da parte dell’Inail di esercitare il diritto
Nota redazionale a cura di Fabrizia Sabbatini
(1)La sentenza in oggetto si inserisce nel vivace dibattito in cui sono da anni
coinvolti gli operatori del diritto, riguardante la risarcibilità o meno del c.d.
“danno tanatologico”, ovvero da perdita del diritto alla vita, e la relativa
trasmissibilità iure hereditatis. Tale dibattito oggi non è ancora approdato ad
una conclusione uniformemente accolta. La giurisprudenza più recente si è
infatti divisa in due opposti orientamenti.
Nella sentenza in esame, che confluisce all’interno del primo dei due filoni
giurisprudenziali, i Giudici della Suprema Corte affermano una serie di principi di diritto di fondamentale importanza: in primo luogo si soffermano sulla
intrasmissibilità del diritto risarcitorio in capo agli eredi del de cuius, stante
l’intrinseca connessione del diritto alla vita alla persona del titolare, pertanto
da questo fruibile solo in natura; il risarcimento del danno tanatologico, fatto
valere iure hereditario, risulta altresì inconfigurabile in quanto la capacità
giuridica, presupposto per l’acquisto di ogni diritto, viene persa al momento
della morte (di tale avviso: Cass. civ. Sez. III, 09-05-2011, n. 10107; Cass. civ.
Sez. III, 24-03-2011, n. 6754; Cass. civ. Sez. III, 24-11-2009, n. 24679). In
secondo luogo viene presa in considerazione la funzione svolta dal risarcimento del danno. Trattasi infatti di funzione non sanzionatoria, bensì di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi subiti e pertanto il risarcimento
stesso assumerebbe una anomala funzione punitiva, qualora operasse nel
momento in cui la persona titolare del diritto abbia cessato di esistere, non
essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona
non esiste più (di tale avviso: Trib. Milano Sez. XII, 13-10-2010, Cass. civ. Sez.
III Sent., 19-10-2007, n. 21976, Cass. civ. Sez. III, 16-05-2003, n. 7632).
Viene infine sancito il principio alla stregua del quale, il danno tanatologico,
in casi analoghi a quello di specie, non può essere riconosciuto ove la vittima
non abbia lucidamente assistito allo spegnersi della propria esistenza, ove,
come nell’ipotesi di coma fino al momento del decesso, non vi sia stata una
“sofferenza psichica” durante l’agonia. In tali casi è unicamente risarcibile, e
trasmissibile agli eredi, un “danno biologico terminale”, configurabile unica-
2 0 1 2
mente nel caso in cui la morte sia sopravvenuta dopo un apprezzabile lasso di
tempo, si da potersi configurare una vera e propria lesione dell’integrità psicofisica del soggetto leso, e non quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall’evento, giacché essa non costituisce
la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma la lesione di un bene
giuridico diverso, cioè del bene vita.
Dello stesso avviso recente giurisprudenza della Corte di Appello di Taranto
(12-01-2012): “In caso di lesione dell’integrità fisica con esito letale, un danno
biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì
da potersi concretamente configurare un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso. Il danno non è perciò risarcibile quando la
morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza
dall’evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della
vita. Parimenti, il danno cosiddetto catastrofale - e cioè la sofferenza patita
dalla vittima durante l’agonia - è risarcibile, e può essere fatto valere iure hereditatis, unicamente allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio
stato, abbia cioè avuto l’angosciosa consapevolezza della fine imminente,
mentre va esclusa quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente il
coma ed il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso.
Non è infine risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita,
per l’impossibilita tecnica di configurare l’acquisizione di un diritto risarcitorio
derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del
titolare, e da questa fruibile solo in natura: e invero, posto che finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il
decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di
acquistare alcun diritto, il risarcimento finirebbe per assumere, in casi siffatti,
un’anomala funzione punitiva, particolarmente percepibile laddove il risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai congiunti o, in mancanza di
successibili, addirittura allo Stato.”.
Copiosa giurisprudenza ha pertanto sancito l’intrasmissibilità iure hereditatis
del diritto al risarcimento del danno tanatologico: “Non è risarcibile la lesione
civile
Gazzetta
58
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
di rivalsa. Pertanto, l’eccezione dell’Augusta, mai sollevata in
primo grado, era nuova e quindi inammissibile ex art. 345
c.p.c..
Inoltre - si tratta di un submotivo assolutamente diverso
dal primo - la Corte avrebbe altresì sbagliato nel ritenere
configurabile nella specie l’ipotesi della compensatici lucri
cum damno, trascurando la diversità dei titoli giustificativi
delle erogazioni.
La prima delle due subdoglianze è manifestamente infondata, alla luce di un duplice ordine di considerazioni. Ed invero, va rilevato in primo luogo che di eccezione nuova può
parlarsi solo quando essa non abbia nessuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, così da costituire
una ragione di indagine e di dibattito diversa da quella espletata in primo grado, senza che questo possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente del processo. Ed è appena il caso di sottolineare come tale presupposto difetti del
tutto nel caso di specie, posto che fin dal primo scritto difensivo la convenuta aveva fatto esplicito riferimento alla comunicazione scritta con cui l’Inail le aveva fatto presente di voler
esercitare il proprio diritto di surroga, comportamento poi
effettivamente adottato come risulta dalla quietanza di pagamento prodotta nel giudizio di secondo grado, cui accenna la
Corte territoriale.
In secondo luogo deve rilevarsi che a norma dell’art. 345
c.p.c., comma 2, nel giudizio di appello, non possono proporsi solo le “nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche
d’ufficio”. Pertanto, il divieto di proporre nuove eccezioni si
riferisce, secondo l’espresso dettato della norma, alle sole
eccezioni in senso proprio, concernenti fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, rilevabili solo su eccezione di parte, e non anche alle mere difese,
consistenti nella contestazione dei fatti posti dall’attore a
fondamento della propria domanda, nè alle eccezioni in senso
improprio, cioè le circostanze dalle quali, già sulla base degli
atti, risultano l’inesistenza del fatto costitutivo oppure l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e che quindi costituiscono il presupposto logico e giuridico necessario
della pronuncia sulla domanda.
Quanto al successivo sub motivo, secondo cui la Corte
avrebbe altresì sbagliato nel ritenere configurabile nella specie
l’ipotesi della compensatici lucri cum damno, la censura è
inammissibile per difetto di correlazione con la ratio decidendi della decisione impugnata. Ed invero, la Corte territoriale
ha fondato la sua decisione sulla considerazione che il creditore surrogato perde ogni legittimazione attiva a pretendere
dal debitore l’adempimento della prestazione ora passata
nell’attivo di altro soggetto, quale l’ente previdenziale.
Tutto ciò considerato, appare evidente come la censura
proposta eluda il punto nodale della pronunzia e non sia
correlata con la ratio decidendi della decisione impugnata
difettando della necessaria specificità, attesa la non riferibilità alla sentenza d’appello fondata - giova ripeterlo - sulla
considerazione che l’esercizio della surrogazione da parte
dell’Inail comporta la perdita della titolarità del credito del
danneggiato. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni
di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione
della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che
alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino
contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il
fondamento logico-giuridico delle prime. Ne deriva l’inammissibilità della censura.
Ciò, fermo restando che secondo l’orientamento nettamente prevalente di questa Corte, cui questo Collegio aderisce,
“nella liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, per evitare duplicazioni
risarcitorie, dal danno effettivamente patito dalla vittima per
la sua diminuita capacità lavorativa specifica, accertato e
quantificato dal giudice con i criteri della responsabilità civile, va sottratto il valore capitale della rendita erogata dall’Inail,
del diritto alla vita di un congiunto (c.d. danno tanatologico) poiché la contestuale perdita della capacità giuridica impedisce l’insorgere nel patrimonio
dell’offeso di un diritto al risarcimento trasferibile agli eredi.” (Cass. civ. Sez.
III, 24-11-2009, n. 24679), sino ad arrivare ai più rigidi orientamenti, i quali
escludono la risarcibilità iure hereditatis finanche del danno biologico e di
quello morale, senza tener conto neppure dello stato della vittima durante il
breve periodo di sopravvivenza: “In tema di risarcimento del danno, nel caso
di lesioni mortali catastrofali che abbiano determinato in capo alla vittima
breve spazio di sopravvivenza (non importa se in stato di lucidità o di coma),
ne è esclusa la risarcibilità “iure hereditatis” come danno reale (non patrimoniale) biologico, morale o tanatologico.” (Cass. civ. Sez. III, 24-03-2011, n.
6754). Tale orientamento si rifà alla linea di pensiero adottata sin dal 1994
dalla Corte Costituzionale, avallando la tesi, già espressa dalla Cassazione nel
1925, contraria ad ammettere pretese risarcitorie a titolo ereditario in caso di
morte immediata della vittima, ritenendo configurabile un diritto al risarcimento “limitatamente ai danni verificatisi dal momento della lesione a quello
della morte la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico
della persona offesa, ormai non più in vita”.
Altra parte della giurisprudenza sostiene invece l’opposta tesi della riconducibilità del danno tanatologico nell’ambito del danno morale, e della conseguente trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento dello stesso. In argomento: “In caso di morte che segua le lesioni fisiche dopo breve tempo, il danno
c.d. tanatologico , consistente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine, deve essere ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi.” (Trib.
Catanzaro, 23-02-2012); così come: “Qualora la vittima di un illecito deceduta a breve distanza di tempo dall’evento lesivo, sia rimasta lucida negli ultimi
momenti della sua vita, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno
cosiddetto tanatologico , da ricondursi nella dimensione del danno morale,
inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria esistenza.” (Cass. civ. Sez. lavoro,
07-06-2010, n. 13672); “Il danno cosiddetto tanatologico va ricondotto
nella dimensione del “ danno morale”, riconosciuto a ristoro della sofferenza
psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo
breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole
attesa della fine della propria vita. Il diritto al risarcimento di tale danno risulta entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte e
può essere conseguentemente fatto valere “iure hereditatis”. (Cass. civ. Sez.
lavoro, 07-06-2010, n. 13672); ed anche: “Va accolta la domanda di risarcimento del danno da “perdita del diritto alla vita”, o danno tanatologico,
proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto i chiamati all’eredità divengono titolari di una pretesa risarcitoria ereditaria in relazione alla
privazione del bene vita della vittima nei confronti del responsabile dell’illecito da costui commesso a danno del congiunto, dal momento che quel che si
trasmette con il decesso della vittima non è il diritto assoluto della persona ma
quello patrimoniale del risarcimento del danno cosicché a seguito della morte
della persona si verifica l’apertura della successione (artt. 5 e 456 c.c.).” (Trib.
Venezia, 15-06-2009).
Alla stregua di questo secondo orientamento il danno tanatologico non costituisce una autonoma categoria di danno, ma va ricondotto al danno morale,
inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, pertanto risarcibile e trasmissibile iure hereditatis.
Non ci sembra di poter condividere quest’ultima linea di pensiero, bensì di
avallare la prima e ben più ragionevole tesi, espressa nella sentenza in commento, secondo la quale il danno tanatologico, da considerarsi del tutto estraneo
ed autonomo dalla più ampia categoria del danno morale, ed inteso come
perdita del diritto alla vita, risulta essere strettamente connesso alla persona del
soggetto leso, pertanto, posto che finché il soggetto è in vita non vi è lesione del
diritto alla vita, una volta sopravvenuta la morte, il soggetto deceduto, in
quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto; di conseguenza alcun diritto risulta trasmissibile agli eredi.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
rappresentando quest’ultimo un indennizzo anch’esso destinato al ristoro di un danno patrimoniale” (Cass. n. 15738/2010,
v. anche Cass. n. 3806/98, Cass. n. 3503/86).
Passando all’esame delle successive censure, deve avvertirsi che viene anticipata la trattazione della terza e della
quarta doglianza per comodità di esposizione.
Con la terza doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2034 c.c., la ricorrente
lamenta che la somma di Euro 76.635, versata dalla compagnia
assicuratrice poco prima dell’udienza di precisazione delle
conclusioni, sarebbe stata corrisposta, in adempimento di
un’obbligazione naturale, con conseguente impossibilità di
compensare la suddetta somma. Ciò risulterebbe dall’espressione “a fini meramente umanitari”, usata dal legale della compagnia assicuratrice - non da un semplice funzionario - con cui è
stata accompagnata la dazione della somma a pag. 8 della
comparsa conclusionale, onde l’erroneità del rigetto del relativo
motivo di appello, da parte dei giudici di secondo grado.
Con la quarta doglianza, articolata per violazione degli
artt. 1284, 1223, 1224 e 2056 c.c., la ricorrente lamenta che
la Corte di appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse il motivo di appello con cui
essa appellante aveva richiesto di vedersi riconosciuto sulle
somme corrisposte l’interesse compensativo al tasso legale.
Entrambe le censure sono infondate - Quanto alla terza,
torna utile premettere che la Corte di appello ha fondato la
sua decisione sulla considerazione che le espressioni usate dal
singolo funzionario dell’ente assicurativo “non modificano il
pagamento di un’obbligazione giuridica in pagamento di
un’obbligazione naturale” con ciò intendendo rilevare che
l’indicazione delle ragioni, per cui venga effettuata un’attribuzione patrimoniale, da parte di un delegato che non abbia il
potere di rappresentare l’effettiva volontà del delegante, non
può indurre a ritenere configurabili i presupposti costitutivi di
un’obbligazione naturale quali la sussistenza di doveri morali
o sociali (comma 1) o di altri doveri previsti dalla legge come
sforniti di azione (comma 2), tali da giustificare un’attribuzione patrimoniale,laddove tali presupposti non solo non risultino essersi verificati ma non siano stati neppure allegati.
Ciò premesso, considerato che le dichiarazioni rese in
giudizio dal procuratore ad litem costituiscono solo elementi
indiziari, che possono liberamente essere valutati dal giudice
per la formazione del suo convincimento, sempre che si tratti
di ammissioni, di significato inequivoco e frutto di una chiara manifestazione di volontà, va sottolineato che la valutazione della Corte territoriale, in merito all’insussistenza nella
vicenda in esame, dei presupposti idonei a giustificare l’attribuzione patrimoniale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
2034 c.c., costituisce giudizio di merito, incensurabile in sede
di legittimità, ove adeguatamente motivato come lo è stato
nella specie. Ne deriva l’infondatezza della censura.
Quanto alla quarta doglianza, va osservato che la decisione della Corte si è basata sul rilievo che nel caso in esame il
Tribunale ha disposto il calcolo sulla somma rivalutata
all’epoca della sentenza, applicando un tasso di interesse del
due per cento, superiore alla soglia legale. Da ciò, l’inammissibilità della doglianza sul punto per carenza di interesse
dell’appellante, che si era avvantaggiato dell’errore del giudice, essendo stato previsto un tasso di interesse sulla somma
rivalutata, superiore alla soglia legale.
2 0 1 2
59
Ora, la sentenza è ed appare corretta. Ed invero, come ha
già avuto modo di statuire questa Corte, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento ai valori monetari esistenti alla data
della liquidazione, è dovuto al danneggiato soltanto il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardo nella
liquidazione.
Tale risarcimento può avvenire attraverso la liquidazione
degli interessi. Pertanto, sull’importo liquidato all’attualità
della data della pronuncia, possono essere riconosciuti gli
interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l’equivalente monetario alla data di insorgenza del credito ovvero mediante l’attribuzione di interessi sulla somma
liquidata all’attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale
medio nel periodo di tempo da considerare ovvero computando gli interessi sull’importo progressivamente rivalutato anno
per anno dalla data dell’illecito (cfr Cass. n. 3931/2010).
Resta da esaminare la seconda doglianza, - la cui trattazione è stata posticipata per comodità di trattazione - la
quale è stata articolata sotto il duplice profilo della violazione
degli artt. 536 e 2043 c.c. nonché dell’omessa ed insufficiente motivazione, e fondata sulla considerazione che la Corte
avrebbe sbagliato quando ha rigettato la richiesta risarcitoria
del danno biologico e morale subito dalla vittima, spettante
agli eredi iure successionis, deducendo che la vittima non
avrebbe subito nessun dolore di carattere psichico perchè era
in coma.
A riguardo, giova osservare che il danno tanatologico, inteso come consapevolezza dell’imminente fine della vita, non
può essere riconosciuto, nel caso di specie, dovendo escludersi
che la vittima, come già accertato dal primo giudice, abbia
sofferto alcun dolore di natura psichica. Ciò, in quanto era in
coma e pertanto non soffrì vedendo lucidamente avvicinarsi la
morte, essendo rimasto nel medesimo stato fino al decesso.
Sotto tale profilo, la decisione impugnata è pertanto assolutamente in linea con l’indirizzo di questa Corte, le cui Sezioni
Unite con la sentenza n. 26972/08 hanno affermato il principio
di diritto, secondo cui, in caso di morte che segua le lesioni
dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante
l’agonia è autonomamente risarcibile, non come danno biologico, ma come danno morale, inteso come sofferenza della
vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria
vita, sempre che “sofferenza psichica vi sia stata e, dunque, che
la vittima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio
stato (il che va escluso in caso di coma immediatamente conseguito all’evento dannoso)...” (così Cass. 28423/08 in motivazione, sostanzialmente conforme sul punto Cass. n. 458/2009),
laddove analoga circostanza, come è stato accertato dal giudice di merito, risulta invece esclusa nel caso di specie.
Del resto, l’orientamento sopra riportato è stato ribadito,
recentemente, da questa Corte, quando ha statuito che “In
caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il
risarcimento del c.d. danno catastrofale - ossia del danno
conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima
al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della
civile
Gazzetta
60
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve
intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla
vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto,
essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto
che deriva dal fatto stesso della morte; e, d’altra parte, in
considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai
congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta (Cass. n. 6754/2011).
Va invece riconosciuto il danno biologico consistente nella
lesione in se e per se dell’integrità psico-fisica, per il tempo intercorso tra l’insorgenza delle lesioni ed il successivo decesso.
Ed invero, costituiscono massime ormai consolidate nella
giurisprudenza di questa Corte, quelle secondo cui, in caso
di lesione dell’integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli
eredi, è configurabile qualora la morte sia intervenuta dopo
un apprezzabile lasso di tempo, si da potersi concretamente
configurare un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso, mentre non è configurabile quando
la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a
breve distanza dall’evento, giacchè essa non costituisce la
massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di
un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr.
c i v i l e
Gazzetta
F O R E N S E
Cass. n. 870/2008, Cass. n. 18163/2007, Cass. n. 10107/2011)
Nel caso di specie, la durata, assolutamente non brevissima,
del periodo di sopravvivenza alle lesioni (di quattro giorni) è
tale da consentire l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio
della salute e non è pertanto ostativa alla configurabilità del
danno non patrimoniale sotto il profilo biologico, il quale,
come è stato chiarito nelle citate sentenze (v. anche Cass. n.
6754/2011), consegue alla lesione del diritto alla salute e non
alla lesione del diritto alla vita. Ne consegue che, nel caso di
specie, ai necessari fini risarcitori si deve prendere nella dovuta considerazione l’intervallo di tempo intercorso tra il
momento in cui è iniziata la compromissione dell’integrità
psico-fisica, gradualmente crescente, e quello in cui essa,
infaustamente evolutasi, ha determinato il sopravvenire del
decesso della vittima. Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, quest’ultima censura merita pertanto accoglimento, nei sensi sopra indicati e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, rigettato ogni altro motivo di doglianza. Ne deriva ulteriormente che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, nell’osservanza del principio
richiamato, la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche
in ordine al regolamento delle spese della presente fase di
legittimità.
(Omissis)
Diritto e procedura penale
Il principio della domanda cautelare: gravi indizi di colpevolezza
e fumus commissi delicti*
63
Maria Antonietta Troncone
Brevi riflessioni dalle prospettive ìdi riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari
69
Rossella Catena
Le sezioni unite e la indeterminata aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti:
una ricognizione di significato valida solo in bonam partem
Nota a Cassazione, Sezione unite penali, sentenza 20 settembre 2012, n. 36258 (ud. 24 maggio 2012)
74
Giuseppe Amarelli
Dialogo tra la Corte Edu e le Corti nazionali sul valore dell’overruling giurisprudenziale
84
Vittorio Sabato Ambrosio
I contrasti risolti dalle Sezioni unite penali
88
A cura di Angelo Pignatelli
Rassegna di merito [
A cura di Alessandro Jazzetti e Andrea Alberico ]
A cura di Alessandro Jazzetti e Giuseppina Marotta ]
91
94
penale
Rassegna di legittimità [
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
●
Il principio
della domanda cautelare:
gravi indizi
di colpevolezza
e fumus commissi
delicti *
● Maria Antonietta Troncone
Procuratore aggiunto presso la Procura
della Repubblica di Nola
*Seminario misure cautelari personali e reali.
Tutela della libertà e difesa sociale organizzato da:
Scuola Bruniana- Fondazione Forense di Nola
2 0 1 2
63
L’ordinamento garantisce massima tutela alla libertà
dell’individuo in tutte le sue manifestazioni. La Costituzione
ha previsto una serie di garanzie con riguardo alle ipotesi in
cui è possibile incidere sulla libertà personale. La libertà personale deve essere tutelata anche quando confligge con interessi “superindividuali” (sicurezza pubblica, necessità di
assicurare le fonti di prova e di punizione dei colpevoli etc.);
per tale ragione, quanto più lo Stato si intromette nella sfera
dell’individuo, tanto maggiori sono le garanzie previste a tutela del singolo.
La violazione del domicilio (ispezioni e perquisizioni) è
pertanto temperata dalla possibilità di farsi assistere dal difensore o da persona di fiducia; la violazione della sfera personale dell’individuo (intercettazioni) è connessa alla commissione di fatti penalmente rilevanti e a rigidi presupposti stabiliti dalla legge; la compressione del diritto di disporre liberamente dei propri beni (sequestro) è agganciato alla possibile
esistenza di un reato.
La disciplina delle misure cautelari ha subito una serie di
evoluzioni a seconda dei sistemi processuali che si sono succeduti: dagli istituti adottati dal sistema inquisitorio (incentrato
sulla carcerazione preventiva senza scadenza temporale, tesa
ad ottenere la confessione del reo, applicata per il solo fatto
che un reato era stato commesso), si è passati ad un sistema
che prevedeva “sufficienti” indizi per l’applicazione delle misure, ma che era svincolato da concrete esigenze cautelari. E
difatti, la disciplina dettata dall’art. 252 c.p.p. del previgente
codice del 1930, che richiedeva “sufficienti indizi di colpevolezza” (prima della modifica con l. n. 330 del 1988); si è poi
arrivati al sistema “accusatorio”, in cui la detenzione cautelare è considerata come “extrema ratio”, applicabile solo ove vi
siano specifiche esigenze cautelari ed in presenza di gravi indizi di colpevolezza. Ancora, l’art. 292 c.p.p., come modificato dalla l. n. 332 del 1995 (comma 2, lett. e bis), ha delineato
per l’ordinanza cautelare uno schema di motivazione assimilabile a quello prescritto per la sentenza di merito dall’art. 546
c.p.p. lett. e).
Un sistema in cui non si parla solo d’indizi di reato, ma di
colpevolezza (ognuno risponde per le proprie azioni) e correlato all’esistenza di tre codificate esigenze cautelari, di cui la
terza (art.274 lett. c, c.p.p.) funge da misura di sicurezza.
Le problematiche che interferiscono con il procedimento
cautelare e con quello di merito s’intersecano fra loro.
Proverei ad esporre i singoli argomenti, per poi ricomporli in un quadro ragionato che tenga conto:
- delle specificità del procedimento cautelare e di merito;
- della differenza concettuale fra indizio e prova;
- dell’esistenza di più tipi di prova;
- del percorso logico attraverso il quale si forma il convincimento del giudice;
- dei diversi tipi d’indizi, in ragione delle caratteristiche
degli indizi stessi e della loro finalizzazione nell’ambito del
procedimento.
Va pertanto affrontato il tema della natura concettuale
dell’indizio e della prova.
Il processo penale è formato da una serie di atti compiuti
dalle parti processuali e “tende a provare il fatto ipotizzato
nell’imputazione; le prove sono gli strumenti impiegati per
verificare l’esistenza di tale fatto”. Il codice del 1988 ha distinto i mezzi di prova dai mezzi di ricerca della prova. Lo stesso
penale
Gazzetta
64
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
codice non ha previsto il principio di tassatività della prova,
tuttavia al giudice non si è lasciata totale libertà nell’assunzione della stessa, in quanto le prove non disciplinate dalla
legge sono subordinate all’esistenza di alcune condizioni: la
prova deve essere idonea ad assicurare l’accertamento dei
fatti e non deve pregiudicare la libertà morale della persona.
In tema di valutazione della prova, il principio cardine è
quello del libero convincimento del giudice, che dà contezza
dell’iter logico seguito con la motivazione del provvedimento.
Il giudice di merito è libero di valutare le prove raccolte,
organizzandole e dando a ciascuna di esse, come pure al loro
complesso, il peso ed il significato ritenuto più opportuno. La
relativa motivazione in cui si estrinseca tale operazioni intellettuale è insindacabile in sede di legittimità se rispetta le
regole della logica ed è frutto di valutazione esatta ed aderente alle risultanze processuali e ai principi generali che regolano la valutazione della prova.
Nella valutazione probatoria, è corretto e legittimo fare
ricorso alla verosimiglianza e alle massime di esperienza
purché, quanto alla prima, si possa escludere plausibilmente
ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile e, quanto alle seconde, essa non vengano
confuse con mere congetture, trattandosi piuttosto di regole
preesistenti al giudizio.
Ciò detto, le prove si distinguono in dirette ed indirette,
a seconda che le stesse si riferiscano, o meno, immediatamente al thema probandum principale. Nell’ambito delle prove
indirette rientrano quelle indiziarie, che sono quelle in cui è
necessaria una valutazione inferenziale del Giudice. S’introduce qui il concetto d’indizio, che in questo momento viene
esaminato con riferimento al procedimento di merito, facendosi così riferimento alla norma di cui all’art. 192 secondo
comma c.p.p.
Il legislatore ha scelto di distinguere, nell’ambito della
norma di cui all’art. 192 c.p.p., la prova dagli indizi, al fine
di poter stabilire le condizioni con cui questi ultimi possono,
considerati nel loro complesso, assurgere dignità di prove e
giustificare, quindi, l’affermazione di colpevolezza.
Il codice non definisce la nozione di indizio. La dottrina
segnala il termine indizio come equivoco. Nel suo significato
più ampio il termine designa “qualunque segno”, nell’accezione più ristretta viene definito come “argomento induttivo, o,
meglio, il dato sensibile su cui lo formuliamo”.
L’indizio consiste quindi in un fatto certo dal quale, attraverso un procedimento logico fondato su regole di esperienza
consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del
fatto incerto da provare secondo lo schema del c.d. sillogismo
giudiziario.
Al fine di pervenire ad una statuizione di condanna in
mancanza di prove, occorre ai sensi del secondo comma
dell’art.192 c.p.p., che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. L’art.192 c.p.p., che consente che l’esistenza di un fatto
sia desunta da indizi, costituisce una delle eccezioni al principio del libero convincimento, anche per quello che è stabilito nei successivi commi 3 e 4 in tema di valutazione della
chiamata in correità.
Pertanto, la circostanza che la norma parli d’indizi gravi,
precisi e concordanti presuppone indefettibilmente che gli
indizi siano più di uno e che i molteplici indizi, nel loro insieme, siano univocamente concordanti rispetto al fatto da di-
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
mostrare, nonché certi e rappresentativi di una rilevante
contiguità logica con il fatto ignoto. Perfino la presenza di un
solo indizio può consentire di desumere l’esistenza di un fatto
ignoto, purché sia talmente preciso da necessariamente condurre al fatto sul piano logico, senza la mediazione di altri
indizi.
Il procedimento di valutazione è complesso, in quanto gli
indizi sono costituiti da circostanze, collegate e comunque
collegabili ad un determinato fatto, il cui peso probatorio può
essere rilevante o modestissimo e la cui normale caratteristica
è che, valutate singolarmente e separatamente, sono equivoche, nel senso che possono avere spiegazioni diverse rispetto
all’inerenza del fatto da provare, ma che valutate globalmente, secondo criteri di comune logica, diventano idonee a dimostrare pienamente il fatto. Pertanto, l’esame globale ed
unitario può risolversi ogni ambiguità di ciascun elemento
probatorio, in modo tale che l’insieme possa assumere quel
pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente
di ritenere conseguita la prova logica del fatto. Nell’ambito di
tale operazione logica, l’indizio viene sì valutato singolarmente, ma al fine del giudizio di certezza e di gravità, deve confluire insieme con gli altri in una ricostruzione unitaria e logica del fatto ignoto.
La prova logica è pienamente radicata nel nostro ordinamento ed è stata codificata dall’art. 192 c.p.p.. Sul punto, va
ricordato che la Corte Costituzionale, con ordinanza n.0302
del 2001 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di costituzionalità sollevata con riferimento all’art.
192 c.p.p., per asserita violazione degli artt.2,3, 13 e 11
Cost.
Difatti, il giudice remittente aveva rilevato il possibile
contrasto della norma con l’art. 111 Cost. nella sua nuova
formulazione intervenuta con legge costituzionale, che, affermando il principio del giusto processo nell’attuazione della
giurisdizione. Il remittente ha sostenuto che la novellata norma costituzionale implica non solo l’esigenza di garantire la
parità tra le parti, ma anche l’adozione di un criterio di rigorosa valutazione delle prove a carico degli imputati, atta ad
evitare ogni forma di alea che comprometta la parità dei cittadini imputati di fronte alla legge, avendo tutti il diritto di
avere il processo per prove forti, che portino davanti a qualunque giudice al medesimo risultato, e non per indizi.
Sul punto, la Corte ha chiarito che, con l’art. 192, comma
2, c.p.p. il legislatore del 1988 ha solo inteso porre dei limiti
al discrezionale apprezzamento dei dati indiziari, introducendo un parametro legale di valutazione probatoria analogo a
quello recato dall’art. 2729 del codice civile, ma che “la prova indiziaria, compenetrata nella risalente tradizione processuale, non solo italiana, costituiva già legittimo fondamento
del convincimento del giudice nella vigenza del codice di rito
abrogato, come riconosce lo stesso rimettente”.
Appare superfluo sottolineare che il procedimento logico
di valutazione degli indizi deve pervenire, in caso di condanna, ad un risultato di certezza, con riferimento a quanto
previsto dall’art. 533 c.p.p. che in tema di sentenze di condanna, afferma che ad essa si perviene se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole
dubbio, secondo la modifica operata dall’art. 5 legge n.46 del
2006. Essa ha più che altro un valore descrittivo, in quanto,
anche precedentemente alla novella, l’esistenza di un ragione-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
vole dubbio comportava il proscioglimento ai sensi dell’art.
530 cpv. c.p.p. Indubbiamente, la colpevolezza che dev’essere
dimostrata in forma rigorosa e completa, mentre la non colpevolezza può giovarsi anche di prove imperfette ed unilaterali.
Ciò detto in merito agli indizi che, in presenza delle caratteristiche della gravità, precisione e concordanza assurgono a
valore di prova, occorre ora esaminare il concetto d’indizio
che si rinviene in altre disposizioni legislative, fra le quali ricordo le più importanti:
• indizi presupposto dell’emissione di misure cautelari, ai
sensi dell’art.273 c.p.p. o di provvedimento di fermo, ai
sensi dell’art. 384 c.p.p.;
• indizi presupposto per l’autorizzazione ad attività intercettativa, ai sensi dell’ art. 266 c.p.p.
Non intendo soffermarmi su quest’ultimo argomento,
estraneo al tema che stiamo trattando, atteso che ciò che
viene richiesto sono i gravi indizi di reato e non i gravi indizi
di colpevolezza. In tema di ammissibilità delle intercettazioni,
non si dibatte in merito alla valutazione della prova, bensì in
merito ai presupposti per il compimento di un’attività endoprocedimentale, come è quella intercettativa, volta alla ricerca della prova e non alla valutazione di una prova già raccolta. Va pertanto chiarito che i gravi indizi richiesti quale presupposto dell’attività intercettativa non vanno intesi in senso
probatorio, ma solo come vaglio di particolare serietà delle
ipotesi delittuose configurate, che non devono fondarsi (anche
in questo caso) su congetture, richiedendo una ricognizione
sommaria degli elementi dai quali possa desumersi la probabilità dell’avvenuta consumazione di un reato. Quindi i gravi
indizi attengono all’esistenza dell’illecito penale e non alla
colpevolezza di un determinato soggetto.
Pertanto, ritornando alla questione degli indizi cautelari
e soffermandoci su quella che è la nozione di gravi indizi di
colpevolezza richiesta dall’art. 273 c.p.p., ne va da un lato
sottolineata la diversità concettuale rispetto agli indizi che,
in virtù delle loro peculiari caratteristiche, assurgono a dignità di prova e, dall’altro, osservato il graduale processo che
porta ad un avvicinamento dei due istituti e dei relativi criteri di valutazione.
Ebbene, il termine “indizi” adoperato dall’art. 273 primo
comma c.p.p. ha una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell’art. 192 secondo
comma c.p.p.. Infatti, mentre in tale ultima norma, la scelta
lessicale operata dal legislatore trova la sua ragion d’essere
nell’esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e, soprattutto,
per stabilire le condizioni in base alle quali gli indizi possono
assurgere a prove - requisiti della gravità, precisione e concordanza), l’uso del termine “indizi” nell’art. 273 c.p.p. non è in
alcun modo riconducibile ad un’analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (cioè di probabilità e
non di certezza) che è richiesto per l’emissione di una misura
cautelare e rispetto al quale non può parlarsi di prove, ma
sempre e comunque di indizi.
Pertanto, i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273
c.p.p. non s’identificano con gli indizi che rappresentano la
prova indiretta o logica idonea a fondare il giudizio di colpevolezza, in quanto, ai fini cautelari, è sufficiente un giudizio
di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell’imputato.
2 0 1 2
65
Gli indizi sono pertanto gravi quando si possa pervenire
a formulare un giudizio prognostico di probabile condanna
dell’imputato anche tenuto conto di possibili acquisizioni ulteriori, sotto forma di nuovi elementi o di approfondimento e
consolidamento di quelli esistenti.
Il P.M., in ogni caso, dovrà compiere la valutazione prognostica in vista del dibattimento; nel momento in cui formula la richiesta di misura restrittiva, gli elementi storici e logici
raccolti devono essere tali da fondare un giudizio di probabilità di colpevolezza dell’indagato dal quale si possa lasciar
prevedere che al dibattimento, unitamente ad altre risultanze
delle indagini, si arriverà all’affermazione della penale responsabilità. La Suprema Corte chiarisce che gli elementi a carico
devono contenere “in nuce” tutti o alcuni degli elementi di
prova; in tal modo il P.M. si pone nell’ottica del dibattimento
formulando di un giudizio prognostico relativo agli stessi
elementi, i quali trasfusi nei corrispondenti istituti probatori,
saranno il fondamento dell’affermazione della responsabilità
dell’imputato.
Ebbene, va ora affrontato il tema delle modifiche introdotte dalla legge 63 del 2001 che ha introdotto l’art. 273
comma 1 bis c.p.p., che ha imposto il rispetto anche in sede
cautelare delle regole di esclusione probatoria nonché di valutazione degli indizi, quest’ultima mediante il richiamo all’art.
192 c.p.p. (norma relativa, invece, alla valutazione degli indizi nel giudizio di merito).
Con la legge 63/2012 c.d. del giusto processo, sono state
estese alla valutazione degli indizi in sede cautelare le regole
di cui all’art. 192 commi 3 e 4 sulla chiamata in correità. Non
è stato operato invece il richiamo al comma dell’art. 192 in
tema di requisiti degli indizi che assumono valore probatorio
nel giudizio di merito.
Con tale riforma, è stata pertanto anticipata alla fase
delle indagini l’operatività delle regole di utilizzazione e di
valutazione della prova tipiche del merito, con una prospettiva di tendenziale parificazione del regime della prova cautelare rispetto a quella della prova del giudizio di merito.
Parte della dottrina afferma che, conseguenzialmente, il
concetto di “prova” si è “emancipato” dal perimetro dell’istruzione dibattimentale. Pertanto, sembrerebbe ormai lecito
parlare di “prova cautelare”, anziché di “gravi indizi di colpevolezza”, potendo essere identici i relativi criteri di valutazione rispetto alla prova di merito, dalla quale la prima differisce soltanto perché, di solito, è cartolare è, sempre, allo
stato degli atti.
Si afferma, altresì, che i richiami normativi contenuti
nell’art. 273, co. I-bis sono solo esemplificativi e non tassativi,
ragione per cui anche nella valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza troverebbe applicazione la regola dell’art. 192,
co. 2, che “prescrive un metodo di valutazione della prova che
attiene alla controllabilità della decisione, indicando a quali
condizioni gli indizi, e le prove ad essi equiparate, possono
assumere il valore di certezza.
Ebbene, credo che pur nel progressivo innalzamento dei
presupposti per l’ applicazione di una misura cautelare, non
possa crearsi un appiattimento su un’ unica nozione d’indizio
probatoriamente efficace.
L’esistenza di più nozioni d’indizio fa sì che i gravi indizi
di colpevolezza si pongano in un punto intermedio rispetto
agli indizi non gravi, anche dette prove minori e gli indizi
penale
Gazzetta
66
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
gravi, precisi e concordanti, che assumono il valore di prova
sia pure indiretta, idonea come quella diretta a condurre
all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Ed infatti, il giudizio di colpevolezza ai fini delle misure
cautelari personali consiste nell’acquisizione di elementi che
inducono a ritenere estremamente probabile che l’inquisito sia
responsabile del fatto contestato, non essendo necessario che
il giudizio di responsabilità porti alla certezza assoluta. Questo è il significato del mancato richiamo, nell’art. 273 comma
1 bis, del comma 2 dell’art. 192, quanto alla necessità che gli
indizi, oltrechè gravi, siano anche precisi e concordanti.
Quindi, resta ferma la diversità della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato,
rispetto a quello di merito, orientata invece all’acquisizione
della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (così la Cassazionea sezioni unite 31/10/2006 n.
234598).
Intendo ora fare dei riferimenti ad alcune pronunce della
Cassazione, distinguendo quelle che hanno inteso differenziare presupposti degli indizi-prove da quelli degli indizi-cautelari e quelle che, invece, hanno creato un’omologazione fra i
due concetti.
Iniziando dalle prime, cito le seguenti pronunce:
• Cass. Pen., sezione IV, 15 ottobre 2007 n.37878:
- “…In proposito, non va neppure dimenticata la diversa
valenza che hanno gli “indizi” richiesti per l’adozione di
una misura cautelare rispetto alla “prova” necessaria ai
fini della condanna.
- Infatti, la nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui
all’art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del
termine “indizi” inteso quale elemento di prova idoneo a
fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che
sta ad indicare la “prova logica o indiretta”, ossia quel
fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art.
192 c.p.p., comma 2), che consente di risalire ad un fatto
incerto attraverso massime di comune esperienza.
- Per l’emissione di una misura cautelare, invece, è quindi
sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli (ex
pluribus, la sentenza citata ed i riferimenti in essa contenuti). E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla l. 1 marzo 2001, n. 63: infatti, nella fase
cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (art. 273 c.p.p., comma 1), giacché l’art. 273 c.p.p.,
comma 1 bis (introdotto, appunto, dalla suddetta legge)
richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non l’art.
192 c.p.p., comma 2 che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone,
quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non
devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti
per il giudizio di merito dall’art. 192 c.p.p., comma 2, e
cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della
concordanza.
- In altri e decisivi termini, i “gravi indizi di colpevolezza”
richiesti per l’adozione di una misura cautelare non si
identificano con gli indizi precisi e concordanti che rappresentano la prova idonea a fondare il giudizio di colpe-
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
volezza, in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità
dell’indagato (ex pluribus, sez. VI, 17 ottobre 2005, Tundo), con la conseguenza che per l’emissione di una misura cautelare personale, per “gravi indizi di colpevolezza”
ex art. 273 c.p.p. devono intendersi tutti quegli elementi
a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per se
a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e
tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno
idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel
frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza; e
con l’ulteriore conseguenza, di immediato rilievo ai fini
che interessano, che, ai fini cautelari, il requisito della
“gravità” degli indizi, di cui all’art. 273 c.p.p., è da considerare sussistente quando detti indizi rivelino un consistente fumus di colpevolezza, pur in presenza di possibili
spiegazioni alternative dei fatti, destinate ad essere verificate in prosieguo (cfr. Cass., sez. II, 19 gennaio 2005,
Paesano).
• Cassazione sezione V, 7 febbraio 2007 n. 9192:
- “.. per l’imposizione di una misura cautelare, è necessaria
una probatio minor di quella necessaria per una condanna, essendo sufficiente una qualificata probabilità di
condanna..”
Cito, poi, le pronunce, che creano un’equiparazione fra lo
spessore degli indizi cautelari e quelli degli indizi-prova:
• Cassazione, sez. I, n. 19867/2005, Lo Cricchio:
- “l’indagato e l’imputato non ancora raggiunto da pronuncia di condanna possono essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale soltanto quando risulti dimostrata, allo stato degli atti, la loro responsabilità rispetto
al reato contestato, ossia quando sia munita di affidabile
base razionale la prognosi relativa al futuro accertamento
della colpevolezza” (...);
- “premessa, ambigua e fuorviarne, della distinzione tra
prova e indizio cautelare fondata sulla differente capacità
dimostrativa”;
- “la l. n. 63 del 2001... impone l’osservanza delle regole
di esclusione probatoria e delle regole di valutazione anche nella materia cautelare, equiparando, nella sostanza,
la valenza dimostrativa dei gravi indizi di colpevolezza a
quella della prova è richiedendo che i primi possiedano il
carisma dell’elevata probabilità o dell’elevato grado di
credibilità razionale, nel quale si identifica la certezza
processuale. Di conseguenza, non è esatto continuare a
differenziare, rispetto alla prova, la minore idoneità degli
indizi cautelari a dimostrare il thema probandum, quasi
che essi abbiano valore di una semipiena probatio”. Più
corretto è, invece, affermare - alla stregua della nuova
disciplina dell’art. 273 - che i gravi indizi non sono altro
che una “prova allo stato degli atti”, valutata dal giudice
allorché la formazione del materiale probatorio è ancora
in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del contrad-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
dittorio dibattimentale. Su questo specifico piano, più che
sulla differente capacità dimostrativa, passa la vera distinzione tra prova e indizi cautelari, i quali, pur non
potendo ovviamente giustificare una pronuncia di condanna, devono rendere razionale e credibile, vale a dire
altamente probabile, la prognosi di colpevolezza”.
• Cass., sez. un, n. 36267/2006, Spennato:
- “il giusto processo cautelare è l’epilogo di un cammino
che... ha visto progressivamente sfumare le tradizionali
differenze evidenziate tra decisione cautelare e giudizio di
merito, con riferimento alla valutazione degli elementi
conoscitivi posti a disposizione del giudice, e ricercare una
tendenziale omologazione dei corrispondenti parametriguida”;
- l. n. 63 del 2001, ratio: “assicurare una tendenziale anticipazione alla fase delle indagini delle regole in tema di
valutazione e di utilizzazione della prova, proprie del
giudizio di cognizione, anche per quanto concerne l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza”;
- “ferme restando la netta distinzione tra gli indizi cautelari e la prova ai fini del giudizio e, quindi, la diversità di
prospettiva in cui gli uni e l’altra si muovono, v’è una
chiara spinta all’omologazione dei parametri di valutazione e di utilizzabilità del materiale conoscitivo oggetto
delle decisioni del giudice della cautela e di quello del
merito”;
- netta presa di distanza dalla disciplina dettata dall’art.
252 c.p.p. 1930, che richiedeva “sufficienti indizi di colpevolezza” (prima della modifica con l. n. 330 del 1988);
- l’art. 292 c.p.p., come modificato dalla l. n. 332 del 1995
(comma 2, lett. e bis), delinea per l’ordinanza cautelare
uno schema di motivazione assimilabile a quello prescritto per la sentenza di merito dall’art. 546 c.p.p. lett. e);
- “certo, non deve essere disconosciuta la differenza tra il
giudizio preordinato alla pronuncia di condanna, che
presuppone l’acquisizione della certezza processuale in
ordine alla colpevolezza dell’imputato, e la delibazione
funzionale all’esercizio del potere cautelare, che implica
un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta
probabilità di colpevolezza. Diverso è senz’altro nei due
accertamenti il grado di conferma dell’ipotesi accusatoria: in quello posto a base della decisione definitiva sulla
regiudicanda, la conclusione è sorretta da un quadro
probatorio completo e non suscettibile di ulteriori aggiornamenti o variazioni, con l’effetto che ogni margine
d’incertezza resta superato; nell’accertamento incidentale de libcrtate, invece, il convincimento giudiziale è esposto al flusso continuo di conoscenze potenzialmente
idonee a smentirlo, a prescindere dalla scansione in fasi e
gradi del processo “principale”;
- “la qualifica di gravità che deve caratterizzare gli indizi
di colpevolezza attiene al quantum di “prova”... e non può
che riferirsi al grado di conferma, allo stato degli atti,
dell’ipotesi accusatoria”;
- è “fuorviarne... la distinzione tra prova e indizio cautelare
fondata sulla differente capacità dimostrativa” (...); “tendenziale accostamento dei criteri di valutazione e di utilizzabilità probatoria nelle varie fasi del procedimento”;
- “fermo restando che la valutazione (delle chiamate di
2 0 1 2
67
correo: n.d.e.), avvenendo nel contesto incidentale del
procedimento “de liberiate” e, quindi, allo stato degli
atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora “in
itinere”, deve essere orientata ad acquisire non la certezza,
ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato”.
• sent. Misseri, sent. 1, 17-19 maggio 2011 :
- richiama pedissequamente la sentenza Lo Cricchio;
- “i gravi indizi null’altro sono, d’altro canto, che “una
prova allo stato degli atti”, valutata dal giudice allorchéla formazione del materiale probatorio è di norma ancora in itinere. E così soltanto l’aspetto di una possibile
evoluzione dinamica, non la differente intrinseca capacità evoluzione dinamica, non alla differente intrinseca
capacità dimostrativa, a contraddistinguere la valutazione della prova in sede cautelare rispetto alla valutazione
nel giudizio di cognizione;
- “la possibilità di una lettura degli elementi probatori incompatibile con l’assunto accusatorio non legittima
l’emissione né, quando detta situazione sopravvenga, il
mantenimento di una misura cautelare, giacché non consente di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza,
sufficienti a fondare una ragionevole probabilità di condanna;
Infine, richiamo da ultima la decisione della Cassazioneprima sezione- n.2136 del 28.11/19.1.2012, Parolisi, che richiede, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la qualificata probabilità di colpevolezza e non la certezza, affermando fra l’altro quanto segue:
- in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 273 c.p.p. - norma di cui
infondatamente il ricorrente denunzia la violazione - devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura
logica o rappresentativa che - contenendo “in nuce” tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre
ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia
consentono, per la loro consistenza, di prevedere che,
anche attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità,
fondando nel frattempo una qualificata probabilità di
colpevolezza in base all’art. 273 del c.p.p. (in tal senso,
sez. un., sentenza n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995,
Rv. 202002, imp. Costantino);
- la valutazione dei gravi indizi di responsabilità, che il ricorrente assume superficiale ed incompleta, non è superfluo precisare, per un verso, che la stessa è segnata dalla
peculiarità della fase e cioè dalla necessaria fluidità
dell’incolpazione (cfr. Cass. sentenze n. 45441/2004 e n.
231/1996), nel senso che, se la sussistenza del grave quadro probatorio in ordine alla riferibilità all’indagato del
fatto-reato per il quale si indaga è suscettibile di precisazioni ed integrazioni, non è predicabile la necessità di una
compiuta ed esaustiva definizione della condotta e
dell’elemento psicologico sin dal momento nel quale
detta valutazione viene effettuata; dall’altro, che gli indizi di colpevolezza possono considerarsi “gravi” quando,
qualitativamente e quantitativamente valutati nella loro
essenza e nella loro coordinazione logica, pur senza rag-
penale
Gazzetta
68
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
giungere il grado di certezza richiesto per la condanna,
conducono a ritenere fondatamente che il reato per cui si
procede sia stato effettivamente commesso e che sia attribuibile all’indagato (in tal senso, ex multis, sez. 2,
sentenza n. 394 del 28/01/1992, dep. 26/02/1992, Rv.
189167, imp. La Rocca).
Tale ultima e più recente pronuncia sembra nuovamente
rimarcare la differenza concettuale fra indizi cautelari ed
indizi-prova, secondo quanto già in precedenza evidenziato,
discostandosi pertanto dalle pronunce che tendevano ad
un’equiparazione dei due concetti.
Infine, per quanto riguarda il fumus commissi delicti, necessario per l’adozione di misure reali, solo poche notazioni.
E’ importante distinguere il fumus dagli indizi di colpevolezza, va anzitutto chiarito che l’art. 273 c.p.p., che riguarda le misure cautelari personali, non è applicabile alle misure
cautelari reali. Ed infatti, nel verificare la legittimità di un
sequestro preventivo, il giudice non deve indagare sulla gravità degli indizi della commissione del reato, che è indicato
quale presupposto della misura, non potendo la verifica del
fumus estendersi fino a fare coincidere l’esame con un vero
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
giudizio di colpevolezza. Ne consegue che il provvedimento
non deve motivare sulla fondatezza dell’accusa, bensì solo
verificare che vi sia l’astratta possibilità che il fatto ascritto
all’inquisito possa essere inquadrato in un’ipotesi di reato. In
sostanza, non è in questione un profilo di colpevolezza e
quindi è necessario che vi siano indizi solo in riferimento
all’essere stato commesso il reato e non alla specifica responsabilità di alcuno. Va tuttavia ricordato che alcune posizioni
dottrinarie sono nel senso che per il sequestro preventivo,
atteso che s’incide su diritti costituzionalmente garantiti, è
necessario che vi siano gravi indizi.
Mi sembra utile richiamare una recente sentenza della Cassazione n. 25063 del 10.5./11.6.2012, che sul tema afferma:
- il giudice della cautela reale, seppure non debba impegnarsi in un giudizio di gravità indiziaria proiettato sulla
colpevolezza dell’indagato, non può arrestare il suo impegno cognitivo, nella delibazione dei presupposti della
misura applicata o confermata, alla verifica della mera
astratta configurabilità del reato ipotizzato, ma deve
valutare gli elementi concreti che concorrono a sostenere
o infirmare il giudizio di sussistenza del reato per cui si
F O R E N S E
●
Brevi riflessioni
dalle prospettive
di riforma
degli ospedali
psichiatrici giudiziari
● Rossella Catena
Magistrato III sezione
della Corte di Appello Sezione Penale di Napoli
n o v e m b r e • d i c e m b r e
2 0 1 2
69
In Italia esistono attualmente sei OPG, formula che individua e sostituisce nominalmente quelle strutture che erano
più comunemente note come manicomi criminali.
Anche in queste strutture, parallelamente a quanto avviene nelle strutture penitenziarie, il numero di persone ristrette
è superiore alla capacità di accoglienza:
• Montelupo Fiorentino accoglie più di 200 persone, mentre
la sua capienza massima è di 188 persone;
• Aversa, in provincia di Caserta, ne contiene più di 200
sulle 150 previste;
• Napoli, con più di 150 persone su una capienza di 150;
• Reggio Emilia, con più di 200 internati su una capienza di
190.
• Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, con più di 200 internati su 194 posti.
• Castiglione delle Stiviere, Mantova, l’unico ad avere anche
un reparto femminile, che contiene circa 200 persone,
delle quali meno di 100 sono donne.
In totale, alla fine del 2009, gli OPG ospitavano circa 1300
internati, tutti soggetti con patologie psichiatriche e, naturalmente, tutti autori di reati, benché con posizioni giuridiche
alquanto eterogenee.
Infatti, procedendo per categorie giuridico - processuali, è
possibile distinguere, in particolare, tra:
1. internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e segg.
c.p.) e sottoposti al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in quanto socialmente pericolosi (art. 222 c.p.),
2. internati con infermità mentale sopravvenuta, per i quali
e stato ordinato l’internamento in ospedale psichiatrico
giudiziario o in casa di cura e custodia (art. 212 c.p.),
3. internati provvisori imputati, in qualsiasi grado di giudizio, e sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria in
ospedale psichiatrico giudiziario, in considerazione della
presunta pericolosità sociale ed in attesa di un giudizio
definitivo (artt. 206 c.p., 312 c.p.p.),
4. internati condannati con vizio parziale di mente, dichiarati socialmente pericolosi ed assegnati alla casa di cura e
custodia, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva,
previo accertamento della pericolosità sociale (art. 219
c.p.),
5. detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000,
Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
6. detenuti condannati in cui l’infermità di mente sia sopravvenuta prima o durante l’esecuzione della pena (art. 148
c.p.),
7. detenuti dei quali deve essere accertata l’infermità psichica,
per un periodo non superiore a 30 giorni (art. 112, c. 2
d.P.R. 230/2000 – Nuovo regolamento di esecuzione
dell’ordinamento penitenziario).
Rispetto al numero dei detenuti presenti nelle strutture
penitenziarie, la percentuale degli internati negli OPG è sicuramente inferiore; non si verificano, infatti, in queste strutture le drammatiche realtà di sovraffollamento delle carceri di
cui si continua a discutere da tempo, senza peraltro riuscire ad
affrontare il problema in maniera globale e con scelte di fondo
che tengano conto delle carenze strutturali ed operino una
seria rimeditazione al fine di verificare quanto possa ancora
dirsi attuale, nel sistema vigente, la funzione rieducativa della
pena; se essa abbia, cioè, ancora un senso non meramente te-
penale
Gazzetta
70
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
orico e tuttora spendibile nella prassi giudiziaria, al di là
delle limitate ed autoreferenziali ricadute all’interno del microcosmo dei ricorrenti convegni sul tema.
Seppure il problema del sovraffollamento non incida in
maniera altrettanto drammatica sugli OPG, nondimeno la
realtà di dette strutture, per altri versi, non è meno inquietante, poiché queste istituzioni sono rimaste nel complesso sostanzialmente estranee ed impermeabili alla cultura psichiatrica riformata, né il meccanismo di internamento è stato
influenzato dalla legge 180/78.
Anzi, si può dire che nel dibattito che comunque investe
da tempo l’universo carcerario, le strutture destinate ai pazienti portatori di patologie psichiatriche sono rimaste del
tutto marginalizzate e sostanzialmente estranee all’interesse
diffuso degli operatori e degli stessi giuristi, nonostante l’esperienza pratica dimostri l’assoluta urgenza di rivedere le categorie ormai vetuste poste a base di istituti altrettanto incidenti sulle libertà fondamentali dell’individuo, ed in maniera
ancor meno garantita, in quanto rimaste, nella prassi concreta, sostanzialmente estranee ad un rigoroso processo di giurisdizionalizzazionedelle garanzie.
Ciò risulta ancora più stridente con quanto ribadito dalla
giurisprudenza costituzionale nel corso degli anni. Sin dalla
sentenza n. 139 del 27.7.1982, infatti, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.
222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice
penale, nella parte in cui non subordinavano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento
da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della
persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura.
In altri termini veniva stabilito e sancito il principio che
la pericolosità sociale non può essere definita una volta per
tutte, come se fosse un attributo naturale di una persona
ovvero di una malattia.
La valutazione della pericolosità sociale va piuttosto attualizzata – come previsto dalla successiva sentenza 18 luglio
2003, n. 253 della medesima Corte Costituzionale1 - e dunque
1 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 253 del 2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 c.p. (Ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di
adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa
misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure
dell’infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale. In motivazione la Corte ha censurato “il vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura detentiva (tale è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: art. 215, primo comma, n. 3, c.p.) anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà
vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice di contenuto
non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica), idonee ad evitare le
occasioni di nuovi reati (art. 228, secondo comma, c.p.), appaia capace, in
concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della
persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale”; ha posto, altresì, in luce che per l’infermo di mente “l’automatismo di una misura segregante e “totale”, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta
pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della
persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione”;
ed ha concluso affermando la necessità “di eliminare l’accennato automatismo,
consentendo che, pur nell’ambito dell’attuale sistema, il giudice possa adottare,
fra le misure che l’ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea
a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e
contenimento della sua pericolosità sociale dall’altro lato”.
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
relativizzata, ovvero messa in relazione ai contesti, alla presenza di opportunità di cure e di emancipazione relative alla
disponibilità di risorse e di servizi.
Ciò significa che la pericolosità sociale deve essere considerata non come una caratteristica dell’individuo e come un
dato ineludibile della sua personalità in presenza di determinati requisiti, bensì come una condizione transitoria, con la
conseguenza che anche le misure di sicurezza vanno di volta
in volta riviste e aggiornate. Vale a dire che le persone benché
prosciolte per infermità di mente, se non riconosciute socialmente pericolose, possono venire dimesse prima del tempo o
non essere ricoverate affatto in OPG.
Anche in seguito la Corte Costituzionale, con la sentenza
n. 367/2004, ha dichiarato incostituzionale la non applicazione di misure alternative all’internamento in OPG finalizzate ad “assicurare adeguate cure all’infermo di mente ed a
far fronte alla sua pericolosità sociale”, rilevando che il ricovero in OPG costituisce una pesante disuguaglianza di trattamento rispetto a quanto la riforma sanitaria prevede. 2
Nella sentenza dell’8 luglio 2009, dopo aver esaminato le
precedenti pronunce, la Corte Costituzionale ha poi affermato che “per effetto delle menzionate decisioni di questa Corte, risulta ormai presente nella disciplina sulle misure di sicurezza il principio secondo il quale si deve escludere l’automatismo che impone al giudice di disporre comunque la
misura detentiva, anche quando una misura meno drastica,
e in particolare una misura più elastica e non segregante come
la libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal
giudice medesimo, si riveli capace, in concreto, di soddisfare
contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale.
Tale principio, dettato in relazione alla misura del ricovero
in un ospedale psichiatrico giudiziario, vale anche per l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia, che è, a sua volta,
misura di sicurezza detentiva e quindi segregante (art. 215,
comma secondo, n. 2, c.p.), sicché ad essa ben si attagliano
le conclusioni circa la violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla salute svolte, in particolare, nella
sentenza n. 253 del 2003.
Differenze significative non possono ravvisarsi nella circostanza che la misura di cui all’art. 222 c.p. presuppone che
il soggetto interessato risulti gravemente infermo di mente, e
quindi non sia penalmente responsabile. Come rilevato in
dottrina e in giurisprudenza, vi è una sostanziale identità
concettuale tra vizio totale e vizio parziale di mente, il cui
unico elemento differenziatore consiste nella diversa incidenza quantitativa esercitata sulla capacità d’intendere e di volere, capacità esclusa nell’ipotesi di cui all’art. 88 c.p., soltanto diminuita - ma comunque grandemente scemata - nell’ipotesi di cui all’art. 89 c.p.
2 La sentenza n. 367 del 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
206 c.p. (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui
non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge,
idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate ed a contenere la sua pericolosità sociale. Con tale sentenza le censure circa l’automatismo
che caratterizzava l’art. 222 c.p. e le conclusioni circa la violazione del principio
di ragionevolezza e del diritto alla salute hanno trovato piena conferma, come
testualmente affermato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza dell’8
luglio 2009.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
Non costituisce ostacolo all’applicazione del principio
sopra indicato neppure il richiamo, operato dalla giurisprudenza più remota, all’art. 157 c.p. (disposizione, peraltro, relativa alla prescrizione), per il calcolo della pena ai fini della
determinazione della durata minima del ricovero in una casa
di cura e di custodia. Quel richiamo, infatti, non presuppone
l’applicabilità della disciplina della prescrizione al sistema
delle misure di sicurezza, ma si riferisce per l’appunto soltanto
alla individuazione di un criterio sulla base del quale stabilire
il periodo minimo di durata della misura (salva la possibilità
di revoca di questa per il venir meno della pericolosità).
Ne deriva che le modifiche normative in tema di prescrizione non incidono necessariamente anche sulle regole che
governano la disciplina delle misure di sicurezza, disciplina
che comunque deve tenere conto della necessità di pervenire
ad un risultato ermeneutico conforme a Costituzione, anche
determinando la nozione di ‘pena stabilita dalla legge’ con
riguardo a tutte le circostanze ricorrenti nella fattispecie
concreta”.
Alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale va
quindi esaminato l’attuale assetto normativo in materia sanitaria.
La riforma sanitaria - legge 833/1978 e successive modifiche, che ha inglobato la legge 180/78 - prevede una risposta
al disagio mentale che si articola nei momenti della prevenzione, cura e riabilitazione, attraverso organizzazioni territoriali con diversi gradienti di assistenza, laddove gli OPG godono di una sorta di incongrua extraterritorialità: il ricoverato non fruisce di cure all’interno del proprio contesto socio
– familiare di appartenenza, ma viene “estratto” da esso ed
“incluso” in una istituzione totale che non risponde ad un
territorio definito; gli OPG, in quanto istituzioni totali – ossia
istituzioni che assumono in sé tutti gli aspetti del quotidiano
– non prevedono gradienti di assistenza diversi con relativa
dislocazione territoriale, che costituiscano risposte diversificate alle variabili esigenze di un soggetto, derivanti dalle
differenze della sofferenza e dalle modalità in cui esse si coniugano nei soggetti stessi.
Bisognerebbe verificare se, ed in quale misura, il legislatore abbia in seguito recepito lo spirito della riforma sanitaria
e i principi fissati dalla Corte Costituzionale in relazione agli
interventi sanitari in questo campo specifico.
Già nel 1999 il decreto ministeriale 230, ed in particolare
il “Progetto Tutela Salute Mentale in ambito penitenziario”,
disponeva, nell’ottica dell’equità e del diritto alla cura, che i
Dipartimenti di Salute Mentale operassero anche all’interno
delle carceri, con gli stessi obiettivi e con le stesse modalità
utilizzate per tutti i cittadini del territorio dove la struttura
carceraria insisteva.
In data 1 aprile 2008 veniva promulgato il DPCM che ha
determinato il passaggio delle competenze sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse sanitarie, delle attrezzature e dei
beni strumentali dalla sanità penitenziaria al servizio sanitario nazionale. L’allegato C del citato decreto prevede le tappe
per il superamento degli OPG. Ciò deriva dal fatto che, essendo gli OPG una risorsa del sistema penitenziario, come tali
era previsto che passassero dalla gestione del sistema penitenziario a quella del sistema sanitario.
In particolare veniva individuato un percorso articolato
in tre fasi:
2 0 1 2
71
1. La responsabilità della gestione sanitaria degli OPG passa
interamente alle Regioni in cui gli stessi hanno sede; i
Dipartimenti di Salute Mentale nel cui territorio insistono
gli OPG elaborano un programma che prevede:
- la dimissione degli internati che hanno concluso la misura
della sicurezza, nonché la loro inclusione sociale;
- il rientro nelle carceri di provenienza dei ricoverati per
disturbi psichici sopravvenuti durante l’esecuzione della
pena, dopo che siano state attivate le sezioni di cura e riabilitazione all’interno delle carceri stesse;
- la possibilità che le osservazioni per l’accertamento delle
infermità psichiche di cui all’art. 112 D.P.R. 230/2000
siano espletate negli istituti ordinari.
2. a distanza di un anno si prevede una ridistribuzione, su
basi regionali, degli internati, in modo che ogni OPG senza modificarne in modo sostanziale la capienza e la
consistenza - si configuri come la sede per i ricoveri della
Regione in cui insiste e delle Regioni limitrofe o comunque
viciniori.
3. dopo due anni, si prevede la restituzione ad ogni Regione
italiana della quota di internati in OPG di provenienza dai
propri territori e l’assunzione della responsabilità per la
presa in carico da parte di ognuna di esse attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi all’interno
della struttura, anche in preparazione della loro dimissione e del loro inserimento nel contesto sociale di appartenenza, dando così piena attuazione al disposto dell’art.
115 c. 1, D.P.R. 230/2000.
Nella Conferenza Unificata Stato – Regioni dell’ottobre 2011
veniva poi sancito l’Accordo sul citato documento recante
”Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG di cui all’Allegato C del DPCM 1 aprile
2008”.
Il 16 dicembre 2011 (pubblicato il 22) è stato varato il Decreto del Consiglio dei Ministri n.211 contro il sovraffollamento delle carceri; al Senato, il 25 gennaio 2012, il decreto veniva
convertito in legge con l’emendamento che prevede la chiusura
degli Ospedali psichiatrici giudiziari, fissata al 31 marzo 2013,
e il trasferimento dei detenuti alla sanità regionale.
L’emendamento era stato riformulato dai due relatori Filippo Berselli (Pdl) e Alberto Maritati (Pd), con l’introduzione
dell’indicazione delle fonti dei finanziamenti e delle somme di
spesa autorizzate.
Alla Camera detto emendamento veniva approvato definitivamente il 14.2.2012 con legge 17 febbraio 2012, n. 9 che,
all’art. 3-ter, “Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari”, prevede che il termine per il completamento del processo di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari - già previsto dall’allegato C
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30
maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo
le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti - èfissato al 1° febbraio 2013.
In sintesi, l’emendamento prevede che a decorrere dal 31
marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in OPG siano
penale
Gazzetta
72
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
eseguite esclusivamente all’interno di ‘strutture sanitarie’, i
cui requisiti – strutturali, tecnologici e organizzativi – saranno definiti entro il 31 marzo 2012 da un ulteriore decreto,
definito in concerto tra il Ministro della salute, il Ministro
della giustizia e la Conferenza permanente Stato-Regioni.
Tali strutture dovranno essere ad esclusiva gestione sanitaria, con previsione di un’attività perimetrale di sicurezza e
vigilanza esterna, e destinate di norma a soggetti provenienti
dal territorio regionale in cui sono ubicate. Il decreto approvato esplicita tra l’altro che “le persone che hanno cessato di
essere socialmente pericolose, devono essere senza indugio
dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di
salute mentale.”
Anche se con ritardo rispetto alla data del 31.3.2012, in
data 1 ottobre 2012 è stato adottato il decreto del Ministro
per la Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia,
avente ad oggetto i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture residenziali che andranno a sostituire
gli OPG.
Il Ministro della Salute Renato Balduzzi ha poi, recentemente, inviato alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di
decreto contenente il riparto tra le Regioni dei fondi per il
definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
previsto dall’articolo 3-ter comma 6 del decreto-legge
211/2011. Si tratta di 174 milioni, di cui 117 per il 2012 e 57
per il 2013, finalizzati alla realizzazione ed alla riconversione
delle strutture, mentre lo stanziamento per il loro funzionamento e per l’adeguamento del personale ammonta a 38 milioni per il 2012, che saliranno a 55 milioni annui a partire
dal 2013.
Il riparto dei fondi prevede che metà delle risorse verranno divise tra le Regioni, in base alla popolazione residente,
mentre l’altra metà sarà ripartita in base al numero dei soggetti attualmente internati negli OPG, suddivisi per Regione
di residenza, e non a seconda della Regione attuale di ricovero. L’obiettivo sembrerebbe, quindi, quello di favorire l’avvicinamento degli internati al proprio luogo di origine, nel
tentativo di favorirne il recupero e il reinserimento sociale.
Le modalità con cui si intende attuare la chiusura degli
OPG, sin dalle prime battute del percorso normativo esaminato, hanno suscitato perplessità e critiche da parte dell’aera
storicamente più impegnata nel movimento di riforma psichiatrica italiana che, pur ovviamente condividendo la previsione
di chiusura degli ultimi istituti manicomiali, non ne condivide affatto il risultato, sia con riferimento alla previsione di
strutture sanitarie con “un’attività perimetrale di sicurezza e
vigilanza esterna”, sia a causa della implicita riconferma di
una pericolosità legata al disagio mentale ed, infine, a causa
dell’evidente ritorno nella pratica psichiatrica della funzione
esplicita di controllo.
In realtà questi punti critici risultano del tutto confermati dal contenuto del decreto dell’1 ottobre 2012, adottato in
concerto dal Ministro della Salute e dal Ministro della Giustizia.
Ed infatti mentre da un lato il decreto sembra andare nel
senso di una restituzione al territorio ed all’ambiente socio –
familiare di origine, a favore dei soggetti internati, eliminando “l’extraterritorialità” che caratterizza gli OPG, restano
estremamente problematiche le soluzioni previste per coniugare l’intenzione curativa con la necessità di sicurezza.
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
Così se “la gestione interna di tali strutture è di esclusiva competenza Sanitaria”, esse restano pur sempre finalizzate all’ ”esecuzione della misura di sicurezza”, e le Regioni
“ferma restando la gestione sanitaria, ne assicurano conseguenzialmente un’implementazione adeguatamente diversificata, anche in termini strutturali, organizzativi, di profili
di sicurezza e di vigilanza esterna” ;
a tal fine, poi, accanto alle competenze del Servizio Sanitario e dell’Amministrazione Penitenziaria viene introdotta la
competenza delle Prefetture “…al fine di garantireadeguati
standard di sicurezza”, nonché la “disponibilità di sistemi
di sicurezza congrui rispetto alla missione della struttura
quali sistemi di chiusura delle porte interne ed esterne, sistemi di allarme, telecamere”.
Il numero dei posti-letto ritorna ad essere, sulla falsariga
delle strutture residenziali intermedie, di 20 ma il decreto non
definisce il numero di strutture per regione e/ o per abitanti e
dunque, anche per questo aspetto, sembra rinviare ad una
prospettiva ‘neomanicomialista diffusa’ in cui il numero di
posti-letto, e dunque le modalità organizzative, sono calibrate esclusivamente sulla domanda, potendo proliferare ad libitum secondo le necessità del momento; e se il suo aumento
può trovare nella compatibilità economica il suo ostacolo, un
suo eventuale decremento finirà, come già in passato, per
trovare nella rigidità organizzativa e nella funzione occupazionale ostacoli spesso insormontabili.
Paradossalmente, negli ultimi anni, le deplorevoli condizioni degli OPG, oltre alla crisi molto esplicita dei concetti di
“inimputabilità” e di “pericolosità sociale” nel dibattito culturale e scientifico, hanno sicuramente contribuito ad una
notevole cautela, da parte di numerosi magistrati, nell’invio
dei pazienti agli OPG; l’allestimento di “nuove residenze psichiatriche” - che si potranno supporre più appropriate sotto
il profilo logistico e più assistite sotto il profilo sanitario finirebbero con il legittimare le varie istanze sanitarie e giudiziarie intese ad abbassare la soglia di accesso ai nuovi surrogati degli OPG, con un prevedibile conseguente aumento
del numero degli internamenti. Nulla, peraltro, garantisce che
l’abnorme sistema di proroghe delle misure di sicurezza, attualmente utilizzato, venga in qualche modo arginato o modificato.
D’altra parte la condizione in cui versa la gran parte dei
Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura nel nostro paese, spesso a porte chiuse, con sistemi di videosorveglianza, con l’estesissimo utilizzo di mezzi di contenzione fisica per soggetti che
nessun reato hanno commesso, lascia facilmente intravedere
quali saranno le reali strutturazioni delle nuove residenze
psichiatriche per soggetti che, invece, hanno commesso reati,
e che sono considerati con provvedimenti giudiziari “pericolosi per sé e per gli altri”.
Un pericoloso ritorno alla duplice funzione di “custodia
e cura” – secondo quanto era previsto dalla legge del 14 febbraio 1904, n. 36, recante disposizioni sui manicomi e sugli
alienati, nonché sulla custodia e cura degli alienati - sembra
profilarsi nel nuovo-vecchio orizzonte della psichiatria con le
stesse contraddizioni che avevano già portato al fallimento
della organizzazione manicomiale.
La nuova legislazione non tocca minimamente gli articoli
del codice penale e del codice di procedura penale riferiti ai
concetti di pericolosità sociale del folle reo, di incapacità e di
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
non imputabilità, che determinano ancora il percorso di invio
agli OPG, e quindi, d’ora in poi, l’invio alle nuove “residenze
psichiatriche”.
Rinnovare con legge, nel 2012, la legittimità del concetto
di “pericolosità sociale” collegato all’infermità mentale concetto considerato ormai, da giuristi e psichiatri, privo di
qualsiasi base scientifica ed empirica - e della nozione di “totale incapacità di intendere e di volere”, pur essa fortemente
criticata da più parti negli ultimi decenni, significa assumersi
la grave responsabilità di contrastare sia lo spirito che la lettera della legge 180/78. Essa aveva spazzato via il nesso malattia - pericolosità, ed aveva sostenuto con forza la responsabilità e i diritti di ogni cittadino, tra cui sta il diritto di essere
giudicato e, se ritenuto colpevole, condannato ad una pena
equa, tendente alla rieducazione del condannato e non consistente in trattamenti contrari al senso di umanità.
La proliferazione di residenze ad alta sorveglianza, dichiaratamente sanitarie, riconsegna dunque agli psichiatri la responsabilità della custodia, ricostruendo in concreto il nesso
cura-custodia che si riteneva del tutto superato. Ne può facilmente derivare la riattivazione di un meccanismo devastante,
articolato da un lato attraverso la responsabilità penale del
curante-custode, e dall’altro attraverso la mancanza di garanzia per l’internato, a differenza di quanto avviene nel regime
carcerario, in cui quantomeno una serie di garanzie per i detenuti – in primis quella della certezza del fine pena – esistono
in misura molto articolata.
Non sembra poi da sottovalutare il rischio, non secondario, connesso alla difficoltà di implementare, nel corso del
2012, la spesa prevista e dunque l’effettiva realizzazione delle predette strutture, neppure con procedure di straordinaria
emergenza: in carenza del pubblico è facile prevedere una
proliferazione di offerta da parte di strutture private, pronte
o rapidamente allestite ai fini previsti dalla legge.
è poi già stato messo in evidenza il rischio che, anziché
privilegiare la presa in carico degli internati da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale con Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali, così da permettere l’effettiva costruzione
di percorsi alternativi agli OPG, concentrando tutto nella
creazione di mini OPG in ciascuna regione, si finirebbe con
il rinverdire e perpetuare la logica manicomiale, con il suo
tragico binomio cura – custodia; a fronte di ciò sembra ancora più inquietante l’idea che potrebbero essere soggetti privati a realizzare e gestire strutture detentive. Senza contare che
ciò incrementerebbe ulteriormente la spesa pubblica, dato che
il ricovero resta disposto dalla magistratura ed a pagare saranno le A.S.L. e lo Stato, qualora sia prevista la vigilanza
esterna.
All’urgenza di dare sollievo agli uomini e alle donne oggi
internati negli attuali OPG, realtà indegne di un paese civile,
si risponde restituendo dignità e diritti di cittadinanza, non
alimentando business o nuovi manicomi, che per loro natura
impediscono la cura e la riabilitazione di persone malate. Anche l’esame dei contenuti dei progetti di riforma del
codice penale - dal Progetto Grosso del 1999 al Progetto Pi-
2 0 1 2
73
sapia, passando per il Progetto Nordio del 2004 - porta a
constatare che essi, pur differenziandosi ampiamente, finiscono per perpetuare la pericolosità sociale e le misure di sicurezza, anche se con nuove denominazioni.
Nel Progetto Pisapia - Commissione Pisapia per la riforma
del codice penale 27 luglio 2006, Relazione del 19 novembre
2007 – l’ultimo in ordine di tempo, non si parla più di pericolosità sociale, ma si prevede che nei confronti dell’agente
non imputabile autore di reato sia applicata una “misura di
cura e di controllo”, con riferimento alla necessità della cura
e con durata non superiore a quella della pena che si applicherebbe all’agente imputabile; vengono poi indicate una vasta
gamma di misure di cura e di controllo, tra le quali il giudice
dovrà scegliere quella più confacente al caso, che vanno dal
ricovero in strutture terapeutiche protette o in strutture con
finalità di disintossicazione al ricovero in comunità terapeutiche, dalla libertà vigilata associata a trattamento terapeutico all’obbligo di presentazione, eventualmente associato a
trattamento terapeutico, dall’affidamento a servizi socio-sanitari allo svolgimento di una attività lavorativa o di una attività in favore della collettività (art. 22 dei principi di delega
al Governo per l’emanazione del nuovo codice penale).
Come già sottolineato, quindi, nessuna delle recenti disposizioni né i progetti in itinere prevedono alcun intervento
normativo sulla categoria della “pericolosità sociale” in relazione alle persone “non imputabili” per “incapacità di intendere e volere” e, quindi, non prevedono alcuna modifica
delle relative norme sostanziali e procedurali. Un’ottica di
riforma radicale della materia dovrebbe invece necessariamente considerare la possibile abrogazione degli articoli 88 e 89
del codice penale, con la conseguenza che ogni soggetto accusato di aver commesso un reato, ancorché affetto da un
disturbo mentale, potrebbe essere tratto a giudizio, sottoposto
a processo ed eventualmente condannato; la successiva erogazione ed espiazione della pena verrebbe modulata, quindi,
in rapporto alle condizioni di salute mentale del singolo.
A questo punto potrebbero essere attuati particolari programmi terapeutici e riabilitativi sia all’interno del carcere che
in costanza di misure alternative alla detenzione, quali la
semilibertà, gli arresti domiciliari, l’ospitalità presso comunità terapeutiche o Centri di Salute Mentale, col vantaggio che
tutti i cittadini, anche se “folli”, potrebbero riacquistare in
pieno i loro diritti, compreso quello, apparentemente paradossale, di essere condannati e di poter espiare una pena
adeguata alla loro colpa, intaccando una volta e per tutte lo
stigma oscurantista che vuole “il folle” sempre incapace e
irresponsabile.
In una necessaria stagione di riforme del sistema giudiziario, sia nei suoi obiettivi che nella sua organizzazione, inserita in una più ampia stagione di riforma dei diritti, non si può
non partire da una rivisitazione e riconsiderazione del concetto di imputabilità, che costituisce uno dei cardini della teoria
del soggetto del reato, peraltro tuttora ancorata a categorie
ed a sistemi di riferimento dei diritti individuali di matrice
ottocentesca.
penale
Gazzetta
74
D i r i t t o
●
p r o c e d u r a
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni unite penali, sentenza 20
settembre 2012, n. 36258
Presidente E. Lupo, Relatore M. Fumo
Le sezioni unite
e la indeterminata
aggravante dell’ingente
quantità
di stupefacenti:
una ricognizione
di significato valida
solo in bonam partem
Nota a Cassazione, Sezione unite
penali, sentenza 20 settembre 2012,
n. 36258 (ud. 24 maggio 2012)
● Giuseppe Amarelli
e
Ricercatore Universitario “Federico II”
Stupefacenti: aggravante dell'ingente quantità - Indicazione del
valore-soglia minimo
Non è ravvisabile la circostanza aggravante ad effetto
speciale dell’ingente quantità di stupefacenti di cui all’art. 80,
comma 2 d.P.R. n. 309/1990 quando la quantità di stupefacente sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza nella
tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la
discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale
quantità sia superata.
• • • Nota a sentenza
Sommario: Introduzione. – 1. Note preliminari: caratteri
e limiti delle ‘clausole generali’, con specifico riferimento ai
concetti quantitativi non numerici – 2. In particolare: il problema della imprecisa nozione di “ingente quantità” nell’aggravante speciale di cui all’art. 80, comma 2 d.P.R. n.
309/1990 – 3. Il precedente contrasto giurisprudenziale: il
criterio mercantilistico – 3.1. Il criterio della agevolazione del
consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili –
3.2. Il criterio ponderale – 4. L’interessante soluzione delle
Sezioni unite
Introduzione
Le fattispecie incriminatrici contenute nel comparto sanzionatorio della legislazione in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonostante la – o forse sarebbe meglio dire, a
causa della – recente, e controversa, riformulazione subìta con
la legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30
dicembre 2005, n. 2721, hanno sollevato negli ultimi anni vivaci contrasti interpretativi nella giurisprudenza sia di merito,
sia, soprattutto, di legittimità, generando un diffuso disorientamento circa i loro precisi margini di operatività.
La scivolosa ambiguità, talvolta, o la incerta genericità,
talaltra, di alcune espressioni letterali contenute nei novellati
artt. 73 e ss. del d.P.R. n. 309/1990 hanno, infatti, alimentato
in sede ermeneutica interrogativi complessi in merito alla rilevanza penale o meno di comportamenti molto diffusi nella
prassi e potenzialmente sussumibili tanto in fattispecie di ridotto disvalore sociale (addirittura, in taluni casi, in meri illeciti amministrativi), quanto in fattispecie sensibilmente più
gravi, severamente sanzionate.
La rapsodica mutevolezza delle risposte fornite a tali que-
1 Per una analisi delle principali novità introdotte con tale riforma, con particolare riferimento ai non pochi profili critici implicati dalle stesse, si rinvia, ex
multis, a G. Insolera-V. Manes (a cura di), La disciplina penale degli stupefacenti, Milano, 2ª ed., 2012; C. Ruga Riva, Stupefacenti e doping, in Diritto
penale, parte speciale, vol. I, a cura di Pulitanò, Torino 2011, 179 ss.; Id., La
nuova legge sulla droga: una legge ‘stupefacente’ in nome della sicurezza pubblica, in questa Rivista, 2006, 234 ss.; C. Piemontese (a cura di), La disciplina
penale degli stupefacenti: un’analisi sul campo, Pisa, 2010; S. Grillo, Stupefacenti: illeciti, indagini, responsabilità, sanzioni, Milano, 2012; A. Bassi, La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti, Padova, 2010.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
siti dalla giurisprudenza ha raggiunto picchi di tale imprevedibilità, da rendere assolutamente necessario, per ovvie ragioni di certezza del diritto e di uguaglianza sostanziale dei cittadini dinanzi alla legge (com’è risaputo, asseverate oggi anche
a livello CEDU), l’intervento dirimente delle Sezioni unite in
più d’una occasione.
In particolare, tre sono state le questioni maggiormente
discusse, che hanno indotto le Sezioni semplici della Suprema
Corte negli ultimi mesi a cavaliere tra il 2011 ed il 2012 ad
adire con delle ordinanze di rimessione ex art. 618 c.p.p. il
massimo organo nomofilattico, allo scopo di ottenere un risolutivo chiarimento preventivo:
la prima è quella relativa alla rilevanza penale ai sensi
dell’art. 73, comma 1 bis, lett. a), T.U. n. 309/1990, o meramente amministrativa ai sensi del successivo art. 75, del
consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nella duplice
ipotesi di mandato all’acquisto o dell’acquisto comune2 , questione questa, peraltro, già affrontata dalle stesse Sezioni
unite penali in tempi non lontani, prima della già menzionata
e poco chiara riforma legislativa del 20063;
la seconda è quella inerente alla corretta qualificazione
giuridica della pubblicizzazione e della messa in vendita di
semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, con
l’indicazione delle modalità di coltivazione e la resa (ma senza specificazione degli effetti ‘positivi’ derivanti dal successivo consumo), oscillando anche in questo caso la giurisprudenza tra la configurabilità del più grave delitto di ‘istigazione’
all’uso di sostanze stupefacenti di cui all’art. 82 T.U. n.
309/1990 e quella del decisamente meno grave illecito amministrativo della semplice ‘propaganda’ di cui al successivo art.
84 del medesimo testo normativo4;
l’ultima, infine, concerne il significato da attribuire alla
locuzione “ingente quantità” ai fini della configurazione
della circostanza aggravante speciale ad effetto speciale di cui
all’art. 80, comma 2 T.U. n. 309/1990, dal momento che essa,
nel corso degli ultimi anni, è stata interpretata in maniera
eccessivamente disomogenea ed oscillante da parte sia delle
corti di merito, sia delle diverse Sezioni della Corte di Cassazione5.
2 C. Cass., sez. V, ord. 16 ottobre 2012, n. 43464. Per consultare il testo dell’ordinanza, nonché un breve commento alla stessa di G. Romeo, Alle Sezioni
unite la questione della rilevanza penale del consumo di gruppo di sostanze
stupefacenti, cfr. www.penalecontemporaneo.it.; sul punto si veda anche A.C.
Tombesi, Sull’uso collettivo di sostanze stupefacenti: si consolida il contrasto
nella giurisprudenza di legittimità, ivi. In argomento, sia consentito rinviare al
nostro L’uso di gruppo tra modifiche normative e overruling, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2011, 1038 ss.
3 Com’è noto, infatti, sotto la vigenza della pregressa normativa, con la sentenza
sez.un., 28 maggio 1997, n. 4, era stato a tal proposito affermato che non
erano punibili, e rientravano pertanto nella sfera dell’illecito amministrativo di
cui all’art. 75, d.P.R. n. 309/1990, l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che fossero avvenute sin dall’inizio per conto
e nell’interesse anche di soggetti diversi dall’agente, quando era certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi, nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le
sostanze destinate al proprio consumo.
4 Cass., sez. I, ord. 29 maggio 2012, n. 25355. Per il testo dell’ordinanza ed un
breve commento di G. Romeo, Richiesto l’intervento delle Sezioni unite a
proposito del reato di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, cfr.
www.penalecontemporaeno.it.
5 Cass., sez. IV, ord. 11 ottobre 2011, n. 38748. Per il testo dell’ordinanza ed un
breve commento si rinvia a M. Pelazza, Rimessa alle Sezioni unite la questione circa l’interpretazione del concetto di “ingente quantità” di sosta stanza
stupefacente, di cui all’aggravante ex art. 80, co. 2 T.U. stupefacenti, in www.
penalecontemporaneo.it.
2 0 1 2
75
Ebbene, mentre la diatriba relativa al c.d. acquisto di gruppo di sostanze stupefacenti è ancora irrisolta, essendo fissata
per il prossimo 31 gennaio 2013 la sua decisione, le altre sono
state entrambe appianate dalle Sezioni unite con due interessanti e recentissime pronunce. Siccome della prima, quella
relativa alla vendita on-line di semi di sostanze stupefacenti,
solo al momento in cui si va in stampa è avvenuto il deposito
(il 7 dicembre 2012) 6, nelle pagine che seguono l’attenzione
verrà concentrata unicamente sull’ultima, essendo in questo
caso già disponibili sia il dispositivo, che le motivazioni7.
1. Note preliminari: caratteri e limiti delle ‘clausole generali’, con
specifico riferimento ai concetti quantitativi non numerici
Prima di addentrarsi nella analisi di questa decisione delle Sezioni unite, relativa all’aggravante ad effetto speciale di
cui all’art. 80, comma 2 T.U. n. 309/1990, prevista per i fatti
riguardanti quantità ingenti di sostanza stupefacenti o psicotrope, è opportuno ricostruire le caratteristiche strutturali di
tale figura circostanziale speciale, per evidenziare le ragioni
da cui è scaturito il contrasto interpretativo sulla sua portata
applicativa.
Com’è noto, questa aggravante costituisce un emblematico esempio di quelle disposizioni incriminatrici redatte dal
legislatore utilizzando la tanto diffusa, quanto controversa,
tecnica di redazione normativa c.d. per ‘clausole generali’,
anziché quella, contrapposta, di tipo analitico-casistico8; vale
a dire, quella tecnica legislativa che fa ricorso a lemmi generici o espressioni linguistiche ellittiche, che necessitano, per
forza di cose, di una concretizzazione e disambiguazione per
mano del giudice in sede di interpretazione ed applicazione.
Sebbene in linea teorica sia sempre preferibile la seconda
modalità di redazione delle norme penali, quella c.d. ‘casistica’, perché è l’unica che consente di rispettare effettivamente
il principio di precisione e quello di determinatezza delle fattispecie penali, è ugualmente frequente nella prassi legislativa
il ricorso anche alla prima modalità, quella c.d. ‘sintetica’. La
tecnica rigida descrittivo-analitica, infatti, in un sistema penale già ipertrofico come quello italiano attuale, oltre a determinare una ulteriore, inarrestabile, espansione dello stesso,
lascia inevitabilmente emergere troppe (incolmabili) lacune
originarie o derivate di tutela, rispetto a comportamenti trascurati, non conosciuti o, addirittura, non immaginabili, al
momento della redazione della norma, ma dotati di caratteristiche e di disvalore simili e rispondenti, quindi, alla eadem
ratio di tutela degli altri fatti tassativamente descritti9.
Senza trascurare che essa finisce con l’innescare un peri-
6 A tale quesito è stata fornita risposta negativa, specificando che nell’offerta in
vendita di semi di piante idonee a produrre sostanze droganti, corredata da
precise indicazioni botaniche circa la loro coltivazione, non è configurabile né
il reato previsto dall’art. 82 del T.u. stupefacenti, né l’illecito amministrativo di
cui al successivo art. 84, ma, nei congrui casi, il delitto di istigazione a delinquere, sub specie di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti.
7 Per un primo commento a tale sentenza Cass., sez. un., 20 settembre 2012,
Biondi, cfr. M. Pelazza, “Ingente quantità” di stupefacenti: le Sezioni unite
accolgono il “criterio ponderale”, in www.penalecontemporaneo.it.
8 Si veda sul punto F.C. Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979; nonché, da ultimo, l’interessante lavoro di D. Castronuovo,
Clausole generali e diritto penale, in www.penalecontemporaneo.it.
9 Sulle distinte tecniche di redazione delle fattispecie cui il legislatore può ricorrere, ex multis, cfr. G. Marinucci-E. Dolcini, Corso di diritto penale, Milano,
2001, 123 ss.
penale
Gazzetta
76
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
coloso processo di obsolescenza giuridica delle scelte politicocriminali del legislatore, cristallizzate in norme incriminatrici eccessivamente settoriali e scarsamente flessibili: fattispecie
di questo tipo – rigide, selettive ed anelastiche – risultano,
invero, incapaci di adattarsi naturalmente al mutare dei tempi ed alla evoluzione tecnologica e culturale del contesto
storico-sociale di riferimento, creando così dei vuoti di tutela
reputati irragionevoli o, all’opposto, risultando del tutto desuete ed inapplicate.
Per ovviare a tali inconvenienti connessi all’utilizzo di una
tecnica normativa puramente analitica, nonché per procedere
ad una “semplificazione della legislazione penale” che sia
tale da garantirne anche il “suo costante adeguamento alla
realtà”10, il legislatore in taluni casi opta, inevitabilmente, per
l’impiego in sede di redazione delle fattispecie incriminatrici
di elementi valutativi di tipo ‘sintetico’ o ‘generale’.
Tuttavia, nonostante le clausole generali di questo genere
siano necessarie e ‘tollerate’ nel nostro sistema penale, non si
può, però, arrivare a sostenere che esse godano di un particolare credito da parte della dottrina e non suscitino incertezze
nei destinatari e negli interpreti, al momento della loro concreta applicazione.
Tutt’altro.
Queste formule lessicali finiscono, difatti, “per introdurre
nel discorso giuridico, in maniera più o meno inevitabile, un
peculiare coefficiente di vaghezza o indeterminatezza, quantitativamente maggiore e qualitativamente diverso da quello
implicito in ogni enunciato normativo”, tale da far sorgere più
di una perplessità in merito alla loro conciliabilità con i principi fondanti la materia penale enunciati nella nostra Costituzione11.
Molti dubbi sono stati così sollevati circa la compatibilità
di questo tipo di clausole normative con il principio di legalità dei reati e delle pene di cui all’art. 25, comma 2 Cost. ed,
in particolare, con la sua sotto-declinazione del principio di
precisione e determinatezza, nonché, più in generale, con il
principio di separazione dei poteri dello Stato e con le esigenze di certezza del diritto, site alla base del rapporto cittadinoautorità12.
Inoltre, altre fondate riserve sono state formulate con riguardo all’antitesi di questi elementi e, quindi, di questa tecnica di redazione delle fattispecie incriminatrici, rispetto al
principio di frammentarietà e di extrema ratio del diritto
penale, nonché ai principi uguaglianza sostanziale dei cittadini dinanzi alla legge, di proporzione della risposta sanzionatoria di tipo penale, di colpevolezza e di prevenzione speciale e generale-positiva della pena.
È evidente che laddove la norma incriminatrice non descriva in maniera puntuale e dettagliata il comportamento
meritevole di sanzione penale, ma ricorra a locuzioni dai caratteri vaghi, sfumati ed ambigui, essa finisca con lo svuotare,
addirittura, la valenza garantista minima del principio di le-
10 Così, F.C. Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., 353,
cui si rinvia per una completa ed approfondita analisi del principio di determinatezza.
11 Sul punto cfr. D. Castronuovo, Clausole generali e diritto penale, cit., 3.
12 La difficile compatibilità di espressioni linguistiche generiche ed imprecise con
il principio di determinatezza è messa ben in evidenza, di recente, da S. Moccia,
La promessa non mantenuta, Napoli, 2001, 17 ss.
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
galità, quella di presidio a favore dei consociati nei confronti
di possibili arbitri nell’esercizio della potestà punitiva da
parte del potere esecutivo o del potere giudiziario.
Una fattispecie incriminatrice di questo tenore determina,
infatti, uno slittamento del potere di selezione dei fatti penalmente rilevanti dal potere legislativo al potere giudiziario,
compromettendo alla radice le fondamenta di un moderno
Stato sociale di diritto di stampo democratico, rappresentate
dal principio di derivazione illuministica della divisione dei
poteri13.
Com’è stato suggestivamente sottolineato, norme eccessivamente indeterminate rischiano di ridurre il principio di legalità ad un mero simulacro vuoto e privo di vis garantista,
nonché di trasformare uno Stato di diritto in uno Stato di
giudici14.
Nel momento in cui il legislatore decide di costruire una
disposizione incriminatrice facendo ricorso ad espressioni
ambigue e generiche, abdica implicitamente al monopolio
della scelta dei fatti penalmente rilevanti che la nostra Carta
fondamentale gli ha voluto riservare, delegando nella sostanza
tale oneroso e fondamentale compito al potere giudiziario.
Quando la disposizione incriminatrice, generale ed astratta, non traccia in maniera chiara gli elementi distintivi del
comportamento sanzionato, a causa di espressioni eccessivamente ambigue e generiche, inidonee a delimitare nettamente
l’area del penalmente rilevante, rispetto a quella attigua, ma
ben distinta per gli effetti che ne conseguono, del penalmente
irrilevante, è il singolo giudice del caso concreto che viene di
fatto caricato di un potere discrezionale enorme circa la sussumibilità o meno al suo interno dei fatti oggetto della res
giudicanda.
Peraltro, una norma indeterminata a causa delle clausole
generali non genera unicamente un simile, pericoloso, slittamento di competenze, bensì innesca anche altri devastanti
effetti distorsivi, che coinvolgono regole e principi essenziali
del nostro diritto penale.
In particolare, essa determina una palese violazione del
principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, consentendo che uno stesso identico fatto sia apprezzato e valutato in termini sensibilmente difformi, quando non diametralmente opposti, dall’ordinamento giuridico, a causa della
(inevitabilmente) divergente discrezionale valutazione dei
giudici chiamati in concreto ad apprezzarlo. Mancando dati
oggettivi certi cui attenersi per risolvere dubbi interpretativi
in merito a casi scivolosi, sono le precomprensioni personali
del singolo interprete a condizionare la soluzione degli stessi,
incrinando così il mito sempre inseguito, ma mai raggiunto,
della certezza del diritto e quello inevitabilmente connesso
della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge15.
Inoltre, una fattispecie così redatta produce anche quegli
altri devastanti e non secondari effetti cui si è accennato
poc’anzi, incrinando la regola – oggi scolpita anche nell’art.
7 della Carta EDU – della accessibilità e della conoscibilità
dei precetti, nonché quella strettamente correlata della preve-
13Sul punto cfr. F.C. Palazzo, Il principio di determinatezza, cit., 75; S. Moccia,
La perenne emergenza, cit., 18.
14 Così, G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale di diritto penale, cit., 124.
15 S. Moccia, La perenne emergenza, cit., 19.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
dibilità delle conseguenze sanzionatorie, aprendo così un
pericoloso vulnus in un altro dei principii fondanti del diritto
penale, quello di colpevolezza.
Una norma incriminatrice eccessivamente imprecisa e
dotata di scarsa capacità selettiva dei comportamenti in essa
sussumibili, non consentendo la libertà di scelte di azione dei
consociati, finisce con il rendere impossibile (o del tutto arbitrario ed irragionevole) l’eventuale giudizio di rimproverabilità in concreto formulato nei confronti del reo16.
Se il precetto primario è, infatti, oscuro e non è ben chiaro il confine tra ciò che è lecito e ciò che è illecito, dipendendo
piuttosto la sua individuazione dall’apprezzamento episodico
e contingente del singolo giudice del caso concreto, sulla base
delle proprie precomprensioni personali, quale addebito si può
forse muovere sul terreno della colpevolezza-rimproverabilità
all’autore del fatto?
Inoltre, un simile scenario normativo, caratterizzato da
genericità ed imprecisione nella descrizione dei fatti penalmente rilevanti, riverbera effetti anche sul terreno delle funzioni della pena, in particolare mettendo in crisi sia quella
special-preventiva positiva, che quella general-preventiva
positiva, non riuscendo in alcun modo a contribuire né alla
risocializzazione del condannato, né all’orientamento culturale dei consociati17.
Ed infatti, quale funzione rieducativa ai sensi dell’art. 27,
comma 3 Cost., potrebbe assolvere una pena inflitta nei confronti di un imputato in assenza di un effettivo giudizio di
inevitabilità e rimproverabilità circa il suo comportamento
antidoveroso?
Quale funzione pedagogica e di aggregazione dei consociati attorno a valori condivisi potrebbe svolgere una pena
edittalmente comminata per un fatto i cui contorni non siano
ben definiti ed il cui disvalore non sia previamente e nitidamente conoscibile?
L’utilizzo di espressioni eccessivamente vaghe determina,
quindi, uno scardinamento di quell’impianto congiunto di
garanzie che la Corte costituzionale – con il supporto della
dottrina – ha faticosamente e coraggiosamente costruito nelle famose sentenze del 1988, nn. 364 e 1085, grazie al quale
– nella prospettiva di scopo della rieducazione del condannato ed in quella congiunta dell’orientamento culturale dei
consociati rispetto al disvalore dei fatti penalmente sanzionati –l’accertamento della responsabilità penale deve essere
sottoposto necessariamente alla verifica in concreto del coefficiente soggettivo minimo della colpa, in relazione agli elementi più significativi della fattispecie e, quindi, della rimproverabilità del reo18.
A ciò si aggiunga, infine, che l’utilizzo nell’ambito delle
fattispecie incriminatrici di espressioni imprecise, stridenti
con il principio del nullum crimine sine lege caerta, ripercuote effetti negativi anche sul terreno del processo penale e
delle relative garanzie, pregiudicando la tenuta di tre principii
processuali irrinunciabili: quello del diritto di difesa dell’imputato sancito dall’art. 24 Cost.; quello strettamente correlato del giusto processo e del contraddittorio per la formazione
16 In argomento si rinvia a F.C. Palazzo, Il principio di determinatezza, cit., 87 ss.
17 Tali dubbi sono espressi da S. Moccia, La perenne emergenza, cit., 86 s.
18 ….
2 0 1 2
77
della prova enunciato dal novellato art. 111 Cost.; nonché
quello dell’obbligatorietà dell’azione penale, messo in crisi
dalla impossibilità di verificare la sua osservanza19.
Una norma imprecisa e vaga, difatti, altera gli equilibri
tra le parti processuali nel contraddittorio per la formazione
della prova e rende arduo per l’imputato e per il suo avvocato
difensore individuare correttamente l’oggetto dell’accusa e,
conseguentemente, ricercare e fornire elementi di prova a sua
discolpa 20.
È però opportuno tenere presente che questi aspetti critici
implicati dalle clausole generali mutano di intensità e di criticità in base alla collocazione di queste nella articolata trama
della legislazione penale: sono decisamente smussati, ma non
certo eliminati, quando le espressioni imprecise sono utilizzate nell’ambito di disposizioni collocate nella parte generale del
codice penale, dal momento che in questo caso hanno una
funzione definitoria generale ed astratta di regole base valide
per l’intero sistema penale allo scopo di garantire uniformità
ed omogeneità di applicazione21; mentre si acuiscono sensibilmente quando, al contrario, esse sono impiegate nelle singole
figurae criminis della parte speciale del codice o della legislazione complementare.
Com’è stato correttamente rilevato è in questa seconda
ipotesi, infatti, che esse «rivelano tutta la loro potenziale
pericolosità in relazione alla loro assai difficile compatibilità
con i principi di stretta legalità e di determinatezza dell’illecito penale”22 , poiché, non predeterminando in maniera
chiara, attraverso segni linguistici inequivocabili, l’ambito di
operatività delle fattispecie che le contengono, lasciano aperti vasti spazi di manovra all’interprete chiamato ad applicarle. Espressioni di tale caratura conferiscono al giudice un
ruolo creativo di non secondaria importanza nell’opera di
concretizzazione del ‘tipo criminoso’ generale ed astratto,
chiamandolo a svolgere un’operazione, più o meno ampia, di
adeguamento dinamico del loro significato23. Operazione
tutt’altro che priva di rilievi problematici, per le ragioni
poc’anzi esposte.
2. In particolare: il problema della imprecisa nozione di “ingente
quantità” nell’aggravante speciale di cui all’art. 80, comma 2
d.P.R. n. 309/1990
Nel caso di specie dell’art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990,
che dispone, al comma 2, che le pene previste per i reati di cui
all’art. 73 del medesimo T.U. (incriminante la produzione, il
traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), ove il fatto riguardi “quantità ingenti” di sostanza,
siano aumentate “dalla metà a due terzi”, ci si trova al cospet-
19 G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 6° ed., Bologna,
2009, 78.
20 Su tale aspetto cfr. G. Marinucci-E. Dolcini, Corso di diritto penale, 4° ed.,
Milano, 2012, 58.
21 Per una completa analisi delle frizioni esistenti tra i principi costituzionali e le
clausole generali di parte generale che contribuiscono a determinare un’estensione normativa delle fattispecie incriminatrici di parte generale (vale a dire, gli
artt. 40, comma 2, 56 e 110 c.p.), si rinvia a L. Risicato, Combinazione e
interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria
delle clausole generali di incriminazione suppletiva, Milano 2001, 41 ss.
22 G. Contento, Clausole generali e regole di interpretazione come “principi di
codificazione”, in Valore e principi della codificazione penale: le esperienze
italiana, spagnola e francese a confronto, Padova 1995, 109 s.
23 Sul punto cfr. D. Castronuovo, 11
penale
Gazzetta
78
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
to di una clausola generale di parte speciale, utilizzata come
“frammento di una disposizione incriminatrice”; essa, infatti,
contribuisce a descrivere il tipo di condotta che integra la figura criminosa aggravata della fattispecie incriminatrice
‘base’.
In particolare, in questo caso ci si trova al cospetto di un
concetto quantitativo, ma non nella forma numerica impiegata, ad esempio, nei reati associativi (si pensi alle tre o più
persone degli artt. 416 e 416 bis c.p.), bensì in quella non
numerica, sovente utilizzata nei reati riguardanti entità patrimoniali economicamente quantificabili 24.
Mentre la prima species dei concetti quantitativi, quella
numerica, rappresenta il non plus ultra della precisione, non
esistendo alcun altro elemento descrittivo dotato di maggiore
capacità selettiva e di vis chiarificatrice, la seconda species,
quella dei concetti quantitativi non numerici, costituisce,
all’opposto, il massimo della imprecisione, delegando in concreto al giudice la sua stessa quantificazione e, dunque, la
delimitazione dell’ambito di operatività della fattispecie incriminatrice che la contiene25.
Nonostante l’evidente frizione di locuzioni di questo tipo
con il principio del nullum crimen sine lege, in particolare –
come già evidenziato – con il principio di precisione e determinatezza, si deve rilevare che esse non sono mai state censurate dalla Corte costituzionale per contrasto con l’art. 25,
comma 2 Cost.
Anzi, com’è risaputo, la Corte costituzionale ha rigettato
sempre le questioni di legittimità costituzionale relative a
clausole generali caratterizzate da concetti quantitativi non
numerici, facendo leva su criteri interpretativi non strettamente letterali. In particolare, i giudici del palazzo della Consulta
hanno rigettato tali questioni, ricusando un atteggiamento
“atomistico” e orientato ai singoli elementi di una fattispecie
separatamente considerati, asserendo, al contrario, che «la
verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale (contenente tali elementi) va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della
fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce”26.
Pertanto, la «inclusione nella formula descrittiva dell’illecito penale di espressioni sommarie, di vocabili polisensi,
ovvero […] di clausole generali o concetti “elastici” non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato», allorquando il recupero di tassatività sia reso possibile, per il
giudice e per il destinatario della norma, dalla «descrizione
complessiva del fatto incriminato», avuto riguardo alle «finalità perseguite dall’incriminazione» (argomento finalistico, o
della “ratio legis”) e al «più ampio contesto ordinamentale in
cui essa si colloca» (argomento sistematico)27.
Tuttavia, nonostante tali indicazioni della Corte costituzionale, l’aggravante in esame ha sollevato in giurisprudenza
notevoli disorientamenti, portando i giudici a ritenere configurata o meno la stessa sulla base di valutazioni discrezionali, oscillanti, non univoche ed ancorate a parametri incerti.
La ragione di ciò risiede nel fatto che l’art. 80 del T.U. fa
ruotare attorno alla clausola generale e flessibile della “ingente quantità” una conseguenza concreta di significativa rilevanza: diversamente che negli altri due casi rimessi alle S.U.
dell’acquisto di gruppo e dell’istigazione all’uso di stupefacenti, dove, addirittura, dalla diversa soluzione del quesito discende la rilevanza penale o meramente amministrativa della
condotta, nel caso di specie deriva un altro effetto estremamente rilevante, l’aumento della pena dalla metà ai due terzi,
che può giungere fino ai trenta anni di reclusione nel caso in
cui le sostanze, oltre ad essere in quantità ingente, siano anche
adulterate o commiste ad altre, in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva 28.
Vale a dire, che dalla definizione del concetto di ingente
quantità ad opera della giurisprudenza, deriva l’ulteriore e
sensibilissimo inasprimento del quadro sanzionatorio ordinario, già connotato da estrema severità, prevedendo per le
ipotesi base, non riconducibili all’attenuante della lieve entità
del fatto di cui al comma 5 dell’art. 73, la reclusione dai sei ai
venti anni (oltre ad una pena pecuniaria dai 20.000 ai
260.000 euro)29.
Peraltro, la sussunzione di un comportamento incriminato nella fattispecie circostanziale aggravata di cui all’art. 80,
comma 2, genera anche altre conseguenze pratiche di non
secondario rilievo, andando ad incidere in negativo su diversi
profili processuali e penitenziari. Da una simile diversa qualificazione del fatto deriva, infatti, l’ampliamento dei termini
di custodia cautelare, la dilatazione dei termini di durata
massima delle indagini preliminari ed, infine, l’inasprimento
del trattamento penitenziario per il condannato.
3. Il precedente contrasto giurisprudenziale:
il criterio mercantilistico
La presenza di questo concetto quantitativo non numerico
nell’aggravante in esame ha fatto sì che si siano andate delineando nella giurisprudenza di legittimità divergenze esegetiche talmente eclatanti da non trovare un punto di incontro
neanche nella prima decisione delle Sezioni unite del 2000. I
criteri in quell’occasione individuati per superare l’indeterminatezza dell’espressione “ingente quantità” si sono, invero,
rivelati incapaci di orientare con certezza gli interpreti30.
Ma procediamo con ordine e proviamo a ricostruire nel
24 Su tale distinzione, si rinvia a G. Marinucci-E. Dolcini, Corso di diritto penale, cit., 135 s.; F.C. Palazzo, Corso di diritto penale, 4ª ed., Torino,
2011, 145.
25 D. Castronuovo, Clausole generali, cit., 13.
26 Così, per es., Corte cost., n. 327 del 2008, sull’infondatezza della questione di
illegittimità dell’art. 434 c.p. (“altro disastro”). Cfr. inoltre Corte cost., n. 247
del 1989 (sull’art. 4, n. 7, l. n. 516/1982: alterazione “in misura rilevante” del
risultato della dichiarazione fiscale): «Quel che non può esser, in ogni caso,
metodologicamente consentito è “isolare” la “misura rilevante” dagli altri
elementi della fattispecie nella quale tale “misura” è inserita, per confrontare
quest’ultima, e solo quest’ultima, con il precetto di determinatezza […]». Sul
punto cfr. Castronuovo, Clausole generali, cit., 16.
27 I passi riportati sono tratti da Corte cost., n. 5 del 2004, infondatezza della
questione di illegittimità dell’art. 14, comma 5-ter, del t.u. dell’immigrazione
(reato di trattenimento sul territorio dello Stato “senza giustificato motivo”).
Tale pronuncia è poi ripresa da molte di quelle successive: da ultimo, per es.,
Corte cost., n. 21 del 2009, infondatezza della questione riguardante l’art. 12,
comma 1, t.u. dell’immigrazione (favoreggiamento c.d. semplice all’emigrazione clandestina). In argomento cfr. ancora D. Castronuovo, ibidem.
28 La sproporzione e la irragionevolezza di questa sanzione, come di quella prvista
per le fattispecie base, è evidenziata da C. Ruga Riva, Stupefacenti e doping,
cit., 180.
29 Questo aspetto è messo in evidenza dalla stessa decisione delle Sezioni unite in
parola Cass., sez. un., 20 settembre 2012, cit.
30 Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 17, Primavera, in Cass. pen., 2001, 69.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
dettaglio le differenti soluzioni prospettate al quesito circa il
significato da attribuire a tale clausola generale nel corso
degli anni da parte della Suprema Corte31.
Ad avviso di un primo orientamento, c.d. ‘mercantilistico’,
risalente agli anni Novanta, la locuzione in questione doveva
essere valutata tramite l’utilizzo del concetto di “saturazione
del mercato”. Per essere considerata ingente la quantità di
stupefacenti spacciata e, quindi, configurata l’aggravante
speciale di cui all’art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990, era
necessario rapportarla “all’area di mercato considerata in un
determinato momento storico e al periodo di tempo necessario per quel mercato di assorbire od esaurire la quantità destinata allo spaccio”32. Ciò conduceva a reputare integrata la
aggravante solo in presenza di un quantitativo di sostanza
stupefacente idoneo “a saturare una vasta area di mercato per
un apprezzabile periodo di tempo”33.
Utilizzando un simile parametro di riferimento per la ricognizione del significato della clausola generale in questione
si conferiva al giudice di merito l’onere di “stabilire di volta
in volta le condizioni in base alle quali può dirsi realizzata
tale saturazione del mercato”, determinando per un verso
“quale sia l’area di mercato nella quale la droga detenuta è
destinata (...) [e] la presumibile quantità di domanda cui l’offerta dello stupefacente sarà destinato” e, per altro verso,
“quale sia il periodo nel quale possa durare la saturazione del
mercato”34.
Com’è stato osservato anche nella recentissima decisione
delle Sezioni unite in commento, il riferimento all’ambito
territoriale ha uno scarso valore ermeneutico, da un lato, in
quanto il mercato della droga ha caratteri globali e, normalmente, non riceve significativi connotati da una determinata
area territoriale; dall’altro, perché la ratio dell’aggravamento
di pena è ancorata all’accresciuto pericolo per la salute pubblica da valutare in relazione al numero orientativo di fruitori finali cui è potenzialmente destinato un determinato quantitativo di droga e non all’area dove essi vivono35.
3.1. Il criterio dell’agevolazione del consumo nei riguardi di
un rilevante numero di tossicofili
Questa tesi si è, però, infranta contro le difficilmente
sormontabili obiezioni delle Sezioni unite, compendiate in un
passaggio della parte motiva della sentenza del 2000 poc’anzi richiamata. In quella sede si è correttamente osservato che
il criterio mercantilistico finiva per valorizzare, nel giudizio
circa la sussistenza della aggravante, un elemento – quello del
mercato – non solo “non richiesto e spurio rispetto alla ratio
della disposizione”, ma addirittura “di impossibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagine”, e quindi “del
tutto immaginario”. Il riferimento ad un “fantomatico mer-
31 Una analitica ricostruzione delle precedenti decisioni è rinvenibile nel testo
della sentenza delle Sezioni unite che si annota, nonché nel commento alla
stessa di M. Pelazza, Rimessa alle Sezioni unite, cit.; in Id., “Ingente quantità”,
cit.; nonché, ancor più dettagliatamente, nel lavoro di G. Leo, Osservatorio
Contrasti Giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 2011, 693 ss. Si ritiene, quindi,
sufficiente in questa sede procedere ad una enunciazione ‘sintetica’ dei diversi
orientamenti, richiamando nelle note solo alcune di queste pronunce.
32 Cass., sez. VI, 6 marzo 1998, n. 2868. Sul punto cfr. M. Pelazza, Rimessa
alle Sezioni unite, cit.
33 Cass., sez. VI, 24 settembre 1998, n. 10722, in Cass. pen., 1999, 2371.
34 Così ancora Cass., sez. VI, 6 marzo 1998, n. 2868, cit.
35 Cass., sez. un., 20 settembre 2012, cit.
2 0 1 2
2 0 1 2
79
cato”, ed alla capacità di assorbimento di una “indefinibile
massa di ipotetici consumatori” veniva censurato, perché
considerato una “enunciazione di nozioni del tutto generiche
e sottratte ad ogni riscontro fattuale”.
Muovendo da tali rilievi critici, le Sezioni unite avevano
allora individuato un nuovo parametro idoneo a dirimere i
dubbi circa la corretta definizione della nozione di “ingente
quantità” di cui all’art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990,
enunciando un principio che, pur non abbandonando del
tutto il riferimento al mercato36, era teso a dare maggior rilevanza al numero di consumatori che la sostanza è in grado,
potenzialmente, di raggiungere.
Secondo questa diversa tesi, l’aggravante in questione
sarebbe, infatti, integrata tutte le volte in cui il quantitativo
di stupefacente, “pur non raggiungendo valori massimi, sia
tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei
riguardi di un rilevante numero di tossicofili, secondo l’apprezzamento del giudice di merito che vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi
in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale
circostanza”.
Tale criterio è stato poi seguito dalla giurisprudenza successiva, facendo riferimento prevalentemente all’“agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili”, piuttosto che al raffronto con le transazioni usuali
nell’ambito territoriale in cui agisce il giudice 37, fatta salva
qualche eccezione38.
Nel corso del tempo si è così arrivati ad individuare tre
elementi la cui sussistenza deve essere necessariamente accertata dal giudice di merito per ritenere sussistente l’aggravante:
in primo luogo “l’oggettiva eccezionalità del quantitativo
sotto il profilo ponderale”; in secondo luogo “il grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di tale quantitativo
comporta”, ed infine “la possibilità di soddisfare richieste di
numerosissimi consumatori per l’elevatissimo numero di dosi
ricavabili”39.
Tuttavia, il richiamo contenuto in questa tesi alle “transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale il giudice
di fatto opera”, finiva per riavvicinarla proprio all’orientamento contrapposto che voleva confutare, reintroducendo
nella valutazione del concetto di ingente quantità quel criticato riferimento generico ed incontrollabile al ‘mercato’ degli
stupefacenti. Essa, quindi, paradossalmente, non riusciva a
superare le censure mosse al criterio mercantilistico, cadendo,
anzi, nei medesimi errori, attraverso la valorizzazione di pa-
36 Ad avviso di questo primo arresto delle Sezioni unite, infatti, doveva ritenersi
ingente la quantità che fosse “oggettivamente ... notevole”, tale da “superare
notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in
transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale il giudice del fatto
opera e, per questo, è in grado di formarsi una esperienza fondata sul dato reale presente nella comunità nella quale vive”.
37 Sul punto cfr. G. Leo, Osservatorio Contrasti Giurisprudenziali cit., 693, ss.;
M. Pelazza, Rimessa alle Sezioni unite, cit.
38 Ad esempio la Suprema Corte in Cass., sez. III, 22 settembre 2011, n. 40009,
ha censurato una sentenza di merito per non aver indicato, “a fronte di un
dato ponderale non eccessivamente rilevante”, le ragioni per cui tale quantitativo “era idoneo a costituire una offerta straordinaria tale da aumentare in
modo eccezionale il consumo di cocaina nell’ambito del territorio”. Nello
stesso senso si veda anche Cass., Sez. VI, 14 dicembre 2004, n. 49085; Cass.,
sez. V, 9 luglio 2008, n. 39205.
39 In tal senso cfr. Cass., sez. IV, 12 luglio 2011, n. 33314 e Cass., sez. IV, 1 febbraio 2011, n. 9927.
penale
Gazzetta
80
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
rametri indeterminati e vacui, non previsti come elementi
costitutivi nella fattispecie aggravata di cui all’art. 80, comma
2 T.U. stupefacenti40.
3.2. Il criterio ponderale
Anche questo criterio, quindi, non è riuscito a risolvere
tutti i problemi che la indeterminatezza della clausola generale in questione poneva agli interpreti. Facendo leva su di
esso, infatti, la giurisprudenza successiva non è riuscita ad
approdare ad una soddisfacente uniformità sul significato
della stessa, giungendo, altresì, a ritenere “ingenti” quantità
anche molto diverse tra loro.
Le pronunce delle corti di merito e di quelle di legittimità,
pur impiegando il medesimo criterio diagnostico per valutare
la sussistenza o meno della rigorosa aggravante ad effetto
speciale dell’art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990, hanno
fornito risposte in “evidente disarmonia, [pur] a fronte di
dati quali-quantitativi e di realtà territoriali in tutto assimilabili”, mentre l’applicazione giurisprudenziale della norma
deve muoversi “quanto più possibile su parametri improntati
a criteri oggettivi, e, quindi, verificabili”, ciò al fine di garantire il rispetto “del principio di determinatezza, aspetto del
più generale principio di legalità presidiato dall’art. 25 Cost.,
comma 2”41.
Per tale ragione, altra parte della giurisprudenza, con il
preciso obiettivo di superare questo quadro quanto mai ‘variegato’ venutosi a delineare circa il concetto di quantità ingente, di “meglio definire l’ambito di apprezzamento rimesso
al giudice del merito”, ed evitare che l’applicazione giurisprudenziale “[prestasse] il fianco a critiche di opinabilità di valutazioni, se non di casuale arbitrarietà”, ha cercato di individuare e sviluppare dei criteri oggettivi, di natura ponderale,
cui ancorare la applicazione dell’art. 80, comma 2 d.P.R. n.
309/1990.
La Sezione VI della Suprema Corte è così pervenuta in
alcune recenti decisioni del 2010 e del 2011 a stabilire che non
possono “di regola definirsi ‘ingenti’ “quantitativi di droghe
‘pesanti’ - in particolare eroina e cocaina - inferiori ai due
chilogrammi; e quantitativi di droghe ‘leggere’ - in particolare, hashish e marijuana - inferiori ai cinquanta chilogrammi”.
Ciò non di meno, anche questo criterio c.d. ponderale, che
conferisce valore normativo ai parametri quantitativi fissati
in via interpretativa per le singole sostanze stupefacenti, non
è stato considerato risolutivo, divenendo anch’esso bersaglio
di penetranti rilievi critici ad opera della giurisprudenza della
Sezione IV della stessa Corte di Cassazione, nonché, succes-
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
sivamente, della III e della V Sezione. Alcune sentenze di
queste sezioni hanno, infatti, espressamente respinto il criterio
dei limiti ponderali, riconoscendo l’aggravante anche per
quantitativi inferiori ai parametri stabiliti dalla VI Sezione,
come ad esempio nel caso di detenzione di 10, 20 e 28 kg di
hashish42 e rilevando come la scelta del legislatore “di riservare al giudicante il potere di considerare un fatto aggravato o
attenuato in relazione agli innumerevoli, e mai predeterminabili, casi della vita” sia sicuramente legittima43.
In particolare, si è osservato come esso (consentendo indebitamente al giudice, nel silenzio della legge, di “fissare
predeterminati limiti quantitativi minimi, al fine di ritenere
configurabile la circostanza aggravante in questione”44) sia
incompatibile con il principio di legalità, dal momento che
conferisce al potere giudiziario un compito – quello di definizione dei limiti di operatività delle fattispecie incriminatrici,
tramite soglie aritmetiche – che è di prerogativa esclusiva del
legislatore45.
Inoltre, nei confronti di tale tesi è stata mossa una ulteriore obiezione, tutt’altro che peregrina, relativa al parametro
quantitativo utilizzato per valutare la sussistenza dell’aggravante. Si è eccepito che la scelta di rapportarla ai valori ‘medi’
di purezza della sostanza sia decisamente inadeguata, considerato che “le percentuali di principio attivo variano da valori irrisori (anche inferiori all’1%) a valori superiori al 90%”,
aggiungendo che, “nella logica introdotta dalla sesta sezione
(...) (condivisibile nelle sue finalità) andrebbe individuata, per
coerenza sistematica, una soglia per l’aggravante anche per le
altre sostanze stupefacenti, in particolare per quelle maggiormente diffuse (per es.: quante pastiglie di extasy sono necessarie per configurare l’aggravante in questione?)”46.
Ben si capisce, allora come, vigendo una simile confusione
interpretativa sul punto, la IV sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla applicazione dell’aggravante in oggetto, abbia giustamente ritenuto
opportuno rimettere alle SS.UU., con ordinanza 11 ottobre
2011, n. 38748, la questione: “se, per il riconoscimento della
circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, si
debba fare ricorso al criterio quantitativo con individuazione
di limiti ponderali minimi per tipo di sostanza, ovvero debba
aversi riguardo ad altri indici che, al di là di soglie quantitative prefissate, valorizzino il grado di pericolo per la salute
pubblica, derivante dallo smercio di un elevato quantitativo,
e la potenzialità di soddisfare i numerosi consumatori per
l’alto numero di dosi ricavabili”.
4. L’interessante soluzione delle Sezioni unite
Con la recentissima decisione che si annota, le Sezioni
unite hanno risposto a tale quesito, ponendo (si spera defini-
40 Così, Cass., sez. un., 20 settembre 2012, cit.
41 Nella prassi, infatti, si è verificato che i valori ritenuti ingenti dai giudici di
primo o secondo grado ai sensi dell’art. 80, comma 2 T.U. stupefacenti presentavano caratteristiche estremamente eterogenee, oscillando, ad esempio, dai 15
grammi ai 100 chilogrammi per quanto concerne la cocaina, e dai 106 grammi
ai 45 chilogrammi per quel che riguarda l’eroina. Ciò ha consentito che la
medesima aggravante sia stata riconosciuta, ad esempio, in caso di detenzione
di mezzo chilo, un chilo e 1,5 chili di cocaina, e di 10 kg di hashish (oltre che,
ovviamente, in relazione a quantità più elevate, quali 126, 287 e addirittura
8.762 chili di hashish, 72 e 170 chili di cocaina, 2.500 kg di canapa indiana),
ed esclusa, invece, in casi analoghi, relativi a 10 e 18 chili di hashish; 30 e 40
kg di hashish; 4,5 kg di cocaina e 850 grammi di eroina pura. Per il relativi
riferimenti giurisprudenziali si rinvia ai già menzionati lavori di G. Leo e M.
Pelazza.
42 Rispettivamente Cass., sez. IV, 1 febbraio 2011, n. 9927; Cass., sez. IV, 29
settembre 2011, n. 38794 e Cass. sez. IV, 12 luglio 2011, n. 33314
43 Così Cass., sez. III, 31 marzo 2011, n. 17211, con nota di A. Aimi, Sull’aggravante della ingente quantità di materiale pedopornografico, in www.penalecontemporaneo.it; conformi Cass., sez. III, 14 luglio 2011, n. 30237; Cass., sez. III,
13 luglio 2011, n. 35144; Cass., sez. III, 18 marzo 2011, n. 16447.
44 Cass., sez. IV, 3 giugno 2010, n. 24571.
45 Analoghe obiezioni sono state formulate anche da Cass. Sez. IV, 2011, n. 9927;
nonché da Cass., sez. IV, 14 luglio 2010, n. 36360.
46 Così, testualmente, Così Cass., sez. IV, n. 9927/2011, cit.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
tivamente) fine ai problemi interpretativi in precedenza esposti ed accogliendo, sostanzialmente, l’orientamento ponderale
così come reinterpretato dall’ordinanza di rimessione, sebbene
con sfumature leggermente diverse che consentono di superare le censure che, nel recente passato, gli erano state mosse.
Innanzi tutto, prima di addentrarsi nel merito della decisione in parola, è interessante mettere in evidenza il punto di
partenza da cui muove la Corte per cercare la risposta al
quesito circa il significato da attribuire alla nozione ambigua
e generica di “ingente quantità”: la costatazione della manifesta sproporzione e disomogeneità delle sentenze di merito e
di legittimità che, rispetto a fatti omologhi, hanno fornito
soluzioni estremamente disparate, finendo con il ritenere
configurata la severa aggravante dell’art. 80, comma 2 d.P.R.
n. 309/1990, concepita dal legislatore per i soli “casi di estrema gravità”, integrati dalla “figura criminale” del “grossista”,
anche rispetto a casi di minore disvalore e a quantitativi
tutt’altro che ‘eccezionalmente rilevanti’.
Questa premessa, infatti, condiziona la soluzione, perché
la S.C. – incanalandosi lungo questo solco – si premura principalmente di cercare di fornire una risposta al quesito di
diritto sottopostole in grado di rimuovere la pericolosa “insidia al principio costituzionale di eguaglianza” integrata dalla
“estrema differenziazione e mutevolezza” dei quantitativi di
volta in volta ritenuti ingenti dai giudici di merito; nonché di
sopire i dubbi sollevati dalla norma in questione circa la compatibilità con il principio di determinatezza e tassatività di cui
all’art. 25 co. 2 Cost. e 7 CEDU.
Come sempre più spesso accade, le Sezioni unite hanno
immediatamente scartato la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 2
d.P.R. n. 309/1990 per violazione dell’art. 25, comma 2 Cost.,
per violazione del principio di precisione, percorrendo quella
via – sempre più praticata dalla giurisprudenza di legittimità,
anche su indicazione esplicita della Corte costituzionale –
della interpretazione conforme alla Costituzione47. Facendo
perno su questa leva ermeneutica, esse hanno condiviso appieno la valutazione di manifesta infondatezza della questione già formulata dalla IV Sezione, rilevando come l’ordinamento conosca anche altre ipotesi di disposizioni che evocano
il concetto di “ingente quantità” (ad es., l’art. 160 del d.lgs.
152/2006 in materia di traffico illecito di rifiuti, o gli artt.
600-ter e quater c.p. in relazione alla detenzione di materiale
pedopornografico), rispetto alle quali il dubbio di contrasto
con il principio di determinatezza è stato sinora sempre ritenuto manifestamente infondato dalla Cassazione.
A supporto di tale pregiudiziale affermazione, le Sezioni
unite hanno addotto le valutazioni espresse dalla Corte costituzionale in altre occasioni circa espressioni analoghe, in
base alle quali non è da ritenersi incompatibile con il principio
in questione l’utilizzo da parte del legislatore penale di
“espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, di clausole generali ovvero di concetti elastici”, spettando all’interprete in
tali ipotesi il compito di rendere certe e determinate quelle
fattispecie che, in astratto, possono apparire prive di contor-
47 Non è questa la sede per trattare questo stimolante tema, ma per approfondimenti si rinvia a M. D’Amico-B. Randazzo (cura di), Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Torino, 2009; G. Sorrenti, L’interpretazione
conforme a Costituzione, Milano, 2006.
2 0 1 2
81
ni sicuri e definiti48. In particolare, nel caso di specie, la concretizzazione della clausola generale dell’ingente quantità
deve avvenire mettendola in contatto con “la realtà fenomenica”, attraverso l’ausilio di “conoscenze condivise” e delle
“(comuni) massime di esperienza”.
Scartata, quindi, la possibilità di sollevare una questione
di legittimità costituzionale per violazione del principio di
determinatezza, la Suprema Corte si sforza di indicare quali
possano essere i criteri da adottare per conferire alla aggravante in esame un’area di operatività più delimitata ed in
grado di non prestarsi ad abbracciare classi di fatti eccessivamente eterogenee.
Due sono i parametri che, a suo avviso, devono essere
utilizzati in maniera complementare per oggettivizzare l’aggravante dell’ingente quantità e sottrarla all’apprezzamento
discrezionale, o sarebbe meglio dire arbitrario, dei giudici di
merito: la valorizzazione del “sistema tabellare” che caratterizza la legislazione penale in materia di stupefacenti; e quella del dato statistico relativo ai quantitativi di sostanze stupefacenti, emergente dal “materiale giudiziario” a disposizione
dell’Ufficio del Massimario.
Com’è noto, una delle tabelle allegate al Testo unico in
materia di stupefacenti, periodicamente aggiornata con decreto ministeriale, è volta ad indicare quali siano i “limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili ad un uso esclusivamente personale”. Essa, cioè, è preposta a fissare dei “limiti-soglia” orientativi, oltre i quali le
condotte di cui all’art. 73, comma 1-bis, “sono considerate di
regola penalmente rilevanti”; oltre i quali si passa dalla “presunzione di detenzione per uso personale” alla “presunzione”
– pur sempre vincibile, tramite altri elementi probatori eventualmente acquisiti in sede processuale – di “spaccio”.
Ad avviso delle Sezioni unite, se il dato quantitativo ricavabile dal sistema tabellare assume un ruolo fondamentale
nell’opera di demarcazione dell’area del penalmente rilevante
delle condotte di detenzione di sostanze stupefacenti, allora
esso deve essere preso necessariamente in considerazione
anche quando si tratta di definire il perimetro di applicazione
della relativa circostanza aggravante ad effetto speciale di cui
all’art. 80, comma 2. Vale a dire, che anche per determinare
il concetto di ingente quantità da cui dipende la applicabilità
o meno della menzionata aggravante è indispensabile “individuare un parametro numerico”.
“Se il legislatore ha positivamente determinato la soglia
quantitativa (...) di punibilità (dunque un limite ‘verso il basso’), consegue che l’interprete ha il compito di individuare una
soglia al di sotto della quale, secondo i dati offerti dalla fenomenologia del traffico di sostanze stupefacenti, non possa
parlarsi di ingente quantità (un limite, quindi, ‘verso l’alto’)”.
Naturalmente, questa soglia limite, nel caso dell’aggravante in esame, non può essere individuata unicamente attraverso il sistema tabellare, essendo quest’ultimo parametrato
solo sulle condotte ordinarie di detenzione di sostanze stupefacenti e non anche su quella aggravata dell’ingente quantità;
a tale scopo è necessario avvalersi anche del dato statistico a
disposizione della giurisprudenza di legittimità. Essa, allora,
48 In questo senso si veda C. cost., sentt. n. 247/1989; 34/1995; 69/1999; 5/2004;
395/2005; nonché, da ultimo, C. cost., n. 327/2008, relativa alla controversa
nozione di disastro innominato di cui all’art. 434 c.p.
penale
Gazzetta
82
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
deve essere rinvenuta in un valore ponderale ritenuto “eccezionale” rispetto a tale dato statistico, vale a dire, in un valore che costituisca uno “‘strappo’ a un criterio di (relativa)
regolarità”.
Per individuare questo valore medio delle transazioni di
sostanze stupefacenti, rispetto al quale reputare poi eccezionale quello di ingente quantità, secondo il corretto avviso
della Corte non ci si deve avvalere, però, dei valori ponderali
utilizzati dalla Sezione VI della Cassazione e, cioè, due chilogrammi per le c.d. droghe pesanti, cinquanta chilogrammi per
le c.d. droghe leggere. Questo dato, invero, deve essere calcolato, anziché in termini di peso complessivo della sostanza, in
termini di “dosi-soglia”, individuate sulla base dell’effettiva
quantità di principio attivo riscontrata nella sostanza detenuta. Solo in questo modo è possibile tenere conto dell’effettiva
efficacia drogante della sostanza, in conseguenza del diverso
grado di purezza della stessa ed attribuire così un significato
più preciso alle menzionate indicazioni ponderali49.
È evidente che anche il ricorso al criterio ponderale, ancorato al peso complessivo, non riesce a risolvere quei dubbi
espressi da altra parte della giurisprudenza circa la disomogeneità e mutevolezza delle decisioni relative alla sussistenza o
meno dell’aggravante, ben potendo riscontrarsi casi in cui nei
due chili di sostanze stupefacenti il principio attivo sia inferiore o pari al 50% e casi in cui sia pari o prossimo al 100%.
Ancorando tale criterio ai limiti soglia stabiliti dalle tabelle ministeriali e calibrati sulla quantità di principio attivo,
invece che sul peso complessivo della sostanza stupefacente,
si riesce a superare definitivamente questa impasse e ad impedire che, in sede di applicazione giudiziaria dell’art. 80, comma 2, si registrino palesi violazioni del principio di uguaglianza, a causa della eccessiva indeterminatezza del suo precetto
primario.
Così facendo, come si dirà tra breve, si consente di restituire determinatezza alla disposizione incriminatrice attraverso l’utilizzo di criteri di giudizio concreti, precisi e controllabili, il cui impiego, cioè, non genera disomogeneità applicative, ma, al contrario, è in grado di fissare dei limiti certi attraverso una attività euristica razionale.
Dai dati a disposizione della Corte (dati sicuramente imprecisi se rapportati al fenomeno dello spaccio in generale,
perché calcolati su un mercato illegale, connotato da una
elevatissima cifra oscura, ma pur sempre indicativi se considerati in scala) si può evincere che il valore medio delle transazioni di sostanze stupefacenti consente di individuare in
2000 dosi il quantitativo al di sotto del quale una quantità di
sostanza stupefacente “non può certo ritenersi ‘ingente’”. Per
calcolare il valore di tale quantitativo la Corte, come si è
detto, non si attiene ai dati ponderali generici, bensì utilizza
i criteri forniti dalla tabella ministeriale per determinare la
quantità di principio attivo idonea a costituire una “dose”, ed
individuare così la quantità di “dosi” in concreto confezionabili, tenuto conto della quantità di principio attivo effettivamente rinvenuto nella sostanza.
Attraverso questo ragionamento, le Sezioni unite pervengono allora alla enunciazione di un principio di diritto che, in
realtà, si articola in due distinte e significative affermazioni.
49 In argomento cfr. anche M. Pelazza, “Ingente quantità” di stupefacenti, cit.
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
A loro avviso, infatti, l’aggravante dell’ingente quantità di
sostanze stupefacenti “non è di norma ravvisabile quando la
quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza
nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando
la discrezionale valutazione del giudice del merito, quando
tale quantità sia superata”.
La prima parte di questo enunciato ha una precipua funzione di delimitazione ‘verso il basso’ dell’ambito di operatività dell’aggravante dell’ingente quantità. Essa, cioè, è funzionale ad impedirne l’applicazione a classi di fatti estremamente
eterogenee fra loro, stabilendo che al di sotto di un dato quantitativo, l’aumento di pena preveduto dall’art. 80, comma 2
non può essere mai disposto. Il suo valore è, dunque, di sbarramento in bonam partem per l’imputato, impedendo la configurabilità dell’aggravante in relazione a casi ritenuti non eccezionali, all’esito del risconto con i due combinati parametri
oggettivi del numero delle dosi e del valore massimo di ciascuna, valore com’è noto variabile in base al tipo di sostanza.
La seconda parte, invece, ha una funzione ben diversa,
perché è volta a relativizzare il ruolo ed il valore di questi limiti soglia, individuati in via interpretativa dalla giurisprudenza, ribadendone il carattere meramente orientativo e non
rigoroso.
Le Sezioni unite, infatti, nel momento in cui hanno stabilito che, nell’ipotesi in cui siano superati quei limiti ponderali, l’aggravante non deve essere ritenuta automaticamente
configurata – essendo comunque rimesso l’apprezzamento
circa la sua effettiva sussistenza alla discrezionale valutazione
del giudice di merito – hanno introdotto una interessante
valvola di sfogo, capace di impedire possibili automatismi “in
malam partem”, ogniqualvolta il limite ponderale delle 2000
dosi sia superato.
Una simile soluzione ermeneutica appare in grado (almeno
prima facie) di fronteggiare adeguatamente le contrapposte
obiezioni formulate in passato nei confronti dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Per un verso, infatti, sembra immune da quelle censure
circa la compatibilità con il principio di legalità e di uguaglianza prima ricordate, restituendo determinatezza in via
interpretativa alla locuzione “ingente quantità” e garantendo
uniforme applicazione all’aggravante di cui all’art. 80, comma
2, in perfetta sintonia con il principio di uguaglianza di cui
all’art. 3 Cost.
Per altro verso, risulta impermeabile anche a quelle critiche
di segno opposto, che vedevano nel criterio ponderale un attentato al principio di separazione dei poteri ed un’indebita
ingerenza del giudice in un ambito di competenza esclusiva
del Parlamento. Essa, infatti, sembra non arrivare all’eccesso
di fissare in via interpretativa una soglia di punibilità rigida
che il legislatore, invece, deliberatamente, non ha voluto stabilire per questo tipo di reati, limitandosi a stabilire una soglia
minima al di sotto della quale l’aggravante dell’ingente quantità non può essere applicata. Ciò significa che, nel caso di
superamento della soglia-limite delle 2000 dosi di principio
attivo, il giudice è sempre tenuto a valutare in concreto, sulla
base del restante materiale probatorio a disposizione, se il
quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato sia tale da
doversi considerare ingente ai sensi dell’art. 80, comma 2.
In questo modo, la Suprema Corte pare riuscire a supera-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
re il problema del deficit di determinatezza dell’aggravante in
questione, senza, però, finire, all’opposto, per sollevare quello
della sovrapposizione di poteri tra Parlamento e giudice, determinando uno sconfinamento del potere giudiziario in un
ambito di esclusiva riserva e prerogativa parlamentare, quale
quello della individuazione di una soglia rigida di punibilità
di natura quantitativa-numerica, automaticamente operante.
Essa, infatti, sembrerebbe limitarsi a restituire determinatezza al concetto controverso di “ingente quantità”, tramite
criteri oggettivi e ponderali che consentono di eliminare il
rischio di violazioni del principio di uguaglianza, senza impedire al giudice di merito di escludere ugualmente la sussistenza della circostanza in questione sulla base di altri elementi di fatto della vicenda a sua disposizione.
Ciò pare consentire di superare tutti i diversi dubbi espressi circa la compatibilità di questa imprecisa clausola generale
con il principio del nullum crimen sine lege e con gli altri
principii fondamentali del diritto penale. Ed, infatti, da un
lato, si restituisce alla stessa un grado apprezzabile di accessibilità e prevedibilità per i potenziali destinatari; dall’altro,
non si arriva, però, all’eccesso di determinare una arbitraria
sostituzione del potere giudiziario a quello legislativo nell’attività di selezione del disvalore penale di determinati comportamenti.
Il criterio individuato dalle Sezioni unite sembrerebbe,
quindi, rappresentare il prodotto di una attività ermeneutica
“consentita”, di mera ricognizione di significato di una porzione di fattispecie incriminatrice e del suo ‘tipo crimonoso’
(come espressamente rivendicato dagli stessi giudici di legittimità); di una attività ermeneutica, cioè, che, tramite criteri
attendibili e controllabili, consente alla disposizione legislativa generale ed astratta di divenire norma attagliata al caso
concreto50.
Tuttavia, pur condividendo l’apprezzabile sforzo prodotto
dalle Sezioni unite per l’apprezzabile scopo di eliminare palesi violazioni del principio di uguaglianza, non si può fare a
meno di muovere a tale soluzione qualche rilievo critico.
Se si prova, infatti, a testare la coerenza e la razionalità di
questo criterio diagnostico della sussistenza o meno dell’aggravante in esame, non in maniera atomistica e ‘monadica’,
concentrando l’attenzione solo sulla fattispecie in questione e
sui problemi che essa solleva in sede applicativa, bensì in
maniera articolata e sistematica, attraverso un raffronto di
ampio spettro con le altre fattispecie incriminatrici – quasi
sempre circostanziali – contenenti concetti quantitativi non
numerici, emerge qualche perplessità in proposito.
All’esito di tale confronto, questa opzione ermeneutica,
infatti, perde buona parte della sua vis persuasiva, poiché
emerge chiaramente come essa non individui un criterio generale oggettivo, universalmente valido e, quindi, sempre utilizzabile per dipanare tutti gli altri contrasti interpretativi che
pongono locuzioni letterali di analogo tenore rispetto all’ingente quantità dell’art. 80, comma 2, T.U. n. 309/1990.
Tutt’altro. Essa risulta avere una valenza puramente relativa,
limitandosi a fissare un dato ponderale orientativo, capace di
guidare l’interprete solo ed esclusivamente nel caso specifico
della detenzione di stupefacenti di ingente quantità.
50 D. Castronuovo, Clausole generali, cit., 18.
2 0 1 2
83
Anzi, sembra mettere la Suprema Corte nelle condizioni
di ‘dover’ operare – per ragioni di equità e ragionevolezza –
una medesima valutazione discrezionale di questo tipo anche
negli altri casi dubbi, quali, ad esempio, la detenzione di materiale pedopornografico o il disastro ambientale innominato
o il furto aggravato di ingente valore ecc. Vale a dire, che per
evitare anche in tali sedi analoghe disomogeneità decisionali
si dovrebbe fissare per ogni clausola generale un limite soglia
predeterminato, ad esempio 1000 files con immagini o video;
500.000 euro ecc.
Ma se ciò accadesse sarebbe davvero difficile continuare
a sostenere che questa soluzione non alteri i rapporti tra poteri dello Stato.
Essa, altresì, finisce con il conferire al giudice il potere di
sostituirsi al legislatore nella selezione dei fatti penalmente irrilevanti, attraverso l’individuazione di una soglia limite quantitativa (sebbene operante solo verso il basso) al di sotto della
quale escludere la configurazione della relativa fattispecie.
Insomma, dalla vicenda in questione emerge una amara
conclusione: le clausole generali ed, in particolare, i concetti
quantitativi non numerici, pur essendo talvolta elementi necessari per garantire una maggiore elasticità delle fattispecie
incriminatrici, costituiscono, però, delle minacce tutt’altro
che trascurabili per alcuni dei fondamentali principii garantisti del sistema penale, primo tra tutti quello di precisione e
determinatezza.
penale
Gazzetta
84
D i r i t t o
●
Dialogo tra la Corte Edu
e le Corti nazionali
sul valore
dell’overruling
giurisprudenziale
● Vittorio Sabato Ambrosio
avvocato
e
p r o c e d u r a
Gazzetta
p e n a l e
F O R E N S E
Corte Edu: (Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29, Raccolta 1996 V; S.W. c. Regno Unito, § 35, 22 novembre 1995;
Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, §§ 40-41, serie A no
260 A)
I Contrasti tra la Corte Edu e le Corti Nazionali
Sulla nozione allargata del concetto di legge
La nozione di «diritto» («law») utilizzata nell’articolo 7
corrisponde a quella di «legge» che compare in altri articoli
della Convenzione; essa comprende il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale e implica delle condizioni qualitative, tra le quali quelle dell’accessibilità e della prevedibilità.
Tribunale di Torino terza sezione penale ordinanza di sospensione del
procedimento e di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale:
Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale, nei termini
di cui in motivazione, dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non
prevede l’ipotesi di revoca della sentenza di condanna [o di
decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della
pena su concorde richiesta delle parti] in caso di mutamento
giurisprudenziale - intervenuto con decisione delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione - in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge penale come reato, per contrasto
con l’art. 117 Costituzione, in relazione all’art. 7 CEDU (come
interprato dalla Corte EDU) e agli art. 5 e 6 CEDU; con l’art.
3 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 610, comma
2, 618 c.p.p., 172 disp.att.c.p.p. ed all’art. 65 Regio Decreto
30.01.1941, n. 12 (ordinamento giudiziario); con l’art. 13 della
Costituzione; con l’art. 25 della Costituzione; con l’art. 27,
comma 3, della Costituzione.
Corte costituzionale, sentenza 12 ottobre 2012 n. 230
La Corte Costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità, escludendo valore normativo al mutamento del diritto vivente
L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite
“aspira” indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma – come lo stesso rimettente riconosce – si tratta di connotati solo «tendenziali», in quanto basati su una efficacia non
cogente, ma di tipo essenzialmente “persuasivo”. Con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di
essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice
della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione;
mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere
le loro posizioni, anche su impulso delle sezioni singole, come
in più occasioni è in fatto accaduto.
***
SOMMARIO: Premessa; 1. La giurisprudenza della Corte
Edu sul concetto di legge; 2. La tesi sostenuta dal Tribunale di
Torino e i problemi che essa pone in rapporto con la cd successione mediata; 3. La risposta della Corte costituzionale; 4.
Brevi considerazioni conclusive
Premessa
L’osmosi dei concitati rapporti tra la Corte Edu e le corti
interne invera, oggi più che mai, la nascita di complicati contra-
n o v e m b r e • d i c e m b r e
sti idonei a mettere in discussione principi fondamentali dell’ordinamento interno in favore di un ordinamento sovranazionale che condiziona, con continue ingerenze, le tutele riconosciute al cittadino.
Tra le principali questioni al centro di un vivace ed attuale
dibattito si pone la tematica del valore da attribuire al cd. overruling giurisprudenziale, ovvero se il mutamento del diritto
vivente, avvenuto tramite un revirement delle Sezioni unite
della Corte di Cassazione, abbia un’efficacia normativa diretta
a consentire un’abolitio criminis e se esso possa comportare una
revoca del giudicato penale di condanna.
La Corte Edu, la giurisprudenza di merito del Tribunale di
Torino e la Corte costituzionale si confrontano su tale problematica questione che tocca i cardini fondamentali sui quali
poggia la strutturazione garantista del nostro sistema penale
costituzionalmente orientato.
In particolare, la tematica che ci occupa rischia di rivoluzionare la stabile differenza tra gli ordinamenti di civil law e
common law riconoscendo valore di legge ai mutamenti giurisprudenziali ad opera delle Sezioni Unite.
È evidente che la risoluzione della problematica si centralizza attorno alla cogenza della riserva di legge, nell’accezione
recepita dall’art. 25, secondo comma, Cost.; principio che, secondo quanto reiteratamente puntualizzato dalla dottrina e
della giurisprudenza, demanda il potere di normazione in materia penale – in quanto incidente sui diritti fondamentali
dell’individuo, e segnatamente sulla libertà personale – all’istituzione che costituisce la massima espressione della rappresentanza politica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio
universale dall’intera collettività nazionale (Corte Cost. n. 394
del 2006 e n. 487 del 1989), il quale esprime, altresì, le sue
determinazioni all’esito di un procedimento – quello legislativo
– che implica un preventivo confronto dialettico tra tutte le
forze politiche, incluse quelle di minoranza, e, sia pure indirettamente, con la pubblica opinione.
1. La giurisprudenza della Corte Edu sul concetto di legge
La rilevanza normativa del diritto vivente nasce, in ottica
sovranazionale, dall’interpretazione estensiva dell’art. 7 Convenzione Edu, la quale ha mostrato sempre di volere aderire ad
un sistema di legalità sostanziale.
Nello specifico, la nozione “diritto” contenuta nell’art. 7
ingloba nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, riconoscendo al giudice un ruolo fondamentale nell’individuazione
dell’esatta portata della norma penale, il cui significato è reso
esplicito dalla combinazione di due dati, quello legislativo e
quello interpretativo.
Tale visione sostanziale del principio di legalità si confronta, peraltro, secondo la corte di Strasburgo, con particolari
condizioni qualitative, quali l’accessibilità della norma penale
e la ragionevole prevedibilità delle sue conseguenze. La Corte
di Strasburgo, dopo aver ribadito i principi consolidati in merito alla nozione di diritto, ha affermato che:“a causa del carattere generale delle leggi, il testo di queste… non può presentare una precisione assoluta”, posto che si serve di “formule più
o meno vaghe la cui interpretazione e applicazione dipendono
dalla pratica; pertanto, in qualsiasi ordinamento giuridico, per
quanto chiaro possa essere il testo di una disposizione di legge,
ivi compresa una disposizione di diritto penale, esiste inevita-
2 0 1 2
85
bilmente un elemento di interpretazione giudiziaria….; del
resto, è solidamente stabilito nella tradizione giuridica degli
stati parte della convenzione che la giurisprudenza contribuisce necessariamente all’evoluzione progressiva del diritto penale” (Corte EDU, Grande Camera, 24 aprile 1990, Kruslin c.
Francia., Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. c. Italia;
Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c.
Italia; Corte EDU, 8 dicembre 2009, Previti c. Italia).
Si può quindi affermare che il processo di conoscenza della
norma presuppone una relazione di tipo concorrenziale tra
potere legislativo e potere giudiziario, con la conseguenza che
gli elementi qualitativi dell’accessibilità e della prevedibilità di
cui parla la Corte si riferiscono non tanto all’astratta previsione
legale quanto alla norma “vivente”, risultante dall’applicazione
e interpretazione dei giudici.
Si specifica che la tesi della legalità sostanziale è stata sempre adottata dalla Corte per una precipua esigenza di globalizzazione/armonizzazione dei peculiari sistemi ordinamentali che
compongo il ricco e variegato universo della cd. Grande Europa, con lo specifico intento di limare le differenza tra gli stati
Civil law, storicamente fedeli ad un regima di legalità formale,
e stati Commow law, devoti all’integrazione del dato giurisprudenziale al dato normativo.
Infatti, in tale prospettiva si rinviene il ruolo centrale della
giurisprudenza della Corte EDU mirante ad estendere il contenuto dei precetti della convenzione onde garantire una protezione dinamica ed evolutiva dei diritti contenuti nella Convenzione conforme alle esigenze sociali moderne.
Ne consegue che, al sistema delineato dalla Cedu osta il
principio della riserva di legge in cui ad una base formalmente
legislativa corrisponde una giurisprudenza incerta o oscillante.
Invero, se la ratio della riserva di legge è anche quella di assicurare la prevedibilità dell’esito (quindi il fatto deve essere ben
chiaro e fissato dal legislatore), è chiaro che un’evoluzione ermeneutica oltremodo oscillante ed incerta della norma non è
evidentemente in linea con la ratio della riserva di legge, perché
quella legge non è prevedibile nei suoi esiti applicativi, non è
accessibile nel suo contenuto sostanziale, avendo una applicazione giurisprudenziale incerta ed imprevedibile.
2. La tesi sostenuta dal Tribunale di Torino e i problemi che essa
pone in rapporto con la cd successione mediata
Sono queste le principali coordinate che ispirano l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del Tribunale di Torino.
L’ordinanza è occasionata da una presunta illegittimità
costituzionale dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non prevede
la revoca della sentenza di condanna passata in giudicato (e
delle pronunce ad essa assimilate) anche nel caso di «mutamento giurisprudenziale» determinato da una decisione delle Sezioni unite, in base al quale il fatto già giudicato non è più considerato come reato.
I giudici torinesi optano per una ricostruzione amplia della
formula “nuovo elemento di diritto”, contenuta nell’art. 673
c.p.p., tesa a far rientrare nel proprio contenuto i mutamenti
giurisprudenziali ad opera delle Sezioni unite della Cassazione
che fungono da revirement idoneo a sconfessare il precedente
orientamento nomofilattico.
Il compiuto apparato motivazionale dell’ordinanza richiama
i precedenti giurisprudenziali sia in materia di revoca del giudi-
penale
F O R E N S E
penale
Gazzetta
86
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
cato cautelare che in tema di giudicato esecutivo, i quali, invocando la nozione di legalità sostanziale desumibile dalla
Cedu, arrivano alle seguenti conclusioni: “il mutamento di
giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite
della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di
diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva,
della richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata. La Corte ha precisato che tale soluzione è imposta
dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il cui art. 7, come interpretato
dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale…..“il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integra un nuovo elemento idoneo a legittimare la riproposizione della richiesta di revoca di sequestro preventivo
già rigettata con provvedimento non più suscettibile di gravame” (Cass. Pen., sez. un., sentenza n. 18288 del 21/01/2010,
Cass. Pen. sez. 2, sentenza n. 19716 del 06/05/2010).
Sulla base di queste valutazioni il giudice rimettente propende per un’applicazione estensiva di tali principi in tema di
abolizione del reato asserendo che una revoca della sentenza
è ammissibile anche nelle ipotesi in cui l’abolitio criminis
avviene mediante un overrulinggiurisprudenziale teso ad
emendare la precedente linea giurisprudenziale, in quanto
ritenuta frutto di una non corretta applicazione dei canoni
dell’ermeneutica giurisprudenziale.
Si tende, mediante tale lettura evolutiva, a minare l’imperatività del principio di intangibilità del giudicato, con l’effetto di far rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 2
comma 2 del codice penale anche la mera modifica del diritto
vivente che, reinterpretando la norma incriminatrice, esclude
la rilevanza penale di una determinata condotta che un filone
giurisprudenziale precedente sussumeva nella tipizzazione di
una fattispecie incriminatrice legislativamente prevista.
L’affermazione di una tale tendenza avrebbe avuto un
impatto dirompente anche in merito al fenomeno della successione delle leggi penali, con riferimento soprattutto alla
discussa rilevanza della cd. successione mediata, regolativa di
quelle situazioniin cui viene sottoposta a modifica non direttamente la norma penale incriminatrice, bensì il contenuto
di una norma extrapenale integratrice del precetto criminale,
con conseguente attivazione del complesso meccanismo della
successione delle leggi penali nel tempo anche per quelle interpretazioni correttive della norma penale volte ad elidere la
rilevanza penale di alcune condotte.
Una diffusa teoretica dottrinale e giurisprudenziale aveva
affermato che il mero mutamento di norme giuridiche dell’ordinamento generale direttamente richiamate da norme penali comportava una modifica normativa idonea ad inverare un
fenomeno successorio, il quale, a seconda delle ipotesi, dava
la stura o ad un’abolitio criminis (ex art. 2 comma 2 c.p.)
derogativa l’intangibilità del giudicato o ad una mera modificazione legislativa (ex art. 2 comma 4 c.p.) con l’applicazione,
al solo caso concreto, della legge penale più favorevole limitata però nella sua operatività dal giudicato penale. Siffatta
tesi sosteneva che l’estensione del fenomeno della successione
mediata è suffragata dal dato testuale dell’art. 2 c.p. che, pur
se intitolato “successione di leggi penali”, descrive il suddet-
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
to fenomeno in modo asettico, parlando genericamente di
“legge”. Infatti, usando le parole delle Sezioni unite Penali in
materia: “per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del
fatto”(Cassazione Penale, sentenza 23 maggio 1987).
Ne consegue che, seguendo tale opzione interpretativa,
ogni minimo mutamento di elementi che integrano la legge
penale - sia che riguardino modifiche della legge extrapenale
integratrice, sia che si rivelino frutto di una cambiamento del
diritto vivente teso ad escludere dall’ambito interpretativo del
precetto la rilevanza di alcune condotte penalmente rilevanti
- implicherebbe l’operatività dei principi di cui all’art. 2 c.p.
con tutte le conseguenze che si pongono in tema di intervento
del giudicato di condanna, il quale può essere travolto soltanto da un’abolitio criminis, giammai da un’abrogatio sine
abolitio.
Con riferimento alla possibilità di attribuire efficacia
normativa ad un mutamento giurisprudenziale idoneo a dar
vita ad una successione di leggi penali del tempo si registra
un datato precedente giurisprudenziale relativo alla qualifica
di incaricato di pubblico servizio per i dipendenti degli istituti bancari, in relazione alla possibilità per questi ultimi di
commettere delitti contro la P.A.
In particolare, il richiamo alla problematica della natura
giuridica del rapporto di lavoro degli impiegati degli istituti
creditizi ci permette di rinvenire precedenti giurisprudenziali
delle Sezioni Unite che, attribuendo quasi una vis normativa
alle proprie posizioni, in un primo momento hanno interpretativamente esteso la qualifica di incaricato di pubblico di
servizio a tali soggetti (Cassazione Penale, 10 ottobre 1981-19
novembre 1981, Carfì), mentre in un successivo momento
hanno escluso l’applicazione di una tale qualifica identificando come privata la natura di tale attività lavorativa (Cassazione Penale, 23 maggio 1987 - 16 luglio 1987, Tuzet).
È chiaro che un’applicazione della successione mediata
cosi totalizzante tesa a includere nei perversi meccanismi
dell’art. 2 c.p. tutte le trasformazioni, extrapenali e giurisprudenziali, dei precetti che puniscono i fatti oggetto di una
inabdicabile esigenza preventiva dei fenomeni criminosi,
avrebbe comportato delle conseguenze impensabili generative
di un diritto penale sostanziale sottoposto agli arbitrii del
potere giudiziario, atto a creare un vulnus dei diritti costituzionalmente garantiti e delle esigenze di prevedibilità e accessibilità delle conseguenze penali sfavorevoli.
Da quanto riportato pare che un problema relativo al
mutamento del diritto vivente si era già posto negli ormai
lontani anni ‘80.
Va specificato che a porre un freno all’estensione a dismisura delle modifiche delle norme penali sono intervenute ancora una volta le Sezioni Unite Penali che, in tema di successione, hanno icasticamente affermato che: “L’indagine sugli
effetti penali della successione di leggi extrapenali va condotta facendo riferimento alla fattispecie astratta e non al fatto
concreto: non basta riconoscere che oggi il fatto commesso
dall’imputato non costituirebbe più reato, ma occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se la norma extrapenale modificata svolga in collegamento con la disposizione incriminatrice un ruolo tale da far ritenere che, pur essendo
questa rimasta letteralmente immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extrape-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
nale sia cambiata e in parte non sia più prevista come reato”
(Cassazione penale, sez. unite, 16 gennaio 2008, n. 2451).
3. La risposta della Corte costituzionale
In questo scenario si inserisce la recentissima sentenza
della Corte Costituzionale del 12 ottobre 2012 n. 230 che,
mediante un’adamantina operazione ermeneutica, sconfessa
il valore di legge dei mutamenti giurisprudenziali determinati da un overruling delle Sezioni unite.
Nelle corposa motivazione di infondatezza della questione
di costituzionalità la Corte innanzitutto sostiene che la Corte
Strasburgo non dà nessuna rilevanza alle modifiche del diritto vivente.
In particolare, il giudice delle leggi osserva che: “La stessa Corte di Strasburgo ha avuto modo, del resto, di rilevare,
in termini generali, come, nel caso di avvenuta composizione
di un contrasto di giurisprudenza da parte di un tribunale
supremo nazionale, l’esigenza di assicurare la parità di trattamento non possa essere utilmente invocata al fine di travolgere il principio di intangibilità della res iudicata: infatti,
intendere il principio di eguaglianza nell’applicazione della
legge nel senso che ciò che risulta dalle decisioni posteriori
implica la revisione di tutte le decisioni definitive anteriori
che risultino contraddittorie con quelle più recenti sarebbe
contrario al principio di sicurezza giuridica” (Corte europea
dei diritti dell’uomo, 28 giugno 2007, Perez Arias contro
Spagna, sempre nella misura in cui i principi interpretativi
siano applicabili al nostro ordinamento).
Dipoi la Corte Costituzionale passa più propriamente a
confutare la tesi sostenuta dal Tribunale di Torino nell’ordinanza di rimessione, sulla base del rilievo che, nel nostro ordinamento, a differenza degli stati di common law, non
opera il principio dello stare decisis. All’uopo si interroga sul
valore che ha nel nostro sistema l’orientamento espresso da
una decisione delle Sezioni Unite, affermando che esso “aspira indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito:
ma – come lo stesso rimettente riconosce – si tratta di connotati solo «tendenziali», in quanto basati su una efficacia
non cogente, ma di tipo essenzialmente “persuasivo”. Con la
conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della
declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione
dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque
giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata
motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi
a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle
sezioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto”.
È proprio questo il passaggio fondamentale risolutivo
della questione di costituzionalità, in quanto sulla base di
tali rilievi si esclude che un semplice revirement giurisprudenziale possa travolgere l’intangibilità della res iudicata, pena
la violazione dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici
esauriti tanto agognata dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea (Corte di giustizia, sentenze 22 dicembre 2010,
C-507/08, Commissione contro Repubblica slovacca; 3 settembre 2009, C-2/08, Fallimento Olimpiclub s.r.l.; 16 marzo
2006, C-234/04, Kapferer).
Per completezza il giudice delle leggi effettua una lungimirante analisi di quello che potrebbe accadere nel caso in cui
si ampliasse la revoca del giudicato penale di condanna ex art.
2 0 1 2
87
673 c.p.p. anche in presenza di un’abolitio criminis avvenuta
ad opera di una rinnovata interpretazione delle Sezioni unite
che privano di rilevanza penale una condotta fino ad allora
fatta rientrare nell’ambito applicativo di una determinata
fattispecie di reato. Opinando in tal senso la Corte rileva che:
“la richiesta pronuncia additiva comporterebbe una vera e
propria sovversione “di sistema”, venendo a creare un generale rapporto di gerarchia tra le Sezioni unite e i giudici
dell’esecuzione, al di fuori del giudizio di rinvio: con risultati, peraltro, marcatamente disarmonici, stante la estraneità
della regola dello stare decisis alle coordinate generali dell’ordinamento. In sede esecutiva, il giudice sarebbe tenuto, infatti, ad uniformarsi alla decisione “favorevole” delle Sezioni unite, revocando il giudicato di condanna. Di contro, il
giudice della cognizione, il quale si trovasse a giudicare ex
novo un fatto analogo, non avrebbe il medesimo obbligo, e
potrebbe quindi disattendere – sia pure sulla base di adeguata motivazione – la soluzione adottata dall’organo della nomofilachia (provocando eventualmente, con ciò, un nuovo
mutamento di giurisprudenza)”.
Sulla base di queste coordinate argomentative la Corte
Costituzionale rinviene nella tesi della rilevanza normativa
del mutamento del diritto vivente una palese violazione (rectius: eversione) della ratio del principio della riserva di legge
ex art 25 Cost.
Infatti, il valore normativo dell’overruling, pregiudicherebbe le più elementari garanzie che uno Stato Liberale deve
assicurare al proprio cittadino, dovendo quest’ultimo essere
sottoposto solo alla legge promulgata dall’organo legislativo
democraticamente eletto, con espressa esclusione di un incontrollabile potere di creazione giudiziaria elusivo della libertà
di autodeterminazione e della calcolabilità delle conseguenze
delle proprie condotte.
4. Brevi considerazioni conclusive
La sentenza della Corte Costituzionale mina l’effetto a
cascata che può avere nel nostro ordinamento l’orientamento
della Corte Edu che considera legge anche il diritto di derivazione giurisprudenziale.
In realtà, tale affermazione è coerente ma va limitata solo
ed esclusivamente al sistema creato dalla Convenzione Eduche
ha l’esigenza di estendere i propri scarni precetti mediante
l’opera interpretativa della giurisprudenza della Corte che si
candida ad essere giudice del caso concreto.
La Corte Costituzionale, di contro, con argomentazioni
insuperabili che si fondano su considerazioni di teoria generale del diritto e su inderogabili norme di rango legislativo e
costituzionale, chiude perentoriamente il varco alla possibilità di attribuire valore normativo alle variazioni del diritto
vivente ad opera delle Sezioni unite, considerando le pericolose conseguenze che potrebbe creare in tema di successione
di leggi penali nel tempo ed in materia di revoca del giudicato
penale di condanna.
È evidente che ammettere il valore normativo dell’overruling avrebbe significato arrecare un vulnus ad indiscutibili
principi fondamentali sui quali si fonda la nostra civiltà giuridica, sia con riferimento al principio di legalità formale
tendenzialmente assoluta con tutti i suoi corollari, sia al principio dell’intangibilità del giudicato al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
penale
Gazzetta
88
D i r i t t o
●
p r o c e d u r a
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni unite penali, sentenza 20
novembre 2012 (ud. 19 luglio 2012), n. 45246
I contrasti risolti
dalle Sezioni unite
penali
●
e
A cura di Angelo Pignatelli
Avvocato
Misure cautelari personali - Contestazione a catena
la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia
cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame solo se
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se per effetto della retrodata zione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento caute- lare;
b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare
***
La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso
alle Sezioni unite è la seguente «Se, nel caso di contestazione a
catena, la questione della retrodatazione della decorrenza del
termine di custodia cautelare possa essere dedotta nel procedimento di riesame oppure soltanto con l’istanza di revoca ex art.
299 c.p.p.».
Un primo prevalente orientamento afferma che l’imputato o
l’indagato in stato di custodia cautelare, nei cui confronti siano
stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale, che assuma la sussistenza di un’ipotesi di cosiddetta contestazione a catena e, conseguentemente, del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, deve presentare apposita istanza
di scarcerazione al giudice che ha la disponibilità del procedimento e, in caso di rifiuto, può impugnare con appello al Tribunale indicato nell’art. 309 c.p.p., comma 7, il provvedimento, ma
non può impugnare direttamente davanti al Tribunale l’ulteriore ordinanza impositiva della misura cautelare ai sensi dell’art.
309 c.p.p., poiché la cosiddetta contestazione a catena non incide sul provvedimento in sé ma soltanto sulla decorrenza e sul
computo dei termini di custodia cautelare (sez. 1, n. 1785 del 15
aprile 1991, Falanga, Rv. 187387; sez. 1, n. 1184 del 10 marzo
94, Annis, Rv. 197209; sez 1, n. 4776 del 09 luglio 1997, Surino,
Rv. 208503; sez. 6, n. 833 del 05 marzo 99, Gozzi, Rv. 213682;
sez. 6, n. 31497 del 22 maggio 2003, Dzmaili, Rv. 226286; sez.
1, n. 19905 del 4 marzo 04, Russo, Rv. 228053; sez. 2, n. 41044
del 13 ottobre 2005, Guttadauro, Rv.232697; sez. 1, n. 35113
del 13 luglio 2007, Chiodo, Rv. 237632; sez. 2, n. 35605 del 27
giugno 2007, Crisafulli, Rv. 237991; sez. 6, n. 10325 del 23
gennaio 2008, Zecchetti, Rv. 239016).
Un secondo diverso orientamento, che trae origine da una
sentenza della sez. 3 n. 9946 del 09 febbraio 10, Chiaravalloti,
Rv. 246237, in un caso in cui non risultava che l’indagato avesse
dedotto davanti al Tribunale del riesame la questione della retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297c.p.p.,
questione che era stata proposta con il ricorso per cassazione;
ciò nonostante, la Corte ha ritenuto che il Tribunale fosse tenuto a rilevare d’ufficio la retrodatazione ove ne ricorressero i
presupposti, poiché l’indagato aveva prospettato l’insussistenza
delle esigenze cautelari e ciò determinava l’obbligo di pronunciarsi al riguardo: «atteso che: - comunque era stata chiesta la
revoca della misura, e se essa fosse estinta per decorrenza dei
termini di durata massima ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a),
n. 3, ciò prevarrebbe sulla sussistenza o meno delle esigenze
cautelari; - ritenendo il contrario e non applicando tale principio
sussisterebbe in caso di decorrenza di detti termini l’ingiusta
carcerazione dell’inquisito; - tale argomento assorbe quello rela-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
tivo all’avvenuta o meno deduzione sull’applicazione della retrodatazione».
Al fine di risolvere la questione le sez.un. hanno ripercosso
lo sviluppo della giurisprudenza sul tema dei rapporti tra procedimento di riesame e procedimento di revoca dell’ordinanza
cautelare, oggetto di plurimi e complessi interventi delle Sezioni
unite volte a tracciare la linea di confine tra le questione devolute alla cognizione del giudice dell’impugnazione e quelle affidate alle decisioni del giudice del procedimento principale.
Dalla lettura di tutte le sentenze delle Sezioni unite ripercorse nell’ambito della complessa motivazione a cui si rimanda, è
risultato evidente che i casi presi in considerazione per affermare la competenza del giudice del procedimento principale sono
sempre quelli di “eventi caducatori sopravvenuti”, ad eccezione
di quelli che si verificano nell’ambito della stessa procedura
incidentale di impugnazione.
Conclusivamente il Supremo Collegio ha statuito il seguente principio di diritto: «Nel caso di contestazione a catena, la
questione della retrodatazione della decorrenza del termine di
custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame
solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare;
b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare».
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni unite penali, sentenza 24
ottobre 2012 (ud. 19 luglio 2012) n.41461
Rito abbreviato condizionato
L’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in
cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli
non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte.
***
La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni unite aveva
ad oggetto il seguente quesito: «se l’ordinanza di ammissione al
giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria sia
revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e
sopraggiunte».
I Supremi Giudici evidenziavano che rispetto alla problematica sottoposta al loro scrutinio non si registrava un vero contrasto interpretativo.
Invero, affermano le Sezioni unite con indirizzo esegetico
univoco che la sopravvenuta impossibilità di assunzione dell’integrazione probatoria, cui l’imputato abbia subordinato la richiesta di accesso al rito abbreviato condizionato, non incida
sulla sua corretta instaurazione e sulla sua celebrazione, in
quanto, alla luce delle regole generali che disciplinano l’istituto,
non è configurabile un diritto dell’imputato ad ottenere, in
questo caso, la retrocessione del giudizio né, tanto meno, un
potere del giudice di disporla (sez. 1, n. 13544 del 22 gennaio
2009, Xie, Rv. 243130; sez. 2, n. 15117 del 02 aprile 2007,
Polverino, Rv. 236391; sez. 5, n. 40580 del 23 settembre 2002,
Einaudi, Rv. 222970). Tale approdo ermeneutico muove dall’implicito presupposto che il vincolo discendente dalla condizione
2 0 1 2
89
posta dall’imputato con la richiesta di accesso al giudizio abbreviato riguardi l’ammissione dell’integrazione probatoria invocata, ma che, una volta disposto il rito con la condizione chiesta
dall’imputato, non possa configurarsi una sorta di retroattiva
perdita di efficacia dell’atto d’impulso qualora la prova non
venga concretamente assunta per cause indipendenti dalla volontà del giudice. Tale premessa generale viene desunta, in primo
luogo, dall’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art.
438, comma 5, e art. 441 bis c.p.p.
Nell’ambito di questi principi generali, si tratta di stabilire
– secondo i Giudici Ermellini - se fatti imprevedibili e sopravvenuti alla introduzione del rito esplichino una qualche influenza
sui presupposti costituenti l’oggetto della condizione dedotta
dall’imputato per accedervi e sulla verifica effettuata dal giudice per ammetterlo.
La risposta data dal Supremo Collegio è stata negativa.
Invero, secondo l’interpretazione letterale dell’art. 438 c.p.p.
comma 5, il vincolo di subordinazione insito nella domanda
avanzata dall’imputato e oggetto della delibazione giudiziale
attiene all’ammissione della integrazione probatoria e non alla
effettiva assunzione delle ulteriori acquisizioni probatorie.
Di conseguenza il vincolo di subordinazione insito nella richiesta dell’imputato deve ritenersi utilmente assolto con l’instaurazione del rito e l’ammissione delle prove sollecitate dalla
difesa; il relativo atto di impulso processuale non può essere
influenzato dalle vicende correlate al distinto e successivo momento della effettiva assunzione della prova - che può essere
influenzata da diversi fattori - e non può subire una retroattiva
perdita di efficacia quando, per qualunque motivo, la prova non
venga concretamente assunta.
Sotto questo aspetto, l’impossibilità di revocare l’ordinanza
ammissiva del giudizio abbreviato, qualora l’integrazione probatoria cui è stata subordinata la domanda si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopravvenute, non si pone
in conflitto neppure, sotto un profilo logico-sistematico, con la
pregressa valutazione di necessità ai fini della decisione compiuta dal giudice nell’ambito dell’ordinanza che ammette il rito.
L’ostacolo obiettivo all’acquisizione della prova opera, infatti, in ugual misura per il giudice dinanzi al quale si celebra il
rito abbreviato e per quello del dibattimento dinanzi al quale ammettendo la revocabilità dell’ordinanza introduttiva del rito
in caso di impossibilità sopravvenuta dell’acquisizione probatoria per fattori imprevedibili - il giudizio dovrebbe svolgersi.
Pertanto, l’eventuale retrocessione del processo, oltre a non
porre rimedio a tale situazione, secondo il Collegio, provocherebbe un’ingiustificata e irrazionale dilatazione dei tempi di
definizione del processo che non sarebbe giustificata da maggiori garanzie dell’imputato.
A sua volta, la Corte Costituzionale, conferma l’indirizzo
esegetico delle Sezioni unite laddove pur non essendosi espressamente pronunciata sulla revocabilità del giudizio abbreviato,
ha, però, affermato l’irrilevanza della sopravvenuta impossibilità “soggettiva” di assunzione della prova dedotta in condizione all’atto della richiesta del rito, ritenendo implicitamente come
tale impossibilità non pregiudichi la sua prosecuzione e l’utilizzabilità ai fini della decisione di tutti gli atti in precedenza acquisiti ed integranti quello “stato degli atti” accettato dall’imputato nel momento in cui ha aderito al giudizio speciale.
Sembra, dunque, potersi dedurre che anche per il Giudice
delle Leggi la modalità di innesco del rito abbreviato descritta
penale
Gazzetta
90
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
nell’art. 438 c.p.p., comma 5, debba essere interpretata nel
senso che la condizione apposta dall’imputato riguardi esclusivamente l’ammissione dell’integrazione probatoria richiesta,
senza estendersi all’effettiva assunzione della medesima, qualora ciò non risulti possibile (giuridicamente o materialmente) per
vicende sopravvenute e indipendenti dalla volontà del giudice.
(Corte Cost., ord. n. 326 del 2001).
La soluzione interpretativa accolta dal Collegio si armonizza anche con i principi espressi dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo che, pur non affrontando ex professo la questione,
ha affermato la complessiva compatibilità della disciplina contenuta negli artt. 438 e ss. c.p.p. con la Convenzione.
La domanda di accesso al giudizio abbreviato rappresenta,
l’espressione di una scelta consapevole e ponderata caratterizzata dalla volontaria accettazione della riduzione delle garanzie
conseguente all’adesione al rito speciale in cambio di una consistente riduzione della pena in caso di condanna: “l’istante,
assistito da due difensori di fiducia, è stato indubitabilmente in
grado di rendersi conto delle conseguenze della sua richiesta di
adozione della procedura abbreviata” (Corte EDU 18/10/2006,
Hermi c. Italia, p. 78).
Sulla base di tutte le considerazioni sinora brevemente riassunte la Cassazione a Sezioni unite ha formulato il seguente
principio di diritto: «l’ordinanza di ammissione al giudizio
abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato
subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte».
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni unite penali, sentenza
07 dicembre 2012 (ud. 27-11-2012), n. 47604
Pubblicità finalizzata alla vendita dei semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti
La offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni
botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato
dell’art. 82, cit. T.U. stup., salva la possibilità di sussistenza dei
presupposti per configurare il delitto previsto dall’art. 414 c.p.
con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di
sostanze stupefacenti
***
La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni unite è la
seguente: «Se integra il reato di istigazione all’uso di sostanze
stupefacenti la pubblicizzazione e la messa in vendita di semi di
piante idonee a produrre dette sostanze con la indicazione
delle modalità di coltivazione e della resa».
Un primo orientamento interpreta l’art. 82, comma 1, cit.
T.U. stupefacenti nel senso che la condotta istigatoria in esso
delineata comprende l’attività di pubblicizzazione di semi di
piante idonee a produrre sostanze stupefacenti con precisazioni
sulla coltivazione delle stesse. L’argomentazione posta alla base
della conclusione si incentra nel rilievo che, anche in mancanza
di pubblicità volta ad esaltare la qualità del prodotto e l’uso
dello stupefacente che si ricava dalle piante, la normale finalità
della coltivazione è l’ottenimento e l’utilizzo della droga. Sussiste, pertanto, una interconnessione tra pubblicizzazione di semi,
coltivazione degli stessi e utilizzo di sostanze stupefacenti. (sez.
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
4, n. 26430 del 20 maggio 2009, Pesce, Rv. 244503; sez. 4 n.
23903 del 20 maggio 09 Malerba Rv. 244222; sez. 4, n. 2291
del 23 marzo2004, D’Angelo, Rv. 228788; conforme alle ricordate decisioni è quella della sez. 4, n. 15083 del 08 aprile 2010,
Gracis. Ad analogo risultato pervengono altre due decisioni:
sez. 6, n. 38633 del 24 settembre 2009, Barsotti, Rv. 244559;
sez. 5, n. 16041 del 05 marzo 2001, Gobbi, Rv. 218484).
Un secondo orientamento, movendo dal principio giurisprudenziale secondo il quale la vendita di semi di piante dai quali
sono ricavabili sostanze stupefacenti non costituisce reato perché riconducibile agli atti preparatori privi di potenzialità
causale rispetto alle attività vietate.
Alla luce di tale principio, la sentenza interpreta il rapporto
tra la fattispecie penale dell’art. 82, comma 1, riferita a chi
pubblicamente istiga all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e l’illecito amministrativo, di cui al successivo art. 84,
concernente la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall’art. 14. In particolare, rileva che la condotta dell’art. 84 non possa consistere in
un propaganda finalizzata alla vendita, ma semplicemente in
un’opera di diffusione senza induzione all’acquisto; nella condotta dell’art. 82, invece, si riscontra un qualcosa di aggiuntivo
che spinge all’uso del prodotto da parte del destinatario della
propaganda.
Ne consegue che, nei casi in cui la pubblicità si soffermi
solo sulla illustrazione delle caratteristiche delle piante che
nascono dai semi e sulle modalità della loro coltiva- zione, il
reato dell’art. 82 non può ritenersi sussistente perché l’azione
non è idonea a suscitare consensi ed a provocare il concreto
pericolo dell’uso di stupefacenti da parte dei destinatari del
messaggio. (sez. 4, n. 6972 del 17 gennaio 2012, Bargelli,
Rv.251953).
Così delineato il contrasto interpretativo, le Sezioni unite
hanno premesso che qualsiasi tipo di inserzione pubblicitaria
avente ad oggetto sostanze stupefacenti deve essere oggetto di
divieto per effetto dell’art. 10, comma 2, della Convenzione
adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 25 marzo 1981 n. 385: obbligo assolto nel
nostro ordinamento con l’art. 84 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Hanno altresì precisato i Supremi Giudici che non è possibile equiparare la nozione di stupefacente a quella di pianta
dalla quale, con determinati procedimenti chimici neppure
menzionati nella pubblicità, è ricavabile una sostanza drogante
che, allo stato naturale, è compresa nelle tabelle; una simile
esegesi non rientra nel novero di una plausibile interpretazione
estensiva perché travalica l’ambito dei possibili significati letterali, sia pure amplificati all’estremo, del termine stupefacente e
dilata il fatto tipico integrandolo con una ipotesi non espressamente inclusa con palese violazione del principio di tassatività
e del divieto di analogia nel diritto penale.
Dopo aver eseguito il corretto discrimine tra le ipotesi di cui
all’art. 82 e 84 del testo Unico sugli stupefacenti e illustrata la
corretta esegesi del delitto previsto dall’art. 414 c.p. le Sezioni
unite hanno indicato il principio di diritto al quale la Corte di
appello, in sede di rinvio, si dovrà conformare: «La offerta in
vendita di semi di piante dalle quali è ricavatole una sostanza
drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltiva- zione delle stesse, non integra il reato dell’art. 82, cit. T.U.
stupefacenti, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti
per configurare il delitto previsto dall’art. 414 c.p. con riferi-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
●
Rassegna di legittimità
●
A cura di Alessandro Jazzetti
Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Napoli
e
Andrea Alberico
Dottore di Ricerca in Diritto Penale
Avvocato
2 0 1 2
91
Atti processuali – Documentazione degli atti – Verbale - Nullità Incertezza assoluta sulle persone intervenute - Presupposti
In tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistere incertezza assoluta sulle persone intervenute è necessario
che l’identità del soggetto partecipante all’atto non solo non
sia documentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili.
Cass., sez. un., sentenza 19 luglio 2012, n. 41461
(dep. 24 ottobre 2012) Rv. 253213
Pres. Lupo, Est. Cassano, Imp. Bell’Arte ed altri, P.M. Fedeli
(Conf.)
(Rigetta, App. Catania, 23 febbario 2009)
Edilizia - Disciplina urbanista - Impianto fotovoltaico - Realizzazione in zona agricola - Autorizzazione unica - Rilascio - Necessità
L’autorizzazione unica, costituendo titolo abilitativo idoneo ad escludere la configurabilità del reato previsto dall’art.
44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, deve essere rilasciata
anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona
agricola, la cui ubicazione deve tener conto delle tradizioni
agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, nonché
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. (Fattispecie
nella quale è stato ritenuto sussistente il “fumus” del reato
ipotizzato in sede cautelare in relazione alla realizzazione
degli impianti previo rilascio di semplice DIA).
Cass., sez. III, sentenza 20 marzo 2012, n. 38733
(dep. 04 ottobre 2012) Rv. 253285
Pres. Mannino, Est. Fiale, Imp. Ferrero e altro, P.M. Gaeta
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Brindisi, 24 giugno 2011)
Edilizia - Disciplina urbanistica - Impianto fotovoltaico - Titolo
abilitativo - Autorizzazione unica - Rilascio - Necessità
Integra il reato previsto dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 la realizzazione di impianti fotovoltaici, che
deve essere preceduta dal rilascio dell’autorizzazione unica,
che ha carattere omnicomprensivo ed è sostitutiva del permesso di costruire all’esito della conferenza di servizi appositamente indetta dall’amministrazione competente per la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.
Cass., sez. III, sentenza 20 marzo 2012, n. 38733
(dep. 04 ottobre 2012) Rv. 253285
Pres. Mannino, Est. Fiale, Imp. Ferrero e altro, P.M. Gaeta
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Brindisi, 24 giugno 2011)
Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento penitenziario) Regime detentivo previsto dall’art. 41 bis O.P. - Richiesta di revoca
anticipata - Rigetto per silenzio rifiuto - Reclamo - Competenza Tribunale di sorveglianza di Roma - Sussistenza
A seguito della legge n. 84 del 2009, la competenza a
decidere sul reclamo avverso il provvedimento ministeriale di
rigetto, per silenzio-rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del decreto impositivo del regime detentivo previsto
dall’art. 41-bis dell’Ordinamento penitenziario spetta al tribunale di sorveglianza di Roma.
Cass., sez. I, sentenza 18 settembre 2012, n. 39863
(dep. 09 ottobre 2012) Rv. 253288
penale
Gazzetta
92
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
Pres. Chieffi, Est. Caiazzo, Imp. Confl. comp. in proc.
Iacolare, P.M. Delehaye (Conf.)
(Dichiara competenza)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno
- Limiti di durata annuale - Computo - Modalità
In tema di limite di durata del lavoro notturno, ai fini
dell’integrazione del reato previsto dall’art. 18-bis del d.lgs.
8 aprile 2003, n. 66, il riferimento all’anno per calcolare se
il periodo massimo di 80 giorni di lavoro notturno sia stato
superato deve essere computato dall’inizio del rapporto di
lavoro.
Cass., sez. III, sentenza 27 aprile 2012, n. 37903
(dep. 01 ottobre 2012) Rv. 253287
Pres.: Mannino, Est. Andronio, Imp. Seravalli e altro, P.M.
Salzano (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Tolmezzo, 10 novembre 2011)
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Procedimento - Giudizio di legittimità - Procedimento camerale non partecipato - Compatibilità con la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo
Il procedimento per la trattazione in sede di legittimità
dei ricorsi in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione
(camera di consiglio non partecipata) non trova ostacolo
nella sentenza 10 aprile 2012 della Corte europea per i diritti dell’uomo, nel caso Lorenzetti c. Italia, in quanto tale
pronuncia, nell’affermare la necessità che al soggetto interessato possa quanto meno essere offerta la possibilità di richiedere una trattazione in pubblica udienza, non si riferisce al
giudizio innanzi alla Corte di cassazione.
Cass., sez. un., ordinanza 18 ottobre 2012, n. 41694
(dep. 25 ottobre 2012) Rv. 253289
Pres. Lupo, Est. Macchia, Imp. Nicosia, P.M. Riello (Diff.)
(Solleva questione legittimità costituzionale, App. Catania,
05 luglio 2011)
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere - Ordinanza di ammissione - Revocabilità anche al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 441 bis c.p.p. - Esclusione
L’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non
può essere revocata salvo che nell’ipotesi espressamente disciplinata dall’art. 441 bis c.p.p.
Cass., sez. un., sentenza 19 luglio 2012, n. 41461
(dep. 24 ottobre 2012) Rv. 253212
Pres. Lupo, Est. Cassano, Imp. Bell’Arte ed altri, P.M. Fedeli
(Conf.)
(Rigetta, App. Catania, 23 febbraio 2009)
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Presupposti - Abbreviato condizionato - Sopravvenuta impossibilità dell’acquisizione
della prova richiesta dall’imputato - Revocabilità dell’ordinanza
di ammissione del rito - Esclusione
L’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso
in cui l’acquisizione della prova dedotta in condizione divenga impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte,
atteso che il vincolo di subordinazione insito nella richiesta
condizionata è utilmente assolto con l’instaurazione del rito
e con l’ammissione della prova sollecitata dall’imputato.
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
Cass., sez. un., sentenza 19 luglio 2012, n. 41461
(dep. 24 ottobre 2012) Rv. 253211
Pres. Lupo, Est. Cassano, Imp. Bell’Arte ed altri, P.M. Fedeli
(Conf.)
(Rigetta, App. Catania, 23 febbraio 2009)
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Oggetto e Limiti - Persona
offesa - Necessità dell’acquisizione di riscontri esterni - Esclusione
- Valutazione delle dichiarazioni - Requisiti
Le regole dettate dall’art. 192 comma terzo c.p.p. non si
applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali
possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato,
previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più
penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la
Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona
offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri
elementi).
Cass., sez. un., sentenza 19 luglio 2012, n. 41461
(dep. 24 ottobre 2012) Rv. 253211
Pres. Lupo, Est. Cassano, Imp. Bell’Arte ed altri, P.M. Fedeli
(Conf.)
(Rigetta, App. Catania, 23 febbraio 2009)
Rapporti giurisdizionali con Autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Decisione pronunciata “in
absentia” - Richiesta di esecuzione della pena in Italia - Interesse
alla rinnovazione del giudizio contumaciale - Esplicita richiesta
da parte dell’interessato - Esigenza - Conseguenze - Fattispecie
In tema di mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria estera per l’esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna, qualora l’interessato ne abbia fatto
esplicita richiesta, la corte d’appello deve disporre la sua
consegna con la duplice condizione della rinnovazione del
giudizio secondo la normativa propria dello Stato richiedente e del reinvio in Italia per l’esecuzione della pena eventualmente irrogata all’esito di tale nuovo giudizio. (Fattispecie
relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, in cui la
S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che
aveva disatteso la richiesta difensiva di consegna finalizzata
alla nuova celebrazione del processo, disponendo l’esecuzione della pena in Italia, previo rifiuto della consegna e contestuale rimessione in libertà dell’interessato, sul presupposto
che era suo onere attivarsi nello Stato estero per far venire
meno il titolo esecutivo). (cfr. Corte di Giustizia U.E.,
C-306/09, I.B.).
Cass., sez. VI, sentenza 19 settembre 2012, n. 36590
(dep. 21 settembre 2012) Rv. 253274
Pres. Milo, Est. Citterio, Imp. Grigore, P.M. Iacoviello
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, App. Roma, 22 agosto 2012)
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali - Reato - Sussistenza - Presentazio-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
ne della domanda di registrazione del segno distintivo - Sufficienza - Esclusione
In tema di contraffazione di segni distintivi e di commercio di prodotti con segni falsi, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 c.p. dalla l. n. 99 del 2009, non
è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della
sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad
2 0 1 2
93
ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che
questo sia stato effettivamente conseguito.
Cass., sez. V, sentenza 13 luglio 2012, n. 36360
(dep. 21 settembre 2012) Rv. 253207
Pres. Grassi, Est. Sabeone, Imp. Shao, P.M. Scardaccione
(Conf.)
(Annulla con rinvio, App. Lecce, 11 ottobre 2010)
penale
Gazzetta
94
D i r i t t o
●
p r o c e d u r a
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
DIRITTO PENALE
Rassegna di merito
●
e
A cura di Alessandro Jazzetti
Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Napoli
e
Giuseppina Marotta
Concorso di circostanze: attenuanti generiche – Collaborazione ex
art. 8 l. 152/91
(art. 69 c.p.)
E’ pur vero che, in linea teorica, le circostanze attenuanti
generiche e l’attenuante prevista dall’art. 8 d.1. n° 152/91
possono concorrere tra di loro (cfr. Cass., sez. 5, n° 47451/04),
ma esse non devono però essere basate sugli stessi elementi
(cfr. Cass., sez. 5, n° 34574/10). Orbene, questo è proprio ciò
che si verificherebbe nel caso di specie, non essendo rinvenibili per il riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche ulteriori ragioni oltre alla collaborazione,
già positivamente valutata ai fini dell’attenuante prevista
dall’art. 8 d.1. n° 152/91.
Corte Appello Napoli, sez. III
sentenza 6 novembre, 2012, n. 4847
Pres. Grasso, Est. Rizzi Ulmo
Avvocato
Concorso di circostanze: concorso tra più circostanze attenuanti
ad effetto speciale – Applicazione dell’attenuante più favorevole
– Criteri e modalità di applicazione
(dell’art. 63 comma 5 c.p.)
La dizione del comma 2 dell’art. 8 d.1. n° 152/91 (si ribadisce: “nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le 2
disposizioni dell’articolo l’) va interpretata nel senso che il
riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 8 d.1. n°
152/91 comporta come effetto automatico l’elisione dell’aggravante prevista dall’art. 7 del medesimo testo legislativo
(cfr., seppure affrontando la diversa problematica del calcolo
della prescrizione, Cass., sez. 1, n° 26826/11), della quale
quindi non si può tenere conto: con la conseguenza che bisognerà operare solo e necessariamente la riduzione prevista
dall’art. 8. Tra l’altro, nel caso che qui ci occupa si verifica un
concorso tra più circostanze attenuanti ad effetto speciale,
con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 63 comma 5 c.p.,
occorrerà applicare solo la circostanza attenuante più favorevole (nel caso di specie quella prevista dal comma 7 dell’art.
74 d.P.R. n° 309/90, che comporta una riduzione della pena
dalla metà ai 2/3, mentre quella prevista dall’art. 8 d.1. n°
152/91 comporta una riduzione “solo” da 1/3 alla metà), con
una eventuale ulteriore riduzione (fino ad un massimo di 1/3)
per la presenza dell’altra attenuante ad effetto speciale.
Corte Appello Napoli, sez. III
sentenza 6 novembre, 2012, n. 4847
Pres. Grasso, Est. Rizzi Ulmo
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: differenza con il reato di
estorsione
(art. 392 – 629 c.p.)
Ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione nel caso che il soggetto possa far
valere il suo diritto dinanzi all’autorità giudiziaria, occorre
avere riguardo al grado di gravità della condotta violenta o
minacciosa che, se manifestata in modo gratuito o sproporzionato rispetto al fine, ovvero tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima, integra gli estremi dei più grave delitto di estorsione”. In particolare si è rilevato in giurisprudenza che la condotta minacciosa o violenta sproporzionata rispetto al preteso diritto, tale da determinare la coartazione
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
dell’altrui volontà, assume “ex se” i caratteri dell’ingiustizia,
trasformandosi in condotta estorsiva. Ed ancora si è osservato che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia e la violenza non sono fini a sé stesse, ma sono
strettamente connesse alla condotta dell’agente, diretta a far
valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali, per cui non possono mai
consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di
violenza.
Tribunale Nola, coll. C)
sentenza 25 ottobre 2012, n. 2257
Pres. Est. Di Iorio
Illecita concorrenza: elementi costitutivi – Presupposti
(art. 513 bis c.p.)
Il delitto di cui all’art. 513/bis c.p. è sussistente a in tutti
i casi in cui vengano poste in essere forme di intimidazione
costituite da atti di violenza o di minaccia esercitati contro
l’imprenditore concorrente (o contro suoi collaboratori) per
impedirne, limitarne, scoraggiarne, controllarne l’attività,
anche qualora non si concretizzino in alcuno degli atti di
concorrenza in senso tecnico previsti dall’art. 2598 c.c. (cfr.
Cass., sez. 2, n° 6462/10; Cass., sez. 3, n° 44169/08; Cass.,
sez. 2, 15.3.2005, n° 13691; Cass., sez. 1, 22.2.2005, n°
19713; Cass., sez. 1, 1.2.1996, n° 2224, Buzzone; Cass., sez.
3, 15.2.1995, n° 450, Tamborrini).
Corte Appello Napoli, sez. III
sentenza 13 novembre, n. 5029
Pres. Grasso, Est. Rizzi Ulmo
Illecita concorrenza: condotta violenta ed intimidatoria – Caratteristiche
(art. 513 bis c.p.)
Integra senza ombra di dubbio il delitto in esame, la condotta intimidatoria e violenta volta a costringere taluno a
non vendere nella stessa zona, con evidente limitazione della
loro attività commerciale a tutto vantaggio di quella dell’imputato. Ciò in quanto l’art. 2598 c.c., nel definire gli atti di
concorrenza sleale, contiene al numero 3) una formula aperta (“si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale e
idoneo a danneggiare l’altrui azienda”), nella quale ben può
rientrare qualsiasi comportamento violento o intimidatorio
idoneo ad impedire al concorrente di auto - determinarsi nell’
esercizio della sua attività commerciale.
Corte Appello Napoli, sez. III
sentenza 13 novembre, n. 5029
Pres. Grasso, Est. Rizzi Ulmo
Rapina: circostanze aggravanti - Luoghi di privata dimora – Nozione e caratteristiche
(art. 628 co. 3 c.p.)
Con riferimento a tale reato non pare però sussistente
l’aggravante contestata di cui all’art. 628 co. 3 n. 3 bis c.p..
Deve rilevarsi, infatti, che detta aggravante si configura in
relazione a quelle situazioni in cui l’agente, per porre in atto
la condotta criminosa, violi un luogo di privata dimora, inteso quale luogo adibito non solo alle esigenze di vita ma
anche all’esercizio di un’attività, che ogni persona ha diritto
di svolgere liberamente e legittimamente senza turbamenti da
2 0 1 2
95
parte di terzi, ai quali può essere vietata la introduzione o la
permanenza nel luogo stesso (cfr. Cass, sez. 2, sent, n. 1353
del 06/11/1984). E’ dunque tale luogo che viene protetto
dalla norma in esame, la quale attribuisce al fruitore del
luogo di privata dimora il potere di impedire l’accesso e di
espellere coloro che si introducono per azioni illecite. Essa
presuppone, quindi, che l’azione criminosa provenga da un
soggetto terzo che, introducendosi permanendo illecitamente in detto luogo, arrechi turbamento al libero esercizio delle
predette attività nel luogo deputato ad esse.
Tribunale Nola, coll. C)
sentenza 25 ottobre 2012, n. 2257
Pres. Est. Di Iorio
Ricettazione: elemento soggettivo – Incauto acquisto – Presupposti e differenze
(art. 648 – 712 c.p.)
La norma di cui all’art.648 c.p. richiede che l’agente acquisti o, comunque, riceva cose di provenienza delittuosa al
fine di trarne profitto. Pertanto, elemento essenziale per la
configurabilità del reato sotto il profilo materiale è l’acquisto
del possesso di tali cose di illecita provenienza (delitto presupposto), mentre, sotto il profilo dell’elemento psicologico,
è necessario che l’imputato sia consapevole della provenienza delittuosa del bene in suo possesso. A tal fine il giudice di
merito è tenuto ad indagare se, date le particolari modalità
del fatto, l’agente poteva, allorché ricevette, acquistò od occultò il bene, aver raggiunto la certezza della sua illecita
provenienza e, dunque, dell’anteriorità di un reato commesso da altri, ciò che il giudice desumerà da elementi gravi,
univoci e concordanti raggiungendo la prova certa del dolo
diretto anche per distinguere la fattispecie da quella di cui
all’art.712 c.p. (incauto acquisto).
Trib. Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 12 novembre 2012, n. 14808
Ricettazione: possesso ingiustificato di titolo bancario illecito –
Valutazione – Criterio
(art. 648 c.p.)
In tema di valutazione della prova in relazione al delitto
di ricettazione, ben può apprezzarsi anche la condotta
dell’imputato che non ha fornito alcuna giustificazione sul
possesso del titolo bancario. Ed invero, il soggetto che riceva
o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole
che ne disciplinano la circolazione è di certo consapevole
della illecita provenienza del bene dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco è documento che, per sua
natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona
titolare del conto ovvero della persona da questi delegata (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 22555 del 09/06/2006 ).
Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 12 novembre 2012, n. 14808
Ricettazione: falsificazione polizza assicurativa - Concorso nel
reato presupposto – Esclusione del reato
(art. 648 c.p.)
Per la configurabilità del reato di ricettazione è necessario
non aver concorso nel reato presupposto, come espressamente richiesto dall’art. 648 c. p.. Ne consegue che nel caso di
falsificazione di polizza assicurativa di cui sia immediato ed
penale
Gazzetta
96
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
unico beneficiario l’imputato, deve ritenersi che questi abbia
concorso nella falsificazione direttamente mediante la materiale realizzazione dei documenti falsi, o quanto meno come
mandante di colui che ha materialmente provveduto alla
falsificazione (al quale deve avere necessariamente fornito i
dati suoi e della sua automobile. (negli stessi termini cfr.
Cass., sez. 2, n° 27413/11;Cass., sez. 2, n° 16566/09).
Corte Appello Napoli sez. III
sentenza 6 novembre 2012, n. 4838
Pres. Grasso, Est. Rizzi Ulmo
Sanzioni accessorie: reato continuato – Rito abbreviato - Criteri di
applicazione
(art. 81 c.p.)
In caso di condanna per reato continuato, ai fini della
applicazione delle pene accessorie, si deve fare riferimento
non alla pena complessivamente irrogata, bensì solo a quella
inflitta per il reato più grave, ovviamente tenendo conto
anche della riduzione di 1/3 per il rito abbreviato (cfr. Cass.,
sez. 1,9.11.1995, n° 12741, Triolo; Cass., sez. 4, n° 3538/04;
Cass., sez. 6, n° 17616/08; Cass., sez. 1, n° 27700/07; Cass.,
sez. 6, n° 17542/06).
Corte Appello Napoli sez. III
sentenza 6 novembre 2012, n. 4847
Pres. Grasso, Est. Rizzi Ulmo
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
da quell’ambito esorbitanti, altrimenti intercorrendosi in
palese violazione dei termini di decadenza fissati dall’articolo 585 c.p.p. e vanificandosi l’eventuale appello incidentale,
impossibile contro motivi nuovi nel senso denunciato
Corte di Appello Napoli, sez. II
sentenza 23 maggio 2012, n. 2558
Pres. Maddalena, Est. Gianella
Impugnazioni: appello – Vizi di motivazione – Esclusione dalla
cognizione del Giudice di gravame
(art. 606 c.p.p.)
In sede di giudizio d’appello non è possibile dedurre vizi
attinenti alla motivazione, in quanto a ciò la parte è legittimata solo in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.
606, primo comma, lettera e), poiché al giudice d’appello
sono conferiti i più ampi poteri – e doveri- di integrazione
della motivazione eventualmente viziata o, addirittura, omessa, caso ben diverso, all’evidenza, da quello della omessa
decisione, che comporta la restituzione degli atti al P.M.
presso il giudice a quo perché eserciti l’azione penale. Parimenti non possono esser dedotti, nel giudizio d’appello, i
vizi di cui all’articolo 606, primo comma, lettera b), c) e d),
propri del ricorso per cassazione, convertendosi, le relative
doglianze, in motivi attinenti al merito.
Corte di Appello Napoli, sez. II
sentenza 23 maggio 2012, n. 2558
Pres. Maddalena, Est. Gianella
PROCEDURA PENALE
Impugnazioni: sentenza depositata allo scadere del termine concesso con proroga – Termine per proporre appello – Criteri di
determinazione
(art. 154 disp. Att. c.p.p., 548 c.p.p.)
La sentenza in ordine alla quale sia stata concessa proroga ai sensi dell’art. 154, comma 4 bis, disp. Att. c.p.p. è, a
tutti gli effetti, una sentenza pronunciata fuori dei termini di
legge, dovendosi guardare al termine di novanta giorni, e non
a quello prorogato nei suddetti sensi: conseguentemente, il
dies a quo per proporre l’impugnazione è quello di cui al secondo comma dell’articolo 548 c.p.p., e tale termine risulta
rispettato nel presente procedimento. “In materia di termini
per l’impugnazione, la proroga dei termini per la redazione
della motivazione, disposta ai sensi dell’art. 154, comma
quarto bis, disp. Att. c.p.p. non comporta il prolungamento
del periodo fissato per il deposito della sentenza, sicché il dies
a quo dei termini di impugnazione coincide con la scadenza
del termine stabilito per il deposito aumentato del periodo
prorogato, ma con il giorno di notificazione alle parti dell’avviso del deposito (Cass. sez. II, 16.1.2006, n. 1514, P. G. in
proc. Cangiano ed altri, RV 233325).
Corte di Appello Napoli, sez. II
sentenza 23 maggio 2012, n. 2558
Pres. Maddalena, Est. Gianella
Impugnazioni: motivi nuovi – Modalità e caratteristiche
(art. 585 c.p.p.)
Ai sensi dell’articolo 585, quarto comma bis, c.p.p., possono essere presentati solo motivi attinenti a questioni già
enunciate con i motivi contestuali, di cui alla lettera a) dell’articolo 581 c.p.p., e non già con i quali si pongano questioni
Valutazione della prova: testimonianza de relato – Inutilizzabilità
– Limiti e criteri
(art. 195 c.p.p.)
In tema di prova testimoniale, l’inutilizzabilità della dichiarazione “de relato” resa dal testimone deriva esclusivamente dall’inosservanza della disposizione del comma primo
dell’art. 195 c.p.p., allorché il giudice, “richiesto dalla parte”,
non abbia disposto che sia chiamata a deporre l’altra persona
a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti. In
mancanza della richiesta di parte, il giudice può anche esercitare il potere d’ufficio conferitogli dall’articolo 507 cod. proc.
pen. (richiamato dall’art. 195, comma secondo, c.p.p.), ma la
circostanza che egli non ritenga di avvalersi di tale potere non
comporta l’inutilizzabilità della dichiarazione “de relato”
(Cass., sez. IV, 13.1.2006, n. 1151, Carmellino, RV
233170)”.
Corte di Appello Napoli, sez. II
sentenza 23 maggio 2012, n. 2558
Pres. Maddalena, Est. Gianella
Impugnazioni: appello – Applicazione pene accessorie - Reformatio in peius – Esclusione
(art. 597 c.p.p.)
Non si viola il principio della reformatio in peius, di cui al
terzo comma dell’articolo 597 c.p.p., qualora il giudice d’appello provveda, d’ufficio, all’applicazione di pene accessorie
eventualmente omessa dal primo giudice (Cass. sez. un.,
17.7.1998, n. 8411, P.G. in proc. Ishaka, Arch. Nuova proc.
pen., 1998, IV, 561; Cass. sez. IV, 29.1.2004, n. 3538, Maisto,
RV 230305; Cass. sez. V, 22.2.2008, Ciocci, Riv. Pen., 2009,
1, 107; Cass. sez. V, 17.2.2010, G. Dir., 2010, 20,92).
Corte di Appello Napoli, sez. II
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
sentenza 23 maggio 2012, n. 2558
Pres. Maddalena, Est. Gianella
Valutazione della prova: plurime chiamate di correo – Riscontro
reciproco – Ammissibilità
(art. 192 c.p.p.)
In tema di chiamata di correo, v’è reciproco riscontro in
caso di pluralità di chiamate se si ha convergenza in ordine
allo specifico fatto materiale oggetto del narrato ( Cass. sez. IV,
16.2.2006, n. 6221, Aglieri ed altri, RV 233085)”; “l’art. 192,
comma 3 e 4, del c.p.p. non ha svalutato sul piano probatorio
le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da
persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p.
o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, comma secondo lett. b), c.p.p. perché ha
riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero
indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri
elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o
natura (Cass. sez. un. 1.2.1992, n. 1048, Scala ed altri”; ben
possono ulteriori chiamate in correità – coeteris paribus – fungere da riscontro obiettivo alle dichiarazioni accusatorie rese
ai sensi dei commi terzo e quarto dell’art. 192 c.p.p. (Cass. sez.
II, 9.6.1999, n. 7437, P.M. Cataldo, RV 213845; Cass. sez. II,
20.3.2000, n. 3616, Calascibetta ed altri, RV 215558; Cass.
sez. I, 3.12.1999, n. 13885, Greco ed altri, RV 215803; Cass.
sez. I, 31.5.1995, n. 2328, Carbonaro)”.
Corte di Appello Napoli, sez. II
sentenza 23 maggio 2012, n. 2558
Pres. Maddalena, Est. Gianella
Valutazione della prova: dichiarazioni di imputato di reato connesso – Riscontri – Necessità
(art. 192 co. 3 c.p.p.)
Ai sensi dell’art. 192, comma terzo, c.p.p., per ritenere la
responsabilità di un imputato sulla base delle dichiarazioni
accusatorie di un coimputato o di persona imputata in un
procedimento connesso è necessario che le dette dichiarazioni
siano suffragate da riscontri obiettivi. Ma non è necessario
che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite
dal dichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, la citata disposizione richiede che gli “altri elementi di prova”, unitamente ai quali il
giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta,
confermino l’attendibilità delle stesse, non le singole circostanze riferite; altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e le dichiarazioni delle persone menzionate nell’art.
192, commi terzo e quarto, c.p.p. sarebbero svuotate di quel
valore probatorio che il legislatore ha attribuito loro.
Corte di Appello Napoli, sez. II
sentenza 23 maggio 2012, n. 2558
Pres. Maddalena, Est. Gianella
Leggi penali speciali
Armi: fuochi micidiali – criterio distintivo tra la fattispecie ex art.
10 l. 497/74 ed art. 678 c.p.
(l. 497/74 – art. 678 c.p.)
Ricorre la violazione delle legge armi ogniqualvolta la
condotta criminosa abbia ad oggetto fuochi micidiali e dun-
2 0 1 2
97
que potenzialmente pericolosi e considerato ancora che la
micidialità , criterio distintivo delle fattispecie di cui all’art.
10 l. 497/74 e 678 c.p. può derivare anche dalla concentrazione in un unico posto di materiali che, singolarmente
considerati, non possiedono tale caratteristica, ne consegue
che anche le sole modalità di detenzione possono rendere
pericolosa la detenzione di quantitativi di fuochi di artificio
che altrimenti detenuti non costituirebbero un rilevante pericolo.
Trib. Nola coll A)
sentenza 5 dicembre 2012, n. 2661
Pres. Aschettino, Est. Critelli, Andreoni
Gratuito patrocinio: criteri di liquidazione dopo l’intervento del
D.M. 140/12 – Riduzione della metà – Obbligo e ratio legislativa
(art. 9 D.M. 140/12)
Con specifico riferimento alle liquidazioni delle prestazioni dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato e di quelle ad esse equiparate (difesa d’ufficio di
irreperibili e di non abbienti ex artt. 116 e 117 T.U. 115/2002),
oltre ai criteri generali di liquidazione suesposti di cui agli
artt. 1, 9, 12, 13, 14, si deve tener conto altresì “della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione personale della persona difesa”(art. 9 comma 1 secondo periodo
espressamente richiamato dall’art.12 comma 7). E’ previsto,
inoltre, che “gli importi sono -di regola- ridotti della metà”
(art.12 comma 7 che richiama l’art.9 comma 1). La ratio di
tale disposizione è, con ogni evidenza, quella di contenere
gli oneri di spesa pubblica evitando che i compensi ai difensori siano liquidati con riferimento al valore che le prestazioni assumono sul “libero mercato”, prevedendo la decurtazione della metà degli importi. Il significato da attribuirsi
all’espressione “di regola” non può che essere quello di una
pleonastico rimarcare che la riduzione “della metà” non ha
eccezioni ma costituisce la norma, mentre non sembra possa
interpretarsi nel senso di un potere discrezionale di decurtazione dei compensi; ciò sia perché non risulta precisato se e
quando operare la riduzione non essendo indicato alcun
parametro specifico ulteriore rispetto ai criteri generali – già
applicabili anche al patrocinio dei non abbienti- e di certo
non utilizzabili due volte nella determinazione del compenso,
sia perché quando il decreto ministeriale ha inteso istituire
una discrezionalità lo ha fatto espressamente.
Tribunale Napoli, G.M.Bottillo
decreto 18 ottobre 2012
Rifiuti: stato emergenza rifiuti - Profili sanzionatori – Modifiche
legislative
(d.lgs. 152/2006– 205/2010)
Il quadro normativo descritto dal d.lgs. 152/2006 è stato
ulteriormente modificato con il decreto legislativo 3.12.2010
n. 205 emanato per l’attuazione della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, ai fini dell’adeguamento della legislazione italiana alla normativa comunitaria.
Con riferimento alle aree in cui vige lo stato di emergenza
rifiuti, le sanzioni penali sono dettate dal d.l.6.11.2008
nr.172 convertito in Legge 30.12.2008 nr.210 che, limitatamente alle suddette aree in cui vige lo stato di emergenza
dichiarato ai sensi della legge 225/1992 e fino alla sua cessazione, ha introdotto pene più severe per la gestione incontrol-
penale
Gazzetta
98
D i r i t t o
e
p r o c e d u r a
lata dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in relazione ad una
serie di condotte già vietate dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
(c.d. codice ambientale), prevedendo la trasformazione di
alcune di esse da fattispecie contravvenzionali a fattispecie
delittuose e la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose. L’art. 6 comma 1 lett. d) d.lgs. 172/2008 convertito in Legge 30.12.2008 n. 210 contestato nel caso in esame,
sanziona, dunque, con un sensibile innalzamento della pena
edittale e previa trasformazione in delitto, la condotta di
chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione.
Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 19 novembre 2012, n. 15270
Rifiuti: trattamento sanzionatorio per reati commessi nell’ambito
della Regione Campania - Perduranza dello stato di emergenza
(l. 18/11)
Con riferimento alla Regione Campania, va precisato che
la Legge24 gennaio 2011 , n. 1 (in G.U. 24/01/2011, n.18),
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
26 novembre 2010, n. 196 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 26 novembre 2010 ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
27.11.2010), recante disposizioni relative al subentro delle
amministrazioni territoriali della regione Campania nelle
attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti ha previsto,
in aggiunta al comma 7 del citato d.l., il comma 7-terche
espressamente stabilisce: “...stante l’accertata insufficienza
del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all’articolo 6 del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210». In altri termini, perdurando la insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio
campano, già inserito tra le aree ove vigeva lo stato di emergenza, le condotte di chiunque effettua attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta
autorizzazione, continuano ad essere sanzionate più gravemente ai sensi del d.l. 172/2008 (quindi, con delitto e non
già contravvenzione) e ciò fino alla data del 31.12.2011.
Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 19 novembre 2012, n. 15270
Rifiuti: emergenza rifiuti per la Regione Campania – Reato commesso sotto il vigore della legge emergenziale più severa – Applicabilità dell’art. 2 c.p. per sopravvenienza di norma sostanziale
più favorevole dopo la scadenza del termine non prorogato
La normativa emergenziale di cui alla l.18/11 non è attualmente applicabile essendo essa fondata sul presupposto
della dichiarazione preventiva dello stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti per la Regione Campania, presupposto venuto meno in forza della Legge 24 gennaio 2011 , n. 1 di conversione in legge del decreto-legge 26
novembre 2010, n. 196 che, all’art.1 comma 7 ter, aveva
previsto un’applicazione della più grave fattispecie delittuosa
fino al 31.12.2011, data oltre la quale la norma non ha più
efficacia in mancanza del necessario presupposto dello stato
di emergenza ambientale della Regione.
p e n a l e
Gazzetta
F O R E N S E
Ne consegue che, in mancanza di novelle o proroghe
temporali, non può applicarsi la norma suddetta seppure in
vigore all’epoca della commissione dei fatti contestati. Di
contro, tale condotta deve essere derubricata ed inquadrata
nella corrispondente fattispecie contravvenzionale di cui al
Testo Unico Ambientale (d.lgs.152/2006), in forza del principio generale di cui all’art.2 c.p. della sopravvenienza di una
norma sostanziale più favorevole che ha previsto un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Tribunale Napoli, G.M. Bottillo
sentenza 19 novembre 2012, n. 15270
Tariffe forensi: liquidazione da eseguirsi dopo l’entrata in vigore
del D.M. 140/12 – Normativa transitoria – Modalità e criteri di
applicazione
(D.M. 140/2012)
In base alla norma transitoria di cui all’art. 41, le disposizioni di cui al Regolamento si applicano “alle liquidazioni
successive alla sua entrata in vigore”. Il dato letterale della
norma induce a ritenere che, stante il richiamo del Testo Unico Spese Giustizia alle tariffe professionali abolite, a seguito
dell’entrata in vigore del Regolamento, alle istanze di liquidazione pendenti vadano applicati i nuovi parametri, ancorché
esse facciano riferimento a prestazioni difensive esauritesi
anteriormente alla entrata in vigore del citato regolamento.
Secondo quanto statuito di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione Sezioni unite civili (sentenza n. 17406 del
12.10.2012) “i nuovi parametri sono da applicare ogni volta
che la liquidazione del giudice intervenga in un momento
successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto
(23.8.2012) e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia completato la propria
prestazione professionale, anche se parte di essa si è svolta
sotto le vecchie tabelle”. Infatti, seppure è vero che il terzocomma del citato art. 9 del d.l. n. 1/12 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all’entrata in vigore del
decreto ministeriale contemplato dal comma precedente “da
ciò non si può trarre argomento per sostenere che sono quelle
tariffe – e non i parametri introdotti da nuovo decreto – a
dover trovare applicazione qualora la prestazione professionale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe”. Di contro, la liquidazione dovrà essere effettuata applicando le pregresse tariffe se l’attività professionale
si è conclusa prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale. Riassuntivamente, da una lettura sistematica delle
norme e dell’orientamento giurisprudenziale appena citato
appare più conforme al dato legislativo ritenere che: a) alle
istanze di liquidazione pendenti fino al 23.7.2012 per attività professionale esauritasi anteriormente alla emanazione del
decreto, siano applicabili le vecchie tariffe in ragione della
loro ultrattività fino alla data del 23.7.2012; b) alle istanze di
liquidazioni pendenti dal 24.7.2012 devono, viceversa, essere
applicati i nuovi parametri, sia con riferimento a prestazioni
professionali esauritesi anteriormente alla entrata in vigore
del nuovo regolamento, sia con riferimento a prestazioni
professionali svoltesi, in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe ed in parte sotto la vigenza dei nuovi parametri.
tribunale Napoli, G.M. Bottillo
decreto 18 ottobre 2012
Diritto amministrativo
L’evoluzione dello spoils system al vaglio della Corte Costituzionale
101
Gli appalti pubblici e p.m.i. tra specialità reale ed apparente
107
Almerina Bove
Pasquale Di Lieto
Rassegna di giurisprudenza sul Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 114
(d.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss. mm.)
amministrativo
A cura di Almerina Bove
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
●
L’evoluzione
dello spoils system
al vaglio
della Corte Costituzionale
● Almerina Bove
Dottore di ricerca e Avvocato
presso l’Avvocatura Regionale della Campania
2 0 1 2
101
Sommario: Premessa - 1. Lo spoils system e la “prima fase”
della riforma della dirigenza pubblica: dal d.lgs. 29/’93 alla
legge Frattini - 2. (segue). La legge “Frattini” al vaglio della
Corte Costituzionale: verso una nuova fisionomia dello spoils
system - 3. Le pronunce della Consulta sul d.l. 262/2006
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 24 novembre 2006, n. 286: il progressivo smantellamento del sistema delle spoglie - 4. La riforma Brunetta e gli
interventi normativi post riforma - 5. Gli ultimi approdi
della giurisprudenza costituzionale.
Premessa
Con il termine spoils system si indica la cessazione automatica, ex lege, di incarichi dirigenziali al mutamento della
compagine di Governo1: trattasi di istituto intorno al quale
ruotano problematiche di rilevo, in quanto il suo ambito di
applicazione deve necessariamente perimetrarsi in coerenza
con il bilanciamento delle due esigenze - contrapposte- di
perseguire l’efficienza dell’organo politico, alla quale è speculare la fiduciarietà delle nomine e di garantire il buon andamento dell’amministrazione, il cui baluardo si coglie nel
principio di imparzialità dell’azione amministrativa.
La storia dello spoils system, tradotta nel contesto italiano, si atteggia come un dibattito a due voci, quella della
giurisprudenza costituzionale, da un lato, e del legislatore
statale, dall’altro.
Il presente contributo intende ripercorrere le tappe di tale
dibattito, dalla cd. “prima privatizzazione” del pubblico impiego fino al “post - riforma Brunetta”.
1. Lo spoils system e la “prima fase” della riforma
della dirigenza pubblica: dal d.lgs. 29/’93 alla legge Frattini
Con il decreto legislativo del 3.02.1993 n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
in conformità agli obiettivi fissati nella legge-delega 23 ottobre 1992, n. 4212 , si realizza una riforma strutturale e sostanziale del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione: da un lato, per quel che riguarda il profilo
sostanziale, alla concezione gerarchizzata e fidelizzata dell’apparato burocratico rispetto ai vertici politici si sostituisce il
principio di separazione tra i compiti di direzione politica e
quelli di direzione amministrativa; dall’altro, dal punto di
vista strutturale, si gettano le fondamenta della cd. “contrattualizzazione” del pubblico impiego: il lavoro alle dipendenze
della P.A. cessa di essere regolato dal regime pubblicistico per
essere assoggettato alla disciplina privatistica e ai relativi
strumenti di disciplina (contratti individuali e collettivi).
Con le riforme di cui ai decreti legislativi del 31 marzo
1La presente disamina avrà ad oggetto lo spoils system cd. “all’italiana”, diverso dal modello americano, nel quale la cessazione automatica colpisce non
solo il rapporto di ufficio, ma anche lo stesso rapporto di servizio con l’amministrazione. Si veda, al riguardo, G. Nicosia, Le opinioni della Corte Costituzionale su “spoils system”, fiducia e imparzialità negli incarichi di funzione
dirigenziale: il “caso speciale” è davvero speciale?, nota a C. Cost. n. 103 del
23.03.2007, in Lavoro nelle P.A. , 2007, 2, p. 497.
2Legge 23 ottobre 1992, n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e
la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”.
amministrativo
Gazzetta
102
d i r i t t o
a m m i n i s t r at i v o
1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, l’indicato processo di
privatizzazione del pubblico impiego si delinea compiutamente, toccando anche la dirigenza di livello generale, e si arricchisce di contenuti innovativi: in particolare, si scinde la disciplina dell’accesso alla qualifica dirigenziale da quella dell’accesso all’incarico dirigenziale e, in sostanza, il rapporto di
servizio dal rapporto d’ufficio3.
Per quanto concerne il conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale4, l’art. 19 del d.lgs. 29/93, nella sua nuova formulazione, prevede- in piena coerenza con l’obiettivo di
maggiore flessibilità nell’organizzazione dell’apparato amministrativo - il principio della temporaneità dell’incarico dirigenziale (comma 2), la cui durata non può essere inferiore a
due anni e superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo5 ed
individua tre differenti tipologie di funzione dirigenziale, collocate in ordine decrescente di rilevanza e di maggiore coesione con l’organo politico. Si prevede, altresì, che l’incarico dirigenziale, di qualunque livello, possa essere conferito- con
contratto a tempo determinato ed entro precisi limiti percentuali riferiti all’organico di ciascuna fascia “a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o
aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.
Si tratta della cd. dirigenza “esterna” che, come è stato
sostenuto6 , consacra “una vera e propria frattura tra rapporto
di impiego (legato allo status di dirigente all’interno di un
Ente pubblico) e rapporto organico (che attiene all’esercizio
delle funzioni ed alla capacità di impegnare l’amministrazione
verso l’esterno)”, posto che il conferimento dell’incarico, e la
successiva instaurazione del rapporto organico, possano prescindere non solo dalla corrispondenza con la qualifica di
appartenenza del dirigente (se è vero che ad un dirigente di
fascia inferiore può essere destinatario di incarichi di fascia
superiore), ma dall’esistenza stessa del rapporto d’impiego (nel
caso di attribuzione ad estranei all’amministrazione, con
contratto di diritto privato)”.
Tale innovazione - congegnata per arricchire il bagaglio di
competenze a servizio della P.A., tanto vero che presupposto
indefettibile per il ricorso alla stessa è quello per cui la professionalità del soggetto esterno non sia rinvenibile nei ruoli
3 N. Durante, Spoils system e dirigenza pubblica, pubblicato in www.giustiziaamministrativa.it il 9.09.2011.
4 Per l’accesso alla qualifica dirigenziale, la riforma del 1998 ha previsto unicamente il «concorso per esami», cui segue la stipulazione del contratto di lavoro
(art. 28), nonché l’iscrizione dei soggetti, in tal modo selezionati, nel «ruolo
unico dei dirigenti» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed
articolato in due fasce (art. 23); ed è al predetto ruolo unico che ciascuna amministrazione statale avrebbe dovuto rivolgersi per il conferimento dei relativi
incarichi, determinando così la costituzione del rapporto di ufficio. Cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 107 del 23.03.2007, par. 7.1.
5La stessa disposizione specifica, altresì, che la durata dell’incarico e gli obiettivi da realizzare devono costituire l’oggetto del contratto accessivo al provvedimento di conferimento dell’incarico.
6 N. Durante, op. cit.
Gazzetta
F O R E N S E
dell’Amministrazione- si è, peraltro, prestata ad uno scopo del
tutto estraneo alla sua genesi, apparendo come il terreno più
fertile per poter introdurre, in modo surrettizio, forme di spoils
system indiscriminate e generalizzate: è su queste fattispecie
che, come vedremo, è intervenuta a più riprese la Consulta.
Per quanto attiene allo specifico profilo della cessazione
dall’incarico, per i soli incarichi apicali è prevista la possibilità di conferma, revoca, modifica o rinnovo entro 90 giorni dal
voto sulla fiducia al Governo (comma 8); per gli altri, la cessazione dall’incarico consegue all’accertamento di una responsabilità dirigenziale.
I contenuti dell’art. 19 del d.lgs. 29/’93, come modificati a
seguito della riforma del ’98, risultano integralmente trasfusi
nel d.lgs. del 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Sul descritto impianto normativo si inserisce il primo degli
interventi legislativi oggetto di declaratorie di incostituzionalità: la legge del 15 luglio 2002, n. 145, recante Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio
di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato (cd. “Legge
Frattini”).
L’art. 3 della citata legge, in particolare, intervenendo
sulla disciplina dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, di
cui all’art. 19 del d.lgs. 165/2001, introduce delle modifiche
tali da frustrare in toto lo spirito che aveva animato le precedenti riforme.
Ed invero, il comma 2 dell’art. 19, nella sua nuova formulazione, non contempla più la previsione di una durata minima
dell’incarico dirigenziale; il provvedimento di conferimento
dell’incarico assurge a fonte principale di regolazione dell’incarico del dirigente - fissandone l’oggetto, la durata e gli
obiettivi da conseguire - mentre al contratto accessivo è demandata la sola disciplina del trattamento economico.
Quanto al profilo della cessazione dall’incarico, nelle pieghe dell’apparente riproposizione del modello precedente- improntato ad una concezione “sanzionatoria” della decadenza,
ovvero conseguente all’accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi7 - si inseriscono previsioni completamente avulse dalla logica caratterizzante il sistema pregresso, posto
che la cessazione dall’incarico dipende dal semplice avvicendamento dei vertici politici: si tratta dall’istituzionalizzazione,
anche nel contesto italiano, del cd. spoils system.
Il comma 8, nella sua nuova formulazione, dispone che “Gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo”.
Tale forma di spoils system, cd. “a regime” o “ordinario”,
riferito alla dirigenza apicale, rientra nella “zona franca” individuata dalla Corte Costituzionale in un suo pregresso intervento8, alla cui stregua meccanismi di cessazione automatica degli incarichi dirigenziali al mutamento della compagine
di Governo possono tollerarsi solo se riferiti alla dirigenza
apicale, in ragione del carattere assolutamente fiduciario degli
incarichi de quibus.
La Consulta, in occasione dell’intervento sopra indicato,
sembra aderire ad un orientamento “formale”, nel quale la
7Il riferimento è alla disciplina di cui all’art. 21 d.lgs. 165/2001.
8 Corte Costituzionale, sentenza 16.06.2006, n. 233.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
fiduciarietà, riferita alla dirigenza “apicale”, si giustifica in
ragione della “immediata contiguità” degli incarichi apicali
con il vertice politico: “Questa modalità di conferimento – si
legge nella sentenza - mira palesemente a rafforzare la coesione tra l’organo politico regionale (che indica le linee generali
dell’azione amministrativa e conferisce gli incarichi in esame)
e gli organi di vertice dell’apparato burocratico (ai quali tali
incarichi sono conferiti ed ai quali compete di attuare il programma indicato), per consentire il buon andamento dell’attività di direzione dell’ente (art. 97 Cost.).
A tale schema rimangono, invece, estranei gli incarichi
dirigenziali di livello “non generale”, non conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad esso dallo stesso
grado di contiguità che connota gli incarichi apicali”.
Se, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il comma 8 del d.lgs., 165/2001- così come modificato dalla legge
Frattini- sembra porsi in linea di continuità con gli orientamenti della Consulta, diversa è la sorte dell’art. 3, comma 7,
della legge 145/2002, il quale dispone che: “Fermo restando il
numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione
relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici
vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi
in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione.”.
La disposizione da ultimo citata introduce una forma di
spoils sytem cd. “transitorio” o “una tantum”, riferito non
alla dirigenza apicale ma, indistintamente, a tutti gli incarichi
di funzione dirigenziale di livello generale.
2. (segue). La legge “Frattini” al vaglio della Corte Costituzionale:
verso una nuova fisionomia dello spoils system
Le descritte modifiche alla disciplina della dirigenza statale sono state sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale.
Con ordinanza del 4 novembre 2005, il Tribunale di Roma, invero, solleva questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3, commi 1, lettera b) e 7 della legge 15 luglio 2002,
n. 145, assumendone il contrasto rispetto agli artt. 1, 2, 3, 4,
35, 70, 97 e 98 della Costituzione.
Il remittente denuncia, in particolare, gli effetti sottesi
alla previsione di cui all’art. 3, comma 7: la norma de qua- nel
disporre, sia pure in via transitoria, la cessazione automatica
e generalizzata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale ancora in corso- consentirebbe, di fatto, al solo Governo in carica “di provvedere alla nomina di personale di propria fiducia, da collocare al vertice di tutti gli uffici”, in tal
guisa frustrando il principio di separazione tra funzioni di
indirizzo politico e funzioni di gestione, sancito a più riprese
dalla stessa Consulta e proclamato come principio ispiratore
delle riforme degli anni ’90.
La Corte ritiene fondata la censura de qua e, con sentenza
n. 103 del 23.03.2007, dichiara l’illegittimità costituzionale
dello spoils system una tantum riferito ai dirigenti di livello
generale9, per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione;
9
Dalla questione di legittimità esula la previsione relativa agli incarichi dirigen-
2 0 1 2
103
tanto, sulla scorta di un percorso argomentativo che differisce
da quello adottato nella pronuncia del 2006 sopra citata.
In quella sede, infatti, la Consulta aveva “giustificato” lo
spoils system riferito agli incarichi apicali in ragione della
“maggiore contiguità” degli stessi con il vertice politico, in
guisa che la mera circostanza della nomina diretta da parte
del vertice politico potesse giustificarne la fiduciarietà e fondare, per converso, la “apicalità”.
Nella sentenza in esame la citata argomentazione si rinviene solo incidenter tantum, per lasciare spazio ad un criterio sostanziale, che ha come massimo referente il principio di
buon andamento dell’amministrazione, letto in combinato
disposto con quelli di imparzialità e continuità dell’azione
amministrativa.
Gli indicati principi impongono che la revoca dell’incarico
possa conseguire, a regime, solo ad una accertata responsabilità dirigenziale, in presenza di determinati presupposti e
all’esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato, nel corso del quale al dirigente sia consentito apprendere le ragioni poste a fondamento della revoca dell’incarico.
Solo attraverso un meccanismo così congegnato è possibile salvaguardare, da un lato, il principio di continuità amministrativa, perseguito dalla precedenti riforme attraverso
la predisposizione di un nuovo “modello di azione”, che misura “il rispetto del canone dell’efficacia e dell’efficienza alla
luce dei risultati che il dirigente deve perseguire […], avendo
a disposizione un periodo di tempo adeguato, modulato in
ragione della peculiarità della singola posizione dirigenziale
e del contesto complessivo in cui la stessa è inserita; e, dall’altro, il principio di imparzialità dell’azione amministrativa,
“che è alla base della stessa distinzione funzionale dei compiti tra organi politici e burocratici, e cioè tra l’azione di governo - che è normalmente legata alle impostazioni di una
parte politica, espressione delle forze di maggioranza - e
l’azione dell’amministrazione, la quale, nell’attuazione
dell’indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece,
ad agire senza distinzioni di parti politiche e dunque al «servizio esclusivo della Nazione» (art. 98 Cost.), al fine del
perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall’ordinamento”.
“è evidente - conclude la Corte - che la previsione di una
anticipata cessazione ex lege del rapporto in corso impedisce
che l’attività del dirigente possa espletarsi in conformità al
modello di azione sopra indicato”.
Possiamo quindi affermare che la cessazione dell’incarico
legata al semplice avvicendamento degli organi di Governo
rappresenti un vulnus non solo al principio di continuità
dell’azione amministrativa, ma all’imparzialità della stessa,
facendo della burocrazia un corpus non più orientato al servizio esclusivo della P.A. ma ai mutevoli disegni delle forze di
Governo. Con la pronuncia in esame l’approccio della Consulta nei confronti dello spoils system sembra cambiare radicalmente: se nella sentenza del 2006 il sistema delle spoglie
era considerato addirittura servente al principio di buon an-
ziali di livello non generale. Questi ultimi, a norma dell’art. 3, comma 7 l.
145/2002, si intendono confermati automaticamente nel caso non venga adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un
provvedimento si segno differente.
amministrativo
Gazzetta
104
d i r i t t o
a m m i n i s t r at i v o
damento dell’amministrazione, nel caso di specie il medesimo
principio di buon andamento, letto in combinato disposto con
quelli di imparzialità e continuità dell’azione amministrativa,
ne determina la caratterizzazione in termini di vulnus10.
3. Le pronunce della Consulta sul d.l. 262/2006 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006,
n. 286: il progressivo smantellamento del sistema delle spoglie
I principi elaborati dalla Consulta, come in precedenza
rassegnati, sono destinati ad una progressiva applicazione: sul
già perfettibile quadro normativo introdotto dalla legge
145/2002, si innestano le previsioni di cui al decreto legge del
3.10.2006, n. 262 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”).
Anche a prescindere dalle perplessità che suscita la collocazione in un provvedimento d’urgenza afferente alla materia
tributaria e finanziaria di una disposizione destinata ad incidere in modo sostanziale sulla disciplina della dirigenza statale, si è rilevato come le norme in esame abbiano cancellato
in modo sistematico più di un decennio di riforme. Una cancellazione che opera de plano, posto che la disciplina in esame
afferisce non solo al meccanismo di spoliazione a regime, ma
anche a quello in via transitoria. Ed invero, lo spoils system a
regime, un tempo limitato alla sola dirigenza apicale, viene
ora esteso, indistintamente, a tutti gli incarichi- apicali e nonconferiti ai cd. “dirigenti esterni” (sia quelli di cui al comma
5 bis dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, sia quelli di cui al comma
6); quanto, poi, alla spoliazione transitoria, il comma 161
costituisce “il manifesto” della prassi politica che vuole la
dirigenza tutta asservita alla realizzazione del proprio indirizzo, posto che è prevista la cessazione automatica, allo spirare
del termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto, di tutti gli incarichi dirigenziali “esterni” conferiti dal
precedente Governo (cioè prima del 17 maggio 2006).
Il primo intervento della Corte sulla nuova disciplina è
quello di cui alla sentenza del 20.05.2008, n. 161; in quella
sede si sollevava, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto legge 262/2006,
per la parte relativa al personale non appartenente ai ruoli di
cui all’art. 23, assumendone il contrasto con gli artt. 97 e 98
della Costituzione.
La Consulta, invocando il precedente di cui alla sentenza
n. 103 del 2007, adotta un percorso argomentativo diretto a
valutare se le peculiarietà del caso sottoposto al suo esameafferenti alla tipologia dell’incarico e alla previsione del potere di conferma in capo all’organo politico- siano in grado di
condurre a conclusioni differenti rispetto a quelle nella prima
sede rassegnate.
Per quanto attiene al profilo della tipologia dell’incarico,
la Corte afferma che la differenza, sul piano strutturale, tra
incarico dirigenziale conferito a personale già inserito nei
ruoli di cui all’art. 23 e incarico conferito ai dirigenti dipendenti di “altre” pubbliche amministrazioni (altre rispetto a
quella conferente l’incarico) “non costituisce un elemento in
grado di diversificare in senso fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale, che deve rimanere caratterizzato, sul piano
funzionale, da una netta e chiara separazione tra attività di
10 In questo senso, Giovanni Di Cosimo, op. cit.
Gazzetta
F O R E N S E
indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie”.
In difetto dei requisiti legittimanti la fiduciarietà dell’incarico, deriva che- anche per il dirigente esterno- “il rapporto
di lavoro instaurato con l’amministrazione che attribuisce
l’incarico deve essere connotato da specifiche garanzie, le
quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da
assicurare la tendenziale continuità dell’azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione”.
Né vale, ad infirmare l’indicato impianto argomentativi,
la circostanza del potere di conferma in capo al vertice politico: “il potere ministeriale di conferma non attribuisce, infatti, al rapporto dirigenziale in corso alcuna garanzia di
autonomia funzionale, atteso che dalla mancata conferma la
legge fa derivare la decadenza automatica senza alcuna possibilità di controllo giurisdizionale”.
Con la sentenza n. 81 del 05.03.2010 la Consulta- sulla
base di argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte, evidentemente giustificate dall’identità della fattispecie sottoposta al suo esame - perviene alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2, comma 161, del decreto legge 262/2006,
nella parte in cui prevede in via transitoria che gli incarichi
conferiti, prima del 17.05.2006, a personale non dipendente
da pubbliche amministrazioni (art. 19, comma 6) cessino ove
non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto.
In conclusione, la spoliazione transitoria degli incarichi
dirigenziali cd. “esterni” sembra definitivamente cancellata
ad opera degli interventi della Consulta.
4. La riforma Brunetta e gli interventi normativi post riforma
La risposta del legislatore italiano ai principi consacrati
nella giurisprudenza costituzionale si traduce nel Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni)11.
Nel contesto delle disposizioni di cui al capo II, dedicato
alla dirigenza pubblica, espressamente finalizzate “a favorire
il riconoscimento di meriti e demeriti, e rafforzare il principio
di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e le funzioni di gestione amministrativa, spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia”, si inserisce l’art. 40, che riformula il testo dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001.
Apparentemente, la norma recepisce i principi elaborati
dalla Consulta, ripristinando, al comma 8, la spoliazione a
regime limitata ai soli incarichi di cui al comma 3, cioè gli
incarichi cd. “apicali”12.
11Si tratta dell’intervento normativo noto come “riforma Brunetta”.
12 M. Persiani rileva come la limitazione dello spoils system alle posizioni effettivamente apicali e fiduciarie di “segretario generale di ministeri” oltre agli
“incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente” non possono non essere salutate con
favore, al pari di quella di cui all’art.52 della medesima legge n.150, che persegue lo stesso intento di garantire la libertà dell’amministrazione dalla politica
modificando il regime delle incompatibilità attraverso la preclusione delal direzione di strutture deputate alla gestione del personale a coloro che negli ultimi due anni abbiano rivestito cariche o comunque beneficiato di rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici. Cfr. La
nuova disciplina della dirigenza pubblica, in Dottrina e attualità giuridiche,
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
E, tuttavia, il comma 1, lett. b) inserisce una nuova previsione, quella di cui al comma 1 – ter: “ L’amministrazione
che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero
alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non
intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è tenuta
a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso
con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili
per un nuovo incarico”.
Si tratta di una norma che, formalizzando- al di là dell’ipotesi della ristrutturazione- la possibilità di una mancata
conferma dell’incarico pur “in assenza di una valutazione
negativa” del dirigente, tradisce, in fatto, il dichiarato spirito
della riforma di porre al centro del proprio funzionamento la
valutazione dell’operato dei dipendenti pubblici e, in particolare, dei dirigenti.
Dunque, a dispetto delle dichiarazioni di intento, la propugnata autonomia tra politica ed amministrazione sembra
un obiettivo tutt’altro che raggiunto e le perplessità suscitate
dalla riforma Brunetta, con riferimento alla risoluzione della
problematica relativa all’autonomia della dirigenza pubblica,
si traducono numerose anche rispetto agli interventi normativi successivi.
Emblematico il caso del decreto legge 31.05.2010, n. 78
(“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica”), convertito nella legge
30.07.2010, n. 122.
L’art. 9, comma 32 del citato decreto interviene sul già
controverso comma 1- ter del d.lgs. 165/2001, disponendo
che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla
scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche
in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.
[…]Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma,
al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o
di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il
dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia”.
La previsione de qua, come è stato efficacemente sostenuto13,
“svuota di significato tanto il principio di autonomia funzionale, quanto quello di valutazione premiale dei risultati con
riferimento della dirigenza pubblica”: oltre a preservare la
possibilità che la mancata conferma dell’incarico prescinda da
valutazioni legate al merito, la norma elimina le precedenti
garanzie- seppur residuali- di una interlocuzione con l’amministrazione e del congruo preavviso. Il principio di efficienza, e- in
ultima analisi- quello di buon andamento dell’amministrazione
risultano, inoltre, compressi nella misura in cui si annullano le
prospettive di crescita professionale per il dirigente, il quale- a
seguito della mancata riconferma- potrà ricevere solo incarichi
corrispondenti alla propria fascia di appartenenza.
Introduzione, pag. 2697 e s.
13 G. Gardini, Sulla costituzionalità delle disposizioni in materia di dirigenza
pubblica (spoils sytem) contenute nelle recenti manovre finanziarie, in Foro
amministrativo, 2011, 09, 2968. Sullo stesso tema si veda anche G. Gardini
“L’autonomia della dirigenza nella (contro) riforma Brunetta, in Lavoro nelle
Pubbliche Amministrazioni, 2010, 3-4, p. 579.
2 0 1 2
105
Il vulnus più significativo ai dettami della Consulta è inferto, da ultimo, con la legge 14.09.2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari), al cui art. 1, comma 18, si legge che: “Al
fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in
relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei
confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia
ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro
incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto, prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il
dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento
economico in godimento a condizione che, ove necessario,
sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri
fondi analoghi”.
Si realizza, attraverso la disposizione in esame, la più
evidente smentita ai principi elaborati dalla Consulta: prescindendo da ogni considerazione in ordine alla caratterizzazione
funzionale dell’incarico e da una valutazione dell’operato del
dirigente, da condursi sulla scorta di un confronto dialettico
con l’amministrazione di appartenenza, si introduce- dietro
la veste delle “motivate esigenze organizzative”- un’ulteriore
ipotesi di cessazione dell’incarico in corso, peraltro generalizzata, posto che è riferita “al personale avente qualifica
dirigenziale”14.
La conclusione che è dato trarre, a seguito della disamina
del contesto normativo e giurisprudenziale riferito alla dirigenza pubblica, è quella per cui la problematica sottesa allo
spoils system - a dispetto dei numerosi interventi della Consulta - traduca un dibattito ancora aperto, a riprova della
difficoltà, pratica e non di principio, nell’arrestare i tentativi
di “continua osmosi” tra politica ed amministrazione.
5. Gli ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale
Con sentenze nn. 124 del 11.04.2011 e 246 del 25.07.2011
la Consulta è nuovamente intervenuta sul tema in esame.
La prima pronuncia ha ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150- nella parte in cui dispone che “gli incarichi di
funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art.
23, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo”.
14 G. Gardini (“L’autonomia della dirigenza nella (contro) riforma Brunetta”)
osserva come la norma in esame “darebbe vita ad uno spoils system a rovescio,
mirato a colpire solo i dirigenti pubblici di ruolo e non quelli presi a prestito
dal settore privato. Senza sottacere che, a rigore, un simile meccanismo di
passaggio ante tempus ad altro incarico, discrezionalmente deciso dall’organo
politico, non garantisce nemmeno quella razionalizzazione dei costi cui è dedicata l’intera manovra finanziaria in cui è racchiusa questa disposizione sulla
dirigenza: la norma, infatti, prevede contestualmente alla cessazione dall’incarico il diritto del dirigente a conservare, sino alla naturale scadenza del contratto, il trattamento economico in godimento”.
amministrativo
Gazzetta
106
d i r i t t o
a m m i n i s t r at i v o
In questa sede la Consulta opera una sintesi dei suoi precedenti orientamenti, definendo - in via generale - il parametro alla cui stregua delimitare con contorni netti l’ambito
della fiduciarietà degli incarichi, e - simmetricamente - quello
della legittimità costituzionale dei meccanismi di spoils system.
L’affermazione di principio è dirompente: lo spoils system
è costituzionalmente illegittimo - ipso iure - a meno che non
sia riferito “a posizioni apicali, del cui supporto l’organo di
governo «si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico
amministrativo»”.
Ciò posto, si comprende che se la fiduciarietà dell’incarico
dipende unicamente dalla sua destinazione funzionale al diretto supporto dell’attività di indirizzo politico, tale caratteristica difetta in ragione della mera circostanza dell’attribuzione di incarichi a dirigenti di “altre” P.A.; come già sostenuto nella sentenza n. 161/2008, “la natura esterna dell’incarico non costituisce un elemento in grado di diversificare in
senso fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale, che deve
rimanere caratterizzato, sul piano funzionale, da una netta
e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie” .
Sulla scorta della stessa ratio la Consulta, nella sentenza
n. 246 del 25.07.2011, dichiara costituzionalmente illegittimo
l’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165- nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- nella parte in
cui dispone che “gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 6 cessano decorsi novanta giorni dal
voto sulla fiducia al Governo”.
In conclusione, gli interventi della giurisprudenza costituzionale sembrano aver risolto il nodo centrale, avendo individuato il criterio atto a definire e circoscrivere l’area della fiduciarietà.
Si tratta di un criterio sostanziale, che ha come referente
il principio di separazione funzionale: lo spoils system è costituzionalmente legittimo in tutte quelle ipotesi nelle quali il
principio di separazione funzionale risulta essere estraneo
alla disciplina del rapporto, che- al contrario- richiede “un’intima compenetrazione e coesione che giustifichi un rapporto
strettamente fiduciario finalizzato alla compiuta definizione
dell’indirizzo politico-amministrativo”; si tratta degli incarichi di diretto supporto alla funzione di indirizzo politicoamministrativo, propria degli organi di Governo15.
Ogni qual volta, invece, l’incarico dirigenziale esuli dal
contesto appena indicato, rientrando nell’alveo delle funzioni
prettamente gestorie, sarà nuovamente al principio di separazione funzionale che dovrà essere informata la sua disciplina,
15 Cfr. sentenza n. 304 del 28.10.2010, ove la Corte dichiara costituzionalmente
legittimo lo spoils system riferito agli incarichi afferenti agli uffici di diretta
collaborazione, posto che - nell’indicata ipotesi - “non assume rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la distinzione funzionale tra le
attribuzioni del Ministero e quelle degli uffici in esame, dovendo, al contrario,
sussistere tra loro un’intima compenetrazione e coesione che giustifichi un
rapporto strettamente fiduciario finalizzato alla compiuta definizione dell’indirizzo politico-amministrativo; e che la separazione di funzioni, ritenuta
dalla giurisprudenza costituzionale necessaria per garantire il rispetto dei
principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa,
deve essere assicurata esclusivamente tra l’attività svolta dai ministri, con il
supporto degli uffici di diretta collaborazione, e quella esercitata dagli organi
burocratici, cui spetta la funzione di amministrazione attiva”.
Gazzetta
F O R E N S E
con la conseguenza che ogni ipotesi di cessazione automatica
legata al mero avvicendamento delle forze politiche non potrà
che risolversi in una lesione alla continuità ed imparzialità
dell’azione amministrativa.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
●
Gli appalti pubblici
e p.m.i. tra specialità reale
ed apparente*
● Pasquale Di Lieto
*
Specializzato alla Scuola per le Professioni legali
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Questo contributo è frutto di un lavoro di Tesi per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, relatore Ch.mo Consigliere Carlo Buonauro.
2 0 1 2
107
Sommario: 1. Il ruolo delle PMI nella legislazione italiana
ed europea - 2. La rilevanza delle norme contenute nello
Statuto delle imprese e le ragioni di una legiferazione di
principio - 3. Il sub appalto e la suddivisione in lotti:quali
innovazioni? - 4. Il problematico coordinamento dello Statuto delle imprese con il Codice dei Contratti Pubblici anche
alla luce dei “decreti Monti”.
1. Il ruolo delle PMI nella legislazione italiana ed europea
La crescita economica di un Paese è strettamente legata
alla capacità dell’ordinamento giuridico di fornire strumenti
normativi, volti a semplificare e ad incentivare l’iniziativa
imprenditoriale e gli investimenti nei settori produttivi.
Le piccole e medie imprese costituiscono un fattore caratterizzante dell’economia italiana e sono la maggiore fonte di
occupazione nell’Unione Europea. In questo periodo sono
contemporaneamente i soggetti maggiormente colpiti dalla
“crisi”, ma, per il potenziale di flessibilità e di innovazione
che posseggono, possono costituire una solida base per una
ripresa duratura della crescita economica.
La creazione di un contesto legislativo favorevole alle
piccole e medie imprese è il punto di partenza dello Small
business act for Europe1 (SBA).
In primo piano, tra i dieci principi guida, a cui gli Stati
membri si devono attenere nell’attuazione di politiche nazionali d’incentivo, vi sono gli indirizzi che regolano i rapporti
delle PMI con la Pubblica Amministrazione. Quest’ultima è,
non solo un interlocutore indispensabile con cui misurarsi,
ma può divenire anche un’importante fonte di business, agevolando la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Un
maggiore grado di accessibilità delle PMI agli appalti consentirebbe un incremento quantitativo e qualitativo della concorrenza nei contratti pubblici con un consequenziale risparmio
per le stazioni appaltanti. Sicuramente l’opportunità politica
ed economica conduce verso una rapida ed effettiva attuazione dello SBA e del Codice di buone pratiche negli appalti
pubblici.
A ben vedere, però, la natura degli atti dell’Unione che
sono volti a favorire le PMI sono per la loro stessa forma
giuridica poco incisivi sulla legislazione nazionale.
Si tratta, per lo più, di Comunicazioni della Commissione,
che hanno un valore di indirizzo generale, ma non sono vincolanti per gli Stati, che sono a loro volta “liberi” di attuare
gli indirizzi proposti con misure, tempi e modalità proprie
con tutti i rischi e le incognite che ciò comporta.
Vi è una ragione profonda alle spalle di tutto ciò. In realtà, il binomio precedentemente citato, concorrenza e agevolazioni alle PMI ha dei profili che sono intrinsecamente in
contraddizione tra loro. La stessa Commissione europea,
seppur fa trasparire dai propri atti (non vincolanti), come di
vitale importanza per l’economia un valido sostegno alle PMI,
ha “le mani legate”, perché deve bilanciare il principio della
parità di trattamento degli operatori economici, principio
fondante del sodalizio europeo, con delle misure che comun-
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 ,“Una corsia preferenziale per la piccola impresa” alla ricerca di un
nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act”
per l’Europa).
amministrativo
Gazzetta
108
d i r i t t o
a m m i n i s t r at i v o
que favoriscono alcuni (la maggior parte) attori del mercato.
La natura non vincolante degli atti della Commissione è l’indice di un compromesso tacito tra le istituzioni europee
(Commissione e Corte di Giustizia).
La stretta interpretazione dei principi comunitari ed, in
particolare, del principio di parità di trattamento, ha indotto
la Commissione europea a porre il veto su tutte le misure che
possano operare una distorsione del mercato, favorendo in via
diretta le PMI.
Così non sono state indicate misure come i contratti (c.d.
set-aside) e le quote di appalti riservati o meccanismi di preferenza regionale, prevedendo, invece, sistemi che indirettamente siano in grado di facilitare la partecipazione delle PMI
alle procedure di affidamento e riducendo i tempi e gli oneri
amministrativi e burocratici.
Le piccole e medie imprese, per quanto possano essere
competitive, sono sempre in una posizione di svantaggio rispetto ad un’impresa di grandi dimensioni e, dunque, necessitano di un trattamento differenziato, per tale ragione gli
interventi indicati nel Codice di Buone pratiche sono finalizzati a ristabilire un’eguaglianza sostanziale del mercato,
correggendo l’assetto di norme che astrattamente pongono
tutti gli operatori economici sullo stesso piano, ma che, in
realtà, non tengono conto dei profili di specialità di cui sono
corredate le PMI.
2. La rilevanza delle norme contenute nello Statuto delle imprese
e le ragioni di una legiferazione di principio
Dal 2008 al 2012 vi è stato un globale miglioramento del
contesto giuridico in cui operano le PMI europee. Questo è il
risultato dell’analisi della Commissione europea pubblicata
nello SME Performance Review2 . Tuttavia, i dati sull’attuazione in Italia dello SBA sono complessivamente sotto la media
europea. La legge 180/2011 il c.d. Statuto delle imprese nasce
dalla necessità di adottare delle misure per favorire la crescita
delle PMI, ma anche con l’intento più ambizioso di ristabilire
la fiducia dei mercati verso l’economia italiana, in un contesto
politico e finanziario complesso in cui versa il nostro Paese.
Si tratta di una legge che nelle sue dichiarate finalità doveva costituire il veicolo di attuazione dello Small business
act for Europe nel nostro ordinamento e non un pacchetto di
misure urgenti, per risollevare le sorti dell’imprenditoria italiana, com’era, forse, nelle aspettative del Governo e degli
imprenditori stessi3. Lo Statuto delle imprese non contiene
misure per la crescita immediatamente esecutive, ma, al con-
2 Si tratta di uno strumento informativo che attraverso delle schede di riferimento nazionali effettua una ricognizione del ruolo delle PMI nelle economie di
ogni Stato membro, e monitora il profilo di attuazione dello SBA in ogni Paese
sulla base di 62 indicatori statistici, effettuando un confronto con la media
europea. La scheda informativa della Commissione Europea riguardante i dati
2010/2011 delle PMI italiane è disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance .
3 La legge 180/2011 all’art. 1 espressamente prevede che i principi della presente
legge hanno lo scopo di garantire la piena attuazione ed applicazione dello SBA.
Tuttavia, lo Statuto delle imprese non recepisce tutte le indicazioni che provengono dallo Small business act. Non sono presenti norme che facciano riferimento al secondo principio dello SBA e che incentivino gli imprenditori, che abbiano sperimentato l’insolvenza. Non vi sono norme che dettano misure o principi per aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico,
così come è previsto dal settimo principio SBA. Anche sui i principi concernenti la competenza, l’ambiente e l’internazionalizzazione, lo Statuto non prevede
nulla al riguardo.
Gazzetta
F O R E N S E
trario, è ricco di principi generali, che possono avere una
notevole importanza dal punto di vista sistematico e che porteranno dei risultati concreti solo con il passare del tempo e
attraverso l’applicazione degli indirizzi previsti. Attraverso la
lettura comparata dello SBA e dello Statuto delle imprese, si
ha l’immediata percezione che il legislatore italiano tenti di
dare attuazione ai principi SBA con norme dello stesso tenore.
Questa circostanza effettivamente pone delle perplessità, sia
sul piano dell’ordinamento interno e cioè sull’efficacia concreta delle norme contenute nella legge 180/2011, sia sull’effettiva attuazione degli indirizzi dell’Unione Europea.
La legislazione sulle PMI. è parte di un sistema che potenzialmente è sottoposto ad una disciplina formata da vari livelli di regolazione (c.d. multilevel system).
Oltre alla regolamentazione europea e statale, tale ambito
in alcuni settori cruciali degli appalti (lavori pubblici di interesse regionale, approvazione dei progetti ai fini urbanistici
ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e
requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro) può rientrare nella potestà legislativa regionale concorrente e residuale.
Ciò può costituire una ragionevole spiegazione della mancanza di incisività del legislatore statale.
La Commissione parlamentare competente sulle questioni
regionali, nel parere redatto sullo Statuto delle imprese, sottolinea proprio questo aspetto, mettendo in risalto che la
legge 180/2011 potrebbe costituire un “tentativo di ampliare
i limiti della competenza legislativa statale e di aggirare la
potestà regionale in materia di PMI”4. In realtà, la situazione
è ben più complessa: la divisione delle competenze legislative
tra Stato e Regioni è ricca di zone d’ombra, di aspetti e di
materie che sono a cavallo tra le due potestà. Nel caso delle
P.M.I. la competenza andrebbe ricostruita sulla base dei contenuti che si riscontrano nel testo di legge. Occorre precisare
che una rigida ripartizione tra le materie non vi può essere e
che anzi anche all’interno di uno stesso ambito si possono
intrecciare aspetti che rientrano sia nella potestà legislativa
statale, che regionale.
Risolutivo, in tali casi, è “il principio della prevalenza”,
predisposto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale,
che è tendenzialmente orientata a tutelare la potestà legislativa statale5.
Infatti, valutando l’ottica regionalista si sarebbe portati a
far rientrare la legislazione sulle PMI nella potestà legislativa
regionale esclusiva, perché residuale.
A ben vedere, però, lo Statuto delle imprese è ricco di
contenuti che sono strettamente ricollegabili alla “tutela della concorrenza”,inoltre, tale legge, come precedentemente è
stato sottolineato, è emanata in attuazione dei “rapporti con
l’Unione Europea”,entrambe materie di esclusiva competenza
statale.
Il legislatore dello Statuto, in questo che appare, ed è, un
groviglio di competenze è intervenuto sommessamente con un
4 Parere della Commissione questioni regionali del 25 Ottobre 2011.
5 Corte Costituzionale sentenza n. 401/2007, in cui viene recesso ogni collegamento naturale tra la disciplina degli appalti pubblici e la potestà legislativa
regionale invocando la prevalenza della potestà legislativa statale riconducendo
la legislazione degli appalti pubblici nella materia della tutela della concorrenza di cui all’art.117, comma 2, lett.e.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
testo di legge che dà le linee guida, senza il rischio di invadere con misure puntuali ambiti di competenza regionale, lasciando, quindi, l’attuazione dei principi, per larga parte alla
Pubblica Amministrazione e consentendo, ove competenti,
anche alle Regioni di intervenire con una legislazione di dettaglio6. Paradigmatiche, in tal senso, risultano le norme statutarie (art.13 comma 2 lett. c) per favorire l’accesso delle PMI
agli appalti di fornitura e di servizi pubblici locali, banditi dai
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per
importi inferiori alle soglie comunitarie. L’architettura dei
meccanismi agevolativi viene lasciata alle determinazioni
degli Enti, dando loro solo degli indirizzi generali, cui dovranno attenersi in sede di composizione del bando. Identiche
considerazioni valgono per le modalità di coinvolgimento sia
delle PMI, nella realizzazione di grandi infrastrutture, che
delle imprese residenti nelle Regioni sono localizzati gli investimenti. Dal tenore della norma non si ravvede quali possano
essere le modalità di coinvolgimento delle PMI alle grandi
opere. In realtà, non sarà possibile riservare alle PMI quote
di lavori, perché ciò violerebbe i principi che reggono la concorrenza, ma le stazioni appaltanti dovranno utilizzare gli
strumenti offerti dagli istituti della suddivisione in lotti e del
subappalto. Complessivamente risulta non agevole immaginare quali concrete ed effettive ricadute positive potranno
registrarsi nell’interesse degli operatori economici di minori
dimensioni, lasciando l’attuazione dei principi SBA nella disponibilità delle stazioni appaltanti; in tal modo, si accentua
il rischio che queste indicazioni rimangano “lettera morta”.
Introdurre un regime speciale, o meglio, dei meccanismi riequilibrativi che tengano conto dei caratteri di specialità di cui
sono corredate le PMI, non è compito facile per il legislatore.
Sono molti i limiti che gli si pongono davanti e, allo stesso
tempo, sono numerosi i punti critici della disciplina degli
appalti da superare, per consentire un maggiore grado di accessibilità alle gare. Seppure la Commissione europea, in sede
di risultati di attuazione dei principi SBA in materia di appalti pubblici, ha promosso il sistema italiano (unico settore SBA
a registrare un trand positivo sopra la media europea).
La partecipazione agli appalti delle PMI in Italia è, comunque, fortemente condizionata dal costo e dai tempi lunghi
per l’assolvimento degli obblighi burocratici richiesti per
partecipare alle gare.
Gli ostacoli per le PMI iniziano, quindi, ancor prima di
poter presentare l’offerta, data la complessità degli adempimenti da compiere.
I costi in termini di ore di lavoro dei dipendenti, sommate
alle spese vive per assolvere agli oneri amministrativi costituiscono un ostacolo alla partecipazione alle gare d’appalto. Tali
elementi gravano sulle ridotte strutture gestionali delle PMI per
il cui assolvimento può essere necessario anche un tempo maggiore rispetto ad un’impresa di dimensioni più rilevanti.
Le esigenze legate al “fattore temporale”, nella maggior
parte dei casi, non vengono prese in considerazione dalle
stazioni appaltanti, quando fissano le scadenze dei bandi di
gara.
6 Sintomatica, a tal proposito, la norma statutaria contenuta nell’art.1 commi 3
e 4 dove viene fatta salva esplicitamente la competenza legislativa sia delle
Regioni a statuto speciale, che di quelle a statuto ordinario.
2 0 1 2
109
La legge 180/2011 ed i successivi provvedimenti legislativi del Governo Monti pongono la loro attenzione sul tema
della semplificazione (in particolare d.l. n. 5/2012 c.d. Semplificazioni).
Lo Statuto prevede (art. 13 commi 3 e 4) che le stazioni
appaltanti non possano chiedere alle imprese documenti e
certificati già in loro possesso o documentazione aggiuntiva
rispetto a quella prevista dal Codice dei Contratti.
Non si segnalano sostanziali novità; tali norme appaiono
duplicative di disposizioni ordinamentali, già vigenti, poiché
la stessa regola è già contenuta nell’articolo 18 comma 2 della l. 241/1990.
Sull’applicazione del principio dell’autocertificazione integrale nella fase di ammissione alle gare d’appalto, non è più
possibile dubitare già dopo l’introduzione dell’art. 77-bis del
d.P.R. n.445/2000 e le successive disposizioni del Codice dei
contratti. In effetti, la norma potrebbe, forse, avere un senso,
solo se riferita in generale alla possibilità del concorrente di
adempiere agli obblighi di produzione documentale mediante
autocertificazioni, superando la disciplina della verifica dei
requisiti speciali di cui all’art. 48 del Codice, atteso che per
la verifica del possesso dei requisiti generali opera da tempo
il principio dell’acquisizione d’ufficio, ulteriormente rafforzato dalle nuove disposizioni dell’art. 15 della legge 183/2011
(c.d.legge di stabilità 2012).
La norma statutaria sembra, infatti, introdurre una modifica al meccanismo della c.d. verifica a campione, come è
delineato del comma 1 dell’art. 48 del Codice. La disposizione introduce un “doppio binario”, definito in relazione alla
tipologia dei soggetti concorrenti.
Se alla gara partecipano micro-piccole-medie imprese a
queste non è possibile richiedere la documentazione probatoria dei requisiti speciali, con la conseguenza che risulterebbe
priva di scopo il computo di queste ai fini della determinazione del campione (10% delle offerte presentate).
Le norme statutarie non appaiono risolutive di quelli che
sono i problemi delle PMI per l’eccessiva burocratizzazione
del procedimento di partecipazione agli appalti. Chiari effetti di semplificazione dovrebbero,invece, provenire da misure
che non sono state predisposte per favorire in modo particolare le PMI. Ci si riferisce all’introduzione con l’art.6 bis del
Codice, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di
cui al d.l. n. 5/2012. Il nuovo Ente, a partire dal 01/01/2013,
acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per poter accedere alle procedure disciplinate dal D.lgs. 163/2006. Con l’informatizzazione e lo snellimento della produzione dei documenti e dell’attestazione dei
requisiti vi saranno effetti positivi in chiave di semplificazione per tutte le imprese e ricadute positive anche in sede di
controllo della PA. Infatti, la verifica del possesso dei suddetti requisiti, da parte degli enti aggiudicatori, avverrà esclusivamente mediante la Banca dati nazionale.
3. Il sub appalto e la suddivisione in lotti:quali innovazioni?
Nello Statuto si riscontra una maggiore concretezza, nelle norme adottate per il superamento degli impedimenti
connessi all’entità degli appalti .
Le PMI, che potenzialmente parteciperebbero alle gare,
spesso sono escluse, semplicemente per la loro incapacità di
amministrativo
Gazzetta
110
d i r i t t o
a m m i n i s t r at i v o
presentare un’offerta per l’intero contratto, o perché non
posseggono i requisiti finanziari richiesti, o la dimensione dei
lavori non si adatta alla loro capacità produttiva.
Il primo ostacolo viene superato dallo Statuto con l’art.
13 comma 5, che pone il divieto alle stazioni appaltanti di
prevedere requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni o dei servizi oggetto del contratto. Il comma 5
recepisce un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato in
sede di impugnazione del bando di gara e consente di non
vanificare il favor per la suddivisione in lotti degli appalti7.
Tutto ciò per evitare che le stazioni appaltanti costruiscano
bandi di gara “tagliati su misura” per alcuni operatori del
mercato, prevedendo dei requisiti incongrui e inevitabilmente,
tagliando fuori la maggior parte dei potenziali concorrenti.
È una norma che solo indirettamente favorisce le PMI,
perché, in realtà, tutela tutti gli operatori economici, salvaguardando il più elementare principio di equità e di concorrenza.
Infatti, il legislatore statutario prende in considerazione solo i
requisiti finanziari, mentre l’indirizzo giurisprudenziale citato
dispone che il bando debba rispettare la proporzionalità anche
per ciò che concerne i requisiti tecnici. Il comma 2 dell’art. 13
della legge 180 è finalizzato a favorire l’accesso delle PMI alle
gare d’appalto attraverso la suddivisione in lotti.
è bene precisare, che solo in alcuni casi, le caratteristiche
di un appalto di notevoli dimensioni possa giustificare l’aggiudicazione ad un unico appaltatore, ma, nella maggior
parte, non vi è alcun impedimento normativo alla suddivisione degli appalti in lotti.
L’aggiudicazione di lavori e servizi in lotti separati consente, non solo un ampliamento della concorrenza, ma anche
un risparmio per le stazioni appaltanti e può favorire la crescita delle piccole e medie imprese, consentendo loro maggiori possibilità di aggiudicarsi le commesse pubbliche8.
Sul reale fondamento della relazione esistente tra frazionamento degli appalti ed ampliamento delle opportunità per
le PMI di entrare nel mercato, secondo alcuni commentatori,
si potrebbe dubitare, vista la particolare ampiezza applicativa,
già riconosciuta ai modelli collaborativi tra imprese quali
raggruppamenti, consorzi ed, in particolare, con l’istituto
dell’avvalimento. Tuttavia, è necessario tenere presente che
tali istituti comportano, comunque, oneri per il concorrente.
La Legge n.180 prevede che le stazioni appaltanti debbano
suddividere gli appalti in lotti o lavorazioni nel rispetto dell’articolo 29 del Codice, e purché ciò non comporti nuovi o
maggiori oneri finanziari, nonché, evidenziando le possibilità
di subappalto e garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti nei vari stati di avanzamento.
Con la lottizzazione degli appalti la dimensione dei lotti
più facilmente può corrispondere alle capacità produttive
delle PMI e consente anche di far emergere le imprese che
sono maggiormente specializzate nel settore con un consequenziale innalzamento del livello qualitativo del prodotto
offerto. La norma dell’art.13 comma 2 è comunque destinata
ad esplicare i suoi effetti già durante la “progettazione”
dell’appalto, fase disciplinata dall’art. 279 del Regolamento,
7 Cfr. Tar Campania- Napoli ,Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 471.; Tar Lazio-Roma,
Sez. III bis, 31 luglio 2007, n. 7259.
8 L. 180/2011, art.13, comma 2, lett. a.
Gazzetta
F O R E N S E
vincolando la stazione appaltante, a frazionare l’appalto complessivamente considerato in più lotti funzionali.
Risultano di grande attualità le indicazioni fornite dall’Autorità di vigilanza sulla nozione di “lotto funzionale”, intesa
come quella porzione di lavoro o servizio, la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle
altre parti dell’appalto9. In questo modo, ogni singolo lotto
avrà una propria autonomia, tentando di arginare lo spreco
di denaro pubblico nel caso in cui l’opera non venga portata
a termine.
La lottizzazione non è certo una novità: l’art. 29 del Codice dei Contratti già contiene il principio di ispirazione comunitaria, per cui non si possono frazionare gli appalti a fini
elusivi dell’applicazione delle norme europee, ma riconoscendo al tempo stesso la possibilità di scomporre un lavoro o un
servizio, a condizione che si applichi il diritto UE, se la somma
degli importi dei singoli lotti supera la soglia comunitaria.
Non è chiaro, invece, se l’incremento delle possibilità di subappalto, richieste dallo Statuto, debba essere inteso in senso
generale o circoscritto alla sola lottizzazione. Probabilmente,
la seconda soluzione risponde meglio alle finalità dello Statuto stesso, poiché offre alle PMI maggiori opportunità di ottenere subappalti che si adattano alle loro dimensioni, derivando dall’affidamento di un lotto, anziché di un intero appalto.
Il frazionamento in lotti e le maggiori garanzie per il subappalto sono da considerare le disposizioni che hanno il
carattere maggiormente innovativo e concreto di tutto il testo
di legge, tanto che le norme di cui alla lettera a) e alla lettera
d) dell’art. 13 comma 2 sono state successivamente riprodotte dalla c.d. manovra Monti nel quadro dei principi generali
dei contratti pubblici.
L’art.2 del Codice appalti è stato ampliato dal d.l. n.
201/2011 con due nuovi commi.
Il comma 1 bis, che introduce espressamente il principio,
secondo cui in materia di appalti pubblici le stazioni appaltanti, “devono, ove possibile, suddividere gli appalti in lotti
funzionali”.
Il comma 1 ter ribadisce il favor per l’instaurazione di
meccanismi tesi a garantire modalità di coinvolgimento delle
PMI nella realizzazione di grandi infrastrutture compresi
insediamenti produttivi e strategici. Quest’ultimo si presta ai
medesimi rilievi che, precedentemente sono stati fatti alla
luce dell’art.13 comma 2 lett.d. L’inserimento di questa norma, nel Codice dei contratti, conferisce al principio previsto
un valore meramente rafforzativo, ma nulla di più.
L’interpretazione e l’applicazione del nuovo comma 1 bis
dell’articolo 2 pongono qualche interrogativo, soprattutto per
ciò che concerne le condizioni che devono presentarsi, per
potere frazionare l’appalto. In particolare, la suddivisione
deve essere non solo tecnicamente possibile, ma anche economicamente conveniente.
Questi “requisiti” possono costituire una comoda via
d’uscita per le stazioni appaltanti.
Calando la norma nella realtà applicativa, il requisito
della convenienza economica appare subito quello più restrittivo nei confronti della suddivisione dei lavori.
9 Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, determinazione n. 5 del 9.6.2005.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
Si pensi solo all’ipotesi in cui l’accorpamento delle diverse
prestazioni sia fatta dalla stazione appaltante, per conseguire
delle “economie di scala” derivanti dalla semplificazione e
razionalizzazione della gestione dei rapporti contrattuali con
un unico interlocutore. Tuttavia, se da un punto di vista economico per la P.A. può non essere sempre conveniente la
frammentazione degli appalti, ciò deve, comunque essere
valutato alla luce del risparmio che si potrebbe conseguire con
l’aumento del livello di concorrenza e anche con l’aumento
della qualità dei prodotti e servizi prestati da imprese più
specializzate.
Chiaramente queste valutazioni ed i criteri con cui effettuare le scelte sono lasciate al bilanciamento degli interessi
delle stazioni appaltanti in sede di redazione del bando. Si
consideri che la suddivisione in lotti può portare loro benefici in un’ottica di medio e lungo periodo e non sempre le P.A.
hanno dimostrato tale lungimiranza. Dal tenore della norma,
si capisce subito che l’auspicato frazionamento non pare facilmente attuabile per tutti gli appalti. Inoltre, il requisito della
possibilità tecnica combinato con la convenienza economica
dilata la discrezionalità con cui la stazione appaltante può non
ritenere opportuno suddividere l’appalto in lotti. Seppure, è
previsto espressamente un obbligo di frazionamento in tutti i
casi in cui ciò sia tecnicamente praticabile, vi sono delle vie
d’uscita con cui la PA può svincolarsi.
In ogni caso, a fronte della novella introdotta dalla legge
180/2011 e alla luce dell’introduzione del comma 1 bis
all’art.2, la stazione appaltante dovrebbe motivare la scelta di
non operare il frazionamento in lotti, argomentando o ragioni di impossibilità oggettiva sul piano tecnico organizzativo,
ovvero che non sia conveniente dal punto di vista economico,
in quanto il frazionamento produrrebbe comunque maggiori
oneri. In tal senso, nel testo di legge non è previsto alcun
obbligo di motivazione della stazione appaltante, anche se
questa sembra opportuna alla luce del principio di cui all’art.
2, attraverso cui la frammentazione degli appalti diviene la
regola posta alla base del modus operandi della P.A., mentre
l’affidamento unitario deve costituire l’eccezione.
Prima dell’introduzione del nuovo principio, il giudice
amministrativo richiedeva alla stazione appaltante che procedesse all’accorpamento di lavori in un unico lotto e che, alla
base di ciò, vi fosse “un razionale presupposto di ordine sia
territoriale, sia funzionale che potesse giustificare tale
scelta”10. Non solo, ma la Pubblica Amministrazione aveva
già allora l’onere di dimostrare che l’accorpamento fosse la
migliore scelta rispetto alle altre soluzioni possibili.
A fronte di un bando di gara che prevede un appalto non
suddiviso in lotti, la piccola e media impresa, che non è in
grado di soddisfare i requisiti tecnici ed economici più elevati
dovuti alla maggiore entità della gara, non aveva precedentemente e forse non ha ancora sicure prospettive di tutela. Infatti, per giurisprudenza consolidata, il bando, che presenta
clausole con effetti che escludono ab origine un potenziale
concorrente, è immediatamente lesivo della sfera giuridica
dell’impresa e quindi l’impugnazione dell’atto è esperibile
vittoriosamente. Tuttavia, il giudice amministrativo, sull’al-
10 Cons. Stato, Sez.V, 20 marzo 2007 n. 1331; Tar Puglia- Bari, 19 febbraio 2007,
n.475; Tar Lazio - Roma, 11 marzo 2004, n. 2375.
2 0 1 2
111
ternativa tra accorpamento e frazionamento, si è espresso,
fino a questo momento, nel senso che “non esistono rigidi ed
espressi divieti volti ad impedire che più opere possano essere
affidate ad una stessa impresa sulla base di un’unica gara”11.
Alla base di tale risoluzione della stazione appaltante
viene addotta la presenza di precisi nessi di carattere funzionale, temporale, oppure logistico ed economico, non escludendo, però, che l’accorpamento in un’unica gara possa essere disposto anche quando la realizzazione di opere o la fornitura di servizi è astrattamente scomponibile. Come abbiamo
avuto modo di analizzare, neanche con la normativa vigente
vi è un divieto rigido di accorpamento, ma si tratta di una
norma che, seppure esplicitamente impone di suddividere gli
appalti in lotti, allo stesso tempo, concede alle stazioni appaltanti nella fase attuativa la possibilità di disattendere a tale
regola.
Il problema del frazionamento in lotti si pone a seconda
della prospettiva con cui si analizza la fattispecie. Il giudice
amministrativo, nelle sentenze in cui affronta il tema, tende
a preservare prevalentemente il rispetto della disciplina comunitaria sulla concorrenza, secondo cui l’accorpamento di
procedure di appalto teoricamente scindibili, non è esplicitamente vietato12.
Con l’introduzione del comma 1 bis all’art.2, quale principio generale della disciplina dei contratti pubblici, la giurisprudenza dovrà rivalutare alcune posizioni, estremamente
restrittive.
In questo cambio di direzione sarà fondamentale l’analisi
di come opereranno le stazioni appaltanti nel bilanciamento
degli interessi in gioco,alla luce anche del nuovo principio
della suddivisione in lotti. L’amministrazione non potrà più
compiere liberamente “apprezzamenti caso per caso”,in quanto si riduce notevolmente, ma non si estingue del tutto, la
discrezionalità con cui la P.A. compie le proprie valutazioni
in merito13.
Il concreto esercizio del potere discrezionale deve, infatti,
essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento di appalto e
deve rispettare le specifiche norme del Codice dei contratti. Il
giudice amministrativo è chiamato a sindacare tali scelte ed
a tutelare l’applicazione del diritto vigente.
Oggi un obbligo per le stazioni appaltanti c’è e non potrà
più essere ignorato. Se nel passato il giudice poteva dire a
chiare lettere che “non esiste un principio generale di non
cumulabilità di più appalti in un’unica competizione”, con la
riforma dell’art.2 del Codice dei Contratti tale affermazione
non trova più preciso riscontro nella normativa vigente14. La
prassi amministrativa degli appalti e la giurisprudenza ci
daranno nel prossimo futuro un riscontro su quale posizione
prevarrà e in che modo verrà valutato, alla luce del nuovo
art.2, il frazionamento degli appalti .
Il problema delle dimensioni degli appalti può essere fronteggiato anche consentendo ad un operatore economico di
fare affidamento sulle capacità economiche e finanziarie,
11 Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2003, n. 7620.
12 Tar Lazio-Roma ,29 luglio 2008, n. 7625.
13 Tar Emilia Romagna- Parma, 6 dicembre 2006, n. 589.
14 Cons. Stato, Sez.VI, 27 novembre 2006, n.6908; Tar Liguria,15 Aprile 2005,
n. 502.
amministrativo
Gazzetta
112
d i r i t t o
a m m i n i s t r at i v o
nonché sulle competenze tecniche di altre imprese. Incentivare le aggregazioni di PMI, indipendentemente dalla forma
giuridica che li lega, è un indirizzo che viene proposto anche
dal Codice di buone pratiche della Commissione europea. Lo
Statuto delle imprese tenta di recepire tale indicazione nel
secondo comma lett. b dell’art.13, dove prevede, che le stazioni appaltanti debbano semplificare l’accesso agli appalti delle
aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese, privilegiando
associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di
impresa. Tale norma è assistita dalla eadem ratio degli altri
commi dell’art.13 anche se dalla lettura della disposizione non
si comprende quali siano i concreti modelli attuativi. Anche
in questo caso il legislatore enuncia un principio che viene
lasciato alla libera attuazione delle stazioni appaltanti. Inoltre, la formulazione della norma non viene in aiuto, prevedendo esplicitamente, che è necessario privilegiare alcune tipologie di aggregazioni d’impresa. Tale previsione può indurre in
errore nel difficile equilibrio con il principio di non discriminazione. Fornire degli strumenti e delle possibilità in più alle
PMI è comunque possibile.
In primis, le PA per attuare il favor espresso nello Statuto
devono concedere il tempo necessario alle imprese per definire le forme di cooperazione .
La necessità di tempi sufficienti per redigere l’offerta è
particolarmente importante negli appalti di grandi entità,
dove, per poter partecipare, le PMI devono, preliminarmente,
trovare dei partner con cui presentare un’offerta congiunta.
Le autorità aggiudicatrici dovrebbero preparare gli operatori
del mercato agli appalti che si intendono bandire, attraverso
la pubblicazione di avvisi di pre-informazione, che consentano ai potenziali partecipanti di avere a disposizione un lasso
di tempo sufficiente per l’elaborazione di un’offerta comune.
Inoltre, il legislatore statutario avrebbe potuto prevedere la
costituzione di un ente nazionale sul modello della Enterprise Europe Network, che abbia il preciso compito di sostenere
le PMI, attraverso un servizio di consulenza, che consenta di
sfruttare al massimo le opportunità disponibili, mettendo in
contatto fra loro le piccole e medie imprese e assistendole
nella ricerca di partner15.
4. Il problematico coordinamento dello Statuto delle imprese con
il Codice dei Contratti Pubblici anche alla luce dei “decreti Monti”
Lo Statuto delle imprese non è solo composto da principi
generali a cui necessitano ulteriori provvedimenti per essere
attuate, come risulta dalle disposizioni commentate, ma vi
sono anche norme self executing ,in particolare, ci si riferisce
agli artt. 12 e 15.
Questi ultimi, anche se in modo diverso, fanno espresso
riferimento al d.lgs. 163/2006.
Il primo, abrogando esplicitamente parte dell’art. 91 ed
innalzando le soglie di accesso agli appalti contenute nell’art.91
comma 1 del Codice dei contratti, passando da una soglia di
100.000 euro a 125.000 euro, le soglie minime per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e da 100.000 a 193.000 euro la soglia
per gli affidamenti con gara da parte delle amministrazioni
locali. Vi è stato un dietrofront a tali modifiche con il ripristi-
15 Cfr. il sito www.enterprise-europe-network.ec.
Gazzetta
F O R E N S E
no del testo previgente e l’abrogazione dello stesso art. 12, a
seguito del decreto-legge n. 201/2011 art. 44,comma 5, convertito senza modifiche con l. 214/2011. Anche l’art. 15 contiene un puntuale rimando al Codice dei Contratti, infatti, è
stabilito che la norma di cui all’art.118 comma 3, secondo
periodo, sia applicata anche alle somme dovute agli esecutori
in sub contratto in fornitura con posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori,
oppure in base allo stato di avanzamento delle forniture.
La norma del d.lgs. n.163/2006 richiamata dall’art.15
prevede che qualora gli affidatari di un contratto non trasmettano alla stazione appaltante le fatture dei pagamenti effettuati al subappaltatore nel termine di 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento agli affidatari.
L’art.15 mira ad estendere l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 118, comma 3, del Codice anche al caso
dei subcontratti di fornitura con posa in opera. Tuttavia,
poiché la fornitura con posa in opera, se presenta le caratteristiche descritte dell’art. 118, comma 11, del Codice, è da
considerarsi senz’altro un subappalto a tutti gli effetti, non vi
è dubbio che la stessa già ricada nell’applicazione dell’art. 118,
comma 3. E allora, anche in tale caso, o lo Statuto delle imprese si è limitato a ribadire una disposizione già esistente,
oppure ha inteso estendere la portata dell’art. 118, comma 3,
anche ai contratti di fornitura e posa in opera che non presentino le caratteristiche per l’assimilazione ai contratti di subappalto (cioè le caratteristiche descritte dell’art. 118, comma 11,
del Codice.). Lo Statuto delle imprese incide inevitabilmente
sulla disciplina del Codice dei Contratti, ma ad eccezione
dell’art.12, che prevede un’abrogazione esplicita, le altre norme statutarie sono da coordinare, ove possibile, con la disciplina codicistica.
Una mancata abrogazione esplicita di norme contrastanti
o che, comunque, pongono delle deroghe alla disciplina generale, determinano dei problemi interpretativi di rilevante entità. Per tale ragione, sarà lecito domandarsi se, e in che modo,
tali disposizioni siano coordinate con la disciplina prevista
dal Codice, visto che alcune di esse sono in contrasto con
essa. É abbastanza chiaro che il legislatore dello Statuto non
si è posto nell’ottica del fruitore del diritto, cioè di coloro che
avrebbero dovuto poi ricostruire il quadro normativo da applicare al caso concreto.
A tali problemi tenta di dare rimedio il d.l. n. 201/2011,
trasponendo alcune innovazioni dello Statuto nel Codice dei
Contratti, ma anche, in questo caso, rimangono dei nodi irrisolti.
Due disposizioni cruciali per la struttura normativa dello
Statuto non sono state introdotte nel Codice dei Contratti
Pubblici da parte del “Decreto Monti”: i commi 3 e 4 dell’articolo 13. Le motivazioni della mancata traduzione di tali
disposizioni, in modifiche al Codice dei Contratti, è da ricercare nel fatto che la possibilità per le imprese di presentare
autocertificazioni è già contenuta nell’art. 38, 41 e 42 del
Codice, oltre ad essere prevista dalla l. n. 241/1990, la quale
pone il divieto per la P.A. di chiedere certificati o documenti
di cui sia già in possesso. Invece, il comma 4 dell’art. 13,
presenta problemi di compatibilità con l’art. 48 comma 2 del
Codice, in quanto se la P.A., nel caso di micro, piccole e medie
imprese, chiede solo all’impresa aggiudicataria la documen-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
tazione probatoria dei requisiti di idoneità, questo va a modificare in maniera sostanziale il regime della cauzione provvisoria. Infatti, in caso di mancata dimostrazione del reale
possesso dei requisiti di ordine speciale, da parte delle imprese ammesse e sorteggiate, quindi, non ancora aggiudicatarie,
viene prevista come atto dovuto l’escussione della cauzione
provvisoria. Inoltre, l’art. 13 comma 4, come abbiamo precedentemente sottolineato, sembra introdurre una modifica al
meccanismo della c.d.verifica a campione, così come è delineata dal comma 1 dell’art. 48 del Codice.
Oltretutto anche l’art. 41 comma 4 del Codice dei Contratti in tema di dichiarazioni di istituti bancari attestanti la
capacità finanziaria di un’impresa deve essere coordinato con
l’art. 13 commi 4 e 5. Rimane da predisporre il coordinamento tra l’art. 118 comma 3 in tema di sub-appalto, che deve
essere letto alla luce dell’art. 13 comma 2 dello Statuto delle
imprese. Il legislatore statutario ha specificato che in caso di
subappalto, dovrà essere direttamente la stazione appaltante
a pagare il subaffidatario, derogando all’articolo 118 comma
3 del Codice, che, invece, dispone una duplice possibilità,
prevedendo sia il pagamento diretto del subappaltatore da
parte della stazione appaltante e, in alternativa, il pagamento
tramite gli affidatari principali .
La norma statutaria ha il sapore di una misura dal carattere eccezionale e, quindi, appare più logico che la sua efficacia sia circoscritta ai soli subappalti di un lotto. In caso contrario, infatti, diventerebbe una regola generale, che toglierebbe ragione di esistere alla possibilità di un pagamento da
parte dell’appaltatore, come previsto dal Codice.
Dalle considerazioni, che sono state fatte, si desume che un
vero e proprio regime speciale per le PMI non è stato creato
con l’emanazione dello Statuto delle imprese. Le norme statutarie immettono le PMI in un rapporto di specialità, rispetto
alle imprese più grandi, ma ciò avviene solo astrattamente,
perché la maggior parte di queste ha natura programmatica.
In definitiva, lo Statuto dà degli indirizzi cui si dovrà
dare seguito attraverso un’attuazione concreta; tale circostanza pone la legge 180/2011 “in un limbo” a causa delle incertezze per la sua applicazione. Appare evidente che alla stato
attuale le necessarie iniziative devono partire dalle Pubbliche
Amministrazioni che dovranno bandire appalti “intelligenti”,
mirati a massimizzare la concorrenza in mercati che sono
spesso viziati dall’oligopolio o dal dominio di grandi imprese.
Queste ultime non sono dei fornitori convenienti per la P.A.,
perché, inevitabilmente, dettano condizioni e prezzi. In considerazione del fatto che le maggiori criticità del nostro sistema, rispetto alla media europea, sono state registrate nel costo
del recupero crediti, nei costi di avvio di un’impresa, nei termini di pagamento eccessivamente lunghi delle autorità pubbliche, nella scarsità di imprese che offrono formazione e ricerca, l’imprenditoria italiana attendeva un intervento legislativo che adottasse misure più concrete16. Nonostante i numerosi limiti dello Statuto, il quadro complessivo che si può
delineare, non è del tutto negativo.
16 Si deve segnalare, sotto il profilo della lotta ai ritardi nei pagamenti della P.A.,
che l’art. 10 dello Statuto delle imprese contiene una delega al Governo, affinché lo stesso attui ,attraverso lo strumento della legislazione delegata, il recepimento della direttiva 2011/7/UE, entro il termine di 12 mesi.
2 0 1 2
113
Un primo passo è stato fatto nei confronti delle PMI e
questo è un dato di fatto.
In Italia, dal dopo guerra in poi, la politica e le Istituzioni,
hanno incoraggiato prevalentemente lo sviluppo delle grandi
imprese17. Lo slancio verso una nuova cultura imprenditoriale, proiettata in una politica economica nazionale fondata sul
principio think small first, è sicuramente apprezzabile, ma in
tempo di crisi non è sufficiente a tamponare i problemi contingenti che devono affrontare le PMI.
amministrativo
Gazzetta
17 Risulta opportuno invertire la prospettiva di G. Agnelli secondo cui: “quello
che fa bene alla FIAT fa bene all’Italia”.
114
d i r i t t o
●
Rassegna
di giurisprudenza
sul Codice
dei contratti pubblici
di lavori, servizi
e forniture
(d.lgs. 12 Aprile 2006,
n. 163 e ss. mm.)
●
A cura di Almerina Bove
Dottore di ricerca e Avvocato
presso l’Avvocatura Regionale della Campania
a m m i n i s t r at i v o
Gazzetta
F O R E N S E
Avvalimento dei requisiti di altra impresa - Richiede un’espressa
manifestazione di volontà, mentre il solo vincolo associativo derivante dalla costituzione dell’ATI non è sufficiente
L’istituto dell’avvalimento non opera automaticamente
per la semplice sussistenza di un vincolo associativo scaturente dall’A.T.I., poichè, mediante il raggruppamento, le
singole imprese assumono il mero impegno di costituirsi in
associazione nel caso di aggiudicazione della gara per l’esecuzione dell’appalto, senza l’insorgenza di ulteriori e specifici obblighi (nella specie riferibili alla messa a disposizione di
mezzi tecnici e/o finanziari). L’impresa che intenda avvalersi
dei requisiti di un’altra deve necessariamente darne atto in
sede di presentazione dell’offerta, e ciò in quanto l’Amministrazione deve poter verificare ab initio la sussistenza in capo
ad ogni partecipante dei requisiti richiesti dal bando. Non
può, d’altro canto, ritenersi che l’Amministrazione sia obbligatoriamente chiamata ad effettuare indagini ulteriori rispetto alla verifica dei contenuti esplicitati nelle domande presentate, al fine specifico di accertare se i requisiti di cui la
singola impresa risulti carente siano rinvenibili in altro soggetto del raggruppamento. Di qui la necessità che l’impresa
manifesti espressamente la volontà di avvalersi dei requisiti
di un’altra già in sede di presentazione dell’offerta.
Consiglio di Stato, sez. V, 6 dicembre 2012, n. 6257
Pres. Marzio Branca; Est. Antonio Bianchi
Bando di gara – È legittima la clausola che impone uno specifico
capitale sociale, non essendo ne’ irragionevole ne’ pregiudizievole per la partecipazione delle società di persone
La clausola contenuta nel bando di gara, che impone il
possesso di un determinato capitale sociale in capo alle imprese partecipanti, senza distinguere tra società di capitali
(che necessariamente tale requisito devono possedere) e società di persone (che invece non sono tenute a dotarsene) non
prescrive, per queste ultime, un obbligo di impossibile attuazione. La considerazione per cui queste società non sono
legalmente tenute a dotarsi di un capitale sociale non esclude
che le stesse abbiano piena facoltà di dotarsene e ciò anche
per dimostrare all’esterno la loro solidità economica e finanziaria. Inoltre, la richiesta di un capitale minimo per l’ammissione alla gara non è irragionevole, atteso che nell’ambito degli affidamenti di lavori pubblici il possesso di un determinato capitale sociale (e la sua dimostrazione da parte
dell’impresa partecipante) funge da garanzia per la Pubblica
Amministrazione in ordine alla solidità ed affidabilità
dell’impresa.
Consiglio di Stato, sez. V, sent. del 6 dicembre 2012, n. 6257
Pres. Marzio Branca; Est. Antonio Bianchi
Bando di gara - Il requisito tecnico richiesto, in caso di ATI, va riportato proporzionalmente dalle imprese associate e alle stesse
proporzionalmente imputato anche per i contratti pregressi
Se la legge di gara richiede quale requisito tecnico l’aver
stipulato un contratto pregresso con un importo minimo avente per oggetto il servizio dedotto in appalto, e che tale importo vada ripartito, in caso di imprese associate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione al raggruppamento
dichiarata nell’atto di impegno, tale regola di proporzione va
estesa, nel silenzio della lex specialis, anche ai contratti di
appalto pregressi, utili ai fini della dimostrazione del possesso
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
del requisito, eseguiti anch’essi in forma associata, stanti
l’identità della materia da regolare e l’identità di ratio.
Ne consegue l’insostenibilità del contrario assunto per cui
la capacità tecnica espressa andrebbe sempre invariabilmente commisurata al valore dell’intero appalto pregresso, indipendentemente dalle quote vigenti tra le componenti
dell’A.T.I. appaltatrice. L’interpretazione così proposta consentirebbe inammissibilmente a ciascun componente di
un’A.T.I. di avvalersi di esperienze di cui solo in parte, in
realtà, disporrebbe, per avere concorso all’esecuzione del
relativo contratto solo, appunto, in parte. Tale tesi inoltre
permettendo di imputare a se stessi precedenti esperienze
contrattuali proprie, in realtà, solo pro quota, contravverrebbe in radice alle esigenze di esperienza diretta e specifica
sottese alla prescrizione dei requisiti di capacità tecnica, che
impongono piuttosto di avere riguardo all’esperienza effettivamente maturata dal concorrente in ragione delle prestazioni da lui rese.
Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6243
Pres. Carmine Volpe; Est. Nicola Gaviano
Cessione di ramo d’azienda - La relativa comunicazione determina
l’obbligo della P.A. di esprimersi in ordine al subentro del cessionario nel contratto
A seguito della comunicazione dell’avvenuta cessione di
ramo di azienda dall’originario concessionario, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare in concreto la sussistenza in
capo alla cessionaria dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione del servizio in questione, al fine del subentro nel contratto ai sensi dell’art. 116 del Codice dei contratti pubblici,
di fornire una esplicita risposta in merito e, nel caso, di adottare la determinazione di risoluzione in contraddittorio con la
società ricorrente ai sensi dell’art.136 del Codice medesimo.
Un contegno di inerzia dell’Amministrazione concedente
sulla richiesta di subentro nel rapporto si configura quale
silenzio inadempimento che inficia anche il provvedimento
di risoluzione contrattuale.
T.a.r. Campania-Napoli, Sez. I, 14 novembre 2012, n. 04086
Pres. Cesare Mastrocola, Est. Fabio Donadono
Commissione aggiudicatrice - Ammissibilità di composizione
multidisciplinare
Salve specifiche ipotesi di incompatibilità, non può ritenersi illegittimamente costituita una commissione in cui
differenti competenze tecniche specifiche di cui siano in possesso i singoli commissari siano compresenti in modo da assicurare comunque completezza ed idoneità di giudizio.
Merita, in tal senso, condivisione l’orientamento secondo
cui non è necessario che tutti i componenti abbiano la medesima esperienza di settore ed uguali titoli: la competenza
tecnica deve, piuttosto, essere riferita alla commissione nel
suo complesso, in considerazione del fatto che essa costituisce
un organo che, anche in ragione della sua natura di collegio
perfetto, deve operare in funzione di un giudizio che sarà il
risultato di una valutazione finale imputabile congiuntamente a tutti i suoi componenti.
T.a.r. Campania-Napoli, Sez. VIII, 22 novembre 2012, n. 4760
Pres. Antonino Savo Amodio; Est. Paolo Corciulo
2 0 1 2
115
Commissione aggiudicatrice - Requisiti di idoneità alla nomina
quale componente
L’idoneità ad essere componente di una commissione
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006
n. 163, va valutata alla luce del possesso di titoli professionali e dell’esperienza maturata nel settore oggetto del contratto, ma senza che il dato relazionale tra specificità della
competenza ed elementi tecnici di valutazione debba assumere connotazioni di assoluta identificazione. Al fine di verificare l’idoneità del soggetto nominato, nel contemperamento
di esigenze organizzative e insopprimibili garanzie di imparzialità, può senz’altro farsi ricorso al principio di continenza
e compatibilità dei requisiti professionali dei membri di commissione: il criterio di continenza suppone che il possesso di
requisiti professionali di ordine più generale ed ampio possa
ritenersi presuntivamente sufficiente a giustificare anche
l’idoneità del commissario ad esprimere giudizi ed apprezzamenti nell’ambito di una disciplina specialistica, purchè
sempre attratta nell’orbita della disciplina professionale di
raggio superiore; il criterio di compatibilità va viceversa
inteso come elemento da apprezzarsi in negativo, nel senso
che impone di escludere l’idoneità di requisiti professionali
generali solo ove irrilevanti, se non addirittura in conflitto
con l’oggetto specifico del contratto.
TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sent. 22 novembre 2012,
n. 4760
Pres. Antonino Savo Amodio; Est. Paolo Corciulo
Offerta tecnica - Necessità, a pena di esclusione, della sottoscrizione in calce - Inidoneità di ogni altra modalità di sottoscrizione
In considerazione della natura ad substantiam della forma scritta dei contratti pubblici di appalto e della valenza
impegnativa della dichiarazione di offerta, la firma assolve
la funzione indefettibile di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità di quest’ultima e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il
profilo sia formale sia sostanziale, potendosi solo ad essa
riconnettere gli effetti propri della manifestazione di volontà
volta alla costituzione di un rapporto giuridico.
La mancanza della firma, che deve per definizione essere apposta in calce al documento, non può considerarsi a
guisa di irregolarità formale, sanabile nel corso del procedimento, ma inficia irrimediabilmente la validità e la ricevibilità dell’offerta, senza che, all’uopo, sia necessaria una
espressa previsione della lex specialis. In conformità all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, la sottoscrizione
conclusiva della dichiarazione di impegno non è surrogabile
dalla sottoscrizione solo parziale delle pagine precedenti
ovvero dall’apposizione della controfirma sui lembi sigillati
della busta che la contiene. Alla firma in calce di un documento non è equiparabile, d’altro canto, quella apposta solo
in apertura di esso (‘in testa’) ovvero sul solo frontespizio di
un testo di più pagine, in quanto unicamente con la firma in
calce si manifesta la consapevole assunzione della paternità
di una dichiarazione e la responsabilità in ordine al suo contenuto.
T.a.r. Campania-Napoli, Sez. VIII, 6 dicembre 2012, n. 4982
Pres. Antonino Savo Amodio; Est. Olindo Di Popolo
amministrativo
Gazzetta
Diritto tributario
Un’analisi critica del nuovo istituto del reclamo nel processo tributario
119
tributario
Clelia Buccico
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
●
Un’analisi critica
del nuovo istituto
del reclamo
nel processo tributario
● Clelia Buccico
Professore Associato di Diritto Tributario
Seconda Università degli Studi di Napoli
2 0 1 2
119
Sommario: 1. Premessa: prospettive e finalità del reclamo; 1.1.
Profili di incostituzionalità; 1.1.1 Il procedimento di reclamo
e la giurisdizione condizionata; 2.L’ambito applicativo:
2.1.La tipologia di atto impugnato; 2.1.1..Osservazioni sulla
disciplina degli atti suscettibili di mediazione; 2.2. Parte resistente nell’eventuale giudizi; 2.3. Il valore della controversia; 2.3.1.Carenza legislativa integrata dalla prassi: il problema della tutela cautelare; 2.3.1.1.Tutela cautelare ex art. 47
del D.Lgs. n. 546/1992 dopo il rigetto del reclamo; 2.4. La
data di notifica; 3. L’istanza; 3.1.Soggetti legittimati alla
presentazione dell’istanza; 3.2.Il contenuto formale dell’istanza; 3.3.La notificazione; 3.4. I termini di presentazione; 4.Gli
effetti della presentazione dell’istanza; 5.La trattazione
dell’istanza; 6.Mediazione parziale. 7. Ulteriori profili di incostituzionalità: la mediazione e il principio di indisponibilità della pretesa tributaria; 8.Conclusioni
1. Premessa: prospettive e finalità del reclamo
La Manovra estiva 2011 (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39
- convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) ha apportato talune interessanti modifiche alle norme che disciplinano il
processo tributario. In particolare l’articolo 39, comma 9, del
Dl 6 luglio 2011 n. 98, inserisce, nel corpo normativo del Dlgs
546/1992, in coda al capo II del titolo I che disciplina le parti
e la loro rappresentanza e assistenza in giudizio, il nuovo articolo 17-bis, rubricato «Il reclamo e la mediazione»con il
quale viene disciplinata una speciale procedura di reclamo e
mediazione avente ad oggetto le controversie relative ad atti
emessi dall’Agenzia delle entrate di valore non superiore a
ventimila euro.
Come giustamente sottolineato da parte della dottrina
(anche Turchi) la collocazione della norma non appare felice,
dal momento che gli istituti del reclamo e della mediazione
non interessano tanto i profili soggettivi della lite o quelli afferenti alle comunicazioni degli atti, quanto (sia pure solo in
modo eventuale) il procedimento che si svolge avanti alla
commissione tributaria provinciale, e avrebbero quindi trovato migliore collocazione all’inizio del capo I del titolo II, relativo appunto all’introduzione del giudizio di primo grado.
In data 19 marzo 2012 è stata poi emanata la Circolare n.
9/E dell’ Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Affari Legali e
Contenzioso e delle Finanze che spiega e analizza l’articolo 39,
comma 9, del Dl 6 luglio 2011 n. 98, seguita, per ulteriori
chiarimenti dalla Circolare n.33/E del 12 agosto 2012.
Se si può certamente ammettere che la modesta entità
delle liti oggetto di mediazione obbligatoria e l’elevato numero
di procedimenti pendenti possono costituire l’antefatto giuridico che ha alimentato l’iniziativa legislativa, al contempo si
deve sottolineare che in un sistema che già prevede l’autotutela e l’accertamento con adesione, non v’era probabilmente
bisogno di altri istituti intesi a permettere alle parti di definire il procedimento o il processo tributario senza attendere la
sentenza del giudice; in questo senso, il reclamo e la mediazione introducono un’ulteriore (necessaria) forma di contraddittorio fra il contribuente e l’Agenzia delle entrate che appesantisce, invece di semplificare, l’iter procedimentale da seguire,
e non sembra comportare reali vantaggi in termini di efficienza dell’azione amministrativa e di efficacia della tutela giurisdizionale. Non si vede in effetti quali chances di riuscita
possa avere un reclamo presentato dal contribuente dopo il
tributario
Gazzetta
120
d i r i t t o
fallimento del tentativo di adesione, o dopo il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela (Stevanato, Sepio, Turchi).
In realtà si deve sottolineare come il nuovo istituto è in
linea con la tendenza a riportare la determinazione della
ricchezza ai fini tributari nella sua naturale sede amministrativa, riservando il processo alle patologie dell’azione amministrativa. Infatti, va detto che nel nostro sistema il patologico
ricorso alla giustizia tributaria, anche per le liti minori, rappresenta un’anomalia legata ad una forzosa omologazione del
sistema processuale tributario a quello civilistico, con l’effetto che ci si dimentica spesso che la prima autorità ad intervenire nel rapporto giuridico d’imposta non è il giudice ma
l’Amministrazione finanziaria.
Il nuovo istituto si può inquadrare in linea generale come
un tentativo di superare l’impostazione privatistico-processualistica del giudizio tributario ed evitare che il giudice intervenga sull’accertamento positivo o negativo del credito erariale
anziché svolgere il ruolo che più gli compete ovvero quello di
controllo sul comportamento dell’Amministrazione.
L’istituto è destinato da un lato ad un obiettivo di veloce
riscossione da parte dell’Amministrazione finanziaria e,
dall’altro, di stimolo ai contribuenti al fine di evitare il vaglio
di una controversia non rilevantissima da parte del giudice
tributario sottoponendosi, fisiologicamente, all’alea della decisione del giudice medesimo. In altri termini, dunque, un
istituto che dovrebbe configurare una convergenza di interessi
e che dunque appare destinato al successo fermo restando che,
tale obiettivo, potrà essere raggiunto solo «se nella fase di
mediazione le aree legali dell’Agenzia e i difensori dei contribuenti si comporteranno applicando concretamente i principi
di collaborazione, buona fede, correttezza e ragionevolezza».
Si aggiunga però, per onore di cronaca, che non è nuova
l’idea di introdurre nell’ordinamento tributario una sorta di
riesame in sede amministrativa, nell’ottica di perseguire finalità deflative del contenzioso.
Il disegno di legge governativo per la delega sulla riforma
del contenzioso tributario, nella versione originaria, prevedeva il «riesame preventivo in sede amministrativa dell’atto
impugnato o del rapporto controverso»: una sorta di «filtro
amministrativo», inteso quale strumento di deflazione del
contenzioso.
Per effetto degli emendamenti successivamente apportati,
nella legge delega n. 413/1991 il riesame preventivo in sede
amministrativa veniva trasformato nell’esame preventivo del
«rapporto tributario» da parte dell’organo giurisdizionale, e
specificamente della Commissione tributaria provinciale.
Conformandosi ai criteri direttivi formulati dal legislatore
delegante, l’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, rubricato, nella
formulazione originaria, «esame e definizione preventiva della
controversia», introduceva una sorta di «rito speciale abbreviato» il quale, escludendo «ulteriori gradi di giudizio (l’appello e il ricorso in Cassazione)», avrebbe consentito «di deflazionare le pendenze in sede contenziosa», in caso di adesione
espressa dall’Amministrazione finanziaria all’opzione per l’abbreviazione del rito, formulata dal contribuente nel ricorso.
A seguito di ulteriori interventi legislativi, ha trovato
collocazione nell’art. 48 la disciplina della conciliazione giudiziale, progressivamente allineata con l’istituto dell’accertamento con adesione, estendendone l’ambito di applicazione a
tutte le controversie devolute alla giurisdizione delle Commis-
t r i b u ta r i o
Gazzetta
F O R E N S E
sioni tributarie, comprese quelle di rimborso. La definizione
conciliativa della controversia si configura come prosecuzione, in sede processuale, dell’accertamento con adesione del
contribuente non concluso nella fase precontenziosa e rappresenta, indubbiamente, un efficace strumento di deflazione.
Dal 1° aprile 2012, per le sole liti «minori», la conciliazione giudiziale è stata esclusa, cedendo il passo ai nuovi istituti
del «reclamo» e della «mediazione».
Veniamo così all’analisi del testo normativo.
La norma sancisce che per gli atti notificati a decorrere al
primo aprile 2012, per le controversie, come detto, di valore
inferiore a ventimila euro, calcolato sulla base del valore del
tributo e al netto di sanzioni e interessi1, e relative ad atti
emessi dall’Agenzia delle Entrate2 , il contribuente che intende
opporsi al provvedimento dovrà preventivamente presentare,
alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto
(comma5) un apposito “reclamo” (avente peraltro ad oggetto
il contenuto “minimo” del ricorso). La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso (comma 2).
Il reclamo contestuale e simbiotico al ricorso giurisdizionale, è presentato allo stesso soggetto che ha emanato l’atto
contestato , il quale, nei novanta giorni successivi, può disporne l’annullamento totale o parziale. Per il comma 8, il reclamo,
infatti, è “volto all’annullamento totale o parziale dell’atto”,
e ciò costituisce palmare dimostrazione della sua reale natura:
esso, da questo punto di vista, altro non è che un ricorso in
opposizione amministrativa .
Il reclamo, però, assomma in sé ulteriore natura e funzione, identificandosi materialmente, fin dall’origine, con l’atto
introduttivo del processo e producendo gli effetti propri di
questo, secondo la disciplina ordinaria della legge processuale tributaria .
Nella sistematica dell’art. 17-bis, perciò, siamo in presenza di un ricorso bensì in opposizione, ma anche, in prima
battuta o almeno contestualmente, idoneo a interrompere il
termine processuale di 60 giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs
n. 546 e, in seconda battuta, ad assurgere ad “altro esemplare” dell’atto costitutivo del rapporto davanti alla commissione tributaria. Dunque, ci troviamo di fronte a un atto suscettibile di radicare due diversi tipi di procedimento: amministrativo e giurisdizionale.
Scopo immediato della legge, pertanto, è quello di concedere uno spatium deliberandi all’amministrazione affinché
1 Relazione illustrativa del decreto-legge (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) recante:
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria». Si sottolinea che ai
sensi del comma 3 dell’articolo 17bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, il valore
della controversia “è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5
dell’articolo 12”. Nella specie, il secondo periodo del predetto articolo 12,
comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che “Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente
alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
Pertanto, il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun
atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente
con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso
di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni,
il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate.
2 Di conseguenza, tra i requisiti posti dalla norma in commento vi è la legittimazione processuale passiva dell’Agenzia delle entrate nell’eventuale, successivo processo. Cfr Circ. n. 9/E del 19 marzo 2012 Agenzia delle Entrate – Dir.
Centrale Affari Legali e Contenzioso
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
essa stessa, ex auctoritate sua, provveda a correggere errori
nei quali è incorsa o ad emendare l’atto da possibili vizi, di
modo che l’esito di tale procedimento escluda l’interesse del
contribuente a radicare il rapporto processuale. Insomma, di
concedere all’agenzia uno spazio preprocessuale assai simile,
quanto agli effetti, all’autotutela in annullamento o revoca su
impulso di parte.
1.1. Profili di incostituzionalità
Come detto quindi, il reclamo ha natura di istanza amministrativa, suscettibile di convertirsi in ricorso giurisdizionale all’esito (negativo) del contraddittorio svolto presso la
Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate.
Viene così introdotta nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di giurisdizione condizionata al previo esperimento di
un’istanza amministrativa, che parrebbe porre problemi di
costituzionalità analoghi a quelli già affrontati in passato
dalla Consulta
1.1.1.Il procedimento di reclamo e la giurisdizione
condizionata
Un sicuro effetto derivante dall’applicazione dell’art. 17bis è quello di un rinvio dell’accesso alla giustizia pari alla
durata della procedura amministrativa obbligatoria3.
Rinvio che si traduce in una vera e propria preclusione
alla possibilità per il contribuente di un ricorso diretto (Il
comma 2 prevede che «la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado».).
In siffatta prospettiva, la procedura di reclamo potrebbe
allora considerarsi lesiva del diritto di difesa del contribuente
sulla scorta della giurisprudenza costituzionale in tema di
«giurisdizione condizionata».
Giova in proposito ricordare che non sono mancati i casi
in cui la Corte costituzionale ha riconosciuto l’opportunità
del differimento dell’azionabilità del diritto in ragione di
«esigenze di ordine generale» e «superiori finalità di giustizia»4,
di «pericoli di abusi»5, di particolari «interessi sociali»6.
Ciò ha portato una parte della dottirna (Turchi) a sottolineare che nel caso in esame, il differimento dell’azione giu-
3F. Pistolesi, op. loc. cit., pag. 26, manifesta perplessità circa la conformità della
disciplina all’aspettativa di durata ragionevole del processo riconosciuta e tutelata dall’art. 111 Cost., osservando come - considerando anche i novanta
giorni della procedura dell’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 19 giugno
1997, n. 218, i sessanta giorni previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e i
quarantasei della sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre
- il giudizio potrebbe non iniziare prima di nove mesi dopo la notifica dell’atto
dell’Agenzia delle entrate. Nello stesso senso A. Russo, «Manovra correttiva
(D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito) - Legittimità costituzionale del reclamo
e della mediazione nel processo tributario», in il fisco n. 30/2011, pagg. 1-4843,
il quale evidenzia che si supera un anno tra la notifica dell’atto e il pronunciamento in primo grado se si considerano anche il termine per la costituzione in
giudizio dell’Agenzia delle entrate pari a sessanta giorni (art. 23) e il termine
minimo per la comunicazione della fissazione dell’udienza pari a trenta giorni
(art. 31).
4 Corte cost., sent. 23 novembre 1993
5 Corte cost., sent. 4 marzo 1992, n. 82, in tema di controversie di lavoro
6 Corte cost., sent. 15 luglio 2003, n. 251, in tema di assicurazioni obbligatorie.
La Corte evidenzia come, in tale caso, la previsione di un preventivo ricorso
all’assicurazione si legittima con il fatto che quest’ultima è soggetto terzo che
necessita di raccogliere informazioni sul sinistro per procedere alla liquidazione
del danno senza necessità di avviare inutili contenziosi in sede giurisdizionale i
cui costi andrebbero a ricadere sulle tariffe delle polizze assicurative generalmente praticate
2 0 1 2
121
risdizionale è previsto per permettere alle parti di instaurare
una fase di mediazione amministrativa intesa a prevenire la
lite processuale, e perciò assimilabile ai tentativi obbligatori
di conciliazione già previsti dall’ordinamento e ritenuti
legittimi dalla Corte costituzionale.
In particolare, la Corte ha dichiarato manifestamente
infondate le questioni di costituzionalità delle norme del codice di rito che, regolando il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie di lavoro, avrebbero ritardato
l’esercizio dell’azione e generato questioni processuali inutili
e contrarie alla finalità perseguita, come quelle concernenti
appunto l’improcedibilità della domanda in difetto dell’attivazione del tentativo.
La Corte ha ribadito che l’art. 24 Cost., laddove tutela il
diritto di azione, non comporta l’assoluta immediatezza del
suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare interessi generali, con le dilazioni conseguenti7.Del resto, il tentativo obbligatorio di conciliazione
doveva essere esperito entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, decorsi i quali si considerava comunque
eseguito e cessava l’impedimento all’esercizio dell’azione. Si
trattava di un termine obiettivamente limitato e non irragionevole, anche considerando che la richiesta di parte produceva nella sostanza gli effetti della domanda giudiziale (sospensione del decorso di ogni termine di prescrizione e di decadenza per un tempo sufficiente ad instaurare la lite); che il giudice adito prima dell’esperimento del tentativo, o in pendenza
del relativo termine, si limitava a sospendere il processo e a
fissare il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo, dopo di che il processo doveva essere riassunto
entro centottanta giorni, a pena di estinzione; e che, già prima
e nel corso dell’espletamento del tentativo di conciliazione, la
legge ammetteva rimedi cautelari. In un simile contesto normativo, l’improcedibilità della domanda conseguente al
mancato esperimento del tentativo di conciliazione rappresentava semplicemente “la misura con la quale l’ordinamento
assicura effettività all’osservanza dell’onere”.
Queste considerazioni risultano in massima parte estensibili agli istituti regolati dall’art. 17-bis del d.lgs. 31-12-1992,
n. 546. Anche il reclamo e la mediazione tributaria sono
finalizzati a prevenire l’instaurazione del giudizio e rispondono agli interessi generali richiamati dalla Corte costituzionale; anche la presentazione del reclamo all’Agenzia delle
entrate produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e non grava di un onere eccessivo la parte interessata; e
anche la sanzione di inammissibilità del ricorso non preceduto dal reclamo può essere giustificata nella prospettiva
assunta dai giudici delle leggi. Né sembrano porsi – almeno
nella maggioranza dei casi – particolari problemi sul piano
della tutela cautelare, come meglio si dirà infra. Non pare
pertanto che la disciplina in commento, intesa alla luce dei
7 Corte Cost., 13-7-2000, n. 276, in “Giur. it.”, 2001, pag. 438, ove si legge che
il tentativo obbligatorio di conciliazione (poi soppresso nel 2010) tendeva a
“soddisfare l’interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato, evitando
che l’aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di
lavoro provochi un sovraccarico dell’apparato giudiziario, con conseguenti
difficoltà per il suo funzionamento; dall’altro, favorendo la composizione
preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento
più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo”.
tributario
Gazzetta
122
d i r i t t o
principi posti in materia dalla giurisprudenza costituzionale,
leda il diritto di difesa del contribuente.
La stessa Corte ha, tuttavia, più volte ribadito che la compressione del diritto di difesa che in tal modo si verifica deve
essere bilanciata dall’interesse ad un miglior funzionamento
della giustizia, riservando a sé il potere di verificare l’adeguatezza della soluzione adottata in relazione allo scopo perseguito8.
E si è infine precisato che, anche ricorrendo siffatte condizioni di utilità generale, «il legislatore è sempre tenuto ad
osservare il limite imposto dall’esigenza di non rendere la
tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, in conformità al principio della piena attuazione della garanzia stabilita dagli artt. 24 e 113 Cost.».
Si spiega, quindi, come, in diversi interventi in materia
tributaria9 ed extra-tributaria10, la Corte abbia dichiarato
l’illegittimità di disposizioni che disponevano la decadenza
del diritto di azione per la mancata attivazione del procedimento amministrativo11.
Nella disciplina in esame, giova ripeterlo, si sancisce
l’inammissibilità del ricorso non preceduto dalla presentazione del reclamo.
Dunque, diversamente da quanto ad esempio accade in
materia previdenziale (Cfr. art. 443 c.p.c.), l’omessa presentazione del reclamo ex art. 17-bis non comporta la sola sospensione del giudizio con obbligo di avvio della procedura
amministrativa, ma determina la decadenza del contribuente
8 Corte cost., sent. 18 gennaio 1991, n. 15, in tema di controversie con le Poste,
in Foro it. n. 1/1991, pag. 3060, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 20 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni). La norma subordinava l’azione di risarcimento dei danni contro
l’Amministrazione delle poste alla condizione del preventivo reclamo in via
amministrativa. La Corte osservava, tra l’altro, che la stessa eccessiva durata
del ricorso amministrativo (sei mesi) fosse per sé solo idonea a configurare un
contrasto con i parametri costituzionali. Inoltre, nella sentenza si legge che
«anche se il termine fosse ridotto in una misura più ragionevole, l’introduzione
nell’art. 20 del codice postale di una disciplina analoga a quella prevista dall’art.
443 c.p.c. non troverebbe giustificazione nella ratio di favore per il cittadino,
sulla quale tale disciplina si fonda in materia di controversie previdenziali. La
definizione di queste controversie implica un complesso di accertamenti tecnici
per i quali gli enti previdenziali dispongono di un’apposita organizzazione e di
personale specializzato, onde appare opportuno, nell’interesse dello stesso assicurato, che la fase giudiziaria sia preceduta da un esame della controversia in
sede amministrativa. Nelle controversie con l’Amministrazione postale, invece,
si tratta di accertare fatti di inadempimento (cioè disservizi) e la conseguente
responsabilità per danni. Per questo tipo di accertamenti il giudice dispone di
strumenti e conoscenze adeguati, mentre l’esperienza attesta la scarsa funzionalità, come mezzo di prevenzione delle liti, della condizione di accesso alla
giurisdizione prescritta dalla norma impugnata».
9 Cfr. Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 406, cit.; Id., 27 luglio 1994, n. 360,
in GT - Riv. giur. trib. n. 12/1994, pag. 1163, con commento di C. Glendi, «Anche per l’imposta sugli spettacoli non è più condizionato l’accesso all’a.g.o.»;
10 Corte cost., sent. 26 luglio 1979, n. 93, in tema di controversie di lavoro; Id.
18 gennaio 1991, n. 15, cit.; Id. 10 febbraio 1993, n. 40 e Id. 25 luglio 2008,
n. 296, in tema di controversie con le Ferrovie.
11Sono invece legittime quelle disposizioni che, all’omessa introduzione della
procedura amministrativa, fanno corrispondere la sola sospensione del processo. Riferendosi a questi casi, in dottrina e in alcuni pronunciamenti della Corte
costituzionale, si parla di «condizioni di procedibilità» dell’azione, distinguendole dalle «condizioni di proponibilità» che sono state dichiarate illegittime
perché ritenute troppo gravose. Il legislatore aveva certamente presente tali categorie allorquando, all’art. 443 c.p.c. in materia di controversie previdenziali,
ha previsto che «la domanda relativa alle controversie in materia previdenziale
e assistenza obbligatorie [...] non è procedibile se non quando siano esauriti i
procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa». Tuttavia, sull’assenza di uniformità di significato del termine «procedibilità» nel sistema normativo, cfr. S. La China, «voce Procedibilità (dir. proc.
civ.)», in Enc. dir., Milano, 1986, vol. XXXV, pag. 795; C. Glendi, «Procedimento di mediazione e processo civile», in Corr. Trib. n. 10/2011, pag. 801
t r i b u ta r i o
Gazzetta
F O R E N S E
dal diritto a ricorrere, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
E ciò, in base ai citati precedenti della giurisprudenza
costituzionale, sarebbe di per sé idoneo a suscitare dubbi
sulla legittimità della norma in commento per quella preclusione definitiva (da essa derivante) all’azionabilità del diritto
più volte censurata in sede di controllo di costituzionalità.
Quel che desta maggiori perplessità è un altro profilo
della normazione, ossia la sanzione di inammissibilità del
ricorso, prevista dal secondo comma dell’art. 17-bis, qualora
il radicamento del processo innanzi al giudice non sia stato
preceduto dal reclamo in opposizione. Qui il contrasto con
l’opinione delle Corti, secondo me, è lampante.
Un conto è ritenere che l’obbligatorietà del preventivo ricorso in opposizione non arrechi un vulnus al diritto alla
tutela giurisdizionale; altro è prevedere una misura sanzionatoria che, volendo garantire a tutti i costi il rispetto di quel
procedimento, punisca l’errore del ricorrente con la negazione
radicale e definitiva della tutela giurisdizionale della sua situazione giuridica sostanziale.
Una siffatta sanzione sconfina nell’irragionevolezza e
denuncia una sproporzione evidente tra interesse che intende
proteggere e diritto che finisce irrimediabilmente per calpestare.
Certo, il concreto meccanismo d’instaurazione della lite
nel nostro procedimento, con la coincidenza perfetta tra modalità e tempi di proposizione del ricorso in opposizione
nella forma del reclamo e modalità e tempi di proposizione
del ricorso giurisdizionale a mente dell’art. 20 del d.lgs. n. 546
del 1992, contribuirà senz’altro a ridurre la gravità di questa
sproporzione e la drammaticità del problema. È infatti probabile che in molte circostanze, anche quando l’atto introduttivo assuma solo la forma del ricorso e non anche quella del
reclamo, il giudice possa fare applicazione, qualora le circostanze di fatto lo convincano in tal senso, del principio c.d.
della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti e del
principio del raggiungimento dello scopo e, quindi, possa non
pronunciare l’inammissibilità.
Tuttavia, al di là di questo “escamotage” empirico, che
dovrebbe peraltro far leva su un’interpretazione “allargata”
dell’art. 156 del codice di procedura civile, se si ragiona col
rigore del diritto la disposizione del secondo comma dell’art.
17-bis non può sfuggire ad una secca alternativa: o essa s’interpreta come costituzionalmente lesiva del diritto alla tutela
giurisdizionale, oppure - ed ecco l’opzione che potrebbe salvarla, in qualche modo, da una siffatta censura - essa si considera sostanzialmente irrilevante o improduttiva di effetti,
argomentando che l’atto inoltrato all’agenzia sia sempre
espressivo della volontà di proporre anche il reclamo, ossia
sia sempre testimone dell’avvio della fase d’opposizione amministrativa.
Insomma, detto ruvidamente e in poche battute, delle due
l’una: o la previsione sull’inammissibilità viene espunta formalmente perché reputata illegittima, oppure la si espunge
sostanzialmente, sterilizzandola con un’interpretazione abrogante, ma costituzionalmente orientata dell’intero procedimento disciplinato nell’art. 17-bis.
Interpretazione, quest’ultima, che potrebbe far leva, tra
l’altro, su un elemento strutturale tipico della nostra procedura: l’atto che dovrebbe avviare il riesame amministrativo e il
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
ricorso in via giurisdizionale sono identici nel contenuto,
ontologicamente unitari e il radicamento, così del procedimento amministrativo, come del rapporto processuale, avviene con la “riproduzione” in due esemplari del medesimo atto:
il ricorso è documentalmente unitario ed è sostanzialmente
lo stesso, quale che sia l’esemplare.
Ora, sebbene dal punto di vista “formale” tra l’uno e
l’altro dovrebbe potersi ravvisare una differenza, perché in
quello inizialmente inoltrato all’agenzia dovrebbe potersi
cogliere la volontà, manifestata anche in forma non solenne,
di reclamare, dal punto di vista sostanziale, come detto, tra i
due esemplari non vi è e non vi potrebbe essere nessuna diversità, stante la doppia e contestuale natura che la legge riserva
all’atto unitariamente considerato: di ricorso in opposizione
amministrativa e di ricorso giurisdizionale .
D’altra parte, giacché il termine dilatorio di novanta giorni previsto dal nono comma - come tutti i termini di tal natura, - paralizza temporalmente l’efficacia di un atto già completo nei suoi elementi strutturali , coincidente, nel nostro
caso, col ricorso giurisdizionale, e siccome lo spatium deliberandi corrispondente a quel termine è concesso, in prima
battuta, a favore dell’amministrazione procedente, affinché
eserciti le proprie funzioni in autotutela, sarebbe oltremodo
singolare sanzionare il ricorrente impedendogli la tutela giurisdizionale del proprio diritto quando il procedimento amministrativo obbedisce prevalentemente ad interessi di matrice pubblicistica.
Per evitare la deflagrazione del problema, in verità, sarebbe sufficiente adeguare il secondo comma dell’art. 17-bis alle
previsioni già presenti nell’ordinamento dettate per procedimenti similari, le quali legano al mancato esperimento
dell’azione amministrativa la conseguenza della improcedibilità processuale. Così, per esempio, l’art. 443 del codice di
procedura civile dispone, appunto, l’improcedibilità della
causa in materia di assistenza e previdenza obbligatorie non
preceduta dal procedimento di componimento extragiudiziario della lite; l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, conformemente
alla Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, disciplina il procedimento conseguente alla pronuncia, anche in questo caso, d’improcedibilità per le controversie civili e commerciali soggette a mediazione obbligatoria . Sarebbe sufficiente, dunque, una semplice
modifica normativa per eliminare, senza smentire le finalità
originarie della previsione, i fondati sospetti di legittimità che
accompagnano la disposizione in esame.
La mancata proposizione “formale” del reclamo, fin qui
esaminata, non deve essere confusa con altra, diversa fattispecie: quella della rituale proposizione del reclamo, ma con
radicamento del processo prima del novantesimo giorno concesso alle parti per il componimento della lite o per l’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo da parte dell’ufficio emanante.
L’irregolare costituzione del rapporto processuale, in
questa circostanza, non può senz’altro sottostare alla sanzione d’inammissibilità, la quale, infatti, è disposta solo per la
mancata presentazione del reclamo.
Il termine dilatorio, piuttosto, a me pare atteggiarsi a requisito di procedibilità affinché il diritto all’azione giudiziale
acquisti e spieghi piena efficacia e non mi sembra possa essere
qualificato alla stregua di condizione dell’azione o di presup-
2 0 1 2
123
posto processuale . Quel termine, in buona sostanza, non si
pone tra due diversi atti processuali (o tra un atto estraneo al
processo e un successivo, distinto atto giudiziale), ma si colloca tra due attività del ricorrente: la prima, volta ad avviare
l’azione amministrativa e, contestualmente, ad interrompere i
termini processuali per la proposizione del ricorso davanti
alla Commissione tributaria; la seconda attività, invece, finalizzata al deposito dello stesso ricorso alla Commissione.
Ecco perché, a mio modo di vedere, il termine di cui si
discute è ascrivibile tra i requisiti di procedibilità e il suo
mancato rispetto non può che determinare una momentanea
sospensione del giudizio fino all’esaurimento del procedimento per via amministrativa o fino allo spirare del termine del
novantesimo giorno.
Rispetto alla normazione recata dall’art. 10 del d.P.R. n.
787 del 1980 sui ricorsi avverso gli atti emessi dai centri di
servizio del Ministero delle finanze, la Corte costituzionale,
d’altra parte, ha in qualche modo avallato l’interpretazione
tratteggiata: non potendo il termine dilatorio prescritto in
quella norma impedire la tutela giurisdizionale nella forma
della sospensione cautelare ai sensi dell’art. 47 del d.lgs n. 547
del 1992, essa ha legittimato l’instaurazione del processo prima
dello spirare dei sei mesi dalla presentazione del ricorso al
Centro di servizio12 . Confermando, così, almeno implicitamente, la configurazione di quel termine per come dianzi indicata:
non come condizione dell’azione o presupposto processuale,
ma, più semplicemente, come requisito di procedibilità.
La sentenza richiamata, per la sua cristallina linearità,
consente di ritenere risolto, per così dire in apicibus, anche il
problema della tutela cautelare giudiziale che l’art. 17-bis
parrebbe, a prima vista, sollevare . Si deve dire che la disciplina della riscossione in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività
produttive, introdotta dall’art. 29 della legge 30 luglio 2010,
n. 122, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, contemplando una sospensione
ex lege dell’accertamento esecutivo pari a 180 giorni, limita,
di fatto, la gravità del problema della immediata esazione del
credito. Tuttavia, possono residuare ipotesi “minori”, così da
mantenere viva l’esigenza di un provvedimento cautelare di
natura giurisdizionale, come può accadere per il credito iscritto a ruolo a seguito di controlli formali o automatici delle
dichiarazioni, per quello sottoposto a riscossione straordinaria e per i crediti relativi a tributi non ricompresi nella nuova
disciplina sulla riscossione.
Ebbene, la strada già tracciata dalla Corte a proposito
della vecchia procedura di contestazione degli atti formati dai
centri di servizio spiana la soluzione anche per le fattispecie
or ora indicate: la costituzione in giudizio potrà avvenire
12 Nella sent. 24 luglio 1998, n. 336, la Corte ha precisato che “è da ritenere che
la normativa impugnata, nel coordinamento che va necessariamente operato tra
il precedente e l’attuale rito del processo tributario, non impedisca al contribuente, che ricorre avverso la iscrizione a ruolo operata dal centro di servizio e
chiede la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, di depositare, presso
la segreteria della commissione tributaria, l’altro esemplare del ricorso, senza
attendere il decorso del termine previsto nell’art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980.
Si soddisfa, in tal modo, secondo le regole e le forme tuttora applicabili ai ricorsi avverso le iscrizioni a ruolo, anche l’esigenza alla quale ha voluto ovviare l’art.
47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, richiedendo e ponendo come condizione di ammissibilità per l’istanza cautelare la costituzione in giudizio”.
tributario
Gazzetta
124
d i r i t t o
prima dello spirare del termine dilatorio e il provvedimento
d’urgenza, pertanto, potrà essere adottato nell’immediatezza,
sebbene il processo debba poi essere dichiarato sospeso per
temporanea improcedibilità della trattazione della causa nel
merito.
Ma andiamo avanti nell’analisi del testo normativo.
Per le controversie di valore non superiore a ventimila
euro, così come disciplinato, il nuovo istituto è alternativo,
come anticipato, alla conciliazione giudiziale prevista dall’articolo 48 del D.Lgs. n.546 del 1992. In base al comma 1
dell’articolo 17 bis, infatti, nelle controversie instaurate a
seguito di rigetto dell’istanza ovvero di mancata conclusione
della mediazione, “è esclusa la conciliazione giudiziale di
cui all’articolo 48”. Pertanto, il reclamo, sebbene riferito alla
fase amministrativa, sostituisce la conciliazione, assorbendone la funzione.
La nuova procedura non trova inoltre applicazione con
riferimento alle controversie relative ad atti volti al recupero
di aiuti di Stato di cui all’articolo 47bis del predetto decreto
legislativo n. 546 (comma 4).
Il legislatore ha, quindi, escluso espressamente dalla mediazione le controversie concernenti il recupero di aiuti di
Stato dichiarati incompatibili, in esecuzione di una decisione
adottata dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 14
del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999.
Pertanto, sono escluse dalla mediazione tutte le controversie aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato illegittimi,
indipendentemente dalla tipologia di atto inerente al caso di
specie (ad esempio, atto di recupero, avviso di accertamento,
cartella di pagamento), nonché i relativi interessi e sanzioni13.
Ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 546
del 1992, “il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali
provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome
da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”.
In particolare la norma parla di “apposite strutture diverse ed autonome “ da quelle che curano l’istruttoria degli atti
reclamabili. A tal punto si evidenzia che l’esame del reclamo
viene analizzato comunque dal personale dell’agenzia anche
se appartenente a strutture diverse che difficilmente avranno
difficoltà a valutare negativamente l’operato di chi ha istruito
la pratica.
Anche se l’Agenzia delle Entrate ha specificato che al riguardo, le “strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili” sono gli Uffici legali
delle Direzioni provinciali, nonché le analoghe strutture delle
Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara per i
procedimenti di competenza di quest’ultimo.
L’Agenzia delle Entrate, anche per “sedare” le forti critiche
che sono state sollevate da gran parte della dottrina in merito
alla bontà di un istituto che, di fatto, permette alla stessa
Agenzia di assumere il duplice ruolo di “parte in causa” e di
“mediatore” (con evidenti rischi di imparzialità), ha individuato queste strutture negli uffici legali delle Direzioni regionali o provinciali. Si intende in questo modo assicurare l’autonomia di giudizio di chi deve decidere sul reclamo; ma è
13 Cfr Circ. n. 9/E /2012 cit.
t r i b u ta r i o
Gazzetta
F O R E N S E
facile osservare che detta autonomia rischia, almeno in certi
casi, di restare sulla carta, non esistendo alcuna reale terzietà
fra organi pur sempre appartenenti all’Agenzia delle entrate;
e che, comunque, le garanzie di tutela riconosciute al contribuente nella fase procedimentale amministrativa non sono – e
non potrebbero essere – equiparabili a quelle tipiche del giudizio avanti alle commissioni.
tiene subito a precisare che la mediazione non determina
un più gravoso esercizio dell’azione in giudizio per il contribuente, dal momento che, in caso di mancata conclusione
positiva della fase amministrativa della mediazione, la norma
considera l’azione giudiziaria già esercitata. E in più aggiunge che il procedimento di mediazione si svolge su di un piano
di sostanziale parità fra contribuente e Ufficio, peraltro in
una situazione in cui entrambi hanno manifestato e documentato in maniera completa e definitiva le proprie posizioni.
Le perplessità non svaniscono, si spera almeno che tale
attività sia svolta con trasparenza ed equità di trattamento.
Il reclamo segue inoltre alcune disposizioni del DLgs
546/92, in quanto compatibili, che disciplinano la forma e il
contenuto del ricorso (comma 6).
In particolare il riferimento è agli articoli 12,18,19,20,21
e al comma 4 dell’art.22.
Ne consegue che ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992,
per proporre reclamo contro atti dell’Agenzia di valore superiore a 2.582,28 euro, il reclamante deve essere assistito da
un difensore; possono formare oggetto di reclamo solo gli
atti impugnabili ex art. 1914; il reclamo deve contenere tutti
gli elementi di cui all’art. 18, dovendo individuare, attraverso
i motivi, la causa petendi e il petitum dell’azione amministrativa; il reclamo deve essere notificato in una delle tre modalità previste dall’art. 16 e va depositato presso l’ufficio15 che ha
emesso l’atto impugnato, competente ex art. 22 (che riguarda,
peraltro, la costituzione in giudizio). Infine, il termine è quello stesso previsto dall’art. 21, per cui il reclamo deve essere
proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo.
14 Attualmente, però, sono molto più numerosi i casi in cui, o per modifiche
normative, ovvero per ampliamenti giurisprudenziali, risultano impugnabili
atti dell’Agenzia delle entrate che sono di valore indeterminabile: si pensi alle
controversie su agevolazioni non quantificabili, su provvedimenti autorizzatori come quelli che riguardano la attribuzione o la cancellazione della partita
IVA, sugli interpelli disapplicativi: il valore indeterminabile della «pretesa», in
questi casi, dovrebbe comportare l’esclusione dalla procedura di reclamo.
Non vi è un’incompatibilità assoluta tra reclamo e processi su dinieghi di rimborsi, e, più in generale, su liti pretensive: come spesso accade, la norma è
stata evidentemente pensata avendo riguardo agli atti impositivi e soprattutto
agli atti di accertamento, ma il generico riferimento all’art. 19 rende arbitrario
escludere a priori le controversie di rimborso, se di valore non superiore a 20.000
euro. Non è però agevole stabilire se il reclamo vada presentato anche in caso
di silenzio dell’Amministrazione, là dove un atto, in senso formale e probabilmente anche in senso sostanziale, manca.
15 Come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria che, “dato il nesso che
sussiste tra l’articolo 17bis e il ricorso giurisdizionale, deve ritenersi che trova
applicazione nel procedimento in esame l’articolo 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992,
sebbene non espressamente richiamato. Tale norma dispone che è parte nel
processo tributario (e quindi competente a ricevere l’istanza di mediazione)
l’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto
“ovvero, se l’ufficio è un centro di servizio o altre articolazioni dell’Agenzia
delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di Amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito della dotazione organica
prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri
aggiuntivi, degli Uffici dell’Agenzia”, l’Ufficio al quale spettano le attribuzioni
sul rapporto controverso.Dal combinato-disposto delle norme sopra richiamate consegue che l’istanza di mediazione va presentata alla Direzione che ha
emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto”
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
2. L’ambito applicativo
I criteri individuati dalla norma attengono:
1) alla tipologia di atto impugnato;
2) alla parte resistente nell’eventuale giudizio;
3) al valore della controversia.
4) alla data di notifica
La contestuale sussistenza dei requisiti sopra indicati impone
a chi intenda proporre ricorso di esperire preventivamente e
obbligatoriamente il reclamo.
2.1. La tipologia di atto impugnato.
Dal combinato disposto delle norme sopra citate sembrerebbe emergere che il contribuente deve esperire la fase amministrativa ogni qual volta intenda impugnare uno degli
atti individuati dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992,
emesso dall’Agenzia delle entrate, e il valore della controversia
non sia superiore a ventimila euro.
In realtà la stretta correlazione sequenziale delineata dalla legge fra reclamo e ricorso giurisdizionale porta a ritenere
reclamabili i soli provvedimenti dell’Agenzia delle entrate
autonomamente impugnabili in giudizio avanti alla commissione tributaria provinciale. Non solo dunque i provvedimenti espressamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. 31-12-1992, n.
546, ma anche quelli che, seppur non ricompresi nell’elenco,
risultano impugnabili in ragione del loro contenuto e dei loro
effetti preclusivi. L’art. 17-bis fa riferimento agli atti “emessi” dall’Agenzia, dovendo intendersi per tali (come dispone
l’art. 39, 11° co., del d.l. n. 98 del 6-7-2011) quelli notificati a
decorrere dall’1-4-2012, ancorché formati precedentemente
dagli uffici.
Sui dubbi sorti in dottrina per la precisa individuazione
della tipologia di atti oggetto del reclamo è intervenuta la
Circolare 9/E del 19 marzo 2012 che sottolinea che sono
oggetto di mediazione le controversie relative a:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di
definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il
quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi
alle Commissioni tributarie.
Sempre l’Agenzia sottolinea che debba ritenersi oggetto di
mediazione anche il rifiuto tacito della restituzione di tributi,
sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti,
sulla base delle seguenti considerazioni.
Come sopra ricordato, ai sensi del comma 6 dell’articolo
17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, al “procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al
comma 4 dell’articolo 22, in quanto compatibili”.
Tra gli atti impugnabili, l’articolo 19, comma 1, lett. g),
del D.Lgs. n. 546 del 1992 espressamente include il rifiuto
tacito alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri
accessori. Pertanto, in applicazione del combinato disposto
dei commi 1 e 6 dell’articolo 17 bis, la fase della mediazione
va esperita anche in relazione al rifiuto tacito di rimborso.
L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ritiene che una
2 0 1 2
125
diversa interpretazione non risulti giustificabile tenuto conto
che tra le ipotesi di diniego espresso e tacito di rimborso si
determinerebbe una disparità di trattamento, tanto più evidente laddove si consideri che le modalità di esercizio dell’azione giudiziaria da parte del contribuente verrebbero a essere
“decise”, di fatto, dall’Agenzia delle entrate, a seconda che
quest’ultima si determini, o meno, a denegare il rimborso con
un provvedimento espresso.
Aggiungendo, inoltre, che la previsione della possibilità
di impugnazione anche in presenza di diniego tacito alla restituzione è ricollegabile alla volontà del legislatore di garantire al contribuente la tutela giurisdizionale dei suoi diritti
anche in caso di inerzia da parte dell’Amministrazione.
Ulteriore applicazione al procedimento di mediazione è
previsto anche per il disposto dell’articolo 19, comma 3 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, in base al quale “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione
unitamente a quest’ultimo”.
Ciò comporta che il contribuente, qualora intenda impugnare, con il ricorso, anche un atto presupposto adottato
dall’Agenzia delle entrate, del quale affermi la mancata precedente notificazione, è tenuto ad osservare preliminarmente
la disciplina introdotta dall’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546
del 1992 e, quindi, a presentare l’istanza di mediazione.
Sempre secondo la prassi, non sono, invece, oggetto di
mediazione le controversie concernenti gli altri atti elencati
dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, i quali, pur essendo impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, non sono
emessi dall’Agenzia delle entrate e, di norma, non sono riconducibili all’attività della stessa.
Si tratta, più precisamente, dei seguenti atti:
cartella di pagamento;
- avviso di mora di cui alla lett. e) dell’articolo 19, comma
1 del D.Lgs. n. 546 del 1992; peraltro, tale atto è stato
soppresso e sostituito dall’avviso di intimazione di cui
all’articolo 50, comma 2, del Dpr 602/1973;
- iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77
del DPR n. 602 del 1973, prevista dalla lett. ebis) del
medesimo articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del
1992;
- fermo di beni mobili registrati, di cui all’articolo 86 del
DPR n. 602 del 1973, elencato sub lett. e-ter) dell’articolo
19, comma 1;
- atti relativi alle operazioni catastali, indicate nell’articolo
2, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Resta inteso, tuttavia, che, nel caso in cui eccepisca la mancata notifica di un atto presupposto riconducibile all’attività
dell’Agenzia delle entrate, il contribuente è comunque obbligato a presentare preliminarmente l’istanza di mediazione.
2.1.1. Osservazioni sulla disciplina degli atti suscettibili di
mediazione
Guardando agli atti suscettibili di reclamo e di mediazione, un posto preferenziale è occupato da quelli espressione
della funzione di accertamento (per i quali, probabilmente, è
stata pensata la nuova disciplina), quali avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e atti affini.
Vengono in rilievo le caratteristiche della funzione di accertamento, che, consistendo nella determinazione autorita-
tributario
Gazzetta
126
d i r i t t o
tiva di imponibile e imposta, è - come è noto - una funzione
vincolata, nel senso che è priva di discrezionalità amministrativa. Ne consegue che per tali atti vi è soltanto spazio per un
riesame di legittimità, per di più astretto dalla vincolatezza
della funzione di accertamento. Sicché è probabile che si contestino fatti e giudizi dell’Ufficio (ridondanti sulla validità
degli atti), dei quali l’apporto del contribuente può consentire
differenti e più circostanziate ricostruzioni/valutazioni per
pervenire a più fedeli determinazioni di imponibili e imposte.
Naturalmente non possono escludersi «zone grigie», anche
per difficoltà di ordine probatorio, in ordine alle quali si impongono le soluzioni più attendibili e dimostrabili, espressioni pur sempre di stime e valutazioni.
Per altri atti della riscossione, emessi dall’Agenzia delle
entrate e impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie,
possono aversi margini di discrezionalità. Per tali atti si profila anche un riesame di opportunità e naturalmente sono
possibili accordi amministrativi volti a concordare in tutto o
in parte le scelte amministrative per meglio finalizzarle. Alle
quali, del resto, deve pervenire l’Ufficio «se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale
dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, … avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al
grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa».
Diversamente in presenza di meri atti (contemplati dall’art.
19 del D.Lgs. n. 546/1992), la posizione del contribuente è di
diritto soggettivo e, di regola, l’Ufficio non esterna volontà,
essendo chiamato piuttosto a ricognizioni, valutazioni, comunicazioni, naturalmente ripetibili e sempre sindacabili: eventuali scelte dell’Ufficio finirebbero col sovrapporsi all’assetto
di interessi che presiede all’esercizio delle funzioni amministrative volta per volta interessate.
Vere e proprie obbligazioni, invece, possono configurarsi
in relazione ai rimborsi; ma anche la disciplina degli stessi,
per le ragioni sopra enunciate, deve ritenersi prevalentemente
inderogabile, per lo meno in ordine ad an e quantum degli
stessi (che siano duali dei correlati obblighi tributari di versamento), potendo residuare margini di disposizione su profili,
quali tempi e modalità di pagamento, su cui naturalmente
sono possibili accordi.
In definitiva, la procedura ex art. 17- bis D.Lgs. n.
546/1992 per gli atti espressione di funzioni di amministrative (di accertamento, sanzionatoria e di riscossione), che poi
sono le ipotesi di gran lunga prevalenti, sollecita l’autotutela
amministrativa (totale o parziale), prevalentemente nelle forme dell’annullamento, ma anche in quelle della revoca; al di
fuori di tali ipotesi essa, comunque, si misura per lo più con
norme imperative ed inderogabili. Pochi spazi residuano per
discrezionalità ed accordi amministrativi (alcuni ambiti della
riscossione) come anche per accordi privatistici (essenzialmente alcuni profili dei rimborsi).
2.2. Parte resistente nell’eventuale giudizio
Il comma 1 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992
trova applicazione limitatamente alle controversie concernenti atti emessi dall’Agenzia delle entrate.
Di conseguenza, tra i requisiti posti dalla norma in commento vi è la legittimazione processuale passiva dell’Agenzia
delle entrate nell’eventuale, successivo processo.
t r i b u ta r i o
Gazzetta
F O R E N S E
Al riguardo occorre precisare quanto segue, con particolare riferimento alle controversie relative agli atti emessi
dall’Agente della riscossione, quale, ad esempio, la cartella di
pagamento che, come ricordato nei precedenti punti, di norma
non rientra tra gli atti per i quali l’articolo 17-bis prevede la
fase di mediazione:
a) se il contribuente solleva contestazioni attinenti esclusivamente a vizi propri della cartella di pagamento - quali, ad
esempio, le eccezioni relative alla ritualità della notifica
– la controversia non può essere oggetto di mediazione;
b) nel caso in cui impugni la cartella di pagamento sollevando vizi riconducibili solo all’attività dell’Agenzia delle
entrate e la relativa controversia sia di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente deve preventivamente
esperire il procedimento di mediazione;
c) qualora il contribuente, in sede di impugnazione della
cartella di pagamento, formuli eccezioni relative sia all’attività svolta dall’Agenzia sia a quella dell’Agente della riscossione, si possono verificare le seguenti ipotesi:
c.1) Il contribuente notifica il ricorso solo all’Agente
della riscossione
In questo caso, l’Agente della riscossione ha l’onere di
chiamare in causa l’Agenzia delle entrate, considerato che, ai
sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che
non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli
atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Intervenendo in giudizio, la Direzione eccepisce, limitatamente alle contestazioni sollevate in relazione all’attività
dell’Agenzia, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in base al
quale “La presentazione del reclamo (i.e. istanza di mediazione) è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
In subordine, la stessa Direzione si difende nel merito, mentre
l’Agente della riscossione svolge la propria difesa per quanto
concerne i vizi propri della cartella di pagamento, riconducibili quindi alla propria attività, non operando rispetto a
questi la previsione di inammissibilità di cui all’articolo 17bis, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992;
c.2) Il contribuente avvia la fase di mediazione nei confronti dell’Agenzia, senza notificare il ricorso all’Agente
della riscossione
In tale ipotesi, trova applicazione l’articolo 17-bis del
D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione alle contestazioni riguardanti l’Agenzia delle entrate. Come sarà più diffusamente
chiarito, in ipotesi di mancata conclusione favorevole della
mediazione, il contribuente potrà valutare l’eventuale prosecuzione del contenzioso, mediante la costituzione in giudizio
nei termini individuati dal combinato disposto dell’articolo
17-bis, comma 9, e dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 546 del
1992;
c.3) Il contribuente notifica il ricorso all’Agente della
riscossione e contestualmente avvia la fase di mediazione con
l’Agenzia delle entrate
Anche in tal caso trova applicazione il procedimento di
cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. infra).
Per meglio chiarire, si applica anche al reclamo la regola
prevista dall’art. 19, 3° co., del d.lgs. 31-12-1992, n. 546, in
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
base alla quale ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato (e reclamato) solo per vizi propri, e
“la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente
l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”. Ciò significa –
per un verso – che non è ammissibile il reclamo contro la
cartella di pagamento di imposte o sanzioni tributarie presentato per vizi inerenti ad avvisi di accertamento o ad atti di
irrogazione notificati in precedenza e non opposti nei termini
; e che – per altro verso – l’omessa notifica dell’avviso di accertamento può essere fatta valere con reclamo o con ricorso
contro il ruolo o la cartella, agendo indifferentemente nei
confronti dell’Agenzia delle entrate o di Equitalia (tenuta a
chiamare in causa l’ente impositore).
Il contribuente può scegliere quindi se radicare il procedimento di reclamo nei confronti dell’Agenzia delle entrate, o
agire subito avanti al giudice tributario notificando il ricorso
all’agente della riscossione. Nel caso (piuttosto improbabile)
in cui egli decida di contestare anche l’atto presupposto non
notificato dall’Agenzia, la presentazione del reclamo diventa
invece necessaria
2.3. Il valore della controversia
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546
del 1992, il valore della controversia “è determinato secondo
le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12”.
Nella specie, il secondo periodo del predetto articolo 12,
comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che “Per valore
della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in
caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni
di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
Nell’individuare i requisiti per l’applicazione della mediazione, occorre tenere conto che il processo tributario – sebbene rivolto al c.d. accertamento sostanziale del rapporto controverso – è comunque strutturato secondo le regole proprie
del processo impugnatorio (cfr. ex plurimis, Cass., SS. UU.,
18 gennaio 2007, n. 1054; più recentemente, Cass., 13 marzo
2009, n. 6129).
Pertanto, il valore della controversia va determinato con
riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo
del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di
atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione
delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate.
Da ciò deriva che:
qualora un atto si riferisca a più tributi (per esempio, Irpef
e Irap ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale) il
valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle
imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente;
in presenza di impugnazione cumulativa avverso una
pluralità di atti , la necessità di uno specifico e concreto nesso
tra l’atto impositivo oggetto dell’istanza di mediazione e le
contestazioni formulate dal contribuente, richiesto dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, impone di individuare il
valore della lite con riferimento a ciascun atto impugnato con
il ricorso cumulativo. Ne consegue che, in relazione agli atti
aventi un valore non superiore a ventimila euro, il contribuen-
2 0 1 2
127
te è tenuto ad osservare in ogni caso la procedura prevista
dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Relativamente alle controversie aventi ad oggetto il rifiuto
espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della
controversia va invece determinato tenendo conto dell’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori.
Nel caso in cui l’istanza di rimborso riguardi più periodi
d’imposta, occorre fare riferimento al singolo rapporto tributario sottostante al singolo periodo d’imposta. Pertanto, in
tali ipotesi il valore della lite è dato dall’importo del tributo
richiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.
Ad esempio, se con una determinata istanza si richiede il
rimborso di tributi afferenti a più periodi d’imposta e per uno
solo di essi l’importo richiesto a rimborso non supera i ventimila euro, per quest’ultimo il contribuente deve presentare
istanza di mediazione prima della eventuale instaurazione del
giudizio.
• Le controversie di valore indeterminabile
Poiché l’articolo 17-bis richiede che la controversia sia
contraddistinta da un valore espressamente individuato, restano escluse dalla fase di mediazione le fattispecie di valore
indeterminabile, quali, ad esempio, quelle relative ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’Anagrafe unica delle Onlus oppure quelle concernenti esclusivamente la spettanza di un’agevolazione.
Di contro, il contribuente deve esperire la fase della mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo il diniego o la revoca dell’agevolazione ma anche il tributo o il
maggior tributo accertato contestualmente con il provvedimento impugnato e/o le relative sanzioni irrogate con il medesimo atto.
In tal caso, infatti, il valore della controversia è individuabile nel tributo o maggior tributo accertato, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
• I contributi previdenziali e assistenziali
La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, in quanto la loro base imponibile è
riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Si tratta, in
particolare, dei casi in cui la mediazione riguardi avvisi di
accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione
o controllo formale delle dichiarazioni.
In tal caso, il valore della lite va, ovviamente, determinato al netto dei contributi accertati.
L’atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato
nell’atto stesso.
2.3.1. Carenza legislativa integrata dalla prassi: il problema
della tutela cautelare.
La norma mostra subito un vistoso silenzio, non parla
minimamente di tutela cautelare.
L’apparente modestia delle controversie suscettibili di reclamo e di mediazione non deve trarre in inganno.
A parte che, anche di fronte ad una pretesa relativamente
contenuta, in specie di valore non superiore a 20.000 euro,
ben può sussistere il presupposto del danno grave e irreparabile, che postula l’esercizio della domanda cautelare, occorre,
inoltre, tener presente che, a norma del comma 3, dell’art. 17bis del D.Lgs. n. 546/1992, il valore della controversia, a cui
fa riferimento il comma 1 della norma indicata, deve essere
tributario
Gazzetta
128
d i r i t t o
determinato «secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12» del D.Lgs. n. 546/1992 e che, in base a detta disposizione, «per valore della lite si intende il valore del tributo al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con
l’atto impugnato», salvo i casi di controversie relative soltanto
alla irrogazione delle sanzioni, eccedenti il valore costituito
dalle somme di queste, per cui è ben possibile che la somma
pretesa dall’Ufficio con l’atto suscettibile di reclamo ecceda
anche di molto il limite di 20.000 euro, che l’Ufficio può esigere con uno degli atti di cui trattasi, restando in tal modo
ancor più elevato il rischio del danno grave e irreparabile.
Non può d’altronde escludersi la necessità di una tutela
cautelare sotto il profilo di una mancanza di interesse concreto ed attuale alla tutela cautelare in ragione della natura degli
atti reclamabili per l’eventuale assenza di una loro immediata
esecutività.
Tra gli atti reclamabili possono anche esservi atti non
dotati di immediata esecutività, per i quali, di conseguenza,
manca il presupposto dell’attualità del pregiudizio, che solo
giustifica la tutela cautelare.
Ma possono ben esservi, fra gli atti suscettibili di richiesta
di mediazione, atti oggetto di controversie dove il presupposto
dell’attualità del pregiudizio è ben configurabile, rendendo,
di conseguenza, assolutamente indispensabile la presenza di
un efficace rimedio cautelare.
2.3.1.1.Tutela cautelare ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992
dopo il rigetto del reclamo
Dopo aver registrato il possibile verificarsi di concrete
esigenze di tutela cautelare anche a fronte di atti suscettibili
di reclamo e di mediazione ex art. 17-bis del D.Lgs. n.
546/1992, seguendo, per chiarezza di chi legge, l’ordine di
progressivo avvicinamento ai nodi problematici di maggiore
difficoltà, occorre prendere in considerazione l’ipotesi del
possibile soddisfacimento dell’esigenza di tutela cautelare
dopo che il procedimento di reclamo mediatorio sia stato
attivato e sia stato concluso «senza che sia stato notificato
l’accoglimento del reclamo e senza sia stata conclusa la mediazione».
In questi casi, sempre che vi sia ancora tempo, perdurando
l’attualità del pregiudizio e gli altri presupposti del fumus
boni iuris e del periculum in mora, è possibile l’attivazione
della tutela cautelare?
Poiché il comma 9 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992
prevede che, in tal caso, «il reclamo produce gli effetti del ricorso», si è già nell’ambito di un procedimento giudiziale avviato.
Si può discutere se sia il caso di inserire l’istanza di sospensione cautelare nel reclamo, che è atto amministrativo,
ancorché convertibile ex lege nell’atto introduttivo del giudizio
di primo grado, o se sia il caso di proporre apposita istanza
cautelare, ai sensi della seconda parte del comma 1 dell’art.
47 del D.Lgs. n. 546/1992, dopo che vi sia stata la costituzione in giudizio del ricorrente entro il termine di trenta giorni,
decorsi i novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo e senza che sia stata conclusa la mediazione, o dalla data del «ricevimento del diniego», in caso di
rigetto del reclamo medesimo prima del decorso dei novanta
giorni, o dalla data di notificazione dell’atto di accoglimento
parziale del reclamo stesso. Quest’ultima via è senz’altro legittima ed è, fors’anche, la più corretta, ove si consideri che,
t r i b u ta r i o
Gazzetta
F O R E N S E
come già si è detto, il reclamo è pur sempre un atto amministrativo, benché convertibile ex lege in atto giudiziale ed
equivalente ad esso quanto agli effetti, e che l’istanza di sospensione cautelare può ben presentarsi subito dopo, o anche
coevamente all’iscrizione a ruolo della causa, così da poter
rappresentare lo stato del periculum in mora e del fumus
boni iuris in termini di maggiore prossimità temporale dell’esigenza di tutela rispetto al momento iniziale della presentazione del reclamo
Impossibile innesto della sospensione cautelare ex art. 47
del D.Lgs. n. 546/1992 durante il reclamo mediatorio
Se alla stregua di quanto appena rilevato non sembra
dunque sussistano ostacoli a riconoscere l’applicabilità
dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 dopo che sia esaurito negativamente il procedimento di reclamo mediatorio, resta da
verificare se tale norma possa invece trovare applicazione
durante tale procedimento, posto che, come sopra si è visto,
anche in questo periodo di tempo ben possono verificarsi (e
sempre che, ovviamente, si verifichino) i presupposti per la
sua concreta applicabilità.
Nel contesto dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, la
discrepanza diacronica tra la presentazione del reclamo alla
Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell’Agenzia
delle entrate e la proposizione del ricorso viene drasticamente
sanzionata dall’espressa comminatoria dell’inammissibilità
del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, senza la
previa presentazione del reclamo, che, solo decorsi novanta
giorni senza che sia stato notificato il suo accoglimento e
senza che sia stata conclusa la mediazione, «produce gli effetti del ricorso» .
In questo contesto disciplinare viene ad essere esclusa in
radice ogni possibilità di ammissibile accesso alla giurisdizione tributaria prima e a prescindere della presentazione del
reclamo e dell’esaurirsi del relativo procedimento.
La pendenza del processo si ha solo al momento in cui il
reclamo produce gli effetti del ricorso e solo da tale momento
decorrono i termini di cui agli artt. 22 (costituzione in giudizio del ricorrente -30 gg dalla proposizione del ricorso) e 23
(costituzione in giudizio della parte resistente – entro 60 gg
dalla notifica del ricorso) e possono quindi proporsi le domande cautelari davanti all’organo giurisdizionale.
Prima di ciò, nessuna domanda cautelare può ritenersi
proponibile ex art. 47, comma 6, del D.Lgs. n. 546/1992, per
cui appare evidente e non altrimenti colmabile, con qualsivoglia versione interpretativa, il vuoto di tutela cautelare che ne
consegue.
La Circolare sancisce che “La presentazione dell’istanza,
così come la proposizione del ricorso giurisdizionale, non
comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto
impugnato.
Si evidenzia, inoltre, che la sospensione giudiziale dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992
può essere richiesta alla Commissione tributaria provinciale
solo in pendenza di controversia giurisdizionale e che, quindi, l’istanza di sospensione giudiziale non può essere proposta
prima della conclusione della fase di mediazione.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 2-quater, comma 1-bis
del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, “Nel
potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato”.
Stante la funzione cui è preordinato il procedimento di
mediazione, si ritiene possibile e opportuno, al fine di garantire un’adeguata tutela del contribuente, estendere l’applicabilità del citato articolo 2-quater, comma 1-bis del DL
n. 564 del 1994 alle fattispecie in esame.
In altri termini, anche nell’ambito del procedimento amministrativo disciplinato dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n.
546 del 1992, per sua natura funzionale al riesame ed eventuale rideterminazione della pretesa, il contribuente può
chiedere la sospensione degli effetti dell’atto.
Quando le eccezioni sollevate nell’istanza non appaiono
infondate, la Direzione può dunque concedere, su istanza
formulata contestualmente all’atto introduttivo del procedimento di mediazione, ovvero separatamente, la formale sospensione, in tutto o in parte, dell’esecuzione dell’atto in
presenza del richiamato presupposto.
Si precisa che il periodo di sospensione degli effetti dell’atto non può comunque protrarsi oltre il tempo necessario alla
conclusione della fase di mediazione.
All’eventuale esito negativo del procedimento di mediazione consegue ovviamente l’iscrizione a ruolo o l’affidamento del carico all’Agente della riscossione e l’immediata revoca della sospensione precedentemente concessa.
Resta ferma la possibilità di avvalersi delle norme in materia di riscossione straordinaria [in particolare, articoli 29,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e 15-bis del DPR n. 602 del 1973].”
Resta però un problema.
Va osservato che – ai nostri fini – il reclamo presenta
forti similitudini con l’istanza di accertamento con adesione,
perché dà anch’esso luogo a un contraddittorio preprocessuale finalizzato a un riesame del provvedimento e (in presenza
di una proposta di mediazione) a una definizione concordata
dell’imponibile. Durante il procedimento di adesione, la legge
non consente agli uffici di riscuotere imposte a titolo provvisorio: logica vorrebbe che, pur in mancanza di una disciplina
espressa sul punto, il procedimento di reclamo seguisse gli
stessi principi, e fosse preclusa agli uffici e agli agenti della
riscossione, sino alla conclusione di tale procedimento, la
possibilità di riscuotere in via provvisoria le imposte accertate o liquidate, o di adottare misure conservative. Questa soluzione, condivisa in dottrina, eliminerebbe in radice il problema della tutela cautelare del contribuente a fronte degli
atti esecutivi dell’Agenzia nella fase preprocessuale del reclamo e della mediazione.
Peraltro, in relazione agli avvisi di accertamento emanati
ai sensi dell’art. 29 del d.l. 31-5-2010, n. 78, la riscossione
coattiva è oggi differita ipso iure dalla sospensione legale
dell’esecuzione degli accertamenti stessi, che opera addirittura a prescindere dalla presentazione del reclamo (o dalla
proposizione del ricorso). Come noto, infatti, la norma appena citata ha previsto la cd. concentrazione della riscossione
nell’accertamento, allo scopo di eliminare – con riguardo alle
attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento
delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva e ai connessi provvedimenti sanzionatori notificati a partire dall’1-10-2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31-12-2007 e successi-
2 0 1 2
129
vi – la tradizionale fase della riscossione tramite ruolo, e
snellire il procedimento di esazione dei tributi accertati. Sono
scomparse l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, ed
è stata conferita esecutività all’avviso di accertamento e al
provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
In questo nuovo sistema, l’esecuzione forzata è differita
per legge a un momento successivo alla conclusione del procedimento di reclamo e mediazione, sicché non sembrano
porsi – in fase di reclamo – problemi di tutela cautelare dei
contribuenti. L’esecuzione non può avvenire infatti prima di
180 giorni dall’affidamento in carico all’agente della riscossione: affidamento che, a propria volta, deve seguire di almeno 30 giorni il decorso del termine di pagamento delle somme
accertate, coincidente con quello di presentazione del ricorso
(o del reclamo). Fra la data di presentazione del reclamo e
quella di inizio dell’esecuzione forzata devono dunque decorrere almeno 210 giorni, che possono diventare di più in caso
di previa richiesta di accertamento con adesione e di sospensione feriale dei termini processuali. Il procedimento di reclamo e mediazione non può invece protrarsi per più di 90
giorni, durante i quali, in forza della disciplina appena richiamata, l’atto reclamato non è ancora eseguibile.
Residua l’ipotesi in cui, ravvisando fondato pericolo per
il buon esito della riscossione, l’Agenzia delle entrate affidi in
carico la riscossione a Equitalia subito dopo il decorso dei 60
giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, ed Equitalia
intenda procedere immediatamente in executivis. Non è detto
che, al momento dell’affidamento in carico, il reclamo sia già
stato presentato: il termine di presentazione potrebbe infatti
essere stato differito per effetto di sospensione feriale o di
richiesta di accertamento con adesione. In ogni caso, in queste
situazioni (e nelle altre sopra ricordate in cui la riscossione
coattiva può avvenire subito dopo i 60 giorni dalla notifica
del provvedimento amministrativo), una volta escluso che la
sospensione dell’esecuzione consegua ex lege alla presentazione del reclamo, il contribuente rimarrebbe esposto al rischio
di subire l’esecuzione, non potendo agire in via cautelare
avanti alla commissione tributaria.
Così come regolato dall’art. 47 del d.lgs. 31-12-1992, n.
546, invero, l’esercizio dell’azione cautelare nel processo tributario presuppone la proposizione del ricorso di merito e
l’instaurazione del relativo giudizio, avente appunto ad oggetto il provvedimento di cui si chieda (oltre all’annullamento)
la sospensione: non sembrano dunque ammissibili istanze di
sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti emanati
dall’Agenzia delle entrate, proposte alla commissione tributaria provinciale durante la fase di reclamo che precede l’instaurazione del processo.
Per permettere al contribuente di chiedere fin da subito la
tutela cautelare, parte della dottrina ha proposto “in via subordinata ed ipotetica” di ritenere pendente il processo già
al momento della presentazione del reclamo, che è idoneo a
produrre “il principale effetto giuridico del ricorso giurisdizionale, cioè quello di impedire la definitività, l’inoppugnabilità dell’atto contro cui si ricorre”: durante il procedimento
di reclamo, il processo rimarrebbe in uno stato di quiescenza
destinato a risolversi all’esito della fase amministrativa, e il
contribuente potrebbe costituirsi in giudizio avanti alla commissione tributaria provinciale prima del termine stabilito
dall’art. 17-bis, al solo fine di chiedere la sospensione dell’ese-
tributario
Gazzetta
130
d i r i t t o
cuzione dell’atto reclamato. La tesi, indubbiamente suggestiva, contrasta con la rigida bipartizione tracciata dalla norma
tra fase amministrativa di reclamo, cui il giudice tributario
rimane (e non può che rimanere) del tutto estraneo, e fase
giurisdizionale, nella quale soltanto la commissione acquista
e può esercitare i propri poteri di annullamento e cautela.
2.4. La data di notifica
Ai sensi del comma 11 dell’articolo 39 del DL n. 98 del
2011, il nuovo istituto trova applicazione con riferimento “agli
atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile
2012”.
In relazione alla data di notifica, il nuovo istituto trova applicazione con riferimento agli atti suscettibili di reclamo “ricevuti dal contribuente” a decorrere dal primo aprile. Nel caso di
atto notificato a mezzo posta anteriormente al 1° aprile 2012,
ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, il
nuovo istituto risulta applicabile, con la conseguenza che l’eventuale giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale
non può essere proposto direttamente, dovendosi avviare in via
preventiva il procedimento del reclamo obbligatorio.
Più precisamente rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il notificatario.
Nel caso di atto notificato a mezzo posta anteriormente
al 1° aprile 2012, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, il nuovo istituto risulta applicabile, con la
conseguenza che l’eventuale giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale non può essere proposto direttamente, dovendosi avviare in via preventiva il procedimento di cui
all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.
In proposito si rappresenta che il terzo comma dell’articolo 149 c.p.c., aggiunto dal comma 1 dell’articolo 2 della legge
28 dicembre 2005, n. 263, stabilisce che “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna
… all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento
in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.
Si ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre 2002, n. 477, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del combinato disposto del previgente testo
dell’articolo 149 c.p.c. e dell’articolo 4, terzo comma, della
legge 20 novembre 2002, n. 890, nella parte in cui prevedevano che la notificazione si perfezionasse, “per il notificante,
alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché
alla data, antecedente, di consegna all’ufficiale giudiziario”.
Sulla base della giurisprudenza di legittimità successivamente formatasi, si ritiene che “la distinzione dei momenti
di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario può essere invocata quando si tratti di far discendere
conseguenze negative per il notificante, non dipendenti dalla
sua volontà ma non quando la norma preveda che un termine
debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notifica, essendo in tali casi
necessario avere riguardo alla effettiva ricezione dell’atto
(Cass. 10837/2007)” (Cass. 25 ottobre 2011, n. 22084).
Ulteriore fondamento a sostegno della predetta interpretazione è offerto dalla formulazione dello stesso articolo 17bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, che al comma 1 impone di
avviare il procedimento di mediazione a “chi intende proporre ricorso”, ossia a chi ha ricevuto la notifica dell’atto che
ritiene illegittimo o infondato.
t r i b u ta r i o
Gazzetta
F O R E N S E
3. L’istanza
3.1.Soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza
In ragione dello stretto nesso tra l’istanza di mediazione e
il ricorso giurisdizionale, vi è perfetta coincidenza tra la legittimazione processuale attiva nel giudizio tributario e la legittimazione a presentare l’istanza di cui all’articolo 17-bis.
Pertanto, sebbene non espressamente richiamate dalla
norma in commento, si ritengono applicabili al nuovo istituto
le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 546 del
1992, per quanto concerne, in particolare, l’individuazione
della legitimatio ad causam, vale a dire della capacità di essere parte nel processo tributario, e della legitimatio ad processum, che consiste nell’attitudine del soggetto che ha la titolarità dell’azione a proporre la domanda e a compiere validamente gli atti processuali.
Ciò comporta che l’istanza può essere alternativamente
presentata:
- dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia
direttamente sia a mezzo di procuratore generale o speciale; la procura va conferita con atto pubblico o per
scrittura privata autenticata;
- dal rappresentante legale del contribuente che non ha la
capacità di stare in giudizio.
- dal difensore, nelle controversie di valore pari o superiore
a 2.582,28 euro.
L’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 rinvia, per la predisposizione dell’atto di reclamo, all’art. 12 del D.Lgs. n.
546/1992, con la conseguenza che occorre inserire in calce
all’atto l’incarico al difensore.
Il rinvio all’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 comporta che,
nonostante la fase antecedente all’eventuale costituzione in
giudizio sia, in sostanza, una fase amministrativa, il contribuente sia tenuto a munirsi di difensore tecnico (esempio,
dottore commercialista, avvocato, consulente del lavoro).
Detto obbligo viene meno ove la causa sia di valore inferiore
a euro 2.582,28.
È bene che il contribuente inserisca subito nella procura
al difensore la facoltà di pervenire ad una mediazione della
lite. Infatti, tale potere, se non conferito espressamente, potrebbe risultare precluso, in quanto comporta una disposizione del diritto in contesa ai sensi dell’art. 84 del codice di
procedura civile. Per il compimento degli atti che causano la
disposizione del diritto controverso non è sufficiente il solo
mandato ad litem, occorrendo il conferimento al difensore di
un apposito potere in tal senso mediante indicazione espressa
nella procura. Ciò vale, ad esempio, per l’acquiescenza alla
sentenza (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1610), per la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 e per la
rinuncia al ricorso (Cass. 15 luglio 2005, n. 15016).
In base al prevalente orientamento della giurisprudenza
(per tutte, Cass., SS.UU., 2 dicembre 2004, n. 22601), qualora il ricorso sia sottoscritto dalla sola parte, il che si concretizza in un difetto di assistenza tecnica, il giudice non può
dichiarare subito inammissibile il ricorso, ma deve invitare la
parte a regolarizzare la propria posizione, e, solo in caso di
inottemperanza, può essere dichiarata l’inammissibilità.
Un meccanismo simile, peraltro, è ora contemplato
dall’art. 182 del codice di procedura civile post L. 18 giugno
2009, n. 69.
È dubbio che tale orientamento possa trovare applicazio-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
ne nel reclamo, visto che l’ordine di regolarizzazione verrebbe
impartito dopo il deposito del ricorso, quindi dopo che la
fase di reclamo/mediazione ha avuto luogo. Per sostenere la
tesi affermativa, si dovrebbe accettare che il giudice, nell’ordinare al contribuente di munirsi di difensore, ordini altresì
di riesperire la fase di reclamo/mediazione, che deve necessariamente precedere l’iter processuale.
3.2.Il contenuto formale dell’istanza
Il reclamo deve contenere la domanda di annullamento
totale o parziale dell’atto. Facoltativa è invece la motivata
proposta di mediazione che la parte può inserire nell’atto,
completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa
(proposta che, a ben vedere, si traduce in una particolare
domanda di annullamento parziale).
Giova sottolineare sin d’ora che l’oggetto della domanda
(petitum), di annullamento totale o parziale dell’atto, dovrà
già essere formulato con chiarezza nel primo atto. Vale a dire
che il reclamo stesso, essendo destinato a produrre «gli effetti del ricorso», dovrà contenere, a pena di inammissibilità,
l’indicazione dell’«oggetto della domanda», requisito contenutistico essenziale del ricorso, prescritto dall’art. 18, norma
espressamente richiamata dal comma 6 dell’art. 17-bis.
L’oggetto della domanda, individuato in sede di reclamo,
ovvero in un atto potenzialmente idoneo ad esplicare, in un
momento successivo, gli effetti del ricorso, sarà quindi immodificabile. Tradotto in termini operativi, se nel reclamo/ricorso
si insiste esclusivamente per il parziale annullamento dell’atto,
nell’eventuale successiva fase giurisdizionale non potrà essere
formulata la diversa domanda di annullamento totale.
Nel corpo dell’atto introduttivo, sarà opportuno tenere
ben distinta la proposta di mediazione, se formulata subordinatamente alla domanda di annullamento integrale dell’atto,
affinché detta proposta non possa essere erroneamente intesa,
nell’eventuale successiva fase contenziosa, come parziale acquiescenza alla pretesa impositiva.
La tutela del contribuente potrebbe essere lesa perché egli
manifesterebbe in anticipo la volontà di pervenire ad una
soluzione stragiudiziale della controversia. Il giudice potrebbe
essere condizionato. Allora si potrebbe ipotizzare l’applicabilità dell’art.10 del Dlgs 28/2010 in materia di mediazione civile e commerciale, secondo il quale “ le dichiarazioni rese o
le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il
medesimo oggetto, salvo consenso della parte dichiarante”.
Detto ciò Quando il contribuente presenterà la proposta?
Il contribuente presenterà la proposta nei casi in cui sia
consapevole fin dall’inizio della debolezza delle proprie tesi
difensive, e soprattutto nella consapevolezza di avere scarsissime possibilità di vittoria nella successiva fase processuale.
In questo caso, laddove dovesse andare a buon fine la mediazione, riceverebbe un doppio vantaggio. Il primo consisterebbe nella riduzione della sanzione al 40% delle sanzioni irrogabili in rapporto all’ammontare risultante dalla conciliazione (art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 546/1992), ed il secondo,
riferito alla fase processuale, consisterebbe nel risparmio
delle spese di lite e del procedimento di mediazione. Il legislatore tributario ha introdotto, infatti, una disposizione che
sanziona la soccombenza di fronte al giudice, non solo con il
pagamento delle spese di giudizio, ma anche con l’obbligo di
2 0 1 2
131
rimborsare alla controparte «una somma pari al 50 per cento
delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del
procedimento» (art. 17-bis, comma 10). Con l’avvertenza,
peraltro, che, laddove una parte abbia presentato proposta di
mediazione non accolta in fase di conciliazione e successivamente avallata dal giudice, le spese processuali potranno essere compensate anche in caso di soccombenza. L’intento è
evidentemente quello di incentivare la proposta di mediazione
sia da parte del proponente che del ricevente, sanzionando,
con l’accollo delle spese di lite, la controparte che abbia, senza giusti motivi, rifiutato la proposta di mediazione.
E’ importante ricordare che il contenuto della domanda
varia a seconda del fatto che il reclamo sia presentato contro
un atto impugnabile in giudizio o a fronte di un silenzio-rifiuto di rimborso: l’oggetto del reclamo è costituito rispettivamente dalla richiesta di annullamento dell’atto impugnabile e dalle domande di accertamento del credito del contribuente e di condanna dell’ufficio alla restituzione. In presenza di provvedimenti a contenuto unitario ma divisibile (quali
avvisi di accertamento contenenti più riprese reddituali o
provvedimenti impositivi con contestuale irrogazione delle
sanzioni), la domanda di annullamento può investire singole
parti dell’atto, trattandosi appunto di statuizioni che, seppur
funzionali alla produzione di un medesimo effetto (l’obbligazione tributaria) o di effetti connessi (l’obbligazione sanzionatoria rispetto al debito d’imposta), restano autonome fra
loro: sicché è possibile parlare di distinti capi dell’atto e riconoscere a ciascuno autonomo rilievo, anche per quanto concerne i suoi eventuali vizi. Ciò comporta la possibilità di richiedere l’annullamento parziale dell’atto, con riguardo a uno
o ad alcuni dei capi in esso contenuti. L’autonomia del potere
sanzionatorio rispetto a quello di imposizione rende altresì
configurabile il reclamo avverso il solo provvedimento riguardante le sanzioni, per motivi indipendenti dall’an e dal
quantum dell’obbligazione tributaria. Nelle ipotesi di responsabilità di imposta, il coobbligato in via solidale dipendente
può presentare reclamo contro tutti (e soli) i provvedimenti
che gli siano notificati: e, dunque, anche contro l’avviso di
accertamento dell’obbligazione principale, a lui direttamente
intestato e notificato.
Fatte tali premesse, ricordiamo che il procedimento è introdotto da una specifica istanza, formulata dal contribuente
nei confronti dell’Agenzia e motivata sulla base di elementi di
fatto e di diritto che devono coincidere con i motivi di impugnazione proposti nel ricorso.
È in ragione di tale coincidenza che, a seguito dell’inutile
decorso della fase di mediazione, l’istanza può produrre gli
effetti del ricorso giurisdizionale.
Ciò comporta, peraltro, che:
• i motivi esposti nell’istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso, a pena di inammissibilità; sotto
tale profilo va ribadito che, in applicazione del comma 2
dell’articolo 17-bis, è inammissibile il motivo di ricorso,
proposto innanzi alla Commissione tributaria provinciale,
per il quale non sia stata preventivamente esperita la procedura del reclamo. Né è consentito integrare (successivamente all’introduzione del giudizio) i motivi del ricorso.
Invero, ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 del D.Lgs. n.
546 del 1992, l’integrazione dei motivi di ricorso è ammessa esclusivamente quando “resa necessaria dal depo-
tributario
Gazzetta
132
d i r i t t o
sito di documenti non conosciuti ad opera delle altre
parti o per ordine della commissione”;
Perciò, l’unico caso in cui è possibile l’integrazione dei
motivi è rappresentato dal deposito di documenti non conosciuti ad opera della Direzione provinciale/DRE, ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quid iuris, se il contribuente viene a conoscenza di nuovi
documenti dopo la proposizione del reclamo, ma prima della
costituzione in giudizio?
L’art. 17-bis, al comma 6, nell’individuare precisamente le
norme applicabili al procedimento, non contiene alcun richiamo all’art. 24. Ma sarebbe irragionevolmente lesivo del diritto alla difesa, e quindi costituzionalmente illegittimo, inibire
l’esercizio della facoltà di dedurre motivi aggiunti nei soli
confronti del contribuente che abbia acquisito conoscenza di
nuovi documenti nel corso del procedimento instauratosi per
effetto della proposizione, oltretutto obbligatoria, del reclamo, ed ammettere viceversa l’integrazione dei motivi se la
conoscenza dei nuovi documenti sia intervenuta successivamente, in occasione del deposito dei documenti stessi nella
successiva fase giurisdizionale. Si avverte l’esigenza di coordinamento normativo, tra la vigente disciplina sull’integrazione dei motivi e il neo-introdotto istituto del reclamo.
Nell’attesa dell’intervento legislativo, il diritto alla difesa
del ricorrente, costituitosi in giudizio, potrebbe essere garantito dal giudice, attraverso un’ordinanza che disponga d’ufficio l’acquisizione dei «nuovi documenti», e renda quindi
possibile l’integrazione dei motivi, nel rispetto dei termini e
delle procedure prescritte dall’art. 24.
La Circolare 19/E sancisce “….Né è consentito integrare
(successivamente all’introduzione del giudizio) i motivi del
ricorso. Invero, ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 del D.
Lgs. n. 546 del 1992, l’integrazione dei motivi di ricorso è
ammessa esclusivamente quando “resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o
per ordine della commissione”;
L’integrazione dei motivi deve, stante tali premesse, a
nostro avviso, essere ammessa anche ove il contribuente sia
reso edotto dei nuovi documenti nelle more del procedimento
di reclamo, quindi prima della costituzione in giudizio. La
Commissione tributaria, mediante ordinanza, potrebbe disporre d’ufficio l’acquisizione dei nuovi documenti, al fine di
consentire il diritto di integrazione dei motivi.
il ricorso depositato nella segreteria della Commissione
tributaria provinciale deve essere conforme a quello consegnato o spedito alla Direzione con l’istanza di mediazione, a
pena di inammissibilità dello stesso
Per individuare il contenuto dell’istanza bisogna fare riferimento ai commi 6 e 7 dell’art.17 bis. In primis viene richiamato l’art.18 del Dlgs 546/97. Per effetto delle norme sopra
richiamate, nell’istanza vanno indicati:
1) la Direzione nei cui confronti è avviato il procedimento
amministrativo in esame, cui spetta la legittimazione in
giudizio ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 546 del
1992, ossia alla struttura “che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto”;
2) il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa
residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto
nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
t r i b u ta r i o
Gazzetta
F O R E N S E
3) l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza;
4) i motivi.
Nell’istanza va indicato anche il domicilio presso il quale
il contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al
procedimento, quali, ad esempio, l’accoglimento dell’istanza
o il diniego. In assenza di elezione di domicilio, le comunicazioni sono effettuate presso la residenza o la sede legale del
contribuente.
Nell’istanza il contribuente dovrà indicare, altresì, il valore della controversia che – come è noto – va determinato al
fine di stabilire l’obbligatorietà della fase di mediazione.
L’Agenzia delle Entrate reputa, inoltre, ammissibile la
redazione di un’unica istanza allo scopo di avviare il procedimento di mediazione con riguardo a più atti impugnabili,
in modo speculare alla redazione di un ricorso cumulativo.
In tal caso, tuttavia, si instaurano – per ciascuno degli
atti impugnati - separati procedimenti, non trovando applicazione l’articolo 29 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che disciplina
la riunione dei giudizi.
Infine, in calce all’istanza potrà infine essere richiesta la
sospensione della riscossione. (problema di cui sopra riferito
alla tutela cautelare superato dalla prassi)
Abbiamo precedentemente detto che in base al comma 6
dell’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione l’articolo 22, comma 416, del medesimo decreto, secondo
cui “Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma
1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o
la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”.
In base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, all’istanza predisposta il contribuente dovrà allegare:
- copia dell’atto impugnato;
- copia di tutti i documenti che, in caso di esito negativo del
procedimento di mediazione e di eventuale costituzione in
giudizio, il contribuente intenderebbe allegare al ricorso e
depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, con il proprio fascicolo di causa, per
provare in giudizio la fondatezza delle eccezioni sollevate
avverso l’atto impugnato.
La mancata allegazione di atti o documenti già in possesso dell’Ufficio non costituisca motivo di rigetto dell’istanza.
Di contro, la mancata allegazione di atti o documenti non
in possesso dell’Ufficio potrebbe rendere l’istanza incompleta
(e non conforme quindi al ricorso, completo di allegati, eventualmente depositato in Commissione al termine del procedimento), allorché tali atti o documenti siano dimostrativi di
fatti rilevanti ai fini della compiuta e corretta disamina delle
ragioni addotte dal contribuente.
Potendo quindi l’obbligatorio procedimento di mediazione estinguere la controversia, non si può fare a meno di produrre già in tale fase i documenti indicati nell’istanza, proprio
perché il deposito del fascicolo completo nella segreteria della Commissione tributaria provinciale può avvenire solo se
16 È evidente come il testuale richiamo all’applicabilità del comma 4 dell’articolo
22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 realizza le condizioni necessarie a ché il nuovo
istituto, attraverso la disamina delle medesime eccezioni e dei medesimi atti che
si intende sottoporre al Giudice, possa risultare funzionale all’obiettivo di anticipare l’esito del giudizio in sede amministrativa e di evitare il ricorso alla
fase giurisdizionale.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
fallisce il tentativo di mediazione.
Nell’istanza, infine, può essere formulata, come detto, una
motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
L’Agenzia delle entrate, destinataria della domanda di
annullamento, dispone in fase di reclamo di poteri diversi – e
più ampi – rispetto a quelli del giudice tributario. Mentre
infatti il giudice non può adottare metodologie di accertamento differenti da quelle prescelte dall’ufficio, né ricostruire
l’imponibile sulla base di ragioni di fatto o di diritto non allegate dalle parti ( Il principio secondo cui il giudice tributario
deve decidere “entro i limiti posti, da un lato, dalle ragioni di
fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e,
dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente” è affermato, fra le altre, da Cass.,
20-10-2011, n. 21759, ; Id., 21-7-2010, n. 17072,; Id., 28-12010, n. 1825,), l’Agenzia delle entrate può tornare sul provvedimento emanato e modificarne il contenuto. In effetti, il
reclamo è assimilabile a un’istanza obbligatoria di autotutela
e consente all’ufficio di modificare l’originaria pretesa impositiva sia sul piano quantitativo (riducendo l’ammontare delle
imposte e delle sanzioni originariamente accertate), sia sotto
il profilo della motivazione.
L’accoglimento parziale del reclamo determina una riduzione della pretesa originaria, mentre la motivazione del
provvedimento può essere emendata in caso di positivo esperimento della mediazione, che appare pensata anche a questo
scopo: il che non comporta alcuna inammissibile modifica del
contenuto del provvedimento pendente iudicio, proprio perché
la motivazione viene rivista al di fuori del giudizio, nell’ambito di un procedimento amministrativo assimilabile in parte
qua a quello di accertamento con adesione.
L’esercizio di queste prerogative caratterizza gli istituti del
reclamo e della mediazione e vale appunto a orientare l’esito
del procedimento delineato – in maniera per la verità non del
tutto limpida – dall’art. 17-bis del d.lgs. 31-12-1992, n. 546,
consentendo alle parti di pervenire a una determinazione
condivisa dell’imponibile e dell’imposta.
3.3.La notificazione
Tra le disposizioni applicabili al procedimento di mediazione, il comma 6 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del
1992 richiama anche l’articolo 20 dello stesso decreto, il quale, al comma 1, stabilisce che “Il ricorso è proposto mediante
notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16”.
Ne consegue che per la notificazione dell’istanza trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 2 e
3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per il quale “le notificazioni
sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17.
“Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente
a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in
plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento,
sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”.
Pertanto, la notifica dell’istanza nei confronti dell’Ufficio
che ha emanato l’atto deve essere effettuata secondo una
delle seguenti modalità (30):
2 0 1 2
133
• a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste
dall’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
• mediante consegna diretta all’Ufficio dell’Agenzia delle
entrate, che ne rilascia ricevuta;
• direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Si ricorda infine che, nelle ipotesi di spedizione a mezzo
del servizio postale, la notificazione dell’istanza, al pari della
notificazione del ricorso, si considera effettuata – ai fini del
computo del termine di sessanta giorni utile per l’impugnazione dell’atto - alla data di spedizione tramite servizio postale della medesima istanza e non a quella di ricezione da parte
della Direzione (cfr. articolo 16, comma 5, del D.Lgs. n. 546
del 1992).
Nella pratica, possono sorgere problemi analoghi a quelli
che attengono al rispetto delle modalità di notifica del
ricorso giurisdizionale, concernenti ad esempio la sorte del
ricorso – e, ora, anche del reclamo – spedito in busta chiusa,
con posta ordinaria o con raccomandata semplice: ma la
soluzione di questi problemi deve tener conto delle peculiarità della fattispecie regolata dall’art. 17-bis del d.lgs. 31-121992, n. 546, alla quale non sono tout court applicabili le
conclusioni cui la giurisprudenza è pervenuta nell’interpretare l’art. 20. Nel silenzio della legge, la Corte di cassazione ha
ritenuto a volte che la spedizione postale del ricorso in busta
chiusa, priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in essa
contenuto, costituisse una mera irregolarità ove il contenuto
della busta e la riferibilità alla parte non fossero contestati,
essendo altrimenti onere del ricorrente provare l’infondatezza della contestazione mossa dall’ufficio (18); e ha altre volte
considerato nulla tale notifica per violazione di un essenziale
requisito di forma, ammettendo però la sanatoria della nullità per effetto della costituzione in giudizio della parte resistente (19). Nel caso del reclamo, eventuali vizi formali di
notifica dovrebbero risultare irrilevanti in tutte le ipotesi in
cui l’Agenzia delle entrate venga comunque in possesso dell’atto e – come la legge prevede – dia corso al relativo procedimento. In altri termini, l’effetto sanante di una eventuale
nullità, prodotto in sede processuale dalla costituzione in
giudizio della parte resistente, risulta qui anticipato al momento della ricezione del reclamo da parte dell’ufficio destinatario, tenuto ex lege alla relativa istruttoria a prescindere
dall’esistenza di vizi di notifica dell’atto stesso.
3.4. I termini di presentazione
L’istanza va notificata:
• a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data
di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare;
La tardiva presentazione del reclamo, quindi, comporta
l’inammissibilità del successivo eventuale ricorso in commissione, salve le ipotesi di doverosa rimessione in termini della
parte interessata (sulla base di quanto dispone oggi l’art. 153,
2° co., c.p.c.). L’art. 17-bis del d.lgs. 31-12-1992, n. 546 non
fornisce alcuna indicazione in merito al comportamento che
l’ufficio deve adottare in caso di tardiva notifica del reclamo.
Si potrebbe quindi ritenere che, nonostante la tardività della
notifica, il reclamo debba essere esaminato dall’ufficio e segui-
tributario
Gazzetta
134
d i r i t t o
to, in caso di rigetto, dalla proposta di mediazione; ma la disciplina del procedimento delineata dalla stessa norma (di cui
si dirà meglio infra) induce a concludere che, in realtà, l’ufficio
non sia vincolato in tal senso e possa limitarsi a respingere il
reclamo – o, addirittura, restare inerte – attendendo la scadenza del termine (novanta giorni dalla presentazione dell’atto)
previsto dalla legge per la sua conversione in ricorso. A quel
punto, il reclamo si convertirebbe in un ricorso inammissibile
perché tardivo, fatta salva – ripetesi – la rimessione in termini
del contribuente da parte della commissione tributaria.
Nulla impedisce comunque all’ufficio di esaminare nel
merito e accogliere un reclamo tardivo, posto che, come noto,
anche i provvedimenti di imposizione divenuti definitivi perché non tempestivamente impugnati possono essere annullati
in via di autotutela amministrativa. In queste situazioni, il
reclamo produce effetti del tutto analoghi a quelli dell’istanza di annullamento di un atto definitivo: e come tale va considerato dall’ufficio.
Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l’istanza può essere proposta dopo il novantesimo
giorno dalla domanda di rimborso presentata entro i termini
previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto
alla restituzione non è prescritto (cfr. articolo 21, comma 2
del D.Lgs. n. 546 del 1992).
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, in caso di presentazione di istanza di
accertamento con adesione il termine per la proposizione
dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un
periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte
del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.
Al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si
applicano inoltre le disposizioni sulla sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969,
n. 742, stante lo stretto nesso tra la presentazione dell’istanza
e la proposizione del ricorso giurisdizionale, nonché il richiamo espresso all’applicabilità dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546
del 1992, contenuto – come si è detto – nel comma 6 dell’articolo 17-bis in argomento.
La sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre non
trova, invece, applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, di cui ai commi 7 e seguenti del citato articolo 17-bis, che deve pertanto concludersi comunque
nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale.
Secondo parte della dottrina, però, (Turchi) la particolare
natura del reclamo, che costituisce una sorta di ricorso sub
condicione ed è destinato a produrne ipso iure gli effetti nelle
situazioni sopra esaminate, sembra autorizzare diversa conclusione, e far ritenere che anche il termine di presentazione
del reclamo resti sospeso nel periodo compreso fra il 1° agosto
e il 15 settembre di ogni anno.
4. Gli effetti della presentazione dell’istanza
Possiamo riscontrare un effetto sostanziale - La notifica
dell’istanza di mediazione alla Direzione produce innanzitutto l’effetto (sostanziale) di interrompere il decorso del
termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto. E possiamo
riscontrare un effetto processuale - Il comma 9 dell’articolo
17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del
t r i b u ta r i o
Gazzetta
F O R E N S E
reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle
entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti
termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di
accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”.
Per espresso disposto normativo, quindi, l’istanza proposta ai sensi dell’articolo 17-bis produce gli effetti del ricorso,
con la conseguenza che la notificazione dell’istanza equivale
alla notificazione del ricorso (effetto di “chiamata in giudizio”) e che il termine di trenta giorni, stabilito dall’articolo 22
del D.Lgs. n. 546 del 1992 per instaurare la controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale mediante il
deposito del ricorso (effetto “di costituzione in giudizio”) va
calcolato a partire dal giorno successivo:
- a quello di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione, senza che sia
stato notificato il provvedimento di accoglimento della
stessa ovvero senza che sia stato formalizzato l’accordo di
mediazione;
- a quello di comunicazione del provvedimento con il quale
l’Ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei predetti
novanta giorni;
- a quello di comunicazione del provvedimento con il quale
l’Ufficio, prima del decorso di novanta giorni, accoglie
parzialmente l’istanza.
Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del
provvedimento dopo la scadenza del novantesimo giorno, il
termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento
dei novanta giorni.
5. La trattazione dell’istanza
La circolare prende in considerazione tre ipotesi:
a) se l’istanza presentata dal contribuente contiene una
motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa, che presenti i presupposti
per l’accoglimento integrale, lo stesso Ufficio può invitare il
contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione
nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di
particolari formalità;
b) in mancanza di proposta formulata nell’istanza, l’Ufficio, quando opportuno, comunica una propria proposta
motivata di mediazione, completa della rideterminazione
della pretesa tributaria, con tutte le indicazioni di carattere
procedurale utili sia per la sottoscrizione dell’accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
c) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l’Ufficio invita il contribuente al contraddittorio. In
relazione a questo aspetto, la circolare prende in considerazione l’ipotesi che il contribuente, prima di proporre reclamo,
abbia esperito inutilmente la procedura di accertamento con
adesione. In tale ipotesi viene affermato come uno degli elementi acquisiti in sede di contraddittorio ai fini della mediazione, è relativo alle motivazioni per le quali non si è chiusa
l’adesione. Sul punto, si dovrà verificare in quali termini un
ufficio diverso da quello che precedentemente ha valutato
l’istanza di adesione, possa considerare i predetti elementi. Per
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
converso, si dovrà comprendere lo “spazio” che il contribuente avrà a disposizione per chiudere la mediazione non avendo,
precedentemente, chiuso l’adesione. Sul punto, il documento
di prassi osserva come la mediazione potrebbe intervenire in
ragione del fatto che il contribuente prenda cognizione della
linea difensiva che l’ufficio seguirà in occasione del contenzioso tributario.
La circolare 9/E evidenzia quali possano essere gli elementi di analisi. In particolare sottolinea:
Tra gli elementi oggetto di analisi possono assumere particolare rilevanza:
• i motivi del ricorso, con i quali il contribuente espone in
dettaglio i vizi formali e sostanziali che potrebbe eccepire
in sede contenziosa ;
• l’eventuale indicazione di documenti non disponibili o non
esibiti dal contribuente in fase di accertamento con adesione (nei casi ovviamente in cui non sia preclusa l’esibizione);
• la formazione di un orientamento della Corte di cassazione ovvero della giurisprudenza di merito locale, contrario
o favorevole alle posizioni dell’Agenzia.
Ribadendo che tali profili, del resto, possono risultare
determinanti anche per il contribuente, che, in sede di mediazione, potrebbe decidere di aderire alla proposta (non accolta
in sede di accertamento) a seguito della sopravvenuta conoscenza degli elementi sopra richiamati ovvero in considerazione dei motivi dell’eventuale rigetto dell’istanza prospettati
dall’Ufficio, che anticipano la linea di difesa dell’Amministrazione nell’eventuale fase contenziosa.
L’esito del contraddittorio – che si svolge possibilmente
nell’ambito di un solo incontro – viene descritto in un apposito verbale.
Al contraddittorio il contribuente può partecipare personalmente oppure conferire procura al proprio difensore, fatti
salvi i casi in cui il contribuente intenda parteciparvi personalmente.
Il verbale di contraddittorio deve essere sottoscritto, da
un lato, dal contribuente o dal difensore munito di procura e,
dall’altro, dal dirigente o dal funzionario incaricato del contraddittorio.
Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio,
il dirigente o funzionario incaricato annota la “mancata presentazione” dello stesso sull’originale dell’invito al contraddittorio.
6. Mediazione parziale
Se si forma un consenso sull’annullamento parziale, non
vi sono problemi, ma se invece sulla pretesa ridotta il contribuente decide comunque di andare in giudizio, potrebbe non
esservi più corrispondenza tra i contenuti del ricorso e quelli
dell’atto impugnato, parzialmente modificato. Dovrà allora o
ammettersi una proposizione di motivi aggiunti, o ipotizzare
che l’annullamento parziale «modificativo» possa essere disposto solo quando sull’atto residuo il contribuente sia disposto a fare acquiescenza.
Tra queste due alternative, si pone forse come ipotesi più
razionale che in realtà di annullamento parziale si parli nel
nuovo art. 17bis ai soli fini di una riduzione quantitativa della pretesa, mentre una riconsiderazione dei contenuti dell’atto
impugnabile, in chiave modificativa, sia propria piuttosto
2 0 1 2
135
della mediazione, che è una vicenda nella quale appunto si crea
un consenso tra Amministrazione e contribuente.
Su tale punto l’Amministrazione finanziaria ha chiarito
che “stante la marcata finalità deflativa dell’istituto in esame,
si ritiene che la conclusione di una mediazione parziale
possa intervenire esclusivamente in casi eccezionali, in presenza di specifiche e motivate ragioni. In altre parole, la
conclusione della mediazione, in armonia con la ratio del
nuovo istituto, deve condurre, di norma, alla definizione del
rapporto, evitando l’attivazione della fase giurisdizionale”.
L’Ufficio quando non pervenire all’annullamento totale o
parziale dell’atto, o non accetta la proposta del contribuente,
sarà tenuto a formulare una propria proposta di mediazione
tenendo in considerazione:
• le questione potenzialmente controversie della pretesa,
• la sostenibilità della stessa
• il grado di economicità dell’azione amministrativa17.
Si tratterebbe, come approfondirà Turchi, di un dovere dai
confini molto incerti, perché correlato all’esistenza di parametri (l’eventuale incertezza delle questioni controverse, il
grado di sostenibilità della pretesa e il principio di economicità dell’azione amministrativa) che nel caso concreto potrebbero orientare non tanto alla ricerca di una definizione mediata della controversia, quanto alla conferma integrale del
provvedimento reclamato.
le questione potenzialmente controversie della pretesa
Nel sistema giuridico italiano non trova applicazione il
“precedente giurisprudenziale”, ovvero il principio di common law in base al quale una sentenza può esplicare effetti
anche su soggetti che non sono stati parti del giudizio. Infatti, ai sensi dell’articolo 2909 c.c. “L’accertamento contenuto
nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra
le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Conseguentemente è possibile ritenere che in via di principio, ogni questione giuridica proposta nell’ambito di un
processo è “incerta” fino al momento in cui non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che definitivamente
“accerti” la questione giuridica controversa.
Occorre tuttavia rilevare che, a seguito delle modifiche
introdotte dall’articolo 47, comma 1, lettera a) della legge 18
giugno 2009, n. 69, l’articolo 360-bis, primo comma, n. 1),
c.p.c. attualmente dispone che “Il ricorso è inammissibile:
“1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della
Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare
o mutare l’orientamento della stessa;”.
In altri termini, il legislatore ha previsto l’inammissibilità
del ricorso per cassazione quando la questione giuridica con
esso sollevata sia difforme dalla giurisprudenza della Suprema
Corte e i motivi di impugnazione proposti dall’istante non
prospettano sufficienti elementi per ritenere possibile un mutamento di posizione interpretativa da parte della Cassazione.
Ne consegue che, attualmente, è possibile ritenere che anche in relazione a questioni di diritto sia individuabile una
17In questa fase si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla conciliazione
giudiziale. Si tratta di una conciliazione “fuori udienza”, visto che ancora non
si è incardinato il processo tributario, e si applica pervenendo a un accordo tra
il contribuente e l’Ente impositore attraverso intese extraprocessuali. Per
un’analisi di tali punti vedasi Circ. 9/E/2012, parag. 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3.
tributario
Gazzetta
136
d i r i t t o
“certezza”, rappresentata dalla presenza di un orientamento
consolidato della Corte di cassazione, tale da indurre a ritenere che un eventuale ricorso per cassazione potrebbe effettivamente essere dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte.
Orbene, nell’eventualità che la posizione assunta nell’atto
impugnato contrasti con gli orientamenti giurisprudenziale si
rende opportuno favorire un accordo di mediazione, sulla
base dell’eventuale proposta formulata dal contribuente o,
diversamente, elaborata dall’Ufficio.
In assenza di prassi amministrativa e di pronunce della
Suprema Corte, la proposta di mediazione sulla questione
giuridica può essere motivata sulla base della presenza di un
orientamento delle Commissioni tributarie, favorevole alle
posizioni espresse dal contribuente, se del caso tenuto conto
altresì degli altri due criteri della sostenibilità della pretesa in
giudizio e dell’economicità dell’azione amministrativa.
Come infatti già chiarito precedentemente, l’Ufficio procede con la fase di vera e propria mediazione ogniqualvolta,
in caso di possibile esito sfavorevole o parzialmente sfavorevole del contenzioso, non siano ravvisabili i presupposti per
la prosecuzione in appello della controversia. Per converso,
ciò comporta che la pretesa ritenuta sostenibile va difesa in
ogni stato e grado del giudizio.
È il caso di precisare che, in adesione a preminenti esigenze di uniformità e imparzialità del comportamento degli Uffici, è esclusa la possibilità di mediare in relazione a questioni risolte in via amministrativa con apposito documento di
prassi, cui gli Uffici devono necessariamente attenersi anche
nella gestione delle relative controversie, a nulla rilevando
l’eventuale contrario orientamento della giurisprudenza cui
l’Amministrazione non abbia ancora prestato adesione.
Il grado di sostenibilità della pretesa
Tale criterio appare funzionale alla necessità che, nella
trattazione della mediazione, l’Ufficio esamini le questioni di
fatto basandosi sostanzialmente sul grado di sostenibilità
della prova in giudizio della pretesa tributaria e sulla fondatezza degli elementi addotti dall’istante.
Si ritiene in particolare che la scarsa sostenibilità della
pretesa sia sufficiente a motivare la mediazione su questioni
di fatto.
Al riguardo, le valutazioni di opportunità, evidenziate nel
precedente punto sotto il profilo delle questioni di diritto risolte dalla Cassazione, vanno estese alla giurisprudenza di
merito relativamente alle questioni di fatto sollevate nell’istanza di mediazione.
In sintesi, la proponibilità dell’accordo di mediazione è
direttamente correlata, soprattutto per le questioni di fatto,
al prevedibile esito sfavorevole del giudizio di merito.
Va ulteriormente precisato che la giurisprudenza da prendere in considerazione è essenzialmente quella della Commissione tributaria provinciale e della Commissione tributaria regionale nelle cui circoscrizioni ha sede la Direzione,
a condizione che sia condivisa o, nella negativa, a condizione
che non possa essere utilmente contrastata con ricorso per
cassazione.
3) Il principio di economicità dell’azione amministrativa
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, “L’attività amministrativa … è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”.
t r i b u ta r i o
Gazzetta
F O R E N S E
Il principio di economicità va, quindi, inteso non solo
come necessità di ottimizzazione economica delle risorse, ma
altresì come ottimizzazione dei procedimenti, vale a dire come
impegno a non gravare il procedimento amministrativo di
oneri inutili e dispendiosi, cercando di realizzare una rapida
ed efficiente conclusione della propria attività amministrativa,
nel rispetto degli altri principi di legalità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
Si tratta di criterio che sostanzialmente accompagna i
precedenti, in quanto individua, in special modo a fronte di
una scarsa sostenibilità della controversia, l’opportunità di
procedere alla mediazione della pretesa tributaria.
In tale valutazione va considerato anche il rischio di soccombenza nelle spese di lite.
7. Ulteriori profili di incostituzionalità: la mediazione e il principio
di indisponibilità della pretesa tributaria
L’art. 17-bis accorda al contribuente e all’Agenzia delle
entrate la possibilità di comporre la controversia attraverso
una mediazione proponibile da entrambe le parti.
Il potere riconosciuto all’Amministrazione di rinunciare a
parte del credito vantato va conciliato con il principio di indisponibilità della pretesa tributaria che si fa discendere
dall’art. 53 Cost.
Si è così affermata la legittimità di derogare a siffatto
principio solo laddove la discrezionalità nella conclusione di
accordi transattivi rimanga finalizzata a un’oggettiva maggiore economicità dell’azione amministrativa.
Sicché, appare apprezzabile che il legislatore, diversamente dall’intervento in materia di transazione fiscale, abbia
(parzialmente) limitato la discrezionalità dell’Agenzia delle
entrate stabilendo che la stessa, nel valutare l’opportunità di
addivenire ad una mediazione, debba tenere in considerazione
elementi come l’incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa, il principio di economicità
dell’azione amministrativa.
Si ritiene che tale valutazione, in ottemperanza ai principi
di trasparenza, imparzialità e correttezza - che devono caratterizzare l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost. debba risultare dall’atto stesso di mediazione in modo da
consentirne una verifica.
Nonostante tali accorgimenti restano, però, alti i rischi di
un uso distorto di istituti transattivi come quello in commento - che nell’ipotesi più ottimistica possono tradursi in un’applicazione non uniforme sul territorio nazionale - a fronte di
vantaggi in termini di economicità dell’azione amministrativa
che sono puramente teorici e che risultano di difficile prova.
Ed anche se la tendenza del legislatore sembra di segno
opposto, non si può fare a meno di ribadire che il principio di
indisponibilità della pretesa tributaria non è un ostacolo da
rimuovere, bensì una garanzia di giustizia dell’ordinamento
tributario essendo finalizzato ad assicurare quell’imparzialità
che si identifica, poi, con la stessa giustizia e che non appare
pertanto da essa scindibile.
8. Conclusioni
Le difficoltà di coordinamento normativo, le forzature
interpretative inevitabilmente implicate e i profili di incostituzionalità della neointrodotta disciplina, inducono a chiedersi se si sia davvero fatto un passo avanti.
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
Si avverte l’esigenza di rimeditare la neo-introdotta disciplina del reclamo/ricorso, per le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore, in passato, ad abbandonare l’idea di intro-
2 0 1 2
137
durre nell’ordinamento tributario un «filtro amministrativo»
obbligatorio, preferendovi la definizione conciliativa della
controversia ex art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
tributario
Gazzetta
Diritto internazionale
[ A cura di Francesco Romanelli ]
Rassegna di diritto internazionale 141
internazionale
A cura di Francesco Romanelli+
F O R E N S E
●
Rassegna di diritto
internazionale
●
A cura di Francesco Romanelli
Avvocato e Specialista
di diritto ed economia delle Comunità europee
n o v e m b r e • d i c e m b r e
2 0 1 2
141
Fondi strutturali – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Ammissibilità
geografica – Attuazione di un investimento cofinanziato dall’Unione europea a partire da una località situata al di fuori delle regioni ammissibili e da un operatore stabilito in tale località
Le disposizioni del diritto primario dell’Unione in materia
di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio
2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999,
devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un
investimento cofinanziato dall’Unione europea sia attuato a
partire da una località situata al di fuori delle regioni ammissibili e da un operatore stabilito in tale località, a condizione
che tale investimento sia diretto, in maniera mirata e identificabile, verso le regioni ammissibili.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. III, sentenza 19
dicembre 2012, Causa C579/11
La Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial
Humano approvò le candidature dell’Instituto Nacional de
Administração (Istituto nazionale dell’amministrazione), del
Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (Sindacato dei
quadri tecnici dello Stato), dell’Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa (Istituto superiore delle scienze del
lavoro e dell’impresa), del Ministério da Saúde (ministero della
Salute) e dell’Instituto do Desporto de Portugal (Istituto dello
sport del Portogallo) a un finanziamento nell’ambito della categoria d’investimenti del POPH1 relativa alle formazioni per
l’amministrazione pubblica. Poiché tali candidati erano tutti
stabiliti nella regione di Lisbona, dette decisioni sono state
adottate ai sensi dell’eccezione prevista al punto 6, lettera a),
dell’allegato V del QRSN2, in quanto il finanziamento richiesto
1Tra i programmi operativi previsti dal Quadro di Riferimento Strategico Nazionale portoghese (QRSN) figura il programma denominato «Potenziale Umano»
(in prosieguo: il «POPH»). Uno degli assi prioritari (asse 3) del POPH riguarda
il perfezionamento professionale e comprende una categoria d’investimenti denominata «Formazioni strategiche per la gestione e l’innovazione nell’amministrazione pubblica» (in prosieguo: le «formazioni per l’amministrazione pubblica»). Le formazioni per l’amministrazione pubblica sono menzionate al punto
7 dell’allegato V del QRSN tra le categorie di investimenti cui si applicano le
eccezioni alla regola dell’ammissibilità territoriale. A tale proposito, il punto 8
del medesimo allegato precisa quanto segue: osservando (…) che gli obiettivi
perseguiti privilegiano segnatamente la riduzione dei costi amministrativi e il
miglioramento della competitività nazionale aumentando l’efficienza dell’amministrazione, è particolarmente importante segnalare che, nonostante la concentrazione significativa delle risorse umane dell’amministrazione pubblica
nella regione di Lisbona, gli effetti delle azioni da realizzare si ripercuotono
necessariamente su tutto il territorio nazionale, a causa del tipo degli enti e dei
servizi che essi forniscono (rivolti a tutti i cittadini e/o agli operatori economici
nel loro complesso). Detta concentrazione di servizi nella regione della capitale
spiega che una parte significativa degli investimenti da realizzare converge in
tale regione (…)»
2Il punto 6 dell’allegato V del QRSN così dispone: «Le spese relative ad operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione sono ammissibili al finanziamento nel quadro dei programmi operativi qualora siano effettuate nelle regioni NUTS 2 contemplate da ciascuno di tali [programmi operativi]. Il suddetto criterio generale di ammissibilità della spesa su base territoriale è applicato, in linea generale, in base alla localizzazione degli investimenti.
Nel caso di investimenti materiali (la cui localizzazione è chiaramente identificabile), l’applicazione è immediata. Nel caso di investimenti immateriali, detto
criterio di ammissibilità è applicato in funzione dell’ubicazione dell’ente beneficiario – definita come l’ubicazione della sede di quest’ultimo o di una sua delegazione (o stabilimento) responsabile per l’esecuzione dell’operazione. Costituiscono eccezioni alla regola generale di ammissibilità territoriale le spese relative
a: a) operazioni con rilevante effetto di ricaduta (“spill over effect”) nei settori
internazionale
Gazzetta
142
D i r i t t o
I n t e r n a z i o n a l e
rientrava nell’obiettivo «Convergenza» di cui all’articolo 5 del
regolamento n. 1083/2006. Ritenendo che tale eccezione sia
incompatibile con il diritto dell’Unione e che le decisioni adottate dalla Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano riducano quindi illegittimamente i fondi disponibili per gli enti interessati stabiliti nelle regioni portoghesi NUTS 23 che sono ammissibili a titolo dell’obiettivo «Convergenza», la Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)
ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tali decisioni dinanzi al Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.
La Corte ha ritenuto che l’interesse della regione che dovrebbe beneficiare del cofinanziamento da parte dell’Unione è soddisfatto al meglio se l’operatore incaricato dell’attuazione offre
le migliori garanzie qualitative e quantitative per portare a buon
fine il progetto. Nel caso in cui tale operatore sia stabilito al di
fuori di detta regione, tale circostanza non osta a che il progetto gli sia affidato. A tale proposito si deve considerare che, se è
vero che la finalità dei Fondi strutturali e degli altri strumenti
finanziari dell’Unione, rammentata ai punti 30 e 31 della presente sentenza, è quella di accelerare la convergenza delle regioni in ritardo di sviluppo, essa non consiste ciononostante nel
riservare le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito dei programmi cofinanziati dall’Unione ai soli operatori stabiliti in
tali regioni. Infatti, conformemente a detta finalità, sono le
suddette regioni a dover beneficiare del cofinanziamento da
parte dell’Unione e non gli operatori che vi sono stabiliti.
Regno Unito - Diritto costituzionale - Scottish Act 1998 - Competenza legislativa del Parlamento scozzese - Diritto penale – Tabacco - Divieto di vendita attraverso distributori automatici
Nel diritto costituzionale del Regno Unito non eccede le
competenze legislative devolute con lo Scottish Act 1998 la
legge del Parlamento scozzese che vieta, tra l’altro, l’esposizione di tabacchi e prodotti correlati nonché la vendita di
tabacco attraverso distributori automatici ovvero da parte di
soggetti non iscritti nell’apposito Registro.
Corte Suprema del Regno Unito, sentenza 12 Dicembre 2012
nella causa [2012] UKSC 61.
e con le modalità di cui ai punti 7 e 8; b) (...)». Il punto 7 così recita: «Costituiscono eccezioni alla regola generale di ammissibilità su base territoriale le
spese relative ad operazioni realizzate nell’ambito della regione NUTS 2 di Lisbona (…), ma i cui effetti si diffondano nelle restanti regioni continentali del
Portogallo e che siano considerati assai rilevanti per lo sviluppo delle regioni
continentali del Portogallo rientranti nell’obiettivo “Convergenza”». Occorre
rilevare che tali categorie d’interventi costituiscono casi eccezionali, debitamente giustificati in base al tipo delle operazioni e all’effetto moltiplicatore che esse
comportano in regioni diverse da quelle in cui l’investimento è realizzato. Tali
categorie rappresentano, complessivamente, una percentuale esigua della dotazione finanziaria dei Fondi strutturali in termini di programmazione. Le indicazioni presentate ai punti seguenti, stabilite in partenariato tra la Commissione europea e le autorità portoghesi, potranno, se del caso, essere oggetto di
ulteriori precisazioni nell’ambito dei singoli programmi operativi tematici». Il
punto 8 dell’allegato V del QRSN stabilisce «metodi specifici» per determinare
l’ammissibilità delle spese alla luce degli effetti di ricaduta al di fuori della regione di Lisbona. 3 Sono le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito
dell’obiettivo “Convergenza” corrispondenti al livello 2 della classificazione
comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE)
n. 1059/2003 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per
la statistica (NUTS) (GU L 154, pag. 1)], il cui prodotto interno lordo (PIL) pro
capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati
comunitari per il periodo 20002002, è inferiore al 75% del PIL medio dell’UE
a 25 per lo stesso periodo di riferimento.
Gazzetta
F O R E N S E
Il 27 gennaio 2010, il Parlamento scozzese approvò la
legge denominata Tobacco & Primary Medical Services (Scotland) Act 2010 con la quale si disciplina la vendita al dettaglio
dei prodotti del tabacco e che include la proibizione dell’esposizione di prodotti del tabacco e stabilisce l’istituzione di un
registro dei rivenditori di tabacco, oltre a modificare i criteri
per l’accesso al convenzionamento per la somministrazione
dei servizi medici primari nell’ambito del Servizio Sanitario
scozzese. La legge fu promulgata dalla sovrana il successivo
3.3.2010 e immediatamente una Compagnia britannica con
interessi in numerosi Paesi ricorse alla Court of Session Outer
House eccependo l’illegittimità costituzionale della normativa
per violazione dell’Union with Scotland Act 1706 e dell’Union
with England Act 1707 in quanto lesiva della libertà di commercio fra gli Stati dell’Unione giacché il divieto di esposizione dei prodotti, di vendita attraverso distributori automatici
e l’istituzione di un registro dei rivenditori, unici abilitati alla
vendita di sigarette e derivati, avrebbe inevitabilmente provocato la diminuzione dell’offerta e consequenzialmente dei ricavi che gli imprenditori del settore avrebbero ragionevolmente potuto attendersi.
Il ricorso fu rigettato dalla Outer House, giudice di primo
grado, così come l’appello proposto alla Inner House.
Il Giudice Lord Hope, al cui parere hanno aderito unanimemente gli altri componenti del Collegio, ha riassunto i tre
punti essenziali perché le leggi scozzesi siano costituzionalmente legittime: primo, la questione della competenza deve
essere determinate in ciascun caso secondo le norme dettate
dalla sezione 29 e dagli allegati 4 e 5 della legge del 1998
istitutiva del Parlamento scozzese, non essendo compito dei
Tribunali stabilire se sia preferibile che la legislazione in determinate materie sia approvata nel Parlamento di Edimburgo
o in quello di Westminster, dovendo tale materia essere regolata solo da atti del Parlamento del Regno Unito.
Secondo, le norme devono essere interpretate nello stesso
modo di ogni altro provvedimento legislativo vigente nel Regno Unito e cioè secondo il senso proprio delle parole usate.
Terzo, la qualificazione di una legge come costituzionale
non può di per sè essere utilizzata come guida per la sua interpretazione. La legge deve essere interpretata come qualsiasi altra legge, ma deve riconoscersi che le finalità della legge
ne hanno formato le espressioni. Deve infatti considerarsi la
preoccupazione del legislatore nazionale che il Parlamento
scozzese fosse abilitato a legiferare effettivamente sulle materie che sono state devolute, assicurando parimenti adeguate
salvaguardie per quelle materie che si intendeva riservare.
Tale finalità costituisce il contesto di ogni discussione circa
la competenza legislativa. Così, dice ancora la Supreme Court,
è legittimo considerare anche le finalità delle norme per comprendere l’effettivo significato delle parole della legge in esame. La circostanza che la sezione 29 della legge sulla devoluzione del 1998 fornisca un meccanismo per determinare se
una disposizione di una legge del Parlamento scozzese vada
al di là delle competenze legislative ad esso devolute non stabilisce una presunzione in favore della competenza, ma aiuta
a mostrare che uno degli scopi della legge del 1998 fu di abilitare il Parlamento a legiferare entro i poteri conferitigli
dalla sezione 28 della medesima norma.
Effettuata tale premessa, i Supremi Giudici britannici
hanno ritenuto che lo scopo dei divieti di commercializzazio-
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
ne da parte di soggetti non iscritti nel Registro o attraverso
distributori automatici e le relative sanzioni penali - secondo
le categorie penalistiche italiane equiparabili a contravvenzioni e multe - fosse quello di scoraggiare o eliminare la vendita
o la fornitura di prodotti del tabacco o materiali per il fumo.
La Corte ha ritenuto che seppure la norma in esame vieti
la vendita di sigarette attraverso distributrici automatiche e
l’esposizione di prodotti legati al tabacco ed al fumo in ambienti esterni ai locali destinati alla loro vendita, ciò non abbia
violato né la riserva di legge penale né quella di protezione dei
consumatori. Con la conseguenza che non sono stati violati
dal legislatore scozzese i limiti del proprio potere legislativo.
Diritto costituzionale canadese – Divisione dei poteri – Regolamentazione dei mercati e del commercio – Proposta di legge per
la creazione di un’unica autorità di garanzia per il mercato finanziario – Costitutional Act (Canada) 1867, sezione 91 comma 2
Nel diritto canadese una legge federale che intenda creare un’unica autorità nazionale di garanzia del mercato finanziario viola la ripartizione delle competenze tra la Federazione e le singole province e territori.
Corte Suprema del Canada, sentenza 22 dicembre 2011
nella causa 33718 avente ad oggetto il parere preliminare di
legittimità costituzionale proposto dal Governor in council4.
Il preambolo del disegno di legge sottoposto all’esame
della Corte Suprema canadese affermava che il suo scopo
fosse quello di creare una singola autorità di controllo del
mercato finanziario in Canada. Più estesamente l’art. 9 affermava che lo scopo della legge fosse quello di assicurare protezione agli investitori, di tutelare mercati dei capitali leali,
efficienti e competitivi e di contribuire all’integrità ed alla
stabilità del sistema finanziario canadese.
La legge disponeva in ordine ai requisiti per la registrazione degli operatori finanziari, agli elementi essenziali dei prospetti informative e dei moduli di sottoscrizione, alle informazioni che il cliente era tenuto a ricevere, agli specifici obblighi
dei partecipanti al mercato, alla rete per la regolamentazione
dei titoli derivati, i rimedi civilistici e disciplinari nonché disposizioni di diritto penale relative al mercato finanziario.
La proposta non imponeva unilateralmente un sistema
unificato permettendo invece che le singole province ed i
territori optassero per l’adesione ad esso, con la speranza di
creare in tal modo un efficace ed effettivo sistema di controllo e regolamentazione nazionale del mercato.
Il Governo federale canadese, con la provincia dell’Ontario e alcuni interventori ha argomentato dinanzi alla Corte
che la proposta di legge, considerate nella sua interezza, ricadesse nella competenza generale del Parlamento di regolamentazione dei mercati e del commercio secondo l’art. 91, comma
2 della Legge Costituzionale del 1867. Dalla parte opposta le
province dell’Alberta, del Quebec, Manitoba, New Brunswick
e altri interventori che hanno invece argomentato che il disegno di legge ricadesse nell’ambito della competenza provinciale in materia di proprietà e diritti civili ai sensi dell’art. 92,
comma 13 della Legge Costituzionale violando con ciò le
prerogative del legislatore provinciale di regolamentazione
4 In Canada, il Governor in council è il Governatore generale che agisce su proposta del governo federale
2 0 1 2
143
degli istituti giuridici civilistici, ai sensi del successivo comma
16 del medesimo art. 92 ed in particolare il potere di regolamentazione sui contratti, la proprietà e le professioni.
Secondo la Suprema Corte canadese, per determinare la
validità costituzionale della legislazione sotto il profilo della
divisione dei poteri5, è necessario che i giudici tengano conto
dello scopo e degli effetti della norma sottoposta al loro esame.
L’indagine deve poi volgersi a se la legislazione ricada nell’ambito dei poteri che sono stati richiamati per giustificarla6. Se la
risposta è positiva e quindi si ritenga che la norma rientri tra i
poteri conferiti al livello di governo che l’abbia adottata, essa
potrà essere considerata valida. Quando una materia riguardi
aspetti sia federali sia provinciali si giustifica la concorrente
applicazione del potere legislativo federale e provinciale.
Il potere del Parlamento di regolare i mercati ed il commercio ai sensi dell’art. 91.2 della legge costituzionale si articola
in due forme: la competenza sul commercio interprovinciale e
la competenza sui mercati in generale e sul commercio.
Nel caso di specie, la richiesta di parere di legittimità si è
limitata solo all’aspetto della competenza in materia di mercati e del commercio. Questa competenza è necessariamente
circoscritta: essa non può essere utilizzata in modo da impedire ai legislatori provinciali di regolare questioni locali e le
attività industriali all’interno dei propri confini. Né potrebbe
il potere delle Province di legiferare in materia di proprietà e
diritti civilistici entro i propri confini, privare il Parlamento
federale delle sue competenze ai sensi dell’art. 91.2 della Legge costituzionale in materie di interesse nazionale che trascendano il livello locale e riguardino il Canada come insieme.
La Corte7 si era già espressa circa i requisiti che la legislazione deve a questo proposito avere, giacché l’interesse nazionale dovrà essere qualitativamente differente dalle tematiche
provinciali. La questione è stata quindi risolta rispondendo
alle seguenti questioni: a) se la legge fosse parte di uno schema
generale di regolazione del mercato; b) se detto schema prevedesse un’autorità di controllo; c) se la legge riguardasse i
mercati in generale piuttosto che una singola industria, quale
quella finanziaria; d) se in tal caso, le province, singolarmente o di concerto tra loro, non fossero in grado di attuare
detto schema regolatorio ed e) se lo schema fosse tale che la
mancata inclusione di una o più province o territori in esso
5 Global Securities Corp. v. British Columbia (Securities Commission), 2000 SCC
21 (CanLII), 2000 SCC 21, [2000] 1 S.C.R. 494; R. v. W. McKenzie Securities
Ltd. (1966), 56 D.L.R. (2d) 56, leave to appeal refused, [1966] S.C.R. ix (sub
nom. West & Dubros v. The Queen); Gregory & Co. v. Quebec Securities
Commission, 1961 CanLII 75 (SCC), [1961] S.C.R. 584; Québec (Sa Majesté
du Chef) v. Ontario Securities Commission reflex, (1992), 10 O.R. (3d) 577,
leave to appeal refused, [1993] 2 S.C.R. x (sub nom. R. du chef du Québec v.
Ontario Securities Commission); Bennett v. British Columbia (Securities Commission) 1992 CanLII 1527 (BC CA), (1992), 94 D.L.R. (4th) 339; Bell Canada v. Quebec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 1988 CanLII
81 (SCC), [1988] 1 S.C.R. 749; Smith v. The Queen, 1960 CanLII 12 (SCC),
[1960] S.C.R. 776; Citizens Insurance Co. of Canada v. Parsons (1881), 7 App.
Cas. 96; Re Wakim; Ex parte McNally, [1999] HCA 27, 198 C.L.R. 511; R.
v. Hughes, [2000] HCA 22, 202 C.L.R. 535; Reference re Secession of Quebec,
1998 CanLII 793 (SCC), [1998] 2 S.C.R. 217; Reference re Remuneration of
Judges of the Provincial Court of Prince Edward Island, 1997 CanLII 317
(SCC), [1997] 3 S.C.R. 3; Northern Telecom Canada Ltd. v. Communication
Workers of Canada, 1983 CanLII 25 (SCC), [1983] 1 S.C.R. 733.
6 Ad esempio, in ambito comunitario, i considerando dei provvedimenti normativi.
7 General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing, 1989 CanLII 133
(SCC), [1989] 1 S.C.R. 641
internazionale
Gazzetta
144
D i r i t t o
I n t e r n a z i o n a l e
avrebbe indebolito le sue attitudini di successo in altre parti
del paese.
La Corte ha ritenuto che l’effetto della legge sarebbe stato
quello di duplicare e scomporre gli esistenti regimi regolatori
provinciali e territoriali. Con la conseguenza che, in applicazione della giurisprudenza precedente, la proposta di legge,
considerata nel suo insieme, non possa essere considerata
come ricadente nell’ambito della competenza in materia di
mercato in generale e di commercio. La Corte ha rilevato
l’errata impostazione del disegno di legge il quale, invece di
soffermarsi sul fatto che il settore del mercato finanziario si
sia tanto trasformato da ricadere nell’ambito delle competenze regolatrici federali per meglio preservare la funzione di
sostegno all’economia del paese e di mantenimento della
stabilità finanziaria del Canada, si sia preoccupato delle regolamentazioni minori degli aspetti dei contratti finanziari
all’interno delle province, includendo tutti gli aspetti dell’ordinamento delle diverse competenze professionali. Tali competenze, ha rimarcato la Corte, restano sostanzialmente di
Gazzetta
F O R E N S E
competenza dei livelli locali, concernendo i diritti di proprietà e delle obbligazioni e non il mercato come insieme. La
Corte ha rilevato poi come non fosse sufficiente la presenza
di regolamentazioni in materie di genuino interesse nazionale,
distinto dagli interessi delle singole province.
La Corte ha concluso che mentre l’importanza economica
ed il carattere pervasivo del mercato finanziario può, in ipotesi, giustificare un intervento legislativo federale che sia
qualitativamente differente da quello che possono effettuare
le province, ciò non giustifica l’integrale apprensione della
regolazione dell’industria finanziaria, conseguenza ultima
della proposta di legge federale.
La Corte ha invece affermato che un approccio cooperativo che permetta l’adozione di uno schema che riconosca la
natura essenzialemente provinciale della regolamentazione dei
titoli consentendo al Parlamento di affrontare le problematiche nazionali è conforme ai principi costituzionali canadesi
ed alle prassi adottate dai governi federali e provinciali in
altri settori di attività.
Questioni
[ A cura di Mariano Valente / Procuratore dello Stato ]
Se ed entro che limiti sia configurabile il reato di omissione o ritardo
di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale
non tenga un comportamento di totale indifferenza dinanzi alla richiesta
di un privato, ma attivi iniziative per la definizione della pratica
di cui quest’ultimo sia stato messo a conoscenza. / Anna Sofia Sellitto
147
150
Se ed in che limiti è legittima l’esclusione dall’esame di Stato del candidato sorpreso
a copiare da un telefono cellulare palmare. / Anna Laura Magliulo e Mary Musto 153
questioni
Può il dies a quo del termine di prescrizione per la proposizione dell’azione risarcitoria
dei danni derivanti da emotrasfusioni individuarsi nella data della prima diagnosi
del contagio? / Elisa Asprone
F O R E N S E
●
DIRITTO CIVILE Può il dies a quo
del termine di prescrizione
per la proposizione dell’azione
risarcitoria dei danni derivanti
da emotrasfusioni individuarsi
nella data della prima diagnosi
del contagio?
● Elisa Asprone
Dottore in Giurisprudenza
La questione prende spunto dalla
sentenza n. 3227 del 2012, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, IV sezione civile e offre l’opportunità di affrontare l’interessante tematica del risarcimento dei danni cc.dd. lungolatenti,
soffermandosi in particolar modo sul
dies a quo del termine di prescrizione
della relativa azione risarcitoria.
La sentenza in argomento individua
come termine iniziale per proporre
l’azione risarcitoria per il danno subito
da emotrasfusione di sangue infetto con
contrazione del virus HCV, quello della
prima diagnosi di contagio, valorizzando il dato secondo cui già a partire da
tale momento il danneggiato ha avuto
contezza della malattia, del tipo di malattia, delle possibili conseguenze dannose, nonché del nesso di causa che
collega l’evento alla trasfusione ovvero
tale consapevolezza avrebbe dovuto
acquisire se si fosse diligentemente attivato per chiedere ed ottenere notizie in
merito alla causa del contagio.
La rilevanza della pronuncia si ravvisa nella circostanza secondo la quale
il termine iniziale della prescrizione non
viene individuato in via presuntiva nel
momento della presentazione della domanda amministrativa relativa all’indennizzo ex L. 210 del 1992 – termine
dal quale, come segnalato dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. 2008
n. 576), “appare ragionevole ipotizzare
che la vittima abbia avuto una percezione sia del tipo di malattia che delle
possibili conseguenze dannose, tale da
concretare una situazione giuridica-
n o v e m b r e • d i c e m b r e
2 0 1 2
mente rilevante ai fini risarcitori”- bensì già anteriormente, a partire cioè
dalla prima diagnosi del contagio.
In via preliminare, appare opportuno procedere ad una disamina della
questione inerente i danni cc.dd. lungolatenti, analizzati sotto l’angolo prospettico del termine di prescrizione.
La tematica della prescrizione appare, invero, di particolare rilevanza nelle
controversie di risarcimento del danno
da emotrasfusioni ed emoderivati, cioè
quello prodotto rispettivamente dalle
trasfusioni di sangue infetto e di frazioni dello stesso (es. globuli rossi, piastrine, plasma).
Numerose cause sono state, infatti,
intentate a distanza di lunghi anni dal
fatto produttivo del danno. Un lasso di
tempo considerevole che ha in taluni
casi evidenziato la difficoltà di rientrare
nel termine prescrizionale previsto, il
quale, per le sole azioni rivolte nei confronti del Ministero della salute, va
ravvisato in quello breve ex art. 2947
c.c., data la responsabilità extracontrattuale del medesimo.
Detta difficoltà sconta un dato immanente in tutti i casi di danni cc.
dd.lungolatenti. Si tratta, invero, di
ipotesi in cui la manifestazione esterna
del danno risulta cronologicamente
sfalsata rispetto alla condotta produttiva dello stesso e quindi la malattia può
manifestarsi spesso dopo un considerevole lasso di tempo rispetto al contagio.
I fattori scatenanti del danno, cioè,
agiscono eziologicamente nel corso di
lassi temporali assai lunghi rispetto al
dies della verificazione della condotta,
cagionando gravi patologie in capo alla
vittima a distanza di lunghi anni.
La figura degli illeciti cc.dd. lungolatenti può riportarsi, dunque, a quella
delle fattispecie a formazione progressiva, in cui sussista una condicio iuris
di efficacia legata all’integrale verificazione del danno.
Si pensi non solo ai danni derivanti
da emotrasfusioni o emoderivati, ma
anche all’ipotesi di mesotelioma pleurico
o peritonale conseguente ad un’esposizione alle polveri di amianto, o ancora
all’AIDS. In quest’ultima ipotesi ben può
accedere che la situazione di chi ha contratto il virus sia addirittura asintomatica e si protragga per anni, prima che la
malattia dispieghi tutte le sue potenzialità offensive e si manifesti come AIDS
accertato a seguito di diagnosi.
147
Sovente, poi, il soggetto che ha contratto la malattia (si pensi al virus HCV
nelle trasfusioni di sangue infetto) ben
difficilmente, almeno nella fase iniziale,
ha contezza del nesso tra il contagio e il
fattore scatenante (nella specie la trasfusione), tale da proporre una tempestiva
azione risarcitoria.
Può, poi, accadere che tale soggetto,
specie se sottoposto ad una serie di
trasfusioni intervallate nel tempo, non
sia in grado di individuare quale di
queste sia stata la causa scatenante la
malattia.
Difficile allora sarà stabilire il dies
a quo della prescrizione e frequente
l’ipotesi di proposizione dell’azione risarcitoria da parte del danneggiato
dopo un consistente lasso temporale,
tale da poter far incorrere lo stesso nel
pericolo della intervenuta prescrizione.
Una maggiore tutela per il danneggiato si ravvisa allorquando l’azione
venga proposta nei confronti del medico
o della struttura sanitaria che ha compiuto il trattamento trasfusionale da cui
si assume essere derivato il danno. Il
risarcimento del danno in tali casi affonda le sue radici in una responsabilità
che viene pacificamente definita contrattuale, sia nei confronti del medico
che ha operato sia con riguardo alla
struttura ospedaliera alle dipendenze
della quale il primo operava (Cass. Sez.
Un. 11 gennaio 2008, n. 577), e che
dunque rinviene il suo termine prescrizionale in quello ordinario decennale ex
art 2946 c.c.
Maggiori problemi, invece, si sono
rinvenuti nella casistica giurisprudenziale con riguardo all’azione risarcitoria
rivolta nei confronti nel Ministero della
Salute, la responsabilità del quale rientra in quella aquiliana e il conseguente
termine prescrizionale in quello ordinario breve ex art. 2947 c.c.
Il codice civile del 1942, pur operando una netta cesura con il codice del
1865 e con la tradizione francese, in cui
sussisteva un unico termine prescrizionale per le azioni risarcitorie, sia contrattuali che extracontrattuali, individuato in trent’anni, presenta al riguardo
una formulazione piuttosto scarna.
Il dato normativo di riferimento è,
infatti, costituito dall’art. 2947 c.c.
nella parte in cui recita che il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui il “fatto si
è verificato”. Tale norma è stata più
questioni
Gazzetta
148
volte letta in combinato disposto con la
previsione di cui all’art. 2935 c.c., secondo la quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere”. Si evidenzia,
dunque, che il dies a quo della prescrizione va ancorato non al momento in
cui il diritto è stato violato, ma al momento in cui se ne può intentare la tutela in giudizio.
Le diverse interpretazioni di tali
norme hanno fatto in modo di rendere
detto termine “mobile”: la decorrenza
della prescrizione viene infatti spostata
in avanti a seconda che si faccia decorrere il dies a quo dal momento del fatto,
dal verificarsi del danno, dal momento
in cui quest’ultimo è conosciuto dal
danneggiato, o dal momento in cui
venga dallo stesso percepito come conseguenza della condotta del responsabile, o, ancora, da quello in cui il danneggiato acquisisca contezza di tutti gli
elementi costitutivi di tale danno, compresa l’ascrivibilità dello stesso al soggetto responsabile.
Ci si avvede, allora, di come l’ancorare l’epifania della prescrizione dell’azione risarcitoria a dati variabili, come
quelli innanzi descritti, in relazione
all’interpretazione che si intenda seguire,
possa sortire il riconoscere o il negare al
danneggiato il risarcimento del danno.
In particolare, nelle ipotesi di danni
lungolatenti la situazione si presta a più
insistenti difficoltà, sol che si consideri
che i momenti del manifestarsi del danno, quello della sua scoperta e di verificazione dell’illecito risultano sfalsati
nel tempo.
Allorché si intenda il “fatto” di cui
è parola nell’art. 2947 c.c. come momento in cui si verifica l’illecito o come
momento in cui il danno viene percepito
dalla vittima in tutti i suoi elementi
costitutivi come conseguente alla condotta del danneggiante, può rispettivamente inverare l’ipotesi di lasciare il
danneggiato senza tutela ovvero di procrastinare sine die l’azione risarcitoria,
in spregio ad ogni esigenza di certezza.
L’impianto sistematico del codice
del 1942, così come interpretato all’epoca della sua emanazione, si prestava ad
avvalorare i favori dei convenuti. Invero, si prescindeva da ogni considerazione che riguardasse l’aspetto oggettivo o
soggettivo di un eventuale ritardo
nell’azione risarcitoria, facendo coincidere il dies a quo con il momento della
q u e s t i o n i
verificazione dell’evento dannoso.
Tale situazione, tuttavia, registrò i
dissensi della dottrina dell’epoca, refluiti, poi, in un ribaltamento dell’interpretazione del termine iniziale della prescrizione, intorno agli anni settanta.
Non è un caso che proprio in tale
periodo emergeva in giurisprudenza un
nuovo modo di intendere il danno alla
persona, grazie all’ingresso nell’ordinamento civile della figura del danno
biologico con riflessi, nelle pretese risarcitorie, anche sulle regole relative alla
prescrizione.
Fermo restando, dunque, il tenore
letterale dell’art. 2947 c.c., rimasto immutato, la giurisprudenza, a partire dagli
anni settanta, ha finito col ribaltare la
tradizionale interpretazione dello stesso.
In alcune pronunce, infatti, (Cass.
14.4.1981, n. 2247; Cass. 15.3.1989, n.
1306; Cass. 4.1.1993,n.13; Cass.
20.11.1997, n. 11583; Cass. 10.6.1999,
n. 5701 ; in questo senso CARBONE,
La “storia infinita” del sangue infetto
, in Corriere merito, 2006, 456 ) il termine iniziale della prescrizione veniva
individuato nel verificarsi della lesione,
intesa come modificazione in peius
della sfera giuridica del danneggiato.
Altri indirizzi (Cass. 14.4.1981, n. 2247;
Cass. 15. 3.1989, n. 1306; Cass.
4.1.1993, n. 13; Cass. 20.11.1997, n.
11583; Cass. 10.6.1999, n. 5701 rv
527238) facevano riferimento all’esteriorizzarsi della lesione, ovvero al momento della percepibilità e riconoscibilità del fatto dannoso da parte del
danneggiato (Cass. 19.8.1983, n. 5412
e Cass. 21.7.1989, n. 3444 ).
Come si nota, si passa, dunque,
dalla conoscenza (o conoscibilità) alla
percezione (o percepibilità) del danno.
Non vengono ritenuti sufficienti, cioè, i
soli elementi oggettivi idonei a far desumere la possibilità della conoscenza o
conoscibilità del danno da parte del
danneggiato, ma si valorizza, altresì, la
condizione soggettiva dello stesso, facendo iniziare a decorrere il termine
prescrizionale per l’azione risarcitoria
dal momento in cui il soggetto sia in
grado di cogliere l’evento lesivo in tutti
i suoi elementi costitutivi (in tal senso
Cass. 2645 del 2003: Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno del soggetto che assuma di aver
contratto per contagio una malattia per
fatto doloso o colposo di un terzo inizia
a decorrere, a norma dell'art. 2947
Gazzetta
F O R E N S E
primo comma cod. civ., non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui
diritto o dal momento in cui la malattia
si manifesta all'esterno, ma da quello
in cui essa viene percepita - o può essere percepita - quale danno ingiusto
conseguente al comportamento doloso
o colposo di un terzo”).
Si coglie come tale indirizzo costituisca l’altro polo rispetto all’interpretazione avallata subito a seguito dell’emanazione del codice del 1942. Il danneggiato, in tal modo, viene a godere della
massima tutela, essendo il termine di
prescrizione tutto rivolto verso una
prospettiva vittimo-centrica, di valorizzazione massima, cioè, delle condizioni
soggettive del soggetto leso.
Sul punto, al fine anche di dar conto
della rilevanza della pronuncia della
Corte d’Appello di Napoli in commento, è imprescindibile esporre i principi
enunciati dalla pronuncia delle SS.UU.
della Cassazione n. 576 del 2008, secondo la quale appare limitante ancorare l’epifania del termine prescrizionale per l’azione risarcitoria al manifestarsi del danno all’esterno. Ciò sopratutto
allorché si consideri che una tale soluzione potrebbe impedire una piena
comprensione delle ragioni che giustificano l’inattività del danneggiato.
Occorre dunque procedere, per percorrere la strada segnata dalla Cassazione, ad una effettiva disamina delle
informazione cui la vittima ha avuto
accesso o per la conoscenza delle quali
si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a rappresentare al
danneggiato una situazione completa
circa i dati per intentare una valida
azione risarcitoria e della loro disponibilità in capo al convenuto, con una
conseguente ed eventuale responsabilità
dello stesso per non aver colpevolmente
fornito dette informazioni alla vittima,
nei casi in cui a ciò era tenuto.
La Suprema Corte ha cura, altresì,
di precisare che un’indagine di tale natura non corre il rischio di cadere
nell’analisi di atteggiamenti psicologici
del danneggiato, dovendo comunque
ancorarsi a due dati, l’uno oggettivo e
l’altro soggettivo. Da un lato, cioè, occorre porre in rilievo il parametro
dell’ordinaria diligenza, dall’altro quello delle conoscenze scientifiche dell’epoca, riferite però, non al singolo soggetto
leso, ma alla comune conoscenza scien-
F O R E N S E
tifica che in tale epoca era dato attendersi dai soggetti cui si è rivolta la
persona lesa.
La Cassazione, dunque, pone in
capo all’organo giudicante il dovere di
verificare, da una parte, lo stato delle
conoscenze scientifiche dell’epoca, allo
scopo di accertare se un tale tipo di
contagio fosse riconducibile alla trasfusione praticata e se tale nesso fosse noto
alla comunità scientifica e ai comuni
operatori professionali del settore, e
dall’altra il contenuto della diligenza
esigibile in capo alla vittima, cioè le
informazione che erano in suo possesso
e alle quali doveva essere messa in condizioni di accedere ovvero che doveva
attivarsi per procurarsi.
Il dies a quo della prescrizione va in
sintesi ancorato non già al giorno in cui
il terzo determina la modificazione
causativa del danno o dal momento in
cui la malattia si manifesta all’esterno,
bensì a quello in cui tale malattia viene
percepita o può essere percepita quale
danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria
diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (in tal
senso Cass. 14 luglio 2011 n. 15453).
Occorre, cioè, che il soggetto percepisca non solo la malattia, ma anche che
la stessa sia ricollegabile eziologicamente alla condotta del danneggiante. Solo
in tale momento, invero, sussistono i
presupposti per l’attivabilità dell’azione
in giudizio, divenendo il diritto leso
anche tutelabile giuridicamente.
Alla difficoltà di una indagine di
tale natura, la Suprema Corte, nella
pronuncia a Sezioni Unite innanzi richiamata, offre l’opportunità di ravvisare un indice presuntivo della certa percezione o percepibilità da parte del danneggiato della malattia, eziologicamente
riconducibile alla condotta del danneggiante, nel momento di presentazione
della domanda amministrativa volta ad
ottenere l’indennizzo ex L. 210/92.
Al riguardo, risulta opportuno precisare che la legge da ultimo richiamata,
traendo origine dall'intervento della
Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato
l’illegittimità, alla luce degli artt. 32 e 2
della nostra Carta costituzionale, della
Legge n. 51 del 1966 (che sanciva l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica), ha riconosciuto ai soggetti
danneggiati da complicanze di tipo ir-
n o v e m b r e • d i c e m b r e
2 0 1 2
reversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati, la possibilità di ottenere
un indennizzo da parte dello Stato.
Si tratta di una misura di natura
assistenziale disposta dal legislatore
per motivi di solidarietà sociale e per
testimoniare l’nteresse della comunità
alla tutela della salute: esso prescinde e
si discosta dall’eventuale risarcimento
del danno sofferto in conseguenza del
contagio, potendo anche concorrere
con il medesimo.
Orbene, a detta della pronuncia
della Cassazione a Sezioni Unite sopra
richiamata, la proposizione della domanda volta ad ottenere tale indennizzo
può costituire valido indice idoneo ad
ancorare in maniera certa il dies a quo
della prescrizione.
Secondo la Suprema Corte, infatti,
“appare ragionevole ipotizzare che dal
momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del
contagio deve comunque aver avuto
una sufficiente percezione sia della
malattia, sia del tipo di malattia che
delle possibili conseguenze dannose,
percezione la cui esattezza viene solo
confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.” (Cass.
SS.UU. 2008 n. 576).
La pronuncia della Corte d’Appello
di Napoli in commento valorizza il dato
della diligenza esigibile dalla vittima ed
individua il dies a quo della prescrizione
già al momento della prima diagnosi di
contagio e, dunque, prima della proposizione della domanda volta ad ottenere
l’indennizzo.
Detta pronuncia afferma che le conoscenze scientifiche all’epoca della diagnosi ponevano il danneggiato in grado
di ricondurre eziologicamente l’infezione
riscontrata a suo carico alle trasfusioni
di sangue praticate allo stesso, ciò in
quanto era comunemente e notoriamente diffusa la nozione che le trasfusioni di
sangue costituissero uno dei principali
veicoli di diffusione dei virus epatici e del
virus HCV, non senza tralasciare che, in
ogni caso, in base ai normali precetti di
prudenza e diligenza, il danneggiato
avrebbe potuto attivarsi ed acquisire
ogni utile informazione al riguardo, rivolgendosi alle strutture ospedaliere o al
proprio medico di fiducia.
Si pone altresì in rilievo, nella sentenza in commento, per ancorare il dies
a quo della prescrizione già al momento
149
della diagnosi, valorizzando il dato
della diligenza del danneggiato, che la
prescrizione comincia a decorrere dal
giorno in cui il danno si è verificato,
assumendo al riguardo rilievo, in base
al disposto dell’art. 2935 c.c., la mera
possibilità legale di esercizio del diritto,
e non anche gli impedimenti soggettivi,
ancorché determinati dal fatto del terzo,
e gli ostacoli di mero fatto, come quelli
che trovano la loro causa nell’ignoranza, da parte del titolare, dell’evento generatore del suo diritto e nel ritardo con
cui proceda ad accertarlo (Cass. 22
giugno 2007, n. 14576; Cass. 7 novembre 2005, n. 21500).
Orbene, occorre al riguardo evidenziare che la Suprema Corte della Cassazione, con la pronuncia a SS.UU. innanzi richiamata, prende anch’essa a riferimento il parametro della diligenza esigibile al danneggiato, ponendo al giudice il dovere di verificare, oltre lo stato
delle conoscenze scientifiche dell’epoca,
anche il comportamento diligente della
vittima e individua nella proposizione
della domanda relativa all’indennizzo
un indice ragionevole per ritenere che
tale soggetto avesse, al momento della
presentazione di tale domanda, una
sufficiente percezione sia della malattia
che della sua ricollegabilità eziologica
alla trasfusione.
Appare opportuno tuttavia porre in
luce, in riferimento a ciò, che la data di
presentazione della domanda dei benefici ex L. 210/92 è soltanto uno dei
possibili sintomi della cognizione del
contagio, ma non certo l’unico.
Il ritenere che solo alla data della
presentazione della domanda sia concretizzata la piena percezione non solo
dell’evento, ma anche della riferibilità
del contagio alle trasfusioni in quanto
solo dal momento delle presentazione
dell’istanza la parte ha verosimilmente
avuto percezione dell’esistenza del nesso
di causalità tra le trasfusioni e il contagio, è da ritenersi un assunto privo di
pregio logico, oltre che giuridico.
Può evidenziarsi, infatti, che la domanda di indennizzo viene proposta dal
danneggiato solo allorché lo stesso abbia già avuto percezione dell’esistenza
del nesso di causalità tra le trasfusioni
e il contagio ed è proprio in virtù di
tale cognizione che la vittima si determina a proporre la domanda, tenuto
conto che l’indennizzo è dovuto solo in
presenza di danni irreversibili da vacci-
questioni
Gazzetta
150
nazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati.
Appare dunque logico ipotizzare,
come fa la sentenza della Corte d’Appello in argomento, che già anteriormente
alla domanda di indennizzo la vittima
abbia una sufficiente percezione sia
della malattia, sia del tipo di malattia,
che delle possibili conseguenze dannose, che del nesso causale. Una percezione idonea, quindi, a rappresentare il
termine di riferimento cui ancorare il
dies a quo della prescrizione.
L’individuare, invece, tale termine
iniziale nel momento di inoltro della
domanda di indennizzo finirebbe per
dilatare a piacere del creditore il corso
della prescrizione. Il dies a quo, cioè,
potrebbe essere spostato in avanti dal
danneggiato, il quale, ad esempio, può
rimandare l’inoltro della domanda o
addirittura omettere di inoltrarla, asserendo di aver avuto la percezione non
solo dell’evento, ma anche della sua ricollegabilità eziologica alle trasfusioni,
della definitiva certezza in merito all’esistenza della patologia dopo l’instaurazione della lite e dopo lo svolgimento
della C.T.U.
Il “non-ancora-consapevole” danneggiato colleziona, cioè, una serie di
segnali che possono essere sintomi della
patologia. Dopodiché questi malesseri,
resisi più frequenti e più insistenti, imporranno il soggetto a recarsi da uno
specialista il quale, diagnosticatogli la
patologia, renderà lo stesso “non-piùinconsapevole” riguardo il suo male e
alla ricollegabilità eziologica dello stesso alla trasfusione.
E’ proprio il momento della diagnosi, secondo la pronuncia in esame, che,
a fronte delle conoscenze scientifiche
dell’epoca, offre al danneggiato la percezione circa la sua malattia e circa il
nesso di causalità con la condotta del
danneggiante. Tale momento, pertanto,
tenuto conto delle circostanze del caso
concreto, in relazione alle conoscenze
scientifiche dell’epoca, cristallizza il
dies a quo della prescrizione.
In conclusione deve, pertanto, evidenziarsi che il termine dal quale inizia
decorrere la prescrizione del risarcimento dei danni da emotrasfusioni è da individuarsi già al momento della prima
diagnosi di contagio. Il merito della
pronuncia in commento è, infatti, quello di porre in luce la circostanza secondo la quale già a partire da tale momen-
Gazzetta
q u e s t i o n i
to il soggetto ha avuto (o avrebbe dovuto avere se si fosse diligentemente attivato) una concreta percezione (o percepibilità) sia della malattia, che del tipo
di malattia, che delle possibili conseguenze dannose, che del nesso di causa,
idonea a rendere il diritto al risarcimento del danneggiato azionabile e tutelabile in giudizio ex art. 2935 c.c. in
combinato disposto con l’art. 2947 c.c.
F O R E N S E
●
DIRITTO penale
Se ed entro che limiti sia
configurabile il reato di
omissione o ritardo di atti
d’ufficio ex art. 328 c.p.
nell’ipotesi in cui il pubblico
ufficiale non tenga un
comportamento di totale
indifferenza dinanzi alla richiesta
di un privato, ma attivi iniziative
per la definizione della pratica di
cui quest’ultimo sia stato messo
a conoscenza.
● Anna Sofia Sellitto
Dottoressa in Giurisprudenza
La fattispecie criminosa prevista
e punita dall’articolo 328 c.p. è stata,
com’è noto, oggetto di riforma ad opera
della Legge n. 86 del 26.04.1990 nonchè
ed ancora prima, oggetto di una significativa evoluzione storico-interpretativa.
A tal proposito, infatti, si può ricordare come, nel corso del tempo, il reato
de quo sia stato dapprima qualificato
come crimine di lesa maestà, posto a tutela del rapporto di fiducia tra il sovrano e i funzionari; poi, come diniego di
giustizia finalizzato, stavolta, alla tutela
dei destinatari dell’attività pubblica ergo
i consociati.
A seguito di tale mutamento ermeneutico, si andò alla ricerca della ratio
legis e si ritenne che, nell’intento dei
compilatori dell’originario articolo 328
c.p., la norma avrebbe dovuto tutelare
il prestigio della Pubblica Amministrazione.
Il vecchio articolo 178 del Codice
Zanardelli recitava, infatti, il pubblico
ufficiale, che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione
o insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del proprio ufficio è
punito con la multa da lire cinquanta a
millecinquecento.
Tale ricostruzione può ben spiegarsi se si pensa ad uno Stato autoritario,
come quello fascista, cui si confaceva
ove ciò che importava era che i funzionari fossero ligi ed obbedienti ai propri
doveri e ai propri superiori dunque che
si comportassero secondo criteri di zelo.
F O R E N S E
Abbracciando tale prospettiva formalistica, ne derivava che l’oggetto della
tutela era circoscritto al “regolare funzionamento” della Pubblica Amministrazione, che doveva essere salvaguardato dalle dolose inerzie o trascuratezze
dei propri funzionari dunque ciò che
contava era soprattutto la “fedeltà” del
funzionario verso l’Amministrazione.
Ciò posto, se ne desume che il reato
in questione si presentava come reato di
pericolo e non di danno, essendo sufficiente la violazione di un qualsiasi dovere funzionale, a prescindere dall’esito
di tale inadempimento dunque anche in
mancanza di danno. Ne consegue ancora che, rebus sic stantibus, si creava
una pericolosa commistione tra illecito
amministrativo disciplinare e illecito
penale; in tal modo, si privilegiava una
visione statica della Pubblica Amministrazione in quanto la sanzione si basava
sulle patologie del rapporto interno tra
funzionario e amministrazione piuttosto
che del rapporto esterno tra amministrazione e cittadini ossia i veri destinatari
dell’azione amministrativa.
Nella formulazione successiva al
codice Zanardelli ma antecedente alla
riforma della L. 26.04.1990 n. 86, l’art.
328 - nella sua previsione onnicomprensiva - disponeva che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio o del servizio
è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a due milioni
di lire.”
La nozione di “atto dell’ufficio o del
servizio” finiva così per comprendere
ogni dovere funzionale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, senza distinzione alcuna tra attività
interna, esterna o esternamente rilevante: la conseguenza, tutt’altro che trascurabile, era che neanche l’atto diverso ma
ugualmente idoneo al raggiungimento
dello scopo sarebbe stato valido.
Col passare del tempo, si è colto
sempre più il limite cui tale concezione
conduceva e, per tal via, si è giunti ad
abbracciare un orientamento sostanzialistico in linea con una lettura costituzionalmente orientata nonchè con
l’intero ordinamento giuridico. E’ stato
complessivamente riformulato l’interesse giuridico tutelato che è sì il buon
funzionamento della Pubblica Amministrazione ma non nel suo senso statico
e formale di prestigio della stessa e di
mera fedeltà del funzionario bensì quale tempestività, efficienza ed efficacia ex
artt. 1 e 2 della Legge 241/1990.
Ciò che rileva, dunque, non è l’attività interna e statica della P.A. bensì
l’attività esterna e dinamica della stessa
n o v e m b r e • d i c e m b r e
2 0 1 2
dunque il momento funzionale. Interesse
giuridico tutelato non è il prestigio della Pubblica Amministrazione e non può
essere questo dal momento che tante ed
altre sono le norme preposte alla tutela
di tale fine (art. 97 Cost.); la norma in
oggetto è, invece, finalizzata a tutelare
il civis, il cittadino ed il danno che effettivamente sia derivato dalla condotta,
commissiva od omissiva, posta in essere
dal Pubblico ufficiale.
Non si tratta, dunque, di un reato di
pericolo bensì di un reato di evento e di
danno.
Ciò che è rilevante è “ l’atto d’ufficio o del servizio” ossia la mancanza
dello stesso ma non in re ipsa considerata bensì nel momento succedaneo
dell’esplicazione degli effetti nel mondo
esterno dunque ciò che conta è il risultato, l’esito lesivo della suddetta condotta.
L’art. 328 c.p. non può più essere considerata quale “norma penale in bianco”
i cui precetti siano posti aliunde (es. in
norme amministrative) ma acquista autonomia normativa a prescindere dalle
regole amministrative.
Sono questi i presupposti su cui si
fonda la riforma avutasi con la Legge n.
86 del 26.04.1990.
Alla luce di tale nuova lettura, la
questione può essere inquadrata nei seguenti termini: qual è il discrimen tra
irregolarità della condotta sul piano
amministrativo e reato con particolare
riguardo all’ipotesi in cui il pubblico
ufficiale non abbia tenuto un comportamento di totale indifferenza dinanzi alla
richiesta ma abbia attivato iniziative per
la definizione della pratica di cui il privato sia stato messo a conoscenza?
La questione prospettata trae spunto
da una recentissima ed interessante sentenza del 2.10.2012 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione
II Penale, in composizione collegiale.
Prima di analizzare il contenuto della
motivazione, sono opportune alcune ulteriori precisazioni sul reato in questione, così come riformulato dalla citata
L. 86/1990 e che la suddetta pronunzia
pone in evidenza.
L’art. 328, II comma, c.p. sanziona
il pubblico ufficiale, o incaricato di un
pubblico servizio, che, “fuori dei casi
previsti dal I co., [...] entro trenta giorni
dalla richiesta di chi vi abbia interesse
non compie l’atto del suo ufficio e non
risponde per esporre le ragioni del ritardo”; la richiesta deve essere redatta in
forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della stessa.
Dal confronto con la fattispecie delineata nel primo comma della norma potrebbe sembrare che di un vero e proprio
rifiuto possa parlarsi solo in quest’ulti-
151
ma, mentre con riferimento alla condotta descritta nel secondo comma sarebbe più consono parlare di omissione o
ritardo nel compimento dell’atto. Del
resto, la rubrica dell’articolo indica distintamente rifiuto ed omissione e questa distinzione sembra ritrovarsi anche
nel testo della disposizione, posto che
solo il primo comma parla espressamente di “rifiuto”, mentre il II comma parla
di “non compimento” dell’atto, o di suo
“ritardo”.
È al riguardo opportuno riportare
testualmente un intero passo della menzionata decisione del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ove si sottolinea
che “in realtà, a ben vedere anche nel
secondo caso il fatto incriminato ruota
intorno ad un rifiuto. Infatti, rifiutarsi
di fare una cosa significa semplicemente
non fare ciò che si è richiesti di fare, essendo consapevoli della richiesta ricevuta. Ebbene, la fattispecie di cui al II co.
presenta tutti questi elementi. La condotta illecita, sia nel I che nel II comma
dell’art. 328, presenta quindi la medesima struttura e consiste nel fatto di rifiutare il compimento di un atto d’ufficio.
Rifiuto si ha ogni qualvolta l’agente volontariamente non compie un atto che
gli è stato richiesto di compiere, quando
abbia consapevolezza di tale richiesta.
Da questo punto di vista, la differenza
tra le due fattispecie di cui all’art. 328
c.p. è puramente formale e consiste semplicemente in ciò: quell’unico e medesimo concetto (rifiuto di un atto) nel 1°
co. è espresso in forma sintetica (“rifiuta”), mentre nel 2° co. è espresso in forma analitica (“non compie l’atto” dopo
la richiesta). Le differenze sostanziali tra
le due ipotesi incriminatrici emergono,
semmai, una volta che la condotta di rifiuto venga calata in ciascuna delle due
fattispecie e riguardano essenzialmente
le ragioni dell’atto dovuto, il momento
a partire dal quale l’atto non potrebbe
più dirsi tempestivamente compiuto,
la forma della richiesta, la rilevanza di
un’eventuale risposta del pubblico agente. Si tratta, in sostanza, di differenze
che discendono dalla circostanza che la
fattispecie di cui al 2° co. è costruita in
termini, per così dire, più formalizzati rispetto all’altra. Quest’ultima ruota
intorno all’omissione di atti la cui doverosità discende dall’effettivo ricorrere
di una situazione di pericolosità a carico
di interessi di un certo tipo (da qui una
certa indeterminatezza in relazione, ad
es., al termine finale o ai contenuti delle ragioni che giustificano l’urgenza e la
doverosità dell’atto). La prima ruota,
invece, sul funzionamento di meccanismi più rigidamente prestabiliti: necessità di una richiesta scritta; necessità di
questioni
Gazzetta
152
una legittimazione ad avanzarla; termine rigidamente fissato in trenta giorni
dalla ricezione della richiesta; possibilità
di esporre le ragioni del ritardo. Mentre,
insomma, la fattispecie di cui al 1° co.
è animata dall’urgenza di fronteggiare
una situazione di pericolo a carico di
certi interessi - ed a questo finisce inevitabilmente per informarsi la ricostruzione dei suoi elementi tipici - la fattispecie
di cui al 2° co. è invece costruita in termini spiccatamente procedimentali: essa
ruota dunque sulla successione di una
serie di passaggi prestabiliti.
La condotta illecita è descritta in
entrambi i casi in forma omissiva e consiste nel mancato compimento dell’atto
dovuto. Entrambi i reati, insomma, appartengono alla categoria dei reati omissivi propri: costituiscono, cioè, figure di
reato che incriminano la mancata produzione di un risultato (nel nostro caso,
di un atto d’ufficio). Tuttavia, a rilevare
non è una qualsiasi omissione, ma solo
quella che si configuri come rifiuto, sul
presupposto di una richiesta rivolta
all’agente, della quale egli sia consapevole. Il rifiuto è manifestazione di volontà negativa tradottasi nella mancata
adozione dell’atto. La nozione richiama
un atteggiamento di diniego, una volontà proterva a fronte di una qualche
sollecitazione esterna. Ciò non implica
che la volontà debba manifestarsi necessariamente in forma esplicita. Anche
l’inerzia silente protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o
addirittura di decadenza può assumere
valenza di rifiuto in presenza dei presupposti determinanti la doverosità dell’atto da compiersi (cfr. Cass. pen. 19 novembre 2003 n. 2510; 9 dicembre 2002
n. 7766; 20 febbraio 1998, n. 5482; 21
gennaio 1998, n. 2339). Può sostenersi
quindi che anche nella fattispecie in esame l’offensività del delitto è incentrata
su un particolare atteggiamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio nei confronti dei suoi doveri
professionali. Non sono punite le semplici omissioni (condotte di mera inerzia
o di semplice non facere), ma soltanto le
condotte consistenti in un rifiuto ossia le
manifestazioni di volontà negativa, per
quanto implicita, nei confronti di una
richiesta o di un ordine. L’illegittimità
sul piano amministrativo del comportamento del pubblico ufficiale non si
traduce mai in via generale in un’automatica responsabilità penale. Piuttosto,
quest’ultima è collegata a presupposti
distinti dalla liceità o meno della condotta che l’ordinamento giuridico predispone nell’ambito della funzionalità
amministrativa, in quanto non può prescindere dall’accertamento che, nel caso
concreto, si sia deliberatamente voluto
q u e s t i o n i
omettere uno specifico atto (cfr. Cass.
pen. 19 gennaio 1987, in Cass. pen.
1988, p. 291). L’indagine sulla configurabilità di un atteggiamento di questo
tipo in capo al pubblico ufficiale deve
essere particolarmente rigorosa, al fine
di evitare un’applicazione formalistica
della fattispecie, incapace di cogliere il
tratto distintivo tra il reato e l’irregolarità delle condotte sul piano amministrativo. Questa esigenza si pone in modo
particolare là dove il pubblico ufficiale
non abbia tenuto un comportamento di
totale indifferenza dinanzi alla richiesta,
ma abbia attivato iniziative per la definizione della pratica di cui il privato sia
stato messo a conoscenza (cfr. Cass. pen.
5 giugno 2007, n. 31669). Occorre inoltre che il pubblico ufficiale cui è diretta
la richiesta scritta avesse piena consapevolezza della propria competenza a
compiere l’atto e, quindi, del dovere di
compierlo e della propria responsabilità
per il ritardo.”
Muovendo da tali premesse e considerando il caso di specie, oggetto della
suddetta sentenza, deve dubitarsi della
riconducibilità del comportamento tenuto dal pubblico ufficiale all’ambito di applicazione della fattispecie in questione.
Dall’analisi della menzionata pronunziata, infatti, può evincersi e ricavarsi il seguente principio giuridico.
Allorquando la pratica instaurata
del privato sia caratterizzata da una certa complessità tale da rendere necessari
approfondimenti e consulenze tecniche
da parte di altri esperti ed il pubblico
ufficiale si renda operativo nel senso
di avviare tali ricerche e collaborazioni
(nel caso di specie, difatti, l’imputato
aveva palesato l’intenzione di avvalersi dell’ausilio e della competenza di un
avvocato amministrativista) nonchè di
intraprendere un dialogo con le parti interessate, la condotta non può considerarsi omissiva nè il soggetto agente può
ritenersi inerte.
A fortiori, nel caso di specie, non
solo l’istanza presentata era di non
agevole risoluzione ma gli stessi privati
interessati ne erano ben a conoscenza
in quanto resi adotti dallo stesso pubblico ufficiale oltre che ben consapevoli,
già da soli, della difficoltà della pratica
tant’è che essi stessi avevano intrapreso
due strade diverse (dapprima richiesta di
permesso di costruire e successivamente
semplice richiesta di autorizzazione per
lo spostamento della pizzeria), confondendo così ulteriormente la questione
e rendendola maggiormente intricata e
complessa.
La fattispecie criminosa prevista e
punita dall’art. 328 c.p., dunque, non
può dirsi integrata laddove ancor prima della presentazione della richiesta, le
Gazzetta
F O R E N S E
parti private possano dirsi consapevoli
del possibile ritardo nella definizione
della vicenda per la complessità di essa,
palesata e comunicata dagli organi competenti nonchè determinata, peraltro,
anche dal loro comportamento. Altresì,
quando vi sia un’interlocuzione formale con le parti stesse tramite ad esempio
pareri tecnici e giuridici anche dopo la
richiesta ex art. 328, co. 2, c.p., non può
dirsi che vi sia inerzia silente assimilabile al rifiuto di provvedere bensì prosecuzione di un dialogo che trova la sua
ragion d’essere nella complessità della
vicenda.
Dall’analisi del caso di specie, oggetto della recentissima sentenza emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Sez. II Penale, si può altresì evincere che
non sempre è agevole tracciare il confine
ed individuare il discrimen tra irregolarità della condotta del funzionario sul
piano amministrativo ed illecito penale
ossia il reato. Tale distinguo, talvolta, è
labile e può comportare non poche difficoltà sul piano applicativo. Alla luce
degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, si può affermare che
il parametro di riferimento deve essere
non la “mancanza dell’atto d’ufficio o
del servizio” in sè e per sè considerata
bensì gli effetti che da questa scaturiscono ossia il risultato, l’esito lesivo della
condotta posta in essere dal pubblico
ufficiale o dall’incaricato di pubblico
servizio. Ciò a dimostrazione della mutata chiave di lettura della fattispecie
criminosa prevista e punita dall’art. 328
c.p.: dunque, non una tutela formale e
statica dell’attività amministrativa bensì una tutela dinamica e funzionale che
guardi ai rapporti esterni della Pubblica
Amministrazione e, ancor più, che tenga
conto del destinatario dell’operato della
stessa ossia il cives, il cittadino. Ai fini
della configurabilità della responsabilità
penale del funzionario, pertanto, non
sarà sufficiente la semplice “mancanza
dell’atto” dunque non basterà la violazione formale di un dovere funzionale
ma dovrà svolgersi un accertamento molto più pregnante e sostanziale nel senso
di tener conto, in primis, dell’eventuale
risultato lesivo e dannoso per i consociati ed in secondo luogo si dovrà analizzare la condotta del funzionario e le
ragioni del suo operato. In particolare,
in un caso come il presente ove il pubblico ufficiale non sia stato inerte cioè
non abbia tenuto un comportamento di
totale indifferenza dinanzi alla richiesta
ma abbia, anzi, attivato iniziative per la
definizione della pratica di cui il privato
sia stato messo a conoscenza, non potrà che concludersi con l’affermazione
dell’assenza di responsabilità sul piano
penale dello stesso.
F O R E N S E
●
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Se ed in che limiti è legittima
l’esclusione dall’esame di Stato
del candidato sorpreso a copiare
da un telefono cellulare palmare.
Anna Laura Magliulo e Mary Musto
Dottoresse in Giurisprudenza
La questione nasce dall’analisi della
sentenza n. 3726 del 06.08.2012, con
cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli ha respinto il ricorso proposto da un’alunna di
una scuola di istruzione secondaria avverso la propria esclusione dalla prosecuzione delle prove dell’esame di Stato.
Tale provvedimento veniva disposto
in quanto la candidata, durante lo svolgimento di una delle prove scritte, veniva
sorpresa a copiare da un telefono cellulare palmare. A fronte di tale condotta
l’Istituto Scolastico provvedeva, ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del O.M. n. 41 del
2012, all’esclusione della medesima.
Il TAR ha ritenuto che tale articolo
facesse riferimento ad un’attività di natura vincolata della Pubblica Amministrazione e ha considerato fondata l’applicazione dello stesso al caso di specie.
Inoltre, ha evidenziato la possibilità di
estendere agli esami di Stato la disciplina
prevista in materia di concorsi pubblici.
A seguito della proposizione del ric or s o d i pr i mo g rado, i n d at a
29.06.2012, è intervenuta l’ordinanza
cautelare presidenziale di ammissione
dell’alunna a prove scritte suppletive, in
esito alle quali la medesima affrontava
anche le prove orali, conseguendo una
votazione finale superiore alla sufficienza (punti 75/100).
Avverso la sentenza del TAR è stato
presentato dalla candidata appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con
sentenza n. 4834 del 2012, ribaltando
la statuizione della sentenza di primo
grado, ha dichiarato illegittima l’esclusione della studentessa.
Il Supremo Consesso fonda il proprio convincimento sulla base del fatto
n o v e m b r e • d i c e m b r e
2 0 1 2
che l’esclusione era stata disposta senza
tener conto dell’intero curriculum scolastico della candidata e che l’episodio
andava ricondotto ad uno stato d’ansia,
probabilmente legato anche a problemi
di salute.
A tal proposito, il Consiglio di
Stato ha precisato che la condotta sanzionabile deve essere oggetto di una più
approfondita valutazione in rapporto
alle circostanze di fatto in concreto rilevabili e all’intero curriculum scolastico della candidata, come confermato
dal dettato normativo di cui all’art. 13,
comma 1, del D.P.R. n. 323 del 1998.
In particolare, tale norma prevede
che il superamento dell’esame di Stato
costituisce attestazione delle “competenze, conoscenze e capacità anche
professionali acquisite”. Pertanto, essendo l’esame di Stato volto ad accertare
le basi culturali, le capacità critiche, il
personale interesse nonché il costruttivo
impegno del candidato nell’ultimo anno
del corso di studi, ne deriva che la valutazione non può fondarsi solo sulle
prove sostenute nei giorni dell’esame, né
tanto meno la violazione di un obbligo
comportamentale idoneo ad inficiare
una singola prova potrà di per sé comportare un provvedimento che determini il mancato superamento dello stesso.
Beninteso, ciò vale per gli esami di
stato e non anche per i concorsi pubblici. Infatti, per quest’ultimi è espressamente previsto all’art. 13, comma 4, del
D.P.R. n. 487 del 9.05.1994, la vincolante esclusione dal concorso per quei
candidati che abbiano copiato in tutto
o in parte i loro elaborati.
La questione de quo, concernente
l’espulsione a seguito di utilizzo di un
palmare durante gli esami di Stato, risulta essere di estrema attualità. Va rilevato, infatti, che il continuo sviluppo
tecnologico, proprio dei nostri giorni,
ha determinato l’ingresso nel mercato
di strumenti innovativi che consentono
di fornire un enorme quantitativo di
informazioni in tempi piuttosto celeri.
In particolare, con l’avvento degli
smartphone e dei palmari, che permettono di scaricare intere pagine da Internet, nonché di ricavare elementi utili per
la stesura di elaborati, la vita degli studenti è sensibilmente mutata. L’estrema
rapidità con cui simili mezzi tecnologici
consentono di acquisire dati e nozioni,
tuttavia, reca con sé il rischio di incorrere in un illecito ogniqualvolta l’utiliz-
153
zo degli stessi avvenga durante l’espletamento di prove d’esame.
La VI sezione del Consiglio di Stato
ha anche in un’altra occasione affrontato la spinosa questione in oggetto manifestando l’assenza di univocità di vedute in merito. Infatti, a distanza di
pochi mesi, è stata emanata la sentenza,
n. 391 del 27.01.2012 che ha sancito la
legittima esclusione di un candidato il
cui telefono cellulare, non consegnato
preventivamente alla commissione, aveva squillato durante la prova d’esame.
La differente impostazione giurisprudenziale, emergente dalle pronunce
summenzionate, deriva, in parte,
dall’assenza di una normativa ad hoc in
materia.
Va rilevato, infatti, che per gli esami
di Stato, conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, manca
una fonte giuridica di rango primario
che disciplini gli adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle
prove: né la L. 425/1997 né il Regolamento attuativo contenuto nel D.P.R. n.
323/1998 prevedono alcunché sulla
possibilità o meno di introdurre cellulari o altri dispositivi tecnologici in
grado di consentire al candidato di
mettersi in contatto con l’esterno o comunque di copiare la prova d’esame.
In realtà, una norma che assurge a
fonte di rango primario potrebbe essere
individuata nell’art. 13 del D.P.R.
487/1994, cui fa espresso riferimento il
Consiglio di Stato nella sentenza n. 4834.
Tale articolo si applica ai concorsi per
l’assunzione nei pubblici impieghi, per i
quali il carattere vincolante dell’esclusione dal concorso dei candidati che abbiano copiato, in tutto o in parte, i loro
elaborati, è anche necessario presidio
della par condicio dei concorrenti.
In particolare, il D.P.R. del 1994
non fa menzione dei telefoni cellulari
(diffusisi in Italia solo nella metà degli
anni’90), ma vieta, a pena di esclusione,
taluni comportamenti – come quello di
comunicare e mettersi in relazione con
altri, portare appunti o pubblicazioni di
qualunque specie – che potrebbero inficiare sull’autenticità dell’elaborato, e
quindi sull’idoneità dello stesso ad
esprimere il livello di preparazione del
candidato. Il D.P.R. appena menzionato, tuttavia, è stato emanato per disciplinare la specifica materia attinente lo
svolgimento dei concorsi relativi all’accesso al pubblico impiego. Pertanto
questioni
Gazzetta
154
l’applicazione di detta normativa alla
fattispecie in oggetto, come risulta dalle sentenze suindicate, può ammettersi
solo in via analogica.
Maggiori dissapori si sono configurati, in seno alla VI sezione del Consiglio di Stato, in relazione alla natura
vincolata o discrezionale del provvedimento che sanziona la contravvenzione
al divieto ex art. 13 D.P.R. 487/1994.
In particolare, con la sentenza n.
391 del 27.01.2012, il Collegio, adottando un’interpretazione ad litteram del
citato art. 12, comma 5, dell’O.M. n.
41 del 2012, ha ritenuto vincolante il
provvedimento volto a sanzionare la
condotta di chi è sorpreso, nel corso di
una prova, ad utilizzare gli strumenti
censurati dal legislatore.
Al contrario, la sentenza n. 4834 del
12.09.2012, oggetto della presente indagine, pur ammettendo la sanzione
espulsiva per chi incorre in condotte
fraudolente (alla stessa stregua di quanto previsto dal citato art. 13 D.P.R.
487/1994), escludendo in capo alla P.A.
un vero e proprio margine di discrezionalità in merito, specifica che il provvedimento ex art. 12, comma 5, della
suindicata ordinanza ministeriale, debba essere necessariamente motivato.
Con tale pronuncia il Consiglio di
Stato si discosta dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso
dalla sentenza n. 391 del 27.01.2012, in
base al quale a fronte di un’attività
vincolata non sussiste un obbligo di
accurata motivazione.
L’impostazione ermeneutica emergente dalla sentenza da ultimo richiamata mostra la difficoltà di comprendere quale sia l’effettiva natura, discrezionale o vincolata, del provvedimento con
cui la P.A. possa procedere all’esclusione del candidato. In particolare, si osserva che, almeno prima facie, appare
inconciliabile la necessità di un’accurata motivazione di un provvedimento
vincolato.
Va rilevato, infatti, che l’azione amministrativa si distingue a seconda che
l’attività posta in essere abbia carattere
discrezionale o vincolato. Nel primo
caso, alla P.A. è rimessa la possibilità di
valutare l’opportunità di emanare o
meno un determinato provvedimento al
fine di soddisfare l’interesse pubblico
che essa è tenuta a tutelare. Tale facoltà
di scelta è del tutto esclusa quando si
tratta di attività vincolata: in questo
q u e s t i o n i
caso la P.A. deve limitarsi ad accertare
la sussistenza dei requisiti o dei fatti che
legittimano o impongono l’azione amministrativa. In altri termini, essa sarà
chiamata a svolgere una verifica tra
quanto previsto a monte dalla legge,
come presupposto dell’azione, e quanto
effettivamente presente nella realtà
fattuale.
La distinzione tra natura vincolata
o discrezionale del provvedimento, almeno teoricamente, è tale da incidere
sull’ampiezza dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3, l. n. 241 del 1990.
In particolare, la P.A, nel caso in cui.
emani un provvedimento discrezionale,
sarà tenuta a formulare un’ampia e dettagliata motivazione delle ragioni sottese alla sua determinazione; al contrario,
in presenza di un atto vincolato ciò potrebbe apparire superfluo, risultando,
invece, sufficiente la semplice enunciazione dei presupposti dell’azione posta
in essere. Infatti, se l’organo amministrativo che agisce non ha facoltà di
scelta tra più soluzioni possibili e non
deve comparare e bilanciare interessi
pubblici con interessi privati, la motivazione del suo operato ben potrebbe limitarsi a dar conto di come è stata accertata una data situazione al fine di evidenziare la correttezza del suo operato.
In realtà, l’entità dell’obbligo motivazionale non varia a seconda dell’attività esercitata dall’amministrazione. Va
rilevato, infatti, che la motivazione
rappresenta il percorso logico-giuridico
seguito dalla P.A. nell’emanazione del
provvedimento finale e si può ritenere
che essa costituisca un elemento essenziale del medesimo.
La motivazione, a seguito dell’evoluzione del procedimento amministrativo, sempre più teso a potenziare la
tutela del privato, assume un connotato
irrinunciabile. Tale strumento, infatti,
mira a realizzare l’avvicinamento tra
l’amministrazione e gli amministrati. In
particolare, esso è posto a difesa del
ricorrente, in quanto consente al medesimo di conoscere i motivi che hanno
indotto la PA ad assumere la decisione
e di valutare l’opportunità di impugnare o meno la stessa.
Pertanto, il vizio di motivazione, a
prescindere dal tipo di attività posta in
essere, ha natura sostanziale. Esso si
atteggia come un’alterazione del procedimento in cui si incasella e gode di una
dignità più incisiva rispetto a quella dei
Gazzetta
F O R E N S E
vizi formali e procedurali cui fa riferimento l’art. 21 octies, comma 2, primo
alinea. Da qui deriva che la mancanza
di tale elemento, anche nel caso in cui
l’atto emanato abbia natura vincolata,
ossia quando “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, sarà tale da generare la nullità del
provvedimento ai sensi dell’art. 21 septies.
Sulla base delle argomentazioni ermeneutiche fin qui formulate, emerge
che il collegamento “obbligo motivazionale – atto vincolato”, operato dal Supremo Consesso nella sentenza n.
4834/2012, non risulta privo di fondamento come potrebbe desumersi prima
facie, ma il frutto di un’attenta disamina delle norme sul procedimento amministrativo e dell’evoluzione che lo ha
riguardato. Sposando tale tesi il Consig lio d i St ato appa re d iscost a rsi
dall’orientamento giurisprudenziale
prevalente, in ordine al quale l’atto
vincolato non necessita di una motivazione, poiché ritiene opportuno assicurare una maggiore tutela ai privati. Ciò
risulta del tutto in linea con la generalizzazione, realizzata dal legislatore del
1990, dell’obbligo di motivare “ogni
provvedimento amministrativo”.
Recensioni
Il Diritto delle imprese in crisi e tutela cutelare, A cura di Francesco Fimmanò,
Collana Università Telematica Pegaso-Ricerche Di Law & Economics, 2012, Milano
157
recensioni
a cura di Amalia De Carlo
F O R E N S E
●
Il Diritto delle imprese
in crisi e tutela cutelare,
a cura di Francesco
Fimmanò,
Collana Università
Telematica Pegaso-Ricerche
Di Law & Economics,
2012, Milano
● A cura di Amalia De Carlo
Avvocato
Il “diritto delle imprese in crisi”, nasce
con lo scopo preciso di rendere efficiente
l’impresa ex post, ossia dopo l’emersione
della crisi, sia mediante la riduzione dei
tempi e dei costi occorrenti per lo svolgimento della procedura, sia mediante la
riallocazione dei beni facenti parte del
complesso aziendale nel miglior modo
possibile. Nel momento in cui l’impresa
entra in crisi i vari creditori sociali, attraverso le procedure concorsuali, entrano
in “concorso” tra loro, o meglio concorrono tutti alla soddisfazione del proprio
credito e/o della propria pretesa, secondo
le regole dettate dalle diverse procedure
concorsuali, che servono a coordinare le
diverse pretese creditorie ed a stabilire i
principi per una ordinata distribuzione
proporzionale alle singole pretese, salvaguardando il complesso aziendale, e permettendo, in taluni casi, il proseguimento
dell’attività d’impresa. Le procedure concorsuali rappresentano lo strumento attraverso il quale è possibile disporre delle
imprese inefficienti e favorire la riallocazione del patrimonio degli imprenditori
insolventi. E’ in questa finalità che può
essere riconosciuta alla procedura concorsuale una funzione cautelare rispetto
all’allocazione efficiente dell’impresa in
crisi nel mercato, nell’interesse dell’economia. Questo è quanto sostiene il prof.
Francesco Fimmanò, che, attraverso la
raccolta sistematica e coordinata dei contributi di professionisti specializzati in
diversi settori, quali professori universitari, magistrati, avvocati, notai, affronta ed
n o v e m b r e • d i c e m b r e
2 0 1 2
analizza la tematica dell’impresa in crisi,
estremamente attuale, sia analizzandola
dai diversi punti di vista degli autori, sia
tenendo conto della tutela cautelare del
patrimonio dell’impresa, che risulta fondamentale al fine di non creare una disgregazione del patrimonio ed un azzeramento del complesso aziendale.
Come sottolineato nel volume stesso,
intitolato “Diritto delle imprese in crisi e
tutela cautelare”, molto spesso nella pratica le differenti sensibilità ed esperienze
determinano forti discrasie nel metodo e
nell’approccio all’impresa insolvente. Ciò
nasce da una prospettiva diversa, sia essa
penale, civile, fallimentare, contabile o
amministrativa, dove talora si confonde
l’interesse dell’imprenditore con quello
dell’azienda, l’interesse pubblico alla legalità con quello del mercato. Tuttavia se si
riconduce tutto all’interesse oggettivo e
superiore dell’impresa, riconosciuto anche dalla nostra Costituzione, tutto appare più chiaro ed armonioso nel disegno
del legislatore. Il valore da tutelare sempre
e comunque è quello dell’impresa come
espressione dinamica dell’attività economica, che nella fase della crisi vive uno dei
suoi tipici momenti ciclici. Il confronto tra
esperienze interdisciplinari, scientifiche
ed operative, ha il compito di ricostruire
il quadro sistematico d’insieme, il sistema
delle fonti, i rapporti tra materie concorrenti, in modo da trasformare le diversità
da momento di scontro in opportunità di
confronto e sinergia.
Il volume si propone di affrontare,
nell’ambito della procedura concorsuale,
il momento e la funzione della tutela
cautelare da diversi punti di vista e prospettive, che si incontrano e convergono
nell’interesse comune della tutela dell’impresa e quindi dell’economia. Si pensi ai
diversi tipi di tutela cautelare che può
consistere in provvedimenti del Tribunale
o di altra autorità amministrativa, in
misure cautelari “penali” e “contabili”,
che spesso tra loro si scontrano dando
vita ad enormi lungaggini processuali,
che finiscono per danneggiare l’impresa
stessa. Il contributo dei diversi autori, è
volto, quindi ad offrire all’interprete una
ricostruzione sistematica della disciplina
relativa al diritto delle imprese in crisi,
proponendo soluzioni e spunti per un’armonizzazione delle materie concorrenti e
delle diverse tutele cautelari, che seppur
provenienti da organi diversi, hanno in
comune il fine ultimo che è rappresentato
dall’interesse e benessere delle imprese.
157
L’opera, partendo da un’accura e sistematica analisi dell’impresa in crisi,
quale oggetto proprio della tutela cautelare, passa ad esaminare la funzione
della tutela cautelare nell’ambito delle
diverse procedure concorsuali. Rilevano,
a tal proposito, i capitoli dedicati alla
tutela cautelare del patrimonio e dell’impresa di cui all’articolo 15 legge fallimentare alla luce della recente Legge n. 134
del 7 agosto 2012, in tema di gestione
delle imprese in crisi, alla tutela cautelare
e all’amministrazione dell’impresa nel
processo fallimentare, e alla effettività
della tutela cautelare nel processo fallimentare stesso. Di notevole interesse e
pregio sono poi i contributi dedicati alla
tutela cautelare nell’ambito del concordato preventivo, intesa come protezione
anticipata alla luce del decreto sviluppo,
e come tutela anche conservativa dei diritti. Si passa poi all’attenta analisi delle
misure cautelari contabili, e del rapporto
di queste con le procedure concorsuali. I
rimedi cautelari contabili, sono assimilabili, quanto al fine cui tendono, alle misure cautelari previste dal codice di procedura civile, ma se ne discostano quanto agli aspetti procedimentali. Si passa
poi alla trattazione delle misure cautelari penali, che possono consistere in sequestri preventivi, sequestri per equivalente,
confische, misure di prevenzione cosiddette antimafia, che vanno ad incidere
sull’impresa ed a scontrarsi con le procedure concorsuali, generando, talvolta,
esse stesse il crollo dell’impresa. La trattazione prosegue con l’analisi della tutela
cautelare nello specifico ambito societario, attraverso la trattazione, ad esempio,
del pegno, sequestro e usufrutto delle
quote delle s.r.l., della confisca obbligatoria in ambito societario e delle azioni
di responsabilità nelle s.r.l. dichiarate
insolventi. Di notevole rilevanza e attualità sono infine i contributi dedicati alle
misure prevenzionali antimafia, al fallimento delle imprese confiscate alle mafie,
ed alle imprese pubbliche e private, con
l’inevitabile coinvolgimento della responsabilità dello Stato.
Nonostante la diversità e la molteplicità dei punti di vista espressi dagli autori sullo stesso argomento, il volume, attraverso la raccolta dei contributi dei diversi interpreti, ha sicuramente il pregio
di aver creato una base per un dialogo
costruttivo ed ha offerto uno spunto per
la soluzione dei problemi mediante il
confronto.
recensioni
Gazzetta
Indice delle sentenze
Diritto e procedura civile
CORTE DI CASSAZIONE
Cass. civ., sez. un., 28.11.2012 n. 21110 s.m.
Cass. civ., sez. III, 27.11.2012, n. 20984 (con nota di Sorrentino)
Cass. civ., sez. un.,13.11.2012, n. 19704 s.m.
Cass. civ., sez. un., 13.11.2012, n. 19702 s.m.
Cass. civ., sez. III, 06.11.2012, n. 19160 s.m.
Cass. civ., sez. III, 02.10.2012, n. 16754 s.m.
Cass. civ., sez. un. 02.10.2012, n. 16727 (con nota di Restucci)
Cass. civ., sez. un., 04.09.2012. n. 14828 s.m.
Cass. civ., sez. I, 02.08.2012, n. 13904 s.m.
Cass. civ., sez. II, 24.07.2012, n. 12923 s.m.
Cass. civ., sez. III, 20.04.2012, n. 6273 (con nota di Sabbatini)
TRIBUNALE
Trib. Napoli, sez. X, 21.09.2012., Giud. C. d’Ambrosio s.m.
Trib. Napoli, sez. VI, 20.09.2012, Giud. Est. A. Quaranta s.m.
Trib.Napoli, sez. X, 19.09.2012. Giud. L. Trapani s.m.
Trib. Napoli, sez. I, 18.09.2012, Giud. A. Scognamiglio s.m.
Trib. Napoli, sez. IX, 17.09.2012, Giud. E. Di Vaio s.m.
Diritto e procedura penale
CORTE DI CASSAZIONE
Cass. pen., sez. un., 27.11.2012, n. 47604 (con nota di Pignatelli)
Cass. pen., sez. un., ord. 18.10.2012, n. 41694 s.m.
Cass. pen., sez. I, 18.09.2012, n. 39863 s.m.
Cass. pen., sez. VI, 19.09.2012, n. 36590 s.m.
Cass. pen., sez. un., 19.07.2012, n. 45246 (con nota di Pignatelli)
Cass. pen., sez. un., 19.07.2012, n. 41461 (con nota di Pignatelli)
Cass. pen., sez. V, 13.07.2012, n.36360 s.m.
Cass. pen., sez. III, 27.04.2012, n. 37903 s.m.
Cass. pen., sez. III, 20.03.2012, n. 38733 s.m.
CORTE DI APPELLO
App. Napoli, sez. III, 13.11.2012, n. 5029 s.m.
App. Napoli, sez. III, 06.11.2012, n. 4847 s.m.
App. Napoli, sez. III, 06.11.2012, n. 4838 s.m.
App. Napoli, sez. II, 23.05.12, n. 2558 s.m.
TRIBUNALE
Trib. Nola, coll. A), 05.12.2012, n. 2661 s.m.
Trib. Napoli, G.M., 19.11.2012 s.m.
Trib. Napoli, G.M., 12.11.2012 s.m.
Trib. Nola, coll. C), 25.10.2012, n. 2257 s.m.
Trib. Napoli, G.M., decreto 18.10.2012 s.m.
Diritto amministrativo
CONSIGLIO DI STATO
Cons. Stato, sez. V, 06.12.2012, n. 6257 s.m.
Cons. Stato, sez. V, 05.12.2012, n. 6243 s.m.
T.A.R.
T.a.r. Campania-Napoli, sez. VIII, 6.12.2012, n. 4982 s.m.
T.a.r. Campania-Napoli, sez. VIII, 21.11.2012, n. 4760 s.m.
T.a.r. Campania-Napoli, sez. I, 14.11.2012, n. 4086 s.m.
Diritto internazionale
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
C.G.U.E., sez. III, 19.12. 2012, Causa C‑579/11 (con nota di Romanelli)
CORTE SUPREMA DEL REGNO UNITO
Corte Suprema del Regno Unito, 12.12.2012, Causa [2012] UKSC 61(con
nota di Romanelli)
CORTE SUPREMA DEL CANADA
Corte Suprema del Canada, 22.12.2011, Causa 33718 (con nota di
Romanelli)
Elenco autori
Andrea Alberico
- Sui rapporti tra procedimento ordinario e procedimento di prevenzione: fin dove si spinge il cd. principio di autonomia rispetto alla richiesta di revoca
della misura di prevenzione?, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 114
- Nota redazionale a Cassazione penale, sezione I, 29 aprile 2011, n. 18590, Gazzetta Forense n. 3/2012 p. 62.
Giuseppe Amarelli
- L’aggravante speciale del delitto di estorsione delle “più persone riunite” al vaglio delle Sezioni unite, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 49.
- Le Sezioni unite e la indeterminata aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti: una ricognizione di significato valida solo in bonam partem. Nota
a Cassazione, Sezione unite penali, sentenza 20 settembre 2012, n. 36258, Gazzetta Forense n. 6/2012, p. 74.
- La tutela del singolo verso i poteri privati e gli strumenti di tutela nei confronti dell’abuso del diritto, Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 17.
- Relazione introduttiva sull’incidenza delle fonti comunitarie e internazionali nel nostro ordinamento penale, Gazzetta Forense n. 4/2012, p. 80.
- Dialogo tra la Corte EDU e le Corti nazionali sul principio di retroattività della legge penale favorevole, Gazzetta Forense n. 5/2012, p.78.
- Dialogo tra la Corte Edu e le Corti nazionali sul valore dell’overruling giurisprudenziale, Gazzetta Forense n. 6/2012 p. 84.
Elisa Asprone
- Violazione dell’obbligo di acquisire il c.d. consenso informato. Sull’onere del paziente di provare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito e la
condotta omissiva del medico, Gazzetta Forense n. 2/2012, p. 9
- Può la pubblica Amministrazione rifiutarsi di adempiere un contratto di appalto nel caso in cui l’impresa aggiudicatrice, pur avendo eseguito
regolarmente la propria prestazione, versi in una condizione di irregolarità ai fini del D.U.R.C.? Gazzetta Forense n. 4/2012, p. 135.
- Può il dies a quo del termine di prescrizione per la proposizione dell’azione risarcitoria dei danni derivanti da emotrasfusioni individuarsi nella data
della prima diagnosi del contagio? Gazzetta Forense n. 6/2012, p. 147.
Federico Baffi
- La nuova disciplina del falso in attestazioni e relazioni del professionista nella legge fallimentare, Gazzetta Forense n. 4/2012, p. 85.
- L’avvalimento dei requisiti c.d. “soggettivi” di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 79.
- Sistema Idrico Integrato. Moduli Gestionali e determinazione delle tariffe, Gazzetta Forense n. 4/2012, p. 107.
Achille Benigni
- La tutela contro gli atti dell’esecuzione esattoriale, Gazzetta Forense n. 4/2012, p. 123
Pierangelo Bonanno
- I servizi pubblici locali dopo il d.l. n. 1/2012, Gazzetta Forense n. 2/2012, p. 109
- La mediazione e la responsabilità medico sanitaria: limiti e prospettive, Gazzetta Forense n. 5/2012, p. 9
Francesca Bonito
- Anatocismo e prescrizione. Dopo le sezioni unite della Corte di cassazione 111e la Corte costituzionale si aprono nuove possibilità per gli utenti del
servizio bancario? Gazzetta Forense n. 3/2012 pag.111
Paola Borrelli
- La Corte di Cassazione muta indirizzo sui rapporti tra sospensione per complessità ed utilizzo del semestre aggiuntivo, Gazzetta Forense n. 5/2012, p. 61.
Almerina Bove
- L’evoluzione dello spoils system al vaglio della Corte Costituzionale, Gazzetta Forense n. 6/2012, p. 101.
Clelia Buccico
- La Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012: l’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni operative per la mediazione tributaria, Gazzetta Forense n. 2/2012, p.
117.
- Un’analisi critica del nuovo istituto del reclamo nel processo tributario, Gazzetta Forense n. 6/2012, p. 113.
Enrico Campoli
- La liquidazione delle spese di custodia in seguito ad archiviazione del procedimento: competenza del P.m. e/o del G.i.p?, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 47.
Raffaele Cantone
- Il riparto di giurisdizione in materia tributaria nelle decisioni della Cassazione del 2011, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 101.
Alfredo Capuano
- Può il pagamento con assegno postdatato rilevatosi sprovvisto di copertura finanziaria configurare il delitto di truffa? Gazzetta Forense n. 2/2012, p.135.
Gazzetta
F O R E N S E
n o v e m b r e • d i c e m b r e
2 0 1 2
161
- Può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo concesso con contratto di locazione finanziaria in caso guida in stato
di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c) ? Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 112.
Flora Caputo
- L’organo di controllo nelle società di capitali nelle recenti evoluzioni normative. Prime riflessioni, Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 9.
Felice Carbone
- L’infiltrato: non impedire un evento equivale a cagionarlo?, Gazzetta Forense n. 2/2012, p. 74.
Rossella Catena
- Brevi riflessioni dalle prospettive di riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari, Gazzetta Forense n. 672012, p. 69.
Corrado d’Ambrosio
- La ristrutturazione dei debiti civili, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 9.
- Le sezioni specializzate in materia di impresa, Gazzetta Forense n. 5/2012, p.13.
- Il sovraindebitamento dei soggetti economici e del consumatore nel D.L. N. 212/2011, (conv. nella L. 10/2012), Gazzetta Forense n. 6/2012, p. 30.
Pietro D’Alessandro
- Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sezione civile VII, sentenza 5 gennaio 2012, Gazzetta Forense n. 2/2012, p. 48.
- Nota redazionale a Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 10 aprile 2012, n. 5692 Gazzetta Forense n. 4/2012, p.70.
- Nota redazionale a Cassazione Civile, sezione I, 26 marzo 2012, n. 4792, Gazzetta Forense n. 5/2012, pag. 50.
Pier Giorgio De Geronimo
- Accordi procedimentali e strumenti di programmazione negoziata, Gazzetta Forense n. 2/2012, p. 105.
Gaetano Del Giudice
- L’organo di controllo nelle società di capitali nelle recenti evoluzioni normative.
- Prime riflessioni, Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 9.
Fabio Dell’Aversana
- Segregazione patrimoniale e famiglia di fatto, Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 24.
Maria Teresa Della Vittoria Scarpati
- La tutela cautelare nel giudizio amministrativo alla luce delle novità contenute nel codice del processo amministrativo: ai fini della rapida definizione
della controversia nel merito è ammessa la tutela cautelare, oppure l’applicazione dell’art. 55 comma 10 del c.p.a. rappresenta un’alternativa rispetto
alla concessione dell’istanza cautelare? Gazzetta Forense n. 4/2012, p. 141.
Pasquale Di Lieto
- Gli appalti pubblici e p.m.i. tra specialità reale ed apparente, Gazzetta Forense n. 6/2012, p. 107.
Gabriella Di Maio
- Una lettura “costituzionalmente orientata” del diritto di accesso ai documenti amministrativi tributari, Gazzetta Forense n. 5/2012, p. 102.
Carmela Esposito
- Osservazioni in tema di iudex suspectus, Gazzetta Forense n. 2/2012, p. 79.
Riccardo Esposito
- Quid juris quando (non costituitosi in giudizio l’intimato) il ricorrente non abbia tempestivamente depositato l’avviso di ricevimento (cd. cartolina) della
raccomandata postale fungente da notifica?, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 113.
- L’indennizzo ai medici specializzandi: risarcimento per tardivo recepimento delle direttive comunitarie e dilatazione del termine prescrizionale, Gazzetta
Forense n. 4/2012, pag. 12
- Quando non è stata esperita la mediazione, la domanda giudiziale dinanzi al Giudice di Pace è qualificabile come improcedibile oppure possono trovare
applicazione gli artt.320 e 322 c.p.c.?, Gazzetta Forense n. 5/2012, p. 127.
Rosanna Fattibene
- La tutela giurisdizionale dei diritti in tempi di crisi finanziaria. Il “Decreto Crescitalia” ed il riesame delle pronunce giudiziali, Gazzetta Forense n.
5/2012, p. 32.
162
e l e n c o
a u t o r i
Gazzetta
F O R E N S E
Giuseppe Ferraro
- Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile, Gazzetta Forense n. 6/2012, p. 9.
Francesco Frezza
- Portatori di handicap e danno da vacanza rovinata. Nota a Tribunale di Avellino 13 giugno 2011, n. 1119, Gazzetta Forense n. 5/2012, pag. 25.
Michela Fusco
- Il ruolo dell’avvocato nel procedimento di mediazione, Gazzetta Forense n. 2/2012, p.139.
Clelia Iasevoli
- I contenuti positivi della prevenzione speciale e il diritto all’educazione del minore autore di reato, Gazzetta Forense n. 4/2012, p. 75.
- La fonte di prova vulnerabile e l’omessa documentazione delle dichiarazioni, Gazzetta Forense n. 5/2012, p. 69.
Daniele Imbruglia
- Ai fini dell’articolo 34, comma 3, c.p.a., quando si possono definire sussistenti gli interessi risarcitori necessari per aversi un accertamento dell’illiceità
dell’atto amministrativo se nel corso del giudizio l’annullamento del medesimo non risulta più utile per il ricorrente?, Gazzetta Forense n. 5/2012, p.
131.
Umberto Lauro
- Il nuovo rito speciale per le cause di licenziamento. Legge 28 giugno 2012 n. 92, art. 1, commi 47-68, Gazzetta forense n. 6/2012, p. 23.
Anna Laura Magliulo
- Costituisce ipotesi di “abuso del diritto” il ricorso a più precetti in caso di titolo esecutivo rappresentato da un’unica sentenza di condanna a favore di
più creditori rappresentati dallo stesso difensore? Gazzetta Forense n. 2/2012, p.133.
- Se ed in che limiti è legittima l’esclusione dall’esame di Stato del candidato sorpreso a copiare da un telefono cellulare palmare, Gazzetta Forense
n.6/2012, p.153.
Immacolata Maione
- A quale giurisdizione appartengono le questioni meramente patrimoniali attinenti alla gestione dei rifiuti disciplinate dal D.L. n. 90/2008?, Gazzetta
Forense n. 1/2012, p. 116
- Quando non è stata esperita la mediazione, la domanda giudiziale dinanzi al Giudice di Pace è qualificabile come improcedibile oppure possono trovare
applicazione gli artt. 320 e 322 c.p.c.?, Gazzetta Forense n. 5/2012, p. 127.
Raffaele Manfrellotti
- Controllo notarile e questioni di legittimità costituzionale, Gazzetta Forense n. 4/2012, p. 9.
Gaetana Marena
- Discutibile interazione tra il federalismo fiscale ed il principio costituzionale di uguaglianza, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 84.
- La neo‑centralità dell’integrazione pubblico‑privata nella gestione della cosa pubblica, Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 81.
Daniele Marrama
- Società partecipate da amministrazioni e fallimento, Gazzetta Forense n. 5/2012, p. 95.
Andrea Merlo
- L’errore sul motivo nel testamento e la presupposizione, Gazzetta Forense n. 2/2012, p.16.
Raffaele Micillo
-
-
-
-
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore, ordinanza 19 gennaio 2012, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 37.
Nota redazionale a Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, sentenza 22.02.2011, n. 19, Gazzetta Forense n. 2/2012, p. 46.
Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. VIII civile, sentenza 07 giugno 2012, n. 6891, Gazzetta Forense n. 4/2012, p. 57.
Nota redazionale a Tribunale Di Napoli, Sezione V, ordinanza reclamo 24 luglio 2012, Gazzetta Forense n. 5/2012, p. 56.
Rosa Molè
- La portata normativa dell’art 19 dello statuto del lavoro, Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 30.
Mary Musto
- Costituisce ipotesi di “abuso del diritto” il ricorso a più precetti in caso di titolo esecutivo rappresentato da un’unica sentenza di condanna a favore di
Gazzetta
F O R E N S E
s e t t e m b r e • o t t o b r e
2 0 1 2
163
più creditori rappresentati dallo stesso difensore? Gazzetta Forense n. 2/2012, p.133.
Se ed in che limiti è legittima l’esclusione dall’esame di Stato del candidato sorpreso a copiare da un telefono cellulare palmare, Gazzetta Forense
n.6/2012, p.153.
Enzo Napolano
- Crisi dell’imprenditore e flessibilità soggettiva del contratto di appalto pubblico, con particolare riferimento alle modifiche della compagine dell’ATI,
Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 74.
Giuseppe Pedersoli
- La transazione fiscale di cui all’articolo 182‑ter della legge fallimentare: una novità soltanto annunciata, Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 95.
Angelo Pignatelli
- Il contributo minimo di partecipazione ricavabile dal linguaggio intercettato, Nota a Corte di Appello di Napoli, sez. II pen., sentenza 27 ottobre 2011,
n. 5178, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 54.
Tonia Raia
- Il mutuo nel terzo millennio: verso il superamento del dogma della realità. Nota a Cassazione civile, sez. I, 03 gennaio 2011, n. 14, Gazzetta Forense
n. 1/2012, p. 15.
Ermanno Restucci
-
-
-
-
Pignoramento presso terzi nei confronti della P.A.: la notificazione del pignoramento.
Nota a Cassazione civile, sez. III, sent. 18 agosto 2011, n. 17349, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 24.
Nota a Tribunale di Napoli, sez. feriale, ordinanza 10 agosto 2012, Gazzetta Forense n. 5/2012, p. 37.
L’ordinanza ex art. 789 c.p.c.: natura del provvedimento ed impugnazione esperibile. Nota a Cass. civ., sez. Un. 02 ottobre 2012, n. 16727, Gazzetta
Forense n. 6/2012, p.39.
Giuseppe Riccio
- Le letture dibattimentali tra immediatezza e “non dispersione”, Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 49.
- Centralità della motivazione e ragionevole dubbio, Gazzetta Forense n. 5/2012, p. 65.
Francesco Rinaldi
- Eccezione di compromesso, bando di gara e capitolato di appalto: questioni e brevi riflessioni, Gazzetta Forense n. 4/2012, p. 113.
Francesco Romanelli
- Il respingimento in mare e la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, Gazzetta Forense n. 1/2012, p.107.
Fabrizia Sabbatini
- Nota redazionale a Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Lavoro, sentenza 5 giugno 2012, n. 3592, Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 43.
- Nota redazionale a Corte di Cassazione, Sezione III, 20 aprile 2012, n. 6273, Gazzetta Forensen. 6/2012, p.57.
Carmen Scuotto
- Nota redazionale Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, sentenza 27 ottobre 2011, n. 24101, Gazzetta Forense n. 2/2012, p. 44.
- Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ord. 20 giugno 2012, Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 41.
Gaetano Scuotto
- Nota redazionale a Tribunale di Napoli, sez. XI, sentenza 25 luglio 2011, n. 9314, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 39.
Anna Sofia Sellitto
- Se ed entro che limiti si configura il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. con riguardo all’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione,
Gazzetta Forense n. 4/2012, p.138.
- Se ed entro che limiti sia possibile derogare al principio del contraddittorio nella formazione della prova, utilizzando dichiarazioni rese fuori dal
dibattimento, con particolare riguardo all’ipotesi di “minaccia del dichiarante” nell’ambito di processi aventi ad oggetto reati di associazione di
stampo mafioso, Gazzetta Forense n. 5/2012, p.128.
- Se ed entro che limiti sia configurabile il reato di omissione o ritardo di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. nell’ipotesi in cui il pubblico ufficiale non tenga
un comportamento di totale indifferenza dinanzi alla richiesta di un privato, ma attivi iniziative per la definizione della pratica di cui quest’ultimo sia
stato messo a conoscenza, Gazzetta Forense n. 6/2012, p.150.
164
e l e n c o
a u t o r i
Gazzetta
F O R E N S E
Luca Semeraro
- Sequestro preventivo e confisca per equivalente nei reati tributari, Gazzetta Forense n. 2/2012, p. 69.
Enza Sonetti
- Il trattamento fiscale privilegiato degli immobili posseduti da enti ecclesiastici al vaglio della Commissione Europea, Gazzetta Forense n. 1/2012, p. 93.
- Esenzione Imu per gli enti non commerciali. A che punto siamo?, Gazzetta Forense n. 5/2012, p. 113.
Ida Sorrentino
- Quali poteri spettano al giudice nella valutazione dei fatti determinanti l’apertura del procedimento ex art 143, co.11, d. lgs. 267/2000? È procedibile
l’azione di incandidabilità cui all’art 143, comma 11, d. lgs. 267/2000, nell’ipotesi in cui, nelle more del procedimento, si siano già svolti due turni
elettorali? Gazzetta Forense n. 2/2012, p.137.
- Quale rito deve applicarsi nel giudizio di appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 e qual è, dunque,la forma dell’atto
introduttivo? Gazzetta Forense n. 3/2012, p. 115.
- Licenziamento antisindacale: rilevanza delle dinamiche del caso per l’esclusione dell’insubordinazione e del danno alla produttività. Nota a Corte di
Appello di Potenza, sez. lav., 23 febbraio 2012, n. 170, Gazzetta Forense n. 4/2012, p. 22.
Pietro Sorrentino
- Nota redazionale a Corte di Cassazione, sezione III, 27 novembre 2012, n. 20984, Gazzetta Forense n.6/2012, p. 52.
Giuseppina Speranzini
- Quali poteri spettano al giudice nella valutazione dei fatti determinanti l’apertura del procedimento ex art 143, co.11, d. lgs. 267/2000? È procedibile
l’azione di incandidabilità cui all’art 143, comma 11, d. lgs. 267/2000, nell’ipotesi in cui, nelle more del procedimento, si siano già svolti due turni
elettorali? Gazzetta Forense n. 2/2012, p.137.
- Quale rito deve applicarsi nel giudizio di appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 e qual è, dunque,la forma dell’atto
introduttivo? Gazzetta Forense n. 3/2012, p.115.
Maria Antonietta Troncone
- Il principio della domanda cautelare: gravi indizi di colpevolezza e fumus commissi delicti, Gazzetta Forense n. 6/2012, p. 63.
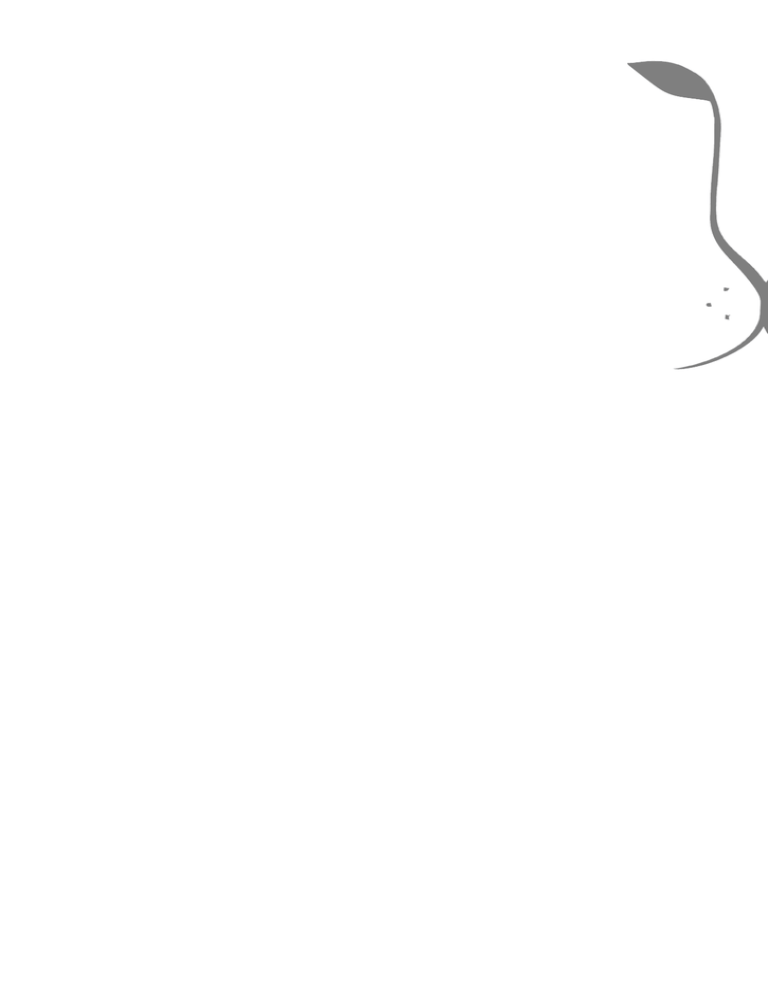
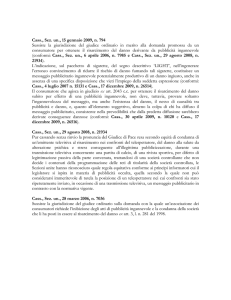
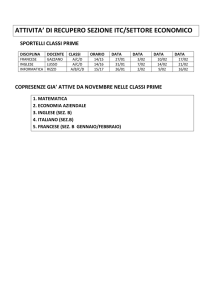
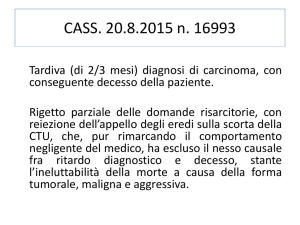
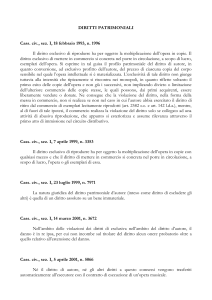
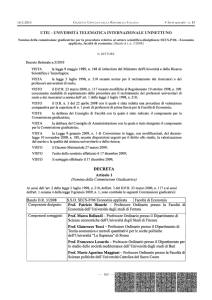
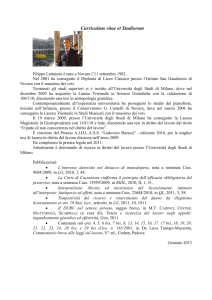
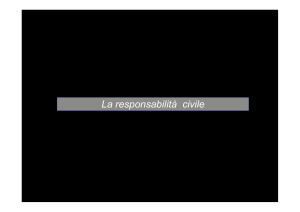
![Seminario della Cananea[1] - Associazione dei Costituzionalisti](http://s1.studylibit.com/store/data/002637490_1-0e7fc1c250f9f0c48cf0612878399e3d-300x300.png)