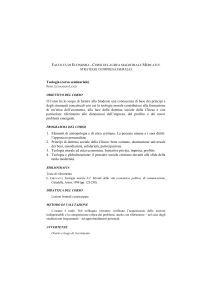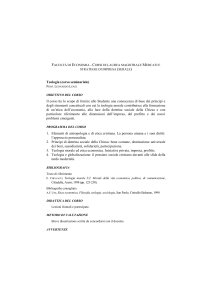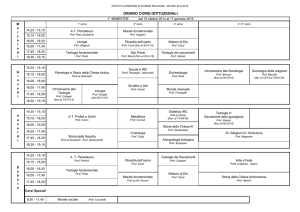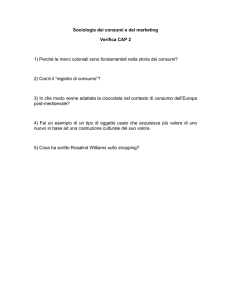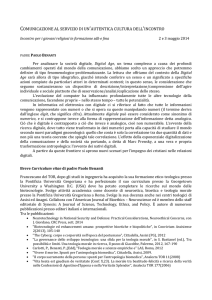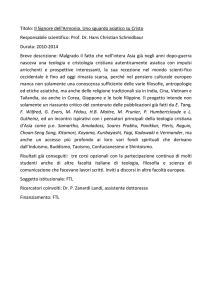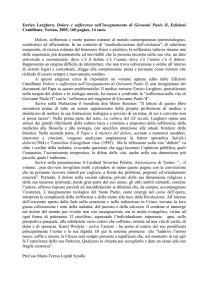REGATT 18-2009.qxd
15/10/2009
17.22
Pagina
L
627
L ibri del mese / segnalazioni
C. BALZARETTI,
IL PAPA, NIETZSCHE
E LA CIOCCOLATA.
Saggio di morale
gastronomica,
EDB, Bologna 2009,
pp. 256, € 18,90.
9788810104866
L’
autore sostiene che vi siano molte ragioni per riconoscere al cibo diritto di
cittadinanza nella teologia. Si pensi al
fatto che una storia del cristianesimo fatta di
asceti e di penitenti dimentica il ruolo della festa, del precetto festivo e del pasto festivo. Pertanto egli ritiene che la disputa sulla cioccolata
abbia una sua dignità, soprattutto se collocata
nel contesto del digiuno ecclesiastico e della
morale dell’epoca moderna. Va aggiunto che nel
contesto storico in cui essa si avviò furono coinvolti nomi interessanti, quali ad esempio il De
Medina, altrimenti noto in teologia morale a
motivo del rimando al probabilismo (si può seguire un’opinione probabile, anche se ve n’è una
più probabile).
L’autore prende spunto dalla contestata direttiva europea, non quella sulla lunghezza dei
baccelli di pisello o sulla circonferenza minima
di altri frutti, su ciò che sia o non sia cioccolato,
che ha visto l’Italia perdente davanti alla Corte
di giustizia europea, per recuperare un altro, più
alto dibattito protrattosi per oltre un secolo
(per giunta senza giungere a conclusione): se
cioè la cioccolata rompesse il digiuno (come sostennero domenicani e carmelitani) oppure no
(come sostennero i gesuiti, che però erano importatori, e qualche francescano che, magari
senza prendere posizione esplicita, sosteneva
saggiamente che conveniva non turbare le coscienze dei fedeli, perché «qui enim scrupolos
seminat peccata metet»).
Non ci si deve stupire dello spazio fatto dai
teologi dell’epoca a… tanta questione, semplicemente occorre tenere presente che le novità
portate dalla scoperta del nuovo mondo ponevano di fronte a interrogativi etici prima impensabili, quale appunto quello se la cioccolata
rompesse o meno il digiuno, tanto più che era
presa come bevanda, ma bevanda non del tutto appariva a motivo della densità, per tacere
degli effetti venerei che da più di qualche teologo e medico si sosteneva producesse.
Se il casuista Thomas Hurtado altercava con
i medici contemporanei a metà del 1600 se
cioccolata e tabacco rompessero il digiuno eucaristico, poteva sempre dire di essere in buona
compagnia visto che il card. Francesco Maria
Brancaccio (1592-1675) aveva scritto a sua volta il
De chocolatis potu diatribe. Quesito, quello
del rapporto cioccolata/digiuno, risolto in maniera tranciante dal medico genovese Felini
CLXXVII
(1630-1711) nella sua Risposta dimostrativa che
la cioccolata rompe il digiuno del cavalier
Francesco Felini. Operetta non meno utile che
necessaria al cristiano cioccolatiero, consacrata alla m. rev. suor Teresa Maria da San Giuseppe carmelitana scalza nel convento di Santa Teresa di Genova. Il Felini sostiene che il «cristiano cioccolatiero» è un cristiano a dir poco in
imbarazzo, che riesce a coniugare digiuno e gola… se non fosse che santa Rosa da Lima nelle
fatiche dell’estasi fu sostenuta da un angelo che
le offriva proprio una tazza di cioccolata e questo nonostante fosse opinione diffusa tra i teologi e i medici che, ahimé, la cioccolata muove
gli spiriti libidinosi.
Ma anche un nome illustre come Daniele
Concina, altrimenti impegnato con la storia del
probabilismo e del rigorismo e la disciplina antica e moderna della Chiesa sul digiuno, regnante
Benedetto XIV, pubblicava egli pure un Memorie storiche sopra l’uso della cioccolata in tempo di digiuno, esposte in una lettera a mons. illustris. e reverendis. arcivescovo di Venezia
(1748).
In sintesi, lo scritto di Balzaretti, che è mosso dalla volontà di completare e correggere le
sommarie e imprecise informazioni sulla «disputa» diffuse dalle storie della cioccolata, illustra
nella prima parte una serie di luoghi comuni ed
errori che giustificano un riesame delle fonti.
Nella seconda ricostruisce il contesto in cui si
colloca la disputa morale, accenna a studi sull’alimentazione, sulle società, sul rapporto
cibo/religione/digiuno. Nella terza parte si sofferma sui diversi momenti della disputa se la
cioccolata sia bevanda o no e sulla rappresentatività del dibattito dei moralisti cattolici sulla
cioccolata come espressione di un contrasto tra
le due Europe, quella cattolica appunto e quella protestante. Nella quarta parte infine discute
su questa tesi e la dimostra insufficiente, per
concludere con un riferimento alle varie interpretazioni della mela come frutto proibito del
paradiso terrestre. Riferimento spiegato nelle
conclusioni per la sua valenza teologica.
Il senso della ricerca del nostro è una sollecitazione ai teologi a riprendere nei loro dibattiti temi maggiormente attinenti al vissuto dei
cristiani. Insomma, il cibo dovrebbe interessare
il teologo, perché il rapporto cibo/morale non è
un problema marginale del cristianesimo, ma si
colloca all’origine e al centro della teologia cristiana. All’origine, se è vero che il primo peccato e la storia della salvezza partono proprio da
un atto di ghiottoneria, al centro perché l’eucaristia è un banchetto. Dunque è il momento
che il teologo rifletta sul business legato alla cosmesi, alla salutistica, al body fitness e alla gourmandise, temi tutti che vedono invece la Chiesa un po’ distratta.
Il corpo infatti pare interessare la Chiesa solo all’origine e alla fine, dunque morale della sessualità, della manipolazione genetica, problematiche dell’eutanasia. Oggi la bioetica si è so-
stituita alla dietetica che è invece abbandonata
in toto alla sfera temporale «con il ritorno di
una vecchia tradizione interrotta nel Seicento,
quando la gola si era emancipata dalla medicina
ma, d’altra parte e paradossalmente, si assiste a
«una ripresa di tematiche connotate religiosamente». Il protestantesimo all’inizio si caratterizzò per il rifiuto dei precetti alimentari ecclesiastici. Più recentemente anche il cattolicesimo
abbandona tali norme, mentre molte confessioni protestanti usano prescrizioni dietetiche
per preservare il corpo da cibi dannosi, religiosamente qualificati come impuri. Insomma a
differenza di tradizioni religiose, che usano il cibo come segno di appartenenza e identità di
gruppo, l’ossessione salutista è diventata la nuova morale di una religione che ha come oggetto di culto il corpo.
Curioso anche che nella polemica tra cristiani la cioccolata fosse cattolica e il caffè protestante, proprio perché la cioccolata come bevanda termina la sua esistenza con l’Ancien régime e continua a vivere soprattutto come
cioccolato, la cui produzione (e determinazione
degli ingredienti da parte della Comunità europea) per ironia della sorte è oggi soprattutto in
mano a paesi protestanti.
Credo che queste considerazioni possano
rendere interessante lo scritto, che è corredato
da dotte appendici, tra cui il bando di scomunica in lingua spagnola contro i consumatori di
cioccolata e l’elenco di tutti gli autori che hanno scritto sulla questione del rapporto cioccolata/digiuno.
Quanto al titolo, una dettagliata spiegazione del quale è fornita a p. 84, la ricerca segue tre
strade: l’interpretazione (Nietzsche) di un dibattito di teologia morale (il papa) che costituiva
un episodio della storia dell’alimentazione (la
cioccolata). Del dibattito morale c’è poco da dire, l’argomento non meritava tanto interesse e
la morale magari avrebbe dovuto e dovrebbe
preoccuparsi piuttosto degli schiavi di ieri e di
oggi impiegati nella raccolta di cacao (oggi in
Costa d’Avorio, che è il maggior produttore di
cacao, sono soprattutto bambini schiavi provenienti dal Mali e da altri paesi più poveri a raccogliere il cacao).
Tuttavia l’abbandono della pratica del digiuno e dell’astinenza ha una rilevanza storica che
forse la Chiesa non ha meditato a sufficienza,
restando vittima del processo di secolarizzazione e disincanto weberiano del mondo. Mary
Douglas commentando la Paenitemini di Paolo
VI, nel 1966, scrisse che il digiuno del venerdì era
«il solo rito che potesse portare i simboli cristiani in cucina, in dispensa e sulla tavola apparecchiata, come avviene per le regole ebraiche di
purità. Cancellare un simbolo che ha un significato non garantisce che il suo posto sarà occupato dallo spirito di carità: forse sarebbe stato
più sicuro contare su quel piccolo muro simbolico, nella speranza che in avvenire giungesse a
cingere il monte Sion; ma come abbiamo visto,
IL REGNO -
AT T UA L I T À
18/2009
627
REGATT 18-2009.qxd
L
15/10/2009
17.22
Pagina
ibri del mese / segnalazioni
i responsabili delle decisioni ecclesiastiche hanno ricevuto assai spesso un’educazione che li
rende indifferenti ai segni non-verbali, e ottusi al
loro significato. Questo punto è fondamentale
per spiegare la difficoltà in cui si dibatte oggi il
cristianesimo: è come se i semafori della liturgia
fossero manovrati da segnalatori daltonici».1
Ciò ricordato, si può aggiungere, ed è importante anche a livello pastorale, che se è vero che davanti alla fine della società postmoderna non siamo inclini a incasellare in schemi
storiografici una disputa sulla cioccolata, è però
altrettanto vero che possiamo considerarla come una provocazione a riflettere sulle morali
dominanti e a mettere in luce la vera natura di
ogni morale, e a maggior ragione di una norma
giuridica che venga costruita ex post per giustificare una scelta irrazionale.
Aimone Gelardi
1
H. DOUGLAS, I simboli naturali. Esplorazioni in
cosmologia, Einaudi, Torino 1979; citato da Balzaretti a p. 174.
J.B. METZ,
MEMORIA
PASSIONIS.
Un ricordo
provocatorio nella
società pluralista,
Queriniana, Brescia
2009, pp. 251, € 25,50.
978883990444
L
a recente traduzione in lingua italiana di
Memoria passionis. Un ricordo provocatorio nella società pluralista offre non
solo l’opportunità d’attraversare in modo sistematico e sintetico l’opera di Metz, ma è anche
l’occasione per declinare le possibili configurazioni tra cristianesimo e politica nel presente
della nostra storia globale e nazionale.
Nel volume si assiste a un passaggio di paradigma, nonché a un’evoluzione tematica nell’opera dell’autore: la teologia politica si fa mistica politica. Se negli anni Sessanta e Settanta
la riflessione di Metz si era concentrata maggiormente sull’elaborazione della nuova teologia politica come sguardo rinnovato sul mondo
e come teologia fondamentale pratica, negli ultimi due decenni, invece, il tema della memoria passionis ha inaugurato un’ermeneutica critica del cristianesimo, in quanto luogo di rammemorazione della sofferenza ingiusta e innocente.1
Dal momento che questi due poli tematici
sono strettamente interconnessi, vorrei brevemente soffermarmi sulle caratteristiche essenziali della nuova teologia politica che vede in
Metz sia il fondatore sia il più acuto studioso.
Il cuore dell’annuncio evangelico ha una
natura mondana e pubblica che non prefigura
mai una salvezza privata. Allo stesso tempo
628
628
IL REGNO -
AT T UA L I T À
18/2009
quella salvezza non è mai politicamente identificabile con una concreta istituzione storica,
ma esperibile solo come processo critico-sociale mediante il quale le concrete istituzioni
storiche vengono migliorate partendo dalla loro inappagata incompletezza. In Memoria passionis, quello che si presentava come un’ermeneutica critica della mediazione istituzionale
ed ecclesiale del messaggio cristiano, si articola nella prassi individuale e collettiva del cristiano come soggetto politico e come membro di
una comunità civile.
Quello che agli occhi di Metz qualifica e distingue la prassi cristiana, in quanto naturalmente situata e collocabile in un contesto sociale, è
l’esercizio della razionalità anamnestica in un
contesto sociale pluralistico.
All’interno della natura pubblica e mondana
del cristianesimo, una cosa in particolare non è
secolarizzabile: l’essere comunità di credenti
che fa memoria della sofferenza, di quella sofferenza scomoda che risiede nel dolore dell’innocente e della vittima d’ingiustizia. Qui risiede
il nucleo del concetto di memoria passionis: la
vita cristiana è vista come la fatica comunitaria
di far emergere il dolore rinserrato nelle fitte
maglie del sociale, facendosi memoria con-passionevole della passione di Cristo. La sofferenza
è il magma, la sostanza e la carne su cui il cristianesimo articola ogni gesto e informa ogni stile.
Quella di Metz è una teologia critica della
sofferenza sociale; essa poggia non su un’astratta fenomenologia del dolore umano, ma su una
cruda antropologia del male in quanto ingiustizia. In questo punto teorico risiede anche il luogo di massima comunicazione della teologia di
Metz con la teoria critica francofortese, in particolar modo con le movenze della dialettica
negativa adorniana; è proprio Adorno, infatti, ad
aver messo davanti agli occhi della speculazione
filosofica contemporanea la natura sociale del
fianco squarciato dell’uomo.2 Metz rinnova l’acuto e interpellante grido della teodicea ricollocandolo nell’umanità contemporanea la quale, nello stesso momento in cui si scopre sofferente, si riscopre affamata di giustizia.
Peccato o sofferenza? Queste sono le due
categorie ermeneutiche su cui si gioca il volto
con-passionevole del cristianesimo. Da tale
scelta scaturiranno pratiche sociali e politiche
diverse se non contrastanti tra loro. «La questione che inquieta la fede d’Israele, della giustizia per gli innocenti che soffrono, nel cristianesimo fu mutata e trasformata troppo velocemente nella questione della redenzione dei colpevoli (…). Abbiamo forse, nel corso del tempo,
interpretato il cristianesimo troppo esclusivamente come religione sensibile al peccato e
perciò troppo poco come religione sensibile alla sofferenza?» (62).
Ma se la sofferenza si dà come esperienza
sociale, se la sofferenza non è mai pre-politica,
qual è il suo tratto distintivo e sostanziale? Il
cuore della sofferenza sta nel non poter più
amare.3 Questa visione sociale della sofferenza
umana, in quanto impossibilità di relazioni di re-
ciprocità, è in stretta sintonia con la linea predominante nell’antropologia sociale contemporanea.4
La vera sofferenza sociale non deve essere
ascritta meramente alla negazione o al misconoscimento di diritti individuali, bensì all’assenza di condizioni politiche e di spazi pubblici regolamentati, in cui gli individui possano articolare nuove e plurali relazioni. Qui, in questo preciso passaggio, la memoria del dolore sociale
dell’innocente diviene ricerca comune di regole
di giustizia.
Qui la teologia critica della società, a cui
Metz ha dedicato le sue ricerche, si fa prassi politica fondata sulla partecipazione democratica
al rinvenimento qualificato di norme di giustizia
sociale. D’altro canto, il laicato cattolico non
può tralasciare il primato impellente della ricerca dei sofferenti; quel laicato, alla luce della memoria passionis, è chiamato a dare volti e nomi
a coloro che soffrono ingiustamente, per non
potersi neanche dire, per non poter instaurare
libere relazioni di reciprocità in cui quell’identità
possa essere costruita.
Le scienze umane come la stessa teologia
sociale hanno quindi il compito d’essere «l’espressione discorsiva delle diverse forme di torto che derivano dalla sofferenza umana immotivata che si manifesta nel contesto di un costante bisogno d’individuare forme di sofferenza non prevedibili».5 Allo stesso modo, il gesto
che più intrinsecamente identifica l’azione e il
compito del politico consiste nella capacità di
avvertire l’assenza, risiede cioè nella compartecipazione dei membri della comunità politica al
rinvenimento dell’incompletezza delle istituzioni presenti, nel portare alla luce il non-ancora-realizzato nei rapporti di giustizia tra gli uomini.7
Per Metz, l’antitesi di tale concezione del
politico consiste nella morale della maggioranza
appagata, ovvero in uno stile politico in cui una
maggioranza democraticamente eletta, o socialmente rappresentativa del senso comune,
impone, sazia e paffuta, il suo diritto ad agire in
nome del consenso, ignorando sia la minoranza
politica sia le minoranze sociali.
La memoria passionis, ovvero la mistica
politica della con-passione, agisce anche come
rimedio al processo di auto-privatizzazione della Chiesa nella sfera pubblica. A tal proposito
Metz mette in guardia da due derive. Da un lato, il percepirsi come piccolo gregge, ovvero la
tendenza della comunità ecclesiale a definirsi in
maniera esclusiva, ignorando che «chi conosce
unicamente la Chiesa, non può dire di conoscere neppure la Chiesa» (172). Dall’altro lato, la teologia critica di Metz tende a contrastare la tendenza borghese e assistenziale per cui la comunità dei credenti diventa Chiesa-di-servizi. In
questo caso, ritengo che l’accento più pericoloso che Metz voglia evidenziare non risieda tanto nella deriva funzionale e benefattrice delle
attività ecclesiali, quanto nel pericolo che la
Chiesa stessa si trasformi in agenzia sociale e
politica. «C’è (invece) bisogno di un cristianesi-
CLXXVIII