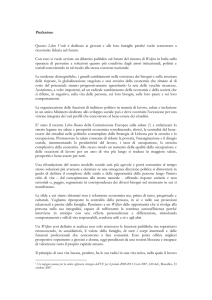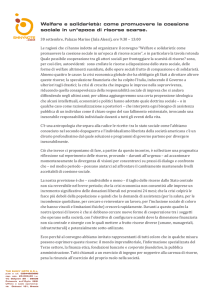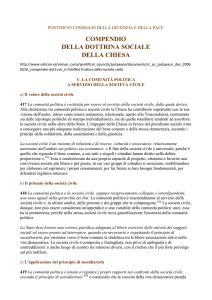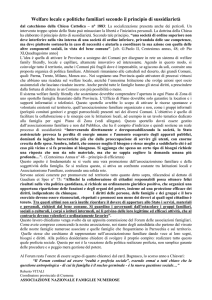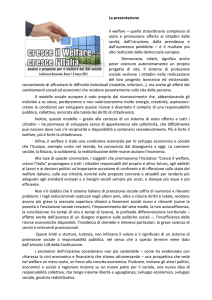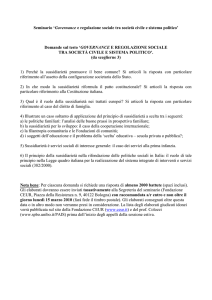La DSC, il welfare e le politiche sociali in Italia.
di Ivo Colozzi
Premessa
Prima di entrare nel merito del tema che mi è stato proposto vorrei fare una premessa di
carattere lessicale. Se andiamo a cercare nel Compendio della DSC (2004) le parole che compaiono
nel titolo di questo contributo a fianco di DSC, cioè welfare (sottinteso state) e politiche sociali, non
le troviamo non solo nell’indice generale, ma neanche nell’indice analitico. E’ evidente che non si
può desumere da una tale mancanza che i problemi e i temi sottesi a queste espressioni non abbiano
ottenuto da parte del magistero sociale della Chiesa una adeguata attenzione. Direi, al contrario, che
il problema cui rimandano, cioè in che modo sia possibile sanare il conflitto prodotto dalla
diseguale distribuzione della ricchezza che si associa allo sviluppo dell’economia capitalistica, è fra
quelli che più hanno contribuito alla nascita della DSC. Resta il fatto, però, che i termini con cui il
problema continua ad essere affrontato rivelano ormai una profonda divaricazione fra il linguaggio
della DSC e quello delle scienze sociali, divaricazione che sicuramente non aiuta queste ultime a
prendere in più seria considerazione i contenuti che la DSC propone su tali temi; contenuti che,
come cercherò di mostrare, sono, invece, quanto mai importanti per orientare la ricerca delle nuove
soluzioni che le mutate condizioni socio-economiche rendono oggi assolutamente necessarie. In
questo senso vorrei sollecitare un rinnovamento lessicale che adottando i termini del dibattito
scientifico internazionale consenta di far apprezzare meglio l’originalità della DSC rispetto agli
approcci oggi prevalenti in campo scientifico e che maggiormente ispirano e condizionano le scelte
politiche degli stati nazionali e degli organismi internazionali.
Di seguito affronterò il tema che mi è stato affidato illustrando innanzitutto come è stato
intesa la politica sociale da parte dell’approccio socialdemocratico o laburista, che ha caratterizzato
la fase moderna trovando la sua più piena espressione e realizzazione nel welfare state o stato del
benessere; nel secondo passaggio presenterò brevemente i fattori che hanno messo in crisi il welfare
state; come questa crisi abbia rilanciato l’altro grande paradigma moderno, il liberalismo, e come le
soluzioni che oggi vengono proposte e sperimentate siano in gran parte dovute ad una inedita
miscela dell’approccio socialdemocratico e di quello liberale. Intendo poi presentare l’approccio
della DSC sul tema e far vedere come essa offra una prospettiva nuova e originale rispetto alle altre
posizioni grazie al riferimento al principio di sussidiarietà. Infine proporrò in termini sintetici una
valutazione della legge italiana di riforma dell’assistenza alla luce dei principi e delle indicazioni
offerte dalla DSC.
1.Il paradigma moderno: lo Stato come attore unico o principale delle politiche sociali.
In un manuale di politica sociale abbastanza recente, M. Hill ha sostenuto che in termini
generali si può definire la politica sociale come “ciò che lo stato fa per il benessere dei
cittadini.”(1999:21) Questa definizione, cui se ne potrebbero accostare tante altre sostanzialmente
uguali, esemplifica in modo adeguato l’approccio con cui la disciplina che si occupa di questi temi,
cioè la social administration, ha letto le politiche sociali, intendendole come intervento dello Stato
in funzione di perequazione o riduzione degli squilibri di reddito/opportunità prodotti dal mercato.
Alle spalle dell’approccio indicato è facile riconoscere dal punto di vista filosofico l’adesione al
paradigma, insieme teorico e morale, tipico della filosofia hegeliana e della sua variante
gramsciana, che considera la società civile come luogo dell’incontro/scontro fra interessi
particolaristici che deve trovare il proprio superamento/inveramento nell’universalismo dello Stato,
incarnazione dello Spirito oggettivo, e dal punto di vista politico la forte vicinanza di queste tesi alle
posizioni del socialismo riformista europeo1. Per R. Titmuss, il rappresentate forse più importante
1
Mi riferisco al movimento nato dopo la prima guerra mondiale e la rivoluzione russa, in contrapposizione
all’interpretazione leninista del marxismo e alla Prima Internazionale. Il socialismo riformista dette vita alla Seconda
Internazionale ed elaborò il modello delle socialdemocrazie. Del concetto teorico e storico di socialdemocrazia si sono
avute molte letture e divergenti interpretazioni. Generalmente esso viene utilizzato per indicare l'insieme di quei
movimenti socialisti che intendono muoversi all'interno delle istituzioni liberali e accettano, pur con certi limiti, la
1
della social administration, ad esempio, il significato più profondo dello stato del benessere
(welfare state) era di promuovere un cambiamento della coscienza collettiva, incoraggiando il
sentimento dell’altruismo, cioè l’atteggiamento di dono non solo verso i prossimi noti, ma verso gli
sconosciuti, cioè nei confronti di ogni membro della società (1970). Condizionata da questa precomprensione, la politica sociale ha letto la storia della società moderna come un processo
tendenzialmente evolutivo le cui tappe fondamentali sono segnate dall’affermarsi progressivo dei
diritti di cittadinanza, prima civili, poi politici e, infine, sociali (Marshall 1976), grazie alla crescita
dell’intervento regolativo dello Stato in funzione di correzione dei limiti e delle discriminazioni
tipici del mercato. Ne è scaturita una modellistica fondata prevalentemente su un criterio di tipo
normativo, tendente, cioè, a far coincidere la piena comprensione e attuazione delle politiche sociali
con l’ampiezza del ruolo svolto dallo Stato, o con la capacità/possibilità delle stesse di ridurre o
contrastare l’importanza relativa del mercato e delle sue logiche nei confronti del sistema sociale
totale.
Un esempio molto significativo di questo modo di procedere ci è offerto ancora da Titmuss (1986),
che ha individuato tre modelli: welfare state residuale o della pubblica assistenza; del rendimento
industriale o remunerativo; istituzionale-redistributivo. Per presentare le caratteristiche dei tre
modelli ci rifacciamo alla rielaborazione che ne ha fatto Donati (1993:37-38) che ha aggiunto ai tre
citati il modello totale o di pianificazione totale.
Il modello residuale concepisce la politica sociale come intervento a posteriori dello Stato che aiuta
solo gli individui e le famiglie che hanno completamente fallito nel mercato e che alla prova dei
fatti si dimostrano incapaci di risolvere autonomamente i loro problemi. L’intervento di regolazione
dello stato sulla società (mercato, reti informali di sostegno), quindi, è minimo.
Il modello acquisitivo-performativo si basa sull’idea dei “meriti” acquisiti nello svolgimento del
proprio lavoro. Indipendentemente dal fatto che abbia o meno risorse proprie, chi ha lavorato e
versato i contributi ha maturato il diritto a delle prestazioni che andranno ad integrare il livello di
vita e di sicurezza che può procurarsi autonomamente. Le istituzioni del welfare, quindi, si
aggiungono a quelle del mercato e le integrano, ma solo per gli attori che si impegnano ad operare
nel mercato.
Il modello istituzionale-redistributivo è fondato sull’idea di benessere sociale come valore che deve
essere assicurato ai cittadini in base ai loro bisogni e indipendentemente dal fatto che abbiano
“meritato”. Le politiche sociali, quindi, intendono garantire uguaglianza di opportunità a tutti i
cittadini, senza per questo eliminare le differenze prodotte dagli altri sistemi di allocazione delle
risorse (mercato e reti di sostegno). Le prestazioni e i servizi sono forniti da istituzioni pubbliche su
base universalistica (in linea di principio tutti i cittadini ne hanno diritto) e finanziati attraverso le
risorse messe a disposizione dal sistema fiscale (principio di redistribuzione).
Il modello totale condivide tutti gli elementi caratteristici del modello istituzionale, ma se ne
differenzia perché nei settori in cui interviene, lo Stato esclude gli altri sistemi di allocazione delle
risorse. Ad esempio, le prestazioni sanitarie sono fornite tutte dallo Stato e solo dallo Stato. Non è
possibile, anche avendone i mezzi, rivolgersi ad una clinica privata o avere una stanza singola a
pagamento nell’ospedale pubblico. E’ stato il modello tipicamente adottato dai paesi a regime
socialista.
E’ evidente che la tipologia di Titmuss soffre di un vizio evoluzionistico e di una eccessiva
prescrittività. Per lui, infatti, i modelli successivi rappresentano l’evoluzione logica e positiva del
primo, che viene considerato in chiave negativa.
2. La critica marx-leninista e radicale al paradigma moderno
Alla linea dominante, sinteticamente illustrata nel paragrafo 1, si è contrapposta, nell’ambito
della comprensione “moderna” della società, la posizione degli studiosi di matrice marx-leninista,
radicalmente ostili al compromesso con l’economia di tipo capitalistico e, conseguentemente,
funzione positiva dell'economia di mercato e della stessa proprietà privata. Per un approfondimento sul tema si vedano
Cole (1968) e Abendroth (1971).
2
all’approccio del socialismo riformista e dei partiti socialdemocratici. Questi studiosi hanno
rovesciato l’interpretazione degli studiosi socialdemocratici sulle motivazioni etiche che fondano e
giustificano il crescente intervento dello Stato, evidenziando, in analogia con l’analisi di Marx sui
meccanismi di crisi dell’economia capitalistica, i fattori che avrebbero inevitabilmente prodotto la
crisi dello Stato del benessere.
Quanto alle motivazioni, gli studiosi di matrice marx-leninista hanno costantemente sottolineato
come sia il passaggio dallo stato liberista a quello assistenziale, realizzatosi per la prima volta nella
Germania governata dal Cancelliere von Bismark, sia l’ulteriore passaggio dallo Stato assistenziale
allo Stato sociale o welfare state, concepito in Gran Bretagna nel corso della seconda guerra
mondiale con il famoso Report on social insurance and allied services della Commissione
presieduta da Lord Beveridge, si giustifichino il primo in funzione di legittimazione dell’economia
di mercato da parte della classe operaia, convinta con questi mezzi a passare da posizioni
rivoluzionarie ad un atteggiamento riformistico, il secondo in funzione del sostegno della stessa
classe allo sforzo produttivo necessario per continuare la guerra contro la Germania hitleriana. Gli
esponenti di questa corrente, quindi, negano il significato attribuito da Titmuss alle politiche sociali
e sostengono, al contrario, che l’espansione degli interventi di welfare ha avuto esattamente la
funzione di mantenere la disuguaglianza e lo sfruttamento prodotti dall’economia capitalistica, ma
entro limiti che risultassero socialmente accettabili, e che la filosofia che lo legittima non sia altro
che ideologia, abbia, cioè, lo scopo di produrre falsa coscienza, alterando la percezione della propria
esperienza da parte delle classi sfruttate e manipolate dal mercato, o, per usare una bella espressione
di Habermas, di “colonizzare i mondi vitali” (1975; 1997).2
Gli esponenti della posizione radicale hanno dato contributi interessanti anche sull’analisi dei
meccanismi di crisi del welfare state, crisi considerata da tutti inevitabile, ma spiegata in modi
abbastanza diversi e articolati su cui in questa sede non mi posso soffermare.
3. I fattori di crisi del welfare state.
Confermando solo in parte le analisi marxiste, il sistema di politiche sociali legato al
modello di welfare state è effettivamente entrato in crisi negli anni ’80 del secolo scorso per una
serie di ragioni, alcune delle quali interessano tutti gli stati nazionali, mentre altre si sono
evidenziate maggiormente in alcuni paesi ed hanno, quindi, un carattere peculiare. Fra le cause di
crisi indichiamo:
a) la globalizzazione dell’ economia. La globalizzazione dell’economia ha messo in crisi gli stati
europei che avevano adottato il modello di Stato sociale rallentandone la crescita economica, in
quanto i costi per le politiche sociali appesantiscono il sistema paese e riducono la competitività
delle aziende nazionali rispetto a quelle di altre nazioni che hanno uno Stato meno interventista sul
piano delle garanzie sociali per i lavoratori e/o i cittadini. Più in generale la globalizzazione ha reso
obsoleto lo schema economico elaborato da Keynes. Non è più vero che per dare impulso
all’economia è sufficiente ridurre i tassi di interesse e incrementare la spesa pubblica e che per
frenarla (se c’è un rischio di inflazione) è sufficiente aumentare i tassi. In un’economia senza
confini territoriali l’espansione della domanda in un paese può causare una crescita occupazionale
in un paese diverso, da cui vengono prodotti i beni più richiesti. Oppure può non avere riflessi
positivi sull’occupazione perché la produttività può essere ottenuta con l’innovazione tecnologica,
cioè sostituendo la forza lavoro con l’uso di computer e robot. Inoltre, la riduzione dei tassi di
interesse può indurre gli investitori stranieri a portare all’estero i loro capitali. D’altra parte, il
rallentamento della crescita economica, che produce comunque un aumento della disoccupazione
strutturale, rende difficile nel lungo periodo mantenere livelli elevati di spesa pubblica. Un ulteriore
Oltre all’ Habermas di questo periodo (1975), possono essere ricordati come rappresentanti
della posizione qui delineata Offe (1977) e J. O’Connor (1977).
2
3
fattore di cambiamento prodotto dalla globalizzazione è la cessione di sovranità nazionale a favore
degli organismi politici ed economici sovranazionali o transnazionali, come l’ Unione Europea e l’
Accordo di libero commercio dell’America del Nord (Nafta). Tali organismi possono oggi vincolare
ad esempio l’ammontare massimo della spesa pubblica in percentuale del PIL, costringendo di fatto
gli stati a rivedere il loro sistema di welfare.
b) il livello troppo alto del debito pubblico. La spesa sociale, in base al principio keynesiano del
deficit spending, è una delle voci che più ha contribuito negli ultimi decenni a portare il debito
pubblico, cioè l’ammontare complessivo dell’indebitamento dello Stato verso terzi in percentuale
del PIL (prodotto interno lordo), a livelli che in alcuni casi superano addirittura l’ammontare
complessivo del PIL o che toccano, comunque, percentuali superiori alla metà. In termini più attenti
all’economia reale che alla finanza, potremmo dire che quando il livello di indebitamento supera
certe soglie, diventa problematica la prospettiva di un ulteriore sviluppo economico “sano” del
paese, cioè uno sviluppo con bassi tassi di inflazione,. Dal momento che la spesa sociale incide in
maniera molto significativa sulla dinamica del debito, ne deriva la necessità di rivedere il sistema di
protezione sociale.
c) un tasso eccessivo di pressione fiscale. E’ un aspetto strettamente collegato a quello precedente.
Se un paese ha un debito molto alto è costretto ad aumentare la pressione fiscale (cioè l’insieme
delle proprie entrate) per ridurlo o, quantomeno, per non espanderlo. Il livello della pressione
fiscale, però, dipende anche dall’incidenza dei contributi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro
per finanziare i sistemi assicurativi di protezione sociale (ad esempio le pensioni). Il problema è che
in una economia aperta, cioè globalizzata, un livello di tassazione troppo elevato produce un blocco
dell’economia perché induce a trasferire sia le imprese che i capitali finanziari in paesi dove il costo
del lavoro e la tassazione sui profitti d’impresa e sui capital gains (incremento di capitali) sono più
bassi. In paesi che praticano o che hanno praticato queste politiche di forte tassazione degli utili per
mantenere sistemi di welfare molto costosi, ad esempio la Svezia e l ‘Inghilterra negli anni ’70 del
novecento, tendono a nascere movimenti anti welfare che mettono radicalmente in discussione la
solidarietà fiscale e propongono un arretramento dei sistemi di protezione sociale su basi minime.
d) i cambiamenti demografici. In tutti i paesi europei si è registrato un aumento dei tassi di
invecchiamento della popolazione, dovuti sia all’abbassamento dei tassi di natalità, sia al
prolungamento della durata media della vita, e una conseguente crescita molto spinta delle spese per
le pensioni e delle spese sanitarie. Ciò, oltre che aumentare in assoluto la spesa sociale, crea
problemi consistenti di equità fra le generazioni, nel senso che la distribuzione della spesa pubblica,
finanziata tramite prelievo fiscale, rischia di penalizzare i giovani e di favorire gli anziani. Inoltre
l’aumento molto forte del numero degli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti mette
in difficoltà le reti pubbliche di assistenza e sostegno che sono costrette sempre più ad appoggiarsi
alle reti familiari e parentali. Queste, d’altra parte, vanno perdendo la loro capacità di tenuta sia
perché la minore natalità ne ha ridotto le dimensioni strutturali (cioè il numero dei componenti su
cui distribuire i carichi del lavoro di cura), sia perché sono sempre più interessate da processi di
indebolimento e di rottura, a causa del diffondersi di separazioni e divorzi. Ne consegue una
contraddizione strutturale che porta ad una crescente insoddisfazione delle famiglie.
e) le nuove immigrazioni. La spinta alla globalizzazione, il forte invecchiamento della popolazione,
il mancato incontro fra domanda e offerta di lavoro per quanto riguarda in particolare i lavori che
richiedono scarsa qualificazione e molta fatica fisica: sono alcune delle ragioni che hanno portato
negli ultimi anni ad un costante aumento, nei paesi della Comunità Europea, della presenza di
immigrati extracomunitari. Questo processo, naturalmente, non avviene in forma “razionale”, cioè
secondo logiche di programmazione dei flussi in base all’offerta di lavoro e rispettando le procedure
previste dagli accordi internazionali per l’immigrazione. Parte anche consistente degli immigrati è
arrivata clandestinamente nei nuovi paesi; non ha il permesso di soggiorno, oppure l’aveva ma è
scaduto; lavora in nero o svolge attività illegali. Naturalmente in tutti questi casi gli immigrati non
possono richiedere la cittadinanza o una forma equivalente che consenta loro di godere dei diritti
sociali che il sistema di protezione sociale garantisce ai cittadini. Nonostante questo hanno bisogni e
4
devono poter contare su forme di protezione in società che tendono ad essere sempre più
“rischiose”. Si pone, quindi, il problema di andare oltre il modello basato sulla tutela dei diritti di
cittadinanza, e di estendere le garanzie anche a chi non è cittadino, ma gode dei diritti riconosciuti
dalle varie Carte dei diritti dell’uomo.
f) le povertà vecchie e nuove e le nuove patologie sociali. E’ impressione diffusa, supportata da una
massa crescente di dati di ricerca, che il welfare state abbia fallito nell’eliminare la povertà dei
gruppi sociali più marginali e che la crescita del benessere e dei modi di vita che a questo si
accompagnano, garantita ai livelli medio-bassi e medi della stratificazione sociale, abbia prodotto
un esito “paradossale”. Il paradosso consiste nel fatto che le stesse politiche sociali creano forme
nuove di povertà, sia di tipo materiale, nel senso che aumenta la percezione dei bisogni insoddisfatti
e con essa la percezione di deprivazione relativa, cioè di vivere peggio della media dei propri
concittadini, ma soprattutto di tipo relazionale (allentamento dei legami parentali, sparizione dei
rapporti di vicinato, riduzione delle reti amicali). Si sono, inoltre, diffuse nuove patologie sociali,
come la tossicodipendenza, e nuove “epidemie”, come la violenza diffusa e gratuita nei confronti di
persone e cose. Nella logica riparativa, cioè di predisposizione degli interventi dopo che si è
manifestata la patologia o il problema, che è tipica del welfare state, il crescere di questi fenomeni
tende a indurre un continuo aumento delle spese per nuovi servizi, che molto spesso dimostrano di
non essere in grado di risolvere i problemi. In altri termini, si potrebbe dire che di fronte al
modificarsi della fenomenologia dei bisogni, il modello tradizionale di politica sociale mostra utilità
marginali descrescenti, cioè un saldo costantemente negativo fra costi e benefici.
g) la modificazione del sistema occupazionale. In tutti i paesi avanzati è da anni in corso una
transizione dal modello “fordista” a quello “postfordista”. Per quanto riguarda il mercato del lavoro,
questa transizione implica la riduzione dell’occupazione sia nel settore primario (agricoltura) sia in
quello secondario (industria), mentre cresce il settore dei servizi sia di tipo tradizionale che di tipo
avanzato, cioè legati all’utilizzo delle nuove tecnologie telematiche (terziario e quaternario o
terziario avanzato). Questi cambiamenti rendono relativamente marginali, anche sul piano
quantitativo, le classi sociali che più hanno voluto e difeso il modello di stato sociale (cioè la classe
operaia e il ceto medio dipendente con carriera relativamente stabile) e i sindacati che li
rappresentano. Le categorie emergenti sono quelle del lavoro autonomo o a forte mobilità, categorie
che sono meno sindacalizzate e meno favorevoli alla logica del welfare tradizionale basata su
prestazioni standardizzate, anche perché caratterizzate da percorsi lavorativi che saranno sempre
più differenziati e che pertanto necessitano di forme di garanzia molto più flessibili e
individualizzate. Le modificazioni accennate hanno riflessi importanti anche sulla famiglia. Ne
sottolineo due, che mi sembrano i più rilevanti: la forte riduzione del tipo di famiglia che costituiva
l’asse portante del modello di welfare state, cioè la famiglia che fa capo al male breadwinner, cioè
al capofamiglia maschio unico procacciatore di reddito; la crescita della partecipazione femminile al
mercato del lavoro e il continuo aumento della loro capacità di guadagno che ne riduce la
dipendenza.
h) individualismo e privatismo. Anche come conseguenza dei cambiamenti che stanno interessando
il mondo del lavoro, si stanno diffondendo molto velocemente orientamenti “culturali” favorevoli
ad un ancor più marcato individualismo e privatismo. Essi producono una riduzione del consenso
non solo nei confronti dei programmi e delle prestazioni dello Stato sociale, che sono percepite
come eccessivamente standardizzate e burocratizzate rispetto alle situazioni estremamente
differenziate prodotte dall’estendersi delle forme di flessibilità lavorativa, ma pure nei confronti di
quelle politiche di solidarietà che favoriscono gruppi della popolazione le cui condizioni di
debolezza possono, almeno in certa misura, essere imputate a comportamenti “colpevoli” o non
legittimi, ad esempio alcolizzati, senza fissa dimora o immigrati clandestini. In questo senso si può
dire che a un livello più profondo sta andando in crisi l’idea di solidarietà sociale che sta alla base
della concezione e delle pratiche dello Stato sociale tradizionale.
4. Gli approcci attuali alle politiche sociali.
5
Contrariamente a quanto previsto dagli studiosi di orientamento marx-leninista e radicale, la
crisi del welfare state non ha prodotto sconvolgimenti di tipo rivoluzionario, capaci di rimettere
radicalmente in discussione la logica dell’economia capitalistica, nè forti innovazioni teoriche che
possano essere considerate indicatori di reale discontinuità rispetto al paradigma moderno, ma
piuttosto l’avvio di ipotesi e proposte politiche che hanno cercato di rilanciare e valorizzare l’altro
polo della dicotomia su cui si è strutturato il paradigma moderno, cioè il mercato.
4.1. Il primo orientamento, che potremmo definire “neoliberista-repubblicano”3, è quello che
si è affermato a livello ideologico in Gran Bretagna e negli Stati Uniti con i governi Thatcher e
Reagan. Dal punto di vista etico il principio che deve guidare la riorganizzazione delle politiche
sociali per i sostenitori di questo approccio è la “privatizzazione della responsabilità” (Rodger
2004:13), nel senso che spetta ai singoli individui, non alla società, il dovere di rispondere ai propri
bisogni sociali mobilitando le due risorse che hanno a disposizione: l’inserimento nel mercato
attraverso il lavoro e l’appartenenza alla famiglia ed alla comunità. Da questo punto di vista il
problema, sottolineato dalla maggior parte degli autori, è che l’invadenza dello stato sociale ha
prodotto una perdita di funzioni della famiglia e un conseguente indebolimento della sua coesione
interna (Popenoe 1988; Cheal 1991), così come una crescente diffusione di comportamenti
opportunistici da parte di chi gode dei benefici di welfare (Sorensen 1998), che servono ormai ad
integrare il reddito senza aumentare l’impegno sul mercato del lavoro, più che a soddisfare autentici
bisogni sociali. Si pone, quindi, un problema di “rimoralizzazione” della società, cioè della
riscoperta da parte sia delle famiglie che delle comunità di valori forti di impegno e solidarietà, e da
parte dei singoli individui dell’impegno per il lavoro. Il compito della società, in questo disegno, è
di offrire le opportunità perché questi valori possano concretizzarsi e tradursi in pratiche diffuse e
condivise. Per quanto riguarda gli apparati creati dal welfare state, i sostenitori di questo approccio
hanno suggerito il passaggio da un sistema basato sulla dominanza della fornitura pubblica dei
servizi, ad un sistema misto (welfare mix) , che potremmo definire più precisamente welfare mix
competitivo. Tale sistema è caratterizzato dai seguenti elementi:
- distinzione netta fra funzione di finanziamento (che resta in gran parte in capo allo stato),
funzione di gestione (sempre più affidata ad organizzazioni di terzo settore e anche di
mercato), funzione di acquisto (che viene parzialmente o totalmente affidata agli utenti che,
nel caso non siano in grado di svolgerla, devono poter contare su operatori di sostegno o
case managers);
- misure di sostegno economico sia alle famiglie che alle imprese di servizio, al fine di
allargare la domanda e di aumentare l’offerta in modo tale da rendere effettiva la possibilità
di scelta;
- tipi di regolazione che consentano l’avvio di forme di concorrenza fra i produttori di servizi.
Proprio quest’ultimo punto ha portato recentemente qualcuno a definire il nuovo “modello”
anche come “mercato sociale dei servizi” (C. Ranci (a cura di) 2001), dove l’aggettivo “sociale”
vuole richiamare sia l’esigenza di una regolazione pubblica che garantisca l’equità del sistema e
il mantenimento del vincolo di solidarietà, sia il fatto che si tratta di un mercato speciale in cui
risorse “sociali” come la responsabilità, il legame fiduciario e la solidarietà giocano un ruolo
centrale.
4.2. E’ noto che sul piano operativo i governi conservatori della signora Thatcher sono
riusciti a modificare solo modestamente il sistema inglese delle politiche sociali e, soprattutto, che
le riforme avviate hanno avuto impatti molto modesti sulla riduzione della spesa sociale. Tuttavia
3
Uso il termine repubblicano nel senso che ha assunto nella tradizione politica degli Stati Uniti di valorizzazione degli
aspetti morali e delle virtù civiche. Credo sia importante affiancare questo aggettivo a quello con cui solitamente viene
indicata questa posizione, perché facendo riferimento solo al liberismo, che postula la riduzione dell’azione regolativa
dello stato sul mercato e sulla società, non si coglie l’aspetto di riscoperta dei valori morali che, invece, connota
fortemente l’approccio neoliberista adottato dai governi della signora Tatcher e del presidente Reagan e che lo distingue
dal liberismo della Scuola di Chicago, rappresentato in modo egregio da M.Friedman (1987), fondato esclusivamente
sul razionalismo utilitaristico del calcolo costi benefici e sulla libertà di scelta.
6
l’importanza del nuovo approccio si può apprezzare maggiormente se ne consideriamo una variante
spuria, quella elaborata dagli esperti del New Labour inglese che Donati, evidenziando il gusto postmoderno della contaminazione fra due tradizioni di pensiero che si sono contrapposte per tutto il
periodo moderno (liberalismo vs. socialismo e collettivismo vs. individualismo), ha definito lib-lab,
e che potremmo caratterizzare anche come welfare mix cooperativo, per distinguerlo dal modello
realizzato dal governo conservatore. Nella posizione che emerge dai documenti ufficiali (i
cosiddetti Green Papers) e da svariate iniziative legislative, anche i neo-laburisti ammettono che la
politica sociale attuata col regime di welfare state ha influenzato negativamente il comportamento
dei cittadini, incentivando atteggiamenti di passività e di dipendenza e disincentivando negli
assistiti la ricerca del lavoro e le responsabilità nei confronti della famiglia. Ad esempio, i sussidi di
disoccupazione o per infortunio o per inabilità si sono trasformati in un espediente per facilitare il
passaggio dalla lista di disoccupazione al prepensionamento anche per chi aveva ancora la capacità
di lavorare. Si pone, quindi, il problema di affermare un nuovo modello di cittadinanza sociale che
produca una “adeguata corrispondenza tra diritti e responsabilità”.4 Nello stesso documento si
sostiene anche l’esigenza di una rifondazione dello stato sociale sulla base dell’etica del lavoro che
richiede, a tutti coloro che possono, di cercare attivamente occasioni di lavoro e/o di formazione, di
cogliere ogni opportunità per diventare indipendente, di garantire un sostegno adeguato ai propri
familiari, non solo in termini reddituali; di accumulare risparmi, se possibile, per garantirsi il futuro,
di evitare di defraudare i contribuenti adottando comportamenti scorretti. Le responsabilità, però,
non sono solo individuali, ma riguardano ogni ambito della vita sociale. La società, intesa come
l’insieme delle reti di sostegno e di servizio create dalle famiglie, dal vicinato e dalla comunità
allargata, quindi anche dalle imprese, ha la responsabilità di cooperare con l’ente pubblico nel
sostegno dei membri deboli, di promuovere l’indipendenza economica delle famiglie attraverso
l’inserimento lavorativo e di contribuire a creare un tessuto sociale forte e coeso, fatto tanto di diritti
quanto di doveri o responsabilità. Posizioni non molto distanti da queste sono state fatte proprie
anche da governi di paesi di lunga tradizione welfarista come la Svezia e i Paesi Bassi.
5. Le politiche sociali nella prospettiva della DSC
Per capire quale sia la posizione della DSC sui nostri temi il documento principale cui fare
riferimento è la Centesimus Anns di Giovanni Paolo II (1991) Al par. 48, in cui l’Enciclica tratta
del ruolo dello Stato nel settore dell’economia, il Papa si riferisce esplicitamente allo “Stato del
benessere”, cioè al welfare state e ne da un giudizio. Da una parte esso ha rappresentato il modo più
adeguato attraverso cui si è risposto “a molte necessità e bisogni, ponendo rimedio a forme di
povertà e di privazione indegne della persona umana” (48) D’altra parte, esso ha registrato “eccessi
ed abusi” che hanno provocato molte critiche e che lo hanno trasformato in “Stato assistenziale”. Il
Papa sostiene che le disfunzioni e i difetti dello Stato assistenziale dipendono da una inadeguata
comprensione dei compiti propri dello Stato che ha portato a non rispettare il principio di
sussidiarietà. “Intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale
provoca la perdita di energie umane e l’aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da
logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gl utenti, con enorme crescita delle
spese.”(48)
Utilizzando una terminologia più vicina al linguaggio delle scienze sociali potremmo dire che
l’Enciclica ha alla base una rappresentazione della società attuale come un sistema articolato in
quattro sfere o settori altamente differenziati. Queste sfere sono: la politica, entro la quale troviamo
gli attori che agiscono nell’ambito della protezione sociale per conto o in rappresentanza dello
Stato; l’economia di mercato, entro cui operano come attori le imprese a scopo di lucro e le
associazioni di tutela degli interessi (organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria); il
terzo settore-privato sociale, dove operano le associazioni di tutela e promozione del benessere delle
La citazione è tratta da un documento prodotto dall’amministrazione laburista col titolo New ambitions for our
country: a new contract for welfare, Stationery Office, London 1999.
4
7
persone e dei gruppi svantaggiati o in difficoltà e le imprese non profit, cioè senza scopo di lucro; i
mondi della vita quotidiana, dove operano le famiglie e le reti informali di sostegno.
Con l’affermarsi del welfare state, le società moderne hanno aumentato progressivamente il livello
di benessere dei cittadini affidando molti dei compiti e delle funzioni che precedentemente erano
svolti dalle famiglie e dalle organizzazioni caritative e mutualistiche alla sinergia fra mercato, il cui
compito era produrre ricchezza, e Stato, cui spettava il compito di redistribuire la ricchezza secondo
criteri di equità. Gli effetti positivi del welfare state in termini di integrazione sistemica5 non si
sono,però, tradotti in un equivalente rafforzamento dell’integrazione sociale ma, anzi, in un
“rinsecchimento”, se non in una vera e propria “colonizzazione” dei mondi vitali e del senso di
solidarietà diffuso negli ambiti di società civile, per cui il tipo di società prodotta dal welfare state
non è stato quello previsto dai riformisti alla Titmuss, nel senso che non si è caratterizzato per una
crescita del senso morale dei cittadini e per il relativo superamento dei particolarismi, ma ha creato
una società in cui si sono verificati anche: una “rivoluzione delle aspettative crescenti”; nuovi tipi di
conflitti legati a problemi di genere, di generazione e di appartenenza culturale; nuove povertà
dovute alla solitudine e all’emarginazione sociale e vere e proprie trappole dell’assistenza. Di
fronte alle crescenti difficoltà a perseguire l’ obiettivo del benessere nelle nuove condizioni create
dal trasformarsi della società da moderna e industriale in dopo-moderna e post-industriale o postfordista, il binomio stato-mercato è sempre più ricorso all’aiuto delle famiglie, delle loro reti
informali e delle nuove espressioni della solidarietà sociale, ormai tradizionalmente denominate in
modo sintetico TS o Privato-sociale, mantenendo, però, nei loro confronti un rapporto di
subordinazione. Intrappolato entro la cultura lib-lab, il sistema politico e molta parte del sistema
delle scienze sociali tende a considerare e ad usare strumentalmente questi attori in funzione di
riduzione dei costi, come è documentato dalle gare di appalto dei servizi lanciate col criterio del
massimo ribasso, o per scaricare compiti e funzioni che non riesce momentaneamente a svolgere
per questioni contingenti. In questo modo ciò che si ottiene di fatto è l’ indebolimento invece che il
rafforzamento delle sfere del TS e delle reti informali, per cui alla lunga lo stato assistenziale
consuma le risorse di solidarietà esistenti senza riuscire a produrne di nuove. La conclusione che si
può trarre dall’analisi è che per conservare o possibilmente incrementare il capitale sociale della
solidarietà è necessario ripensare le relazioni fra le sfere sociali alla luce di un principio nuovo
capace di salvaguardare l’autonomia di ciascuna sfera sociale e, contemporaneamente di metterle in
connessione. In termini concreti ciò significa che la politica sociale, cioè la produzione di
condizioni di benessere, non può restare più una prerogativa dello Stato ma deve diventare una
funzione sociale diffusa (è in questo senso che si parla anche di passaggio dal welfare state alla
welfare society o di welfare societario), che ciascuna sfera perseguirà seguendo le proprie specifiche
modalità e caratteristiche e usando i propri mezzi simbolici e valori-guida. Ad esempio, è evidente
che le imprese che hanno bisogno di lavoratori extracomunitari per continuare a produrre non
possono scaricare il problema della casa per questi lavoratori chiamando in causa lo Stato o il
volontariato. Questo problema di politica sociale deve diventare una responsabilità propria della
sfera economica che cercherà di rispondervi utilizzando il proprio codice e costruendo relazioni con
tutti gli altri soggetti (stato, TS, famiglie) che possono contribuire a risolvere il problema fornendo
ciascuno le proprie specifiche risorse. A questo proposito oggi si comincia a parlare di corporate
welfare, cioè di welfare di impresa o delle imprese. Intraprendere questa strada produrrà come
conseguenza una maggiore differenziazione delle politiche sociali e, quindi, una de-regolazione
delle misure di protezione sociale se con questo si intende il passaggio da schemi validi su tutto il
territorio nazionale a schemi diversificati in base alle condizioni di contesto. Ma in questa
prospettiva la rinuncia all’universalismo formale dei programmi e delle norme del welfare state
tradizionale si giustifica per il fatto che consente di realizzare l’universalismo in senso letterale e
La letteratura anglosassone parla del periodo corrispondente all’espansione del modello di welfare state come dei
“trent’anni gloriosi” (1945-1975) perché caratterizzanti da una costante crescita economica dei paesi dell’area europea e
da un livello molto basso di conflitto sociale.
5
8
sostanziale, cioè come convergere di tutte le risorse disponibili verso la soluzione del problema o il
perseguimento dell’obiettivo.
La condizione perché questa convergenza si realizzi è l’adozione di un adeguato “principio
architettonico”, cioè di un criterio che consenta di mettere in atto le giuste forme di cooperazione e
di valutarne l’adeguatezza nei casi di conflitto o di insoddisfazione da parte di una delle parti in
causa. Tale principio è individuato nel concetto di sussidiarietà.
6. Come va inteso il principio di sussidiarietà
Nella formulazione che ne ha dato la Dottrina Sociale cristiana6, il principio di sussidiarietà obbliga
coloro che ne sono destinatari sia all’azione che all’autolimitazione. Obbliga, infatti, la Comunità
europea, gli Stati nazionali, le Regioni, i Comuni, e gli altri enti territoriali o funzionali, ad aiutare
le famiglie e le formazioni sociali, così da metterle in condizione di sostenere i singoli cittadini
nello sviluppo di una vita degna dell’ uomo (funzione promozionale). Nello stesso tempo proibisce
a questi stessi destinatari di intervenire nell’ambito di vita e di azione delle famiglie e delle
formazioni sociali se queste sono nella condizione di regolarsi autonomamente e di gestire in
proprio i loro compiti (funzione protettiva). Se invece non ce la fanno e non riescono, ad esempio, a
far fronte agli impegni educativi o assistenziali che la situazione richiede, il principio di
sussidiarietà impone alle istituzioni di assumere su di sè questi compiti, ma secondo una modalità
che tenda all’obiettivo di rafforzare le energie e le capacità dei soggetti in difficoltà, in modo da
aumentarne l’autonomia, intesa non come autoreferenzialità, ma come capacità di scegliere il
servizio con cui entrare in relazione per farsi aiutare. (Donati, 1997)
Abbiamo detto che il principio di sussidiarietà possiede una duplice dimensione: una che attiva lo
Stato o altro destinatario, l’altra che limita questo intervento o protegge nei confronti di questo
intervento. Molto spesso negli ultimi anni, anche per motivi oggettivi di ipertrofia
dell’interventismo statale, è stata sottolineata solo la seconda dimensione, quella protettiva, con il
risultato di far coincidere il principio di sussidiarietà con una politica liberista di privatizzazioni e di
ridimensionamento dell’intervento statale. Questa concezione del principio di sussidiarietà non gli
rende giustizia. Una società giusta, infatti, deve soddisfare sia la dimensione protettiva che quella
promozionale.
Esiste, però, anche una terza dimensione del principio, che potremmo definire funzione di
responsabilizzazione degli attori. Essa difende lo Stato e gli altri enti e soggetti che hanno il dovere
della sussidiarietà da un sovraccarico di compiti. Nel principio, infatti, è contenuto un obbligo di
respingere i compiti, e i relativi oneri, che singoli cittadini o comunità subordinate pretendono di
scaricare sulle comunità maggiori, in particolare sullo Stato, pur essendo in grado di assolverli. Su
questa base, ad esempio, lo Stato si può difendere dalla pretesa di togliere alle parti sociali il
problema di chiudere una trattativa contrattuale, pretesa che una delle stesse parti in causa può
avanzare, e di assumersi la responsabilità che ne deriva. Inoltre, il principio di responsabilizzazione
degli attori difende lo Stato sociale e il suo sistema di prestazioni da un eccesso di
rivendicazionismo, dato che parte dalla premessa antropologica secondo la quale la responsabilità
primaria nell’ impostazione della propria vita spetta alla persona e alle relazioni di mondo vitale
prossime alla persona, cioè alla famiglia e alle formazioni sociali. Anche questa dimensione del
principio di sussidiarietà può essere facilmente equivocata, nel senso che si presta a legittimare
comportamenti evasivi. Ad esempio, da parte del Ministro delle Finanze si potrebbe utilizzare il
6
Il principio di sussidiarietà è stato esplicitamente formalizzato nell’ Enciclica Quadragesimo Anno di papa Pio XI,
pubblicata nel 1931. In quell’Enciclica il principio è formulato così:
”Siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l’industria propria per
affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori
comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società, perchè
l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del
corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle.”(n.80)
9
richiamo alla responsabilità primaria dei soggetti sociali per evitare di intervenire nei confronti di
richieste giuste ma molto onerose per le casse dello Stato. Così non può essere, perchè il principio
di sussidiarietà non può essere separato da quello di solidarietà che, appunto, impone l’aiuto in caso
di effettivo e accertato bisogno.
In sintesi possiamo dire che l’interpretazione corretta del principio di sussidiarietà chiede
alle istituzioni (Comunità Europea, Stati-nazione, Regioni, eccetera) di pensarsi e di agire al
servizio della crescita della società civile. Proprio perchè devono coltivare il bene comune, che non
deriva automaticamente, per un processo del tipo “mano invisibile”, dalla molteplicità degli
interessi perseguiti da persone e gruppi, le istituzioni pubbliche devono intervenire nella società ma
per sostenere e stimolare i sottosistemi sociali e, in definitiva, i cittadini nella disponibilità a
sviluppare iniziative proprie e a compiere sforzi per migliorare le loro prestazioni.
7. Sussidiarietà orizzontale, sussidiarietà verticale.
Fino ad ora abbiamo parlato di sussidiarietà riferendoci, sulla traccia dei documenti proposti
dalla Dottrina sociale, al modo di costruire le relazioni fra istituzioni e società civile o fra attori
pubblici e attori privati. La diffusione del concetto anche al di fuori dell’area cattolica, ha fatto sì
che a questo riferimento se ne aggiungesse un altro che riguarda specificamente la relazione
all’interno delle istituzioni pubbliche. Tutto ciò che comuni, provincie, regioni, stati nazionali
possono decidere e realizzare autonomamente non può essere rivendicato né in sede regolativa né in
sede operativa dall’ente di grado superiore, a meno che l’ente minore non dimostri una manifesta
incapacità. La Carta Europea, il documento che definisce i diritti e i principi fondamentali
riconosciuti da tutti i paesi che aderiscono all’Unione, esprime il concetto nei termini seguenti:
“l’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle
autorità più vicine ai cittadini.”(art. 4)7 Per indicare questo secondo riferimento è invalso l’uso di
affiancare al termine sussidiarietà l’aggettivo “verticale”, mentre si parla di sussidiarietà
“orizzontale” quando ci si riferisce alla relazione fra istituzioni e società civile.
La sussidiarietà verticale esige che agli enti minori vadano lasciati non solo competenze giuridiche
e diritti di iniziativa, ma anche i mezzi finanziari ed amministrativi necessari all’organizzazione e
all’esercizio concreto di queste facoltà. Essa impone, quindi, una suddivisione dei poteri legislativi
in legislazione esclusiva e legislazione concorrente, così come una suddivisione dei mezzi fiscali e
di bilancio fra i diversi enti territoriali e lo Stato. Da questo punto di vista l’adozione del principio
di sussidiarietà tende a privilegiare i modelli istituzionali di tipo federalista.
8. Le “trappole” della sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà non è una formula giuridica immediatamente applicabile, ma un
principio costituzionale e regolativo che deve essere interpretato. Lo ha dichiarato il Consiglio
europeo di Edimburgo, nel cui documento finale si dice che quello di sussidiarietà è:”un principio
dinamico che dovrebbe venire applicato alla luce degli obiettivi che un trattato si pone. Permette
l’ampliamento dell’attività della comunità, se le circostanze lo esigono, o, al contrario, anche la sua
limitazione o sospensione, se essa non è più giustificata.” In altri termini, si può dire che quello di
sussidiarietà è un principio di competenza che non definisce nel contenuto ciò che le singole entità
sociali devono perseguire come valori e obiettivi. Questi dipendono dalla comprensione che la
società ha di se stessa e non possono essere prodotti o imposti dalla Stato o, domani, dalla Comunità
europea. Indica, invece, il criterio fondamentale di azione di ogni istituzione o sottosistema sociale,
che è il sostegno: ogni istituzione è tenuta ad intervenire a sostegno dell’altra, quando quest’ultima
non riesce a portare a termine il proprio compito, in un modo che le consenta di aumentare il
7
Lo stesso concetto è stato inserito con formulazione praticamente identica nel paragrafo 12 del Preambolo del Trattato
costituzionale dell’ Unione europea.
10
proprio grado di autonomia. Ma questo vale per tutte le istituzioni e le formazioni sociali, in forma
mutua e reciproca, e non solo per lo Stato rispetto alla società civile.
Nel dibattito svoltosi finora a livello europeo e nelle decisioni che sono state prese, questa
ambivalenza fra dimensione positiva e negativa rimane problematica. Soprattutto manca
l’indicazione che anche il trasferimento di competenze ai livelli superiori della comunità è legittimo
solo nel caso in cui la comunità utilizzi queste competenze per rafforzare i livelli inferiori, cioè stati
membri o regioni, in modo che questi a loro volta possano rafforzare le articolazioni sottostanti e, in
ultima analisi, le possibilità di sviluppo dei cittadini. Nell’articolo 3b del trattato di Maastricht
manca proprio questo obiettivo del principio di sussidiarietà. Il testo recita: “la comunità agisce
secondo il principio di sussidiarietà se e nella misura in cui gli obiettivi delle manovre considerate
non possono essere raggiunti sufficientemente al livello degli stati membri e quindi, in virtù della
loro portata e dei loro effetti, possono essere meglio conseguiti a livello comunitario”. Questo
significa elevare il principio di efficienza a criterio unico della divisione delle competenze. Si tratta
di un approccio riduttivo. Il principio di sussidiarietà è sì uno strumento che trasforma il postulato
dell’efficienza nella regola della divisione del lavoro tra diversi livelli amministrativi, ma è
soprattutto un principio di filosofia sociale che suppone, nel solco della migliore tradizione culturale
europea, un concetto personalistico dell’uomo, per cui il criterio di legittimazione delle scelte di
accentramento o di decentramento in ultima istanza deve rimanere lo sviluppo personale dei
cittadini attraverso il rafforzamento dei gruppi sociali entro cui articolano la propria vita. Il
principio di sussidiarietà, quindi, va reso funzionale al perseguimento del bene comune, che è
definibile come l’insieme delle condizioni sociali e politiche che rendono possibile lo sviluppo
personale dell’uomo, con i conseguenti diritti e doveri.8
Tali condizioni non consistono, contrariamente a quanto propongono i sostenitori dell’ etica
pubblica razionale, nell’ aiutare lo sviluppo di sentimenti altruistici o di moderazione dell’egoismo,
o processi di identificazione empatica o simpatetica, ma nel riconoscimento del carattere
intrinsecamente relazionale della persona e della società, da cui consegue, come valore-guida della
politica, la scelta della tutela e della promozione della persona nelle formazioni sociali primarie in
cui è inserita.
La consapevolezza di questo criterio ultimo di legittimità delle scelte di
accentramento/decentramento non eviterà certamente la nascita di controversie e di conflitti. Potrà,
però, servire a comporle in modo positivo.
9. L’applicazione del principio alla rifondazione dello Stato sociale.
Dal momento che il modello di welfare più diffuso in Europa è stato quello che, facendo
riferimento alle tipologie presentate nel paragrafo 1, possiamo chiamare “istituzionale” o “quasitotale”, la riforma delle politiche sociali ha significato nella maggior parte dei paesi europei un
processo di trasformazione molto ampio dei sistemi esistenti, specie nella direzione di lasciare
spazio alle organizzazioni di TS che, in modi diversi, sono state prodotte dalle formazioni sociali
intermedie (famiglie, chiese, associazioni ecc.) entro cui, secondo l’art. 2 della Costituzione italiana,
si realizza lo sviluppo personale dei cittadini. Se ne potrebbe concludere che, anche se il termine
non è sempre utilizzato, oggi sul principio di sussidiarietà come criterio guida della rifondazione dei
sistemi di welfare esiste un consenso quasi generale. E’ però ormai evidente che dietro l’apparente
unanimismo si nascondono (o si manifestano) approcci molto diversi che portano ad esiti altrettanto
diversificati.
Mi pare che si possano tipologizzare tre diverse possibili concezioni dell’applicazione del
principio di sussidiarietà alle relazioni col privato sociale e , più in generale, con le organizzazioni
private.
Un primo orientamento, che potremmo definire privatistico, parte dal presupposto della
inefficienza del modello burocratico tipico della Pubblica Amministrazione. Secondo i sostenitori di
8
Per un approfondimento del concetto e sue delle relazioni con gli altri temi della DSC rinvio alla voce Bene Comune
dell’indice analitico del Compendio della DSC, pp. 360-361.
11
questo orientamento, il modello burocratico pubblico è molto costoso, quindi incompatibile con un
livello accettabile di tassazione, di indebitamento pubblico e, ultimamente, di sviluppo economico
sostenuto; è,inoltre, rigido, quindi poco capace di rispondere flessibilmente al modificarsi dei
bisogni. Si caldeggia, pertanto, l'affidamento sempre più esteso della gestione dei servizi alle
organizzazioni private, sia di profitto che non-profit, mentre il pubblico dovrebbe riservarsi compiti
di supporto finanziario, di controllo, di garanzia della qualità e affidabilità dei servizi e di intervento
“in ultima istanza” nei confronti di quei problemi o di quelle situazioni per le quali le famiglie, le
associazioni e le organizzazioni non riescono a trovare risposte. La scelta favorevole alla
privatizzazione viene motivata con ragioni economiche (riduzione dei costi), etiche (maggiore
responsabilità sociale), politiche (riduzione del sovraccarico funzionale dello Stato).
L' orientamento istituzionale, invece, insiste sul fatto che la legittimità della politica
pubblica dipende dalla capacità di soddisfare le domande dei cittadini. Di conseguenza il contributo
dei soggetti privati, in particolare quello del Terzo Settore, consiste solo nell' integrare o
“sussidiare” le prestazioni dei servizi pubblici, permettendo di aumentarne l' efficacia e l'efficienza
anche grazie al minor costo. In questa prospettiva il problema cruciale diventa quello della
regolazione nel senso che le attività di questi soggetti, pur nel rispetto formale del principio di
autonomia e di autogoverno, devono poter essere influenzate attraverso meccanismi di premio/
sanzione in modo da renderle coerenti con gli obiettivi della programmazione pubblica.
L' orientamento del pluralismo societario parte dalla constatazione che il modello "quasitotale" di welfare state non solo non riesce più a gestire in modo adeguato ed efficace i servizi
sociali e sanitari, ma agisce come fattore di compressione delle emergenti organizzazioni
"intermedie" fra Stato e cittadino. Il Terzo Settore, infatti, pur nella sua complessa articolazione,
rappresenta un nuovo progetto sociale e umano che esprime un modo nuovo di vivere in società e di
fare società, nella misura in cui mette al primo posto “il senso della dignità umana, la solidarietà, il
nesso fra libertà e responsabilità, assumendosi l’onere di una piena autonomia che si legittima in
quanto realizza il bene comune”
Lo Stato dovrebbe raccogliere e valorizzare tutti i movimenti della società che stanno
sperimentando forme nuove di solidarietà e di aiuto per finalizzarle alla costruzione di una welfare
society. Per far questo lo Stato deve promuovere il Terzo Settore con una regolazione che, evitando
la tentazione di adottare un principio di sussidiarietà rovesciato, che legittima il Terzo Settore nella
misura in cui serve a coprire i deficit dello Stato, lo riconosca per quello che è e lo valorizzi
concretamente, mettendo a sua disposizione gli strumenti regolativi e fiscali necessari, ma non
sufficienti, per realizzare “una società intesa come luogo di incontro, di co-esistenza, di cooperazione, di produzione di beni comuni fra persone che vogliono accrescere, non diminuire, la
loro umanità.”
Nel linguaggio dei giuristi si potrebbe dire che per chi sostiene l’approccio del pluralismo societario
è necessario passare da un regime “concessorio” ad un regime “normativo” o di riconoscimento.
Con questi termini si intende che i soggetti di TS per avere una personalità giuridica non
dovrebbero più sottostate ad un processo di autorizzazione da parte dello stato che “concede” loro il
diritto ad esistere e ad agire, ma dovrebbero essere inquadrati in un regime che li riconosce per
quello che sono, fatti salvi i criteri di liceità, e che richiede loro solo l’adempimento di alcune
procedure.
In questa prospettiva, infine, l’ente pubblico, ai vari livelli istituzionali, non deve concepirsi
innanzitutto come gestore diretto delle politiche sociali ma piuttosto come ordinatore generale che
prende decisioni vincolanti per la comunità di riferimento.
5. L’applicazione del principio di sussidiarietà nella legge 328 di riforma dell’assistenza.
12
Dopo una lunghissima gestazione, l’8 novembre del 2000 il Parlamento ha approvato una
legge-quadro di riforma dell’assistenza, denominata “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.”(L. 328/2000)
Quale dei tre approcci al tema della sussidiarietà ha fatto proprio la legge 328?
Mi pare di poter dire fondamentalmente il secondo, cioè quello istituzionale, con qualche apertura
in direzione del terzo. Vorrei ora documentare questa affermazione entrando nel merito
dell’articolato della legge.
La Legge quadro riprende la definizione di "servizi sociali" già fornita dal Decreto legislativo
112/1998 (art. 128). Vi rientrano quindi tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione
di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse
soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in
sede di amministrazione della giustizia. Alle persone e alle famiglie dovrà essere garantito un
“sistema integrato di interventi e servizi sociali”, promovendo interventi finalizzati a garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza. Questo sistema
dovrà riuscire a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia.
La legge quadro insiste sul concetto di "sistema integrato"; poiché l’intento è quello di evitare
"sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte", ma anche di ottimizzare le
risposte integrando prestazioni di tipo economico con i servizi alla persona e alla comunità. L’art. 1
comma 3 sancisce che gli attori, cioè chi programma e organizza il sistema dei servizi, sono gli enti
pubblici (Comune, Regione, Stato), secondo il principio della sussidiarietà verticale affermatosi con
le leggi Bassanini e recepito nella riforma ter della sanità.
Spetta a questi enti (comma 4) riconoscere e agevolare un ruolo di programmazione e
organizzazione degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione,
delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato nella
programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali. La società civile, quindi, non ha titolarità ma viene fatta partecipare, secondo una logica che
è difficile considerare innovativa rispetto a quanto già acquisito con la normativa degli ultimi
decenni.
I soggetti di TS hanno invece titolarità, assieme agli enti pubblici, per la gestione dei servizi(comma
5). Viene, quindi, confermata la linea degli ultimi anni sulla privatizzazione o esternalizzazione
della gestione dei servizi di assistenza, rispetto alla quale si sottolinea la necessità che le gare di
appalto integrino il criterio del massimo ribasso con elementi di valutazione della qualità dei
servizi. Anche su questo aspetto il modello di riferimento della legge è la riforma ter della sanità.
Risultano significative le ultime righe del comma 5, dove si dice: “Il sistema integrato di interventi
e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione
delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della
solidarietà organizzata.” E’ evidente, infatti, che se il sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali ha tra i suoi scopi “anche” la valorizzazione di queste attività, queste stesse non ne fanno
parte. Si configura quindi un modello duale di assistenza costituito da una parte pubblica (il sistema
integrato, di cui fa parte anche il privato accreditato) e dalla solidarietà privata delle famiglie e delle
persone, che il sistema può/deve valorizzare.
All’art. 2 viene ribadito il carattere universalistico del diritto all’assistenza, sulla linea del
modello istituzionale di welfare, ma si corregge il vecchio criterio teoricamente onnicomprensivo
(dare tutto a tutti) adottando il principio che qualcuno ha chiamato dell’ “universalismo sostenibile”,
che si basa sull’idea di garantire l’essenziale a tutti (Zamagni 1998). La legge, infatti, parla di
“livelli essenziali di prestazioni” da garantire a tutte le persone in condizioni di bisogno. I servizi
che definiscono questo livello essenziale e che devono comunque essere predisposti sono indicati
all’art. 22 e sono:
13
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari;
b) interventi per le situazioni di emergenza sociale, personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Tipici del modello istituzionale di welfare restano anche i metodi operativi (art.3) che
consistono nella programmazione democratica degli interventi e delle risorse, dove per democratica
si intende comprensiva sia di momenti di informazione che di momenti di concertazione con le
cosiddette forze sociali; nell’operatività per progetti; nella verifica sistematica dei risultati in termini
di qualità e di efficacia delle prestazioni. Il Governo dovrà approvare un Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali che indicherà le linee generali per la realizzazione degli interventi e
dei servizi sociali a livello locale. A tali indicazioni dovranno attenersi le Regioni che approveranno
a loro volta un proprio Piano. Infine, i Comuni, d’intesa con le Asl, dovranno fissare i loro obiettivi,
priorità, modalità organizzative in un Piano di zona. Anche su questo punto, però, si registra una
innovazione rispetto al modello istituzionale tradizionale, là dove si afferma come principio della
programmazione la necessità di garantire agli utenti un diritto di scelta fra una pluralità di servizi e
fra prestazioni economiche e servizi. Il principio trova una precisa concretizzazione all’art. 17 dove
si dice che i comuni possono concedere “titoli” validi per l’acquisto di servizi sociali, che possono
essere spesi rivolgendosi a soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali
oppure come sostitutivi di prestazioni economiche. I "buoni" devono essere richiesti dall’interessato
e non "imposti" dall’ente e inoltre non possono sostituire prestazioni economiche assistenziali quali
il minimo vitale, l’assegno o la pensione sociale. Anche su questi aspetti dovrà esserci un indirizzo
nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
Una innovazione terminologica significativa si trova all’art. 5 (Ruolo del terzo settore) dove
compare il termine “sussidiarietà” con riferimento alla relazione fra enti pubblici e società civile. La
dimensione della sussidiarietà verticale, quindi, viene incrociata con quella della sussidiarietà
orizzontale. Nell’articolo, infatti, si afferma che le istituzioni “per favorire l’attuazione del principio
di sussidiarietà” devono promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti di TS.
Dal disposto degli articoli successivi, però, si ricava l’impressione che le azioni sollecitate
coincidano di fatto con l’attività di regolazione-regolamentazione (per l’accreditamento, per le
tariffe, per il controllo di gestione, ecc.) Solo nel caso dei Comuni i due termini promozione
/regolazione-regolamentazione non sembrano coincidere. Infatti si dice (art 6, comma 3 a) ) che i
Comuni devono “promuovere… risorse delle collettività locali tramite forme innovative di
collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini
nell’ambito della vita comunitaria”. Qui si apre uno spazio di azione non regolativa ma di effettiva
sussidiarietà promozionale che potrebbe essere molto interessante ma che richiede da parte degli
operatori pubblici un tipo di competenze che non è scontato siano già presenti e acquisite. In questo
senso la parte della legge che richiama ad un forte coordinamento fra Università ed Enti territoriali
per la predisposizione di nuovi profili formativi per gli operatori di politica sociale risulta quanto
mai importante.
Pur movendosi nella logica del decentramento e della valorizzazione delle autonomie, l’intenzione
della legge è anche quella di assicurare una omogeneità e uniformità del livello delle prestazioni in
ambito nazionale, onde evitare sperequazioni fra una regione e l’altra. Gli articoli 6, 7, 8 e 9
definiscono, quindi, con precisione le competenze rispettivamente dei comuni, delle province, delle
regioni e dello Stato. Si ritorna anche sulla questione delle IPAB.
14
Nel corso degli anni Settanta e Ottanta sembrava che l’intenzione prevalente fosse quella della loro
soppressione e definitiva pubblicizzazione. La nuova norma, invece, riconosce loro un ruolo
importante, pur individuando la necessità di maggiori controlli sulla loro efficienza ed efficacia.
Data la difficoltà di regolare in dettaglio un universo complesso e fortemente differenziato al suo
interno, la legge indica solo i principi direttivi su cui dovrà basarsi il governo, delegato ad emanare
uno specifico decreto. Tali principi si fondano sul binomio: pieno inserimento delle IPAB nella rete
locale di servizi e prestazioni e valorizzazione della loro autonomia anche per il tramite
dell'adozione di profili istituzionali e modalità di gestione mirate alla produzione efficiente di
servizi. Si segnalano, fra gli altri, per le loro implicazioni innovative, i principi direttivi sulle IPAB
che gestiscono esclusivamente patrimoni, quelli sulle IPAB inattive, sulla possibile separazione
della gestione dei patrimoni dai servizi, sulla previsione di adeguate forme di controllo. L'assunto di
fondo è che i patrimoni finanziari e di competenza delle IPAB devono essere compiutamente
finalizzati, nel rispetto della volontà dei fondatori, alla produzione di servizi di qualità, all'interno
della rete locale d’interventi e servizi sociali. Anche le IPAB, come le Onlus o le organizzazioni di
volontariato, dovranno essere autorizzate e accreditate dai comuni per gestire servizi e strutture a
ciclo residenziale o semi-residenziale.
Passando al Capo III, relativo alle disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di
integrazione e sostegno sociale, gli interventi e i servizi che sono stati previsti sono: i progetti
individuali per le persone disabili; il sostegno domiciliare per le persone anziane non
autosufficienti; la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, che prevede
l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità
responsabile; politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura; servizi formativi ed
informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le
famiglie; servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in
particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure
particolari o per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro; prestazioni di
aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico; servizi per l'affido
familiare.
Un elemento innovativo si coglie all’art. 15 comma 3 dove si riserva una quota dei finanziamenti
statali ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e
programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l’autonomia delle
persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente familiare. L’elemento importante è che sia un
finanziamento riservato o ad hoc e che sia destinato solo a quei progetti che realizzano una duplice
integrazione, fra sociale e sanitario e fra pubblico e privato.
Una ulteriore elemento che potrebbe indicare discontinuità rispetto al modello tradizionale si può
cogliere all’art. 28 su “Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema”. Il comma 2, infatti,
mette su un piano paritario enti locali, organizzazioni di volontariato, Onlus e IPAB, come titolari
della possibilità di presentare alla regione progetti per la realizzazione di centri di pronta
accoglienza e di altri servizi, superando la necessità attualmente prevista che i soggetti di TS
presentino i loro progetti ai Comuni, solo ente autorizzato a richiedere finanziamenti alla regione.
A conclusione di questa analisi parziale si può dire, per quanto riguarda il profilo che qui ci
interessa, che la legge 328 resta sostanzialmente in un rapporto di continuità col modello di
sussidiarietà “istituzionale” costruito negli anni ’90, con qualche innovazione che pare recepire la
logica del pluralismo societario e che potrà o meno essere sfruttata dalle Regioni e dagli enti locali
in fase di implementazione della legge.
La valutazione appena proposta trova conferma in uno dei decreti attuativi predisposti dal Governo,
l’”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti
dall’art.5 della L.328/2000”, che riguarda in particolare il TS. Nel documento si definiscono i
15
criteri con cui Regioni e Comuni rispettivamente disciplinano e realizzano l’acquisto di servizi e
prestazioni o l’affidamento della gestione dei servizi a soggetti del TS e si assegna al volontariato la
possibilità di gestire, tramite convenzione, servizi “complementari”, a quelli che richiedono una
organizzazione complessa. Tali criteri sono chiaramente derivati dalla relazione fra Stato e mercato
o fra amministrazione pubblica e imprese, per cui rischiano di provocare l’ “isomorfismo
organizzativo” del TS, vale a dire la sua assimilazione culturale e organizzativa al mercato. Si pensi
che gli elementi “qualitativi” di cui i Comuni devono tener conto per selezionare i soggetti di TS da
cui acquistare o ai quali affidare i servizi sono le modalità adottate per il contenimento del turn over
degli operatori, gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, il rispetto dei trattamenti
economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e
assistenza, a cui si aggiunge, come unico elemento non direttamente ricavato dalle logiche di
mercato, la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della
comunità. Naturalmente non vogliamo dire che gli elementi indicati non siano importanti, ma che
non rispettano la specificità (cultura, normatività, organizzazione, ruolo societario) del TS e, quindi,
ne pregiudicano l’autonomia prefigurando le linee del suo sviluppo nella direzione di una ulteriore
assimilazione ai modelli dell’impresa for profit.
Anche in questo caso, però, troviamo un piccolo segnale di discontinuità rispetto al modello
“istituzionale”. L’Atto di indirizzo, infatti, prevede la possibilità che i Comuni, di fronte a
specifiche problematiche sociali, che si possono intendere o come forme nuove di disagio sociale o
come fallimenti delle risposte adottate nei confronti di problemi conclamati, indìcano “istruttorie
pubbliche”, cioè momenti aperti di confronto e di dialogo, finalizzati a progettare assieme al TS
interventi innovativi e sperimentali. Anche su questo aspetto il ruolo “sussidiario” dell’ente
pubblico rispetto alla comunità (sussidiarietà orizzontale) non è esplicitato. L’idea operativa che si
ricava dal testo è piuttosto quella di due soggetti che decidono un brain storming e, nel caso emerga
un’idea interessante, creano una joint venture per ridurre i rischi di entrata in un mercato nuovo e,
quindi, dagli esiti del tutto imprevedibili. Non è causale il ricorso che ho fatto a termini che sono
tipici della programmazione strategica e dell’economia aziendale. Ho voluto evidenziare, infatti,
come la cultura con cui si sta costruendo il nuovo sistema è ancora in gran parte interna alla
relazione Stato/mercato. Tuttavia, proprio perché è possibile che attraverso il dialogo si avvii un
processo di reciproco apprendimento, la previsione di queste “istruttorie” può essere considerata,
aldilà delle stesse intenzioni del legislatore una possibilità significativa per la trasformazione del
sistema italiano dei servizi in prospettiva sussidiaria.
Riferimenti bibiliografici
Abendroth, W.
1971 Storia sociale del movimento operaio europeo, Torino, Einaudi.
Archer, M.
1997 La morfogenesi della società, Milano, Angeli
Cheal, D.
1991 Family and the state of theory, London, Harvester Wheatsheaf
Colozzi, I.
2002 Le nuove politiche sociali, Roma, Carocci
Di Maggio, P, Powell W.
16
1983 The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in
organizational fields, in «American Sociological Review», 48, pp. 147-160
Donati, P.
1991 Teoria relazionale della società, Milano, Angeli
Donati, P.
1993 L’evolversi della politica sociale dalla prima industrializzazione alle società complesse:
concezioni e modelli, in Donati P. (a cura di), Fondamenti di politica sociale,Milano, Angeli, vol.1,
pp.19-47
Donati, P.
1997 Pensiero sociale e società post-moderna, Roma, editrice A.V.E.
Donati, P.
1998 Ripensare il welfare in Europa: oltre il lib/lab, verso un nuovo «complesso societario», in
«Sociologia e politiche sociali», 1, 1, pp.9-52.
Esping Andersen, G.
1990 The three worlds of welfare capitalism, Cambridge, Polity Press
Ferrera, M.
1993 Modelli di solidarietà, Bologna, Il Mulino
Friedman, M.
1987 Capitalismo e liberta, Pordenone, Studio tesi.
Giovanni Paolo II
1991 Centesimus Annus, Casale Monferrato, PIEMME
Habermas, J.
1975 La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Bari, Laterza
Hansmann, H
1986 The role of nonprofit enterprise, in Rose-Ackerman S. (ed.), The economics of nonprofit
institutions.Studies in structure and policy, New York, Oxford University
Hill, M.
1999 Le politiche sociali. Un’analisi comparata, Bologna, Il Mulino
Marshall, T.H.
1976 Cittadinanza e classe sociale, Torino, UTET
O’Connor, J.
1977 La crisi fiscale dello Stato, Torino, Einaudi.
Offe, C.,
1977 Lo stato nel capitalismo maturo, Milano, Etas Libri.
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace,
2004 Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Roma, Libreria editrice Vaticana,
Popenoe, D.
17
1988 Disturbing the nest, New York, Aldine de Gruyter
Ranci, C. (a cura di)
2001 Il mercato sociale dei servizi alla persona, Roma, Carocci
Rodger, J.J.
2004 Il nuovo welfare societario, Trento, Erickson
Sorensen, A.
1998 On kings, pietism and rent-seeking in scandinavian welfare states, «Acta Sociologica», 41,
pp.363-75
Titmuss, R.
1970 The gift relationship, London, Allen & Unwin
Titmuss, R.
1986 Saggi sul welfare state, Edizioni Lavoro, Roma
18