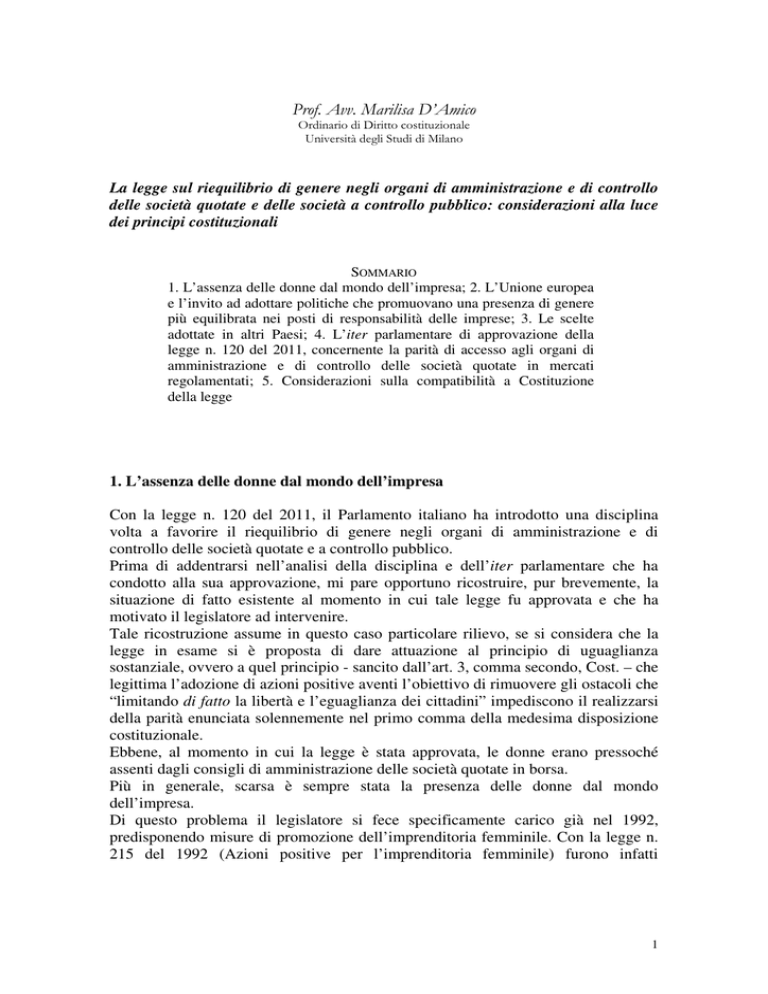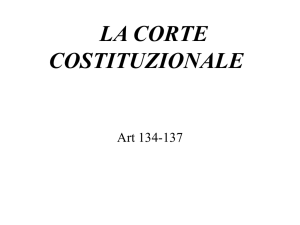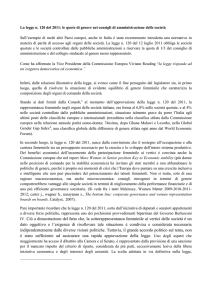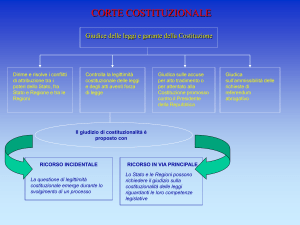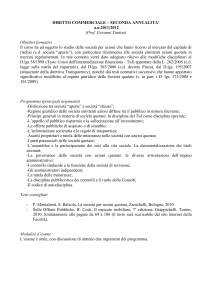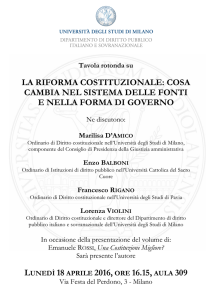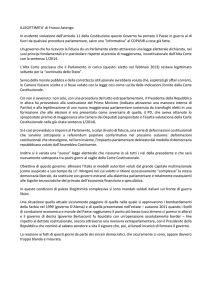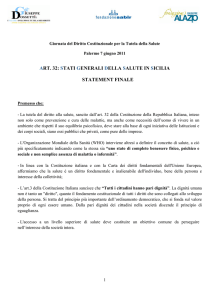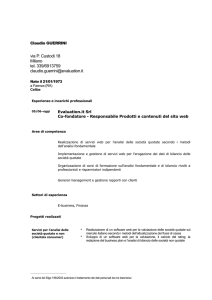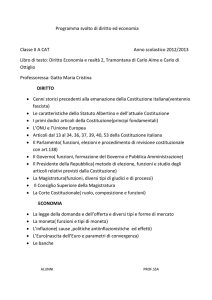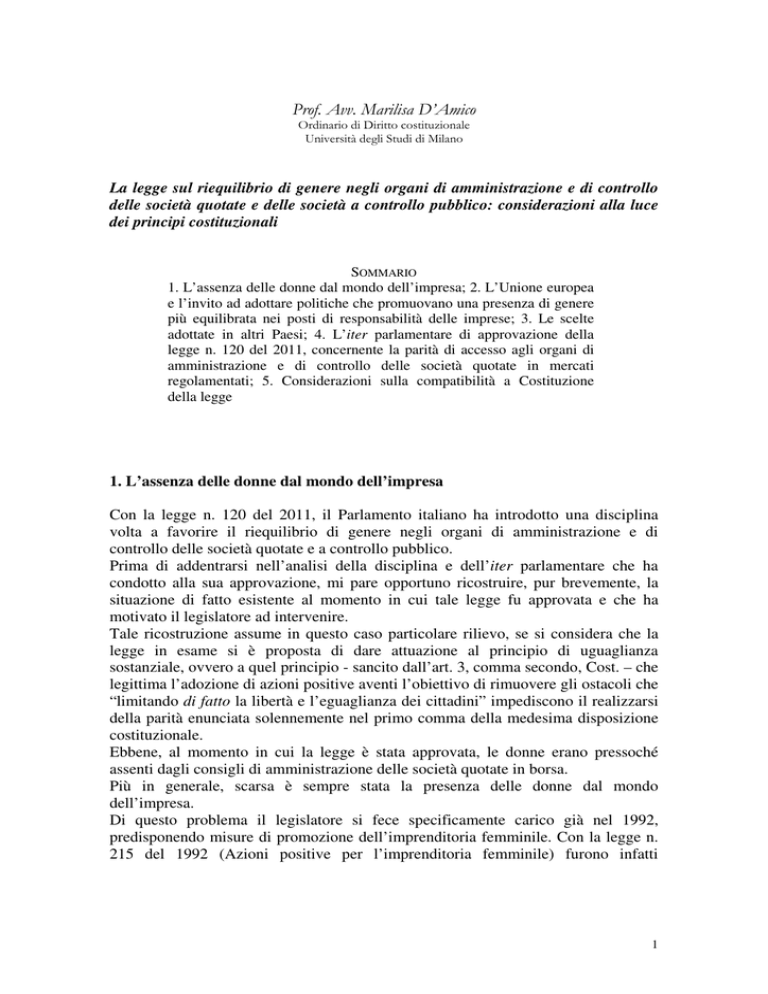
Prof. Avv. Marilisa D’Amico
Ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Milano
La legge sul riequilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo
delle società quotate e delle società a controllo pubblico: considerazioni alla luce
dei principi costituzionali
SOMMARIO
1. L’assenza delle donne dal mondo dell’impresa; 2. L’Unione europea
e l’invito ad adottare politiche che promuovano una presenza di genere
più equilibrata nei posti di responsabilità delle imprese; 3. Le scelte
adottate in altri Paesi; 4. L’iter parlamentare di approvazione della
legge n. 120 del 2011, concernente la parità di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati
regolamentati; 5. Considerazioni sulla compatibilità a Costituzione
della legge
1. L’assenza delle donne dal mondo dell’impresa
Con la legge n. 120 del 2011, il Parlamento italiano ha introdotto una disciplina
volta a favorire il riequilibrio di genere negli organi di amministrazione e di
controllo delle società quotate e a controllo pubblico.
Prima di addentrarsi nell’analisi della disciplina e dell’iter parlamentare che ha
condotto alla sua approvazione, mi pare opportuno ricostruire, pur brevemente, la
situazione di fatto esistente al momento in cui tale legge fu approvata e che ha
motivato il legislatore ad intervenire.
Tale ricostruzione assume in questo caso particolare rilievo, se si considera che la
legge in esame si è proposta di dare attuazione al principio di uguaglianza
sostanziale, ovvero a quel principio - sancito dall’art. 3, comma secondo, Cost. – che
legittima l’adozione di azioni positive aventi l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che
“limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini” impediscono il realizzarsi
della parità enunciata solennemente nel primo comma della medesima disposizione
costituzionale.
Ebbene, al momento in cui la legge è stata approvata, le donne erano pressoché
assenti dagli consigli di amministrazione delle società quotate in borsa.
Più in generale, scarsa è sempre stata la presenza delle donne dal mondo
dell’impresa.
Di questo problema il legislatore si fece specificamente carico già nel 1992,
predisponendo misure di promozione dell’imprenditoria femminile. Con la legge n.
215 del 1992 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile) furono infatti
1
approntate misure finanziarie di favore per le imprese condotte da donne e per le
società a prevalente partecipazione femminile.
La Corte costituzionale fu investita del sindacato sulla conformità a Costituzione di
questa legge, impugnata dalla Regione Lombardia e dalla Provincia Autonoma di
Trento, per violazione del riparto di competenze.
Ebbene, pur accogliendo in parte le doglianze dei ricorrenti (e stabilendo che
occorreva prevedere un meccanismo di cooperazione tra Stato, Regioni e Province
autonome, in modo da coinvolgere gli enti territoriali nella concreta decisione del
Ministro dell’industria di concedere le agevolazioni) la Corte costituzionale dichiarò
sotto gli altri profili non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.
L’importante decisione (sentenza n. 109 del 1993) fu l’occasione per chiarire la
natura delle azioni positive e per confermare l’allarmante assenza delle donne dal
settore dell’economia. La Corte ebbe infatti ad affermare che la misura legislativa
introdotta era diretta “a colmare o, comunque, ad attenuare un evidente squilibrio a
sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulatesi nel corso della
storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli
culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile nell’occupazione delle
posizioni di imprenditore o di dirigente d’azienda”.
Proseguendo nel proprio ragionamento, il Giudice costituzionale spiegò come le
finalità perseguite dal legislatore fossero espressione del dovere di cui all’art. 3,
comma 2, Cost. (principio di uguaglianza sostanziale), e descrisse le azioni positive
come “il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della
libertà e dell’autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza
per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate”.
La disciplina in esame, proprio perché volta a salvaguardare il primario valore
costituzionale della pari dignità sociale, era quindi stata legittimamente introdotta
dal legislatore statale, non potendosi ammettere, in questo ambito, interventi
differenziati per aree geografiche.
La legge n. 215 del 1992 ha certamente contribuito a migliorare la grave situazione
esistente, ma, come anticipato, la presenza delle donne nell’imprenditoria continua
ad essere ancora molto bassa.
Soprattutto, le donne sono assenti dagli organi decisionali delle grandi società. I dati
della Consob aggiornati al 2009 dicono che a far parte dei consigli di
amministrazione delle società quotate in borsa sono, per il 94% dei casi, uomini.
Anche a livello europeo i dati sono sconfortanti. A rivelarlo è un Report
commissionato e pubblicato dalla Commissione europea – “More women in senior
positions-key to economic stability and growth” (Più donne in posizioni chiave per
la crescita economica), del marzo 2010. Dall’indagine svolta, risulta che le donne
continuano ad essere pesantemente sottorappresentate nel processo decisionale
economico. Infatti, i membri dei consigli di amministrazione delle maggiori società
europee quotate in borsa sono uomini in circa l’89% dei casi. Nelle statistiche – ad
esempio quelle stilate ogni due anni dalla European Professional Women Network –
l’Italia si colloca peraltro nelle ultimissime posizioni, mentre la Norvegia risulta il
Paese dell’Unione europea in cui più equilibrata è la presenza di genere nelle società
quotate.
2
Una ricerca condotta dall’Osservatorio sul diversity management della Sda Bocconi
– “The different facets of diversity in boards of directors” (Ricerca presentata il 28
settembre 2010 presso la Sda Bocconi School of Management) – svolta su un
campione di 500 curricula di consiglieri di società italiane quotate, ha poi rivelato
che le donne potenzialmente idonee a ricoprire questi ruoli, perché in possesso degli
stessi requisiti degli attuali consiglieri, sono mediamente più giovani, presentano una
minore mobilità, ma un livello di istruzione più alto.
Non è, quindi, questione di merito. Se determinanti fossero i curricula, le donne
valicherebbero facilmente quel soffitto di cristallo che le tiene invece ancora oggi al
di fuori degli organi di vertice delle società.
Ma a fare le spese di questa assenza sono anzitutto le società, che finiscono per
essere guidate da gruppi omogenei. È infatti dato ormai acquisito che una
molteplicità di competenze ed esperienze incrementa la qualità delle decisioni
assunte.
2. L’Unione europea e l’invito ad adottare politiche che promuovano una
presenza di genere più equilibrata nei posti di responsabilità delle imprese
Dell’importanza di puntare sul cosiddetto fattore D sono consapevoli anche le
istituzioni dell’Unione europea.
Proprio alla luce dei risultati contenuti nel Report pubblicato dalla Commissione
europea Più donne in posizioni chiave per la crescita economica – che evidenzia il
forte squilibrio di genere esistente negli organi dirigenziali delle maggiori società –
Viviane Reding, commissario per la Giustizia, i diritti fondamentali e la
cittadinanza, ha affermato che “Se l’Europa intende seriamente uscire dalla crisi e
diventare un’economia competitiva grazie a una crescita intelligente e inclusiva,
dovrà sfruttare meglio il talento e le capacità delle donne”.
È questo il punto centrale anche della Risoluzione del Parlamento europeo del 10
febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea – 2009
(2009/2101(INI)). Nell’atto si dà conto della grave crisi economico - finanziaria che
sta attraversando l’Unione europea e dei rischi che essa si ripercuota,
principalmente, sulla posizione delle donne nel mercato del lavoro.
La crisi, in realtà, ha colpito soprattutto gli uomini. Ma l’analisi deve tener conto del
fatto che le donne sono meno retribuite degli uomini, che quindi costano di più alle
aziende. In secondo luogo, la presenza delle donne nel mercato del lavoro è
altamente settoriale. In particolare, esse costituiscono fino a due terzi del personale
attivo nei settori dell’istruzione, della sanità e dell’assistenza sociale; la crisi, quindi,
rischia di colpire molto pesantemente il lavoro femminile se i tagli di bilancio
interessano questi ambiti.
Ma quel che più colpisce, come si diceva, è che secondo il Parlamento europeo “la
crisi economica, sociale e finanziaria può rappresentare un’opportunità per fare
dell’Unione un’economia più produttiva e innovativa e una società che prende in
maggiore considerazione la parità tra uomini e donne, purché siano adottate
politiche e misure adeguate”.
3
In questo senso, deplorando il fatto che i piani di ripresa economica si concentrino
principalmente sui posti di lavoro in cui prevalgono gli uomini, il Parlamento
incoraggia invece gli Stati membri a “promuovere l’imprenditorialità femminile nel
settore industriale”, e, più specificamente, a “promuovere una presenza più
equilibrata tra donne e uomini nei posti di responsabilità delle imprese,
dell’amministrazione e degli organi politici”.
Quanto agli strumenti concretamente adottabili per conseguire questi risultati,
significativo è che il Parlamento europeo richiami “gli effetti positivi dell’uso delle
quote elettorali sulla rappresentanza delle donne”. In termini del tutto simili il
Parlamento europeo si è espresso anche nella più recente Risoluzione dell’8 marzo
2011 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea – 2010 (2010/2138 (INI)).
Nel documento si insiste sulla necessità che gli Stati fissino obiettivi vincolanti per
garantire la presenza paritaria di donne e uomini nei posti di responsabilità delle
imprese.
Pare, dunque, che siano le stesse istituzioni dell’Unione europea a suggerire di
utilizzare, anche in ambito economico, uno strumento che ha trovato iniziale
applicazione – con esiti spesso positivi – in ambito politico, nell’adozione delle
discipline nazionali elettorali.
3. Le scelte adottate in altri Paesi
È stata la Norvegia ad aver inaugurato il ricorso al meccanismo delle quote in
campo economico.
Il primo intervento normativo risale al 2003, quando è stata approvata una legge che
ha fissato una soglia minima di presenza di ciascun genere – corrispondente al 40%
– all’interno dei consigli di amministrazione delle società pubbliche. Nel 2006 la
previsione è stata estesa anche alle società private.
L’inosservanza della norma – alla quale occorreva adeguarsi entro due anni
dall’entrata in vigore della stessa – comporta rigide sanzioni, al limite dello stesso
scioglimento della società inadempiente. Se sono coinvolti interessi pubblici
preminenti, che richiedono la ‘sopravvivenza’ della società, è invece prevista
l’erogazione di pesanti sanzioni economiche.
Grazie a questo intervento normativo, la presenza femminile nelle più grandi
imprese norvegesi è salita dal 36% del 2006 al 42% del 2009.
La scelta adottata in Norvegia è stata molto apprezzata anche dal Parlamento
europeo, che nella già citata Risoluzione sulla parità tra donne e uomini del 2009 ha
invitato “la Commissione e gli Stati membri a considerare l’iniziativa norvegese
come un esempio positivo e a progredire nella stessa direzione”.
Anche in Spagna, nel 2007, le società pubbliche quotate di grandi dimensioni (con
almeno più di 250 dipendenti) sono state invitate a sviluppare piani di promozione
delle pari opportunità, e a prevedere, entro il 2015, una partecipazione minima – pari
ad almeno il 40% – di ciascun sesso nei consigli di amministrazione.
In questo caso non sono però previste sanzioni, ma solo incentivi, che sembrano
aver prodotto qualche discreto risultato. Negli ultimi anni si riscontrano infatti
segnali di progresso nella rappresentazione delle donne nei consigli di
4
amministrazione delle più grandi società (che passa dal 5% del 2006 al 10% del
2009).
Anche in Francia è stata di recente approvata una legge (Représentation équilibrée
des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance
et à l’égalité professionnelle – Loi 2011/103 del 27 gennaio 2011) che prevede che
entro 6 anni le donne dovranno ricoprire almeno il 40% dei posti nei consigli di
amministrazione delle società sia pubbliche sia private.
Alternativa alla previsione normativa di quote – che a sua volta può presentarsi sotto
la diversa veste di obbligo assistito da sanzione o di invito accompagnato da
incentivi – è la possibilità di adottare codici di corporate governance.
Si tratta di codici di autoregolamentazione, in cui, come accaduto in alcuni Paesi
quali ad esempio la Finlandia e la Gran Bretagna, sono state inserite previsioni
volte a favorire l’ingresso di più donne nei consigli di amministrazione delle società
quotate.
4. L’iter parlamentare di approvazione della legge n. 120 del 2011, concernente
la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società
quotate in mercati regolamentati.
Anche in Italia si è in un primo momento tentato di introdurre, a livello di
autoregolamentazione, un incentivo ad incrementare il numero delle donne nei
consigli di amministrazione delle società quotate. Ma il tentativo di inserire una
simile previsione in occasione della riforma del Codice di autodisciplina delle
società quotate nella Borsa italiana è fallito. Anche per questo, quindi, si è deciso di
puntare sull’introduzione di un vincolo a livello legislativo.
Nel 2009 sono stati presentati alla Camera dei deputati e al Senato tre progetti di
legge dal contenuto molto simile.
Obiettivo di questi progetti (C. 2426, presentato nel maggio 2009 a firma dell’on.
Golfo, e C. 2956, presentato a novembre 2009 a firma dell’on. Mosca; S. 1719,
presentato dalla senatrice Germontani), era di modificare il Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58 del 1998,
introducendo previsioni volte a favorire la parità di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati.
Il primo dato significativo è che i richiamati progetti di legge provenivano
dall’iniziativa di diverse forze politiche. Ciò dimostra come l’assenza delle donne
dagli organi decisionali dell’economia sia un dato oggettivo, preoccupante
indipendentemente dal punto di vista politico che si adotta nell’approccio alla
tematica.
Come si evince dalle relazioni illustrative che hanno accompagnato le proposte, il
fine perseguito era quello di intervenire per risollevare una condizione di
sottorappresentanza femminile negli organi delle società quotate in borsa talmente
grave da porre l’Italia nelle ultime posizioni delle statistiche europee.
Il punto di vista da cui si sono prese le mosse, poi, non è solo che questa condizione
fosse penalizzante per le donne, ma che in questo modo si riducesse l’ambito di
risorse e di talento a cui il Paese poteva attingere per il proprio sviluppo.
5
Le proposte di legge, in altre parole, nascevano dalla “convinzione che il sostegno
alla partecipazione della donne al lavoro e alla carriera sia un presupposto e uno
strumento essenziale per la crescita e per la competitività del nostro sistema
produttivo” (C. 2956) e che il fattore D costituisca un “valore aggiunto apportato
dalle donne nella gestione d’impresa”, che esplica “i suoi effetti anche sul piano dei
profitti d’impresa” (C. 2426). Nella stessa direzione andava anche la relazione
illustrativa al disegno di legge presentato al Senato, che ricordava come una ricerca
della società Cerved sulle donne manager rivelasse che le imprese guidate dalle
donne conseguono migliori risultati rispetto alle altre, accrescono più velocemente i
ricavi, generano più profitti, e sono meno rischiose.
In effetti, come già evidenziato, il riequilibrio di genere negli organi decisionali
delle società è obiettivo che, nei più recenti studi, viene ricollegato non solo alla
necessità di garantire alle donne parità di accesso nella gestione d’impresa, quanto
alla constatazione che collegi composti in modo equilibrato tra donne e uomini siano
in grado di conseguire risultati migliori, perché frutto di decisioni assunte sulla base
di un confronto tra sensibilità, esperienze, attitudini e punti di vista differenti.
Ripercorrendo l’iter parlamentare attraversato dai richiamati progetti di legge, si può
ricordare come le due proposte presentate alla Camera, e sottoposte all’esame della
Commissione Finanze in sede deliberante, sono poi confluite in un testo unificato
adottato dalla Commissione stessa, e approvato il 2 dicembre 2010.
In questa prima versione, approvata dalla Camera e poi trasmessa al Senato, si
richiedeva che “il riparto degli amministratori da eleggere [fosse] effettuato in base
a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi”. Il disegno di legge stabiliva esso
stesso a quali condizioni tale criterio potesse dirsi soddisfatto. Infatti vi si precisava
che “Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli
amministratori eletti”. Il riparto si applica per tre mandati consecutivi e la violazione
di tali prescrizioni comportava la decadenza dalla carica dei componenti eletti. Le
previsioni riguardano anche la composizione dei collegi sindacali e sono altresì
estese alle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate nei mercati
regolamentati.
Ora, sebbene la proposta di legge avesse ricevuto l’appoggio delle maggiori forze
politiche, in Senato il cammino del progetto ha dovuto subire un rallentamento, ed è
stato oggetto di modifiche.
I correttivi più significativi sono stati quelli proposti dal Governo, che, in primo
luogo, aveva proposto la sostituzione della sanzione della decadenza con la
previsione di sanzioni di natura meramente pecuniaria, da comminare alle società
inadempienti al termine di un procedimento di competenza della Consob. Con un
altro emendamento il Governo aveva poi proposto di graduare l’obiettivo del
riequilibrio di genere, scandendo le fasi temporali attraverso cui realizzarlo. Più
precisamente, si richiedeva di riservare al genere meno rappresentato, nel primo
mandato, un decimo dei posti, nel secondo mandato, un quinto dei posti, e solo nel
terzo, un terzo dei posti. Inoltre, si proponeva di posticipare l’applicazione della
legge ad un anno (e non quindi a sei mesi) dalla data della sua entrata in vigore.
Le modifiche governative sono state fortemente criticate in Commissione. Un dato
da sottolineare positivamente, tuttavia, è che le difficoltà incontrate non hanno
6
ostacolato la volontà politica di approvare un testo normativo condiviso, se non
negli specifici contenuti, certamente negli obiettivi.
Dopo un primo momento di stallo, dunque, i gruppi parlamentari sono riusciti a
trovare un punto di mediazione tra la posizione espressa dal Governo con i propri
emendamenti e quella dei senatori (molti dei quali anche appartenenti alla
maggioranza) che ritenevano indispensabile non posticipare eccessivamente l’entrata
a regime della legge e mantenere nel testo la previsione di sanzioni davvero
dissuasive.
Nella versione definitiva della legge, quindi, è stata reintrodotta la sanzione della
decadenza, che deve però essere preceduta da due successive diffide della Consob
nei confronti della società inadempiente. La prima diffida deve contenere un termine
ad adempiere di quattro mesi (scaduto vanamente il quale verrà comminata una
sanzione pecuniaria), la seconda di tre mesi. In caso di persistente inottemperanza è
previsto che i componenti eletti decadano dalla carica. Lo statuto dovrà inoltre
disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione di
amministratori in corso di mandato, al fine di garantire, anche in tale ipotesi, il
rispetto del riparto di genere richiesto.
La Consob, inoltre, per esercitare i propri poteri in ordine alla violazione,
all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia, è stata impegnata ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un apposito
regolamento.
Quanto ai tempi per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge, accolta la
proposta del governo di posticipare l’applicazione della legge ad un anno dalla sua
entrata in vigore, con un altro subemendamento è stata però proposta (ed ottenuta)
una scansione dei tempi differente. Si indica, infatti, in un quinto la quota richiesta
per il primo mandato e si stabilisce che già dal secondo le società dovranno
conformare i cda e i collegi sindacali in modo tale che almeno un terzo dei posti sia
occupato dal sesso sottorappresentato.
Merita di essere ricordato che proprio sulla scansione temporale dei passaggi
attuativi dell’obiettivo del riequilibrio di genere si sono però registrati i maggiori
contrasti. Il Governo, proprio il giorno dell’8 marzo, quando era prevista la
votazione, ha espresso parere negativo su quest’ultimo subemendamento. La
votazione è stata pertanto rinviata, con l’intento di evitare la formalizzazione di una
contrapposizione tra Governo e Commissione che avrebbe reso ancora più difficile
l’approvazione del disegno di legge.
Forse anche a seguito di questo segnale di disponibilità, il giorno successivo il
Governo ha mutato orientamento, esprimendo parere favorevole. Ne è seguita
l’approvazione in Commissione del progetto di legge nella versione risultante dal
subemendamento richiamato.
Il progetto di legge, approvato dal Senato il 10 marzo, è tornato alla Camera, dove
ha ricevuto la definitiva approvazione.
5. Considerazioni sulla compatibilità a Costituzione della legge
La disciplina introdotta con la legge n. 120 del 2011, fin dal momento in cui è stata
sottoposta all’esame del Parlamento, è stata da taluni accolta criticamente, in quanto
7
ritenuta lesiva del diritto di iniziativa economica privata e dello stesso principio di
uguaglianza. In particolare, in questi termini si era espresso l’allora Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio Giovanardi (Quote rosa? Scivolano sulla Carta, Il Sole
24 Ore, 8/12/2010).
Ora, sulla questione attinente al rapporto tra la disciplina in esame la Costituzione,
nonché ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella propria giurisprudenza
formatasi in materia di sistemi di quote, ho avuto già modo di esprimermi durante
un’audizione tenuta innanzi alla Commissione Finanze della Camera dei deputati
proprio nel corso del procedimento di approvazione della legge n. 120.
Riprendo qui il parere espresso in quella sede.
Sotto il profilo del rapporto con il diritto di iniziativa economica, anzitutto, rilevo
che la circostanza che sia stato proprio il Parlamento europeo, sebbene in un atto
non vincolante, a suggerire di seguire l’esempio norvegese, porta utili argomenti a
favore della tesi secondo cui questo tipo di misure non inciderebbero indebitamente
sulla libertà di iniziativa economica, in quanto finalizzate al raggiungimento di un
maggiore equilibrio sociale e, in ultima analisi, della realizzazione del principio
comunitario dell’effettiva parità tra donne e uomini in ambito lavorativo.
Si consideri, poi, che l’art. 41 Cost., nel garantire la libertà di iniziativa economica,
aggiunge anche che essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Questo aspetto
è stato sottolineato anche dalla Commissione Affari costituzionali che, nell’iter di
approvazione del progetto di legge alla Camera, ha espresso – con alcune
osservazioni poi recepite nel testo – parere favorevole. Inoltre, a voler essere
formalisti, in ogni caso l’art. 41 Cost. dovrebbe cedere rispetto all’art. 3, comma 2,
Cost., ovvero a uno dei principi supremi previsti dalla nostra Costituzione.
Quanto alla compatibilità di tali previsioni proprio all’art. 3 Cost., nonché all’art.
51 Cost., estensivamente interpretato (in quanto norma riguardante l’accesso alle
cariche elettive e agli uffici pubblici), va osservato, anzitutto, che la legge n. 120 è
evidentemente finalizzata, come detto, a dare attuazione al principio di uguaglianza
sostanziale, sancito dal comma 2 della citata disposizione costituzionale. La norma,
come detto, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che, limitando
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva
partecipazione della stessa all’organizzazione politica, economica e sociale.
Va detto, però, che non ogni previsione normativa che si ponga l’obiettivo di
realizzare l’uguaglianza ai sensi dell’art. 3, comma 2, Cost., è, per questa sola
circostanza, legittima. Occorre, infatti, confrontarsi con la giurisprudenza della Corte
costituzionale, che nelle proprie pronunce ha individuato i limiti che le “azioni
positive” incontrano nel nostro ordinamento.
In questo senso, è utile ripercorrere la giurisprudenza della Corte sulla conformità a
Costituzione sia delle norme finalizzate ad attribuire un vantaggio specifico alle
donne quali soggetti appartenenti ad una categoria debole, sia di quelle che,
formulate in termini neutri, sono volte a garantire parità di chances tra a donne e
uomini nella competizione elettorale.
Assume particolare rilievo, in questa ricostruzione, anzitutto la già citata sentenza n.
109 del 1993, nella quale, lo si ricorda, la Corte ha affermato – proprio con
riferimento a misure introdotte in materia economica – che le azioni positive “sono
8
il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e
dell’autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le
singole categorie di persone socialmente svantaggiate”.
In questa pronuncia, dunque, la Corte costituzionale mostra di giudicare con favore
le misure normative che, “proprio perché presuppongono l’esistenza storica di
discriminazioni attinenti al ruolo sociale di determinate categorie di persone e
proprio perché sono dirette a superare discriminazioni afferenti a condizioni
personali (sesso) in ragione della garanzia effettiva del valore costituzionale
primario della ‘pari dignità sociale’, introducono vantaggi specifici a favore della
categoria svantaggiata”.
Vista la forte analogia tra lo strumento oggi introdotto (il sistema delle quote) e
quello sovente utilizzato in materia elettorale, pare poi utile un riferimento anche
alla giurisprudenza costituzionale in tale settore.
Con la sentenza n. 422 del 1995, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime
tutte le misure normative intese a favorire la rappresentanza politica femminile,
affermando che qualsiasi disposizione tendente ad introdurre riferimenti “al sesso”
dei rappresentanti, anche se formulata in modo neutro, si porrebbe in contrasto con
tale principio. Nella successiva sentenza n. 49 del 2003, però, la Corte ha cambiato
orientamento, e ha dato rilievo, tra l’altro, alla circostanza che la misura prevista dal
legislatore regionale fosse formulata in termini neutri (“ambo i sessi”).
Primo elemento di cui tenere conto nel valutare la conformità a Costituzione della
misura che si intende oggi approvare è proprio la scelta di formulare la misura
introdotta senza esplicitare che essa è rivolta ad uno dei due generi. Si tratta di una
scelta indubbiamente apprezzabile, posto che, in questo modo, la disposizione evita
di tradursi in una esplicita misura di favore nei confronti di una particolare categoria
di soggetti. Già questo aspetto, forse, potrebbe indurre la Corte costituzionale ad
esprimersi in termini favorevoli nell’ambito di un eventuale giudizio di legittimità
costituzionale.
Ciò premesso, occorre segnalare però che le misure introdotte dalla legge n. 120
presentano una differenza rispetto a quelle sinora richiamate.
Infatti, esse non introducono una riserva di posti nell’ambito delle liste di candidati
al consiglio di amministrazione (o del collegio sindacale) – similmente a quanto
previsto nelle leggi elettorali sopra menzionate – ma stabiliscono direttamente un
riparto di posti negli organi. Infatti, l’equilibrio di genere è raggiunto solo se il
genere meno rappresentato all’interno dell’organo ottenga almeno un terzo degli
amministratori eletti (o dei sindaci eletti).
Dunque, le norme, sebbene formulate in modo neutro, e quindi non esplicitamente
rivolte a favorire le donne, potrebbero ritenersi tese ad attribuire direttamente un
risultato. Al sesso sottorappresentato, lo si ribadisce, non si vede riservata una
percentuale di posti in lista, ma una percentuale di posti negli organi elettivi. Ciò
potrebbe porsi in difficile equilibrio con quella giurisprudenza costituzionale che
esclude l’ammissibilità di norme che “non si propongono di ‘rimuovere’ gli ostacoli
che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati bensì di attribuire
loro direttamente quei risultati medesimi” (sentenza n. 422 del 1995).
Va considerato, innanzitutto, che i limiti che la Corte pone alle azioni positive
riguardano la materia elettorale e la possibilità che l’attribuzione del risultato sia
9
strumento coercitivo della volontà dell’elettore (così, in particolare, Corte
costituzionale, sentenza n. 4 del 2010).
Inoltre, e soprattutto, occorre ragionare sulla circostanza che misure come quelle
oggi in esame si propongono di rimediare a situazioni di discriminazione
storicamente perpetrate. In ciò si rivelano simili alle affirmative actions statunitensi.
La Corte suprema, chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità di provvedimenti
attraverso cui, nell’accesso al lavoro e all’istruzione universitaria, veniva riservata
una quota di posti ai soggetti facenti parte di categorie discriminate, ha chiarito quali
siano i requisiti che rendono legittime tali misure. Le affirmative actions devono,
anzitutto, avere natura temporanea. Per evitare che si trasformino a loro volta in
misure discriminatorie esse possono operare, dunque, per il solo tempo necessario a
raggiungere l’obiettivo per il quale sono state previste.
Ora, come già detto, le misure previste nel progetto approvato della Camera sono
formulate in termini neutri. Astrattamente, quindi, potrebbero avere permanente
efficacia nell’ordinamento. Non favorendo esplicitamente taluni soggetti, esse
troverebbero applicazione anche qualora (ipotesi per vero irrealistica …) fosse
quello maschile il sesso sottorappresentato da tutelare.
Proprio perché volte a garantire una certa percentuale di posti negli organi
decisionali delle società, tuttavia, si rivela decisiva – e va valutata pertanto
positivamente – la scelta di aver inserito nel testo unificato all’esame della
Commissione Finanze (come proposto nel progetto di legge C. 2956) una clausola di
delimitazione temporale delle misure introdotte.
Con questo accorgimento, in caso di contestazione sulla loro legittimità
costituzionale, la Corte dovrebbe quindi valutare come legittime le disposizioni
introdotte, che, peraltro, come già visto, si muovono nella direzione indicata (pur se
non imposta) dagli stessi organi dell’Unione europea.
In definitiva, dunque, e in attesa di verificare, a breve, i concreti effetti della legge,
deve ribadirsi l’assoluta con divisibilità dell’intervento approntato dal legislatore, in
quanto finalizzato a garantire non già solo al sesso sottorappresentato parità di
accesso ai vertici delle società, quanto, soprattutto, un riequilibrio di genere utile alla
stessa funzionalità di tali organi, messi in grado di adottare decisioni ‘migliori’, alle
quali tutti, non solo le donne, dovrebbero avere interesse.
10